Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 4 IN RICORDO DI …
- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 6 FESTIVAL ED EVENTI
- 7 OCCHIO CRITICO
- 7.1 LA (S) CORRETTEZZA DELL’IMPEGNO: “IN DUBIOUS BATTLE. IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI” DI JAMES FRANCO; “MISS SLOANE. GIOCHE DI POTERE” DI JOHN MADDE di Marco Incerti Zambelli
- 7.2 TUTTO QUEL FRACASSO: “CANE MANGIA CANE” DI PAUL SCHRADER di Francesco Saverio Marzaduri
- 7.3 AIUTIAMOLI A CASA LORO? “L’ORDINE DELLE COSE” DI ANDREA SEGRE; “BABYLON SISTERS” DI GIGI ROCCATI di Paolo Vecchi
- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 9 QUALITA’ IN SERIE
- 10 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 11 AUTORI
- 12 CREDITS
ABSTRACT
IL CINEMA DI JIM JARMUSH TRA MOVIMENTO E FALSO MOVIMENTO di Marino Demata
Il saggio, che potrebbe anche essere definito “La poetica del movimento nel cinema di Jarmush”, individua nell’impermanenza, nello spostamento e nel viaggio l’asse centrale della sua concezione della vita presente nei suoi film. A sostegno di tale tesi, l’Autore prende le mosse dal primo film di Jarmush, “Permanent Vacation” documentando, con le parole stesse del protagonista, la necessità di andare verso ciò che è diverso. Questo concetto è analizzato in altri film della sua ormai ricca filmografia e in particolare i road movies “Stranger than Paradise”, “Dead Man”, “Broken flowers” e l’inedito in Italia “The limits of control” e con accenni anche alle altre opere. L’Autore distingue il movimento liberamente scelto da alcuni protagonisti dei suoi film, da quello diverso di altri personaggi, per i quali il movimento non è una scelta libera, ma una costrizione, o la conseguenza di un contratto o una fuga. Non manca un riferimento al “falso movimento”, termine mutuato dall’omonimo film di Wim Wenders.
LYDA BORELLI LA PRIMA DONNA DEL NOVECENTO di Maurizio Villani
L’articolo dapprima dà conto della mostra dedicata a Lyda Borelli aperta a Venezia a palazzo Cini. Si sofferma poi sulla carriera teatrale e cinematografica dell’attrice, presentandone la filmografia completa.
VILLAGGIO SALUTA E SE NE VA di Francesco Saverio Marzaduri
I suoi personaggi sono diventati un fenomeno culturale: il prototipo dell’uomo medio destinato da che mondo è mondo a subire. Un ritratto di Paolo Villaggio, scomparso a luglio, la cui maschera ha rischiato sovente d’inflazionare un interprete tra i più originali e rappresentativi.
JEANNE, GLI OCCHI CHE (NON) SORRISERO di Francesco Saverio Marzaduri
Lo sguardo languido, l’enigmatico sorriso, l’immancabile sigaretta accesa. Un ritratto di Jeanne Moreau, scomparsa a luglio: musa della “Nouvelle Vague” francese, volto simbolo del cinema d’autore, incarnazione di una femminilità esistenzialista e volitiva.
FILMMAKER ALLA RIBALTA: AGOSTINO VINCENZI di Paolo Micalizzi
Profilo di un filmmaker pesarese, attivo fin dal 1964, che ha trasmesso nelle sue opere ,principalmente, esperienze raccolte nella sua attività di insegnante e di osservazione della vita dei giovani. E che esprime la sua passione per il cinema anche con delle “Conversazioni” relative a tematiche ed Autori, tra cui primeggia Michelangelo Antonioni, ispiratore del suo percorso cinematografico. Al suo attivo anche la regia teatrale di commedie dialettali.
STAGE NAZIONALE FEDIC. NON SOLO CINEMA di Enzo Bruno
L’esperienza di vivere 5 giorni immersi nella splendida collina toscana, dove i nostri pensieri e le nostre storie sono diventate immagini. Come per magia. Come solo il cinema riesce a fare….
BIOGRAFILM: UN FESTIVAL PER IL DOCUMENTARIO RICCO DI PROPOSTE di Paolo Micalizzi
Resoconto di un Festival con ospiti d’eccezione come Francis Ford Coppola e la sua famiglia di registi, Peter Greenaway, Pierce Brosnan, Piera Degli Esposti ed altri e con la presentazione di numerosi documentari internazionali che riscuotono l’interesse di un ampio pubblico, che diventa anche giurato della Sezione italiana. Un Festival ricco di proposte tra cui il mercato del documentario con la presentazione di nuovi progetti e i Concerti in un apposito Parco che in questa edizione ha registrato oltre 100mila presenze.
SAN GIO’ VERONA VIDEOFESTIVAL. LE IMMAGINI, LE STORIE, LE IDEE di Guido Zauli
Un Festival raccontato da Guido Zauli che sottolinea il singolare luogo delle proiezioni, le storie raccontate , principalmente ,nelle opere premiate e le idee che vi sono contenute.
LA (S) CORRETTEZZA DELL’IMPEGNO: “IN DUBIOUS BATTLE. IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI” DI JAMES FRANCO; “MISS SLOANE. GIOCHE DI POTERE” DI JOHN MADDE di Marco Incerti Zambelli
Un ritrovato interesse al cinema d’impegno sociale in due recenti opere americane, nelle quali centrale è l’indagare sui mezzi ( morali e non solo) utilizzabili per raggiungere l’obiettivo.
TUTTO QUEL FRACASSO: “CANE MANGIA CANE” DI PAUL SCHRADER di Francesco Saverio Marzaduri
Tratto dall’omonimo romanzo di Edward Bunker, e giunto nelle sale italiane con un anno di ritardo, il ventesimo lungometraggio di Paul Schrader narra di tre ex galeotti, Troy, Diesel e Mad Dog, desiderosi di reintegrarsi nella vita civile senza ottenere i risultati sperati. Quando un potente boss gli offre la possibilità di compiere un ultimo crimine, grazie al quale sistemarsi per il resto della vita, il trio decide di accettare senza troppe esitazioni. Ma qualcosa non va come previsto…
AIUTIAMOLI A CASA LORO? “L’ORDINE DELLE COSE” DI ANDREA SEGRE; “BABYLON SISTERS” DI GIGI ROCCATI di Paolo Vecchi
“L’ordine delle cose” affronta il tema dei migranti con estrema precisione in tutti i suoi termini, dalle divisioni tribali in Libia, alla conseguente difficoltà a stipulare accordi con interlocutori sfuggenti e poco affidabili, all’orrore dei centri di accoglienza, alle pressioni di un governo preoccupato per la perdita di consenso.
“Babylon Sisters” entra in un fatiscente palazzo di Trieste che ospita extracomunitari di svariata provenienza dando conto della complessità dei loro problemi, con un’ottica costruttiva che non diventa mai stucchevole e trova accenti di vera commozione descrivendo il rapporto tra una piccola indiana e un burbero professore in pensione.
AI CONFINI DELL’IMPERO di Marcello Cella
Tre recenti documentari raccontano le realtà più marginali ed oscure del mondo occidentale: “Brexitannia” di Timothy George Kelly, “Stranger in Paradise” di Guido Hendrikx e “The Workers Cup” di Adam Sobel.
“LA LINGUA DEI FURFANTI. ROMANINO IN VALLE CAMONICA” DI ELISABETTA SGARBI di Tullio Masoni
In un unico film la regista visita gli affreschi realizzati dal Romanino nelle chiese di Pisogne, Breno e Bienno, in provincia di Brescia. Fra passato e presente la memoria di un luogo contadino che nasconde il capolavoro come fosse un suo segreto.
RILLINGTON PLACE di Giancarlo Zappoli
Reginald Christie, tra gli anni ’40 e i ’50 ha ucciso almeno 8 donne, divenendo così uno dei più famosi serial killer britannici. Questa miniserie con Tim Roth e Samantha Morton nei ruoli di Christie e di sua moglie ripercorre la vita di un uomo apparentemente ‘qualunque’ offrendo all’attore uno delle sue più complesse e ambigue interpretazioni tanto da fargli pensare: “In che cosa mi sono infilato?”
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
Segnalazioni-recensioni di libri, recenti, dedicati a Gabriele Ferzetti, Alida Valli, Ermanno e Fabio Olmi, Fernando Di Leo.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
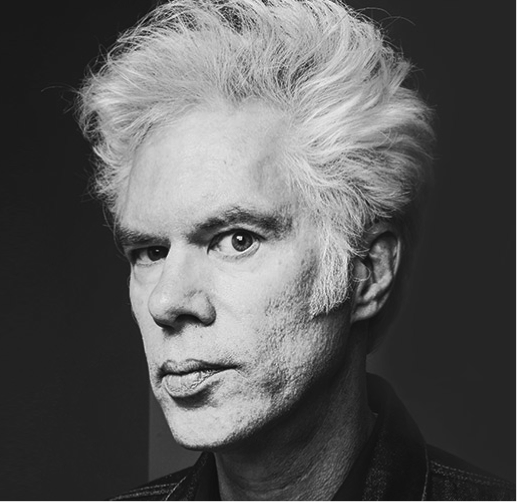 IL CINEMA DI JIM JARMUSH TRA MOVIMENTO E FALSO MOVIMENTO
IL CINEMA DI JIM JARMUSH TRA MOVIMENTO E FALSO MOVIMENTO
di Marino Demata
“Permanent vacation”: il manifesto del movimento
Se si ripensa alla filmografia di Jim Jarmush, dagli esordi fino alle sue opere più recenti, appare del tutto evidente un filo rosso di collegamento, che è costituito dalla categoria del movimento. Che si materializza nei film del regista di “Akron” in varie forme, ma che fondamentalmente ed in ogni film della fase iniziale è come mutamento di luogo, come impermanenza, come insofferenza o impossibilità alla stasi, come necessità dello spostamento. Come vedremo dall’esame di alcuni titoli, il movimento è, soprattutto nella prima parte delle opere del regista, determinato dalla volontà del protagonista e dalla propria insofferenza al “restare nel medesimo luogo”. Ma in molti altri casi esso è determinato da circostanze, situazioni e volontà altrui che lo rendono obbligato. In entrambi i casi esso costituisce l’asse portante comune alla opere del regista perché è proprio dal mutamento di luogo che scaturiscono i cambiamenti (o le conferme) nell’animo e nella personalità dei personaggi.
Prendiamo subito il primo film di Jarmush del 1980, un film quasi sperimentale, nel quale l’autore già segnala il suo talento originale e la sua vocazione,mai più dismessa, ad essere autore indipendente e al di fuori di ogni schema. Già il titolo, “Permanent vacation”, sottende un concezione della vita come una continua vacanza e quindi come continuo e necessario cambiamento di luogo. Con uno stratagemma narrativo il regista fa dire ad un certo punto ad Allie (Chris Parker), il protagonista del film, con voce fuori campo: “e così mi trovo qui, in un posto di cui non conosco nemmeno la lingua”. Il posto è Parigi ove Allie si è recato imbarcandosi da New York su una nave dopo aver occasionalmente e avventurosamente messo insieme i soldi del viaggio. Attraverso questa affermazione fuori campo Jarmush comunica allo spettatore che il film a cui sta assistendo è un flashback che descrive gli ultimi due giorni di Allie a New York, dove nasce l’esigenza del viaggio.
Nelle due giornate newyorkesi descritte nel film Allie girovaga a piedi per la città e incontra molte persone, si reca innanzitutto dalla sua ragazza, che si lamenta di essere troppo solo e si sente rispondere: “Siamo tutti soli. Alcune persone sono capaci di distrarsi con le loro ambizioni. Ma io non sono così. Loro credono che la gente come me sia pazza. Per come vivo. Capisci? Puoi chiamarmi incosciente. Ma è l’unico modo per me.” Poi incontra altre persone in una New York che sembra bombardata, tanto è piena di macerie e di miserie, trasparente metafora delle macerie dell’animo umano.
E finalmente il regista, ancora una volta con voce la voce fuori campo di Allie, esprime la propria concezione della necessità del movimento: “Io mi muovo da questo posto, queste persone, ad un altro posto, ad altre persone…Per me le persone che ho incontrato sono come una serie di stanze, proprio come i luoghi ove ho trascorso del tempo. La prima volta cammini in questa stanza curioso delle novità, la lampada, la TV ecc. Ma poi le novità scompaiono completamente. E poi c’è questa specie di paura…Credo che il succo del discorso sia che dopo un po’ qualcosa te lo dice. Ti parla una voce: Qui è tutto. E’ tempo di cambiare. Vai da qualche altra parte.” E qui Jarmush, sempre attraverso la voce fuori campo di Allie, introduce una distinzione meta-filosofica tra le persone e le cose: “Le persone tendono ad essere tutte uguali. Forse usano un frigorifero diverso oppure il bagno…o qualcos’altro. Ma queste cose ti parlano e tu devi cominciare ad allontanarti. Potresti non avere voglia di andare, ma le cose ti hanno detto di farlo. “
Emblematica è la scena finale: la nave si allontana e l’acqua dell’oceano marca il confine temporale e spaziale tra il prima e il dopo, tra il nuovo e il vecchio continente, tra il passato, il presente e l’ignoto e indefinito.
Le origini di tutto
Da dove viene a Jim Jarmush un così forse senso del movimento, una così marcata necessità di andare verso l’altrove, anche quando non si è obbligati da situazioni e necessità esterne?
A nostro giudizio sono rintracciabili almeno tre ordini di cause:
1) Innanzitutto se diamo un’occhiata alla biografia del regista fino a quel momento non possiamo mancare di rintracciare la stessa inquietudine che egli ha trasmesso ad Allie e un po’ a tutti i personaggi dei suoi film. La spinta al mondo della cultura e del cinema gli deriva dalla madre, critica cinematografica e teatrale, che gli fece scoprire il mondo dello spettacolo, ma anche il mondo della letteratura. E Jim divenne un appassionato divoratore di libri e un diligente spettatore di moltissimi film. Finchè non si imbattè nei testi della Beat Generation e ne rimase folgorato, e poi fu impressionato dalle immagini del New American cinema di New York e nella contro-cultura cinematografica underground. Fu a Chicago per un anno alla scuola di giornalismo e poi a New York, alla Columbia University. Ma la sua inquietudine lo porta, proprio come il suo autobiografico personaggio, Allen, a Parigi per quasi un anno ancora prima della laurea.
2) Il senso del movimento, del cambiamento, del viaggio era stato uno dei punti forti della contro-cultura americana dalla fine degli anni ‘60 alla fine degli anni ’70. Nel 1969 “Easy Rider” era stato una sorta di manifesto cinematografico del cambiamento, fondato sul desiderio di libertà, di fuga dalle convenzioni e dal perbenismo, di ricerca dell’altro come persona e come luogo. Insomma: il viaggio, il road movie. Con l’annullamento del tempo. Wayatt (Peter Fonda) all’inizio del viaggio in moto getta a terra l’orologio e lo lascia lì. Si manifesta nel film una nuova concezione del tempo e dello spazio come ricerca del diverso e della libertà, e come ricerca dell’America autentica, perduta ormai dentro l’involucro della convenzionalità borghese: nasce in questo modo il filone del road movie. Dopo “Easy Rider” ricordiamo “Vanishing Point” di Richard Serafian, “Duel” di Spielberg e soprattutto “Cinque pezzi facili” di Bob Rafelson. E nasce in ogni caso l’esigenza di stare sulla strada e non negli studios. Proprio come sono stati sulla strada, a New York, qualche mese prima, i fratelli di colore di “Shadows” del giovane Cassavetes.
3) E infine va considerata l’influenza che esercitarono sulle sue concezioni personaggi del cinema, di cui Jarmush riuscì a guadagnarsi la stima e l’amicizia con la sua bravura ed anche con la sua spiccata personalità. Ci riferiamo a Laslo Benedek, Spike Lee, Tom DiCillo, Nicholas Ray, e soprattutto Wim Wenders. Quest’ultimo aveva fatto un percorso inverso a quello del personaggio di Permanent Vacation. Uno spostamento di luogo dall’Europa all’America alla scoperta del “diverso”, dell’essenza del nuovo e del sogno americano. Girare in auto per l’America e vederla utilizzando i suoi occhi di Europeo era la realizzazione del suo sogno.
Dunque abbiamo rintracciato tre elementi fondamentali che influenzano decisamente la formazione cinematografica di Jarmush e soprattutto la sua concezione del movimento e del viaggio. C’è però da precisare che da “Easy Rider” a “Permanent Vacation” sono trascorsi dieci anni e la situazione è decisamente cambiata. Il viaggio, come è inteso in “Easy Rider”, è un mezzo di libertà e soprattutto di ricerca del nuovo, dell’America più autentica nei confronti dello squallore della società ufficiale e borghese. Invece con Jarmush siamo già negli anni ’80: alcuni sogni sono tramontati e resta invece la crisi dell’individuo e la sofferenza verso un presente che offre ben poco di soddisfacente. Il viaggio diventa soprattutto la ricerca di se stessi in un altro luogo che possa offrire gli giusti stimoli. Il movimento da un luogo all’altro si accompagna spesso col movimento riflessivo del proprio animo, che a volte è di crescita, ma altre volte determina solo la consapevolezza che si tratta di un “Falso movimento”, quello che darà il titolo ad un importante film di Wenders (1) e che significa movimento che ritorna su se stesso, come un cerchio nel quale si ritorna nello stesso luogo dal quale si è partiti, come se non fosse successo nulla. Metafora dei fallimenti dell’animo umano e di quelle illusioni tipiche degli anni ’60: così inteso il movimento in sé possa risolvere tutti i problemi.
L’influenza di Wenders sul giovane Jarmush è fortissima. Così come l’incitamento a proseguire col cinema e l’aiuto concreto offertogli. Il regista tedesco aveva fin dall’inizio creduto nel talento di Jarmush e contribuito alla produzione e distribuzione di “Permanent Vacation” grazie alla sua Gray City Film. Qualche mese dopo mise a disposizione di Jarmush tutta la pellicola avanzata dal suo film “Lo stato delle cose”, ritenendo che il promettente regista americano volesse girare un film corto. Jarmush invece si presentò all’appuntamento con Wenders con una storia delle durata di 30 minuti, che poi, in un secondo momento, fece diventare della lunghezza di un lungometraggio!
Il primo vero road movie
Quest’idea, della quale Jarmush era profondamente innamorato, apparve subito di difficile realizzazione per mancanza di fondi. Il nuovo film, “Stranger than Paradise”, potè uscire infatti solo nel 1984. Ed è un vero e proprio road movie. Dopo una prima parte ambientata all’interno di un appartamento a New York, troviamo i tre personaggi, due uomini e una donna in giro per l’America, da New York a Cleveland e poi in Florida.
Come nasce l’idea di intraprendere un viaggio tra i due amici, Willie e Eddie (la ragazza si trovava già a Cleveland)? Attraverso questa semplice conversazione:
– Ho voglia di andarmene da qui per qualche giorno e vedere qualcosa di diverso.
– E dove andremo?
– Non lo so.
Dunque vedere qualcosa di diverso senza sapere cosa. Senza le forti motivazioni che spingevano sulle loro moto Bill e Wayt. Non ci sono più gli eroi di “Easy Rider”, che percorrono in moto le strade dell’America alla ricerca di nuove frontiere, di nuovi spazi, di nuove persone da conoscere e di nuove emozioni. Resta ora la generazione dei Willie e degli Eddie, che non si pone sulla strada alla ricerca delle nuove emozioni che l’America potrà offrire. Al contrario qui il ritmo del road movie non è più un “andare verso”, ma un “fuggire da”. Fuggire da una realtà sempre più ostile e deludente per andare verso l’indefinito, l’indifferenza, l’abbandono. Per poi magari ritrovare la medesima solitudine e incomunicabilità:
– E’ incredibile – dice Eddie – Ogni posto sembra uguale agli altri.
– E ora te ne sei accorto? – E’ la risposta di Willie.
Road movie dunque, come si è detto, non come un andare verso, ma come un fuggire da: innanzitutto da se stessi, dalla grande delusione del sogno americano, che nei termini immaginati e vissuti da Willie non potrà mai realizzarsi.
Questo tema particolare del viaggio che non porta da nessuna parte, perché tutti i luoghi e le persone sono in definitiva sempre uguali vene citato in uno dei film successivi, “Dead Man” (1995). In questo film in realtà il viaggio ha un suo significato profondo e porta effettivamente verso qualcosa di molto diverso. Eppure anche in quest’opera emerge un breve riferimento al “falso movimento”. L’indiano che accompagna William Blake (Johnny Depp) nel suo viaggio/fuga fa una riflessione sulle città americane di fine ‘800. In tale riflessione il concetto di diversità/identità è espresso dal colto indiano in un modo più mediato e sofisticato che altrove, allorché dice di aver girato per molte nuove città dell’America e di aver incontrato sempre le medesime persone: “Ogni volta che arrivavo in una nuova città i bianchi vi avevano già trasferito la loro gente. In ogni nuova città la gente era la stessa della città precedente. E io non riuscivo a capire come facessero a spostare una città così velocemente.”
“Dead Man”
Ma naturalmente il movimento non è tutto “falso”. Al contrario: il vero movimento è quello che produce il vero mutamento ed è l’essenza del cinema di Jarmush. Tanto che il regista sente più volte il bisogno di renderlo visivamente, anche nella maniera più ovvia ed immediata, già nel titolo di alcuni film, come “Permanent Vacation”, del cui senso abbiamo parlato, e come “Mystery Train” (1989).
Oppure in alcune immagini dei titoli di testa o di coda: “Mystery Train” si apre con l’immagine del treno che si porta verso Memphis e che ospita una coppia di giovani turisti giapponesi in pellegrinaggio musicale verso i luoghi “sacri” di Elvis Presley. L’immagine del treno si alterna ai credits, che a loro volta sono accompagnati da tipico suono del treno in corsa. La stessa modalità troviamo nei titoli di coda ove notiamo che il treno si muove nella direzione opposta: il senso del movimento da e per è reso nella maniera più efficace possibile.
Anche “Dead Man” (1995) inizia con l’immagine delle ruote del treno in corsa. Ma ancor prima del treno, la prima immagine che lo spettatore vede è una significativa didascalia da Henry Michaux, che evoca subito, con l’uso del verbo “to travel” la centralità del viaggio, del movimento: “It is preferable not to to travel with a dead man” . Il treno conduce il protagonista (Johnny Depp forse nella sua migliore interpretazione in assoluto) in una cittadina dell’Arizona, ove dovrebbe essere assunto come contabile, secondo quanto assicurato da una lettera di assunzione. In primissimo piano le rotaie sfrecciano sui binari, e più volte riappaiono sulla scena in un montaggio quasi convulso che le alterna all’immagine dell’interno del vagone.
Ove si trova seduto un uomo del tutto diverso dagli altri viaggiatori: viene dal nord e indossa un vestito che sembra bizzarro agli altri, tutto quadrettato, cappello nero e un ampio borsone. Siamo alla fine dell’’800 e l’uomo si chiama William Blake (Johnny Depp porta il nome del celebre poeta inglese, del quale il film abbonda di fantastiche citazioni). Blake/Depp trascorre il tempo ad osservare gli altri viaggiatori e a guardare il paesaggio desertico fuori dal finestrino. La scena del treno dura circa dieci minuti: i tempi dilatati e lenti ai qual Jarmush ci ha abituati, ma sempre pieni di elementi significativi. Dieci minuti tra le immagini e il rumore delle rotaie e i silenzi pieni di curiosità dell’interno del vagone. Silenzi rotti soltanto dalle improvvise affermazioni del macchinista,che, lasciata per un istante la caldaia della locomotiva, prende posto proprio di fronte a Blake e declama versi dal sapore di morte. La morte che è già nel titolo del film e che informerà di sé l’intera storia/viaggio verso il nulla o, se si vuole, viaggio iniziatico verso un nuova vita. Perché le immagini del treno in movimento dei primi dieci minuti di film danno non solo il senso del “vero” movimento intrapreso volontariamente dal protagonista per raggiungere il suo lavoro (che non troverà), ma sono anche la metafora di quello che sta per accadergli. Cioè un lungo viaggio/fuga al quale sarà costretto.
Questo senso del movimento volontario e verso una meta precisa che, nelle intenzioni del protagonista, dovrebbe dargli l’opportunità di una nuova vita, forse non è mai così netto e diretto come in “Dead Man”. Dalla fredda Cleveland, ove Blake ha lasciato i genitori morti e la ragazza che lo ha abbandonato, fin nella calda Arizona. Viaggio in treno che è premessa e metafora del vero viaggio che Blake farà dopo aver appreso che il promesso lavoro non c’è e dopo essere stato ingiustamente accusato di un omicidio in realtà non commesso. Un viaggio che, al contrario di quello iniziale in treno, è un movimento non voluto, ma obbligato. Una vera e propria fuga che trasforma subito il film in uno dei road movie più affascinanti della storia del cinema.
Come sempre in Jarmush, il viaggio è fisico e soprattutto dell’animo: in questo caso verso la morte già evocata dal titolo del film. Nel corso di questo viaggio Blake ha la fortuna di incontrare un indiano, chiamato Nessuno (Gary Farmer), in certo senso “indipendente” dalle varie tribù, che gli racconta la sua storia. Anche questa è una storia di viaggi e spostamenti coatti: è stato portato per lungo tempo in Inghilterra in semi-schiavitù, ove però ha conosciuto e approfondito la cultura europea. E poi di nuovo, libero, in America. Assistiamo dunque ad un rovesciamento (non sarà l’unico) dello stereotipo che vuole il bianco colto e Intraprendente rispetto all’indiano rozzo e incolto. Qui l’indiano ne sa di più del bianco ed ha tanto da insegnargli. Il cinema “indipendente” di Jim Jarmush – che sempre resterà tale – si manifesta proprio attraverso il rovesciamento degli stereotipi del cinema classico hollywoodiano. Non solo la superiorità culturale dell’indiano rispetto al bianco, ma anche il rovesciamento del genere western classico, che porta il film ad essere in realtà un anti-western, innanzitutto attraverso il bianco e nero che cancella di un solo colpo decenni di film fondati su una standardizzata tavolozza cromatica. Ma anche la creazione da parte di Jarmush del protagonista non eroe, ma anti- eroe, uccisore dei suoi nemici suo malgrado, solo per difendersi e sopravvivere, ma il cui destino è scandito dal suo viaggio di avvicinamento alla morte, preannunciata già nel titolo del film. Un viaggio reso ancora più struggente dal costate accompagnamento della chitarra di Neil Young, che “è diventata un personaggio del film, controcanto del protagonista Johnny Depp.” (2)
Proprio questo rovesciamento concettuale a favore degli indiani rispetto ai bianchi fu l’elemento che entusiasmò e convinse, fin dalla lettura del copione, Johnny Depp ad accettare la parte, anche con un budget più ridotto del solito: l’attore, che sul bicipite ha tatuato un capo cherokee, ha trovato nel personaggio di Blake in Dead Man la possibilità di rendere omaggio alle sue origini indiane.
Il movimento volontario: “Broken flowers”
Come abbiamo visto, se il movimento (il più delle volte nella versione del viaggio) è la caratteristica fondamentale del cinema di Jarmush, esso però si può distinguere in movimento voluto e cercato e in movimento obbligato, a cui un personaggio è costretto dalle circostanze o dalla volontà altrui dalla quale non sempre ci si può sottrarre.
“Broken flowers” (2005) , oltre ad essere un film meraviglioso, è quello che forse illustra meglio di ogni altro questa voglia di andare in cerca di qualcosa. In questo caso il qualcosa è di estrema importanza ed induce il protagonista, l’eccellente Bill Murray, a vincere la propria pigrizia, la propria immobilità e vocazione alla “permanenza” dovuta all’età matura e al proprio carattere, per intraprendere un viaggio faticoso, in quattro diverse città lontane l’una dall’altra in quattro angoli degli States.
Don è una persona agiata, vive in una bella casa, ha un lavoro molto redditizio nel campo dei computer ed ha trascorso la propria vita facendo il playboy. Ha avuto moltissime donne e la cosa gli ha procurato molta soddisfazione ed autostima. Ma da un po’ di tempo questo tipo di vita comincia ad essere meno funzionale ad un ultracinquantenne quale egli è ormai. Don comincia a porsi molte domande sul senso della propria vita, sul proprio passato e sul suo futuro. Un senso di noia mista a malinconia si impadroniscono di lui e quasi lo immobilizzano a volte impedendogli perfino di alzarsi dal suo divano davanti alla TV, ove vede ripetutamente il suo film preferito, guarda caso il “Don Giovanni” di Alexander Korda! E in un’altra occasione lo vediamo sempre seduto sul solito divano ad ascoltare musica e a sorseggiare champagne, brindando probabilmente alla sua solitudine.
Vive con la sua ultima fiamma, Sherry (Julie Delpy) che ha preparato le valige per andarsene via e glielo comunica in modo alterato aggiungendo di non voler più vivere con un playboy ormai immobile e sulla via del tramonto. Vedendola avviarsi all’auto, Don è incapace di dire altro che il suo nome.
Eppure quella vita, che ha preso la strada della monotonia e della noia esistenziale, riceve un improvviso scossone dall’arrivo di una lettera anonima in busta rosa e con i caratteri rossi di una macchina da scrivere. La lettera è di una delle sue ex fiamme, che gli comunica di aver avuto, dalla relazione con lui, un figlio, oggi ventenne, che si è voluto mettere sulle sue tracce. Don confida il tutto a Winston, il suo vicino ed amico, che ha l’hobby del detective ed è non privo di capacità e di felici intuizioni. Secondo Winston Don deve fare la lista delle donne da lui avute in passato poco più di venti anni prima, tutte quelle che potrebbero essere la madre di suo figlio, rivederle, trovare indizi e così arrivare al ragazzo.
Don mostra di essere molto riluttante a smuoversi dalla sua apatia. Ma in realtà l’arrivo della lettera rosa ha smosso qualcosa nel suo animo. E quando il suo amico detective a sorpresa gli porta il piano di viaggio, i biglietti aerei delle varie località, le auto affittate e gli hotel prenotati, le carte stradali con le direzioni da seguire per arrivare alle abitazioni delle sue donne di un tempo, e perfino un CD da ascoltare in auto nei vari spostamenti, a Don non resta altro da fare che iniziare il suo pellegrinaggio nelle quattro diverse località americane. Tante sono le possibili madri, più una quinta che però è morta.
Don inizia dunque questo volontario movimento e il film diventa subito decisamente l’ennesimo road movie targato Jarmush. E, come nei road movies precedenti, esso è anche l’occasione per mostrarci un’America ben lungi dall’essere da cartolina illustrata: le quattro località visitate, delle quali il regista ritiene del tutto inutile dirci i nomi, sono diverse e lontane tra loro, e riflettono la visione di Jarmush dell’America: paesaggi malinconici e una varia umanità accomunata dalla disillusione del sogno americano.
E, per ciò che riguarda il protagonista, come sempre il movimento non è solo uno spostamento da un luogo a l’altro, ma è un movimento che smuove qualcosa di profondo dell’animo. Per Don si rivela una rivisitazione del proprio passato, un fare i conti con se stesso, con quello che è stata la propria vita, con i personaggi che la hanno accompagnata e in qualche modo arricchita. Proprio per questo è un viaggio un po’ malinconico, in qualche caso una vera e propria “recherche du temps perdu”, che lascia una traccia triste e a volte perfino straniante. Ma la posta in gioco del movimento è molto alta: trovare il proprio figlio vuol dire dare un senso diverso alla propria vita ed una direzione nuova fino a quel momento insperata. Don è consapevole che il suo viaggio può portargli questo risultato ed anche quando si rende conto del fallimento della sua ricerca e ritorna a casa, con caparbietà pensa che sarò proprio il figlio che prima o poi verrà a cercarlo. Come minacciato, ma in realtà, nella sua visione, promesso nella lettera anonima,
In questo caso il ritorno al punto di partenza senza risultati apparenti non configura un “falso movimento”. Don è cambiato ed ora ha uno scopo nella sua vita e pensa di vedere in ogni ragazzo che incontra il possibile figlio arrivato in città sulle sue tracce. Creando anche dei grotteschi malintesi, atraverso i quali Jarmush, come in ogni film, arricchisce l’ordito anche drammatico con un sottile senso di umorismo.
“The limits of control”, il film fantasma
Un altro eccezionale road movie è “The limits of control” (2009). Un film fantasma nel nostro Paese, dove non è mai approdato. Un vero peccato aver privato lo spettatore italiano del piacere di vedere un film straordinario, unico nel suo genere, ricco di situazioni interpretate da attori eccellenti che il protagonista, che viene semplicemente chiamato Lone Man/l’uomo solitario (Isaach De Bankolé ) incontra sul suo cammino.
Per questo siamo stati orgogliosi di aver trovato il film all’estero e di averlo proiettato, assieme ad altri undici film fantasma, nella rassegna annuale della nostra Rive Gauche nell’ambito di “Estate fiorentina 2017”.
Quello descritto nel film, , è un movimento solo in parte volontario. Lone Man è un killer di professione che ha un appuntamento di lavoro all’aeroporto di Parigi con due uomini che gli conferiscono l’incarico di uccidere un personaggio di grande rilievo. Ma la prudenza dei due mandanti, necessaria in questi casi, gli impedisce di andare direttamente al compimento della sua missione: dovrà passare attraverso una serie di incontri che gli forniranno altrettanti indizi, in una specie di gioco dell’oca che dovrà gradatamente portarlo al traguardo.
Comincia dunque il viaggio del Lone Man, che avrà come teatro la Spagna, prima Madrid, poi a Siviglia in treno, poi Almeria e infine un piccolo centro vicino a quest’ultima città. Ma, a differenza che negli altri film, il viaggio, almeno apparentemente, non porterà a mutamenti decisivi nell’animo del protagonista, il quale è un professionista e rimane sempre imperturbabile qualsiasi cosa accada, con l’unica preoccupazione di trovare, nelle varie tappe del suo peregrinare, le persone giuste che gli forniscano le informazioni necessarie per avvicinarsi alla meta, ossia all’assassinio che deve compiere.
In tal modo lo spettatore si rende conto che il road movie a cui sta assistendo assume le sembianze di un vero e proprio thriller, dagli esiti incerti, cadenzato dagli incontri con gli informatori che avvengono nelle varie località verso le quali Lone Man viene mandato ad ogni incontro precedente.
A Madrid soggiornerà in un appartamento situato in un condominio fatto di torri circolari. Per incontrare i suoi interlocutori si reca al bar prestabilito e ordina due caffè in due tazze. Perché? E’ una sua abitudine oppure è un altro rituale che rende possibile il suo riconoscimento da parte di chi è stato incaricato di fornirgli le informazioni sulla prossima tappa? Altro rituale: al tavolo del bar con ognuno dei suoi interlocutori che di volta in volta devono contattarlo, avviene uno scambio di scatole di fiammiferi. E ogni volta, in quello consegnato a Lone Man si trova un piccolo foglietto di istruzioni in codice, che lui legge, memorizza e poi ingerisce assieme al caffè per non lasciare alcuna traccia.
Chi sono i suoi occasionali interlocutori? Quella che si presenterebbe più piacevole è la ragazza (Paz de la Huerta) che Lone Man ritrova al rientro nell’appartamento di Madrid, e che gli appare completamente nuda e disposta subito a fare sesso. Lone Man dichiara che, pur essendo attratto, non è disposto a fare sesso mentre svolge il suo lavoro. Lo spettatore comprende che si ha a che fare con un vero professionista. Che tra l’altro diffida di tutti e di tutto, e per questo impedisce ai suoi interlocutori anche di usare il cellulare (distruggerà anche quello della ragazza nuda), o di avere contatti con altri mentre sono con lui.
Tutti gli altri incontri avverranno al tavolino di un bar, sempre davanti a due tazze di caffè, secondo il rituale stabilito, che di volta in volta, nelle varie località della Spagna, porta al riconoscimento della persona incaricata di fornirgli le informazioni che lo condurranno alla meta successiva, fino alla meta finale.
E ciascun segreto informatore si esprime cripticamente attraverso massime o frasi filosofiche, come “La realtà è arbitraria”, “Ogni cosa è soggettiva”, “Chi pensa di essere più grande degli altri deve andare al cimitero”, “La vita non ha valore”.
“The limits of control” è dedicato al film di John Boorman “Point Blank”, ma sicuramente è influenzato da altre opere come “Il samurai” di Melville e “Professione Reporter” di Antonioni. Anche quest’ultimo è un road movie che ha come scenario la Spagna di Barcellona e dell’Andalusia, anche se, rispetto al film di Jarmush, è concepito in maniera decisamente opposta, ove chi viaggia in realtà tenta di fuggire il proprio riconoscimento e la morte, mentre in “The limits of control” chi viaggia va verso il compimento di una propria missione che è quella di dare la morte.
Il film è stato molto amato, ma anche molto odiato da una piccola parte della critica americana. In realtà quelli che sono apparsi ad alcuni dei difetti, sarebbero invece, a nostro giudizio, da valutare come dei pregi di grande valore. A cominciare dalla mancanza di una trama rigorosamente definita, in un film ove invece l’indefinito è una delle più valide cifre stilistiche, e dove, d’altra parte, anche lo stesso obbligato vagare del protagonista dalla grande città alla città morta a al deserto della parte finale del film non è altro che un progressivo passaggio dal definito all’indefinito. Si aggiunga poi la graduale fantastica costruzione del personaggio del protagonista-killer, attraverso elementi di caratterizzazione che si accumulano progressivamente: veste in maniera impeccabile eleganti abiti di seta di vari colori (in prevalenza blu e marroni); lo vediamo più volte praticare interminabilmente il “tai chi”, col quale puntualmente apre ogni sua giornata, indizio della sua simpatia per il mondo orientale; parla pochissimo, anche perché il lavoro che svolge richiede meno parole possibili. A Madrid lo vediamo entrare più di un volta al Museo Reina Sophia e soffermarsi solo su due o tre quadri che attraggono la sua attenzione. Per arrivare poi alle brevi, ma veramente significative storie, dei vari personaggi, anch’essi senza nome (interpretati da grandi attori come Tilda Swinton, John Hurt, Gael García Bernal ed altri), che Lone Man deve incontrare sulla sua strada per avere gli indizi che lo porteranno alla sua meta.
Conclusioni
Ci siamo sopra soffermati su quelle che sono state, a nostro giudizio, le tappe più significative della poetica del movimento nel cinema di Jim Jarmush. Per brevità di spazio abbiamo tralasciato altri film che pure non sono affatto estranei a tale contesto. Si prenda ad esempio “Down by law” (1986), nel quale tutta la seconda parte è caratterizzata dal viaggio/fuga dei tre protagonisti dal carcere al nulla, con la significativa scena finale nella quale due degli evasi si trovano di fronte ad una biforcazione della strada e decidono di prendere ognuno una via diversa.
E “Mystery Train” (1989), del quale abbiamo fatto solo cenno al treno presente nei titoli di testa e di coda, ma che in realtà meriterebbe ben altro approfondimento, per la ricchezza di temi trattati nei tre episodi tra loro intrecciati, per il surrealismo, così presente nella prima parte della filmografia del regista, per il raffinato senso dell’umor che pervade quest’ennesimo film del viaggio.
Un po’ fuori dalla tematica di queste note è “Ghost Dog” (1999), ove il protagonista, interpretato da Forest Whitaker, sceglie deliberatamente di non muoversi dalla terrazza dove vive e di affidare all’andirivieni dei piccioni viaggiatori la comunicazione col mondo esterno e in particolare con il malvivente che gli ha salvato la vita e col quale si reputa in debito di riconoscenza perpetua, secondo il codice dei Samurai al quale crede ciecamente.
Il più recente “Solo gli amanti sopravvivono” è un film nel quale Jarmush rivisita a modo suo, come è solito fare, un genere, quello Horror e post-gotico, rovesciandone le logiche e le regole. La coppia di vampiri del film, dai nomi significativi di Adam and Eve, non terrorizza gli esseri viventi, ma ne è terrorizzata. Per tutto quanto di male nel mondo sono capaci di fare gli uomini, fino al punto addirittura di inquinare il sangue di cui i vampiri hanno bisogno per nutrirsi. Ecco perché paradossalmente preferiscono il sangue conservato in laboratorio perché sanitariamente controllato. I due vampiri sono persone estremamente colte, più colte degli uomini medi dei nostri tempi da loro definiti paradossalmente “zombie”, ed hanno scelto di vivere uno a Detroit e l’altra a Tangeri, e per questo spesso viaggiano per incontrarsi. Come si vede il capovolgimento dei valori del genere Horror è simile a quello del genere western di “Dead Man” (l’indiano molto più istruito e intelligente del bianco). Un processo simile di rovesciamento che troviamo anche in “Ghost dog” a proposito del genere Gangster story.
Mentre i viaggi dell’aspirante poeta Paterson (2016) hanno luogo quotidianamente nel bus che egli guida e gli servono come occasione per esplorare pezzi di umanità, linfa ispiratrice per le sue poesie.
Come si vede, la poetica del movimento caratterizza tutto il cinema di questo straordinario regista, che è stato capace, nel corso della sua carriera, di attrarre a sé anche eccezionali collaboratori, tra i quali non si può fare a meno di citare il grande direttore della fotografia, l’olandese Robby Müller che Jarmush ha condiviso con l’amico Wim Wenders e il direttore del montaggio Jay Rabinowitz, nonché tutti i musicisti, in genere suoi amici e talvolta membri della sua stessa band, che hanno accompagnato le storie da lui narrate.
Aspettiamo con curiosità le prossime tappe di questo lungo viaggio, che è il cinema di Jarmush, con qualche nuovo elemento da aggiungere alla sua poetica del movimento dei luoghi e dell’animo umano, alla sua consueta e caratteristica dilatazione dei tempi. Vedremo ancora all’opera la sua consumata capacità di trovare, proprio come Paterson, il personaggio del suo ultimo film, la poesia nel cuore della quotidianità sia essa capace di offrire la percezione di grandi cose o l’immagine di piccole cose.
Marino Demata
Note
1) “Falso movimento” è un film di Wim Wenders girato in Germania nel 1975 e ispirato dal romanzo di Goethe Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister. Un giovane scrittore parte dalla sua città natale per intraprendere un viaggio che favorisca la sua vocazione per la scrittura. Incontra molte persone interessanti, ma alla fine si ritroverà solo e di nuovo al punto di partenza.
2) Pier Cardinali – L’articolo è oggi in “Rockin’ in the free world” del 2010.
SAGGI
 LYDA BORELLI LA PRIMA DONNA DEL NOVECENTO
LYDA BORELLI LA PRIMA DONNA DEL NOVECENTO
di Maurizio Villani
La mostra
L’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini, nell’anno del suo decennale, celebra con una mostra monografica la figura della grande attrice Lyda Borelli, una delle più affascinanti interpreti italiane del primo Novecento: Lyda Borelli primadonna del Novecento. (Venezia, Galleria di Palazzo Cini a San Vio, dal 1 settembre al 15 novembre 2010).
La mostra, curata da Maria Ida Biggi, attraverso immagini, rari documenti d’archivio, una straordinaria galleria di fotografie stereoscopiche e con la ricostruzioni di suoi celebri costumi di scena e diversi ritratti di noti pittori dell’epoca, riporta alla luce la carriera dell’attrice, dai grandi successi teatrali sui palcoscenici d’Italia e del mondo, sino al trionfo cinematografico.
Il percorso espositivo ricostruisce la vita della Borelli, sia come interprete, sia come musa ispiratrice dei più grandi artisti e fotografi del primo Novecento. Come dice la brochure di presentazione della mostra, tra materiali inediti esposti, appartenenti alla famiglia dell’attrice, spiccano le lettere inviale a Lyda Borelli da note personalità della cultura e del teatro italiano. Tra questi, Sem Benelli, Roberto Bracco, Gabriele D’Annunzio, Arnaldo Fraccaroli, Guido Gozzano, Maria Martini, Ada Negri, Marco Praga, Rosso di San Secondo, Matilde Serao, Arturo Toscanini e Annie Vivanti. Un grande interesse rivestono le stereoscopie su lastra di vetro che documentano momenti di vita privata dell’attrice. La mostra fornisce un quadro della sua personalità. Come è stato scritto, “La Borelli incarnava perfettamente la modernità di inizio secolo. Era una donna a un tempo sensuale ed elegante, semplice e misteriosa, che amava dare di sé l’immagine di donna emancipata – guidava l’automobile e l’aereo – costruita attraverso il carattere dei personaggi che interpretava e alla forza del suo proprio nella vita reale, contribuendo a creare una icona liberty e di donna d’avanguardia. Tra le oltre 100 stampe originali visibili, c’è una foto in cui indossa una Jupe culotte, – la prima forma di pantalone femminile, nata a Parigi – durante la rappresentazione de ‘Il marchese di Priola’ al teatro Politeama di Firenze, il 24 febbraio 1911, diventando, per così dire, la madrina del nuovo indumento”.
Arricchisce la mostra un montaggio video, realizzato dalla Fondazione Cineteca Italiana di Milano, che presenta un excursus delle interpretazioni cinematografiche della Borelli, fondamentali nella costruzione della sua immagine di diva. Ai primordi del cinematografo, infatti, la carriera dell’attrice trova un naturale sbocco in questa nuova forma d’arte, in cui il suo stile di attrice e di donna si afferma definitivamente aprendosi a un pubblico più ampio. Attraverso le principali interpretazioni, il video documenta la intensa ma breve carriera cinematografica di Lyda Borelli.
L’Istituto per il teatro e il Melodramma, in concomitanza con l’esposizione, ha organizzato la rassegna Lyda borelli diva cinematografica, che ha messo in programma dal 4 settembre all’8 novembre 2017 le seguenti proiezioni di film: “Rapsodia satanica” (1917) di Nino Oxilia, con musica di Pietro Mascagni eseguita dal vivo; “Ma l’amor mio non muore!” (1913) di Mario Caserini; “Malombra” (1917) di Carmine Gallone; “Carnevalesca” (1918) di Amleto Palermi; “La memoria dell’altro” (1913) di Alberto Degli Abbati (Pellicola inedita musicata dal vivo. La proiezione sarà preceduta da una conferenza introduttiva di Daniela Curro sul restauro eseguito per l’occasione dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, con il sostegno degli eredi di Lyda Borelli).
La vita
Figlia d’arte, Lyda Borelli nacque a Genova nel 1887. Il padre Napoleone, la madre Cesira Banti e la sorella Alda erano attori. Cominciò la carriera in teatro, dove debuttò bambina ne I due derelitti. Dopo numerosi ruoli minori, nel 1904 fu scritturata come prima attrice giovane nella compagnia Talli-Gramatica-Calabresi e debuttò, nel ruolo di Favetta, ne La figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio. Nel 1905 recitò accanto ad Eleonora Duse nella Fernanda di Victorien Sardou, interpretando il ruolo di protagonista. Iniziò così una brillante carriera, contraddistinta da una crescente venerazione, sia da parte degli intellettuali sia da parte del pubblico.
Nel 1909 vestì i panni della principessa Salomè nell’omonimo dramma di Oscar Wilde; accanto a lei, Ruggero Ruggeri nel ruolo di Erode. La rappresentazione riscosse un successo straordinario, in Italia e all’estero, in particolare un Sudamerica. Il personaggio di Salomè consacrò definitivamente Lyda Borelli nell’Olimpo del teatro e la impose come icona liberty di stile e di eleganza.
La Borelli godette della duratura devozione di D’Annunzio, dell’ammirazione di Boccioni, che di lei disse “Se potessi studiare su quella donna potrei forse trovare quello che cerco”, e di quella di Gozzano, che le scrisse: “Voi che date alla ribalta una così intensa visione di vita, lasciate in chi v’accosta nella vita il vago sospetto di avervi soltanto sognata”. Matilde Serao disse della Borrelli che “Mai essere umano, mai essere femminile, seppe tramutarsi così profondamente nelle linee e nelle espressioni ”. Se tanti amici intellettuali la osannavano, ambivalente fu il giudizio di Antonio Gramsci, che criticò l’arte della Borelli come espressione del teatro commerciale e borghese, ma poi, occupandosi del nuovo fenomeno del divismo cinematografico, scrisse di lei: “La Borelli è l’artista per eccellenza della film in cui la lingua è il corpo umano nella sua plasticità sempre rinnovantesi” (Cronache Torinesi, 1913-1917, Torino, Einaudi,1980, pp. 853).
Donna da carattere forte e determinato, durante la Grande Guerra recitò per le truppe e scambiò lettere coi colleghi e gli amici intellettuali al fronte. Seppe imporre la sua immagine di donna emancipata, aperta alle esperienze d’avanguardia. Le fotografie dell’epoca ce la mostrano affiancata ai maggiori aviatori dell’epoca o alla guida di potenti automobili.
Il 1913 fu l’anno del debutto cinematografico di Lyda Borelli, la cui carriera che si concluse nel 1918 dopo l’interpretazione in totale di tredici film. In quell’anno sposò il conte e industriale Vittorio Cini e si ritirò per sempre dalla scena. Il marito cercò, senza riuscirvi, di fare sparire dalla circolazione tutti i suoi film. Dal matrimonio nacquero 4 figli: Giorgio (1918, morto in un tragico incidente aereo e a cui è dedicata la Fondazione di Venezia), Mynna (1920) e le gemelle Ylda e Yana (1924). Morì il 2 giugno 1959 a Roma ed è oggi sepolta, insieme al marito, nel cimitero monumentale della Certosa di Ferrara.
In questo stesso anno il conte Cini donò alla Casa di Riposo per artisti drammatici di Bologna la cifra di cento milioni di lire in ricordo della moglie: da allora la casa fu intitolata a Lyda Borelli.
Il cinema
Il film di esordio cinematografico della Borelli fu “Ma l’amor mio non muore!” di Mario Caserini (1913). In un immaginario principato dell’Europa centrale, vive la bellissima Elsa Holbein, figlia del colonnello Julius che si uccide perché accusato ingiustamente di tradimento. Elsa, per quanto innocente, viene esiliata e trova rifugio in Riviera. Qui inizia a calcare le scene come cantante. Nel pieno del suo successo Elsa conosce il principe Massimiliano, che non sa della sua vera identità. I due si innamorano, ma durante una gita sul lago di Locarno, incontrano Stahr, il vero responsabile del tradimento imputato al colonnello Holbein. Stahr tenta delle avances con Elsa, viene respinto e si vendica lanciando accuse contro il principe, che è costretto a ritornare in patria. Quando Massimiliano torna a cercare Elsa, trova che si è avvelenata.
Il film ebbe un successo trionfale di critica e di pubblico. Come scrive l’Enciclopedia del cinema la Borelli “interpretò il suo primo ruolo cinematografico di femme fatale. Il corpo esile ma voluttuoso fasciato in morbidi drappeggi, l’incedere languido, i gesti lenti e ben studiati, ritmati su un tempo per la prima volta squisitamente cinematografico, costruirono subito lo stereotipo della diva, eterea e raffinata, che sarà ripetuto quasi identico in tutti i film che seguiranno”.
Sempre nel 1913, in copia con Mario Bonnard, Lyda Borelli girò “La memoria dell’altro”, per la regia di Alberto Degli Abbati. Il film racconta la storia di Lyda, affascinante aviatrice che è divisa tra la corte del principe di Sèvre e l’amore per il giornalista Mario Alberti. Dopo molte traversie Lyda e Mario si rincontrano e fuggono a Parigi, ma la felicità dura poco: Mario si ammala gravemente e muore; Lyda cade in miseria e trova aiuto presso un gruppo di apaches, conquistati nel vederla danzare. Disperata per la morte dell’amato, anche Lyda si ammala e muore in una corsia d’ospedale.
Del 1914, per la regia di Carmine Gallone, è “La donna nuda”, adattamento di un celebre lavoro di Henry Bataille, in cui un pittore di scarsa qualità diventa celebre grazie al ritratto della modella divenuta sua moglie. Nel film la Borelli “impose e perfezionò i movimenti ‘serpentini’, l’uso enfatico del corpo e dello sguardo in una recitazione volutamente artificiosa, lontana da intenti realistici” (Enciclopedia del cinema).
Con lo stesso regista la Borelli girò nel 1915 due film. Il primo, “Fior di male”, tratto da un soggetto di Nino Oxilia, racconta la storia di una ragazza madre, costretta alla prostituzione ed ad abbandonare il figlio, che poi ritrova in circostanze drammatiche. Costui, non sapendo chi sia quella donna che lo va cercando, accoltella la madre, credendola una spia della polizia.
Nel secondo, “La marcia nuziale”, Lyda Borelli interpretò Grazia de Plessans, una giovane aristocratica che, abbandonati gli studi in convento, si innamora di Claudio Morillot, maestro di musica che le dà lezioni private. La famiglia si oppone fortemente a questo legame e i due si danno alla fuga. Vivono poveramente fino a che un’amica di Grazia fa assumere dal marito, il banchiere Lachatelier, Claudio, il quale, per corrispondere a un desiderio di Grazia che vorrebbe un pianoforte, ruba del denaro a Lachatelier. Grazia è allibita per questo atto e finisce per accettare la corte del banchiere, che le propone di fuggire con lui. Ritorna però da Claudio e, mentre questi suona al piano La marcia nuziale, si suicida con un colpo di pistola.
Ancora per la regia di Carmine Gallone, dalla commedia La Phalène (1913) di Henry Bataille, la Borelli interpretò nel 1916 con André Habay “La Falena”. Nello stesso anno girò “Madame Tallien”, di Enrico Guazzoni (1916): una rievocazione della rivoluzione francese in cui la storia d’amore tra la Marchesa Teresa di Fontenay e il giovane giornalista Jean Guery si inquadra negli ultimi tempi del Terrore giacobino. Le cronache dell’epoca sottolinearono la grande efficacia delle scene che rappresentano la festa della Dea Ragione, le sedute della Convenzione con la condanna a morte di Robespierre e il suo corpo moribondo trascinato alla ghigliottina ed elogiarono le ottime interpretazioni di Lyda Borelli (Teresa), Amleto Novelli (Tallien) e Renzo Fabiani (Robespierre).
 Nel 1917 Carmine Gallone girò “Malombra”, film tratto dall’omonimo romanzo (1881) di Antonio Fogazzaro, interpretato tra gli altri da Lyda Borelli (Marina di Malombra), Amleto Novelli (Corrado Silla), Augusto Mastripietri (Conte Cesare), Scrive Mariann Lewinsky nella Scheda di presentazione del film al Cinema Ritrovato di Bologna. «“Malombra” risplende d’un sontuoso stile visivo e immerge il pubblico nell’incantesimo di magici paesaggi, d’un romantico sinistro castello e della spettacolare performance della diva Borelli. Posseduta da demoni interiori, Borelli dilata sguardi e gesti, oppure s’adagia su una barca tra cuscini e fiori, languida vittima e fatale Lorelei, il corpo circonfuso di un’aura lucente. Il primo rullo si chiude con una delle scene di maggior impatto dell’intero genere diva-film: Marina di Malombra/Lyda Borelli scioglie la chioma, si abbandona alla sua follia (o è lo spirito di Cecilia?), confonde il viso nelle onde dei capelli mentre lo sguardo allucinato la trasforma in una Menade, infine sviene e cade a terra».
Nel 1917 Carmine Gallone girò “Malombra”, film tratto dall’omonimo romanzo (1881) di Antonio Fogazzaro, interpretato tra gli altri da Lyda Borelli (Marina di Malombra), Amleto Novelli (Corrado Silla), Augusto Mastripietri (Conte Cesare), Scrive Mariann Lewinsky nella Scheda di presentazione del film al Cinema Ritrovato di Bologna. «“Malombra” risplende d’un sontuoso stile visivo e immerge il pubblico nell’incantesimo di magici paesaggi, d’un romantico sinistro castello e della spettacolare performance della diva Borelli. Posseduta da demoni interiori, Borelli dilata sguardi e gesti, oppure s’adagia su una barca tra cuscini e fiori, languida vittima e fatale Lorelei, il corpo circonfuso di un’aura lucente. Il primo rullo si chiude con una delle scene di maggior impatto dell’intero genere diva-film: Marina di Malombra/Lyda Borelli scioglie la chioma, si abbandona alla sua follia (o è lo spirito di Cecilia?), confonde il viso nelle onde dei capelli mentre lo sguardo allucinato la trasforma in una Menade, infine sviene e cade a terra».
Ancora nel 1917 Gallone realizzò “La storia dei tredici”, interpretato da Lyda Borelli e Ugo Piperno. Il film è tratto dal romanzo di Honoré de Balzac Histoire des treize (1833-39) in cui si narra di un gruppo di amici di diverse origini sociali, che si contraddistinguono per differenti ideali politici, visioni del mondo e obiettivi, ma che al tempo stesso sono legati tra loro da un patto non scritto di mutuo soccorso.
“Rapsodia satanica”, di Nino Oxilia (1917) è giudicato tra i più importanti film muti dell’epoca. Ispirato dal poema di Fausto Maria Martini (1915) racconta la storia di un’anziana dama dell’alta società , Alba d’Oltrevita (Lyda Borelli), che per ritornare giovane fa un patto con Mefisto (Ugo Bazzini) in cui si impegna a non innamorarsi. Amata da due fratelli, Tristano (Andrea Habay) e Sergio (Giovanni Cini), Alba rifiuta Sergio, che si suiciderà, e intende sposare Tristano. Ma a questo punto, saltato il patto, Mefisto torna per riprendersi la giovinezza di Alba. La colonna sonora è di Pietro Mascagni, primo celebre compositore a firmare una colonna sonora, sincronizzandola con le scene del film.
Nel 1918 Lyda Borelli, con Livio Pavanelli, Renato Visca, Gino Cucchetti, interpretò “Carnevalesca”, di Amleto Palermi. Nella brochure originale del film si legge: «L’azione di questo bouquet di quattro carnevali si svolge nel castello di Malesia. Il carnevale bianco mostra i giovani figli di un sovrano ed i loro cuginetti e cuginette che si divertono in giochi festosi e fantastici.
Gli anni passano. Luciano, erede della corona, si innamora di Lyda. Ed è il carnevale azzurro.
Ma quando si accorge che si cerca di strappare Lyda alla sua passione, rinunzia al trono e fugge con lei. La fuga del principe alimenta le ambizioni tra i cugini che aspirano allo scettro: si distruggeranno tra di loro. Ed è il carnevale rosso. Tra gli aspiranti vi è Carlo, che pensa di essere il prescelto, ma, temendo che il vecchio re possa cambiare idea e richiamare il legittimo erede, tesse un’insidia a Luciano e lo pugnala a tradimento. Ed è il carnevale nero.»
La carriera cinematografica della Borelli si concluse con la partecipazione a due documentari, girati nel 1918 e oggi perduti, di propaganda bellica commissionati dal Ministero delle armi e munizioni: “L’altro esercito” (intitolato anche “La leggenda di Santa Barbara”) e “Per la vittoria e per la pace!”.
IN RICORDO DI …
 VILLAGGIO SALUTA E SE NE VA
VILLAGGIO SALUTA E SE NE VA
di Francesco Saverio Marzaduri
Inventariare tutto ciò che Paolo Villaggio ha rappresentato nella storia dello spettacolo e del costume nazionale è impresa da far tremare le vene ai polsi. E alla sua dipartita, inevitabilmente, c’è chi si è diviso tra congedi semplici e commossi e chi non ha resistito a sciorinare sentimenti empatici di assortito ordine e grado, dalle reazioni ai commenti, dalle interpretazioni alle polemiche. Con l’ovvio risultato che tutti, indistintamente e chissà se per l’ultima volta, abbiamo detto ciascuno la propria su una personalità che nel bene e nel male ha lasciato un forte segno nell’immaginario collettivo. Da quasi mezzo secolo il milieu fantozziano è assurto a ritratto-etichetta del Paese, a grottesco simulacro di una realtà che avrebbe avuto tutto il tempo per concretizzare le pieghe di quell’Assurdo – letterario prima, cinematografico poi – e trascendere in esiti sociali e politici che forse neanche Villaggio aveva previsto, prima che le gerarchie aziendali, le poltrone in pelle umana, gli acquari in cui fluttuano gli impiegati assumessero proporzioni mostruosamente reali, al di là di ogni fantasia.
Se “corrosiva” è l’aggettivo con cui meglio si potrebbe identificare la sua arte, la sua opera e la sua vis, inappropriate risulterebbero le lacrime. E se negli ultimi tempi la presenza di Villaggio iniziava a farsi ripetizione sempre più bolsa e dolente, sbiadita fotocopia della zampata dirompente con cui il prestigiatore Kranz esplodeva dai boccascena di “Quelli della domenica”, è sufficiente l’abbondante pletora di lazzi e gag, smorfie e battute, aforismi replicati a oltranza dal piccolo schermo e recitati a menadito dai fan, a dire di una testimonianza unica. Ne fornisce prova lo sgangherato (dis)lessico entrato nell’uso comune (“vadi”, “eschi”, “batti… batti lei!” e via elencando); per tacere dell’appellativo “fantozziano” con cui l’Italia, sbugiardata in anticipo nei propri vizi e nelle proprie contraddizioni, non solo si è riflessa ma addirittura ha elevato a patrimonio culturale: l’altra faccia di quella bandiera umoristica, non meno paradossale, condivisa con gli altri due eponimi della risata, Totò e Albertone. Parafrasando Roy Menarini, invertendo il punto di vista, l’accesa passione protagonista degli ultimi giorni non può non costituire un’eredità importante – l’indelebile segno, anzi – di una cultura e un’identità che l’inestricabilità di talento e pochezza, estro e cialtronaggine con cui Villaggio carpiva (e ribaltava) le dinamiche psicologiche rendeva un tratto distintivo.
No, le lacrime non sono davvero la modalità più idonea a salutare un simbolo (eh, sì) quale Villaggio era. Il principale timore sarebbe di cedere al rovescio di quell’universo cattivista e irriverente, e rivalutare le ultime apparizioni: prove senili di una figura messa un po’ da parte da chi l’aveva tripudiato, e ormai segnata dalla vita, atte a rimarcare la fase in cui l’attore genovese – un po’ per paura della vecchiaia, un po’ per voglia di riderci sopra – esorcizzava il trapasso. Su di esse svetta l’inquietante performance del dentista Cagnano in “Denti”. Ma pure i fasti e nefasti di un’intera esistenza, nel monologo teatrale “Delirio di un povero vecchio” e nell’autobiografia “Vita, morte e miracoli di un pezzo di merda”, suonano come il ribaltamento di un’icona, a modo suo, rivoluzionaria. Nell’irruenza dell’esagitato quanto inetto prestigiatore Kranz troviamo una combinazione geniale di ciò che partorì la rivoluzione teatrale del XX secolo. E figlio di Gogol’ e di Kafka è il pavido impiegato Fracchia, il cui milieu burocratizio, a rischio di confonderlo con quello più noto, era già pronto per sublimare nell’alchimia di ambedue i personaggi e fondersi nella maschera italiana più rappresentativa dell’ultimo mezzo secolo, in cui l’azzeramento di ogni scampolo d’innocenza nel pubblico e nel privato è regola prima di un umorismo imprescindibile, e pure disturbante.
Forse ha ragione chi afferma che, per ciascuno di noi, non resta che costruire e motivare l’oggettivo e personale ritratto di ciò che ha rappresentato nella vita, slegato dal clown tragicomico che per riverbero o per premonizione ha denudato l’italiano medio nella propria storica inadeguatezza. Eppure, non si può far a meno di pensare che dietro quella “lavatrice della coscienza sociale” si celasse una personalità timida e schiva, innegabilmente sensibile, la cui debordante fame di successo fungeva da antidoto a una naturale insicurezza. Che di quella sfera-esempio per il Paese ha fatto la propria bandiera e, nel climax consumistico e paratelevisivo di massa, il prigioniero e la parodia (usa e getta come la valanga di cine-panettoni ante litteram che costella la sua filmografia), identificandosi col ruolo, facendo sì che lo spettatore facesse altrettanto e continuasse a farlo. Ciò non tanto perché la tempra scostante lo ha indotto a tenere a distanza la sfera privata dalle lusinghe della vanità, ma più che altro perché il potere della comicità – o meglio, l’autodistruzione della comicità – assurgeva a univoco stratagemma per svergognare gli altri, sublimare sé stesso e la propria creazione alla maniera dei più immortali fool. Ben prima di “Freak” Antoni, Villaggio aveva intuito che in Italia non c’è gusto alcuno ad essere intelligenti, sicché il pubblico medio necessita di un simulacro-spugna per misurarsi con egoismi e meschinità, miserie e codardie, e con un simile doppio farci i conti. Ed è curioso che “Fantozzi”, sul grande schermo, sia uscito lo stesso anno in cui lo scomodo intellettuale Pasolini veniva assassinato. Né si spiegherebbe altrimenti l’abitudine di Villaggio, negli ultimi tempi, di raccontare del proprio ego (ma fino a quanto vero?) arricchendo gli aneddoti di feroci particolari farseschi, spesso grevi e non sempre irresistibili come prima, per non nutrire riserve sulla sua tempra e rivalutarlo come essere umano lontano dalla persona.
Ma pure questo, forse, implica il mito che ci si crea e il parallelo con un universo che, piaccia o no, si fa bigger than life. Al pari (quasi) di un’imponenza wellesiana, Villaggio era (ed è) il detentore di un florilegio di capitoli e parentesi che ognuno è libero d’interpretare e associare come crede. Si potrebbe parlare del sodalizio musicale con l’amico De André, innesco per il suo talento letterario, o dell’esperienza da impiegato all’Italsider, origine di arcinoti organigrammi aziendali. O si potrebbe accennare ai suoi inizi radiofonici, speaker controcorrente per la rubrica “Il sabato del Villaggio”; o quando lo si scoprì irresistibile entertainer la volta in cui, sul palco per annunciare che il previsto dramma di Dürrenmatt era saltato, trasformò l’annuncio in uno show di successo, da cui – complice l’apporto di un giovane Maurizio Costanzo – sarebbero nate le sue maschere. E le partecipazioni ai Caroselli, al Festival di Sanremo come spalla per Mike Bongiorno, la sua presenza di beniamino nazional-popolare per la tivù commerciale in un Paese nel frattempo cambiato. Perfino la parentesi politica, quando tenta di candidarsi nelle file di Democrazia Proletaria e del Partito Radicale, e prima ancora del PCI, o la stessa longeva collaborazione per “L’Unità”, allo scopo di ricollocare l’autore (non il personaggio) in un’area, la politica, su cui da sempre insorgono perplessità. Per soprassedere su un privato fatto di difficoltà e rammarico, riconducibili a una personalità il cui genio si scontra con la megalomania, finché la maschera, prevalendo sull’uomo, non ne fa una figura delirante.
No, davvero non è con le lacrime che ci si deve congedare da Paolo Villaggio. E se lo spettatore continua, e incessante continuerà a fraintendere, scambiando il ruolo con l’interprete, giusto allora che il fiume in piena di cicalecci mediatici, sospeso tra il reale e l’artefatto, prosegua il suo corso. Senza (voler) capire che anche questo fenomeno è diretta conseguenza di un panorama, che Villaggio aveva già teorizzato e praticato, disperatamente incapace di godere di quei simboli del benessere inseguiti con altrettanta disperata determinazione. Un’attualità in cui, un po’ per gusto cialtronesco e un po’ per solida presa di posizione, redivive il dibattito intorno a Ėjzenštejn, il tentativo di chiarire la celebre battuta, la scelta se stare da una parte o dall’altra. E poiché tutti abbiamo il Villaggio in cui meglio rispecchiarci, chi scrive preferisce ricordarlo in una serie d’incontri avvenuti in momenti distinti. Il primo, nel 1998, al teatro Arena del Sole di Bologna dove l’attore – impegnato nel ruolo di Arpagone nell’adattamento di Strehler – si concesse ad un incontro col pubblico. Il secondo a Venezia nel 2000, dove il Nostro figurava nel cast di “Denti”, in concorso, e il sottoscritto riuscì a strappargli, oltreché l’autografo, i più salaci fuori onda. Il terzo tre anni dopo, di nuovo a Bologna, dove gli era dedicata una piccola retrospettiva: qui Villaggio, già conscia ripetizione di sé stesso, non perse occasione per una tiritera – ormai stucchevole nel suo tentativo di far ridere ancora – sulla “cagata pazzesca”. E sempre a Bologna l’ultimo, nel 2007 al teatro Dehon, in cui l’attore concesse una master class durante una pausa di “Serata d’addio”; qui gli rivolsi una domanda che affrontava tutto il Villaggio-pensiero, dai modelli narrativi a quelli cinematografici: a proposito dei primi, rimase sorpreso nel sentirsi chiedere del prediletto Céline, scrittore proverbialmente controverso, nichilista e di ben difficile affezione, dal quale discendeva, ancor più che da Gogol’, Dostoevskij, Čechov o Pirandello, lo spirito cattivista e sulfureo che animava Fantozzi. Ricordo la sua grande passione per la recitazione kabuki (“I sette samurai” era il suo film preferito) e, in fatto di cultura, il famoso aneddoto del poeta russo Evtušenko che, invitatolo a salire su un palco insieme ad altri nomi illustri della letteratura, maldestramente storpiò il suo cognome chiamandolo “Vigliacco”. Sulla realtà, si sa, la vince la leggenda.
Chi vuole saperne di più e desidera individuare le origini del genio. Chi si arena su fraintendimenti e opta per la solita etichetta, mal celando la pigrizia di non voler distinguere le due facciate (e anche questo appartiene all’eredità lasciata dal mito). Tuttavia, non si può non pensare, come scriveva Enrico Giacovelli, che il talento dell’interprete, ampiamente dimostrato al cinema, sarebbe potuto evolvere se non fosse stato inflazionato dalla maschera. Pur importante e doveroso, il riconoscimento di Villaggio come volto tragico per Fellini, che ne ha fatto uno dei propri conclusivi feticci onirici, suona come un tardivo omaggio che il discusso Leone d’oro alla carriera, consegnato nel ’92, ha consacrato restituendo all’interprete una seconda, breve giovinezza nel cinema d’autore, al fianco di nomi come Olmi, la Wertmüller, il Monicelli che già l’aveva diretto in “Brancaleone alle crociate”. E ancora Nichetti, Salvatores, Archibugi (per la quale ha impersonato un televisivo Don Abbondio). Pure, nel corale “Camerieri”, Leone Pompucci gli regala un ruolo su misura di maître vanesio e arrogante, che millanta improbabili ricordi nella ristorazione al servizio di celebrità, quando invece è un meschino e un fallito. Nel coacervo di titoli trascurabili, perlopiù rimasticature in camuffa della propria creatura, evidente traspare l’esecrabile pigrizia di un talento che cedeva al cattivo gusto, puntando alla cassetta più che non alla qualità. L’attore, e non l’autore, ebbe invece modo di dar prova del proprio estro nel cinema che contava, prima di abbandonarlo a lungo: a parte le collaborazioni insieme all’amico Gassman, è da menzionare “Sistemo l’America e torno”, dell’altrettanto dimenticato Nanni Loy, dove impersona un commendatore incaricato d’ingaggiare un promettente cestista americano di colore e convincerlo a trasferirsi in Italia, e dove il tentativo d’ingaggio si trasforma in un increscioso quanto formativo on the road, col protagonista tragicamente coinvolto nelle lotte delle Pantere Nere. A seguire, “Beati i ricchi” di Salvatore Samperi, in cui è il vigile Augusto; in “Non toccare la donna bianca” di Marco Ferreri, è un agente della CIA che fa scoppiare la guerra fra Toro Seduto e Custer nel cantiere delle Halles parigine; e ne “La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone” di Pupi Avati, è il truffaldino pappone Checco. Infine, a fianco del mentore Salce, piace ricordare l’edipico “Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno”, che racconta le vicissitudini e i tardivi turbamenti del trentaduenne “Didino”, alle prese con una madre esageratamente possessiva nei suoi confronti e il cui rapporto, quando il giovane decide di andar via, finisce per essergli fatale.
Tutti possiamo identificarci nel Villaggio che più ci aggrada. Provare simpatia, antipatia, o entrambe le cose, fantasticando magari che la sua morte non sia avvenuta. Che è mancato il nome, del quale si ha un ricordo distorto in quanto persona, laddove perdura il mito del personaggio, e in tal caso immaginare la dipartita come in uno dei suoi finali cinematografici. Chi preferisce pensare che Fantozzi sia in Paradiso, o il suo volo dirottato verso il Saṃsāra buddista, magari rinviato sulla Terra per mancanza di posti. Chi scrive opta per un duplice trapasso e a salire in cielo sia l’anima volutamente, genuinamente cattiva e all’Inferno, per aritmetico ossimoro, ci finisca il suo doppio scalognato. La maschera e l’interprete, ripensando anche all’epilogo del televisivo “Giandomenico Fracchia – Sogni proibiti di uno di noi”, in cui Villaggio, fedele al suo stile, riadattava il Walter Mitty di Danny Kaye. Con occhi ugualmente commossi, il Paese dà il proprio estremo, doveroso ringraziamento a qualcuno che forse non si aspettava un simile commiato, e chissà se lo avrebbe gradito; l’emisfero fantozziano continua indomito la propria leggenda. E a noi non resta che cantare come Ombretta Colli: Facciamo finta che / Tutto va ben, tutto va ben…
JEANNE, GLI OCCHI CHE (NON) SORRISERO
di Francesco Saverio Marzaduri
“Ogni volta che me la immagino a distanza la vedo che legge non un giornale ma un libro, perché Jeanne Moreau non fa pensare al flirt ma all’amore.”
FRANÇOIS TRUFFAUT
La sensualità non è una semplice componente di “Les amants”, uno dei primi titoli della Nouvelle Vague, ma il suo elemento basilare: sicché, quando il film esce, si dubita che possa ottenere il visto censura oltre i confini francesi. Si tratta del secondo lavoro realizzato da Louis Malle con l’allora compagna Jeanne Moreau, nel ruolo di un’impenitente adultera. Ugualmente però, nell’immaginario collettivo, non ci si è ancora separati dal fotogramma d’apertura di “Ascensore per il patibolo”, prima collaborazione tra i due: un primissimo piano sugli occhi malinconici e sommessi della protagonista al telefono che, come ne “La voce umana” di Cocteau, immediatamente catturano lo spettatore imponendogli di seguire per un’ora e mezza una figura solitaria – lei pure fedifraga – mentre si aggira tetramente per le vie di Parigi in cerca dell’amante, sulle note da brivido di Miles Davis. La consacrazione di Jeanne Moreau sullo schermo arriva a trent’anni, lei che nel cinema ci recita già da dieci e all’attivo ha già una ventina di titoli: in “Grisbi” di Becker, ad esempio, è la ballerina cocainomane che rivela al losco Lino Ventura il piano del vecchio Jean Gabin per la rapina all’aeroporto. Ma è Malle a cucirle addosso quell’allure da donna di mondo sensuale, energica e indipendente, dal fascino sottilmente cerebrale, e una bellezza dai tratti insoliti e marcati capace di resistere sessant’anni. Fino alla solitaria dipartita nel proprio appartamento di Parigi, nel bel mezzo di un’estate torrida e in un panorama ove la trasgressione, quale sinonimo di radicale mutamento culturale, è un quid destinato a essere soffiato via. Strani casi offre la vita: Jeanne viene a mancare lo stesso giorno di luglio in cui dieci anni prima moriva Michelangelo Antonioni, che la diresse ne “La notte” nei panni di Lidia, moglie infelice dello scrittore Mastroianni. Pure, la Francia saluta per sempre una delle proprie indelebili icone lo stesso mese in cui l’Italia si congeda da Paolo Villaggio. Nomi che, accostati, sono quanto di più insolito si possa immaginare; senonché il Caso, accomunandone la scomparsa a breve distanza, ne intreccia le figure nel comune ricordo, così come nel ’92 entrambi ricevettero il Leone d’oro alla carriera.
Spiccata antidiva per scelta, dall’incisività pari a quella di certe dive del passato, la Moreau incarna un’immagine di sensualità complementare alla bionda avvenenza di Brigitte Bardot dietro il cui sex appeal l’intero mondo fila: il suo è sinonimo di una disinvoltura intellettuale, esistenzialista e volitiva, dall’intelligenza acuta, profonda, sempre anticonformista. Non è casuale che ambedue siano chiamate a interpretare un’altra pellicola di Malle: lo spigliato “Viva Maria!”, che tuttavia non manca di qualche disappunto, malgrado il battage pubblicitario che ne accompagna la gestazione. A parte il citato “Ascensore per il patibolo”, risulta arduo però non coniugare quello sguardo inaccessibile, dalla sensualità matura e diretta e dall’indefinibile sorriso, al personaggio della libertina Catherine che Truffaut le regala in “Jules e Jim”. Amata da due uomini, che restano amici nel tempo nonostante il triangolo, Catherine è una femme fatale in cui incanto e tenerezza sovrastano tutto ciò che in genere esibisce il prototipo: a ricordarlo è il trattamento che infligge agli spasimanti, accordando volubilmente i favori ora all’uno ora all’altro, o escludendoli entrambi per un temporaneo capriccio. Come le sue azioni, quali dirigere la vettura su cui condurrà Jim a precipitare con lei nella Senna, senza rinunciare alla propria sorridente nonchalance. Catherine è l’incarnazione della misteriosa statua che ammalia i due uomini, la “donna ideale” dietro la cui aria sbarazzina non può che celarsi il presagio: il tourbillon da lei intonato alla chitarra in una celebre scena, che, come in ogni vicenda di amore giovanile “maledetto”, prelude all’improvvisa tragedia (non solo il suicidio, ma anche il rogo di vecchie missive degli ex amanti, che annuncia l’autodistruzione). Il medesimo tourbillon lo avrebbe cantato di nuovo, in compagnia di Vanessa Paradis, durante una delle ultime apparizioni in pubblico: inno-poetica di una bellezza segnata e ancora luminosa. Un’icona di “donna fatale” che funge da contraltare alla dark lady Eva nell’omonimo film di Losey, squillo d’alto bordo che fa perdere la testa a uno scrittore sino a ridurlo a uno stato di subornazione. L’esatto contrario della Christine de “Il treno” di John Frankenheimer, vedova in apparenza fredda e insofferente, prima di appoggiare la causa e proteggere (e invaghirsi di) Burt Lancaster.
Giacché, come qualcuno giustamente ricorda, è ozioso e scontato scrivere di un personaggio-simbolo quando viene a mancare, superfluo si fa il rovistare nella produzione cinematografica e televisiva in cui il volto di Jeanne Moreau ombreggia lo schermo, lungo praticamente l’intera storia del cinema. Sterminato è l’elenco di titoli, autori, interpreti, maestranze con cui l’attrice lavora, spesso in più d’una circostanza. Talora anche solo prestando la voce, il proprio suadente e inconfondibile timbro vocale reso rauco dal tabagismo, sufficiente a contraddistinguerne il mito. Per tacere del poliedrico contributo, eclettico ed instancabile, offerto come regista di due film (doveva dirigerne un terzo, con Juliette Binoche protagonista), documentari (l’ultimo dei quali incentrato su Lillian Gish), produttrice e scrittrice. Pure in televisione è chiamata a dirigere cinque episodi della serie “E.R. – Medici in prima linea”, salvo poi abbandonare il set durante il primo giorno di riprese. Infine, per due volte presidente di giuria a Cannes con vent’anni di intervallo tra l’una e l’altra, senza dimenticare l’aria di cinema respirata in privato come in pubblico, dal ménage con Tony Richardson (che la scritturò per “… E il diavolo ha riso” e “Il marinaio del Gibilterra”), all’unione con William Friedkin.
Jeanne Moreau è tante donne, di quelle che incontri nella vita o che sogni d’incontrare prima o poi. Quasi assenti i grandi personaggi che di solito attizzano le dive, se si esclude qualche lodevole eccezione (Margherita di Valois, Mata Hari, Sarah Bernhardt, Marguerite Duras), e forse per tale motivo poco incensata in proporzione a bravura e carisma, benché numerosi restino i riconoscimenti alla carriera. Semplicistico e riduttivo chiedersi quale grande cineasta ne sappia valorizzare al meglio talento e fascino. Molti suoi personaggi sono una fucina d’ispirazione per successive attrici (“Ogni volta che un attore recita, non si nasconde: si espone”, è un suo aforisma). Alcuni titoli da lei interpretati hanno significative influenze sulle generazioni di cineasti con cui in seguito Jeanne collabora, come in un continuum o in un cerchio che tende alla chiusura. “La notte” funge da modello d’ispirazione per Malle, Godard e Wenders, che la dirige per due volte (in “Al di là delle nuvole” al fianco dello stesso Antonioni). Ne “Il passo sospeso della cicogna” di Angelopoulos, l’attrice torna a recitare insieme a Mastroianni. E tra le prove “mature” degli anni Settanta, la Florence di “Mr. Klein” (ancora Losey) e quell’amaro saluto al cinema del passato ch’è “Gli ultimi fuochi” di Kazan. Nel conclusivo “Querelle de Brest”, Fassbinder “costringe” quella sfiorita bellezza a intonare la raggelante “Each Man Kills the Thing He Loves”: parafrasando qualcuno, tutti abbiamo (ancora) bisogno di quello sguardo. Tutti abbiamo bisogno d’amore. Poco importa se ognuno di noi (poi) uccide (solo) ciò che ama.
E ancora: Buñuel, De Oliveira, Vadim, Gitai, Varda e Peter Brook, Martin Ritt, Bertrand Blier, Peter Handke, Jean-Jacques Annaud, François Ozon. Ma non ci si può congedare da Jeanne Moreau senza ricordare chi l’ha definita “la più grande attrice del mondo”: il titano Welles, probabilmente il più abile a diffonderne il magnetismo oltre i confini nazionali. Che la impiega ne “Il processo”, offrendole il ruolo della conturbante vicina di casa del protagonista Josef K., prima di farne una perfetta Doll Tearsheet in “Falstaff” e, in “Storia immortale”, “umiliarla” splendidamente nella pantomima di una vecchia leggenda: figlia del socio in affari di Mr. Clay, morto suicida a causa dell’insolvenza di un debito col mercante, Virginie Ducrot si persuade che la mise-en-scène porterà alla fine di quest’ultimo e, per le trecento ghinee dell’antico debito, accetta di prestarsi a un ipnotico gioco di specchi.
Come non ricordarla, poi, nell’alter ego della celebre Catherine: la vendicativa Julie Kohler de “La sposa in nero”, cui Truffaut dà le sembianze di una figura all’apparenza imperturbabile, ma invasata dal desiderio-missione di punire quanti, per stupida e fatale leggerezza, procurarono la morte al marito il giorno delle nozze. La brama di vendetta è più forte di qualunque cosa, anche della morte (sebbene Julie conservi la propria etica, scagionando per telefono un’innocente), finché la donna, consegnatasi alla polizia, confessa i reati ma rifiuta di fornirne il movente, sapendo che in carcere avrà la possibilità di uccidere l’ultimo colpevole. Un archetipo che Tarantino avrebbe studiato e deliberatamente saccheggiato per “Kill Bill”, i cui toni sono però caratterizzati da una dose di violenza tanto esasperata quanto lontana dal modello di riferimento.
“Due cose non conoscono limiti, la femminilità e i modi di abusarne”, afferma sessantaduenne (e ancora affascinante) mentre allo specchio applica il rossetto alla futura killer Nikita-Anne Parillaud nella pellicola di Besson. Proprio questo prototipo di donna emancipata e femminista, spregiudicata e libertina, non comparabile ad alcun’altra, è la caratteristica che del mito-Moreau ora si piange. Destinata a volar via nel pieno di un’estate e di un panorama che sembrano trascurare i simboli della cultura e del costume che furono, lo stesso giorno in cui un altro poliedrico e intelligente artista ci lascia, Sam Shepard. Anch’egli, come Jeanne, emblema di un tempo inesorabilmente lontano, di cui, sempre più orfani, non resta che elaborare la memoria.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
 FILMMAKER ALLA RIBALTA: AGOSTINO VINCENZI
FILMMAKER ALLA RIBALTA: AGOSTINO VINCENZI
di Paolo Micalizzi
La passione per il cinema per Agostino Vincenzi nacque, come ricorda, alla fine degli anni 40- inizi 50 quando, per curiosità, incominciò a raccogliere spezzoni di pellicola che l’operatore del cinema “Arena” di Pesaro, che essendo all’aperto funzionava soltanto d’estate, buttava sulla strada dalla cabina di proiezione. Nell’ingenuità della sua adolescenza, ammette, sognava di portare nella casa, dove abitava con i suoi genitori, “frammenti di storie nuove, impresse nei fotogrammi di quella celluloide cosi maltrattata”. Frammenti che custodiva in una scatola di scarpe: Ma su questo Agostino Vincenzi, non è poi tanto sicuro perché , se non ricorda male, in quegli anni le scarpe forse non le aveva, figuriamoci la scatola. Quel che ricorda bene però è che chiese all’operatore come avrebbe potuto unire quei spezzoni di pellicola nella speranza di creare storie più lunghe e più belle. Con l’acetone fu la risposta dell’operatore , stupito per tanto interesse. Seppe che poteva comprarlo in farmacia: vi si presentò con una bottiglia di un litro chiedendo di riempirgliela. Il risultato è che, dopo aver atteso pazientemente a lungo, venne di colpo prelevato da due individui, cosi li definisce, e portato in questura sotto lo sguardo incredulo della gente incontrata durante il tragitto. Lì subì un lungo interrogatorio e trattato come un ragazzino pericoloso. Lui cercò di spiegare il motivo di quella richiesta di acquisto, ma ci volle il padre a toglierlo dai guai spiegando agli inquirenti la sua passione per il cinema. Che continuò nel tempo fino ad acquistare, a rate, una piccola cinepresa C8 Paillard dal negozio Pandolfi, il cui proprietario lo consigliò ad iscriversi al Cineclub Pesaro da lui stesso fondato a metà degli anni 50. Lo fece ed ebbero inizio le sue prime esperienze cineamatoriali.
Nel frattempo ebbe un forte stimolo alla sua conoscenza del cinema con la frequentazione della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro che prese l’avvio nel 1965 nella città marchigiana. Fu lì che scoprì il Neorealismo italiano assistendo ad una retrospettiva: ed ebbe occasione di incontrare direttamente registi, sceneggiatori e scrittori che hanno permesso di divulgare quel movimento nel mondo. “Era, dice, un universo che non conoscevo, un’enorme ricchezza di idee i cui messaggi, nonostante tutto, inducevano alla speranza per un mondo migliore. E tutto ciò ha inciso nella mia mente una traccia indelebile, che tanto ha contribuito al mio pensare il Cinema”. A tal proposito Agostino Vincenzi aggiunge: “Un ulteriore motivo di crescita e di inquietudine mi fu data dall’incontro con Michelangelo Antonioni il quale negli anni 60-70 è stato l’autore del cinema internazionale più discusso, più incompreso ed infine il più acclamato. L’opera di Antonioni ha la forza di nascere, di marcare il nuovo tempo e i suoi film non rappresentano più una società. Come aveva fatto il Neorealismo, ma più generalmente, l’esistenza dei messaggi. E’ la malattia dei sentimenti che interessa il Regista: l’aridità, la solitudine, l’incapacità di comunicare, di dialogare e al tempo stesso la disponibilità ai valori, al bisogno di riempire il vuoto con il calore umano”.
Agostino Vincenzi esplicita chiaramente che Michelangelo Antonioni è stato il regista che ha sempre guardato con grande interesse e dal quale ha tratto motivi per il suo percorso cinematografico “ pieno di dubbi e perplessità, come è logico che sia, ma tracciato con tanta passione e serietà, perché il cinema è una cosa seria”. Un percorso di filmmaker iniziato nel 1964, dopo essersi iscritto alla FEDIC nel 1963 diventando anche Consigliere Nazionale di quella Federazione nel biennio 1972-1974; e svolgendo intanto il lavoro di insegnante di Geometria Descrittiva e Arti Figurative Applicate nei Licei Scientifici. La sua formazione cinematografica si è arricchita nel tempo frequentando stages di approfondimento per la regia, sceneggiatura e fotografia cinematografica.
Il suo esordio come filmmaker è avvenuto nel 1964 con “Il tramonto”. Un’opera ispirata ad una poesia di Leopardi in cui racconta dell’incontro di un bambino che gioca sulla riva del mare con un anziano signore che lo invita a non crescere in fretta.
Fanno seguito poi altri quattro cortometraggi che si riferiscono a tematiche del suo “amato” Michelangelo Antonioni, fino ad arrivare nel 1968 ad uno che gli ha dato tante soddisfazioni essendo selezionato nel 1968 per il Concorso di Montecatini e successivamente in altri Festival ottenendo anche a quello di Teheran una menzione d’onore ed il premio del pubblico per l’emotività suscitata. Si tratta del cortometraggio “La stanza della nebbia” che è che è incentrato su una bimba costretta a vivere nell’isolamento di un casolare di montagna con i genitori rozzi e incapaci di comprenderla.
Evade da quella triste situazione con l’immaginazione attraverso delle visioni dove si mescolano stimoli fantastici, aspirazioni, ricordi tipici di un’età delicata nel passaggio tra infanzia e adolescenza, quando si fa più vivo il bisogno d’affetto , specialmente in un ambiente familiare incapace a darglielo. E vivo è il pericolo di un inaridimento sentimentali ed il sorgere di inibizioni che potrebbero condizionare in maniera deleteria tutta l’esistenza futura. Un racconto che nasce dalla sua esperienza d’insegnante in una scuola media di Sant’Agata Feltria dove casualmente gli era capitato fra le mani il diario di una ragazzina ,sua alunna, dove vi erano annotate forti sensazioni emotive. Secondo il critico Giulio Cattivelli si tratta senz’altro dell’opera più matura di Vincenzi ed una delle migliori apparse nel Concorso di Montecatini e pur rimanendo nel racconto qualche zona ambigua ed oscura, fatto inevitabile in un’opera del genere, l’insieme è notevole per vigore e felicità di intuizioni e dà l’impressione di una cosa seriamente pensata e realizzata con intelligenza e sensibilità. Circa il tema, il critico del quotidiano “Libertà” di Piacenza e collaboratore della Rivista “Cinema Nuovo”, annota che esso “ è svolto con molta finezza, con un linguaggio cinematografico preciso e moderno nel ritmo e nelle soluzioni, perfettamente aderente al non facile registro interpretativo e per certi risvolti addirittura psicoanalitico”. Un premio anche all’opera successiva: “Ellisse” che al Concorso di Montecatini del 1969 si aggiudica, nella sezione informativa, la Coppa AGIS attribuitagli per i notevoli pregi formali: una buona fotografia, e alcune sequenze di ottimo cinema grazie anche a un sapiente montaggio.
Il cortometraggio narra l’insoddisfazione permanente dei giovani d’oggi alla ricerca continua di un qualcosa di positivo che non trovano e non troveranno mai. Il tutto si svolge all’interno di un “comune” edificio fatiscente, sotto gli occhi di un ambiguo personaggio, che negli intenti dell’autore rappresenta una metafora del potere. Un corto sui problemi della coppia in una piccola città di provincia è in “Quel grigio colore del treno”(1977). Protagonista un architetto alle prese con la sua quotidianità fra moglie, amante e figlia. Per Luigi Serravalli, un critico molto attento alla produzione dei filmmakers Fedic, è “uno scompiglio strutturale che lascia qualche perplessità di lettura” e che “ si sofferma su valutazioni Architettoniche abbastanza curiose”. Dopo un documentario turistico per l’Azienda di Soggiorno di Pesaro dal titolo “Più cose per una sola vacanza”(1977), nel 1979 Agostino Vincenzi realizza “Il caso Francesco”, ammesso anch’esso al Concorso di Montecatini dedicato al cinema non professionale(il 30°).
Un’opera ambientata in una casa di rieducazione dove lui ne ha vissuto la quotidianità essendo stato inviato quale supplente annuale dopo che terminato il servizio militare si era accinto ad intraprendere il lavoro d’insegnante. Ricordando quell’esperienza, Agostino Vincenzi annota che nell’ambiente del carcere, dove aveva accettato l’incarico di insegnante dopo aver superato l’imbarazzo e dopo una profonda riflessione,” dopo aver preso una timida confidenza con l’ambiente e con i giovani detenuti che li ‘ospitava’, mi resi subito conto di non aver nulla da insegnare, ma piuttosto tanto da imparare: sguardi senza espressione alla vana ricerca di un punto di riferimento, alla ricerca di un affetto che non avevano avuto e che in quel luogo non avrebbero mai potuto sperare di avere”. Nel 1982 realizza “…E allora?, ammesso anch’esso al Concorso di Montecatini. Al centro del corto, tre donne: un’operaia, una direttrice d’azienda, una prostituta che, come in una seduta piscoanalitica di chiave femminista, si confrontano con la propria coscienza ed analizzano il passato, giudicano il presente, fanno progetti per il futuro. Franco Montini, critico cinematografico del quotidiano “La Repubblica” ed oggi Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, ebbe a rilevare: “ Ciò che colpisce subito nel film è l’estrema nitidezza e precisione della fotografia e dell’immagine, che testimonia della preparazione e dell’esperienza del suo autore”. Nel 2004 Agostino Vincenzi passa dalla pellicola alla realizzazione di cortometraggi con videocamera digitale. Ed inizia con “Rumori dalla memoria”, ammesso in Concorso nel 2005 alla 56^ edizione del “Valdarno Cinema Fedic”. In esso, dichiara l’autore, “narro frammenti angoscianti di episodi realmente avvenuti durante la seconda guerra mondiale, rivissuti con fredda lucidità dalla protagonista della storia, ma dilatati e deformati dallo sforzo emotivo di un lacerante racconto”.
Il gruppo scultoreo dell’artista pesarese Fernanda Paianini è poi il protagonista di “Le donne di Pesaro”(2006) che ne ritrae tutte le fasi di lavorazione. Segue, nel 2007, un cortometraggio intitolato “Titolo provvisorio” con protagonista Irene nel cui animo riaffiorano il radicato rapporto conflittuale con la madre musicista, intimamente persuasa dell’unità dell’Arte nella Musica che le si impone come ragione di vita al punto di dimenticare doveri ed affetti nei confronti della propria figlia: è stato ammesso nella “Vetrina” del “Valdarno Cinema Fedic” 2008. L’attività cinematografica di Agostino Vincenzi prosegue con “L’altro lato della strada”( 2010) e “La verifica”( 2016). Il primo, che è ispirato ad una storia vera desunta da una confidenza di una sua alunna, narra la casuale scoperta da parte di una giovane ragazza della buona borghesia, di ipocrisie, segreti, bugie, ma, soprattutto, di insospettabili ambiguità che si celano all’interno della sua famiglia: un tema delicato in cui emergono anche problemi di omosessualità. L’altro, che è ambientato nella scuola, microcosmo di caratteri, di sentimenti, di sensazioni, è stato realizzato dall’autore, come lui avverte, come pretesto per sottolineare, per stigmatizzare e soprattutto coinvolgere o, forse, per rivivere una scuola che non c’è più e che ,secondo lui, si è adattata troppo in fretta ad una tecnologia invadente che poco aiuta alla formazione umana dei giovani. Ma lo ha realizzato , forse, anche come un motivo per ridare forza e coraggio alla speranza.
Non solo filmmaker Agostino Vincenzi ma anche insegnante di cinema, dopo aver partecipato negli anni a stages di approfondimento per la regia, sceneggiatura e fotografia cinematografica. Sia per il videoCineclub Pesaro che per altri Centri culturali ha effettuato delle “Conversazioni di Cinema” supportate da sequenze filmiche opportunamente scelte. Temi svolti: Educazione visiva e la struttura del racconto dove si sofferma in particolare su “Le invenzioni narrative” di Michelangelo Antonioni; “La semplicità dell’opera e l’alto valore della sua umanità” di Pietro Germi; “I generi cinematografici: Il western classico” ;su Mario Monicelli “Per apprezzarne la saggezza mai retorica di un protagonista della vita italiana”; “Il mistero e la paura nel cinema di Alfred Hitchcock”; “Francesco Rosi: lettura del film ‘Uomini contro’; “La forma della luce: pensiero costante che illumina il cammino della vita”.
Concludono, per ora, il curriculum cinematografico di Agostino Vincenzi, la cui attività culturale è contrassegnata però da altri momenti significativi. Per anni ,infatti, si è dedicato al Teatro rappresentando e dirigendo alcuni spettacoli. Una passione che gli è nata dall’attrazione per l’attività del gruppo “Piccola ribalta”, fondato nel 1952, nata dalle attività del Festival dei gruppi di Arte Drammatica. A quel gruppo Agostino Vincenzi ha offerto la sua collaborazione, in giovane età, pitturando scene di cartapesta e , come modestamente afferma, raddrizzando chiodi usati per poterli riutilizzare in spettacoli successivi. Ed intanto seguiva con vivo interesse, incontri, discussioni, letture di testi teatrali e prove conseguenti allo scopo di poterli poi rappresentare sotto l’’attenta guida del regista e scenografo Carlo Vada. Questa attività teatrale gli ha consentito di conoscere figure, tra gli altri, come , Arnaldo Ninchi e Glauco Mauri “che tanto avrebbero dato in seguito alla televisione e al teatro italiano:” Personaggi dai quali, avendoli frequentati, ho potuto ascoltare, seguire i loro percorsi ed apprendere modi, tempi e la straordinaria funzione del teatro, quale luogo dell’incontro, della condivisione e della cooperazione”. Tra gli spettacoli diretti meritano di essere segnalati le commedie dialettali “El quartir e i su parchè” e “Nadel sla nev”, ma soprattutto “Cegh, zop, matt, a so tutt me”, proposto dall’Associazione teatrale “Le Ombre”, sulla vita e le opere del “poeta degli umili” Odoardo Giansanti, meglio noto come “Pasqualon”, nato a Pesaro il 18 settembre 1852 dove muore il 1 settembre 1932:
”Un personaggio, secondo Agostino Vincenzi, che per Pesaro rappresentò qualcosa di diverso all’incirca nello stesso periodo storico come Triliussa a Roma e Di Giacomo a Napoli. Fu il poeta del mondo dei poveri e degli ignoranti che popolavano il centro urbano di Pesaro e dintorni”. Uno studio, quello del poeta, che ha offerto la possibilità di approfondire la conoscenza di particolari momenti della storia cittadina e della sua quotidianità, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, ma anche di conoscere caratteristiche e peculiarità del dialetto locale.
Un uomo di cultura attento osservatore di ciò che lo circonda, lo definisce in un articolo pubblicato sulla Rivista mensile “IL marchigiano” Enzo Curini, che poi aggiunge:” Vincenzi oltre ad essere un bravo regista, è un poeta, un poeta della pellicola, se cosi lo si potesse definire”. E noi aggiungiamo ,aggiornando il concetto, che lo si può senz’altro definire “Un poeta del cinema”.

Nella foto: Agostino Vincenzi al Festival di Montecatini 1966: si notano da sinistra il Presidente FEDIC Gianni De Tomasi e da destra Giuliano Birindelli, Nino Giansiracusa e Adriano Asti, importanti protagonisti della storia della FEDIC.
FILMOGRAFIA
PELLICOLA
1964 – IL TRAMONTO (8mm, colore, 12′)
1965 – LE DUE CITTA’ (8mm, bn, 10′)
1965 – IL FESTINO (8mm, bn, 15′)
1966 – IL TEMPO CHE OCCORRE (8mm, bn, 14′)
1967 – LE ORE INUTILI (8mm, bn, 20′)
1968 – LA STANZA NELLA NEBBIA (8mm, colore, 25′)
1969 – ELLISSE (8mm, colore, 40′)
1977 – QUEL GRIGIO COLORE DEL TRENO (16mm, bn, 60′)
1978 – PIU’ COSE PER UNA SOLA VACANZA (8mm, colore, 25′)
1979 – IL CASO FRANCESCO (16mm, bn, 26′)
1982 – … E ALLORA?…. (Super 8, colore, 24’)
DIGITALE
2004 – RUMORI DALLA MEMORIA (MDV, colore e bn, 29’)
2005 – LE DONNE DI PESARO (MDV, colore, 15′)
2007 – TITOLO PROVVISORIO ( MDV, colore, 21’)
2010 – L’ALTRO LATO DELLA STRADA (MDV, colore, 24’)
2016 – LA VERIFICA (MDV, colore, 24’)
STAGE NAZIONALE FEDIC. NON SOLO CINEMA
di Enzo Bruno
Prima di raccontare la mia esperienza durante lo stage Fedic 2017, svoltosi a Calci (PI) dal 7 all’ 11 settembre 2017. vorrei presentarmi.
Sono Enzo Bruno, nato a Genova dove risiedo, ho 57 anni e da circa 30 realizzo con alcuni amici film corti e mediometraggi.
Faccio parte del Consiglio Direttivo del Cineclub Fotovideo Genova e da alcuni anni sono socio Fedic.
Tutto inizia con una mail del mio amico, nonché vicepresidente del Cineclub, Claudio Serra, che mi comunica il programma dello stage e mi propone di partecipare.
Alla mia prima reazione di distaccato disinteresse (a settembre si ricomincia a lavorare sodo, altro che vacanza studio) segue una vocina, forse la mia malcelata genovesità, che mi dice: ”Sei pazzo a rinunciare? Un corso sul cinema. 5 giorni in agriturismo! In Toscana!! A questo prezzo!!! Dovresti andare anche se fosse un corso di merletto al tombolo….”
Inutile dire che io e Claudio siamo stati tra i primi ad arrivare giovedì 7 settembre all’agriturismo “I Felloni” di Calci, sede dello stage.
L’arrivo è stato da red carpet, con il caloroso benvenuto degli organizzatori, Roberto Merlino e Maurizio Palmieri, e con le riprese fatte da Marco, che sarà sempre presente con la sua telecamera per darci anche un ricordo filmato del corso.
Il programma di studio si è rivelato molto interessante, perché indirizzato più al “cervello” dei partecipanti e non tanto all’utilizzo dei mezzi tecnici. In altre parole lo stage aveva lo scopo di sviluppare e rendere razionale la capacità di comunicare, seguendo un percorso che dalla creazione di un soggetto culminava nella trasformazione in immagini.
Ad esempio, per quanto riguarda la sceneggiatura, è stato fondamentale capire quanto sia importante, nella creazione di un personaggio, partire dall’insieme delle esperienze vissute che vogliamo dare al personaggio stesso: le cosiddette “circostanze date” del metodo Stanislavskij. Più saranno precise e circostanziate, maggiore sarà la coerenza con cui riusciremo a far interagire il personaggio all’interno della nostra storia.
Interessante e divertente è stata la lezione in cui ognuno ha iniziato a raccontare una propria esperienza, che gli altri partecipanti hanno poi concluso in base alle loro circostanze date.
Altri esercizi estremamente istruttivi sono stati raccontare una storia solo con dieci foto e senza didascalie o raccontarla tramite immagini ritagliate dai giornali o ancora montando a piacimento scene girate in precedenza da altri operatori.
Tutto questo ci ha fatto comprendere quanto a volte sia difficile fare capire agli altri quello che veramente vogliamo raccontare.
A questo proposito è doveroso sottolineare quanto sia stato utile il corpo insegnante, iniziando da Roberto Merlino che ha affrontato tutte le tematiche necessarie per poter realizzare un film in maniera professionale e proseguendo con Leonardo Fiaschi, imitatore e cabarettista di Colorado e Tale e Quale Show, che ha tenuto una lezione sulla comicità, Roberto Galassini, operatore di ripresa e direttore della fotografia, docente della Frame School di Firenze, Alessandro Brucini, sceneggiatore e regista, docente della Frame School di Firenze, Cristiano Mori, sceneggiatore ed attore del pluripremiato film “Il Sarto dei Tedeschi”.
Ma non è solo di questo che voglio raccontare. La sorpresa più piacevole è stato il clima che si è creato, ad iniziare dagli stessi docenti che, trattandoci da amici, a lezione finita erano disposti a parlare con noi anche fino a tarda notte.
E che dire dei partecipanti allo stage? L’ottima idea di Roberto di creare gruppi di 4 o 5 persone intercambiabili di giorno in giorno, ha permesso a tutti di lavorare con tutti, e questo ha aumentato la reciproca conoscenza.
E’ vero, partivamo avvantaggiati, perché avere passioni in comune sicuramente riduce le distanze, ma in questo caso siamo andati oltre e dopo pochi giorni sembrava che ci conoscessimo da sempre
Questo ci ha aiutati parecchio, perché uno degli scopi dello stage era quello di alimentare la nostra creatività, mettendo a disposizione anche degli altri le nostre esperienze personali.
Abbiamo fatto insieme anche colazioni, pranzi e cene sotto gli alberi dell’agriturismo. Certo, abbiamo pagato un piccolo tributo in sangue alle zanzare locali, ma siamo stai abbondantemente vendicati da un paio di gechi, anche se la loro presenza non è sempre stata gradita da alcuni “ingrati genovesi”.
Inutile dire che la cucina della Sig.ra Caterina è sempre stata ottima ed abbondante, sempre disponibile a personalizzare piatti per chi avesse qualche insofferenza alimentare.
Un altro aspetto molto positivo sono state le serate in paese, a Calci, con spettacoli di cabaret o visione di film e la sorprendente visita al Museo di Storia Naturale, uno dei più antichi del mondo.
Non sapevo che a Calci, solo a 15 km da Pisa, ci fosse una splendida Certosa al cui interno c’è questo grande ed interessante museo naturalistico dove, accanto ad una serie infinita di animali imbalsamati, tutta una serie di vasche permette di vedere dal vivo pesci d’acqua dolce provenienti da tutto il mondo.
Se potete andateci. Da non perdere…
Da non perdere anche le partite, fino alle 2 di notte, di scopone scientifico, durante le quali il noto gentleman Roberto Merlino si trasformava in sanguinario guerriero che non faceva prigionieri ma lasciava solo vittime sul campo. Non ha perso una partita!
Certo, la parte didattica è stata la più importante ed impegnativa, ma il ricordo di quanto imparato sarà sempre accompagnato dal ricordo della generosità di Roberto Merlino, che ti fa sembrare semplice l’organizzazione di un evento a cui invece ha lavorato per un anno, l’amicizia di Maurizio Palmieri, che fin dal primo giorno ha sacrificato la sua camera pur di fare stare più comodi me e Claudio, la disponibilità della Sig.ra Caterina, proprietaria dell’agriturismo “I Felloni”, che abbiamo spesso messo a soqquadro utilizzandolo come set cinematografico.
E poi le risate fragorose di Alessandro, la serietà e precisione di Vito, o Gabriella, che sembra la vicina un po’ originale della porta accanto e che per caso scopri aver collaborato con professionisti del calibro di Rudolf Nureyev o Carla Fracci, e Manuele, esperto nel raccontare barzellette che, chissà perché, dette da lui fanno più ridere.
Ed anche Vincenzina, sempre disponibile e ricca di esperienza d’insegnamento all’estero, la sottile ironia di Luciano, pronto a cogliere il lato umoristico di tutte le cose, o la simpatia di Silvia, con la quale ci siamo ripromessi di fare un film insieme, che forse non realizzeremo mai, ma che è stato ugualmente bello averne parlato.
E tutti gli altri compagni di questa avventura, che continuo a ricordare con un sorriso.
Lo stesso sorriso di quando conosci qualcuno che ti piace e che vorresti rivedere al più presto….
FESTIVAL ED EVENTI
 BIOGRAFILM: UN FESTIVAL PER IL DOCUMENTARIO RICCO DI PROPOSTE
BIOGRAFILM: UN FESTIVAL PER IL DOCUMENTARIO RICCO DI PROPOSTE
di Paolo Micalizzi
In undici giorni il Festival ha proposto ben 108 film, 90 dei quali di produzione europea. Particolarmente elevato il numero di anteprime mondiali o internazionali e ben 13 i film di produzione italiana presentati a Biografilm Festival 2017, in anteprima mondiale. Da sottolineare poi che la Sezione che ha incontrato maggiormente i favori del pubblico( voto medio, 8.28) è stata quella italiana e ciò fa molto piacere.
Vincitore del Biografilm Italia è stato “Oltremare” di Loredana Bianconi, opera sul filo della storia il cui riconoscimento è cosi motivato dalla giuria( presieduta da Federica Masin): “Una lettera ritrovata in un cassetto diventa l’inizio di un viaggio nella storia rimossa della colonizzazione italiana in Africa. Un film, unico, raffinato e commovente, che sceglie con coraggio di affidare il racconto ad immagini d’epoca, accompagnate da un sapiente commento sonoro, immergendo cosi lo spettatore in una memoria di cui dobbiamo riappropriarci”.
 La lettera ritrovata era nella casa di famiglia dello zio della regista . Sulle tracce di questo segreto nascosto , il film alterna i documenti alle voci di donne e uomini che, da bambini si trasferirono nell’Africa Orientale Italiana dove erano stati spediti durante il fascismo per rafforzare con nuovi possedimenti il regime. Ne scaturisce un’opera di toccante umanità che evidenzia come non si partiva per questioni ideologiche ma per miseria, speranza, paura, ed anche desiderio d’avventura. Premiato anche “Il principe di Ostia Bronx” di Raffaele Passerini, film stralunato su personaggi emarginati. L’ambientazione è quella della spiaggia nudista di Capocotta, a Ostia, il “regno” di Dario Galetti Magnani messosi sul piedistallo per vendicarsi delle ingiustizie della società. Complice della sua follia, che lo porta a percorrere quotidianamente il bagnasciuga improvvisando monologhi irriverenti e ispirati, la “Contessa” Maury con la quale forma una coppia di attori mancati: è il loro riscatto sociale. Menzione speciale a “Cinema Grattacielo” di Marco Bertozzi, biografia del grattacielo di Rimini “ con i suoi vissuti, i suoi abitanti, i suoi sogni, le sue fantasie”. Ecomostro o paradiso della modernità, si chiede il regista che evidenzia come sia rimasto un corpo estraneo allo scenario urbano, nel cui interno avvengono riti pop e folli riunioni condominiali, e si consumano miti della vacanza di massa e vizi della riviera romagnola. A dare voce al grattacielo lo scrittore Ermanno Cavazzoni che dialoga con lo spettatore e il regista. Assegnato in questa Sezione anche il Premio UCCA- L’Italia che non si vede, da una giuria presieduta da Riccardo Roversi, che è stato attribuito a “The Hate destroyer” di Vincenzo Caruso, incentrato su una signora berlinese di sessantacinque anni che , avendo visto su un muro un adesivo nazista, dal 1985 ogni giorno cancella dai muri scritte omofobe e razziste, dopo averle fotografate. Pur sapendo di rischiare grosso, si rifiuta di piegarsi. Per il Concorso Internazionale la giuria, presieduta da Michael Madsen, ha laureato “To stay alive: a method” di Arno Hagers, Erik Lieshout e Reinier van Brummelen. Il protagonista è uno scrittore sull’orlo del baratro che si salva grazie alla letteratura. Un film, secondo la giuria, che ci “ illumina sul Segreto della vita”. Un premio anche a Qurban Alì Afzali, uno dei protagonisti di “Nothingwood” di Sonia Kronlund , e Menzione speciale a ”Spettacolo” di Jeff Malmberg e Chris Shellen focalizzato sul teatro di Monticchiello. Il documentario “Nothingwood” è incentrato, invece, su Salim Shaheen che con 110 film all’attivo è uno dei più prolifici cineasti dell’Afghanistan diventando un creatore di storie in una terra perennemente in guerra: ha ricevuto anche una Menzione speciale nel Premio HERA “Nuovi talenti” . Come migliore opera prima è stata ritenuta “ Stranger in Paradise” di Guido Hendrikx, un documentario in cui il regista fa intervistare dall’attore Valentjin Dhaenens, che impersona un addetto ai servizi sociali, tre gruppi di giovani migranti appena arrivati in Europa prospettando alcune possibilità di soluzione alla loro richiesta di asilo. Tre approcci alla disperazione umana. Efficaci? Il premio della Giuria per il miglior film europeo è stato attribuito al film “Cherchez la Femme!” della regista iraniana residente in Francia Sou Abadi, una commedia i cui protagonisti sono l’amore, il fondamentalismo islamico e la satira. Spazio nel Festival all’Emilia-Romagna con la presentazione di 10 film, fra cui “Shalom! La musica viene da dentro”.
La lettera ritrovata era nella casa di famiglia dello zio della regista . Sulle tracce di questo segreto nascosto , il film alterna i documenti alle voci di donne e uomini che, da bambini si trasferirono nell’Africa Orientale Italiana dove erano stati spediti durante il fascismo per rafforzare con nuovi possedimenti il regime. Ne scaturisce un’opera di toccante umanità che evidenzia come non si partiva per questioni ideologiche ma per miseria, speranza, paura, ed anche desiderio d’avventura. Premiato anche “Il principe di Ostia Bronx” di Raffaele Passerini, film stralunato su personaggi emarginati. L’ambientazione è quella della spiaggia nudista di Capocotta, a Ostia, il “regno” di Dario Galetti Magnani messosi sul piedistallo per vendicarsi delle ingiustizie della società. Complice della sua follia, che lo porta a percorrere quotidianamente il bagnasciuga improvvisando monologhi irriverenti e ispirati, la “Contessa” Maury con la quale forma una coppia di attori mancati: è il loro riscatto sociale. Menzione speciale a “Cinema Grattacielo” di Marco Bertozzi, biografia del grattacielo di Rimini “ con i suoi vissuti, i suoi abitanti, i suoi sogni, le sue fantasie”. Ecomostro o paradiso della modernità, si chiede il regista che evidenzia come sia rimasto un corpo estraneo allo scenario urbano, nel cui interno avvengono riti pop e folli riunioni condominiali, e si consumano miti della vacanza di massa e vizi della riviera romagnola. A dare voce al grattacielo lo scrittore Ermanno Cavazzoni che dialoga con lo spettatore e il regista. Assegnato in questa Sezione anche il Premio UCCA- L’Italia che non si vede, da una giuria presieduta da Riccardo Roversi, che è stato attribuito a “The Hate destroyer” di Vincenzo Caruso, incentrato su una signora berlinese di sessantacinque anni che , avendo visto su un muro un adesivo nazista, dal 1985 ogni giorno cancella dai muri scritte omofobe e razziste, dopo averle fotografate. Pur sapendo di rischiare grosso, si rifiuta di piegarsi. Per il Concorso Internazionale la giuria, presieduta da Michael Madsen, ha laureato “To stay alive: a method” di Arno Hagers, Erik Lieshout e Reinier van Brummelen. Il protagonista è uno scrittore sull’orlo del baratro che si salva grazie alla letteratura. Un film, secondo la giuria, che ci “ illumina sul Segreto della vita”. Un premio anche a Qurban Alì Afzali, uno dei protagonisti di “Nothingwood” di Sonia Kronlund , e Menzione speciale a ”Spettacolo” di Jeff Malmberg e Chris Shellen focalizzato sul teatro di Monticchiello. Il documentario “Nothingwood” è incentrato, invece, su Salim Shaheen che con 110 film all’attivo è uno dei più prolifici cineasti dell’Afghanistan diventando un creatore di storie in una terra perennemente in guerra: ha ricevuto anche una Menzione speciale nel Premio HERA “Nuovi talenti” . Come migliore opera prima è stata ritenuta “ Stranger in Paradise” di Guido Hendrikx, un documentario in cui il regista fa intervistare dall’attore Valentjin Dhaenens, che impersona un addetto ai servizi sociali, tre gruppi di giovani migranti appena arrivati in Europa prospettando alcune possibilità di soluzione alla loro richiesta di asilo. Tre approcci alla disperazione umana. Efficaci? Il premio della Giuria per il miglior film europeo è stato attribuito al film “Cherchez la Femme!” della regista iraniana residente in Francia Sou Abadi, una commedia i cui protagonisti sono l’amore, il fondamentalismo islamico e la satira. Spazio nel Festival all’Emilia-Romagna con la presentazione di 10 film, fra cui “Shalom! La musica viene da dentro”.
Viaggio nel Coro Papageno” di Enza Negroni che racconta un’attività complessa e socialmente interessante che si svolge nella casa circondariale della Dozza. Ma anche con un omaggio alla coppia di documentaristi Michele Mellara & Alessandro Rossi, i più internazionali tra i filmmaker bolognesi, attivi ormai da 15 anni, il cui sguardo spazia dal mondo studentesco bolognese rappresentato in “Fortezza Bastiani”(2001) ai cambiamenti che a Bologna sono avvenuti dopo il Sindaco Dozza (“La febbre del fare”,2010) ad un ritratto di San Pietroburgo(“Domà-Case a San Pietroburgo”, 2003) per mostrare cosa sta avvenendo nella Russia d’oggi ed infine, finora, a sottolineare il rapporto uomo-macchina e la società delle quattro ruote in “I’m in love with my car”(2017). Omaggio anche a Sabina Guzzanti , personaggio versatile vocato alla satira, una delle voci più scomode del panorama artistico italiano: in programma al Biografilm Festival il film di Giuseppe Bertolucci “Troppo sole” (1994) dove con una simpatia trascinante interpreta 14 personaggi, ed altre sette opere da lei dirette. Sempre più in crescendo il successo del “Biografilm Festival” di Bologna, ideato e diretto con passione e capacità di grande organizzatore da Andrea Romeo, tanto da portarlo a livelli notevoli di qualità e vivacità. Costituiscono , di anno in anno, a dare prestigio al Festival personaggi di grande caratura internazionale. Quest’anno hanno fatto spicco l’attore Pierce Brosnan ,il regista Francis Ford Coppola e la moglie Eleanor che alla veneranda età di 81 Anni ha esordito nella regia con “Paris can wait” che , dopo il Festival di Cannes, è approdato in Italia grazie al Biografilm Festival. Si tratta di “Paris can wait” che racconta di Anne( Diane Lane) sposata con il produttore di Hollywood Michael(Alec Baldwin) che va in auto da Cannes a Parigi con il socio del marito, Jacques. Un viaggio che si trasformerà in una spensierata avventura di due giorni, su una Peugeot d’epoca, tra i borghi della Francia, all’insegna di buon cibo, vino, umorismo e romanticismo: E Parigi potrà attendere. Eleanor Coppola ha ricevuto dal Festival, a nome di tutta la famiglia, il “Life Award “. Grande tributo anche per Francis Ford Coppola. Grande star della famiglia, che ha tenuto una masterclass agli studenti della Biografilm School nel corso della quale ha consigliato loro di mostrare nei film solo il mondo che si conosce.
“Celebration of lives Award 2017” anche ad altri nomi prestigiosi del cinema. A partire dall’ omaggio al regista inglese Peter Greenaway con la proiezione di suoi tre film significativi, e molto stimati nell’ambiente cinefilo, come “Il ventre dell’architetto”(1987), “Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante”(1989), “Giochi nell’acqua”(1988).
Ma anche all’attrice Piera Degli esposti che ha lasciato un’intensa impronta come sceneggiatrice in film come “Il futuro è donna” di Marco Ferreri e come attrice in “L’ora di religione”(2002) di Marco Bellocchio, e sulla quale emergono i ritratti di Marcello Garofalo (“Tre donne morali”, 2006) e di Peter Marcias( “Tutte le storie di Piera”, 2013). Stesso premio anche per Claudia Cardinale e Raffaele Pisu, protagonisti di rilievo del cinema italiano, omaggiati dal Festival anche con la proiezione del film “Nobili bugie” di Antonio Pisu, commedia incentrata sulle vicende di una famiglia di nobili decaduti bolognesi durante l’ultima guerra. Premiata anche Gloria Steinem, omaggiata con il documentario “Woman with Gloria Steinem” uno dei punti di riferimento della cultura statunitense, fondatrice di una rivista femminista con la quale porta avanti la sua lotta politica.
Da sottolineare , a conclusione, che al successo del Biografilm Festival contribuisce anche il “Biografilm Park” con in programma Concerti al Parco del Cavaticcio che hanno registrato oltre 100mila presenze. Grandi presenze anche al “Bio to B/Doc @ Biopic Business Meeting “, una tre giorni di networking e pitching dedicata al cinema documentario e biografico in cui sono stati presentati tanti progetti che hanno riscosso grande interesse da parte dei buyer internazionali arrivati a Bologna da tutto il mondo. Un mercato che ha registrato presenze doppie rispetto all’anno scorso.
23° SAN GIÒ VERONA VIDEO FESTIVAL, LE IMMAGINI, LE STORIE, LE IDEE
di Guido Zauli
Il luogo. Il San Giò Verona Video Festival, svoltosi dal 23 al 27 luglio 2017, ha compiuto ventitré anni. Anche se nato da una cinefilia da record, quella del Cineclub Verona coltivata da più di ottanta anni, è un festival giovane nel panorama internazionale delle mostre cinematografiche. Ma forse è proprio qui che sta la sua forza: il non essersi ossificato sulle proprie glorie adeguandosi, per sopravvivere, alle leggi della compravendita che sempre più invalidano le cinematografie, le mostre, e quella che dovrebbe essere la funzione della critica. Ma non è solo questione di età: la sua vita continua ad essere un percorso che si fa sempre più ripido. La sua indipendenza, lo sguardo implacabile sulla vita, la visione politica benché non ideologica (nel senso deteriore ed etimologicamente errato che di solito viene attribuito al termine), ma con una linea ideale ben precisa, il coraggio di aprirsi ad innovativi autori di ricerca anche linguistica, consapevole che il cinema è in sostanza uno sguardo su ciò che è o viene venduto come realtà: tutto questo lo pone in rotta di collisione con le istituzioni. A parte l’assenza di finanziamenti, quest’anno si è dovuto rinunciare ad un ormai consueto spazio di visione riservata ai corti, quello esterno on the square: la Loggia rinascimentale che dà su Piazza dei Signori (il salotto di Verona), aveva il merito di dare visibilità di fronte alla città, e al turista che poteva stupirsi di trovarvi non solo l’ennesima statua di Dante, dopo il percorso obbligato con la fiction seriale di Giulietta e le banalità pop dell’Arena. E’ rimasta la sede in Santa Maria in Chiavica: una chiesa sconsacrata, in una stretta strada medioevale (fu anche romana) fra le Arche Scaligere e la riva destra dell’Adige; una struttura del XII secolo, interni del XV, frammenti di Santi affrescati.
Benché con qualche problema di orario, tutto il programma, fino alle premiazioni finali, si è svolto in questa suggestione: uno schermo che sovrasta e sostituisce l’altare per una laica comunione con la realtà del mondo, fra icone che raccontavano vecchie storie e le solite domande sulla vita: un po’ come il cinema. Forse ai tempi del sacro culto lo “spettatore/adoratore” poteva più lavorare di immaginazione; oggi c’è sempre meno spazio temporale per andare oltre, verso una personale esperienza, ma il San Giò tenta di restituircela.
Le cinematografie, i temi, i premi. Anche questa edizione ha mantenuto un ampio respiro internazionale ospitando rappresentanti di varie cinematografie nazionali: Svizzera, Gran Bretagna, Russia, Usa, Belgio, Spagna, Libano, Germania, Olanda, Corea del Sud, Canada, Finlandia, Croazia, Algeria, Bosnia Erzegovina, Argentina, Brasile, Senegal, Giappone, Iran, Paraguay, India, Australia, Taiwan, Italia. Ha prevalso la visione documentaristica che se da un lato risponde all’esigenza di realtà che è l’oggetto costitutivo del cinema, ma non nelle sue infinite declinazioni come può accadere nella fiction, dall’altro può rischiare di sconfinare, come linguaggio, nel reportage televisivo dove l’immagine è puro documento, priva d’ogni valenza ed esperienza visionaria, o auratica, come direbbe Benjamin. Anche su questi elementi si sono valutati i lungometraggi in concorso, in particolare quelli che ci hanno riproposto tematiche di attualità: i rifugiati, le vittime delle guerre, le varie forme di emarginazione, le passate emigrazioni che rimandano alle nuove, la perdita e la revisione delle memorie, il perverso senso dell’ospitalità. La giuria di questa sezione ha assegnato i suoi quattro premi a questo genere. Presieduta da Abbas Gharib (Iran), con Fabio Biasio (Berlino), Davide Rossi (Milano) ed il sottoscritto, ha trovato come miglior film “Viaggio al Belgio – A trip to be”, di Mattia Natoli e Nicola Di Girolamo, Belgio 2016.
E’ lo sguardo su un’Italia forse dimenticata, quella che dal 1946 andò a lavorare nelle miniere del Belgio, nella provincia del Limburgo. In quell’anno il governo De Gasperi organizzò una emigrazione di Stato con un flusso di circa duemila lavoratori alla settimana: in cambio il Belgio avrebbe dovuto inviare carbone in Italia. Molti di quella “merce” non ce la fecero: o rimpatriarono, o furono arrestati per il rifiuto di lavorare ed abitare in condizioni disumane. Altri morirono a mille metri di profondità come i 262 di Marcinelle. Natoli e Di Girolamo sono andati in quei luoghi, dagli anziani ex minatori, dalle loro famiglie, dagli ex compagni, dai parroci che ospitano le riunioni sindacali. Non vivono come allora in baracche ma in borghesi villette a schiera con giardino, ma sempre attorno alla miniera: uno scheletro abbandonato, un monumento commemorativo a quanto è costato quel po’ di benessere attuale. Ma non c’è recriminazione nei volti che raccontano, specie in quello di Claudio che ancora nel dialetto sardo evoca la grande bellezza della sua isola. Lo spazio narrativo del film è costituito da un fuori e un dentro, attraverso un confine che quegli italiani devono ancora oltrepassare, ogni giorno. Un fuori estraneo, indecifrabile, freddo come quella neve, quello della società fiamminga, e un dentro confortante nei suoni e nei sapori di casa, nel calore delle tradizioni e delle amicizie, ma tutto circoscritto entro le proprie mura famigliari. Il processo di integrazione è difficile, da entrambe le parti, ma forse molto dipende da chi sa ospitare, da chi ha sfruttato: questo ci conduce all’oggi europeo, all’attualità del film.
La motivazione per il premio alla migliore regia assegnato a “Sarajevo Rewind”, di Eric Gobetti e Simone Malavolti (Italia 2017), ha voluto ricordare come un documentario può contenere elementi che lo avvicinano alla narrazione cinematografica. Eric Gobetti è un giovane storico, di quelli che non si fermano al libro, ai documenti, ma va ad ascoltare ciò che raccontano i luoghi. Per questo già fu premiato nella scorsa edizione. Ma questa volta si è riconosciuta in lui, sicuramente con l’apporto del coautore, una più matura capacità narrativa data anche dal gioco mimetico con cui hanno voluto immedesimarsi nei personaggi.( …)
Premiato per la sua splendida fotografia il lungometraggio “Unwanted Heritage”, diretto e prodotto dalla croata Irena Škorić (2016), ci ha ricondotto sui Balcani, dove le frantumazioni si riflettono anche sulle memorie, quelle che dovrebbero fondare l’identità di un popolo. Dalla fine del secondo conflitto mondiale fino al 1990 i popoli che si confederarono come Unione delle Repubbliche Socialiste Jugoslave costruirono circa mille spomenik: monumenti in memoria della loro vittoriosa resistenza contro le forze italo-tedesche. Nel corso delle recenti guerre balcaniche e durante i regimi che da esse sono stati generati ne sono stati distrutti, devastati o depredati circa la metà, altri sono in abbandono, dimenticati. La Škorić ci ha ricordato che possiamo non desiderare una eredità (unwanted heritage), ma quei monumenti sono il luogo del ricordo di ciò che appartiene all’umanità come memoria, e che è pretestuoso legare ad una particolare visione di parte. Come ci ricorda la citazione nei titoli di testa: La maturità di una società può essere misurata dal rapporto che instaura con l’eredità del suo passato. (Tomislav Premerl, architetto zagabrese). Gli spomenik, diffusi capillarmente sul territorio jugoslavo, erano molto popolari: mete per incontri, commemorazioni e scampagnate, documentate da film di repertorio. Uscì una raccolta di figurine con le foto dei monumenti ed il relativo album che la regista ha ritrovato nei mercatini. Con quelle foto, come da noi per i calciatori, si diceva “celo, manca”; oggi lo si potrebbe dire per i monumenti. Il documentario ci ha condotto da quelli ancora in piedi che dominano solitari e in decadenza le vallate; in parte appartengono ad un realismo socialista che cercava di parlare all’immediatezza popolare, ma soprattutto vediamo le megalitiche sculture simboliste, come il Memorial di Bodgan Bodganovic a Jasenovac: petali di un fiore o ali di farfalla che “sbocciano” dal verde della pianura. In esse non ci sono simboli retorici, riferimenti ideologici. Chiesero a Bodganovic: Dov’è la Stella? Su gli aerei americani, rispose. La mdp e il drone della Škorić ci hanno introdotto, con foto iperrealiste, in questa esperienza anche se ci aspettavamo di poter entrare meglio, dopo forse troppi piani sequenza panoramici, nei meandri concettuali di quelle sculture.
In località Valjevo (Serbia), il 27 maggio 1942, fu impiccato dai nazifascisti il partigiano Stjepan Filipović di 29 anni. Famosa è la foto che lo ritrae pochi attimi prima di essere appeso: con le braccia alzate, a pugni chiusi, grida: Smrt fascismu, sloboda narodu! Morte al fascismo, libertà ai popoli! Nel 1968 fu eretta a Opuzen, suo paese natale sulla costa meridionale della Dalmazia, una grande statua di bronzo che lo ritraeva nello stesso attimo. Nel 1991 elementi del nazionalismo croato anticomunista, o banali vandali, la abbatterono spezzandola in varie parti: alcune, vendute, andarono in fonderia. Oggi ne sopravvivono alcuni pezzi importanti mentre il basamento monumentale in pietra bianca con una scala centrale e due laterali che salivano alla statua è stato demolito; per questioni di circolazione, dicono. Si dice che il Ministero della Cultura avrebbe previsto di restaurarlo, ma non se ne trova conferma; e poi a Zagabria stanno revisionando anche la toponomastica delle piazze. Su quei resti abbandonati a terra, su quella barbara “decostruzione” artistica, su quel “cadavere” di memoria smembrato, su quell’Heritage gettata in discarica la mdp posa i nostri occhi, evitando facili sceneggiature, lasciando allo spettatore consapevole commenti retorici sull’ antiretorica.
La miglior sceneggiatura è andata a “Delta Park”, scritto e diretto da Mario Brenta e Karine de Villers (Italia 2016). Brenta è affermato documentarista ed ha curato la fotografia anche per Coppola e Altman; di questo lavoro è anche regista, photographer, montatore e distributore. Karine de Villers, antropologa e storica dell’Arte, avvicinatasi al cinema grazie a Storck padre del documentario belga, ha curato anche il suono. Le immagini si chiudono con la didascalia: Quale sarà l’ultimo porto dove getteremo l’ancora per non ripartire mai più? Una citazione da Moby Dick: la calma piatta su cui navigava la Pequod ammaliava e annoiava, ma era pure attesa angosciosa per l’insidia che poteva riapparire all’orizzonte o riemergere dal profondo. Come quell’equipaggio anche i protagonisti di “Delta Park” sono in attesa di raggiungere quel porto. Sono una quindicina di ragazzi fuggiti dal vuoto esistenziale dell’Africa e dalle sue tempeste, ora ospitati su un altrettanto vuoto di desolazione, sul delta del Po. In attesa del permesso di soggiorno sopravvivono in un Hotel che ha evitato il fallimento con i 30 euro al giorno che riceve dal Ministero per ogni rifugiato. (…)
In un festival come questo non poteva mancare una ricerca sul cinema come linguaggio. Soprattutto nei corti ne sono stati affrontati i vari generi e componenti sintattici (—), in particolare quelli premiati dalla giuria, composta da Giovanna Tamassia (Verona), Asal Emani (Iran), Elena Gladkova (Mosca), Marco Ongaro e Simone Villani di Verona:
La grafica come processo mentale in “Rise and Repeat”, di Liz Ran Yang, Usa 2016.
Le potenzialità dell’animazione in “Darrel”, di Marc Briones e Alan Carabantes, Spagna 2016.
La messa in discussione del cinema quando è imposizione e mestiere in “Golden time”, di Atefeh Rahmani, Iran 2016; per la sua non recitazione nel rendere il ruolo di madre che vorrebbe ipotecare il futuro del figlio, l’iraniana Nasim Adabi ha ritirato il premio come miglior interprete protagonista. L’accostamento tra documentario e animazione in “Frontera invisibile”, di Mario Muzza e Nicolas RI chat, Argentina-Belgio,2016.
L’essere forse troppo oltre il cinema con la fissità di icone fotografiche, pittoriche e grafiche in “The Sandanese Will Nota Last Ferver”, di Alerei Dimitrio, Russia Olanda 2016.
La capacità della mdp di vedere nelle cose, nella loro solitudine inanimata, prive del rapporto con chi le ha pensate e vissute (come le deserte, decadenti strade di periferia), una loro vita segreta, atemporale in “Azimut” di Emiliana Santoro, Italia 2016.
Il lavoro dell’attore e gli spazi di libertà di pensiero invocati dagli autori in “Cess deus-là”, di Michele Morando, Italia 2017.
Poi il rapporto attore-autore in “Trittico finale”, di Paolo Zagaglia, Belgio 2017, premiato come miglior film: ha rappresentato un momento intenso di questo festival.
I nove minuti, divisi a formare un “trittico”, andrebbero rivisti con maggiore attenzione data la densità delle tematiche suggerite in un così breve spazio temporale. (…)
OCCHIO CRITICO
LA (S) CORRETTEZZA DELL’IMPEGNO:
“IN DUBIOUS BATTLE. IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI” DI JAMES FRANCO;
“MISS SLOANE. GIOCHE DI POTERE” DI JOHN MADDE
di Marco Incerti Zambelli
L’inizio di stagione propone un paio di film americani, in realtà già usciti negli Usa l’anno passato, che paiono rinverdire il glorioso filone del cinema statunitense socialmente impegnato.
In realtà, più che alla bontà della causa, “In dubious battle. Il coraggio degli ultimi“ di James Franco e soprattutto “ Miss Sloane. Giochi di potere” di John Madden sembrano porre al centro il tema della liceità (morale, ma non solo) degli strumenti utilizzabili per raggiungere un pur nobile obiettivo.
Continuando la coraggiosa ma impervia via della messa in scena di capolavori letterari, dopo “As I lay dyng” (Mentre morivo) e “The sound and the fury” (L’urlo e il furore), straordinarie opere di Faulkner, oltre a “Child of God” (Figlio di Dio) di Corman McCarthy ( le citazioni in inglese sono necessarie in quanto nessuno dei tre film ha trovato la via per apparire sugli schermi italiani), il giovane attore regista affronta John Steinbeck, in particolare il primo capitolo della “Dustbolw Trilogy”, che Eugenio Montale tradusse nel 1940 come “La battaglia”, e che si conclude con “Furore”, da cui Ford trasse una delle sue opere maggiori. Riservando a se stesso un ruolo centrale, Franco chiama a raccolta un cast imponente, dai monumentali Robert Duvall, Ed Harris, Vincent D’Onofrio, Sam Shepard (qui nella sua ultima apparizione sullo schermo) ai giovani e decisamente in parte Natt Wolf e Selena Gomez.
La trasposizione filmica rispetta con una certa fedeltà l’opera letteraria, anche se l’accento passa dalla figura del Dottore, dal rigoroso spirito critico, che assiste i braccianti raccoglitori di frutta in sciopero (rovinoso) per un giusto salario nella California degli anni 30, a quella di Mac McLoad, militante del “Partito”, organizzatore appassionato ma cinico della rivolta. La intrecciata vicenda della maturazione politica di Jim Nolan, la sua educazione sentimentale nel rapporto con la tenera figura di Lisa London, madre bambina, sono tratteggiate con partecipazione e anche i personaggi che emergono dalla moltitudine dei lavoratori non scadono in bozzettismi. Sorretto da ottimi professionisti nella realizzazione tecnica, coadiuvato da una indovinata colonna sonora, “In dubious battle” tuttavia non si solleva dal rango di opera ben eseguita, senza raggiungere quel clima epico, evocato nella citazione dal ‘Paradiso Perduto’ di Milton che Steinbeck pone in esergo al romanzo, che pure era nelle intenzioni, ma forse non nelle corde, dell’autore.
John Madden, solido autore ma dai risultati discontinui, da “Ethan Frome” a “Shakespeare in love” fino ai due “Marigold Hotel”, ritrova una strepitosa Jessica Chastain (“The tree of life” , “Zero Dark Thirty”) protagonista di “Miss Sloane”, spietata lobbista di grande successo nella Washington contemporanea, disposta a sacrificare la vita privata, i rapporti umani, perfino la salute per raggiungere il risultato. Apparentemente insensibile al valore morale delle sue battaglie, ‘l’importante è vincere’ è il suo motto, decide tuttavia di abbandonare una potente associazione a sostegno dell’uso libero ed indiscriminato delle armi quando le viene chiesto di promuovere un’azione rivolta alle donne per ottenerne il consenso, per passare nel campo avverso, collaborando con una più modesta compagnia che ha come obiettivo proprio l’approvazione di una legge restrittiva.
Inguainata in un abbigliamento forbito che ne cela (a stento) la carica erotica, alla quale concede solo algidi incontri a pagamento, Miss Sloane si muove con sicurezza e spregiudicatezza, coadiuvata da un solido gruppo di devoti giovani che l’hanno seguita nel nuovo incarico, ai quali chiede totale dedizione alla causa. La cinica ricerca del successo, al confine della liceità, entra in collisione con i “poteri forti” , il mood vira dal sociologico al legal thriller, fino ad un sorprendente ed un poco ambiguo finale. Debitore in parte alle atmosfere di serie televisive di successo, impressione rafforzata da alcuni camei di volti noti da Sam Waterston (“Newsroom” , “Grace and Frankie”) a Christine Baranski (“The good wife”) e dalla durata di più di due ore, il film di Madden ha i suoi punti di forza nella impressionante prova attoriale di Jessica Chastain e nella messa in scena del potente e un poco misterioso mondo delle lobby, alla cui efficacia giova l’occhio distaccato e attento del regista e la sceneggiatura del giovane Jonathan Perera, qui al suo debutto.
TUTTO QUEL FRACASSO:
“CANE MANGIA CANE” DI PAUL SCHRADER
di Francesco Saverio Marzaduri
Non è mai comodo far la conta dei difetti in un film, specie se reca la firma di Paul Schrader. Eppure, lungo i suoi novantré minuti, si ha l’impressione che il romanzo di Edward Bunker, riadattato da Matthew Wilder, conti meno dell’impatto visionario. Complice il montaggio schizofrenico a firma Benjamin Rodriguez Jr., che segue uno straniante modus operandi e alterna stacchi vorticosi a tempi dilatati, tipici dell’estetica trascendentale del cineasta.
Non molto interessa dell’ennesimo colpo, destinato a finir male, di tre criminali gaglioffi bramosi di sistemarsi. A spiazzare sono le scelte estetiche, anche azzardate, in una mise–en–scène che non nasconde vezzi tarantiniani (Bunker era Mr. Blue ne “Le iene”…), pur non replicandone l’ironia, o di soluzioni splatter scioccanti solo in superficie. Nell’era del digitale lo spettatore sorride nel seguire la scia di una pallottola e il suo esasperante percorso prima di vederne colpiti gli obiettivi… E il frastuono allucinogeno di immagini e suoni deformati è un escamotage che fa precipitare il film ancor prima che decolli il tessuto narrativo.
Ancora una volta, però, è tale estetica démodé a fare di Schrader un autore di nicchia. E “Cane mangia cane” non fa eccezione, figurando come un prodotto inclassificabile a livello di gusto, fermo a un immaginario surclassato – se non morto e sepolto – quanto le sale in disuso che scandivano “The Canyons”. Schrader è, in qualche modo, assimilabile ai tre balordi del film, Troy, Diesel e Mad Dog: morti vaganti che sembrano la parodia dei malavitosi scorsesiani, e il cui tentativo di vivere un’esistenza normale rimanda a un’altra opera di Bunker, “Come una bestia feroce”, da cui fu tratto “Vigilato speciale”. O, in tema di reminiscenze, ai tre operai di “Tuta blu” che tentavano di rapinare il fondo-cassa della fabbrica. Non a caso, il regista si ritaglia per sé la parte del boss da cui i protagonisti accettano l’incarico.
Escludendo l’impronta vintage di un film che fa della discontinuità la propria regola, “Cane mangia cane” riprende anche il leitmotiv dell’espiazione, presente sia nei lontani “Affliction” o “Auto Focus”, sia nel più vicino e controverso “Il nemico invisibile”. Un’espiazione possibile sulla carta, ma non nella realtà delle cose (“Una volta che sei dentro fatichi a uscirne”, chiosa la voce narrante di Troy). Addirittura un’espiazione utopica, se a contemplarla è il sanguinario cocainomane Mad Dog che implora l’amicizia di Diesel (il quale lo ammazza esasperato dalle sue psicopatie), laddove nell’incipit è protagonista di una strage in un quadretto domestico dagli accesi colori camp, degno di John Waters.
A unire i protagonisti del film, a seguirli e condurli verso una comune fine, provvedono le soluzioni stilistiche: la tendina che scandisce il passaggio da una sequenza all’altra, come in un fumetto fuori tempo massimo, o la fotografia di Alexander Dynan, che fa di “Cane mangia cane” un provocatorio oggetto pop. E il regista non rinuncia nemmeno a uno j’accuse contro polizia e industria delle armi: nel dibattito televisivo che fa capolino prima ancora dei titoli di testa, nelle battute del gangsta rapper Moon Man (“Hanno licenza di uccidere i fratelli”) o nella scena di tortura ai danni di Troy durante l’arresto. Per concludere con l’uccisione dei due ostaggi di colore, un pastore battista e la moglie, a loro volta detentori di un’arma che non fanno in tempo a usare. E l’impensabile redenzione – prosieguo dell’epilogo de “Il nemico invisibile” – emerge dal cromatismo rosso fuoco con cui si chiude il film: Troy condanna sé stesso a un eccidio liberatorio che odora d’inferno, in cui rapitore e sequestrati perdono la vita. Ma pure trattandosi di provocazione, nessuno meglio di Schrader sa che anche questa è catarsi. Voluta ad ogni costo.
AIUTIAMOLI A CASA LORO?
“L’ORDINE DELLE COSE” DI ANDREA SEGRE;
“BABYLON SISTERS” DI GIGI ROCCATI
di Paolo Vecchi
Un funzionario ministeriale é inviato in Libia per porre un freno agli sbarchi di migranti. Nel corso della visita a un lager dove sono ammassati é avvicinato da una giovane libica che le affida un messaggio da consegnare allo zio che abita a Roma.
In “L’ordine delle cose” Andrea Segre affronta il tema oggi forse di maggiore attualità con estrema precisione in tutti i suoi termini, dalle divisioni tribali nel Paese che fu di Gheddafi, alla conseguente difficoltà a stipulare accordi con interlocutori sfuggenti e poco affidabili, all’orrore dei centri di accoglienza, alle pressioni del governo preoccupato per la perdita di consenso. Tanto da svolgere una funzione quasi didattica, in qualche modo di anticipazione rispetto alla svolta impressa agli eventi dall’attivismo del Ministro degli Interni Minniti. Ma il film non é un pamphlet, ha uno sviluppo narrativo che rifugge da schematismi esplicativi.
I personaggi possiedono una loro sfumata identità, a partire dal protagonista, uomo del tutto “normale”, che applica la propria meticolosità professionale anche alla vita domestica. Essendo dunque l’ambiguità il suo dato costitutivo, finisce per essere preda di un dilemma etico, quello che fatalmente scuote la coscienza di chi deve disporre delle vite altrui in base a ordini superiori. Ed é naturale che questo accada quando oggetto del proprio lavoro da massa indifferenziata assume caratteristiche individuali, dietro cui si può ricostruire un coinvolgente vissuto. L’indecisione del suo protagonista appartiene in parte a Segre stesso, il quale, pur facendo chiaramente capire da che parte sta, non si sbilancia a proporre scorciatoie per affrontare un problema dalle dimensioni epocali.
Nonostante porti il segno di un’indubbia personalità d’autore, “L’ordine delle cose” fa tesoro della lezione di un altro padovano, il compianto Carlo Mazzacurati, alla cui factory ideativa e produttiva Segre fa ampiamente ricorso. Del regista del “Toro” condivide uno sguardo etico prima che estetico e una drammaturgìa sommessa, sotto le righe anche nei momenti forti (gli orrori del centro di accoglienza), variandola sia con alleggerimenti di commedia, sia costruendo un nucleo simbolico al quale ancorare la narrazione (la scherma virtuale del protagonista che nel pre-finale diventa un vero e proprio combattimento, che anticiperà la sua scelta riguardo alla giovane somala).
Shanti, Ashok e la figlia Kamla in Italia ci sono arrivati da tempo. Il padre ha trovato lavoro come cameriere in un ristorante di Trieste, la famiglia vive in un palazzo fatiscente, insieme ad altre coppie cinesi, turche e slave. Con loro abita anche Leone, un anziano professore burbero, che finisce per adottare Kamla quasi come una nipote. Ma il padrone di casa vuole sfrattare tutti, minacciando di chiamare le ruspe in caso di resistenza.
“Babylon Sisters” è il primo lungometraggio a soggetto del documentarista Gigi Roccati. Entrando nel malridotto alveare umano dove abitano gli extracomunitari, il regista si preoccupa da subito di dare un’attendibile idea della complessità, dei problemi e delle situazioni psicologiche ad essi legate. Infatti, se denuncia lo sfruttamento da parte di un proprietario che non si fa scrupolo a mettersi sotto i piedi la legge e la pietà, sottolinea l’atteggiamento solidale del volontariato e di un circolo di anziani. Allo stesso modo non tace le contraddizioni interne a ciascun nucleo familiare, la difficoltà a conciliare tradizioni ataviche con gli stili di vita della nuova realtà. Così Ashok ha la tentazione di far valere la propria natura di marito-padrone quando Shanti è convinta ad adottare dalle amiche un abbigliamento e una pettinatura per lui troppo peccaminosamente occidentali. Ciascuna di loro poi mente sui mestieri esercitati in patria. L’ottica costruttiva di Roccati non diventa dunque mai stucchevole, così come non indulge sulle bellezze “turistiche” di Trieste.
Ma il nucleo tematico e narrativo più convincente e commovente di “Babylon Sisters” è rappresentato dal rapporto tra il vecchio Leone e l’adolescente Kamla. Dopo le schermaglie iniziali, il professore finisce per accogliere nel proprio appartamento la piccola indiana, recitandole Leopardi e Ungaretti e facendole ascoltare Verdi e Puccini, in una consuetudine che da didattica, di trasmissione dei saperi, si trasforma ben presto in affettiva, da nonno a nipote, che consente al primo di uscire da una condizione di solitudine che sembrava irredimibile, alla seconda di aprirsi a nuovi orizzonti culturali.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
AI CONFINI DELL’IMPERO
di Marcello Cella
“Bella esperienza vivere nel terrore, vero? In questo consiste essere uno schiavo”. Con questa frase sibillina il replicante del film “Blade Runner” interpretato dall’attore Rutger Hauer, accoglieva minacciosamente il detective-cacciatore di replicanti Harrison Ford/Deckard. Nel 1982 forse non era ben chiaro il senso di questa affermazione o almeno la si applicava a realtà drammatiche come la guerra o i cataclismi naturali. Oggi il terrore di non sapere più chi siamo o di non poter progettare il futuro appartiene all’esperienza quotidiana di milioni di persone che sono costrette a vivere in un presente che assomiglia sempre più ad una prigione senza possibilità di fuga a causa delle condizioni economiche imposte da un sistema politico-economico oligarchico, quello che denominiamo abitualmente neoliberalismo. I tre documentari presentati in questa rubrica odierna parlano sostanzialmente di questo, dell’angoscia di chi è costretto a vivere ai margini di questo sistema ricchissimo e spietato e per questo è costretto a scelte che non sono tali perchè non prevedono una qualche forma di riscatto, ma contengono solo qualche pallido anticorpo sotto le mentite spoglie di una protesta senza sbocchi. “Brexitannia” di Timothy George Kelly, “Stranger in Paradise” di Guido Hendrikx e “The Workers Cup” di Adam Sobel sono stati presentati recentemente all’interno del festival ferrarese della rivista Internazionale e, pur nelle diversità estrema di temi e stili, possono essere in qualche modo accomunati da questa riflessione amara sullo stato delle cose presenti nel mondo occidentale di oggi.
“Brexitannia” del filmaker londinese ma di origine australiana Timothy George Kelly, si muove ai margini e sulle macerie sociali e culturali del dopo Brexit, il referendum che ha sancito la separazione della Gran Bretagna dal resto dell’Europa. In un racconto a più voci, il livido bianco e nero della fotografia ci accompagna in un viaggio nelle aree urbane britanniche più povere e in quelle rurali più lontane dalle grandi città globalizzate e tecnologiche, dove ha trionfato il voto “contro”. Il voto dei paesi contro le città, dei vecchi contro i giovani, dei cittadini comuni contro le classi dirigenti, dei penultimi (gli inglesi bianchi, poveri, disoccupati o che svolgono i lavori peggiori) contro gli ultimi (gli immigrati dall’Africa), in un puzzle di antica tristezza che qualcuno ha giustamente definito “un ritratto di una democrazia in decadenza”, dove i vecchi imperi sono tramontati e ne rimane solo un’acida nostalgia, il lavoro è sempre più privo di significato umano e sempre più automatizzato, il potere è sempre più lontano da chi ne subisce le scelte. La vera protagonista di questo drammatico e bellissimo documentario è però la solitudine delle persone trattate come “scarti di produzione” da un sistema sociale ed economico, quello neoliberale, sul cui significato il regista si sofferma in alcune illuminanti conversazioni parallele al racconto principale con personaggi come il filosofo americano Noam Chomsky o la sociologa ed economista statunitense Saskia Sassen.
Con “Stranger in Paradise” del cineasta olandese Guido Hendrikx ci trasferiamo inaspettatamente in un’aula scolastica per rifugiati in Sicilia. Qui un attore-insegnante, in uno spettacolare e bizzarro gioco di ruolo, accoglie i richiedenti asilo che devono imparare la lingua e le regole del nostro paese e, più generalmente, dell’Occidente, e gli spiega con apparente cinismo “come stanno le cose” in questa parte di mondo. Ma non si tratta solo di apprendere come funzionano la burocrazia o le leggi in materia di immigrazione, ma delle vere “regole del gioco” non dichiarate che sottostanno a quelle leggi, il cui fine, neanche troppo nascosto, è di accogliere il minor numero possibile di rifugiati, ignorarne storie e condizioni, come le cause che li costringono a partire, e, nel caso che la “corsa ad ostacoli” preparata per loro non funzioni come deterrente, rendere la loro presenza sempre più invisibile e ininfluente. Il film di Hendrikx che si muove agilmente tra finzione e documentario seguendo le rigide regole di sobrietà visiva e narrativa dei cineasti che aderiscono a Dogma95, il movimento-manifesto cinematografico inventato dal regista danese Lars Von Trier, suddivide il suo film in tre capitoli intervallati da “tavole” foto-pittoriche di paesaggio accompagnate da brevi momenti musicali secondo modalità che ricordano proprio la struttura narrativa di “Le onde del destino” di Von Trier. Tre capitoli a cui corrispondono tre diversi gruppi di rifugiati e tre modalità diverse di comportamento da parte dell’insegnante-attore Valentijn Dhaenens. Al primo gruppo egli spiega quanto costano all’Europa, quali rischi portano e perché gli europei non li vogliono. Al secondo, dipinge un’immagine idilliaca in cui saranno accolti a braccia aperte e realizzeranno i loro sogni. Al terzo vengono poste invece domande burocratiche, sulle procedure seguite per arrivare e il diritto d’asilo alla fine delle quali solo tre di loro avranno diritto alla speranza di essere accolti. “Tre approcci, specchio degli atteggiamenti fallimentari dell’Occidente di fronte alla disperazione umana: il rifiuto, l’idealismo, l’indifferenza. I protagonisti sono veri rifugiati, sono vere le loro terribili storie. Un esperimento crudele? Non quanto la realtà” (N.D. “Un esperimento crudele? Non quanto la realtà”, Mymovies, 3/10/2017).
Ma se l’esperimento sociale raccontato da “Stranger in Paradise” può essere visto come una parabola sotto forma di documentario, il racconto di “The Workers Cup” del regista britannico Adam Sobel è assolutamente reale, anche se avviene in un’altra parte del mondo, solo apparentemente molto lontana, e cioè il ricchissimo Qatar dove si stanno costruendo le faraoniche infrastrutture che accoglieranno i campionati mondiali di calcio del 2022. Infatti quando la commissione FIFA ha selezionato il Qatar per ospitare la Coppa del Mondo 2022, il paese ha utilizzato le proprie risorse per cominciare a costruire stadi e opere architettoniche grazie soprattutto a milioni di lavoratori migranti. Si calcola che siano 1,6 milioni gli immigrati impiegati in questi lavori, il 60% della popolazione del paese, provenienti da paesi come Nepal, Bangladesh, Filippine, India, Kenya, Ghana e tenuti in condizioni di semischiavitù. Ma all’interno di questo inferno fatto di sfruttamento lavorativo e orari massacranti per salari miserabili gli stessi sponsor dei mondiali organizzano da anni un torneo di calcio aziendale, “The Workers Cup” per l’appunto, in cui si affrontano le squadre di calcio formate dai lavoratori stranieri delle varie aziende presenti, una sorta di operazione di marketing finalizzata a ripulire la propria immagine, le violazioni dei diritti umani che avvengono sui luoghi di lavoro e lo squallore delle baraccopoli in cui questi lavoratori sono costretti a vivere lontani dal proprio paese, dalle proprie famiglie e anche dalla vista dei ricchi cittadini qatarioti, essendo loro vietato di uscire dai loro “villaggi” dopo l’orario di lavoro e di mischiarsi negli sconfinati centri commerciali con la popolazione locale.
Il documentario di Adam Sobel segue una delle ultime edizioni del torneo raccontando sia l’aspetto sportivo e agonistico, sia e soprattutto le storie di questi lavoratori che vedono nella partecipazione al torneo una fragile strada di riscatto sociale. Eroi sul campo ma ai margini nella società qatariota, i lavoratori perdono progressivamente la speranza che li aveva spinti a emigrare, e i colori, i suoni, le urla festose che accompagnano le partite si perdono progressivamente nel vuoto, nel silenzio, nella solitudine del dopopartita e soprattutto nel ritorno alla amara quotidianità lavorativa dove non c’è spazio per i sogni e le vie di fuga si riducono alla finestrella che separa gli operai al lavoro per ampliare un centro commerciale dalle famiglie intente a fare shopping. Una piccola finestra quasi impercettibile, ma che separa due mondi lontanissimi, il centro del mondo ricco e globalizzato da quello povero di sogni e di oggetti degli “invisibili”. Un luogo che è anche una metafora, non troppo allegra, del mondo di oggi.
BREXITANNIA
Regia: Timothy George Kelly
Produzione: Regno Unito, Federazione Russa
Anno di prosuzione: 2017
Durata: 80′
STRANGER IN PARADISE
Regia: Guido Hendrikx
Produzione: Paesi Bassi
Anno di produzione: 2016
Durata: 72′
THE WORKERS CUP
Regia: Adam Sobel
Produzione: Regno Unito
Anno di produzione: 2017
Durata: 92′
 “LA LINGUA DEI FURFANTI. ROMANINO IN VALLE CAMONICA” DI ELISABETTA SGARBI
“LA LINGUA DEI FURFANTI. ROMANINO IN VALLE CAMONICA” DI ELISABETTA SGARBI
di Tullio Masoni
Un prezioso volumetto accompagna il dvd col film di Elisabetta Sgarbi. Oltre a scritti del fratello, che esamina la pittura bresciana cinquecentesca dedicando a ciascun artista prescelto: Savoldo, Melone, Romanino, Moretto, Moroni, una scheda critica, vi troviamo, fra le belle riproduzioni, altre firme di rilievo: Giovanni Reale, Sergio Risaliti, Luca Doninelli – autore dei testi per il film – Giorgio Ficara. La stessa regista, nel brano di apertura, offre suggestioni che vale riprendere: «In La lingua dei furfanti ho tentato di comporre in un unico film il ciclo di affreschi che Romanino realizzò, fra il 1532 e il 1541, a Pisogne, a Breno, a Bienno, in provincia di Brescia. Ho cercato di mettere in scena quello scambio di vita e forma che sprigiona l’energia dei suoi affreschi nelle tre chiese; sono tornata tra le case e tra la gente di quei borghi che anche Romanino deve aver osservato a lungo e, infine, ritratto. Li ho messi all’opera, e in opera, e li ho trattati come pittura, per dare nuova vita alla pittura, già impetuosa, di Romanino; e ho voluto continuare la sua avventura in questa valle bresciana, avventura riparata dal fulgore di Venezia e Roma , ma che non fa rimpiangere per un solo istante né l’una né l’altra, facendoci sentire così nel cuore della storia.» (1)
“Suggestioni”, dicevo. Elisabetta Sgarbi muove, a proposito, dalla memoria di Giovanni Testori, dalle sue aspre, irriverenti, e appassionate parole:«…Egli (Romanino, ndr) sembra costringere i suoi personaggi a venire sulla scena a furia di calci nel sedere; e non è meraviglia che, una volta lì, essi, tra impetuosa capacità a organizzarsi, in lingua e vergogna, finiscano col gonfiar tutto; a cominciare dalle loro stesse membra per finire alle parole che ruttan fuori quasi nubi di fumetti odoranti d’osteria, e alle piume dei cappellacci, o che si rizzano, unte e bisunte, come quelle di tacchini incazzati.» (2)
Si può comprendere quanto l’energia di queste parole sia stata trattenuta dalla regista durante il lavoro, e talvolta le forme pittoriche ritrovate nell’essenzialità delle tecniche di affresco – il segno/carbone grosso, la visibile, rapida sintesi della pennellata, certa volontaria e anche ineluttabile sommarietà delle proporzioni – richiamano davvero la popolaresca comunicativa del fumetto; ma sembra vero, nondimeno, che altro decide la disciplina: una voce, intanto, che ha la stessa costanza dei movimenti della camera. Movimenti armoniosi fino a “nascondere” la pur notevole complessità, così delicatamente variati tra l’orizzontale e il perpendicolo, tra il campo più lungo (di insieme) e quello ravvicinato, tra la provvisoria fissazione e le ampie curve basso-alto e obliquo degli interni scanditi in sesto acuto, da “riposare” sulla musica in epoca di Franco Battiato.
Si ricorda il fondamentale lavoro compiuto da Luciano Emmer con Giotto – un bianco e nero che permetteva spregiudicati ritocchi sulle riproduzioni – e, al contrario, avvicinandoci col favore delle lacune, delle cancellature che il tempo e l’incuria hanno imposto, l’intonaco lottesco di Credaro, per secoli lasciato in balia del sole e delle intemperie.
Sempre Testori, a proposito degli affreschi di Santa Maria della Neve, parlava di una “Cappella Sistina dei poveri”. Già, gli abitanti dei borghi riparati – dice appunto Elisabetta Sgarbi – dal fulgore di Venezia e Roma, gli antenati della ricamatrice (un po’ griffithiana) che, dal temporale di apertura, fa riapparire la sublime, domestica figura cui l’autore del testo, Luca Doninelli, torna con memoria riconoscente.

Sembra fuori discussione per gli studiosi che Romanino fosse negli anni della Riforma un credente fedele, e tuttavia la “bassa solennità”, la ferialità di molte sue figure adombrano – come appunto fu per il Lotto e, qualcuno sostiene, per Caravaggio – il desiderio di recuperare alla Chiesa uno spirito originario compromesso dal potere; «…Non ho mai visto nessun pittore – scriveva Guido Piovene riferendosi a un quadro raffigurante la flagellazione – fare il Cristo così vecchio: è un contadino, un montanaro, tarchiato, anziano, il cui pelo comincia a diventare grigio, molto potente, assolutamente contrario all’iconografia tradizionale.» (3)
Un pittore credente e fedele alla Chiesa, dunque, ma che subiva il fascino dell’umano, delle sue ambiguità, e del suo tribolato destino.
Il testo di Luca Doninelli mi pare che a questo, anzitutto, tenda. La sua lirica religiosità parrebbe una trama di aperture (o sospensioni) che il filmico e la regia completeranno senza manomettere l’incanto e il senso misterioso del dolore. Un testo umanissimo – recitato con sapiente misura e discrezione da Toni Servillo – e interrogativo, concepito per fondersi con quella materia pittorica e coi modi stilistici che la regista ha scelto per rivisitarla.
Le inquadrature negli interni colgono macchie di luce, filtri reticolari e ombre, mentre sulle pareti affrescate, a contrappunto, gli svanimenti procurati dall’umidità e dalle muffe daranno un senso di incompiutezza o perdita a loro volta “pittoriche”. Ciò avviene per effetto della lingua filmica, e del suo ritmo, messa in armonico ed enigmatico rapporto con un testo letterario che a sua volta si trasforma, attraverso la voce dell’attore, in dramma vivo.
Protagonista del film di Elisabetta Sgarbi è senz’altro la pittura del Romanino, ma non credo sia un azzardo affermare che la regista aggiunge valore a valore; aiuta cioè ad avvicinare l’appartata grandiosità di un’opera e, offrendosi come mezzo poetico di scoperta, assume forza di rivelazione.
La Lingua dei furfanti. Romanino in Valle Camonica
Regia: Elisabetta Sgarbi – soggetto: Giovanni Reale, Eugenio Lio – testi: Luca Doninelli – fotografia (colore): Elio Bisignani, Andres Arce Maldonado – montaggio: Andreas Arce Maldonado, Elisabetta Sgarbi – scenografie: Luca Volpatti – produzione: Betty Wrong/Elisabetta Sgarbi – durata: 33’ – Origine: Italia, 2017
Note
- Elisabetta Sgarbi e Eugenio Lio, a cura di, La Lingua dei furfanti. Romanino in Valle Camonica, ed. Betty Wrong, 2017
- (il brano di Testori è usato dalla stessa autrice in apertura del testo proprio: Una strana biografia familiare)
- La lingua dei furfanti, cit. Piovene è citato da Giovanni reale nel saggio: La dimensione religiosa negli affreschi di Santa Maria della Neve.
QUALITA’ IN SERIE
a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
 RILLINGTON PLACE
RILLINGTON PLACE
di Giancarlo Zappoli
Regia: Craig Viveiros
Soggetto e Sceneggiatura: Tracey Manlone, Ed Whitmore
Interpreti: Tim Roth (Reginald Christie), Nico Mirallegro (Timothy Evans), Samantha Morton (Ethel Christie), Jodie Comer (Beryl Evans)
Produzione: BBC
Distribuzione in Italia: Giallo TV
Origine: Gran Bretagna, 2016
Durata: 3 episodi da 58’
SINOSSI
La serie si apre con l’impiccagione di Timothy Evans che si dichiara innocente e, prima di morire, grida: “Le ha uccise Christie”.
Il primo episodio si focalizza sulla moglie Ethel. Si passa quindi a dodici anni prima quando Ethel ritrova il marito dopo nove anni di assenza. L’uomo è in carcere senza colpa (a suo parere). I due vanno a vivere in un quartiere periferico in un’abitazione in cui il degrado regna sovrano. La donna intuisce che qualcosa non va quando il marito viene salutato da una prostituta e, soprattutto, quando la notte non lo ritrova nel letto. Un giorno lui, che è un ausiliario della polizia, torna a casa malmenato dicendo di essere stato accusato ingiustamente di essere l’amante di un sergente. La notte esce ugualmente ed Ethle lo segue scoprendo che si reca in un pub dove è in compagnia di prostitute. Al mattino lui nega l’evidenza e le suggerisce di farsi curare. Passiamo al 1944 quando una giovane coppia di fidanzati, Arthur e Muriel, li va a trovare. Ethel nota le attenzioni che lui ha per la ragazza (con la quale si spaccia per medico in grado di curarle la tosse), gliene parla e viene quasi strangolata. Decide allora di andare a vivere dal fratello ma non sa poi resistere ai richiami di Reginald e torna proprio quando Arthur sta cercando Muriel che gli aveva detto che si sarebbe recata da Christie per consigli sulla sua salute. 1948: Una coppia di sposi (Timothy e Beryl) va a vivere nell’appartamento sopra all’abitazione dei Christie. Ethel intima al marito di tenere le mani a posto.
Il secondo episodio si focalizza su Timothy Evans. E passiamo al 1949. Tim e Beryl hanno una figlia ma la loro relazione si va deteriorando. Christie insinua che lei sia stata vista con altri uomini. Tim scommette sui cavalli e chiede prestiti alla madre e Beryl è sempre più distante. Distanza che aumenta quando il marito scopre che lei è incinta e che sta tentando di abortire. Christie, spacciandosi ancora una volta come medico, dice di avere un buon metodo per fare tutto in privato. Tim, obtorto collo, acconsente ma quando torna a casa la sera trova Beryl morta. C’era un’infezione in corso afferma Christie che convince l’uomo ad aiutarlo ad occultare il cadavere. Tim decide di allontanarsi da Londra e Reginald si fa consegnare la bambina: ha trovato una famiglia che è pronta a prendersene cura. Quando gli zii vengono a sapere che Beryl è scomparsa da un mese e che lui è pieno di debiti lo invitano ad andarsene. Lui va dalla polizia chiedendo di vedere Christie per riavere sua figlia ma raccontando solo mezze verità. Viene quindi accusato di duplice omicidio perché vengono trovati i cadaveri di Beryl e della bambina. Lui spera nella testimonianza a suo favore di Christie ma non sa che è stato proprio lui ad accusarlo. Il terzo episodio è incentrato sullo stesso Christie che è chiamato come teste dall’accusa nel corso del processo. Lui si farà passare come eroe di guerra e poliziotto (quindi come teste affidabile) accusando Tim. Ethel, che conosce almeno in parte la verità, tace e quando viene interrogata sostiene la sua versione. Timothy viene condannato a morte per l’uccisione della figlia. Nel 1951 la coppia potrebbe andare a vivere in campagna ma Reginald si rifiuta. La moglie lo accusa di aver fatto uccidere un innocente e di voler restare nella grande città per poter agire nell’ombra. Un mattino, mentre dorme, lui la strangola e trascina il cadavere sotto il pavimento di legno di una stanza. E’ però arrivato un altro inquilino al piano di sopra. Costui nel 1953, facendo dei lavori, scopre un cadavere di donna in un’intercapedine. Christie viene arrestato e accusato dell’omicidio di almeno 6 donne (con il dubbio di altre 4 uccisioni). Christie non confesserà l’omicidio della bambina neanche in prossimità dell’esecuzione.
Quello che segue è l’elenco delle vittime accertate del serial killer John Reginald Christie:
- Ruth Fuerst, 21 anni (agosto 1943)
- Muriel Eady, 32 anni (ottobre 1944)
- Beryl Evans, 20 anni (8 novembre 1949)
- Geraldine Evans, 13 mesi (8 novembre 1949)
- Ethel Christie, 54 anni (12 dicembre 1952)
- Rita Nelson, 25 anni (19 gennaio 1953)
- Kathleen Maloney, 26 anni (febbraio 1953)
- Hectorina MacLennan, 26 anni (marzo 1953)
Questa è la descrizione dell’uomo che si trova su Wikipedia: “Christie era all’apparenza un quieto, insignificante, ed innocuo borghese della classe medio-bassa britannica. Quasi completamente calvo, i pochi capelli rimasti erano di un colore giallo paglierino tendente al rosso, e i suoi occhi azzurri erano celati dietro spesse lenti di occhiale. Sua moglie era una donna in sovrappeso dall’aspetto bonario, dal carattere sentimentale e passivo. Le persone del quartiere che conoscevano la coppia, pensavano che Ethel avesse paura del marito. I Christie erano comunque una coppia molto schiva, che teneva soprattutto a mantenere inviolata la propria intimità. Dall’esterno sembravano una coppia felice, due persone comuni reciprocamente devote a loro stesse, e ai propri animali domestici (un cane e un gatto). Un tema e un personaggio del genere non poteva non attrarre l’attenzione del cinema ed è esattamente ciò che accadde nel 1970 con “L’assassino di Rillington Place n. 10”. Le tre famiglie che abitavano nella palazzina non diedero l’autorizzazione alle riprese e il film venne ambientato al numero 7 che era privo di affittuari. Richard Attenborough aveva il ruolo di Christie e dichiarò che inizialmente avrebbe voluto rifiutare quella parte: “Non mi piaceva assolutamente quel ruolo. Trovo il personaggio di Christie ripugnante ma accettai dopo aver letto il copione.”
 A più di 45 anni di distanza il problema si è riproposto per Tim Roth. L’attore e regista britannico non è certo alieno da interpretazioni in cui la violenza è parte integrante del racconto (un film per tutti: “Le iene” diretto da Quentin Tarantino). Nonostante questo ha dichiarato: “Ho fatto un bel po’ di ricerche. La produzione mi aveva inviato un’ampia raccolta di articoli dedicati a Christie, trascrizioni degli atti processuali, referti autoptici, testimonianze di colleghi di lavoro, amici e vicini di casa e un mucchio di immagini che io tenevo nel mio computer in modo che mia moglie non se le trovasse in giro per casa. A un certo punto però metti insieme tutti i pezzi e cominci ad avere un’idea di come tutto dovrebbe essere. E quando questo ha cominciato a chiarirsi ho pensato: ‘Mio Dio, in cosa mi sono infilato?’
A più di 45 anni di distanza il problema si è riproposto per Tim Roth. L’attore e regista britannico non è certo alieno da interpretazioni in cui la violenza è parte integrante del racconto (un film per tutti: “Le iene” diretto da Quentin Tarantino). Nonostante questo ha dichiarato: “Ho fatto un bel po’ di ricerche. La produzione mi aveva inviato un’ampia raccolta di articoli dedicati a Christie, trascrizioni degli atti processuali, referti autoptici, testimonianze di colleghi di lavoro, amici e vicini di casa e un mucchio di immagini che io tenevo nel mio computer in modo che mia moglie non se le trovasse in giro per casa. A un certo punto però metti insieme tutti i pezzi e cominci ad avere un’idea di come tutto dovrebbe essere. E quando questo ha cominciato a chiarirsi ho pensato: ‘Mio Dio, in cosa mi sono infilato?’
I timori di Roth sono più che comprensibili perché questa mini serie offre all’attore l’occasione per una delle più contorte ed efficaci interpretazioni della sua pur ampia e brillante carriera. La regia di Viveiros immerge tutta la situazione in una luce plumbea che si fonde perfettamente con una scenografia fatta di tappezzerie slabbrate, di letti su cui compaiono strane macchie, di ingressi che sembrano tunnel da non visitare. Roth e Morton aderiscono con grande efficacia al mood di cui sopra. Lui ci dà l’immagine di un uomo innocuo, con la testa china, pronto ad occuparsi altruisticamente di tutti. La divisione dei focus ci consente di conoscerlo inizialmente in relazione con una moglie sottomessa ma non stupida, pronta a cogliere i segnali che le giungono da una personalità contorta ma incapace di reagire e di andare fino in fondo nella ricerca della verità.
 Nel secondo episodio emergono le figure di Timothy e Beryl e questo consente alla sceneggiatura di lavorare sulle sfumature del personaggio di Christie che si insinua nella vita della coppia ma anche sulla diversità delle relazioni uomo/donna nel passaggio delle generazioni. Mirallegro offre al suo personaggio un mix di innocenza e di disponibilità ma anche di incoscienza (scommette, è pieno di debiti). Elementi perfetti per ‘costruire’ una colpevolezza che non c’è. Nel terzo episodio Roth ha campo libero per giocarsi, nell’aula processuale, tutte le carte di una personalità perversa ma capace di circonvenzione non solo di incapaci ma anche di un’intera giuria.
Nel secondo episodio emergono le figure di Timothy e Beryl e questo consente alla sceneggiatura di lavorare sulle sfumature del personaggio di Christie che si insinua nella vita della coppia ma anche sulla diversità delle relazioni uomo/donna nel passaggio delle generazioni. Mirallegro offre al suo personaggio un mix di innocenza e di disponibilità ma anche di incoscienza (scommette, è pieno di debiti). Elementi perfetti per ‘costruire’ una colpevolezza che non c’è. Nel terzo episodio Roth ha campo libero per giocarsi, nell’aula processuale, tutte le carte di una personalità perversa ma capace di circonvenzione non solo di incapaci ma anche di un’intera giuria.
La mini serie si trasforma a quel punto in un atto di accusa nei confronti della pena capitale. Ma, in realtà, il segnale era già stato dato nel prologo del primo episodio in cui assistevamo all’impiccagione di Timothy che si proclamava innocente. Questo conferisce un ulteriore valore a questa operazione che si rivela come un’ulteriore prova (qualora fosse ancora necessario) che l’applicazione dell’etichetta “prodotto televisivo” in modo generico e snobisticamente svalutante a tutte le fiction che compaiono sull’ormai non più tanto piccolo schermo è non solo ingenerosa ma anche tristemente miope.
PANORAMA LIBRI
a cura di Paolo Micalizzi
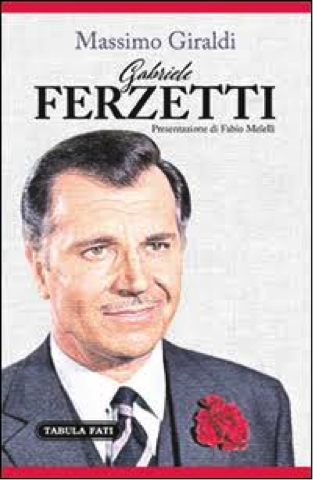 GABRIELE FERZETTI
GABRIELE FERZETTI
di Massimo Giraldi
Tabula Fati, 2016
pagg. 95 , Euro 10.00
Un volume su un attore molto prolifico che, come avverte l’autore, non ha avuto finora quell’attenzione critica e pubblicistica che avrebbe meritato. Eppure ha al suo attivo ben 130 film, dal 1942 1l 2010, ed è stato protagonista in Teatro e in Televisione, come risulta dall’accurato elenco, a cura dell’autore. Nel cinema ha spaziato in tutti i generi e filoni del cinema italiano. Giustamente nella presentazione del libro Fabio Melelli sintetizza il ruolo di quest’attore fra i più importanti del cinema italiano come “un interprete tra i più atipici del nostro cinema, tra i meno classificabili e manierati, un interprete che ha saputo sempre sottrarsi alla tentazione di costruirsi una maschera reiterabile di ruolo in ruolo” aggiungendo che “L’attore Ferzetti, si è sempre calato nei personaggi con partecipato distacco, aderendo naturalmente a psicologie e modi comportamentali, rendendo la sua recitazione quanto di più lontano da qualsivoglia impostazione o cliché”. E ti vengono subito in mente i ruoli nei film di Florestano Vancini che hanno visto in Ferzetti un attore che ha saputo dare vita a personaggi diversi senza, appunto, mai ripetersi. O figure indimenticabili come il Sandro del film “L’avventura” di Michelangelo Antonioni: tutti film degli anni Sessanta che sono quelli in cui Gabriele Ferzetti ha dato il meglio di sé, senza dimenticare però alcuni ruoli degli anni Cinquanta come “Le amiche” di Antonioni o “Donatella” di Mario Monicelli oppure degli anni Settanta in cui spiccano le interpretazioni in “Il portiere di notte” di Liliana Cavani, “Bisturi, la mafia bianca” di Luigi Zampa, e senza trascurare alcuni ruoli degli anni successivi in cui continuava ad avere una sua personalità. Di rilievo anche l’attività teatrale e televisiva a completamento di un’attività d’attore variegata e prestigiosa. Veramente pregevole l’apparatodei credit in cui figurano anche i doppiatori di alcuni suoi personaggi.
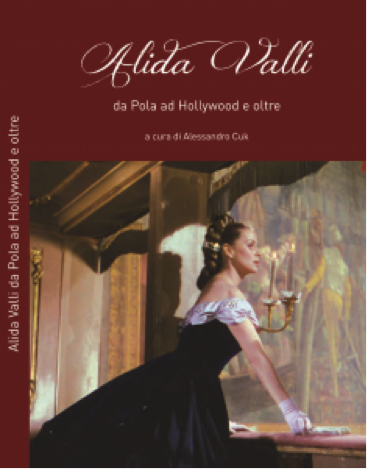 ALIDA VALLI
ALIDA VALLI
da Pola a Hollywood e oltre
a cura di Alessandro Cuk
Alcione Editore, 2016
Pagg. 188, s.i.p
Un libro edito grazie all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia per ricordare un’attrice nata a Pola, e successivamente, a nove anni, trasferitasi a Como al seguito del padre. Una città , quella istriana, alla quale è stata sempre legata, come sottolinea il curatore del libro che ne ripercorre la carriera partendo dal piccolo ruolo avuto, appena quindicenne, in “I due sergenti”(1936) di Enrico Guazzoni dove, ed è l’unica volta, appare con il suo vero nome di Alida Altenburger. Fu Mario Bonnard che la diresse nel 1937 in “Il feroce Saladino” a consigliarle il nome d’arte italiano con il quale diventerà poi famosa in tutto il mondo. A dare svolta alla sua carriera è Mario Soldati che la dirige nel 1941 in “Piccolo mondo antico” e successivamente in “Eugene Grandet”(1946) e “La mano dello straniero”(1954). Da non trascurare negli anni Trenta- Quaranta il sodalizio con Mario Mattòli. Nel 1947 l’incontro con il cinema di Alfred Hitchcock che con “Il caso Paradine” le aprì il successo internazionale dove figurano opere come “ Il terzo uomo”(1949) di Carol Reed oppure dirette da registi francesi come Yves Allegret, Henri Decoin, René Clement, Roger Vladim, Henri Colpì ed altri, come si può rilevare dalla filmografia a cura di Nicola Falcinella. Ma di grande rilievo e valoresono le interpretazioni in “Senso”(1954) di Luchino Visconti e “Il grido”(1957) di Michelangelo Antonioni ma anche in “Edipo Re”(1967) di Pier Paolo Pasolini, “La strategia del ragno”(1970) di Bernardo Bertolucci che l’ha diretta anche nel 1975 in “Novecento(Atto I e II) e nel 1979 in “La luna”. Senza dimenticare “La prima notte di quiete” (1972) di Valerio Zurlini, i due film con Dario Argento(“ Suspiria”, 1977; “Inferno”,1980) ed il sodalizio con Giuseppe Bertolucci che l’ha diretta in ben tre film : ”Segreti segreti”(1984),” Il dolce rumore della vita”( 1999) e “L’amore probabilmente”(2001) con il quale fondamentalmente ha chiuso la sua carriera di oltre cento film. Le cui caratteristiche sono ben sottolineate nel testo di Alessandro Cuk che comprende anche una significativa rassegna stampa ed un’intervista di Enrico Groppali per “Il Giornale” da lei rilasciata una decina di giorni prima della morte.
 OLMI
OLMI
padre e figlio: due mestieri, l’arte del cinema
A cura di Jaurès Baldeschi e Tullio Masoni
Circolo del Cinema “Angelo Azzurro”- Castelfiorentino 2016
Pagg. 190, Euro 12
Libro, edito in occasione di una Retrospettiva cinematografica, in cui è tracciato il percorso filmico di Ermanno Olmi ma anche quello del figlio Fabio, direttore della fotografia di alcuni film del padre, ma non solo. Un percorso fatto attraverso alcuni saggi di studiosi particolarmente attenti al cinema del regista bergamasco. A cominciare da Mario Brenta, stretto collaboratore di Ermanno Olmi sin dal tempo di “Ipotesi Cinema”, la scuola di Bassano da lui fondata. Egli individua la poetica di Ermanno Olmi, e cioè l’originalità di fare cinema, in un’etica dell’estetica e l’essenza del suo insegnamento , mai impartito ex- cathedra ma attraverso l’esempio e la condivisione, nell’attenzione e lo stupore, l’apertura e la meraviglia verso il mondo. L’analisi del suo cinema parte poi dagli “Appunti sul primo cinema di Olmi”, ovvero i documentari, da parte di Gualtiero De Santi a quelle del film “Il posto”, suo primo lungometraggio, dovuta a Tullio Masoni che si occupa anche di “Il mestiere delle armi”, “I fidanzati” di Luisa Ceretto e “L’albero degli zoccoli” di Roberto Chiesi, fino ad arrivare a “Il villaggio di cartone” da parte di Angelo Signorelli e a Paolo Vecchi che si occupa dei film di Olmi che si ispirano a Federico De Roberto e Mario Rigoni Stern. La fotografia di Fabio Olmi nei film del padre è particolarmente analizzata da Marco Incerti Zambelli che anche lo intervista, sottolineando le interpretazioni che egli ne fa. Nel volume, anche un soggetto inedito, quello di “La donna di Magdala” che è illustrato dallo stesso regista con disegni e bozzetti preparatori di questo e di altri film. Una vera chicca.
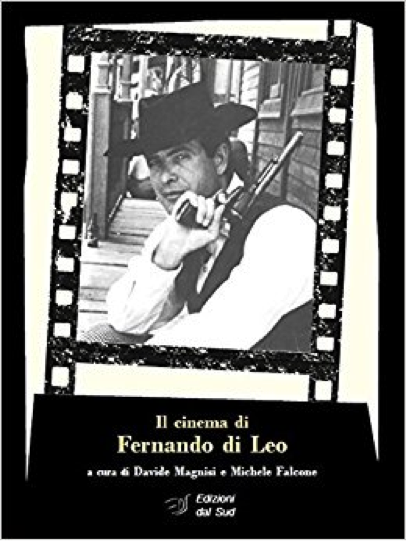 IL CINEMA DI FERNANDO DI LEO
IL CINEMA DI FERNANDO DI LEO
A cura di Davide Magnisi e Michele Falcone
Edizione del sud, 2017
Pagg. 215, Euro 15.00
Un autore, Fernando di Leo, che è stato definito da Quentin Tarantino il Don Siegel italiano, un regista americano, uno dei maestri del cinema d’azione e poliziesco. Il libro cerca di tracciare la figura complessa di questo autore pugliese che oltre a regista è stato uno sceneggiatore prolifico in cui ha concorso a inventare generi come il western/spaghetti e il poliziesco, produttore e anche attore. Una filmografia molto ampia la sua, curata da Michele Falcone, che riguarda i film girati ma anche i soggetti e le sceneggiature e il suo lavoro di assistente alla regia, mentre la bibliografia dovuta a Davide Magnisi consente di constatare l’attenzione avuta sulla sua attività generale e sui singoli film. Il libro si avvale di tanti contributi che spaziano nell’universo del cinema di Fernando Di Leo , utili insieme agli apparati cinematografici per consentirne un-approfondita conoscenza. Fernando Di Leo è conosciuto soprattutto come l’autore dei Cult Movie “Milano calibro 9” (1971) e “Avere vent’anni” (1978) che è stato il suo ultimo film. Ma dalla conoscenza degli altri suoi film emerge una persona il cui apporto al cinema italiano di genere è di grande importanza.
AUTORI
CREDITS
Carte di Cinema 14
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com )
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 14 della rivista online: Enzo Bruno, Marcello Cella, Luisa Ceretto, Marino Demata, Ettore Di Gennaro, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Marco I. Zambelli, Giancarlo Zappoli, Guido Zauli.
























































