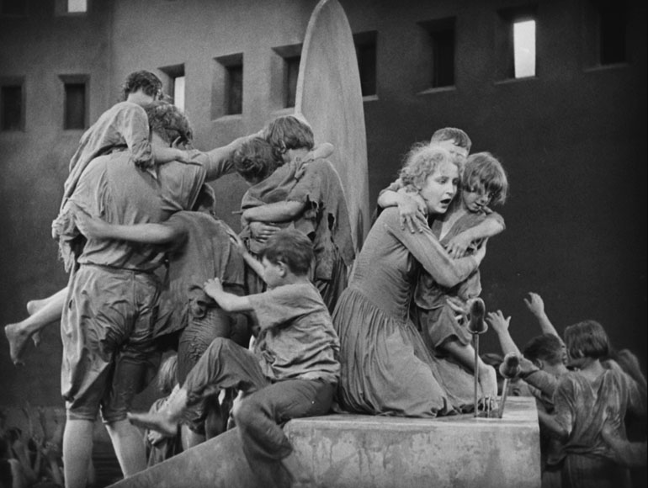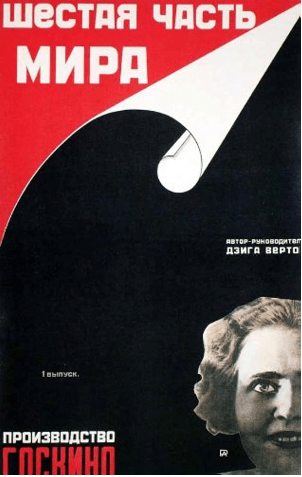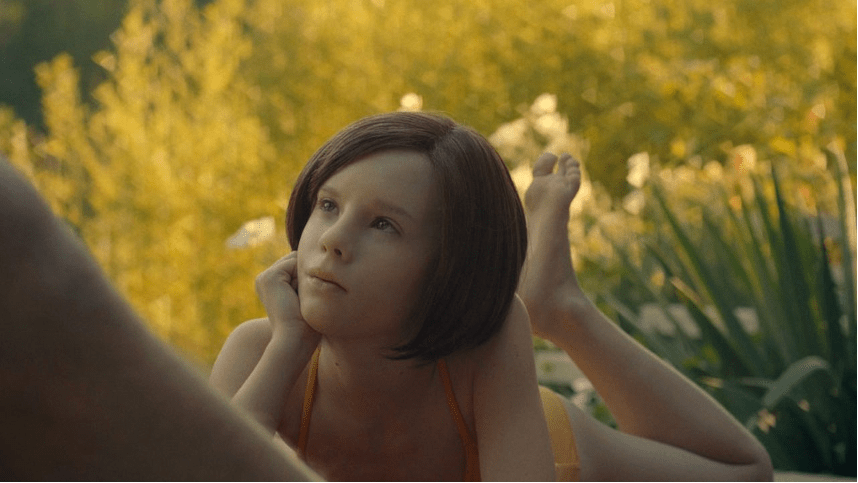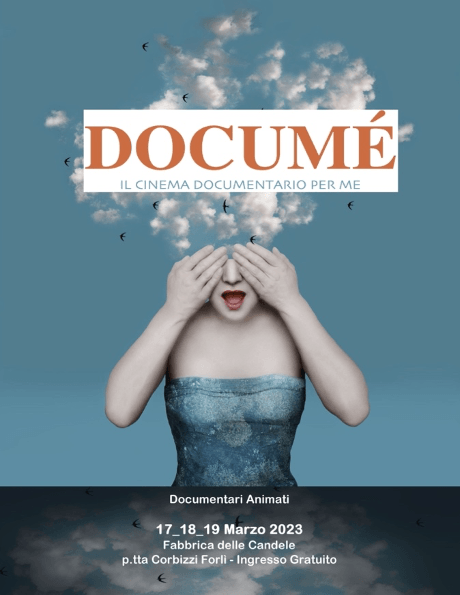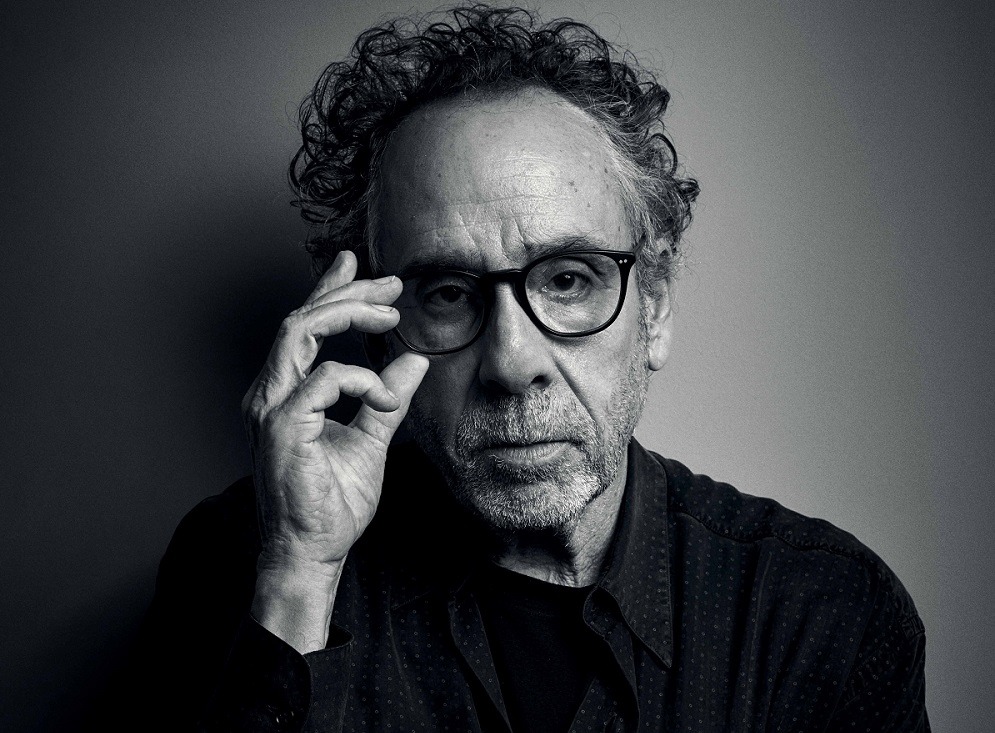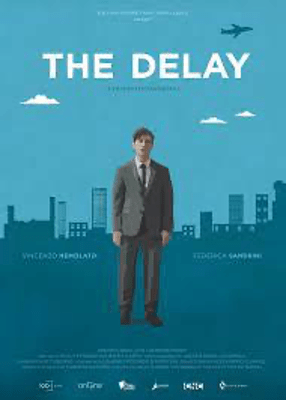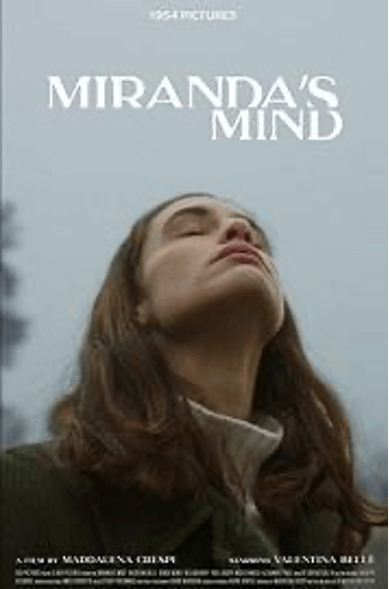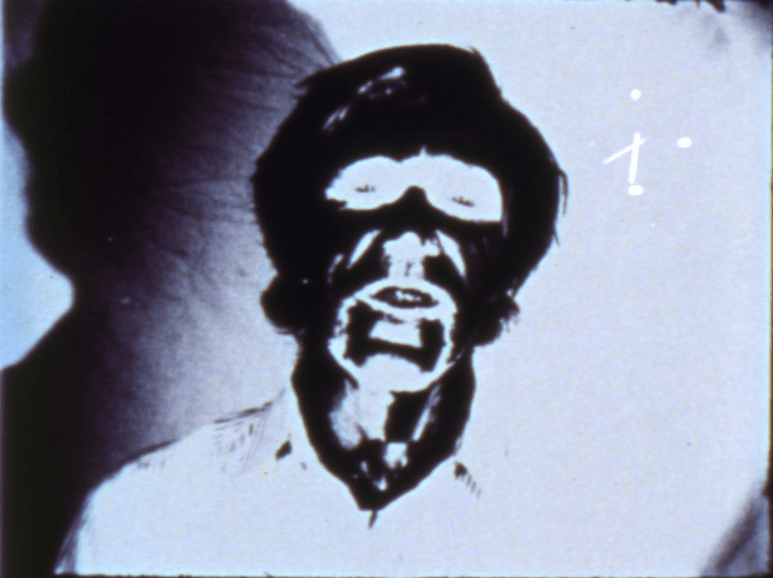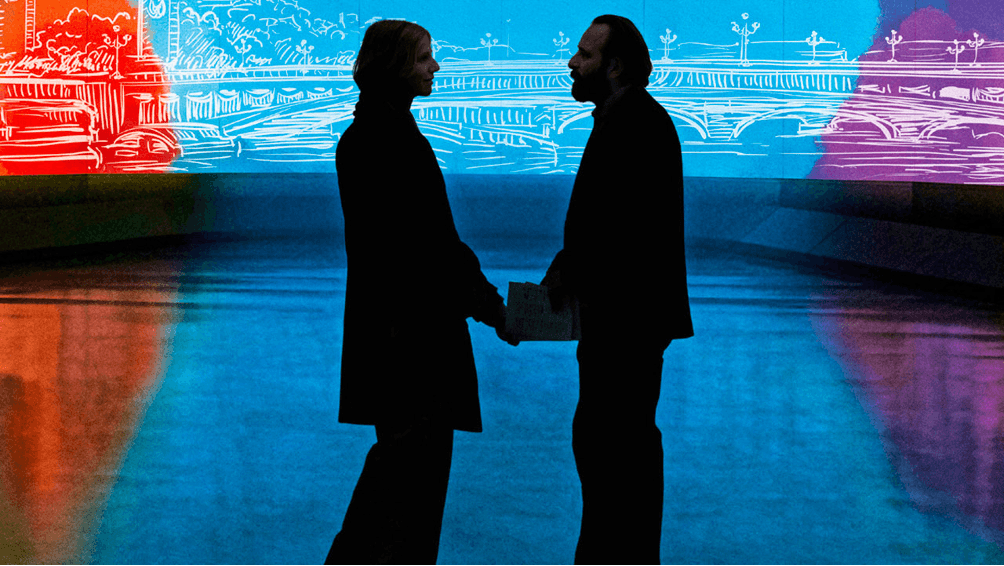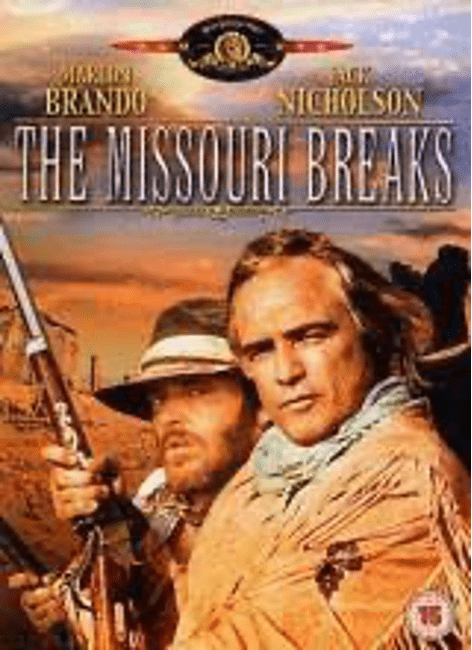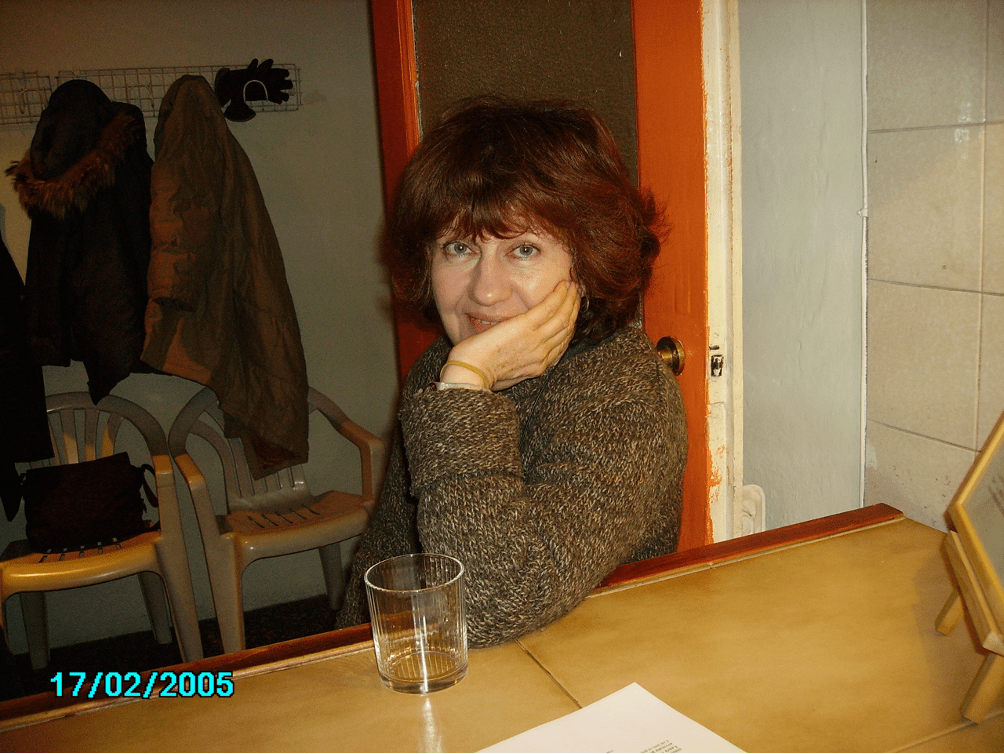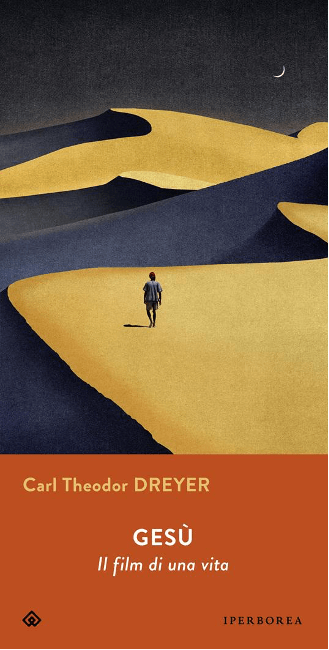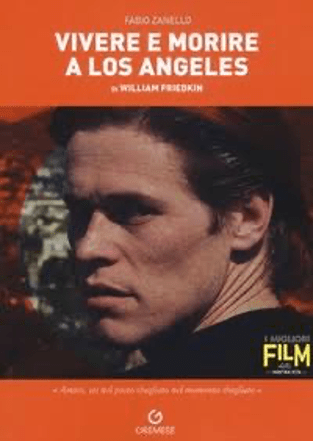Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 6 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO
- 7 OCCHIO CRITICO
- 7.1 EMMANUEL MOURET. UNA RELAZIONE PASSEGGERA di Paola Brunetta
- 7.2 “MAIGRET”: OMBRA DEL PASSATO O PASSATO NELL’OMBRA? di Francesco Saverio Marzaduri
- 7.3 UN PENN SOTTOVALUTATO. “MISSOURI”, 1976 di Tullio Masoni
- 7.4 DUE FILM IRLANDESI “GLI SPIRITI DELL’ISOLA”, DI MARTIN MCDONAGH; “THE QUIET GIRL”, DI COLM BAIRÉAD di Paolo Vecchi
- 7.5 TRA IRAN E ARGENTINA: CINEMA DI GENERE E DI DENUNCIA di Marco Incerti Zambelli
- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 9 PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
- 10 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
RISCOPERTE D’ARGENTO: “TI PIACE HITCHCOCK?” E “GIALLO” di Francesco Saverio Marzaduri
Nel pieno d’un florido periodo tra rassegne e omaggi al maestro del brivido, un’occasione per rispolverare due suoi prodotti, destinati rispettivamente al piccolo schermo e all’“home video”.
SAGGI
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE E IL CINEMA di Maurizio Villani
A cento anni dalla fondazione della Scuola di Francoforte sono analizzati i rapporti critico-estetici tra il cinema e due dai maggiori esponenti della Scuola: Walter Beniamin e Theodor Adorno, Muovendo da premesse teoriche simili i due autori giungono a valutazioni opposte sul valore dell’arte cinematografica.
THE TROUBLE WITH LIFE – AND DEATH di Paola Brunetta
Il saggio The Trouble With Life – And Death si pone come una riflessione sulla fragilità e sui bisogni dell’uomo a partire dall’analisi di un film di Sandra Wollner, The Trouble With Being Born (Austria, Germania, 2020), vincitore del premio speciale della giuria per la sezione Encounters alla Berlinale del 2020 ma accolto in maniera controversa (il festival di Melbourne, per esempio, ha deciso all’ultimo momento di non presentarlo) per come tratta il tema del rapporto tra umano e non umano. Racconta, infatti, la vita di Elli/ Emil, un androide che veste i panni di due persone che non ci sono più allo stesso modo in cui, in un’altra opera citata, gli androidi vanno a sostituire i partner che non abbiamo. Il saggio si conclude individuando il vero problema che gli androidi pongono in quello del nostro narcisismo e chiedendosi se ha senso costruire delle macchine che risolvono, oltre ai nostri problemi pratici, anche quelli emotivo-affettivi, come sembra che avverrà nel nostro futuro.
“PAURA E DESIDERIO” IL PRIMO FILM DI KUBRICK COMPIE 70 ANNI di Roberto Lasagna
Paura e desiderio, uscito 70 anni fa, è il primo lungometraggio di Kubrick, un titolo che si ritroverà un giorno ripudiato dal regista. Ma si tratta dell’esemplare incipit di quello che diventerà l’universo dell’autore, con i suoi tratti e le sue caratteristiche. Le visioni e le ossessioni di Kubrick affiorano con chiarezza in un contesto immaginario, simbolico e ugualmente circoscritto, dove la violenza si accompagna ad alcuni interrogativi che il cinema del regista americano solleverà in futuro con lucido disincanto
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
TREDICI CORTOMETRAGGI DI AUTORI FEDIC DI IERI E DI OGGI IN UNA RASSEGNA DEL CINEVIDEOCLUB PESARO di Paolo Micalizzi
Un’interessante iniziativa del Cinevideoclub Pesaro
DOCUME-IL DOCUMENTARIO PER ME di Gianluca Castellini
Interessante attenzione al Documentario da parte di Sedicicorto di Forlì
IL “TIM BURTON” DI MATTIA ALLEGRUCCI (CINECLUB CESARE PANDOLFI DI PESARO) di Giorgio Ricci
Un video-studio sul visionario Tim Burton.
FESTIVAL ED EVENTI
PREMI ED EVENTI AL PORDENONE DOCS FEST 2023 di Paolo Micalizzi
Resoconto di “Le voci dell’Inchiesta” di Pordenone
CORTINAMETRAGGIO
La XVIII edizione di Cortinametraggio vista da Paolo Micalizzi e Maurizio Villani
VENTISEI NUOVI TALENTI PER IL CINEMA ITALIANO AL FESTIVAL DI CORTINA di Paolo Micalizzi
NOTE DI UN CRONISTA di Maurizio Villani
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre
“BLEU SHUT” di Roberto Baldassarre
Il cortometraggio come mezzo per sperimentare tecniche narrative e di montaggio. “Bleu Shut” di Robert Nelson ne è un fulgido esempio, in bilico tra opera “classica” e performance visiva.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
ADONELLA MARENA, UN GRANELLO DI SABBIA NELL’INGRANAGGIO di Marcello Cella
La documentarista piemontese è stata sempre in prima linea nel raccontare le storie degli invisibili. Un ricordo ed una analisi dei suoi lavori a qualche mese dalla sua scomparsa.
OCCHIO CRITICO
EMMANUEL MOURET. UNA RELAZIONE PASSEGGERA di Paola Brunetta
Dodicesimo lungometraggio di Emmanuel Mouret, regista, sceneggiatore e attore francese, “Una relazione passeggera” (“Chronique d’une liaison passagère”, Francia 2022), proveniente dal festival di Cannes, è la storia dell’incontro e della relazione tra Simone e Charlotte (Vincent Macaigne e Sandrine Kiberlain, magnifici), che non vogliono legarsi ma che si ritrovano uniti indissolubilmente.
“MAIGRET”: OMBRA DEL PASSATO O PASSATO NELL’OMBRA di Francesco Saverio Marzaduri
Trentesimo lungometraggio di Patrice Leconte, l’odierna rivisitazione del personaggio-chiave di Sime-non, nell’incarnazione di Gérard Depardieu, conferisce barlumi d’originalità a un esperimento “démo-dé”, dai toni dimessi, lividi e scabri. Un prodotto di spettri e proiezioni, ove la chilometrica distanza temporale, quella del ricordo in celluloide, perde inesorabile ai punti con quella, ben più dolente, dell’anacronismo narrativo.
UN PENN SOTTOVALUTATO: “MISSOURI” (1976): EO, BALTHAZAR: SONO FRATELLI? di Tullio Masoni
“Missuri”. Montana 1870. Il proprietario di cavalli Davis Braxton assolda un “bounty Killer” per sgominare una banda di ladri. Terzo western di Arthur Penn, nel quadro di un genere criticamente rivisitato dal cinema americano degli anni ’70.
“EO”. A quasi sessant’anni da Au hasard Balthazar di Robert Bresson, Skolimowski propone una fiaba tragica con un asino come protagonista. E’ legittimo un confronto?
Masoni EO
A quasi sessant’anni da Au hasard Balthazar di Robert Bresson, Skolimowski propone una fiaba tragica con un asino come protagonista. E’ legittimo un confronto?
UE FILM IRLANDESI. “GLI SPIRITI DELL’ISOLA”, DI MARTIN MCDONAGH; “THE QUIET GIRL”, DI COLM BAIRÉAD di Paolo Vecchi
“Gli spiriti dell’isola” è un film su un genere di follia tipicamente irlandese, figlia di una natura matrigna, di un clima punitivo e di una vita sociale elementare, vissuta tra la chiesa e il pub. Qui il rapporto tra gli umani si gioca più sugli sguardi che sulle parole, tanto che anche le amicizie si interrompono nel silenzio, senza una vera e propria spiegazione. Girato nell’antico formato di 4:3, “The Quiet Girl” é un piccolo gioiello di sentimenti trattenuti, atmosfere sospese, gesti e sguardi che sostituiscono le parole, che si impone anche grazie alla recitazione di attori bravissimi e ben diretti, tra i quali va ovviamente segnalata l’incantevole
TRA IRAN E ARGENTINA: CINEMA DI GENERE E DI DENUNCIA di Marco I. Zambelli
Abstract: “Holy spider “e “Argentina 1985” , pur nella evidente diversità, hanno in comune un solido riferimento a generi classici, il noir e il legal thriller, ma trovano nel contesto nel quale avvengono le vicende, ambedue tratte da storie vere, una efficace capacità di denuncia e di impegno civile.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
ADONELLA MARENA, UN GRANELLO DI SABBIA NELL’INGRANAGGIO di Marcello Cella
La documentarista piemontese è stata sempre in prima linea nel raccontare le storie degli invisibili. Un ricordo ed una analisi dei suoi lavori a qualche mese dalla sua scomparsa.
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
Segnalazioni-recensioni di quattro libri su: Italo Svevo, Carl Theodor Dreyer, William Friedkin e l’Academy.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
RISCOPERTE D’ARGENTO: “TI PIACE HITCHCOCK?” E “GIALLO”
di Francesco Saverio Marzaduri

“Ti piace Hitchcock?”
In materia di piccolo schermo, nella serie “Storie incredibili” prodotta da Spielberg, ci si ricorderà di un episodio firmato da Todd Holland in cui un “teenager” ossessionato dal cinema horror, rievocando l’immortale doccia di “Psyco”, si ritrova invischiato in un incubo che lo impossibilita a distinguere il vero dalla finzione. E al centro de “La finestra della camera da letto”, girato da Curtis Hanson a ridos-so del segmento, è la disavventura del finto testimone di un’aggressione, che, alle prese con un gioco ritortosi contro di lui, è avvicinato dalla vittima della colluttazione per incastrare il colpevole. Di lustro in lustro, la giocosa voglia di emulare Hitchcock predispone un “pot-pourri” tra appassionati e “aficio-nados” sull’identico asse d’uno stucchevole “già visto”, spremendo succo e meningi, tanto da privare la fantasia di qualsiasi barlume d’idea. Non v’è dubbio che “La finestra sul cortile” sia da collocare tra i più amati e citati capolavori del maestro del brivido; né che negli stessi anni in cui collabora all’americano “Masters of Horror”, un Argento sessantacinquenne, non nuovo ai paradigmi televisivi, realizzi un “tv-movie” a coproduzione internazionale – negli States curiosamente raro – pensato qua-le pilota d’un telefilm, mai concepito, in quattro puntate replicando l’esperimento artistico collaudato anni addietro con “La porta sul buio”. Il cineasta romano non ha mai fatto mistero di appartenere alla combriccola degli affezionati, prediligendo Hitch quale eponimo ipertesto. Fatto sta che dai tempi della “trilogia degli animali”, con la quale nei primi anni Settanta inaugurò la propria filmografia, di acqua sotto i ponti, tra novità e sviluppi nella captazione del prototipo, ne è passata in abbondanza. Ed è cambiato il pubblico, per soddisfare il quale, una confezione-sunto che condensi l’orrifica visiona-rietà di Argento, costituisce un azzardo.
Appare visibile già in partenza la scommessa di offrire qualcosa di eccessivamente collaudato, coniu-gato a un differente parametro (la ricezione del mezzo filmico) e teso, laddove possibile, all’aggiornamento d’una disamina teorica: la sistematica inclusione di manifesti e locandine, da “Ver-tigo” a “Marnie”, sulle pareti d’una stanza o sulle vetrine d’un negozio di “home video”, è luogo cano-nico sin troppo palese di un’indagine, offerta grossolanamente, su un delitto avvenuto in un palazzo nel Torinese, di fronte a quello in cui dimora un occhialuto studente di cinema. “In realtà faccio me stesso – confessa il regista, qui anche sceneggiatore in compagnia del sodale Franco Ferrini – perché il pubblico vuole vedere Dario Argento che fa la tv, ma con la sua personalità. Ho cercato di realizzare ‘Ti piace Hitchcock?’ come un vero e proprio film, non come una fiction: con un ‘tourbillon’ di inqua-drature, inseguimenti, fughe, colpi di scena. Un po’ di realismo e un po’ di fantastico”. Sincerità ripa-gata a 360°, disseminata di immancabili feticci (una mano guantata che apre una porta, una pioggia scrosciante), e invenzioni quali la soggettiva dell’omicida o i primissimi piani su serrature scattanti, riplasmate secondo standard, senza trascurare l’apporto di effetti speciali visivi e sonori. Stile accolto da mezzo secolo nell’immaginario collettivo, cui il non dimenticato autore di “Suspiria” imprime “ad hoc” un tocco d’autoreferenzialità (l’“affiche” de “Il cartaio”, titolo immediatamente precedente) e di ovvia, quanto gratuita, sessualità. I cromatismi rossastri, da un certo punto in poi, sembrano addirit-tura riecheggiare la gotica atmosfera thrilling di cui il Nostro fu fautore, insieme a Pupi Avati – e l’incipit, con un bosco nell’Astigiano a far da cornice, riporta a “La casa dalle finestre che ridono”, con tanto di risate sguaiate da parte di due megere che s’apprestano in una stamberga a sacrificare una gallina.

Ma ancora una volta è una pellicola di Mario Bava – “La ragazza che sapeva troppo”, generalmente considerato il capostipite del giallo all’amatriciana – il punto di riferimento ché l’inverosimiglianza della situazione-spunto, con un protagonista coinvolto suo malgrado, svela l’origine di tanto (troppo) cinema italiano a tinte fosche. Persino in un’operazione televisiva non si fanno sconti a un “climax” in-quietante e sinistro, fomentato da luminosità e rumori ossessivi: si diceva, però, che il linguaggio mediatico imposto e autorizzato disinnesca la “politique” argentiana, e quasi l’addomestica, poiché l’autore rimane ancorato alla centralità del cinema e a una raggiera dilatata quanto inafferrabile, senza venir meno all’effetto grandguignolesco. Si vuole “liquidare” – constata l’acuto Roberto Pugliese – un preciso debito condotto al massimo sviluppo, smascherato in ogni tassello, ove scatole cinesi, “coup de théâtre”, doppi epiloghi non sono l’indizio più meritevole dell’analisi. Sicché, negli ineludibili difetti, il risultato è un divertito giochino citazionista che rastrella “pattern” hitchcockiani, nella fatti-specie rifacendosi a “L’altro uomo” (due ragazze caratterialmente differenti si frequentano di conti-nuo, e la genitrice di una è brutalmente assassinata), cannibalizzati, rimescolati e riproposti (la gam-ba immobilizzata di Giulio dopo un’accidentale fuga, l’istruttore di tennis con cui la madre del prota-gonista vorrebbe convolare a nozze, un corpo da salvare sospeso a mezz’aria da un parapetto, e così via). Elementi assemblati insieme ad altri di matrice affine, lungo una falsariga dichiaratamente me-tatestuale costellata di varianti, variazioni, deviazioni: a partire da un voyeurismo ricalcato da De Palma (e qui le musiche, vedi caso, sono curate da Pino Donaggio), in aggiunta a una pletora di ri-mandi ai classici (la tesi del giovane sull’espressionismo, e in particolare su Fritz Lang, cui si dedicava una strada in “Quattro mosche di velluto grigio”).
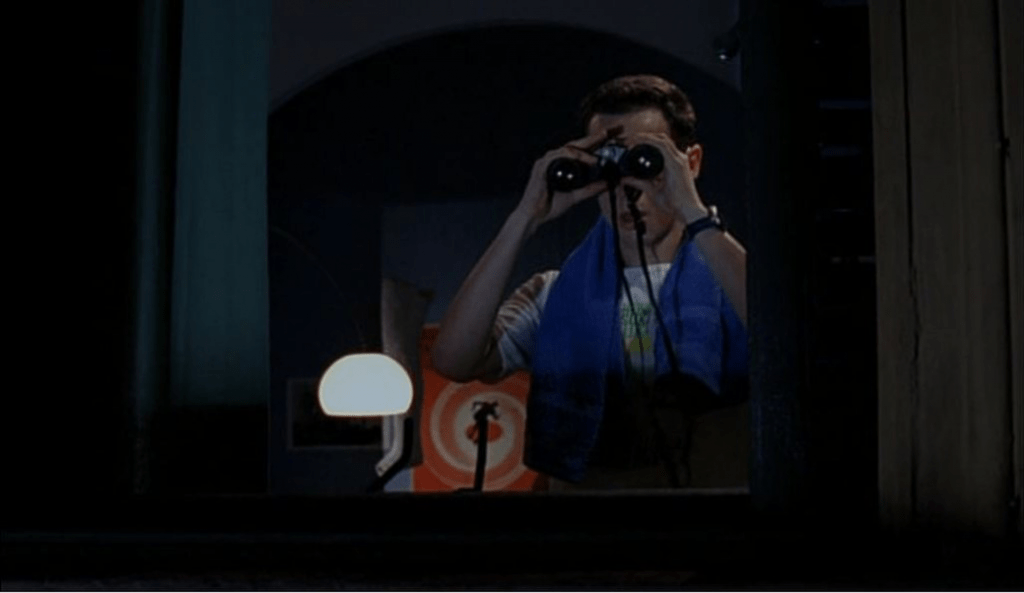
In sostanza, un bignami che s’interroga sul modello filmico, proprio e altrui, ove, relativamente al colpo di scena, il maggior pregio sta nel lavoro dell’attesa prima che nella biforcazione “suspense”-sorpresa, attraverso una dilatazione temporale tirata allo spasimo. Se la restituzione di tale “fatica” è ripagata nelle sequenze, eccessivamente prolungate, dell’inseguimento in motorino o del tentativo di annegare il protagonista, in ugual misura le carenze rientrano in una dissertazione analitica, dal dop-piaggio in asincrono all’imbarazzante recitazione (lo stesso Elio Germano offrirà di sé prove ben più apprezzabili). Ma superato il brogliaccio – la celluloide che si confonde e trasforma in malaugurata realtà – l’osservatore non si sorprende più di niente; e non bastano l’eterna misoginia, o l’ironico mo-ralismo nello sguardo finale di Giulio, a salvaguardare un discorso di “storia infinita” invero conclusa da un pezzo.
“Giallo”
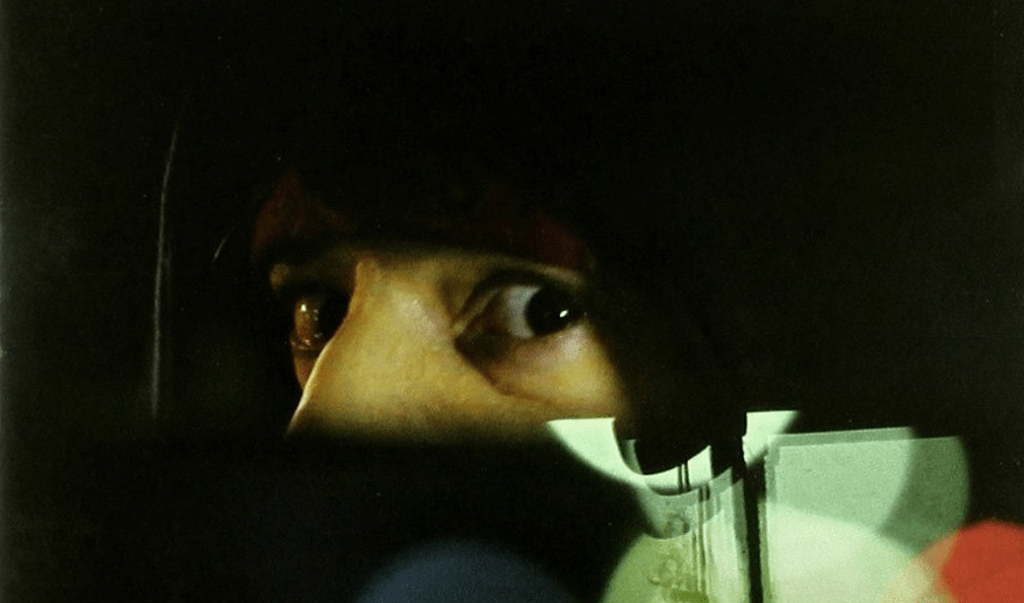
Di “Giallo”, diciottesima fatica cinematografica di Argento è certo più nota l’ultima fase della gesta-zione che l’esito – che riguarda poi, soprattutto, la distribuzione sugli schermi. L’aspetto immediata-mente più curioso dell’esperimento, ragione prima del progetto, sta nella scommessa di proseguire il proprio percorso, si sa di che tipo, a mo’ di confezione televisiva postmoderna studiata per un pubbli-co “new age”. Non ci si contenta più di sangue e delitti: occorre azzardare esplorando, adottando a paradigma una figura di neo-paladino simile al “Dexter” dell’omonima serie, metodico tecnico foren-se della polizia scientifica, e serial killer animato da missione salvifica contro criminali sfuggiti alla giustizia. Coefficiente bastevole a testimoniare come il collaudato “topos” della doppiezza, portato avanti dalla narrativa, non cessi di fungere da innesco per prodotti ove la riproposta, in linea con la sperimentazione, acquista rilevanza nella disamina teorica prima che nel compimento. Corrispettivo dell’identità sottratta, nel corredo di proiezioni e identificazioni, il concetto freudiano di “doppio” prende vita quale esercizio di follia presso menti contorte, senza disperdere l’effetto perturbante nella speculare facciata della legge. Applicando la distinzione “doppelgänger”/“alter ego”, che implica quella proiezione-apparizione, in “Giallo” il bizzarro intrico è marcato da prototipi difformi nelle ri-spettive caratteristiche, complementari tanto da esser l’uno il surrogato identificativo dell’altro. Né sorprende che l’operazione sia finanziata da americani (un paio di firme statunitensi collaborano allo “script”), poi addirittura sottratta e manipolata.
A prescindere dall’interprete Adrien Brody, che il disegno del mostro restituisce dietro un trucco esa-geratamente grottesco (e uno pseudonimo “rétro” ne anagramma il nome), il film è la favola d’una comune solitudine, complice la carenza di affetti domestici, ove il trauma d’infanzia ereditato da “Profondo rosso”, con tanto di coltellaccio insanguinato, miscela la misoginia cara ad Argento con l’inclusione del guscio materno. Figure parimenti emarginate, l’ispettore Enzo Avolfi e la sua “dark (in)side”, Flavio Volpe, vivono e operano in spazi claustrofobici: tane buie e lontane dal grigio degli esterni, che entrambi preservano con parossistica gelosia – il primo nel seminterrato d’una questura, il secondo in un sotterraneo – da cui indotti a uscire attraverso l’icona di Emmanuelle Seigner. Costei simboleggia ambivalente il perduto legame protettivo, cordone ombelicale imposto all’ombroso (e ri-luttante) poliziotto e concesso all’omicida, assurto a estremo contatto con la sorella da lui rapita e seviziata. Condensando l’importanza della colpa, che un personaggio patisce ed espia mediante un’effigie vendicatrice, il protagonista bambino ammazza il matricida così come, adulto, farà altret-tanto con la metà oscura, a sua volta scottata da derisioni infantili; viceversa, accentuata da diffiden-za e apatia, l’alienazione di Avolfi introietta la presenza di Volpe – sin troppo esibita dal “make-up” di Sergio Stivaletti – riportando l’imperitura lotta Bene-Male su un’ambigua unilateralità, priva di nessi familiari (“Sei come lui… Sei un egoista!”, strilla Linda al mesto ispettore, che s’allontana dopo la resa dei conti, disprezzandone il “modus operandi”).

Antitetici sguardi di un’identica “persona”, sbirro e assassino costituiscono una coincidenza d’opposti in un genere dove non conta chi è cosa: rispettivamente giallo e scioglimento, preda e cacciatore so-no interscambiabili pedine la cui immissione è sufficiente a edificare il meccanismo, e l’equa conce-zione di “bellezza” ascrivibile all’abiezione-degradazione del corpo (“Odio le cose belle”, dice il piedi-piatti; “Sei brutta!”, esclama il “body double” torturando la modella Celine). Il corpo resta materia plastica da sfigurare, riplasmare, ripresentare in forma di codice criptico (la bocca di una vittima, or-gano rivelatore del biascicato indizio che scioglierà la matassa), laddove il comparto femminile, ri-spetto alla precedente produzione del cineasta, leggermente s’ammorbidisce: prima che nell’estetica, la donna “artificiale” lo è nell’assoluta distanza dall’esistenza (le straniere in Italia lontane dal loro “milieu”), come suggellerebbe un’accezione spazio-temporale (la reclusione e l’assenza dall’esterno), adibita a rimarcare la predilezione di ambienti chiusi in cui la femmina agisce. La traslazione d’una vittima mai passiva e all’occorrenza provocatrice, che si ribella e fugge, serba il comune sangue di chi, indomita eroina, non si dà per vinta: mai incline al Male, il proprio valore distintivo l’allinea all’antagonista Volpe per valicarlo nell’epilogo – forza d’animo e astuzia permettendo, volti a farne po-tenza irriverente e schiacciante. Il killer è anello di congiunzione tra le due parti, nonostante il turbine di rovesci vanifichi in nome d’una cieca giustizia (“Ha preso il taxi sbagliato”, sancisce l’ispettore).

Se il prologo nella sfera dell’alta moda riporta ai Vanzina di “Sotto il vestito niente”, il cui “plot” non fa mistero di guardare ad Argento, il coraggio nel reiterare una tipologia d’ambiente emulata e supe-rata fa di “Giallo” una proposta teorica di riflessione sul genere: oltreché riferito all’ittero del mostro, parte costitutiva del mosaico (ironicamente, il covo è situato in via Lazzaretto), il giallo non è arcano ma soluzione, unica ipotesi plausibile e necessaria per continuare a girare. Allargando la raggiera spostata su terreni congeniali, l’autore “passeggia” dentro sé stesso percorrendo una confezione di-sossata in ogni fotogramma: ancora una volta Torino, set prediletto per interi assetti o fugaci “patch”, l’attenzione al dettaglio (la siringa del maniaco alla luce d’una lampada), il gusto del tropo (dal teatro d’opera nell’incipit alla giovane malcapitata in taxi, sotto una pioggia scrosciante, sino al tipo di mor-te che fa Volpe), accludendo feticci hitchcockiani o presi a prestito da Antonioni (i flash fotografici dell’omicida, che scatta e rimira sanguinose istantanee). È però il dualismo tra ve-ro/inverosimiglianza, autentico detonatore aneddotico, a rivelarsi (gli spunti del lavoro e della fami-glia), nell’incongruenza e nei rischi di azioni prevedibili (il rivolgersi alla polizia e non essere dapprin-cipio creduti). E sempre per (in)verosimiglianza, senza venir meno a ipertesti di cronaca che riecheg-giano il documento-inchiesta di quarant’anni prima, la salvezza si concede per mera casualità (la so-pravvissuta Celine in un bagagliaio, come la superstite del Circeo). Cieca è la fortuna, quanto la chiave dell’enigma: gli “Occhiali neri” sono dietro l’angolo…
[1] “Giallo” è anche l’omonimo programma televisivo RAI cui il cineasta partecipò attivamente, spesso cimentandosi in una varietà di saggi delle proprie “specialità”.
SAGGI
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE E IL CINEMA
di Maurizio Villani
- La Scuola di Francoforte
1923-2023: ricorre quest’anno il centenario della fondazione della Scuola di Francoforte, nella sua denominazione ufficiale l’Institut für Sozialforschung. Il programma di ricerca della Scuola, soprattutto a partire dagli anni ‘30 del Novecento, sotto l’impulso del nuovo direttore Max Horkheimer, si diede come obiettivo quello di sottoporre le principali concezioni teoriche dell’età moderna ad un’analisi critica, che fosse nello stesso tempo una critica della cultura e una critica della società.

I pensatori che influenzarono maggiormente i francofortesi furono Marx, Hegel e Freud. Le concezioni filosofiche, artistiche e morali erano ricondotte alla struttura sociale e al suo divenire storico-dialettico. L’esito di queste analisi si rivelò radicalmente critico sia verso la società borghese – e la cultura in essa dominante, di stampo irrazionalistico, vitalistico o pragmatistico –, sia verso le realtà politiche “di sinistra”: il comunismo sovietico, ritenuto dai francofortesi una forma di capitalismo di stato trasformato da Stalin in un regime dispotico e il revisionismo socialdemocratico, incapace di opporsi al sistema capitalistico.
La scuola di Francoforte raccolse intellettuali di diversa specializzazione, che produssero studi originali per l’approccio multidisciplinare che li caratterizzò, ma che soprattutto seppero mantenere l’unità del metodo pur nella diversità degli ambiti di ricerca.
Con l’avvento al potere del nazismo nel 1933 i francofortesi, intellettuali marxisti perlopiù di origine ebraica, dovettero lasciare la Germania e si rifugiarono, quasi tutti, negli Stati Uniti, dove nel 1935 ripresero la loro attività restando fedeli alle impostazioni teoriche originarie. Nel 1950 l’Istituto per la ricerca sociale fece ritorno nella sede di Francoforte, influenzando in misura crescente il pensiero filosofico e politico della sinistra europea, fino a diventare una delle principali fonti di ispirazione dei movimenti rivoluzionari degli anni Sessanta.
Del tema del rapporto tra filosofia e cinema si occuparono direttamente Benjamin, Adorno e Horkheimer, nell’ambito di studi sull’industria culturale e sull’estetica.
L’interesse di questi pensatori ha riguardato il mutato significato che l’espressione artistica in generale e quella cinematografica in particolare hanno assunto nella società della comunicazione di massa, in cui i valori estetici o sono profondamente mutati in dipendenza dalla riproducibilità tecnica dell’opera d’arte o sono definitivamente compromessi dalla mistificazione ideologica e dall’omologazione imposte dalle logiche consumistiche. Comune è l’oggetto della riflessione teoretica, ma opposto l’esito dei giudizi di valore sul cinema: Benjamin rivaluta positivamente l’importanza della settima arte, mentre Adorno e Horkheimer ne denunciano gli aspetti manipolatori.
- Walter Benjamin
Walter Benjamin (1892 –1940) è una personalità irrequieta e un pensatore eclettico, che si è occupato di filosofia, di estetica, di letteratura, di sociologia, di misticismo ebraico. Fin dagli anni ’20 si è interessato al cinema, con particolare attenzione per quello sovietico. Nel suo Diario moscovita racconta di un periodo, tra il 1926 e il 1927, trascorso nella capitale russa, in cui si era recato per seguire Asja Lacis, un’attrice e una rivoluzionaria bolscevica conosciuta durante una vacanza a Capri, di cui era pazzamente innamorato. Lì entrò a far parte di un complicato triangolo amoroso di cui faceva parte anche il marito di Asja.
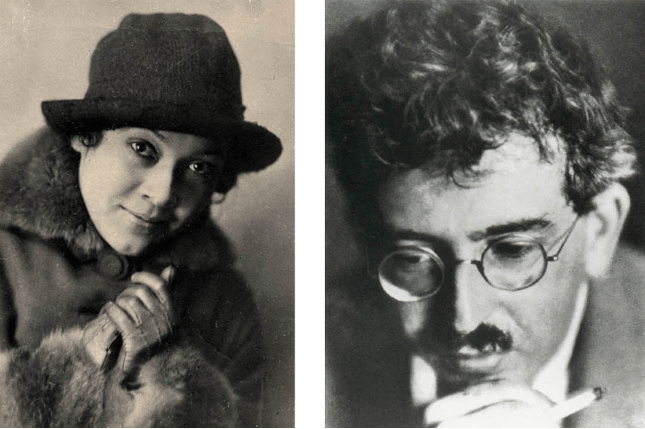
Nel Diario Benjamin testimonia del suo grande interesse per la cinematografia russa di quegli anni; poi fa riferimento a “discussioni incandescenti” riguardanti l’ultima scena di “Metropolis” di Fritz Lang, film uscito in quei mesi. Assoluto capolavoro del cinema espressionista, “Metropolis” mette in scena, in un immaginario fantascientifico, un conflitto di classe tra l’opulenza dei capitalisti e le condizioni di sfruttamento degli operai.
La sceneggiatura del film è di Thea von Harbou, moglie di Lang, e prevede che nella sequenza finale si raggiunga l’intesa tra gli operai e il padrone per tramite di un mediatore che arriva a portare tra il popolo pace ed armonia. Questo finale – oggetto delle discussioni tra Benjamin e i suoi interlocutori moscoviti – venne in seguito ripudiato da Lang, il quale aveva pensato ad una conclusione in cui il conflitto sociale esplodeva in una ribellione violenta che portava alla distruzione della città,
La valenza ideologica del film e le sue controverse interpretazioni vanno riferite alla complessa realtà politico-culturale degli anni ’20-‘30 in Germania: si tenga presente che Thea von Harbou aderì al Partito nazista, mentre Lang, di famiglia ebraica, lasciò la Germania per raggiungere gli Stati Uniti.
Benjamin, tornato a Berlino, nel 1927 scrisse un saggio Sulla situazione dell’arte cinematografica in Russia [«Zur Lage der russischen Filmkunst, in «Die literarische Welt», anno III, n. 10], (Benjamin, 2013). Il saggio dà conto della ricezione del cinema sovietico in Germania (si citano la “Corazzata Potëmkin” di Ejzenstejn e il documentario “La sesta parte del mondo” [“Šestaja čast′ mira”, 1926] di Vertov). Il tono complessivo del saggio è assai critico sullo stato della cinematografia sovietica negli anni in cui si sta affermando il totalitarismo staliniano.
Nella conclusione dell’articolo Benjamin scrive: «Tutti i problemi posti al centro delle discussioni sono per il cinema (proprio come per la letteratura) problemi di contenuto. Con la nuova epoca della pace civile essi sono entrati in un periodo difficile. Il cinema russo troverà una base sicura solo quando i rapporti della società bolscevica (e non solo della vita dello stato!) saranno abbastanza stabili da poter sostenere una nuova “commedia sociale”, nuovi ruoli e nuove situazioni tipiche».
Negli anni Trenta Benjamin approfondisce analiticamente le trasformazioni tecniche che, a suo parere, hanno sovvertito totalmente la funzione e il ruolo dell’arte nella società contemporanea. Il risultato di questi studi è L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, pubblicato nel 1936: saggio in cui il cinematografo è descritto come la forma d’espressione tipica del Novecento che ha introdotto uno dei più decisivi punti di frattura con la tradizione dell’estetica precedente.
Da un lato, secondo Benjamin la riproduzione tecnica dell’immagine comporta una perdita: la generale distruzione dell’aura, vale a dire della costellazione simbolica che avvolge l’opera d’arte intesa come unica, autentica e irripetibile. La perdita dell’aura genera un cruciale mutamento delle forme artistiche e della loro diffusione, che sempre più le fa assimilare a prodotti di consumo. Il cinema, allora, tenterà di ritrovare l’aura negata attraverso il culto del divo: «Il cinema risponde al declino dell’aura, costruendo artificiosamente la personality fuori dagli studi: il culto del divo, cerca di conservare quella magia della personalità che da tempo è ridotta alla magia fasulla propria del suo carattere di merce» (Benjamin, 1991, p. 34).
Da un altro lato l’epoca della riproducibilità tecnica comporta un guadagno: il consumo di massa dell’arte instaura un processo di politicizzazione della cultura.
Il cinema si pone in contrapposizione dialettica con la concezione aristocratica dell’arte, poiché questa non è più in grado di rappresentare le esigenze della contemporaneità. Si ottiene così una democratizzazione dell’arte, che diventa autenticamente popolare, realizzando uno degli obiettivi emancipativi impliciti nella visione di Benjamin del materialismo storico.
Il cinema modifica il rapporto delle masse con l’arte, infatti «da un rapporto estremamente retrivo, per esempio nei confronti di un Picasso, si rovescia in un rapporto estremamente progressivo, per esempio nei confronti di un Chaplin. (…) Al cinema l’atteggiamento critico e quello del piacere del pubblico coincidono».
In un articolo scritto nel 1929, intitolato Chaplin: sguardo retrospettivo, Benjamin recensendo il film “La donna di Parigi” (“A Woman of Paris”, 1923) diretto e prodotto da Charlie Chaplin scrive che «nei suoi film Chaplin si è rivolto al sentimento più internazionale e più rivoluzionario delle masse: il riso» (Benjamin, 2013).
In questa analisi sul cinema vanno almeno citati due temi: quello della percezione delle immagini e quello della valenza politica del cinema.
Riguardo al primo punto Benjamin sostiene che la riproduzione tecnica dell’immagine comporta un profondo cambiamento delle forme della percezione. Il cinema rende accessibili aspetti prima irraggiungibili all’uomo, potenziando la capacità visiva e sensoriale e trasformando i processi percettivi, che passano da una dimensione individuale a una collettiva.
Le possibilità di conoscere e operare si dilatano su quel mondo di cui i mezzi di riproduzione tecnica restituiscono un’immagine, che non è mai una semplice rappresentazione del reale, ma una costruzione artificiale. Questa finzione permette di guardare altrimenti la realtà e le sue mutazioni. Il montaggio, di cui Benjamin riconosce la centralità nella costruzione filmica, crea quindi una seconda natura dei fatti, mostra ciò che sta dietro il visibile e che lega profondamente il cinema e il pensiero, la nuova tecnologia e la filosofia.
Sul tema della funzione politica del cinema Benjamin mette bene in luce la doppia e ambigua valenza che la nuova arte può avere.
Per un verso il cinema può essere un’arma di propaganda, di indottrinamento e di persuasione di cui sia i regimi totalitari sia quelli liberal-democratici si servono per condizionare le masse attraverso un’opera di estetizzazione della vita sociale e politica.
Ma, per un altro verso, per mezzo di una opposta opera di educazione politica, il cinema può far nascere una coscienza critica nelle masse degli spettatori, che comprenderanno come divertirsi non significhi necessariamente essere d’accordo.
«Benjamin, pur essendo vicino ad esponenti dell’Institut für Sozialforschung di Francoforte come Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, non ne condivide dunque la diagnosi totalmente pessimista sull’arte di massa: se sussiste il pericolo di una sua utilizzazione ai fini del fascismo, come il filosofo mostra al termine del saggio, la rivoluzione tecnica e la democratizzazione della fruizione implicano in potenza inclinazioni “progressive”. Quando Benjamin parla di una “politicizzazione dell’arte”, da opporre alla “estetizzazione della politica” perseguita dal fascismo, non si riferisce a un’adesione contenutistica ai temi del realismo socialista, ma intende indicare gli sviluppi di questa ricezione collettiva e critica» (Angelucci, 2014, p.104).
- Horkheimer e Adorno. Il cinema come industria culturale
All’opposto di quanto sostiene Benjamin, Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969) ritengono che il cinema sia uno strumento di annullamento della personalità dei singoli e della loro capacità di opporsi al modello capitalistico di società.
Lo spettatore cinematografico è privato delle sue facoltà creative e di pensiero, assorbito completamente dalla trama e dai personaggi.
L’interesse di Adorno per il cinema data a partire dalla fine degli anni Venti del Novecento. Rivelatrici sono le osservazioni che scrive in numerose lettere all’amico Walter Benjamin. Nel 1934 Adorno trascorre una giornata visitando gli studi cinematografici di Neubabelsberg vicino a Potsdam, conosciuti per essere i secondi più antichi studi al mondo. Nel 1936 descrive l’esperienza in una lettera a Benjamin, in cui denuncia il mimetismo oggettivizzante del linguaggio filmico: «la realtà è sempre costruita con un attaccamento infantile al mimetico e poi “fotografata”». In un’altra lettera a Benjamin, a proposito di “Sogno di una notte di mezza estate” (A Midsummer Night’s Dream. 1935) di Max Reinhardt, scrive che le ambizioni del film di raggiungere la stessa dimensione “auratica” portano inevitabilmente alla distruzione dell’aura.
Con l’affermarsi del regime nazista sia Horkheimer che Adorno devono lasciare la Germania e dopo vari spostamenti in Europa e negli Stati Uniti, si ritrovano a Los Angeles nel 1941. Nella metropoli californiana Adorno ebbe modo di conoscere da vicino il mondo di Hollywood e di intrattenere rapporti con attori e autori degli Studios. In vari scritti manifestò la sua ammirazione per Chaplin, da cui ebbe il “privilegio” di essere imitato, come racconta nel breve saggio “Twice Chaplin”.
Il periodo californiano fu particolarmente fecondo per Adorno, che lavorò intensamente in collaborazione con Horkheimer. Da questo lavoro in comune uscì Dialettica dell’illuminismo (pubblicato nel 1947, ma scritto durante l’esilio americano tra il 1941 e il 1944). All’interno di questo saggio, nel capitolo dedicato all’«Industria culturale» si trova la sintesi più compiuta delle tesi dei due francofortesi sul cinema. In esso si legge: «Quanto più fitta e integrale è la duplicazione degli oggetti empirici da parte delle sue tecniche, e tanto più facile riesce oggi far credere che il mondo di fuori non sia che il prolungamento di quello che si viene a conoscere al cinema. A partire dalla subitanea introduzione del sonoro il processo di riproduzione meccanica è passato interamente al servizio di questo disegno. La vita – almeno tendenzialmente – non deve più potersi distinguere dal film sonoro. (…) L’impoverimento dell’immaginazione e della spontaneità del consumatore culturale dei nostri giorni non ha bisogno di essere ricondotto, in prima istanza, a meccanismi di ordine psicologico. Sono i prodotti stessi, a cominciare dal più caratteristico di tutti, il film sonoro, a paralizzare quelle facoltà per la loro stessa costituzione oggettiva.» (Horkheimer Max.; Adorno T. W. 1966, pp. 132-134).
Il passo riportato si riferisce al cinema hollywoodiano, che (assieme alla musica leggera) è una delle forme di cultura legate allo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa. A giudizio dei due autori i media costituiscono un sistema secondario di sfruttamento, di dominio, di mercificazione e di integrazione, grazie al quale il capitalismo avanzato subordina qualsiasi attività culturale, alta o bassa che sia, a un unico scopo: fare dello spettatore un consumatore.
Lo spettatore cinematografico perde ogni capacità critica di immaginare mondi alternativi e finisce per considerare la realtà come il proseguimento dello spettacolo visto al cinema. Egli non decide più autonomamente, ma è in balia di una società che lo manipola a piacere imponendogli l’adesione acritica a valori precostituiti. Anche se crede di sottrarsi, nel tempo libero, ai rigidi meccanismi produttivi, in realtà il sistema economico determina così integralmente la fabbricazione dei prodotti di svago, che ciò che consuma sono solo copie e produzioni del processo lavorativo stesso. L’industria culturale, quindi, ben lungi dall’elevare le masse al mondo dell’arte è in realtà un dispositivo di conservazione volto a perpetuare la società esistente.
«Da Henny Porten a Clark Gable, la star del cinema, come istanza iconica della trasformazione di un essere umano in merce, è vista da Adorno come la fase finale di un processo di liquidazione: la liquidazione dell’espressività, della singolarità e dell’individuazione – quest’ultimo essendo un concetto fondamentale della Teoria Critica, per il quale è una pietra di paragone di emancipazione, libertà e giustizia. Meglio Greta Garbo che Mickey Rooney, ma meglio “King Kong” che Greta Garbo» (Brezen, 2021).
Adorno e Horkheimer, mentre stavano elaborando le critiche all’industria culturale e, in particolare al cinema, entrarono in contatto con la comunità dei cineasti hollywoodiani e vennero coinvolti nel 1941 nella produzione di un film sperimentale, provvisoriamente chiamato “The Accident” (“L’incidente”), che faceva parte di un Progetto di ricerca sull’antisemitismo. Il film, che intendeva verificare gli atteggiamenti discriminatori nei confronti degli ebrei, non superò la fase del soggetto, anche se fra il 1943 e il 1946 Adorno ne scrisse parecchi trattamenti.
Questo fatto mostra la complessità, e anche la contraddittorietà, del rapporto di Adorno e Horkheimer con l’industria cinematografica, da un lato fatta oggetto di una critica radicale, dall’altro riconosciuta come interlocutrice per una collaborazione produttiva.

Nel 2018 a Venezia la Fondazione Prada presentò la mostra Machines à penser, a cura di Dieter Roelstraete, un progetto che esplorava la correlazione tra le condizioni di esilio e i luoghi che favorirono la riflessione, il pensiero e la produzione intellettuale di tre fondamentali figure della filosofia del XX secolo: Heidegger, Wittgenstein e Adorno. Di quest’ultimo fu analizzata la condizione di esilio a Los Angeles, presentando la riproduzione del salotto della sua casa californiana: un interno borghese che avrebbe potuto benissimo essere la scenografia di un film hollywoodiano. Un altro elemento che rende complessa la relazione di rifiuto/integrazione nella società borghese da parte dei francofortesi.
A tale riguardo è nota la sarcastica battuta di György Lukács, che descrisse i francofortesi come ospiti in una lussuosa suite del metaforico “Grand Hotel Abisso”, nel quale potevano dedicarsi a contemplare l’abisso della crisi della modernità che si apriva sotto di loro seduti in comode poltrone «tra pasti eccellenti e intrattenimenti artistici».
La critica adorniana mette spesso in relazione il cinema e la musica popolare, l’uno e l’altra forme espressive che si affidano entrambe a tecniche di registrazione la cui riproduzione dipende da organizzazioni industriali, che le trasformano in prodotti culturali mercificati e in potenti strumenti di propaganda e di falsificazione.
Il nesso cinema-musica è centrale nella collaborazione tra Adorno ed Hanns Eisler, che portò alla scrittura del volume Composing for the films (1947). Il libro nacque con la specifica esigenza di illustrare agli “addetti ai lavori” quali fossero le condizioni nelle quali il compositore di musica per film lavora all’inizio degli anni Quaranta del secolo scorso. Gli autori si scagliarono con veemenza contro le pratiche vigenti nelle grandi case di produzione. Lo studio apparve a firma del solo Eisler fino al 1969. Adorno, infatti, decise di ritirare il suo nome per non essere associato alle idee politiche del co-autore. Eisler, accusato di comunismo, era in quel momento sotto indagine della Commissione per le attività antiamericane. La sentenza che ne seguì portò all’espulsione di Eisler dall’America e al suo rientro a Berlino Est.
- Adorno: la rivalutazione del cinema negli anni ’60.
Nei primi anni ’60 Adorno ritornò a prendere in esame le tesi centrali di critica del cinema espresse nella Dialettica dell’Illuminismo negli anni ‘40. Lo fece in particolate in due saggi “Resumé sull’industria culturale” e “Film Transparency”, pubblicati nella raccolta Parva Aesthetica. Saggi 1958-1967. Il concetto di Aesthetica, volutamente citato in latino, intende alludere ad un’estetica non-normativa, che non aspira più a definire modelli e valori artistici universali, ma che propone modi problematici di pensiero critico sull’arte. Nei due saggi citati Adorno riformula alcune sue posizioni teoriche indicative di una rivalutazione del cinema, che passa attraverso nuove tesi relative ai rapporti tra arte e tecnica, tra immagine e scrittura, tra natura e bellezza, tra tempo e movimento, tra fruizione artistica e mezzi di comunicazione di massa.
Ad influenzare la “svolta” adorniana ha certamente concorso la pubblicazione nel 1962 del Manifesto di Oberhausen, in cui un gruppo di giovani cineasti (Rainer Werner Fassbinder, Margarethe von Trotta, Alexander Kluge, Hans-Jürgen Syberberg, Volker Schlöndorff, Edgar Reitz e Wim Wenders e altri) denunciava una situazione di crisi del cinema tedesco e auspicava la nascita di un nuovo cinema libero da condizionamenti commerciali, culturali ed estetici. Adorno era molto amico di Alexander Kluge, la cui influenza fu determinante nello stimolare le considerazioni del filosofo francofortese.

Riflettendo sul vincolo realistico dell’immagine fotografica – cui in precedenza veniva imputata l’arretratezza del cinema rispetto alle altre arti – Adorno riconosce ora che il cinema più avanzato ha saputo sviluppare tecniche di montaggio in grado di dissolvere l’aderenza del negativo fotografico all’oggetto rappresentato. Qui è evidente il confronto, non privo di aspetti critici, con le tesi sul montaggio, volto a bloccare ogni sorta di empatia e a sviluppare un’intelligenza critica, espresse da Benjamin, ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica.
Appartiene a questa riconsiderazione del rapporto tra fruizione artistica e mezzi di comunicazione di massa la conclusiva formulazione che Adorno presenta sulla consapevolezza raggiunta dai consumatori dei prodotti dell’industria culturale. Se nella Dialettica dell’Illuminismo la coscienza individuale finiva per nullificarsi nel processo del produrre per consumare, negli scritti di Parva Aesthetica Adorno, anche sulla base di molte rilevazioni demoscopiche (riprese nelle Tesi di sociologia dell’arte, 1979) riconosce che la propaganda ideologica trasmessa dai film non viene necessariamente assimilata in modo passivo degli spettatori, i quali mantengono una capacità di distanziamento tra i contenuti dei messaggi trasmessi nei prodotti dell’industria culturale e la loro ricezione nella coscienza individuale, che così riesce a conservare una sua capacità critica.
Note sito-bibliografiche
Adorno Theodor W. and Benjamin Walter (1999) The Complete Correspondance 1928–1940, Henri Lonitz (ed), trans. Nicholas Walker (Polity Press: Cambridge).
Adorno Theodor; Eisler Hanns. (1947), Composing for the films, New York: Oxford University Press, (tr. it. Theodor W. Adorno, Hanns Eisler, La musica per film, Roma, Newton Compton Editori, 1975)
Adorno, T.W. (1979), Parva Aesthetica. Saggi 1958-1967 (1967), tr. it. di E. Franchetti, Feltrinelli, Milano.
Angelucci D. (2014), Filosofia del cinema, Carocci editore, Roma.
Benjamin W. (1991), L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino.
Benjamin W. (2013), L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica e altri saggi sui media, a cura di Giulio Schiavoni, RCS Libri, Milano.
Brenez N. (2021), T.W. Adorno: Cinema in Spite of Itself – But Cinema all the Same, in
https://www.sabzian.be/text/tw-adorno-cinema-in-spite-of-itself-%E2%80%93-but-cinema-all-the-same
Horkheimer Max; Adorno T. W. (1966), Dialettica dell’Illuminismo, tr. it. di R. Solmi, Einaudi, Torino
“THE TROUBLE WITH LIFE – AND DEATH”
di Paola Brunetta
Non leggo mai niente prima di vedere un film perché voglio essere neutra il più possibile, terreno vergine che possa stare in ascolto totalmente, carta bianca su cui andranno scritte le impressioni che il film suscita in me, sulle quali si potrà costruire, poi, l’interpretazione. Per cui, oggi, di “The Trouble With Being Born” di Sandra Wollner non sapevo nulla, al di là del rimando a Cioran. E mi sono lasciata guidare.
L’inizio sembra un film francese, estate, acqua (di una piscina privata), vegetazione, atmosfera, piccoli animali; un uomo disteso su una sdraio e una bambina che gioca. Poi una casa modernissima nel verde della campagna/ bosco, i due che parlano, che si avvicinano, la voce fuori campo della bambina, Elli, che racconta del legame molto stretto che ha con questo padre con cui fa cose che la madre non le permetterebbe di fare, come stare tanto tempo in acqua o stare sveglia tutta la notte. La nostra mente di spettatori a questo punto corre su tematiche forti, ci sarà un incesto? Sarà questo, il tema del film? Le immagini successive avallano e non avallano quest’ipotesi, c’è lui che compra un vestito bianco alla figlia, quasi un abito da sposa, e che le si stende al fianco e poi balla abbracciato a lei, ma anche l’affetto normale tra un padre (separato dalla moglie, si presume) e la figlia che vede per poco tempo, in questo caso la stagione estiva, come la ragazzina dice nel suo monologo in voice over. Si profila però anche un altro filo narrativo, che si fa sempre più grosso ed importante: la bambina è reale, o è un androide? Dei dettagli ci fanno pensare fin da subito alla seconda possibilità, in effetti: il salvataggio in piscina (troppo tardivo per un essere umano) e un piccolo blocco dei movimenti corporei che si potrebbe, però, ricondurre a una malattia (si aprirebbe, così, un altro filo tematico); ma ad un certo punto i due sono in bagno e lui le sistema la lingua e poi le cura una ferita chiaramente non umana, anche se ciò ci viene mostrato per frammenti di pochi secondi, e a questo punto abbiamo la conferma che, sì, la bambina è un androide che il protagonista tiene con sé e a cui racconta una storia, secondo cui lei sarebbe, dieci anni prima, scappata dalla casa della madre per raggiungerlo a Belgrado, dove si sarebbero coricati insieme ascoltando una canzone, la loro canzone. Della fuga in realtà veniamo a sapere più tardi, dalla TV; per ora lui le parla di Belgrado dieci anni prima, e la bambina-androide localizza il tutto in un bosco, in cui lei ha camminato tanto per raggiungere il papà, mentre qualcuno la cercava.
Sembra essere questo, l’insistenza della bambina su questa fuga che non si capisce quando sia collocata precisamente (dimenticavo: un elemento chiave, che ci fa anche capire che Elli è un androide, è il fatto che non ha il senso del tempo e che sembra apprenderlo dal padre, da quello che lui racconta); ma può essere anche la fine dell’estate, in coerenza con quanto la bambina ha detto fino a quel momento, che sarebbe stata lì, dal papà, nel tempo dell’estate; sembra essere questo, dicevo, il motivo per cui l’uomo, ad un certo punto, porta l’androide alla madre anziana, dicendole di tenerlo: ci andrà sicuramente d’accordo. Lì c’era una villa bellissima, qui un piccolo appartamento in un condominio di periferia; lì un gatto, qui un cane. Lì la modernità, qui il senso della decadenza semplice e discreta dell’abitazione di una persona di una certa età, con il suo carico di ricordi. Ed è qui che si innesta la seconda parte del film.
La donna tratta, o meglio cerca di trattare, la ragazzina-androide come sua nipote e le mostra le foto di famiglia, parlandole in particolare di un fratello, Emil, che è morto giovane dopo una colluttazione con lei, nella quale lei si è fatta molto male, un taglio alla testa che ora, per fortuna, non si vede quasi più. La porta a fare la spesa in un centro commerciale lì vicino, paesaggio urbano squallido e affascinante sapientemente fotografato da Timm Kröger, come tutto il film del resto e come, anche, è sapiente la regia (l’opera, alla Berlinale del 2020, ha vinto il premio speciale della giuria per la sezione Encounters); lei, la bambina e il cane. Ma presto la presenza dell’androide in quello spazio angusto diventa inquietante, forse per i ricordi che suscita, e dopo che la donna ha chiamato il figlio per dirgli che non la vuole più con sé, vediamo un tecnico che la sta riprogrammando in modo tale che sia Emil, il fratello morto giovane (e qui al critico o anche al semplice spettatore cinematografico si aprono altri file mentali, “Alps” di Yorgos Lanthimos, “Family Romance”, LLC di Werner Herzog e “I’m Your Man” di Maria Schrader, su cui torneremo); non prima che l’androide abbia sentito, al telegiornale, la storia di una bambina scomparsa dieci anni prima fuggendo dalla casa materna, nella zona in cui il film ha avuto inizio, le cui ricerche stanno ora riprendendo sulla base della ricostruzione al computer del volto che lei avrebbe oggi. Il volto di Elli.
In ogni caso, ora Elli è diventata Emil e con lui la donna sta meglio, anche se la vita che conducono è sempre quella, casa, centro commerciale, cane. Un bel giorno Emil vede, in un parcheggio, l’uomo della prima parte. Quella notte non riesce a dormire e si riproduce la scena vista all’inizio, della donna che gli si avvicina (dell’uomo che le si avvicina) per consolarlo (consolarla). L’uomo si era rivolto a Elli con affetto e l’aveva abbracciata, la donna respinge Emil nel momento in cui lui tenta un approccio fisico, sia pure solo affettuoso (e qui insorge un altro dubbio: con il vero Emil c’era stato incesto?) (file mentale per i cinefili, “Il giardino di cemento” di Andrew Birkin, da McEwan). E il monologo fuori campo di Elli ora Emil continua, con gli elementi relativi a Emil ma anche, verso la fine, con gli elementi di Elli, come se nella confusione temporale che caratterizza l’androide il passato entrasse nel presente, in tutti i sensi. Ad un certo punto Emil sparisce con il cane, e qui si pensa ad Elli, alla Elli quella vera, dieci anni prima. Però ora si vede un treno che lo sta per investire e si pensa alla morte di Emil, quello vero. Che non sappiamo come sia avvenuta, dopo la colluttazione. E poi si torna un po’ indietro: Emil e il cane sono a casa, lui dà una spinta alla donna (alla sorella) che cade sul pavimento sbattendo la testa, il sangue comincia a uscire, il cane lo lecca, l’Emil androide guarda immobile, pensando (sempre voice over) a ciò che la donna gli aveva detto sulla ferita ma anche a ciò che aveva detto a Elli suo padre, in riferimento alla famosa notte di Belgrado. E a questo punto si vede la sua morte sui binari, o meglio il post mortem, con il cane che guarda stupito, o forse no, i suoi resti di umanoide.
Quanto fragili siamo noi uomini, se il solo fatto di essere nati è percepito come un inconveniente… E quanti bisogni abbiamo… E quanto spesso cerchiamo di colmarli in maniera sublimata, attraverso attori (il documentario di Herzog) o attraverso androidi che impersonano le figure significative che abbiamo perduto… O che non abbiamo mai avuto.
In questo senso, per concludere in un modo più leggero, il citato “I’m Your Man”, in concorso alla Berlinale 2021 dove ha vinto il premio per la miglior attrice protagonista, mostra in chiave di commedia una società in cui degli androidi sostituiscono le persone che vorremmo avere con noi, androidi programmati con i requisiti che vorremmo che avesse, per esempio, il nostro uomo o la nostra donna. Il caso vuole che una collaudatrice di questo programma, che peraltro assolve al compito solo per potersi dedicare con più fondi alla ricerca che le interessa davvero e che è di tutt’altro genere, sia obbligata a tenere per tre settimane uno di questi androidi, quello che rappresenta, secondo i calcoli, il suo uomo ideale, lei che è single incallita e che ha interessi scientifici, o comunque intellettuali, che si discostano di molto da quelli di chi sogna una vita a due classicamente intesa. L’androide infatti comincia ad utilizzare con lei frasi romantiche da manuale per cercare di farla innamorare e di renderla felice, che è poi lo scopo di queste macchine per come sono state programmate, ma lei oppone una strenua resistenza a farsi “catturare” (dal programma, dall’amore…) e più volte cerca di restituire al centro di ricerca l’ingombrante ospite, salvo scoprirsi, quando lui alfine se ne va, innamorata di lui. Di lui o di se stessa?
Questo film è una commedia sentimentale, quindi la risposta ha un’importanza relativa e può essere anche quella romantica dell’amore che trionfa vincendo le resistenze di chi accampa pretesti di ogni tipo per sottrarvisi perché in realtà ne ha paura, ma il vero problema che gli androidi pongono è questo, quello del nostro narcisismo: ha senso costruire delle macchine che risolvono, oltre ai nostri problemi pratici, anche quelli emotivo-affettivi? Il dibattito è aperto.
“PAURA E DESIDERIO” IL PRIMO FILM DI KUBRICK COMPIE 70 ANNI
di Roberto Lasagna
“C’è la guerra in questa foresta. Non una guerra che sia stata combattuta o che lo sarà, ma qualsiasi guerra. E i nemici che qui combattono non esistono, a meno che non siamo noi ad evocarli. Questa foresta, quindi, e tutto ciò che vi accade, è fuori dalla storia. Solo le forme immutabili della paura, del dubbio e della morte provengono dal nostro mondo. Questi soldati che vedete conservano la nostra lingua e il nostro tempo, ma non hanno altro paese che la mente”.
La voce di un fantomatico narratore accompagna l’apertura di “Paura e desiderio” (“Fear and Desire”, 1953), dove una panoramica – da destra verso sinistra – inquadra le montagne e le foreste in cui prende avvio il primo lungometraggio del ventiquattrenne Stanley Kubrick. Il narratore introduce il contesto, uno scenario deprivato di una connotazione temporale, in cui quattro soldati, impegnati in una guerra ignota, sono dispersi nel territorio nemico.
L’aeroplano che li trasportava è precipitato sei miglia dietro le linee nemiche. La condizione restituisce la tensione e il disorientamento dei soldati – il tenente Corby, il sergente Mac e i soldati semplici Sydney e Fletcher. Il comandante segna in terra una traiettoria che risalta nel suo significato simbolico: il loro viaggio per la sopravvivenza è una missione dall’aspetto archetipico e quella che vivono i personaggi è una guerra circoscritta, ma potrebbero essere tutte le guerre. Adesso, il loro obiettivo è rientrare al comando, attraversando con una zattera un fiume sulla cui sponda opposta un generale nemico dimora in una caserma con un gruppo di soldati e potendo disporre di un aereo. Durante la notte, Corby e i suoi uomini uccidono senza pietà i soldati scorti dentro una baracca, di cui rubano il cibo e le armi. Il giorno seguente, in attesa del tramonto per poter navigare con la zattera, sono scoperti da una giovane contadina che non parla la loro lingua, e poiché temono che possa rivelare la loro posizione al nemico, la legano a un albero con le loro cinture e la lasciano sorvegliare da Sidney, il più giovane e anche quello di loro psichicamente più fragile. Sidney inizia una sorta di sconnesso monologo, intrattiene sinistramente la ragazza con parodie e racconti di cui la giovane non intende una parola. A un certo punto, in preda all’eccitazione, decide di slegarla convinto che lei desideri abbracciarlo, ma la donna una volta liberata tenta la fuga e viene uccisa con un colpo di pistola dal soldato. Questi, in preda al delirio, sparisce nella foresta al seguito di parole insensate e di una risata inquietante. La pattuglia nel frattempo è pronta ad attaccare l’avamposto nemico: Corby e Fletcher, una volta distratti i soldati di guardia della caserma, uccidono il generale e il capitano (anche loro interpretati dagli stessi Kenneth Harp e Stephen Coit), prendono inoltre possesso dell’aereo e si danno alla fuga. Nel frattempo Mac, ferito e sofferente sulla zattera, raccoglie il delirante Sydney ritrovato tra le acque.
Nonostante “Paura e desiderio” si ritroverà un giorno ripudiato dal regista, il film è un esemplare incipit di quello che diventerà l’universo dell’autore, con i suoi tratti e le sue caratteristiche. Le visioni e le ossessioni di Kubrick affiorano con chiarezza in un contesto immaginario, simbolico e ugualmente circoscritto, dove la violenza si accompagna ad alcuni interrogativi che il cinema del regista americano solleverà in futuro con lucido disincanto. La dimensione del pensiero occupa un posto principale di “Paura e desiderio”, a cominciare dalle parole del narratore, evocanti l’universalità e l’atemporalità del conflitto rappresentato, per arrivare ai pensieri ad alta voce dei soldati – qualcosa di cui farà tesoro Terrence Malik – e coniugandosi con la vocazione simbolica dove fa presto capolino l’ossessione kubrickiana del doppio – evocata tanto dalla somiglianza dei soldati tra le file del plotone “amico” quanto dall’utilizzo degli stessi attori nel doppio ruolo dei soldati “amici” e “nemici” -. Dimensione mentale all’interno di una cornice sperimentale dove l’abbozzo di temi, che un giorno saranno ripresi e riformulati in una cornice più rifinita, è qui espressione limpida e chiara di un cinema importante perché calato su temi e battaglie che segnano l’animo umano. Il tono freddo, impietoso, disturbante di Kubrick, è qui alle sue prime pagine pronte a fotografare la guerra come contesto di instabilità, dove i nemici sono fuori dalla storia, invenzioni della mente disposte a incarnare le forme della paura, del dubbio e della morte, monotone espressioni del nostro mondo in cui ci troviamo a vivere conflitti, limiti, trappole.
Kubrick lo dice chiaramente sin dalle parole d’avvio del film: quella di “Paura e desiderio” non è una guerra che è stata combattuta o una guerra che sarà, ma una guerra qualsiasi, dunque simbolica, immaginata. L’apologo antimilitarista che il film riassume porta con sé un elemento di sperimentazione che induce il cineasta a porre in risalto l’aspetto allegorico o iperreale della rappresentazione. Il film schiude pertanto il bisogno di fare già i conti con alcuni universali dell’autore, dalla crisi della ragione dell’uomo glorificato dalla modernità, alla doppiezza costitutiva che caratterizza un individuo posseduto dalla paura e dal desiderio (e che si trova a vivere, in altri termini kubrickiani, con occhi spalancati chiusi). Il titolo del film è perfettamente emblematico in tal senso e per i numerosissimi amanti e studiosi del cinema di Kubrick si tratta del primo momento di un lungo racconto, ripercorribile in 13 lungometraggi, da “Paura e desiderio” del 1952 a “Eyes Wide Shut” del 1999, in cui il cineasta sviluppa temi, pensieri, orientamenti sul modo di costruire il racconto cinematografico.
Paura e desiderio sono i sentimenti che predominano nella psiche e convivono in un conflitto che nel film è sempre pronto a manifestarsi. I pensieri dei personaggi danno voce al tentativo di controllare i sentimenti e trovano espressioni in rigidi dettati o pensieri limite. Qualcosa che conduce alla deriva del senso, amplificata dal proliferare di voci che accompagna le sequenze di fuga del tenente Corby e compagni, i quali sono loro stessi manifestazioni emblematiche di differenti modi di affrontare la paura e il desiderio: Corby (Kenneth Harp) esercita la logica e il controllo per trovare sempre una soluzione o una via d’uscita; Fletcher (Steve Coit) è il fedele e accondiscendente servo del tenente; Sidney (Paul Mazursky), è il giovane la cui follia diventa una via di fuga nonché accentuazione di un contesto allucinato; Mac (Frank Silvera) è l’eroe pragmatico, forse non meno colmo di esaltazione di quanto non lo sia di follia il soldato Sidney. La guerra è lo scenario in cui la ragione è corrosa dagli aspetti brutali dell’uomo, e il generale nemico, con il volto dello stesso attore che interpreta Corby, è preoccupato che Proteus, il cane ritrovato che lui chiama tenente, abbia da bere come gli altri soldati, dando espressione al paradossale stato di indolenza che caratterizza la sua condizione di militare abituato a gestire la morte delle truppe e memore di come l’armistizio possa essere una delusione (sono esattamente le sue parole, già anticipatrici di futuri personaggi kubrickiani). Eroismo, follia, razionalità, servilismo, sono aspetti che si materializzano tra le mosse di questi soldati che manifestano il proposito di rimanere civilizzati (non vogliono uccidere la ragazza) ma che ritroviamo in realtà in conflitto permanente, e inevitabilmente sotto scacco delle loro pulsioni e delle loro logiche.
La parabola che Kubrick comincia a raffigurare è quella di un cinema che utilizza con chiarezza la macchina da presa restando a lungo sui volti e sulle loro espressioni, portando qui un primo esempio di quello straniamento recitativo che obbedisce al desiderio di veder sbocciare i pensieri e le emozioni naturalmente. Una parabola dove l’incivilimento è una vicenda di maschere che solo in parte riescono a nascondere la brutalità e i propositi originari.
Costruendo le sue pagine di racconto come un documentario sulla psiche, Kubrick in “Paura e desiderio” racconta l’uomo nella sua incapacità di addomesticare la sua originaria brutalità, così che la guerra metaforica del film è una dimensione ineludibile: una guerra tra forze psichiche, tra consapevolezza e incoscienza, tra pulsioni e ragione. L’uomo si ritrova perennemente infatuato, incosciente e sotto scacco. Il rapporto uomo-donna è quindi nel film qualcosa di immaturo e sconsolante, messo in mostra in maniera beffarda nella performance esagitata del soldato Sidney dinanzi alla ragazza silenziosa e legata al palo. La donna che Sidney non si premura di conoscere, ma che egli immagina desiderosa di condividere la sua smania, non è che lo specchio dinanzi a cui Sidney non vede il mostro che è in sé. Incoscienza come sonno della consapevolezza, per un individuo facilmente manipolabile, che ritroveremo nel cinema di Kubrick sovente disorientato, spiazzato, magari sedotto da un’adolescente ammiccante di cui l’individuo adulto non saprà leggere il mondo interiore, oppure sottratto al suo piedistallo di tranquillità una volta a contatto con il mondo onirico e con le confessioni a sfondo erotico della propria compagna.
“Paura e desiderio”, film autoriflessivo, raccoglie influenze ejzenstejniane, in particolar modo nel modulare un racconto in cui il montaggio classico è sovvertito dalle intemperanze neoavanguardiste dell’ex fotografo di “Look”. Kubrick infatti eredita la lezione del cinema russo d’avanguardia, come nelle sequenze dell’assalto alla baracca dei militari nel bosco, in cui il racconto restituisce lo straniamento di un vero talento del New American Cinema attraversato da una cultura visiva di grande inventiva. La freddezza kubrickiana qui si affianca ad uno stordimento ruvido, al servizio di un racconto filosofico dove l’immagine tende ad animarsi di tensione simbolica. Un film che racconta e mostra, porta ad accentuare l’attenzione sulle immagini, e che il cineasta si impegnerà un giorno a togliere dalla circolazione disconoscendolo (lo paragonerà, etichettandolo come un esperimento amatoriale, a “un disegnino di un bambino attaccato al frigorifero”). Ma in ambito di archeologia kubrickiana, in “Paura e desiderio” si rintraccia il mondo dell’autore, a cominciare dall’ambientazione bellica seppure in chiave dichiaratamente metafisica.
Riportato alla luce grazie a una prima riproposizione pubblica del film nel 1993 al Telluride Film Festival, in Colorado, dopo che Kubrick aveva cercato di distruggere tutte le copie esistenti, “Paura e desiderio”, che non ebbe successo di pubblico, vanta la sceneggiatura di Howard Sackler, drammaturgo che collaborerà – non accreditato – al successivo “Il bacio dell’assassino”, il primo lungometraggio “riconosciuto” dal cineasta americano. I riferimenti alla Tempesta di Shakespeare, e la considerazione che il film fu girato mentre era in corso la Guerra di Corea, si coniugano con la rappresentazione dello stato mentale dei personaggi: tutti si muovono e reagiscono seguendo la loro personalità, i loro desideri e le loro paure, come anticipando quegli aspetti junghiani che ritroveremo (anche) in “Full Metal Jacket”, il film di Kubrick che più immediatamente lascia pensare a “Paura e desiderio”. Se all’epoca la scelta di far interpretare i soldati protagonisti e i loro nemici dagli stessi attori fu giustificata da motivi di budget, essa evoca innegabilmente una rappresentazione dell’Ombra junghiana, aspetto che ritroveremo proprio nel finale del film di guerra che Kubrick licenzierà nel 1987.
Kubrick dirige, fotografa, monta e produce il suo film, affidando la colonna sono a Gerald Fried il quale, nelle sue musiche, importa influenze di compositori come Prokof’ev e Bartók, denunciando scelte musicali in armonia con la poetica autoriale del regista il quale in futuro affinerà le sue scelte e si rivelerà sempre autocritico rispetto al lungometraggio d’esordio.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
TREDICI CORTOMETRAGGI DI AUTORI FEDIC DI IERI E DI OGGI IN UNA RASSEGNA DEL CINEVIDEOCLUB PESARO
di Paolo Micalizzi
Un Cineclub Fedic che si sta facendo valere per la sua attività è il CineVideoClub Pesaro, di cui è Presidente Giorgio Bertuccioli. L’11 marzo ha organizzato in quella città marchigiana una Rassegna cinematografica di cortometraggi amatoriali Fedic che comprendeva 13 opere. Le proiezioni sono avvenute nel prestigioso Hotel Vittoria e hanno riguardato un significativo Panorama che va dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. Degli anni Cinquanta, cioè da quando gli autori venivano denominati cineamatori e così si è continuato a chiamarli fino al Convegno di Bergamo del 1960 quando il termine venne sostituito con quello di cinema indipendente. E che non si tratta di un cinema d’amatore, che molti intendono come hobby, lo si è visto nelle opere presentate di ieri e di oggi. A mostrare come già negli anni Cinquanta, anni in cui sono emersi molti autori che poi hanno abbracciato il cinema come professionisti, dimostrando così il loro valore professionale, sono stati presentati, da chi scrive, due cortometraggi dovuti a Renato Dall’Ara e Franco Piavoli. Del primo è stato proiettato “Scano Boa” (1954) un classico del cinema realizzato nel Polesine, che coglie una situazione particolare, ispirata ad un fatto di cronaca, e cioè quella verificatasi alle foci del Delta del Po in cui sulla stessa barca viaggiavano una bara ed una donna incinta che in mezzo al fiume ha dato poi vita ad una nuova creatura. Di Franco Piavoli, che con i film successivi è stato giustamente definito il poeta – contadino avendoli girati nel territorio rurale di Pozzolengo dove abita, è stato presentato “Emigranti” realizzato nel 1963. Un film, permeato di poesia, che coglie un’umanità povera costretta ad emigrare dalla propria terra in cerca di lavoro. L’occhio di Piavoli, attraverso una cinepresa 8 millimetri, coglie un gruppo di persone che su un treno trascorrono un’intera giornata, compresa la notte, per vederli giungere alla stazione di Milano, punto di snodo per la Svizzera e la Germania. Persone con gli occhi pieni di disperazione e di speranza di un futuro migliore che nel lungo percorso vivono una infinita solitudine. Agli anni Settanta appartiene invece “Nena” (1984), introdotto dallo stesso regista Roberto Fontanelli, che racconta la vita di Nazzarena Casini, l’ultima traghettatrice del Po, nata e vissuta a Salvatonica nel ferrarese, di cui Roberto Fontanelli coglie il profondo amore per il fiume e l’intensa umanità.
All’epoca nostra appartengono invece “La Porziuncola” di Lauro Crociani, girato sul luogo in cui Francesco D’Assisi ebbe la vocazione. Ma anche “Stage 2022” in cui Roberto Merlino ricostruisce lo svolgimento di uno Stage Fedic che Corte Tripoli Cinematografica organizza annualmente a Calci (Pisa). E “Si, lo voglio”, opera del 2022, realizzato da Rocco Olivieri e Vincenzo Cirilli, su soggetto e sceneggiatura di Enzo Bruno, che coinvolge lo spettatore fino alla fine, quando si scopre l’intimo segreto che unisce due uomini. Uno sguardo sulla realtà del riformatorio di Pesaro è poi nel cortometraggio di Agostino Vincenzi che posa il suo sguardo pietoso su un’umanità emarginata dalla Società, del Cineclub “Cessare Pandolfi” di Pesaro è anche “El prem amor” di Giorgio Ricci che traduce per lo schermo una poesia dialettale del pesarese Antonio Nicoli, ma anche la poesia della torinese Maddalena Beltramo dal titolo “Ognisanti”. Un’altra opera di Giorgio Ricci è “Il ladro di biscotti”, tratto da un racconto di Valerie Cox che ambienta alla stazione di Pesaro una storia coinvolgente e divertente basata su un equivoco. In programma poi altri tre cortometraggi, presentati dagli stessi autori. Di Claudio Venanzini “Diagonia” incentrato sulla musica in un’opera sperimentale basata su “dodici note ma nessun accordo possibile”. Della giovane Sonia Bertuccioli “Occhio verde” imperniato su “una realtà distopica di un probabile futuro”, e di Giorgio Bertuccioli “Non tutte le ciambelle riescono col buco”, una seconda indagine del Commissario Panizza, personaggio da lui inventato di una serie poliziesca.
DOCUMÈ
IL DOCUMENTARIO PER ME
di Gianluca Castellini
Si è svolta presso il centro di attività giovanili “la Fabbrica delle Candele” di Forlì, la seconda edizione di Documè. Un appuntamento che vede al centro dell’attenzione, ragazzi tra 15 e 18 anni, analizzare e valutare 16 documentari provenienti da 12 paesi.
Il documentario offre allo spettatore uno schema visivo ricco di suggestioni, frutto di racconti spesso sconosciuti. il documentario può sovvertire o confermare un pensiero, può sorprendere, può creare processi empatici o di identificazione, può commuovere o fare sorridere. Il documentario è un linguaggio universale, utile allo sviluppo del pensiero.
E’ un viaggio in territori e argomenti sconosciuti. Tutti questi paradigmi, li ritroviamo anche nella 2.a edizione di Docume’ dove i racconti s’intrecciano tra loro trovando nuove forme introspettive. Si parla di guerra, tradizioni, ecologia, arte, pandemia, tematiche declinate con le innumerevoli tecniche che il cinema di animazione offre. Sono nuovi punti di vista, mai del tutto scontati che creano un interesse anche per argomenti a volte distanti dal nostro quotidiano. In 2 giornate una giuria composta da 210 ragazzi tra i 15 e i 18 anni, delle scuole Istituto Professionale Ruffilli e Liceo Artistico di Forlì, ha visionato 16 documentari animati apprezzandone sia le tecniche che le tematiche e conoscendo nuove prospettive. Sono nate discussioni, opinioni in un confronto maturo, all’insegna della curiosità. In linea generale si è avvertito un sottofondo di stupore al termine di ogni proiezione e diversi film sono stati accompagnati da lunghi applausi e brusii di approvazione. I film provenivano da 12 paesi. Al termine di lunghi ballottaggi il film che ha prevalso è risultato: “A guerra finita” di Simone Massi.
Proprio su quest’ultimo film la giuria ha indicato il massimo dei voti, con un paio di alzate di mano in più rispetto al film Svizzero “Idodo”. A guerra finita è un urlo di dolore di fronte alle aberrazioni della guerra. E’ un invito a dire basta di fronte al folle pensiero di sopraffazione. E’ un commovente messaggio sottolineato dalla voce sofferta di Gino strada che invita gli uomini ad abbandonare ogni forma di violenza: Un mondo senza guerra è un’altra utopia che non possiamo attendere oltre. Il corto prodotto da Simone Massi in collaborazione con Emergency, è un film in bianco e nero di 5 minuti ed è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia del 2022.
Riportiamo i titoli degli otto finalisti: “Painting by numbers” (Australia), “Bach Hong” (Francia), “Abili a vivere” (Spagna), “A guerra finita” (Italia), “59days” (Grecia), “Iododo” (Svizzera), “Speak kandisky” (Canada), “Strates” (Francia).
La durata media dei film partecipanti era di 7 minuti. Un tempo breve ma con il giusto pathos per attirare l’attenzione della giovane giuria.
Le proiezioni sono state precedute da un’analisi didattica condotta da Simone Soranna della redazione di Long Take, sul significato di documentario e sulle molteplici sfaccettature: Documentario Sociale, geografico, politico, d’inchiesta, biografico, docu-fiction.
Un ulteriore spazio è stato dedicato al Mockumentary, (mock «falso» e (doc)umentary «documentario), il cosidetto finto documentario molto apprezzato dai ragazzi in sala per le sue caratteristiche spesso divertenti. Sono stati riportati alcuni esempi: “Il Mundial dimenticato” del (2011) di Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni e “La vera storia della partita di nascondino più grande del mondo” (2021) di Davide Morando, Irene Cotroneo, Paolo Bonfadini.
Al termine delle proiezioni alcuni ragazzi sono stati intervistati dallo staff sedicicorto, con un giudizio generale sui film e sulle tecniche di animazione rappresentate.
Il documentario animato rappresenta un efficace sistema per trattare argomenti anche complessi, grazie all’impatto visivo che le tecniche di animazione riesce a trasmettere. Inoltre la breve durata dei film permette di mantenere alta la soglia di attenzione.
IL “TIM BURTON” DI MATTIA ALLEGRUCCI
(CINECLUB CESARE PANDOLFI DI PESARO)
di Giorgio Ricci
Sul suo canale YouTube, Mattia Allegrucci ha dedicato due video alla filmografia del regista Tim Burton.
Attraverso una narrazione legata a ricordi personali e alla biografia del regista raccontata nel libro “Burton racconta Burton”, il socio del Cineclub Cesare Pandolfi di Pesaro approfondisce le tematiche e gli stili narrativi e cinematografici cari al regista di Burbank.
Burton, autore di numerose pellicole di successo, è una personalità popolare e apprezzata dalla massa e dalla critica, dalla quale è elogiato per i suoi toni dark e per la sua vicinanza ad autori del calibro di Terence Fisher e James Whale, ai quali si ispira.
Tra le sue opere più famose ricordiamo “Edward Mani di Forbice”, “La Fabbrica di Cioccolato” e “Big Fish”, quest’ultimo ritenuto da molti come il suo capolavoro.
Il documentario di Mattia Allegrucci, diviso in due parti, è stato girato all’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro con l’aiuto di Giorgio Ricci, presidente del Cineclub Cesare Pandolfi.
Questo il link per i video:
https://youtu.be/NCujz0MQ7bo
FESTIVAL ED EVENTI
PREMI ED EVENTI AL PORDENONE DOCS FEST 2023
di Paolo Micalizzi
Un bilancio positivo quello della XVI edizione del Pordenone Docs Fest che ha registrato in cinque giorni intensi di proiezione oltre 3.000 biglietti venduti, ma anche la presenza di 300 ospiti provenienti dall’Italia e dal mondo in rappresentanza di 29 Paesi, con 25 film in anteprima nazionale e 3 prime assolute. Film che hanno soprattutto testimoniato la necessità di lottare ancora per il ruolo delle donne e di impegnarsi per i diritti civili. A conquistare il Gran Premio della Giuria (la regista cilena Valeria Sarmiento, la regista e sceneggiatrice Costanza Quatriglio e la critica cinematografica Beatrice Fiorentino) è stato “Moosa Lane”, un personale racconto epico della regista danese Anita Matland Hopland che per quindici anni ha documentato la storia delle sue due famiglie, – tra Karachi, in una via chiamata Moosa Lane, e Copenhagen – allo scopo di esplorare le proprie origini e di comprendere se stessa. Un film scelto dalla Giuria perché la storia raccontata “è uno specchio del presente in cui si riflettono controversie e tratti di unione tra culture diverse e distanti. Un esempio luminoso di cinema nel suo farsi, aperto, libero, epifanico”.
È stata anche attribuita una Menzione speciale a “When spring came to Bucha” di Mila Teshaieva e Marcus Lenz che documenta il trauma della guerra in Ucraina chiaramente visibile nei volti della gente che esce dai rifugi e cerca senza sosta i corpi dei propri cari. Un’opera che non mostra le atrocità subite dal popolo ucraino ma il loro sconcerto per essere stati attaccati da un Paese con così tanti legami, tra famiglie e amici.
Ma anche la capacità di resistere e ripartire, piena di speranze. Premio Green Documentary Award, per il miglior film a carattere ecologico a “The Oil Machine” dell’inglese Emma Davie, incentrato sul futuro incerto del petrolio, al centro dell’economia della nostra società, ad opera di attivisti ed investitori che chiedono un cambiamento. Premiato “per la capacità di restituire la complessità della crisi climatica dando voce a scienziati, esperti, economisti e attivisti senza dimenticare il punto di vista delle compagnie petrolifere e dei lavoratori che temono di perdere il proprio lavoro”. Un film aperto al dialogo.
Un Premio anche da parte dello Young club di Cinemazero e dei 60 studenti di cinema di tutta Italia accreditati al Festival. È stato assegnato a “Singing on the rooftops” della spagnola Eric Ribes Reig con protagonista Gilda Lowe, Eduardo, l’ultima delle drag queen della Barcellona trasgressiva del Raval che a 90 anni continua, malgrado l’età ad esibirsi sul palcoscenico, la cui vita prende una svolta sorprendente quando accetta di prendersi cura di una bambina di tre anni il cui padre è finito in prigione. Un‘opera, secondo i giurati, “che racconta diversi aspetti dell’inclusività, mostrando che la cura e l’amore possono superare ogni barriera di età, di sessualità, di origini”. Premio del pubblico a “The art of silence “dello svizzero Maurizius Staerkle Drux , documentario sulla vita del leggendario artista e mimo Marcel Marceau. Ma anche Premio Virtual Reality a “Myriad” di Michael Grotenhoff e Christian Zipfel. Assegnato anche il Premio della Critica, in associazione con l’AFIC e il SNCCI – composta da Roberto Baldassarre, Massimo Lechi e Riccardo Lo Re – al film “Steel life” del regista peruviano Manuel Bauer che racconta un affascinante viaggio cinematografico lungo la ferrovia peruviana in cui il regista coglie la disillusione degli abitanti dei luoghi attraversati costretti a migrare per lo sfruttamento eccessivo dell’ambiente. Per la Giuria, un’opera dalla “magistrale capacità di racconto e la precisione dell’analisi del contesto socio – economico di un Paese sfruttato dal sistema capitalistico”.
Di grande interesse alcuni avvenimenti. In particolare quello relativo a “Donne con la Macchina da Presa” che ha presentato alcune opere del documentario femminista italiano dovute, tra le altre, a Maricla Boggio, Isabella Bruno, Rosalia Polizzi, Rony Daopoulo e Annabella Miscuglio. Un omaggio particolare è stato poi reso a Valeria Sarmiento con la presentazione di tre film inediti in Italia. Conclusione del Festival con un Concerto eseguito da Massimo Zamboni su un film dal titolo “Arrivederci, Berlinguer!” di Michele Mellara e Alessandro Rossi, attualizzato per raccontare la statura politica e sociale di un Berlinguer presente, intenso, umano.
CORTINAMETRAGGIO 2023
VENTISEI NUOVI TALENTI PER IL CINEMA ITALIANO AL FESTIVAL DI CORTINA
di Paolo Micalizzi
Ancora un’edizione di successo per Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto dalla vulcanica ed attivissima Maddalena Mayneri che da 18 anni si svolge nella Regina delle Dolomiti. Ventisei i nuovi talenti che la selezione, scelta dal direttore artistico Nicolò Gentili ha presentato quest’anno, su 421 opere pervenute, all’attenzione del numerosissimo pubblico che ha affollato l’Alexander Girardi Hall di Cortina. Secondo le cifre fornite dagli organizzatori oltre 5.000 presenze tra ospiti, pubblico e talent. A fregiarsi del Premio Cortinametraggio per il miglior film è stato “The Delay” di Mattia Napoli con protagonista un uomo fuori sincrono, con il ritardo, che cresce di giorno in giorno che lo porta in una crisi di nervi e lo costringerà a mettere in discussione il ritmo della propria vita.
“Un’opera in cui il regista è riuscito a mantenere il difficile equilibrio fra dramma e commedia, fra realismo e narrazione metaforica” secondo la Giuria composta da Laura Morante, Francesco Pannofino, Pier Giorgio Bellocchio, Giulia Andò, Morena Gentile, Roberta De Paolis e Antonia Truppo. A conquistare la miglior regia è stato invece “Miranda’s Mind” di Maddalena Crespi incentrata su una donna, Miranda, che dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto da parte di un editore per la pubblicazione del suo romanzo prova a cercare pace con il fatto che potrebbe non raggiungere mai il suo scopo. Ed inizierà un viaggio alla ricerca di se stessa. Un tema intimo e complesso, secondo la Giuria, che con maestria la regista costruisce “un racconto sincero e preciso, e, come in un romanzo ci conduce nella mente della protagonista dando vita ai suoi desideri ed alle sue angosce”.
A dare vita al ruolo di Miranda, la bravissima Valentina Bellè. Premiati con una Menzione speciale, “Caramelle” di Matteo Panebarco e “Chi spara per primo” di Emanuele Palamara. Il primo, narra di un legame affettivo fortissimo che unisce tre generazioni: padre/nonno, figlia/madre e nipote/figlio. Il secondo è ambientato nel mondo della piccola criminalità della provincia napoletana decisa a seguire le gesta dei più grandi.
Ancora premi con Rai Cinema Channel che viene attribuito a “Torto marcio” di Prospero Pensa che prende l’avvio da un ragazzo che parcheggia nel posteggio riservato ad un disabile e si sviluppa con la sua spiegazione ad un passante. Giulia Grandinetti si aggiudica poi Il Premio Rete Doc alla migliore regista donna, grazie al suo “Tria – Del sentimento del tradire”, una storia tragica, sospesa tra la vita e la morte ambientata in una Roma distopica dove vige la legge per cui le famiglie immigrate non possono avere più di tre figli. Se ne arriva un quarto lo si fa nascere, ma uno deve essere ucciso, dando alle femmine la precedenza per il sacrificio. La Giuria lo ha premiato “per la maturità registica e per aver affrontato il tema del potere con particolare sofferenza e denuncia”. Un’apposita Giuria, composta da Roberto Ciufoli, Massimo Cappelli e Simone Colombari ha premiato poi come migliore commedia l’opera di Emanuele Vicorito “Tre volte alla settimana” incentrato su tre sorelle, assidue giocatrici del Lotto che tre volte alla settimana tentano la fortuna. Un giorno si trovano di fronte ad una scena di tradimento: diventa così l’occasione per tentare la fortuna che cambierà per sempre la loro vita. Una Menzione speciale è stata poi assegnata a “Feliz navidad” di Greta Scarano: per la Giuria “la storia di una famiglia bizzarra vista attraverso gli occhi preoccupati e poi sempre più coinvolti della fidanzata del figlio”. “Reginetta” di Federico Russotto si guadagna poi il Premio della Giuria Young – presieduta da Marcello Foti e composta da Selene Caramazza, Rocco Fasano e Francesco Centorame – con la motivazione “per l’originalità della narrazione, unita alla poetica e a tratti anche nostalgica rappresentazione della nostra cultura contadina” ed anche perché trattasi di un “affresco quanto mai esemplare di un contesto culturale e sociale assai diffuso nell’Italia del dopoguerra”. Infine, e questa è una novità, è stato assegnato il Premio della Stampa a “9th Floor to the Right” di Andrea Romano, un Corto incentrato sulla strana situazione che si crea quando in casa di Lorenzo si presenta inaspettatamente oltre all’amico che aspettava una terza persona. La Giuria era composta da Giovanni Bogani, Enrica Brocardo, Alessandra De Tommasi, Titta Fiore, Alvaro Moretti, Raffaele Panizza e Michela Tamburrino. Il Premio miglior colonna sonora è stato appannaggio di Sergio Bachelet che l’ha composta per “Reginetta” di Federico Russotto, storia ambientata nella Ciociaria dei primi anni Cinquanta con protagonista una ragazza che mira a diventare Miss Italia e che per arrivare alla giusta trasformazione fisica viene sottoposta dalla famiglia ad una serie di costrizioni fisiche che diventano una vera e propria tortura. Ancora Premi: l’Old Wild West ne ha attribuito uno alla sigla ufficiale del Festival.
NOTE DI UN CRONISTA
di Maurizio Villani
Martedì 21 marzo, con la cerimonia inaugurale all’Alexander Girardi Hall, si è aperta la XVIII edizione di Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri, rivolto alla scoperta dei giovani talenti della cinematografia breve italiana. La manifestazione cortinese si è protratta fino a sabato 25 marzo con lo svolgimento della cerimonia di premiazione dei vincitori delle varie categorie in concorso. A questa edizione, condotta da Elettra Mallaby e Roberto Ciufoli, ha arriso un successo record con oltre cinquemila presenze tra ospiti, pubblico e talent. Sotto la direzione artistica di Nicolò Gentili tra i 421 cortometraggi presentati, ne sono stati selezionati 26, proiettati nel corso di cinque serate. Accanto a questa sezione competitiva, il Festival presenta, come sua abitudine, incontri, mostre, workshop e intrattenimenti.
Novità di quest’anno è stata una selezione di cortometraggi, fuori concorso, dedicata all’Afghanistan, curata da Sohila Akbari giornalista e avvocato impegnata nella difesa dei diritti delle donne.
Tra le varie manifestazioni collaterali, va ricordato l’incontro NUOVO IMAIE IN ALTA QUOTA, ATTORI E REGISTI SEMPRE PIÙ IN ALTO con l’attuale presidente dell’Istituto Andrea Miccichè, che ne ha illustrato le funzioni e le finalità, dando conto delle opportunità di finanziamento cui possono accedere giovani registi per la produzione di cortometraggi. NUOVO IMAIE, acronimo di Istituto mutualistico artisti interpreti o esecutori, è un organismo di gestione collettiva che gestisce e tutela i diritti maturati dagli artisti, interpreti o esecutori del settore audiovisivo e musicale, amministrando e ripartendo il cosiddetto “equo compenso” dovuto ai suoi rappresentati per la pubblica diffusione, comunicazione, trasmissione e riutilizzazione delle registrazioni fonografiche da essi eseguite e delle opere cinematografiche o assimilate da essi interpretate. L’Istituto, tra le molte sue competenze, è al fianco degli artisti anche nella realizzazione di progetti di produzioni e distribuzione di lungometraggi e cortometraggi, “grazie allo stanziamento di fondi per lo studio, la ricerca, la formazione, il sostegno professionale e la promozione, contribuendo alla realizzazione di opere che diano nuova linfa al mercato musicale e audiovisivo e di conseguenza alla cultura del nostro paese. La disponibilità complessiva di fondi nel 2023 per favorire la produzione di cortometraggi è di due finanziamenti di 300.000 euro, che possono essere elargiti fino ad un massimo di 20.000 euro a film.

Tra i numerosi eventi speciali il più originale è stata la proiezione de “La porta in faccia” di Gianni Ippoliti, un corto che per la sua folgorante icasticità non può essere raccontato, ma va solamente visto.
Di tutt’altro tenore gli eventi speciali del 2023 che hanno avuto al centro la collaborazione tra il Festival e l’Aeronautica Militare e la Polizia di Stato. Per celebrate il centenario di fondazione dell’Arma aeronautica sono stati proiettati tre brevi spot del regista Maurizio Simonetti, che raccontano la storia di Roger – questo è anche il titolo dei tre episodi – un bambino che desidera volare e che realizza il suo sogno diventando pilota militare.

La collaborazione tra Cortinametraggio e la Polizia è stata illustrata in una conferenza stampa all’Hotel De La Poste dalla dott.ssa Angela Caruana dell’Ufficio Comunicazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha parlato di come la Polizia abbia, per prima tra le Forze armate, consentito ad atleti disabili di essere assunti in Polizia. Questo tema è stato poi rappresentato nel corto “Segni molto particolari” di Alessandro Parrello, che racconta la storia di Laura, una giovane campionessa paraolimpica di nuoto non vedente, operante nel Commissariato romano di Ponte Milvio, la quale dà un contributo determinante alla risoluzione di un caso rimasto insoluto da tempo.
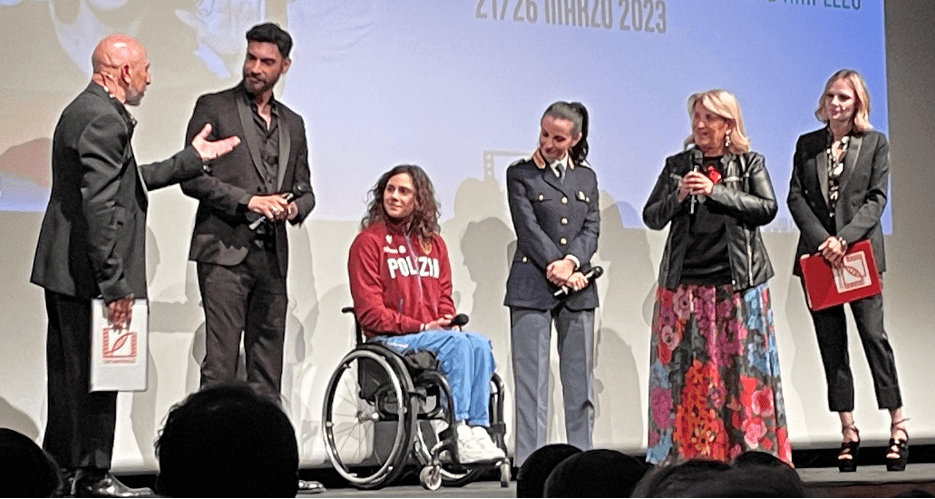
Nel corso della serata conclusiva è salita sul palcoscenico l’atleta paraolimpica, oggi nella Polizia di Stato, Giulia Ghiretti, che ha dichiarato: “Credo che la forza di questo corto sia nel fatto che la protagonista mette a disposizione le sue qualità per fare squadra. Per me è un onore indossare questa maglietta, per me è una porta che si è aperta e lo sarà anche per i futuri nuotatori e sportivi paraolimpici di domani.”
La 18esima edizione di Cortinametraggio si è conclusa con la proclamazione dei vincitori. Ne parla nell’articolo precedente Paolo Micalizzi
A conclusione della premiazione, Maddalena Mayneri ha chiuso la serata dicendo: “Vedere realizzato tutto lo sforzo e il lavoro fatto mi riempie di orgoglio e sono fiera non solo di chi ha vinto questa sera ma di tutti i registi che hanno partecipato e sono stati selezionati, perché per me sono tutti vincitori. Realizzare un festival come questo da ben 18 anni è un onore che sono orgogliosa di portare avanti. Anche quest’anno il pubblico ha riempito le sale delle proiezioni e degli incontri, dimostrando che Cortinametraggio non è solo un festival: è un festival di cui gli spettatori hanno bisogno e che arricchisce in maniera decisiva l’offerta culturale non solo di Cortina ma di tutto il territorio. Per questo siamo già al lavoro sulla 19esima edizione, che si terrà dal 12 al 17 marzo 2024”.
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO
“BLEU SHUT”
di Roberto Baldassarre
Regia: Robert Nelson; Musica di droni: Blue Crumb Truck; Produzione: City Limits Films; Durata: 33:04 (24 fotogrammi al secondo)
Il cortometraggio, attraverso la sua breve durata, consente anche di poter sperimentare sulle immagini e la struttura narrativa, forgiando opere in bilico tra classico filmato e perfomance visiva (ripetibile in loop). Tra i molti cortometraggi di questo tipo che si potrebbero prendere ad esempio, uno dei più stimolanti è “Bleu Shut” (1970) di Robert Nelson. Quest’opera fu proiettata anche agli Incontri del cinema di Sorrento nel 1970, che quell’anno aveva come focus il New American Cinema e il cinema underground americano. Il giovane Martin Scorsese, regista a quel tempo di una manciata di cortometraggi e del lungometraggio “Chi sta bussando alla mia porta” (“Who’s That Knocking at My Door”, 1967), era il curatore della selezione.
“Bleu Shut” è etichettabile come un patchwork, che in poco più di mezz’ora mescola vario materiale filmico e audio, ed è un’opera che si muove su due piani. Questi due livelli sono spiegati dallo stesso Robert Nelson, in versione “negativa”, alla fine del corto. Il primo livello, ovvero il variegato materiale filmico mostrato, sono “frattaglie” estrapolate da home movies, film del passato e/o di progetti abortiti di Nelson, e servono a fornire una base visiva in cui lo spettatore può immergersi e immaginare infiniti mondi, e quindi seguire il fine ultimo del cinema: creare fantasmagorie. Il secondo livello è dettato dal tempo, pertanto legato alla logica. Nell’angolo superiore destro, è posto un orologio che scandisce il tempo che passa, e conferma alla fine che il cortometraggio è durato effettivamente 30 minuti.
Questi trenta minuti, come avverte all’inizio una voce femminile fuoricampo, sono esatti, perché il racconto si svolge in quella mezz’ora, e i tre minuti finali sono “semplicemente” un’extra in cui il regista entra in scena per spiegare brevemente il fine ultimo della sua opera. Una composizione, giocata sull’adagiamento del tempo prestabilito, che anticipa in un certo qual modo “F come falso” (“Vérités et mensonges”, 1973) di Orson Welles, in cui il regista avvertiva lo spettatore che avrebbe detto la verità per la prossima ora. Il film, invece, dura 85 minuti, pertanto la coda finale è menzogna, gioco. E quei tre minuti finali, che non rientrerebbero nella durata vaticinata all’inizio, sono una “facezia” in cui il regista e la troupe si divertono, poiché il corto è terminato ed è come se stessero smontando il set (ma per lo spettatore è ancora spettacolo).
In questo patchwork, è intrigante il found footage assemblato, perché spazia da anonimi filmati amatoriali d’antan, a spezzoni di film di vario genere, e finanche un vetusto hard-core molto sgranato. E tra i differenti lacerti, c’è anche “La passione di Giovanna D’Arco” (“La passion de Jeanne d’Arc”, 1928) di Carl Theodor Dreyer. Punto principale di questo cortometraggio, invece, è il quiz in cui due concorrenti (lo stesso Nelson e William T. Wiley) devono indovinare il nome delle lussuose imbarcazioni mostrate.
Noi sentiamo soltanto le voci (e i ragionamenti) di questi due concorrenti e della valletta che presenta la manche di gioco, perché lo schermo è occupato, di round in round, da un’immagine fissa del battello da indovinare. Immagini da rivista patinata, sineddoche di una cultura – americana – superficiale che occupa prepotentemente lo spazio visivo, e il non mostrare i concorrenti e la valletta è per evidenziare che potrebbero essere qualsiasi individuo/cittadino americano. Non interessano i volti, ma i loro ragionamenti e il loro piacere nel giocare a questo futile passatempo.
Questo gioco, ripetitivo e noioso, è una stilettata contro gli imperanti quiz televisivi, che occupano i palinsesti, mentre le immagini filmiche che appaiono tra una manche e un’altra, divengono, per assurdità, come dei break pubblicitari. Immaginifiche scene, che provengano da un classico della storia del cinema oppure da un greve porno, svilite a spot.
Robert Nelson (1930-2012) ha realizzato soltanto cortometraggi, tra la prima metà degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta. In totale, una decina di lavori. Se “Bleu Shut” si può considerare la sua opera più compiuta, durevole nel tempo sebbene ben certifichi il periodo in cui è stata realizzata, “Grateful Dead” (1967) e “The Great Blondino” (1967) sono le sue opere più note, di cui la seconda realizzata assieme a William T. Wiley. Il primo è un brevissimo corto (meno di 8 minuti), composto da caotiche immagini (sfocate, mosse, rese negative, ecc.) del gruppo, commentate da alcune canzoni del medesimo gruppo; quest’opera si potrebbe considerare un proto videoclip… lisergico. “The Great Blondino”, al contrario, è un’opera di oltre 40 minuti, ma con musica dei Grateful Dead. Girato nel 1966, senza sceneggiatura e una pur minima idea di struttura, quest’opera s’ispira all’acrobata Charles Blondin (1824-1897), che tra le molte funamboliche imprese attraversò su di una fune le cascate del Niagara. Nel corto di Nelson e Wiley quell’ardita impresa viene usata come metafora per descrivere, con una narrazione molto libera e “caotica”, le disavventure del giovane Blondino, che scappa da un poliziotto, è plagiato da una puttana ma infine riesce nella peripezia di fare una temeraria attraversata, come il suo – quasi – omonimo.
OCCHIO CRITICO
EMMANUEL MOURET. UNA RELAZIONE PASSEGGERA
di Paola Brunetta
Leggero, divertente, scanzonato ma al contempo commovente e nel finale piuttosto triste, anche se aperto a possibilità diverse, il nuovo film di Emmanuel Mouret parla ancora d’amore in modo molto francese, sotto il segno di Rohmer con Marivaux sullo sfondo, anche se qui il rimando esplicito è a “Io e Annie” e anche a “Una relazione privata”, il film di Frédéric Fonteyne del 1999 che mostrava gli incontri tra due amanti di cui non si sapeva, o meglio non si vedeva, nient’altro che il loro stare insieme, in quel caso volutamente solo fisico, fino a che lo sviluppo di un sentimento non faceva terminare, con dolore sottaciuto, una relazione che era nata come sessuale e che non poteva assumere altre forme, men che meno delle forme sentimentali. Il titolo originale era non a caso “Une liaison pornographique”; e anche il nostro film, dal titolo italiano molto simile, in originale assume una connotazione un po’ diversa, che è quella della cronaca di una relazione passeggera. La storia, la descrizione passo dopo passo, nelle tappe significative, di una relazione breve senza commenti od osservazioni del narratore, così come la macchina da presa l’ha potuta catturare. Quasi un esperimento entomologico: mostrare se è possibile che due persone si cerchino e si trovino e vivano il loro amore – senza mai chiamarlo così – in modo leggero e spassionato, senza coinvolgimenti ulteriori, mantenendo intatte le rispettive vite. Ma godendo di ciò che quella relazione può dare loro.
Lei, Charlotte, una Sandrine Kiberlain in stato di grazia, è madre single di tre figli, due dei quali già fuori di casa, e avendo una storia impegnativa alle spalle non ha voglia di impelagarsi in una passione amorosa, anzi la ripudia: ha bisogno di spazio, di vita, di luce. Di gioia. Lui, Simon (Vincent Macaigne, sempre più bravo anche se in un ruolo molto vicino alle sue corde abituali), è goffo, impacciato e in diciassette anni di matrimonio con figli non ha mai avuto un’avventura, ma quando conosce Charlotte si sente attratto da lei irresistibilmente, pur con le (più mostrate che reali) resistenze del caso. Resistenze che si esprimono nel fiume di parole che profonde, per coprire l’imbarazzo di una situazione che sembra volere e non volere, pur desiderandola con tutto se stesso. La relazione comunque inizia, scandita da didascalie che indicano i giorni degli incontri, dal 28 febbraio all’estate quando, di ritorno dalle vacanze con moglie e figli, Simon scopre che Charlotte si è innamorata di un’altra persona. Con un’appendice a due anni dopo, in un finale che chiude ma che forse apre. Una corsa dei due di nuovo insieme, verso non si sa quale avvenire, nella consapevolezza, adesso, di entrambi, di non aver voluto, potuto e soprattutto saputo cogliere l’occasione che la vita ha fornito loro con quell’incontro, perché non hanno mai voluto dirsi che quell’incontro era magico e importante, e non era solo una storia di sesso. Sesso che peraltro non è mai mostrato, contrariamente a quanto accade nel citato “Una relazione privata”; in entrambi i film in realtà il sesso ha un’importanza relativa rispetto al sentimento che si forma e cresce piano piano tra i protagonisti, ma in nessuno dei due film questi lo sanno esplicitare e preferiscono anzi, in modi diversi ma con analoga sofferenza, far cadere la relazione. Farla finire.
Si citavano gli attori, affiancati nella parte finale da Georgia Scalliet, e il film è sicuramente un film di attori che ai loro personaggi lega i paesaggi, i luoghi di quell’amore, ripercorsi dalla macchina da presa senza di essi quando la relazione si chiude; ma è anche, e questo forse è l’aspetto più riuscito, un film di dialoghi sottili e penetranti, vivaci e briosi, che la sceneggiatura scritta dal regista con Pierre Giraud mette in campo per rendere un’atmosfera di libertà ma anche di complicità e di tenerezza, di intimità e di bene, di “clinica dell’amore” (per citare i Goncourt), in piena tradizione francese di analisi filosofica della passione, ma anche di spontaneità e autenticità ritrovate.
“MAIGRET”: OMBRA DEL PASSATO O PASSATO NELL’OMBRA?
di Francesco Saverio Marzaduri
Mai come l’anno appena trascorso – scrive Aldo Fittante – la morte ha voluto farsi bella divorando ingegno e incanto nel mare magno della cultura, prevalentemente seminando vittime in generazioni anziane, prossime al congedo, lasciando gli eredi, o sedicenti tali, stupiti e talvolta attoniti dinanzi al vuoto. Sicché, quando si pensa a una figura letteraria a cui non servono presentazioni, subito viene naturale immaginare di ritrovarsi in un tempo inesorabilmente perduto e lontano, che un riadattamento dai toni dimessi, tanto lividi e scabri – tesi alla restituzione d’un comparto urbano iconograficamente semi-spoglio – accentua al pari di un’indagine assai meno importante di tutto il resto. S’accluda una fotografia tutta mezze tinte, a cura di Yves Angelo, e un montaggio asciutto d’impostazione classica, firmato Joëlle Hache, che alterna interni, esterni, riprese di spalle. In siffatta chiave interpretativa, guarda caso nello stesso 2022, s’incanala il Maigret dell’omonimo, trentesimo lungometraggio di Patrice Leconte, il cui trascorso da fumettista, non per nulla, insinua nella Parigi anni Cinquanta una dimensione ombrosa e dimessa, che non ha niente da invidiare alle trasposizioni con cui la memoria collettiva è cresciuta. Riesce ostico, sulle prime, accettare che i tropi identificativi del personaggio di Simenon, probabilmente il narratore col più ampio numero di opere trasposte su grande schermo, nell’incarnazione d’un appesantito e inaspettatamente misurato Gérard Depardieu siano pressoché azzerati sin dall’inizio, quando al commissario, visitato dall’amico medico, viene proibita la “bonne cuisine” e (licenza delle licenze!) l’amata pipa-simulacro. In tale modalità – l’“assenza” – l’intrigo incentra/concentra la disamina, testimoniata nell’estremo fotogramma dalla sparizione del protagonista, in profondità di campo, mentre passeggia lungo una strada vuota.
Non interessa più di tanto che questa tardiva rilettura, volutamente fuori epoca e fuori registro, tragga origine da “La giovane morta”, pubblicato nel ’54, e stando alle dichiarazioni del cineasta (qui anche sceneggiatore a quattro mani col sodale Jérôme Tonnerre), ancorché intenzionato a girare un apologo discrepante dai precedenti, pare non esservi più stato un Maigret in sala dal ’58. Un’attesa alquanto lunga e sofferta, ove la chilometrica distanza temporale, quella del ricordo in celluloide, perde inesorabile ai punti con quella, ben più dolente, dell’anacronismo narrativo, registrato dalla fugace uscita del film a inizio stagione e da un conseguente gramo successo (fuorché, comprensibilmente, in Francia). Non è più l’era dei Maigret, tanto meno di esegesi come quella in oggetto: lunga è la casistica di volti succedutisi via via a incarnare questo sagace e umano poliziotto dalla scorza burbera, accigliato quanto comprensivo, nella misura in cui i “reboot” si rivelano una comoda operazione per il piccolo schermo. Non sempre all’altezza gli interpreti: se Bruno Cremer non fa rimpiangere il nostro Cervi, imprimendogli un tocco debitamente “français”, la maschera mingherlina dell’inglese Rowan Atkinson, coraggiosa nel tentativo di svestire panni ilari ormai collaudati, è riconducibile al comparto “miscast”. E chissà cosa penserebbe Simenon, oggi, di fronte al corpo-Depardieu (chiamato a sostituire Daniel Auteuil), alla prima collaborazione con Leconte dopo una serie di progetti mai concretizzati: consapevole senza dubbio di confrontarsi con robusti prototipi, eppure capace di conferire barlumi d’originalità a un esperimento “démodé” – l’unico che renda possibile coniugare la mimesi attoriale con una riviviscenza personale, che chiama in causa un movente più intimo e privato: l’incancellabile (e insolvibile) rapporto paterno-filiale.
Chi conosce la pagina simenoniana, e magari si sbizzarrisce nell’individuare una “physique du rôle” fedele alla descrizione cartacea, fatica a distanziarsi dal Maigret per antonomasia – Gabin, ovvio – e si trasecola nel segnalare come l’eccellente caratterizzazione di Charles Laughton, ne “L’uomo della Torre Eiffel”, non fosse gradita al letterato. “La struttura era plebea. Maigret era enorme e di ossatura robusta. Muscoli duri risaltavano sotto la giacca e deformavano in poco tempo anche i pantaloni più nuovi”. E ancora: “Arrivava solido come granito e da quel momento pareva che tutto dovesse spezzarsi contro di lui, sia che avanzasse, sia che restasse piantato sulle gambe leggermente divaricate”. L’assortita pletora risponde, dunque, d’un gaudio puramente filmografico, attento però a non tradire quel ch’è la connotazione principale: l’esteriorizzazione del sentimento, assorbito dal ruolo chiamato a ricoprire, camuffato da una glaciale indifferenza relativamente priva di giudizio, e via via sfumato nei segni dell’esistenza. Se l’eponimo Gabin era, e rimane, faccia appropriata nel solco del “noir” secco e duro, il “polar” di Leconte, in poco meno di un’ora e mezza, è incastonato nella solitudine di un’effigie minuscola nonostante la robustezza, fotografata di volta in volta in spazi che inesorabili ne sanciscono la minuzia e, da un istante all’altro, l’imminente trasparenza (dall’interno d’un “bistrot” a una stazione di corriere, da una lunga scalinata alla panchina d’un parco). Tra “quai” e fisarmoniche, Parigi stessa è un “non-luogo” denaturato, contrappuntato da un’anonimia iperrealista, e il decennio Cinquanta un orologio in cui tutto sembra essersi fermato, ora indeterminato ora tardivo: appare presto evidente come l’inchiesta, convenzionale in superficie, sul barbaro omicidio d’una giovane provinciale – a sua volta priva di specifica identità – fornisca lo spunto per una parabola di disillusione, in cui l’innesto d’una “pietas” inaspettatamente svelata funge da autentico epicentro nello scioglimento della matassa.
Se il fascino (in)discreto della borghesia è sempiterna “règle du jeu”, squadernata da dinamiche sociali vetuste, dettate dagli antitetici meccanismi del ceto sociale, l’incarnazione d’un Depardieu al contempo evanescente e tellurico, che una limitata quantità di ciak asseconda nel non dissiparne le sottrazioni, ha tutta l’aria di un’aperta confessione. Quasi che l’interprete, a mo’ di riverbero, si rivolgesse al proprio “doppio” (si pensi all’immagine riflessa sullo specchio d’un “café” o, intento a radersi, nel bagno di casa), trasposto in un assiduo gioco di confronti e scambi, accentuato dall’interesse verso la misteriosa randagia che, nel momento culminante della risoluzione, è oggetto d’una proiezione fantasmatica. Pure, nei lineamenti di quella giovane sbandata e fragile che si premura di proteggere, il commissario non scorge soltanto la somiglianza con la vittima, ma sembra ritrovare la perduta paternità – ormai livida memoria – atta a conferirgli l’estremo spiraglio d’una luce (di etica giustizia). Per continuare a osservare, registrare, comprendere. Frugare nelle rimembranze personali, o perdute. E, denudando anima e corpo (l’incipit lo fotografa nell’atto di spogliarsi), tirare ancora avanti e – anzi – esistere, con un bicchiere di bianco in mano. Leconte ambisce a un Maigret di diversa impostazione, dissimile dagli archetipi che furono: ciò non dissolve l’impressione che il suo sia un “alter ego” assai più attiguo allo scrittore, l’un l’altro medici mancati, e nella filigrana del primo è facile intravedere una tormentata riproduzione del secondo, “peccatore” di eccessi alimentari-sessuali, coprotagonista di un’ambigua relazione con la figlia conclusasi col suicidio di costei, poco più che ventenne.
Una simile icona non disdegnerebbe pose ciniche ad alto tasso di freddezza: ma proprio i dubbi che tanto ne arrovellano lo spirito, trasparenti dai silenzi con la moglie (“Non sembri più tu”), ne fanno un cane sciolto maggiormente ammansito e indulgente, privo del maggior marcatore deittico senza cui – confessa – si sente come le vittime delle proprie indagini. La corazza, recita la sua constatazione, crolla con tutte le certezze obbligando a tornare bambini intimoriti dal buio. E se legami aneddotici emergono univoci tra i coniugi Maigret, i soli plausibili a perdurare uno stanco “ménage”, a chiudere il discorso provvede la figura del tappezziere di Vilnius – ulteriore “alter ego” simenoniano – condannato a rivedere la figliola scomparsa in ogni fanciulla. Immobile è il tempo, non lasciando altro testimone che la perdita di generazioni venture (il “transfert” familiare di commissario e signora, mentre partecipano alle esequie della giovane vittima). E mentre il Nostro “tradisce” la vulnerabilità riposta gelosamente, esternandola lungo una fioca falsariga, l’osservatore è attento a non tradire il senso del procedimento, rammentando che il Maigret in oggetto è una rivisitazione. “Questa è una Magritte”, sancisce ironico con una pipa in mano, giocando con l’assonanza del proprio cognome, laddove la battuta originale rimanda al noto quadro dell’artista, belga come Simenon (la confezione, del resto, è una co-produzione franco-belga). Sicché, nella dimensione colta dell’astrazione, l’esito assume le sembianze del gioco metatestuale (e metacinematografico), ché lo scambio di parti annovera uno scambio d’identità da cui dipendono scioglimento e conseguenze: Leconte è l’autore de “L’insolito caso di Mr. Hire”, anch’esso tratto da Simenon e altrettanto incentrato su un omicidio, e pure di “L’uomo del treno”, ove l’interscambio tra due personalità differenti, nell’ultima drammatica mezzora, conduce a un’effimera, telepatica permuta che le immagina rivivere ciascuna la rispettiva esistenza.
Operina di spettri e proiezioni, che all’occorrenza non dissimula hitchcockiani “escamotage”, “Maigret” contempla personaggi indotti dall’empatia ad assumere spoglie altrui, riveriti da stacchi violenti e netti nell’attimo in cui l’intuizione ha il sopravvento. L’indagine è l’ultima in ordine d’importanza, in primo piano vi è l’uomo alle prese con assilli laceranti: tanto più la vicenda è ridotta all’essenziale, concedendo libere licenze in una sfrondata gestazione, quanto più l’ossessione investigativa per la defunta, “pattern” tra i più impiegati, emerge quale strumento di chiarezza. Acconciata e abbigliata come la vittima, l’emarginata Betty appare agli impuniti “colpevoli” di Ville Lumière gettando i presenti nello sconcerto: un flash fantomatico, speculare di lì a poco al fotogramma della giovane morta, in bianco e nero, su un grande schermo. Col pensiero probabilmente rivolto alla figlia, Maigret la fissa nell’oscurità della sala; l’effigie lo ricambia, quasi ringraziando. Ancora e sempre, il cinema consegna all’immortalità chi non esiste più, né può più esistere dentro una pellicola (e un set cinematografico, guarda un po’, fa capolino ogni tanto). Così pure un non-Maigret assediato da sofferenza e disincanto, capace di rielaborare ma non di giudicare, che si dissolve in un finale-epitaffio: ombra d’un passato nell’ombra, e forse privo di essa. Scatole cinesi d’un cinema “vintage”, che empatico continua…
UN PENN SOTTOVALUTATO. “MISSOURI”, 1976
di Tullio Masoni
Robert Lee Clayton è sereno quando, a fine giornata, tira le somme e sa di avere compiuto il proprio dovere di carogna.
Quella sera si stende supino nell’accampamento; non immagina che riaprirà gli occhi solo per vedere in faccia l’uomo che gli taglia la gola. Un istante di buio a tutto schermo; ora il primissimo piano mostra gli occhi sorpresi da un terrore che non ha avuto tempo. Clayton è ucciso da Tom Logan, il ladro di cavalli che perseguitava.
Clayton è Marlon Brando, Logan è Jack Nicholson. Due protagonisti-nemici ovviamente superpagati; Brando, in più, sembra avesse collaborato alla sceneggiatura e rifinito il personaggio in corso d’opera.
Terzo western di Arthur Penn – dopo “Furia selvaggia-Billy Kid” (1958) e “Piccolo grande uomo” (1970) – “Missouri” fu un fiasco commerciale, soprattutto negli Usa, e, salvo rare eccezioni, ebbe pochi apprezzamenti dalla critica.
Una sorte che mi sembrò strana al tempo e rimane tale oggi, perché un fortuito ripescaggio televisivo mi ha spinto a cercare il dvd e, alla fine, sono rimasto persuaso si tratti di un film notevole.
Ambientato nel Montana qualche anno dopo la guerra di secessione, “Missouri” racconta un dramma forte, non risolto, che si trascina fuori dalle più alte convenzioni del western, e cerca nelle anomalie la propria comunicativa tragica.
Ha scritto giustamente Goffredo Fofi che quello di Penn è un «western originale e nevrotico, con una sua precisa riflessione storica, tra proprietari allevatori, piccoli banditi disadattati e un bounty killer degno di Antonio das Mortes, proteo dalla mille facce, “male” americano che uccide gli inutili alla storia, che è da uccidere.» (1)
Le anomalie che dicevo, e danno carattere al film, sono anche quelle di un codice che si lascia contaminare da una violenza tipica nel genere e “altra”, destinata a forme di tragedia inusitate, da figure demoniache più vicine alla tradizione anglosassone antica che a quella epica celebrata dal genere in molteplici forme fino alle apoteosi degli anni quaranta e cinquanta.
Missouri, allora, può apparirci come opera del limite; anche di quello stabilito dal western critico con Pollack, Peckhinpah, Altman, lo stesso Penn.
Le mandrie di cavalli sparse caoticamente, sempre liberate dagli steccati per finire in altre mani e ancora, danno il segno di una umanità senza legge – valgono solo la volontà dei proprietari e la disperata fame dei ladri – che a quell’affanno assomiglia, si muove fra confini incerti e va incontro ad esecuzioni sommarie o massacri.
Penn sa delineare destini di tragedia nel quadro di una decadenza che non ha più nulla di elegiaco; la malvagità di un Clayton è assai più gelida di quella che Ford aveva attribuito ai suoi padri arcaici, e perfino di quella “celiniana” vieppiù marcata da Sam Peckhinpah. Quanto al fascino storico del genere, il regista sa mantenerlo al fondo ma senza cedere all’abbandono. Si ricordi il magnifico incipit coi cavalieri che avanzano lontanissimi dietro un primo piano di erbe selvatiche e fiori.
“Missouri” resta un film di paesaggio ma colline, prati, valli e anfratti rocciosi, sono esplicitamente scolpiti come scenografia (finta) dal vero; lo stesso vale per i costumi, forse i più filologicamente attendibili, gli ambienti e il colore: asciutto da non compromettere l’incanto (a meno che gli anni e il digitale mi abbiano troppo confuso) e degno di contemplazione per gli occhi di un ladro che deve, fra poco, essere appeso a un albero.
Valgono infine l’amarezza critica – radicale fin quasi alla cancellazione dell’epopea – e la denuncia. Ossia la presa d’atto di una forza che prescinde dalla legge e, al di là della particolare storia narrata, è dominante ieri come oggi. Già lo accennavo: non c’è legge in “Missouri”, perché il potere è totalmente nelle mani della proprietà, e contro quel potere – il buon finale amoroso di Tom Logan e della giovane Jane non conta – si agitano solo bande sciagurate.
Il proprietario David Braxton, testimone dell’ideologia americana e della sua continuità storica muore, certo, ma niente fa pensare che altri simili a lui nel sistema lo seguano o lo seguiranno.
Note
1) Come in uno specchio, Roma, Donzelli, 1995, pag. 203
“EO”, “BALTHAZAR”: SONO FRATELLI?
Era la vigilia del periodo pasquale e, trovandomi a ragionare di cinema con un gruppo di studenti medi, consigliai ai credenti e ai non credenti di vedere o rivedere, a proposito della Passione, La ricotta di Pasolini e Au hasard Balthazar di Bresson.
Sul secondo, in particolare, insistei dicendo che rappresentare il Cristo sofferente con l’agonia di un asino fra le pecore in un paesaggio brullo e solitario era (è) quanto di più elevato si possa immaginare.
L’asino di Bresson attraversa lo squallido mondo della campagna povera – inutilmente toccata dalla modernità delle auto – come guidando una Via Crucis: innocente, circondato dal Male, inconsapevole fra inconsapevoli. Perché, come scriveva Virgilio Fantuzzi: «…Bresson non vuole attori sul suo set, ma modelli, non persone che recitino, che fingano di essere quello che non sono, ma persone disposte a posare, restando esattamente quello che sono…» (1) e dunque l’asino è un emblema di mitezza e rassegnazione nel farsi di un destino nel quale gli umani agiscono, meccanicamente, secondo ruoli fissati.
Una fiaba tragica in bianco e nero, quella dell’autore francese. Ogni inquadratura sottraeva dubbi e consolazione dai margini della precedente. Questa di Skolimowski è invece una fiaba colorata che aggiunge invece che sottrarre, talvolta, per poi digredire e illuminarsi simbolicamente – il confronto crudele fra asino e cavallo, ad esempio – nella ricerca di contrappunti naturalisti come il bosco (notturno e dominato da creature proverbiali quanto misteriose) o la corsa di un drone impazzito; cioè artificiale a effetto fantastico e visualmente smisurato.
L’esistenza dell’asino, scrive ancora Fantuzzi, era:«…legata a un gruppo di esseri umani, i quali rappresentano i vizi (orgoglio, avarizia, lussuria, ubriachezza, violenza…)» e nella loro fatale malvagità, aggiungo io, tristezza irrimediabile: «…l’asino è colui che subisce, con una capacità di sopportazione pressoché illimitata…» (2), mentre l’EO di Skolimowski, provvisoriamente “salvato” dalla crudezza del bianco e nero, accentua per un po’ il fiabesco convenzionale grazie al colore e all’onnipotente tecnologia.
Ma come i “modelli” di Bresson anche i pìcari, i devianti e criminali pazzi di Skolimowski ubbidiscono a una malvagità ineluttabile, anche se può essere compresa, al fondo, nel quadro ideologico delle “piccole patrie” del centro Europa.
Skolimowski è polacco. Voglia o meno, avverte la “cattiveria” di certo costume cattolico, e la coazione immaginaria dei simboli e della ritualità; non per caso, nel pre-finale di EO viene celebrata una messa blasfema.
Cattolico – alla Bernanos, cioè di radicale e pessimistica visione – è stato a lungo Bresson e l’asino Balthazar fu spesso accostato, come implicitamente accennavo all’inizio, al Cristo: innocente e, come tale, vittima nel sacrificio.
Skolimovski si definisce cinico, ammettendo fra le sue rare e profonde commozioni quella che provò davanti alla creatura del maestro francese. Somiglia fraternamente, questa, a EO? Il regista non entra in argomento, forse schermendosi, ma i punti di contatto, in diacronia, sono diversi: la “storia d’amore” fra l’asino e la ragazza, il circo, la già menzionata e inguaribile malvagità degli umani, infine la morte che non vediamo ma avverrà in un macello. Balthazar moriva fra le pecore, EO segue il proprio tragico destino fra le mucche.
Dove Skolimowski vuole affermare una sensibilità nettamente diversa da quella di Bresson – a parte il decisivo ricorso a un’alta definizione cromatico-spettacolare – è nella denuncia animalista. Perché il suo asino, che durante la lavorazione è stato seguito da professionisti affezionati e sostituito fra la Polonia e l’Italia perché non soffrisse i viaggi, propone di riflettere sulla crudeltà e il danno degli allevamenti massivi.
Skolimowski si definisce cinico, ma un vero artista, forse, non lo è mai del tutto.
Note
1. L’anima nella prigione. Osservazioni sul cinema di Bresson, in: Il caso e la necessità. Il cinema di Robert Bresson, a cura di Giovanni Spagnoletti e Sergio Toffetti, Torino, Lindau, 1998. pag.41. Catalogo della retrospettiva allestita per Adriaticocinema nel giugno 1998
2. Virgilio Fantuzzi, ibid
DUE FILM IRLANDESI
“GLI SPIRITI DELL’ISOLA”, DI MARTIN MCDONAGH; “THE QUIET GIRL”, DI COLM BAIRÉAD
di Paolo Vecchi
I protagonisti di “Gli spiriti dell’isola” si chiamano Colm e Pàdraic, la sorella di quest’ultimo Siobhàn, nomi che bastano a collocare la vicenda in Irlanda, per la precisione, aggiungiamo noi, nell’aprile 1923. Il titolo originale del film di Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”, rimanda poi da un lato all’isola in cui si svolge la storia, che in realtà si chiama Inishmore, nell’arcipelago delle Aran, indissolubilmente legato al capolavoro di Flaherty. Dall’altro, alle entità della mitologia celtica, comunicanti con l’aldilà e messaggere di morte, che si materializzano in quella sorta di strega che sembra uscita dal “Macbeth”, presenza macabrache si aggira solitaria, pronta al vaticinio di sventure.
“Gli spiriti dell’isola” è dunque innanzitutto un film su un genere di follia tipicamente irlandese, figlia di una natura matrigna, di un clima punitivo e di una vita sociale elementare, vissuta tra la chiesa e il pub. Ma, sullo sfondo, oltre il braccio di mare, il crepitìo delle mitragliatrici e il rombo dei cannoni rimandano al contesto di un’atroce guerra civile, più recente ma non meno importante a definire il carattere di un popolo da sempre tormentato. A Inisherin il rapporto tra gli umani si gioca più sugli sguardi che sulle parole, tanto che anche le amicizie si interrompono nel silenzio, senza una vera e propria spiegazione. Così, solo dopo avere deciso di rompere con lui, il musicista Colm dice all’allevatore Pàdraic che vuole riempire meglio il poco tempo che gli resta da vivere,concentrandosi sulla scrittura di una composizione per cui essere infine ricordato dopo morto. Di conseguenza, anche la musica assume significato in quanto generatrice di emozioni, a partire dal tema celtico che dà il titolo al film,composto dallo stesso protagonista, Brendan Gleeson, e da lui cantato con accompagnamento dell’abituale consort di violini, thin whistles, ghironda e pecussioni. Ma lo score, opera di Carter Burwell, compagno di strada abituale dei fratelli Coen, si complica nelle sequenze di accentuato lirismo con l’intrusione di lieder colti di Brahms e Orff e di una celebre aria di Mascagni. Allo stesso modo, le luci del direttore della fotografia Ben Davis accarezzano un paesaggio aspro ma affascinante, di scogliere a precipizio sul mare e sentieri costeggiati da muri di pietra a secco, con riferimenti pittorici al bianco e nero del già citato Flaherty dell’ ”Uomo di Aran”(1934) ma anche al coloratissimo, indimenticabile Ford di Un uomo tranquillo(1952), quest’ultimo per il luogo deputato del pub e della variegata fauna umana che lo popola, magari anche per una certa caratterizzazione western negli abiti e nell’andatura di Colm. In qualche modo fordiano é l’alleggerimento comico di una vicenda di per sé estremamente cupa, ad esempio quando il border collie cerca di sottrarre al padrone le forbici con le quali teme, a ragione, che si amputerà altre dita dopo la sfuriata dell’amico. Alla medesima funzione di controcanto, ma come momento di commozione, adempie la sarabanda di animali: cani, appunto, ma anche cavalli, mucche e soprattutto quella tenerissima asinina, la morte della quale rappresenta il climax emotivo del film.
Ma “Gli spiriti dell’isola” racconta soprattutto di una comunità e di individui senza speranza. Da Inisherin ci se ne può andare solo con la morte, o facendo violenza a se stessi e agli affetti più cari, in uno sforzo in prospettiva forse vano, come quello di Siobhàn quando decide di andare a lavorare a Dublino abbandonando il fratello in preda ai suoi fantasmi.
Addirittura girato in gaelico ad eccezione di poche battute di dialogo è “The Quiet Girl”, che in originale fa “An Cailìn Ciuìn”. Il regista si chiama Colm Bairéad, la giovanissima protagonista Caìt, Eibhin la moglie del farmer che l’accoglie…Tratto dal romanzo “Foster” di Claire Keegan, racconta di una ragazzina che, a causa della gravidanza della madre, é temporaneamente affidata dal padre, violento, scialacquatore e infedele, ad una coppia di parenti, pure loro agricoltori. I due, che hanno perso tragicamente un figlio bambino, creano intorno alla piccola quell’atmosfera di affetto e comprensione che le era sempre mancato. Film povero, girato nell’antico formato di 4:3, “The Quiet Girl” é un piccolo gioiello di sentimenti trattenuti, atmosfere sospese, gesti e sguardi che sostituiscono le parole, che si impone anche grazie alla recitazione di attori bravissimi e ben diretti. Tra loro va ovviamente segnalata l’incantevole protagonista, Catherine Clinch, i cui candori e stupori non vengono mai abbandonati allo sciupìo della melensaggine. Luigi Comencini, che di infanzia ne sapeva davvero, ha affermato a proposito del magnifico, commovente “La finestra sul Luna Park” (1957), che il film era la dimostrazione del fatto che la paternità non é un fatto di nascita. “A Quiet Girl” dice all’incirca la stessa cosa, con una sensibilità e un pudore tali da ricordare l’opera di questo nostro indimenticabile regista.
protagonista, i cui candori e stupori non vengono mai abbandonati allo sciupìo della melensaggine.
TRA IRAN E ARGENTINA: CINEMA DI GENERE E DI DENUNCIA
di Marco Incerti Zambelli
“Holy spider“ e “Argentina 1985” , pur nella evidente diversità, hanno in comune un solido riferimento a generi classici, il noir e il legal thriller, ma trovano nel contesto nel quale avvengono le vicende, ambedue tratte da storie vere, una efficace capacità di denuncia e di impegno civile.
“Holy Spider” è il terzo film di Ali Abbasi, regista di origine iraniana naturalizzato danese che, abbandonate le ambientazioni nordiche con forti pennellate horror di “Shelley”, opera d’esordio, e la dimensione fantastica che rimanda alle mitologie svedesi coniugate ad un complesso presente dell’ottimo “Border”, affronta con forza e decisione la tragica situazione del suo paese di nascita. Lo fa prendendo spunto da una storia vera, quella del serial killer Saeed Hanaei che nel 2001 assassinò 16 prostitute a Mashaad, città sacra, meta di pellegrinaggi. La realizzazione del film, di produzione nordeuropea, è stata complessa: rifiutato dalle autorità il permesso di girare in Iran, le pressioni politiche hanno impedito di utilizzare la Turchia per le riprese, che si sono svolte infine in Giordania.
L’autore costruisce, nella prima parte, un solido racconto noir, utilizzando con mestiere topoi e stilemi tipici del genere: la coraggiosa giornalista arrivata dalla capitale, lo scarso aiuto dalle forze dell’ordine, l’oscillare della popolazione tra la paura e l’ignavia, l’insperato aiuto di un giovane giornalista locale. L’identità dell’assassino viene svelata fin dall’inizio e la narrazione trae forza dall’emozionante, ferma risoluzione della donna nel voler scoprire la verità, mettendo anche se stessa in pericolo. Quello tuttavia che fa di “Holy Spider” un’opera sorprendente è da un lato la messa in scena di un Iran inconsueto, mostrando come nella città santa si muova un inaspettato sottobosco di prostituzione e di tossicodipendenza e dall’altro la figura di Saeed Hanaei, reduce della guerra contro l’Iraq, dedito alla famiglia ed instancabile muratore, portatore di una profonda religiosità che lo spinge all’assassinio in nome del Corano e della “pulizia morale”. Nella seconda* parte il processo al serial killer diventa un gigantesco atto di accusa contro il drammatico status quo dell’Iran, intriso di fondamentalismo religioso e di misoginia: l’assassino conquista una crescente benevola popolarità tra una parte dell’opinione pubblica, ‘il popolo lo ama’, la famiglia ne è orgogliosa nonostante la sua condanna, come la potente scena finale sottolinea. Abbasi conferma il suo talento, disegnando, con un uso sapiente della bella fotografia in chiaroscuro di Nadim Carlsen, una vicenda di forte impatto, muovendosi con efficacia tra il noir e la denuncia sociale. E’ sorretto dalla maiuscola prova dei suoi attori, Zahra Amir Ebrahimi, la cui drammatica vicenda personale è echeggiata in Rahimi, la coraggiosa giornalista frutto della fantasia dell’autore, e che ha meritato il premio come miglior attrice all’ultimo Festival di Cannes, e Mehdi Bajestani che giganteggia nell’intenso ritratto di Hananei.
“Argentina 1985”, è diretto da Santiago Mitre, giovane e già affermato regista argentino del quale si è potuto apprezzare “El Estudiante – Lo studente”, analisi feroce della frammentazione politica nella università argentina e “Il presidente”, racconto politico sui retroscena del potere.
Il film, prodotto da Amazon Prime Video ma che Lucky Red saggiamente propone per la visione nelle sale anche dopo la comparsa in rete grazie alla candidatura all’Oscar quale miglior film straniero, narra il percorso del fondamentale processo che a metà degli anni ‘80 vide il paese sudamericano, solo dopo pochi mesi dall’uscita dalla feroce dittatura, portare alla sbarra i militari responsabili delle orribili gesta della giunta. Il regista e il cosceneggiatore Marano Llinas costruiscono un’opera di grande coinvolgimento, a partire dalla messa in scena delle difficoltà incontrate fin dall’inizio da Julio Strassera, il pubblico ministero incaricato dell’accusa, interpretato da uno strepitoso Ricardo Darin, già a fianco di Mitre ne “Il Presidente”. Superato il primo ostacolo con l’attribuzione del processo ad un tribunale civile e non alla corte militare come auspicato dalla difesa, il magistrato si scontra con lo scetticismo, se non proprio con l’ostilità, dell’ambiente giudiziario, che lo porta alla scelta di costruire un team di giovani avvocati, spesso appena laureati, che si rivela una squadra del tutto efficace, riuscendo a raccogliere in pochi mesi una imponente messe di prove. Il progredire del racconto raggiunge il climax con le testimonianze in aula delle vittime e dei loro parenti, narrate con attenta fedeltà alle reali deposizioni, fino alla magistrale arringa finale del Pubblico ministero per poi sciogliersi nella rivelazione della vittoria processuale in una notturna telefonata casalinga e nella rinnovata volontà di continuare a ricercare la verità. Mitre con grande equilibrio intreccia i momenti più drammatici della vicenda con uno sguardo ironico, con tratti da commedia, soprattutto nelle incursioni nella quotidianità di Strassera, le dinamiche familiari raccontate con divertita e divertente partecipazione.
Il risultato finale è un film che tiene perfettamente insieme il forte impegno civile e l’appassionante dipanarsi del legal thriller e pone il regista argentino tra gli autori più interessanti del cinema contemporaneo.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
ADONELLA MARENA, UN GRANELLO DI SABBIA NELL’INGRANAGGIO
di Marcello Cella
“invincibile non è chi sempre vince, ma chi non si fa sbaragliare dalle sconfitte.
Invincibile è chi da nessuna disfatta, da nessuna batosta si fa togliere la spinta a battersi di nuovo. Chisciotte che risorge ammaccato dai colpi e dalla polvere è invincibile”
Erri De Luca
E’ difficile raccontare Adonella Marena e la sua opera di documentarista fuori dalle righe utilizzando i metodi tipici della critica cinematografica perché Adonella è stata per tutta la sua vita anche un’attivista politica che ha sempre voluto raccontare le realtà più nascoste e marginali, i conflitti meno visibili sui media mettendo in gioco tutta sé stessa, il proprio corpo, la propria fisicità, le proprie idee, la propria telecamera. E’ difficile anche perché, guardando i suoi documentari così ricchi di passione civile, di curiosità partecipata alle vite degli invisibili e alle loro lotte per non soccombere ai pregiudizi e alle trappole del pensiero unico, lo spettatore fatica a riconoscere l’Italia di oggi. Forse il maggior merito dei suoi documentari, è proprio quello di raccontare, spesso in presa diretta, i grandi sommovimenti politici e civili avvenuti in Italia tra la fine degli anni ’90 e la fine del primo decennio del 2000, perché la memoria di un’altra Italia non andasse perduta nei cupi deliri sovranisti che dominano la politica e la narrazione mediatica odierna. Quindi la passione politica e civile è stata la prima molla della sua opera documentaristica, come anche la capacità di sperimentare linguaggi diversi e di non farsi chiudere in una categoria estetica eccessivamente definita.
“La mescolanza tra la mia storia, la politica e il desiderio creativo dà origine sia al mio modo di fare cinema sia ai temi ricorrenti nei miei film. Non ho scelto il genere narrativo, l’ho individuato lungo il percorso. Ho sperimentato la fiction, il reportage, il video didattico, il docu-fiction, il documentario creativo. Ma quest’ultimo mi è più congeniale perché mi permette di vivere e raccontare la realtà con uno sguardo più aperto, personale e libero, e uscire dallo schema rigido di un luogo comune che riguarda il documentario, la presunta rappresentazione oggettiva, distaccata, “scientifica” della realtà”.
E in effetti, fin dal suo primo documentario “lungo”, “Okoi e i semi di zucca” (1994) preceduto da una serie di cortometraggi tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 che già nei titoli rivelavano molti dei temi ricorrenti dell’autrice (“Bambine di Palestina”, “Il colore delle differenze”, “Righibè a Torino”, ecc.), il documentario si incrocia con la finzione, pur essendo originato da una storia vera, la costituzione della prima cooperativa di donne migranti in Italia, nel campo della ristorazione. Le vicende, i conflitti e le malinconie della zairese Mamì, della filippina Pace, della marocchina Malika e della siciliana emigrata al nord Rosa si svolgono dentro la cornice di una Torino fredda e indifferente, ma dove già si intravedono i primi semi di un’ostilità che si manifesterà apertamente pochi anni dopo. Una Torino cupa e grigia, attraversata dai fantasmi di un tempo in cui era il centro produttivo più importante d’Italia, che ritorna in “Facevo le nugatine” (1996). Walter Pagliero Valgrand, ex operaio in pensione, si aggira solitario e smarrito fra i ruderi abbandonati dell’ex fabbrica dolciaria Venchi Unica ricordando i tempi in cui essa era affollata di lavoratori che producevano e confezionavano i dolci di marchi famosi come Talmone. Il silenzio e le parole dolenti dell’operaio accompagnano questo viaggio nella memoria e in uno spazio abbandonato al degrado e che verrà abbattuto poco dopo il suo racconto portandosi via, con le macerie, anche i ricordi di persone che a quel luogo hanno dedicato la vita. Mentre le allegre pubblicità pop degli anni Sessanta, i cui filmati sono stati ritrovati dall’autrice proprio all’interno della fabbrica abbandonata, raccontano di un’Italia che non c’è più, l’Italia del boom economico, del consumismo felice e spensierato, di sogni e speranze di un altro tempo, così apparentemente lontano da far dubitare il protagonista del documentario che sia mai esistito.
“Usciremo un giorno e la vita ricomincerà” è invece l’orgogliosa affermazione che Frida Malan, ex partigiana di Giustizia e Libertà, protagonista de “La combattente” (1998), affida alla sua giovane intervistatrice Ilaria, una studentessa che la cerca per realizzare un lavoro di documentazione per il suo corso universitario. Il tema anche in questo caso è la trasmissione della memoria a chi non ha vissuto i drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale e che si avvicina ad essi con superficialità. Infatti in un primo tempo Frida è reticente con la sua giovane interlocutrice. “Come si fa a dire qualcosa quando c’è tutta una vita da raccontare?”, è la prima cosa che dice a Ilaria. Ma poi lentamente le parole si sciolgono e affiorano i ricordi anche se sono accompagnati dal dolore e dalla paura di non essere capiti. “Tanti quando tornavano non dicevano più niente”, dice Frida, consapevole che per molti “non ricordare era un modo per non soffrire, non ricordare per il timore di non essere capiti”. E qui risuonano le parole disseminate in tante parti dell’opera di Primo Levi sulla difficoltà di parlare e far capire quegli eventi così drammatici a chi non può nemmeno immaginare cosa questo significhi per chi li ha vissuti direttamente. Ma Frida ha reagito al silenzio e all’impotenza e ha fatto della sua vita un momento irripetibile di passione. “Ho vissuto con passione tutto ciò che mi sembrava utile per il mondo futuro”, è il messaggio che Frida consegna ad Ilaria che si aggira pensosa nella periferia della Torino notturna, ravvivata da graffiti colorati che raccontano di altre lotte e di altre passioni alla vigilia di un nuovo secolo che si annuncia ancora pieno di ombre e di domande inespresse.
Del 1999 è invece il documentario “La fabbrica degli animali” che racconta di un’altra passione di Adonella, quella per gli animali, considerati essere viventi e senzienti al pari degli umani. Il documentario di Adonella è il primo in Italia nella denuncia del trattamento aberrante cui sono sottoposti negli allevamenti intensivi. L’idea nasce dall’incontro della documentarista torinese con un veterinario che le racconta la condizione in cui vivono questi poveri animali, ridotti a macchine da riproduzione, da carne, latte e uova per soddisfare la follia consumistica dei cittadini occidentali. Le immagini terribili di Adonella Marena ci portano dentro i veri e propri lager in cui vengono ridotti gli animali, ma non rifugge da un’analisi storica del fenomeno che nasce e si sviluppa negli anni del boom economico fra gli anni Cinquanta e Sessanta, nel momento di passaggio dell’Italia da un modello di società sostanzialmente ancora rurale e un modello di società industriale, che conduce il nostro paese sulla strada di un consumismo, anche di tipo alimentare, sconosciuto alle generazioni precedenti. La realizzazione degli allevamenti intensivi risponde a questa nuova vorticosa domanda di consumi alimentari e gli animali vengono progressivamente spogliati della loro natura di esseri senzienti per diventare semplicemente macchine, ingranaggi dell’industria alimentare, nutriti a base di mangimi e farmaci pericolosi anche per la salute umana. Il documentario della Marena fa anche piazza pulita del classico argomento a favore di tali strategie produttive, e cioè la loro necessità per debellare la fame nel mondo, dimostrando, dati alla mano, che la carne prodotta in questi impianti-lager ha ben poco a che fare con questa presunta logica redistributiva, ma molto con il profitto di pochi a scapito della maggior parte dei cittadini del pianeta, degli animali e dell’ecosistema. La soluzione, difficile, ma non impossibile, che si deduce da “La fabbrica degli animali” è che solo la dieta vegetariana e lo sviluppo sostenibile possono invertire questa strada distruttiva e autodistruttiva. Nel documentario, efficace, ma sicuramente un po’ didascalico, cominciano a sentirsi gli echi del movimento di Seattle, del cosiddetto movimento No Global o Altermondialista che sfoceranno in Italia nelle drammatiche giornale del G8 di Genova del 2001.
Gli anni 2000 sono gli anni in cui Adonella Marena lavora sempre più a stretto contatto con i movimenti di contestazione del nostro modello di sviluppo e molte sono le opere che affrontano tematiche politiche e sociali vicine alle rivendicazioni del movimento No Global. E’ del 2000 “Mobilitebio: quando la terra è in vendita”. Infatti il 25 maggio del 2000 a Genova una grande manifestazione si oppone a Tebio, la prima mostra – mercato internazionale sulle biotecnologie. “L’immagine di convegno scientifico e di presunta neutralità (con la quale si vuole informare “correttamente” sul settore della ricerca biotecnologica) si svela come la facciata convenzionale di un obiettivo diverso: offrire una vetrina per le multinazionali del biotech, nate dalle fusioni dei colossi chimico-farmaceutici, che stanno concentrando nelle proprie mani il mercato della cosiddetta “scienza della vita”. Una rete di associazioni riunite sotto la sigla Mobilitebio organizza quindi una grande manifestazione contro le manipolazioni genetiche a cui partecipano anche alcuni dei protagonisti del successivo G8 di Genova, come le Tute Bianche con l’attivista Luca Casarini e don Andrea Gallo. Lo slogan di tutti è: “Quando la terra è in vendita, ribellarsi è naturale”. La telecamera di Adonella accompagna la manifestazione con interviste ai partecipanti ed entra al suo interno lasciando che siano gli attivisti ad esprimere il loro punto di vista.
Il documentario successivo di Adonella Marena, “Tute bianche. Un esercito di sognatori” (2002) viene girato subito dopo i giorni del G8 di Genova e racconta uno dei movimenti protagonisti di quei giorni, ma che hanno già una lunga storia di militanza alle spalle, e cioè le Tute bianche di Luca Casarini, che cambieranno nome proprio a Genova autorinominandosi “disobbedienti”. Adonella racconta dall’interno le vicende del centro sociale “Rivolta” di Venezia, nato già negli anni ‘90 tra le fabbriche dismesse del nord est, facendo emergere con naturalezza e senza ideologismi di maniera le storie degli attivisti e le motivazioni della loro militanza. “Sono, dicono loro, “un esercito di sognatori”, armati solo di plastica e di parole, contro la prepotenza di quello che chiamano Impero. Sono i portavoce degli “invisibili”, i fantasmi, quelli che non hanno rappresentanza né diritti”. La documentarista torinese cerca di ricostruire le loro storie ed il loro pensiero anche utilizzando immagini d’archivio delle loro lotte, come quando si incatenarono sui binari di una ferrovia nel 1994 per non far partire un treno carico di armi diretto in Croazia durante la guerra nella ex Jugoslavia. O come quando, arrivati nel 2000 in Chiapas parteciparono con gli zapatisti alla lunga marcia che li portò a Città del Messico a trattare con il governo messicano. Come in tutte le sue opere l’intento di Adonella Marena è quello di far parlare i protagonisti delle sue storie, a disvelare i loro lati più reconditi senza giudicare a priori. “Tute bianche. Un esercito di sognatori” è quindi un viaggio nei luoghi, nelle azioni, nelle idee e nelle emozioni di questo movimento, così duramente colpito durante i tragici eventi del G8 di Genova nel 2001, per far emergere la profonda verità di uno slogan famoso di quei giorni: “Un altro mondo è possibile”.
Con “M’agradavo vioure ilamoun. (Ipotesi sui giochi olimpici 2006)” (2003), un’espressione che in occitano significa “Mi piaceva vivere lassù”, Adonella Marena torna al documentario d’inchiesta ecologista e racconta con grande acume e amara preveggenza il devastante impatto ambientale delle decine di cantieri e infrastrutture, dei massicci interventi su boschi e reti idriche causati dai lavori per preparare i giochi olimpici invernali di Torino 2006. Le testimonianze degli abitanti di quelle valli denunciano la distruzione dell’ambiente e dell’identità culturale di quelli luoghi in nome del profitto. Luoghi che vengono raccontati con poetica dolcezza dalla musica che risuona di echi lontani dei Lou Dalfin e dai versi di Primo Levi (“Il ghiacciaio” e “Una valle”) recitati dal pittore Vinicio Perugia, luoghi di enigmatici silenzi, spazi di riflessione che contrastano con la frenetica superficialità di politici e tecnocrati che farneticano di una “Torino capitale del divertimento”, una “Torino che non sta mai ferma”, della necessità del “fare in fretta”, mentre i media si genuflettono ai nuovi padroni del vapore censurando ogni voce critica, come nel caso del servizio RAI, mai andato in onda, e ripreso da Adonella, che denunciava le criticità di queste “grandi opere”.
In questo senso, questo documentario, si lega ad un’altra opera di qualche anno prima, più anomala e fuori dagli schemi, come “Anime di città” (2000), ispirato alle atmosfere di “Blues in 16. La ballata della città dolente” di Stefano Benni, in cui le immagini luccicanti della Torino notturna e glamour dei nuovi ricchi, delle pubblicità automotivanti (“io valgo”) dei nuovi vincenti, dei mega cartelloni pubblicitari della moda e del lusso, le insegne luminose, i manichini delle vetrine dei negozi di abbigliamento, le notizie della Borsa, i vestiti firmati delle donne in carriera, accompagnati dai racconti surreali dello scrittore, raccontano una città sempre più solitaria e angosciata che nasconde la propria irrequietezza esistenziale e il proprio nichilismo consumistico dietro le immagini al neon di una città inesistente.
Gli anni 2000 sono anche gli anni in cui Adonella Marena si avvicina al movimento No Tav in Val di Susa e in cui realizza le sue opere più note “No Tav. Gli indiani della valle” (2005) e “Il cartun d’le ribelliun. Da Venaus a Roma a passo d’uomo” (2008). Il primo racconta i primi 15 anni di lotta degli abitanti della Val di Susa contro la realizzazione della TAV, un’opera inutile e devastante per l’ambiente e per l’identità di quei luoghi, attraverso le voci e le storie di chi combatte in prima persona per difendere il proprio diritto a vivere in quei luoghi senza dover partecipare per forza alla corsa dei vincenti (“E’ necessario correre (…) Gli altri hanno bisogno di correre e tu non vuoi farlo”, afferma significativamente uno degli attivisti No Tav intervistati). Il secondo racconta invece la gioiosa marcia di 800 km degli attivisti No Tav dalla Val di Susa a Roma nel 2006 per contestare la realizzazione dell’opera in questione, ma anche per presentare al governo le istanze di tutti i movimenti di contestazione delle grandi opere (erano presenti anche attivisti No Mose di Venezia, No Offshore di Livorno, No Ponte sullo Stretto di Messina, ecc.). In entrambi i documentari emerge l’interesse affettuoso e curioso al tempo stesso, quasi sempre presente nelle opere della documentarista torinese, per chi è disposto a mettere in gioco tutto sé stesso, il proprio corpo, la propria fisicità per sostenere le proprie idee, la propria causa, e il bene comune anche a rischio della propria incolumità personale. Da Seattle a Genova è emerso spesso questo aspetto nei movimenti di contestazione di carattere politico, sociale o ecologista e Adonella cerca di capire e raccontare le azioni e le motivazioni di questi attivisti che non tracciano mai una linea netta fra il proprio impegno politico e sociale e il proprio vissuto quotidiano. Un modo di essere e di pensare che, nel mondo dei contatti virtuali, artificiali, della socialità a distanza sembra appartenere ad altre epoche, più antiche, lontane, quasi dimenticate. Come se la partecipazione diretta alle azioni ideate e realizzate per cambiare in meglio il mondo fosse diventata improvvisamente qualcosa di esotico, qualcosa che non appartiene più alla nostra cultura sempre più “mediata”. E forse è anche la causa di quella sottile malinconia che spesso emerge, quasi involontariamente, in molti documentari di Adonella Marena. La lotta dei No Tav contro le Grandi Opere Inutili che tanto piacciono ai politici, ai tecnocrati e alle mafie, raccontata da Adonella, così attuale e così antica allo stesso tempo, diventa quindi il paradigma di un mondo che “deve” correre, sempre e comunque, anche se non sa più esattamente dove andare e perché lo deve fare, emblematico di una crisi culturale ed esistenziale sottile e non dichiarata, ma che nasconde le crepe sempre più evidenti ovunque il pensiero dominante si presenti come una divinità necessaria, infallibile e senza alternative.
Fra queste due opere Adonella realizza un docu-drama anomalo ma significativo come “Non mi arrendo, non mi arrendo!” (2006), in cui la regista, a 60 anni dalla Liberazione, porta in scena al Teatro Carignano di Torino, storie personali e collettive di resistenza femminile al nazifascismo. Come lei stessa racconta, si tratta di “madri, ribelli, sorelle, partigiane, allieve, maestre, contadine, operaie, figlie, scienziate, sindacaliste, attrici, registe…. Ognuna racconta la propria resistenza, che è anche resistenza alle mode, alla cialtroneria, alla supercialità, all’opportunismo… “. Una contro storia a più voci su quello che significano parole come lotta e resistenza. E patria.
“Esistono patrie in viaggio, patrie in spalla, portate con sé perché quelle di origine di sono disgregate. Tutta la nostra epopea di emigranti è stata patria chiusa dentro una bisaccia e imbarcata per terre d’oltremare. Stava in zolle strette intorno alla radice di una vite, in un pugno di semi di basilico. E la loro definizione della parola “patria” era: chella ca te da a mangia’. Perché se non dà diritto di lavoro e di vita, non è patria, né matria e si è orfani verso terre di adozione”. Con queste parole lo scrittore Erri De Luca introduce il documentario “Lo sbarco” (2011) in cui Adonella Marena, in co-regia con Dario Ferrero, racconta un’altra storia di lotta, di partecipazione attiva e di democrazia diretta, e cioè l’organizzazione e la realizzazione, nel 2010, di un viaggio in nave da Barcellona a Genova di un gruppo di italiani residenti all’estero che, di fronte ai continui episodi violenti di razzismo, corruzione, precarietà nel lavoro, erosione del bene pubblico, espansione del potere mafioso, distruzione del territorio, decide di compiere un atto dimostrativo contro questa pericolosa deriva morale del nostro paese, organizzando, a 150 anni dall’impresa dei Mille di Garibaldi, un’azione analoga ma in senso contrario. Non mille soldati alla conquista del Sud Italia in mano ai Borbone per costruire un’Italia unita, ma mille concittadini decisi a manifestare e a rendere pubblico e partecipato il sogno di un’altra Italia, un paese diverso da quello raccontato dalle cronache di quegli anni. Così la cosiddetta “Nave dei diritti”, sostenuta anche da intellettuali e personaggi dello spettacolo come Dario Fo e José Saramago, Tonino Carotone e Paolo Rossi, salpa significativamente da Tangeri con il suo carico di migranti nordafricani per sostare a Barcellona e poi approdare a Genova, dove, nelle “piazze dei diritti” verrà innescato un dibattito a più voci su come costruire un’altra Italia. All’appello rispondono da molte città d’Europa, e attraverso la rete si incrociano le iniziative. “Nella traversata, condivisa con i cittadini nord africani, si intrecciano testimonianze, incontri e musiche, insieme alle voci che dalla rete portano la loro presenza. Per ricordare i diritti negati, per alimentare idee e sogni. Una Nave dei diritti ma anche un’Arca di Noè su cui imbarcare le esperienze culturali e umane in pericolo di estinzione, una nave dei folli spinta dall’utopia. Una sfida pirata alla rassegnazione che ci circonda. Il documentario vuole proporre uno sguardo sull’Italia di oggi da un punto di vista particolare, quello di cittadini italiani che abitano e lavorano in Europa e che assistono smarriti alla metamorfosi del loro paese. Il loro sguardo speculare mette a confronto due mondi che coesistono in modo stridente oggi in Italia: da una parte una popolazione impaurita dalla crisi economica e sociale, e neutralizzata dal degrado culturale, etico e relazionale, dall’altra i cittadini “resistenti” che desiderano il riscatto civile e umano del loro paese, e la salvaguardia della Costituzione. Faticoso sembra oggi pensare e progettare una risposta, difficile sognare un altro mondo possibile. Allora, attraverso un gesto simbolico forte, un gesto epico e insieme concreto, semplice e sconvolgente, questi cittadini che vedono il proprio paese sempre più lontano, decidono di imbarcarsi nell’impresa possibile di accendere una luce per l’alternativa. All’alba del grande movimento degli indignati che da lì a poco invaderà le piazze”. Il documentario diventa perciò la cronaca partecipata, appassionata, ma a tratti anche malinconica, di questo tentativo utopico di far emergere un’altra Italia possibile. In fondo tutto era partito da Genova e a Genova in qualche modo ritorna, con una circolarità geografica e mentale molto significativa…
Prima de “Lo sbarco”, Adonella torna al suo amato mondo della natura e realizza un altro documentario “Libellule” (2009), delicata opera a meta strada fra lirismo bucolico, impegno ecologista e documentario di divulgazione naturalistica. Le libellule sono gli insetti più antichi, gli abitatori incontrastati delle zone umide che volavano su tutto il pianeta fin dai suoi albori, ma oggi si stanno estinguendo. Il documentario della regista torinese racconta con delicatezza e poesia il mondo di questi antichi abitatori delle paludi e le cause, purtroppo tutte dovute alle azioni umane, della loro progressiva estinzione, dopo aver resistito ai cambiamenti millenari della Terra.
Gli ultimi anni della cineasta piemontese non sono purtroppo densi di realizzazioni. Ed è in qualche modo una conseguenza della sua coerenza, della sua indipendenza produttiva e tematica, della sua vicinanza alle lotte degli invisibili, di chi non vuole arrendersi alle logiche del pensiero unico. Nell’ultimo cortometraggio “Lunestorte” (2018) Adonella torna ad incrociare il linguaggio documentaristico con quello teatrale in un’opera che ancora una volta racconta un’altra storia di esclusione e di riscatto, quella dei malati mentali dell’ospedale psichiatrico (o manicomio, come si diceva una volta) di Collegno, il più grande d’Italia, aperto nel lontano 1856 e chiuso definitivamente solo nel 1996. “Il film rielabora lo spettacolo teatrale “Storie di Lunestorte” di Rosanna Rabezzana e Mirella Violato, allestito per la prima volta nel 2006 nei grandi spazi dell’ex ospedale psichiatrico di Collegno.
Voci, gesti, testimonianze, immagini d’archivio restituiscono un percorso corale di storie vissute tra le mura del manicomio. Il lungo muro che dalla fine dell’’800 rendeva impossibile ogni comunicazione tra interno e esterno del manicomio e manteneva invisibili migliaia di vite, venne aperto nel 1977. La chiusura del manicomio rivelò una realtà drammatica di violenza, degrado e oblio e mise sotto accusa una psichiatria che in quegli anni sarebbe radicalmente cambiata”. La telecamera di Adonella si muove con delicatezza, ma anche con profondo dolore fra i corridoi vuoti dell’ex manicomio, densi di ricordi e di storie angosciose, e i volti delle donne-attrici sul palcoscenico, viaggia in profondità nelle parole di chi pronuncia frasi come pietre, vite perdute come quella di chi, quasi urla al pubblico, “come sarebbe stata la mia vita se a 20 anni non mi avessero rinchiusa?”. Ma il manicomio, anche se chiuso, rischia di tornare nelle gabbie del pregiudizio, della discriminazione e del rifiuto che ancora affollano le menti di chi non sa accettare la diversità. Un monito che risuona nelle parole della voce narrante, Roberta Biagiarelli: “Adesso la porta era stata violentemente e inesorabilmente aperta. Il portone del manicomio più importante, quello di Collegno, era stato aperto a spallate. Distruggere il manicomio non è mai una volta per tutte. E’ un processo che va sempre presidiato, che richiede una cura continua per non ricostruire il manicomio nelle nostre menti, prima ancora che intorno a noi”.
Adonella Marena ci ha lasciato nel novembre dell’anno scorso. Vogliamo ricordarla con le sue parole, quelle di una documentarista scomoda, impegnata nell’abbattere le barriere spesso artificiose fra ciò che è oggettivo e ciò che è soggettivo, mai stanca, come nelle parole dei comandanti zapatisti del Chiapas, di “camminare domandando”.
“Il percorso è stato difficile e controverso, ma il mio retroterra di elaborazione con le donne mi ha dato chiarezza di intenti: la rifIessione del femminismo sui processi di conoscenza, di interpretazione e di rappresentazione del mondo, non più legati solo a parole come razionalità, coscienza, obiettività, ma ad esperienze che inglobavano anche la propria soggettività, il proprio corpo, il linguaggio non verbale o inconscio, mi hanno aiutata a dipanare il dubbio come documentarista: cos’è sinceramente reale se non quello che posso raccontare anche col mio punto di vista e la mia sensibilità? La soggettività non è un limite e lo sguardo delle emozioni e del desiderio non è il tradimento della realtà. Al contrario è l’uso totale della propria testimonianza, della propria presenza nella società. Questa elaborazione è entrata nel mio lavoro di documentarista con gioiosa consapevolezza. Costante, nei miei film è la propensione a dar voce, visibilità, dignità a storie che pur sembrando di “minoranza” o marginalità, rifIettono aspetti inconsueti, stimolanti o anche scomodi della realtà. Cerco di raccontare personaggi e situazioni che possano diventare granelli di sabbia negli ingranaggi di un pensiero unico dominante, perché rivelano pensieri nuovi, o confIitti nascosti, o ottusi conformismi .
Possono disturbare o smascherare.
Possono far ricordare.
Granelli di sabbia l’hanno gettati le migranti di “Okoi..”, con la loro fierezza, cultura, ironia e bellezza, ad allontanare l’immagine del migrante passivo e privo di risorse; la combattente ottantenne, con il rigore, la curiosità e il coraggio inossidabile nel guardare la vita; i disobbedienti delle tute bianche, che smascherano la violenza del potere con la fantasia del corpo; gli indiani valsusini, con la loro lucida determinazione e la pratica tenace di valori in disuso, come il senso del bene comune e della democrazia partecipata.
Granello di sabbia è anche lo sguardo puro e interrogante del vitello nella fabbrica degli animali, e il silenzio della montagna, violata dal fugace sogno olimpico. Ogni film è un’esperienza speciale, spesso lunga, che mi coinvolge nel tempo con il suo carico di atmosfere, amicizie, antipatie, studio, scrittura, azioni esaltanti o grandi fatiche. Poesia o nottate al freddo. Non è facile entrare e uscire dalle storie, alla fine non le abbandono mai del tutto, mi accompagnano confondendosi con la mia vita”.
Adonella Marena sul web:
Associazione Djanet
http://www.associazionedjanet.it/adonella-marena/
“Okoi e i semi di zucca”
“Facevo le Nugatine”
“La combattente”
“La fabbrica degli animali”
“Anime di città”
“Mobilitebio: quando la terra è in vendita…”
https://www.youtube.com/watch?v=dzTkwZ4W2C8
“Tute Bianche, un esercito di sognatori”
https://vimeo.com/ondemand/tutebianche
“M’agradavo vioure ilamoun”(Ipotesi sui giochi olimpici 2006)”
https://www.youtube.com/watch?v=ZD_NpcbFqik
“NoTav: gli indiani di valle”
https://www.youtube.com/watch?v=BS6WLg5OK0s
“Non mi arrendo, non mi arrendo!”
https://www.youtube.com/watch?v=ZmRGeIR_dwY
“Il cartun d’le ribelliun – Il carretto delle ribellioni.
Da Venaus a Roma a passo d’uomo”
https://www.youtube.com/watch?v=28iAbyWqYkU
“Libellule”
https://www.youtube.com/watch?v=DwLMYCnQ1xg
“Lo sbarco”
https://www.youtube.com/watch?v=lUql9pg5mkY
“Lunestorte”
https://www.youtube.com/watch?v=Knq5vu7-UqI
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
ITALO SVEVO TRA CINEMA TELEVISIONE E LETTERATURA
A cura di
Alessandro Cuk e Barbara Sturmar
Alcione Editore – 2022
Pagg. 172, Euro 15
Italo Svevo è stato uno scrittore triestino le cui opere sono state apprezzate in tutto il mondo. E sono state oggetto di significative trasposizioni cinematografiche e televisive. Non dimenticando che ve ne sono state anche teatrali, particolarmente rilevanti. Riferendosi a quelle cinematografiche e televisive Alessandro Cuk e Barbara Sturmer hanno pubblicato un libro dal titolo “Italo Svevo tra cinema e letteratura”. L’obiettivo è quello di indagare e approfondire la relazione tra i testi dello scrittore e le relative trasposizioni sia al cinema che in televisione. A partire, soprattutto dagli anni Sessanta, quando Sandro Bolchi porta in scena in televisione “Un marito”, che era stato rappresentato in teatro. Il cinema invece vi si avvicina con “Senilità” (1962) di Mauro Bolognini. Vi si racconta di un intellettuale quarantenne (Anthony Franciosa) che allaccia una relazione con una ragazza molto giovane e bella (Claudia Cardinale) priva di qualsiasi scrupolo morale. I suoi tradimenti a lungo andare deteriorano il rapporto e i due si lasciano. La situazione dell’uomo si aggrava quando la sorella (Betsy Blair), delusa anche lei sentimentalmente dall’amore per un gaudente scultore (Philippe Leroy) si suicida. Un film ambientato in una Trieste autunnale e crepuscolare di grande fascino. Restando nel campo del cinema, da segnalare è anche il film di Francesca Comencini “Le parole di mio padre” (2001) tratto dal secondo e terzo capitolo del romanzo “La coscienza di Zeno”, scritto nel 1923, la cui ambientazione è spostata da Trieste a Roma. E’ incentrato su Zeno Cosini (Fabrizio Rongione) che un anno dopo la morte del padre (Toni Bertorelle) si innamora di Ada (Chiara Mastronardi), primogenita di Giovanni Malfenti (Mimmo Calopresti) per cui lavora, ma è da lei respinto. Si fa sedurre dalla seconda genita Alberta (Claudia Coli) e sposa, senza amore, Augusta (Viola Graziosi), la terza. Un’opera questa di Italo Svevo portata in televisione per ben due volte: nel 1966 da Daniele D’Anza (su sceneggiatura del triestino Tullio Kezich che ha come protagonista Alberto Lionello ed un’altra nel 1988 da Sandro Bolchi, sceneggiato ancora da Kezich insieme a Dante Guardamagna) interpretato da Johnny Dorelli. “La coscienza di Zeno” avrebbe voluto portarla sullo schermo anche Giorgio Strehler: ne aveva scritto un trattamento che “è ricco di riflessioni talmente accurate da avvicinarlo a un acuto lavoro di critica letteraria”. Il libro di Cuk e Sturmer propone anche un approfondimento del documentario realizzato da Franco Giraldi nel 1978, in occasione del cinquantenario della scomparsa dello scrittore, dal titolo “La città di Zeno. A Trieste con Italo Svevo”, imperniato sulla presenza culturale dell’autore testimoniata attraverso i ricordi, luoghi e memorie raccontati dai discendenti della famiglia ma anche, tra gli altri, di Claudio Magris, Fulvio Tomizza, Vittorio Vidali e Franco Basaglia. Il volume è corredato da significative immagini tratte soprattutto da film e rappresentazioni teatrali.
Gesù. Il film di una vita
di Carl Theodor Dreyer (Autore)
Marco Vanelli (Curatore)
Iperborea, 2023
Pagg. 424, Euro 19.50
Pubblicato da Iperborea, a cura di Marco Vanelli è uscito il libro “Gesù. Il film di una vita” che pubblica la sceneggiatura di un film che non vide mai la luce. Una sceneggiatura già pubblicata altre volte ma mai nella sua versione definitiva, così come avviene invece oggi. “La sceneggiatura pubblicata, informa Marco Vanelli, è quella di un film mentale, girato in testa tante volte dal regista Carl Theodor Dreyer, che si potrebbe dire che il regista il progetto lo avesse comunque realizzato dentro di sé”. Marco Vanelli ripercorre quindi le tappe del regista a proposito della sua intenzione di realizzare questo film. Il maestro danese comincia a pensare ad un film su Gesù sin dagli anni Trenta quando in Europa si affermano tendenze antisemite. E’ da ricordare che negli anni della guerra la Danimarca viene invasa dai nazisti, e ciò stimola in Dreyer un paragone con la Palestina al tempo dei romani: secondo l’editore, i coloni romani come gli invasori tedeschi, il governo ebraico come i collaborazionisti, gli idealisti come la resistenza. E Gesù è nella resistenza. Nel 1949 Dreyer vide l’impresario teatrale americano Blevins Davis disposto a produrre il suo film, ma poi vedendo che il personaggio era inaffidabile accetta l’offerta che gli viene dalla Rai. Ma il 20 marzo del 1968 il regista danese muore, senza aver potuto realizzare il suo film su Gesù che nel tempo prenderà più nomi: “Jesus of Nazareth”, “Gesù l’ebreo”, “The Life of Jesus”, “La vita di Cristo”, “Cristo contro il razzismo”, “La storia del Gesù Ebreo”. Ma di fatto, avverte Marco Vanelli, è sempre stato il “Jesus – film”, inteso come progetto, aspirazione, sceneggiatura,” sogno da desti”, secondo la definizione di Dreyer. Ed afferma che se questa sceneggiatura non è stata realizzata in film “non è stato solo per le innumerevoli traversie produttive, ma anche per il particolare taglio con cui Dreyer rilegge il Vangelo”, essendo stato, aggiunge, per il regista la passione di Cristo un paradigma per raccontare le vicende umane dei suoi personaggi come si è visto nei film “La passione di Giovanna D’Arco” (1928), “Dies Irae” (1943) e “Ordet” (1955). Dal canto suo il figlio di Dreyer afferma che il padre credeva in un Dio cosmico, presente nelle cose e in noi, un Dio da raggiungere faticosamente, duramente. Un’entità con la quale stabilire un dialogo che si sa a priori contorto, aspro, contraddittorio. I tanti frammenti della sua vita, aggiunge, fanno pensare che quello che lui aveva era un bisogno di religiosità e di spiritualità. Dreyer conclude la sua vita di regista nel 1964 con “Gertrud”, la cui protagonista è una donna che ha sempre aspirato all’amore assoluto ma che nella vita ha conosciuto molte delusioni. Ma nel bilancio della sua esistenza dirà: “Tutto è amore”. Un film – testamento della fedeltà di Dreyer ad una creazione solitaria e ascetica”. Una vita terminata con il rimpianto di non aver potuto portare a conclusione il film “Jesus”, di cui finalmente, grazie a Marco Vanelli, si può oggi conoscere il testo più attendibile della sceneggiatura da lui scritta. Mi piace concludere con il giudizio di Federico Fellini su Dreyer, ricordato in quarta di copertina: “I film di Dreyer, cosi rigorosi, casti, austeri. Mi sembrano arrivare da una mitica terra lontana e ai miei occhi il loro creatore è una specie di artista – santo”.
Fabio Zanello
“Vivere e morire a Los Angeles” di William Friedkin
Gremese Editore, 2022
Pagg. 126, Euro 19.50
L’editore Gremese pubblica da tempo una Collana, diretta da Enrico Giacovelli, su “I migliori film della nostra vita”. Oltre una ventina quelli finora pubblicati.
Abbiamo ricevuto di recente quello che Fabio Zanello ha dedicato al film di William Friedkin del 1985, “Vivere e morire a Los Angeles”, ambientato nella Città dei Premi Oscar degli anni Ottanta. Un volume che contiene un saggio di Daniela Cantelli che si sofferma su “Los Angeles anni Ottanta. Friedkin e il voyeurismo dell’anima” in cui sottolinea che il cinema di William Friedkin non è sempre stato popolare e la sua fortuna in Italia ha preso il via in Italia dopo il 1997 quando partecipò al Noir in Festival, in occasione di una retrospettiva, da lei curata, e di un volume. Aggiungendo che quando uscì in America il 1° novembre 1985, incassò poco più di 17 milioni di dollari, piazzandosi al cinquantunesimo posto nella classifica dell’anno e che arrivato in Italia passò pressoché inosservato e fu recensito da pochi, ma nel tempo ha assunto poi uno status di culto.
Prosegue con un Prologo in cui Fabio Zanello si sofferma su “Il neonoir americano degli anni Ottanta” sottolineando il ruolo di William Friedkin, analizzando “il romanzo d’origine” dovuto a Gerald Petievich e riferendo sul lavoro del casting del film e del direttore della fotografia Robby Muller, su alcuni personaggi “duplici, opportunisti e votati alla solitudine” e sulle musiche utilizzate. Poi Fabio Zanello fa un lungo racconto del film analizzandone alcuni aspetti. Per arrivare all’Epilogo in cui analizza alcuni momenti centrali di questo film con cui William Friedkin tende, a suo parere, ancora una volta a imporsi come uno degli “irregolari“ del cinema americano, poiché nella sua poetica il poliziesco ha sempre svolto la funzione di una coordinata per definire l’ambiguità, e il labile confine fra bene e male. Completano il volume alcuni materiali. Da “la parola al regista”a quella della critica , di cui riporta alcuni brani di recensioni. Per finire con un’intervista di Daniela Catelli a Jack Hues che ha composto la colonna sonora del film. Utili sono anche le indicazioni della bibliografia, della videografia e della filmografia, anche di quella successiva a “Vivere e morire a Los Angeles2(1985). Il volume è poi impreziosito da molte immagini del film che rendono più interessante la lettura dei vari capitoli poiché di essi sono un corredo significativo.
Vania Protti Traxler
Sognavamo al cinema.
Conversazioni con Francesca Boschiero e Giovanni B. Gifuni
Edizioni Sabinae 2022
Pagg. 253 , Euro 18
L’Academy è una casa di distribuzione cinematografica che ha contribuito moltissimo all’evoluzione del gusto dello spettatore, ma anche della critica. E lo ha fatto a partire dagli anni Settanta grazie ai film di qualità che con coraggio ha immesso nel circuito delle Sale italiane. Tutto ebbe inizio bel 1978 quando grazie all’Academy fu programmato in Italia “Il matrimonio di Maria Braun” di Rainer Werner Fassbinder. Fu un successo che premiò il coraggio dei coniugi Traxler(Manfredi e Vania) e li spronò a continuare su quella strada. Più volte li si è visti ai Festival più importanti attenti a non farsi sfuggire quelle opere che ritenevano opportuno far circolare affinché il pubblico più vasto potesse vederli. Quelli da loro distribuiti sono stati film dove la qualità si poteva ben sposare con il successo commerciale. Un modo di operare che di certo contribuito a stimolare lo spettatore ad avere fiuto e ad avere il coraggio di compiere un salto di qualità nelle proprie scelte di fruizione del cinema.
Un libro che nasce da conversazioni con Francesca Boschiero e Giovanni B. Gifuni precedute da una prefazione del critico cinematografico Federico Pontiggia. In essa, egli sottolinea anche come la distribuzione di Vania e Manfredi Traxler abbia fatto incetta di premi tra Oscar, David di Donatello, Mostra di Venezia e Festival di Cannes, Berlino, Locarno e Roma e come Vania Protti sia stata una donna di cinema, nobilitando la distribuzione a linguaggio “inteso formalmente e mirabilmente quale selezione e combinazione di film. Grandi, grandissimi film a immagine e somiglianza di sé”. E ne ricorda alcuni: oltre al già citato “Il matrimonio di Maria Braun” (1978) di Rainer Werner Fassbinder, “Paris, Texas”di Wim Wenders che ha ricevuto nel 1984 la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Ed ancora di Wenders “Il cielo sopra Berlino” (1987), poi l’Orso d’Oro del Festival di Berlino “Sorgo rosso” (1987) di Zhang Yimou, “Légami” (1989) di Pedro Almodovar ed i tre di Krysztof Kieslowski “Film Blu” (1993) , “Film Bianco”(1994) e “Film Rosso”(1994). Ma anche “Trans de vie” (1998) di Radu Mihaileanu. Una donna Vania Protti Traxler che non ha barcollato o mollato quando il marito Manfredi è morto a Venezia nel 2000 ma è andata avanti, distribuendo altri capolavori, tra cui “Faust” di Alexander Sokurov, “Leone d’Oro” alla Mostra di Venezia 2011. L’intervista di Francesca Boschiero e Giovanni B. Gifuni coglie Vania Protti Traxler nel suo ufficio, alle cui pareti sono appese decine di film distribuiti in oltre trent’anni di carriera. Su molti dei quali si sofferma nei tanti capitoli in cui poi si sviluppa la conversazione. Facendoci così immergere nella storia del cinema europeo degli ultimi decenni. Di alcuni di questi film ci viene anche fornito un Ricettario, con Menù elaborati da Vania Protti Traxler, che rende ancor più prezioso questo volume che comprende anche l’intera filmografia dei film distribuiti dall’Academy dandoci così la giusta misura del valore di un’attività svolta con tanta passione e coraggio.
CREDITS
Carte di Cinema 29
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E. Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 29 della rivista online, Roberto Baldassarre, Paola Brunetta, Gianluca Castellini, Marcello Cella, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Giorgio Ricci, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Marco Incerti Zambelli.