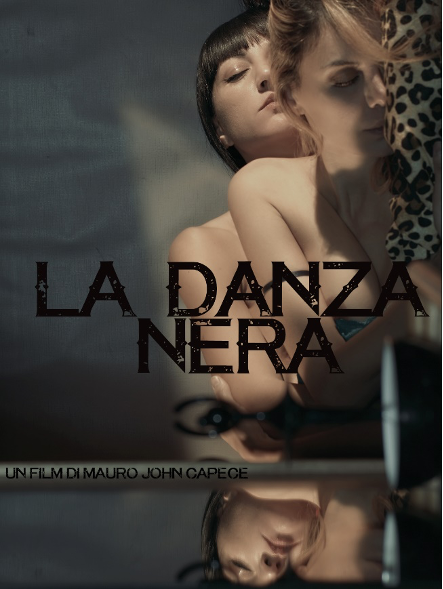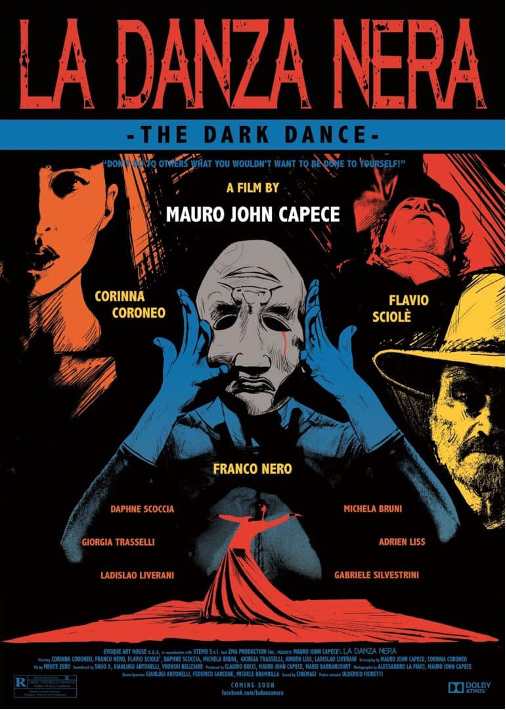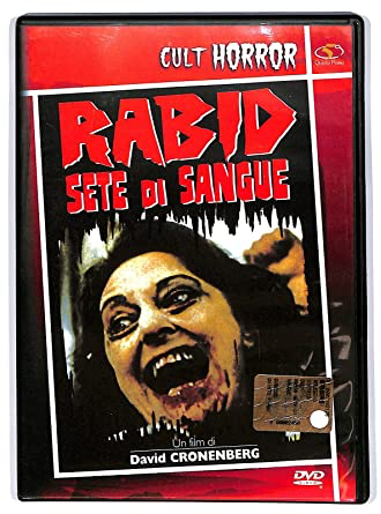Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 3.1 IL COLLEZIONISTA DI CARTE: LA MORTE DELLA LUCE (E IL SUO RISORGERE) di Francesco Saverio Marzaduri
- 3.2 ALDO BUZZI, L’IRONIA DELL’AIUTO REGISTA di Roberto Baldassarre
- 3.3 DA “SCANNERS” A “LA MOSCA”. MUTAZIONI E MATURAZIONE STILISTICA IN DAVID CRONENBERG di Roberto Lasagna
- 3.4 MITI E STEREOTIPI D’AMERICA NEI FILM ITALIANI DEL VENTENNIO FASCISTA di Mario Galeotti
- 3.5 LA PREPARAZIONE AL LUTTO: QUALCHE FILM di Paola Brunetta
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 6 PROFILO
- 7 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO
- 8 OCCHIO CRITICO
- 9 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 10 LA MEMORIA DEL CINEMA
- 11 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
L’ENIGMA DOLOROSO IL CINEMA DI MAURO JOHN CAPECE di Marcello Cella
Alla scoperta del cinema di Mauro John Capece. L’ambiguità, la denuncia, la politicità etica ed estetica di un regista ancora troppo poco conosciuto, ma della stessa generazione dei vari Sorrentino, Garrone, Winspeare, Gaglianone.
L’IMPORTANZA DEL SOTTOTESTO E DELL’AMBIGUITÀ – INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPECE di Marcello Cella
SAGGI
IL COLLEZIONISTA DI CARTE: LA MORTE DELLA LUCE (E IL SUO RISORGERE) di Francesco Saverio Marzaduri
Dietro la confezione dichiaratamente “vintage”, il ventunesimo lungometraggio del cineasta di Grand Rapids è un cinema di attesa, riscatto e redenzione che denuncia un modello politico e sociale in cui il marcio non è nelle mele, ma nei cestini.
ALDO BUZZI, L’IRONIA DELL’AIUTO REGISTA di Roberto Baldassarre
Aldo Buzzi, noto maggiormente come arguto e beffardo scrittore (romanzi e saggi), ha avuto anche una proficua carriera cinematografica, sintetizzata nel suo mirabile libello “Taccuino dell’aiuto regista”.
DA “SCANNERS” A “LA MOSCA” – MUTAZIONI E MATURAZIONE STILISTICA IN DAVID CRONENBERG di Roberto Lasagna
Prima di realizzare, sul finire degli anni Ottanta. Il raffinato melodramma “Inseparabili”, e dopo gli exploit dei ruvidi anni Settanta, David Cronenberg, con il suo cinema delle mutazioni, prorompe regalando alcune tra le esperienze più radicali e allarmanti dell’epoca, con film destinati a divenire cult come “Scanners”, “Videodrome”, “La zone morta”, “La mosca”.
MITI E STEREOTIPI D’AMERICA NEI FILM ITALIANI DEL VENTENNIO FASCISTA di Mario Galeotti
Gli stereotipi che, almeno a partire dalla fine dell’Ottocento in concomitanza con i grandi flussi migratori verso gli Stati Uniti d’America, hanno sintetizzato, in tempi diversi ma con sorprendente continuità, la percezione del mito americano si sono concentrati principalmente su pochi e riduttivi aspetti: la verticalità della metropoli coi suoi grattacieli, l’opulenza, le grosse automobili, l’abuso di superalcolici, le stravaganti abitudini, la figura del facoltoso uomo d’affari. Stereotipi che offrivano una rappresentazione parziale della ben più complessa realtà americana e che, almeno in parte, si ritrovano in alcuni film italiani del ventennio fascista, soprattutto commedie: Due cuori felici di Baldassarre Negroni (1932), Cose dell’altro mondo di Nunzio Malasomma (1939), Centomila dollari di Mario Camerini (1940), Dopo divorzieremo di Nunzio Malasomma (1940).
LA PREPARAZIONE AL LUTTO: QUALCHE FILM di Paola Brunetta
Il presente saggio affronta in particolare due opere che vertono sul tema della preparazione al lutto e che si possono accostare ad un altro film che tratta tangenzialmente questo tema, “The Father – Nulla è come sembra” di Florian Zeller: “Nowhere Special” di Uberto Pasolini e “Supernova” di Harry Macqueen. Colpiscono sia la delicatezza con cui in entrambi i casi è toccato l’argomento, che ci parla del valore delle opere, sia la curvatura che i registi danno a un qualcosa che generalmente, nella letteratura e nel cinema, viene proposto come elaborazione di un lutto. Si guarda cioè al dopo, al post mortem, e non ci si concentra sul prima, come fanno i nostri film. Oppure, secondo un filone che negli ultimi tempi vede spesso come protagonisti gli adolescenti, si parla del prima in termini di malattia, per la persona interessata e per coloro che le stanno vicino. Si tratta, in ogni caso, di film sulla morte (imminente) ma anche di film sull’amore. Storie d’amore intense e toccanti tra un padre e un figlio, e tra due uomini maturi. Storie di dedizione all’altro, di abnegazione, di dono di sé mai patetiche o drammatiche ma sempre discrete, misurate. Poetiche.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
INAUGURAZIONE DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE STUDI E RICERCHE CINEMA FERRARESE di Maurizio Villani
Resoconto dell’iniziativa che ha sede presso il Circolo dei Negozianti a Palazzo Roverella.
SAN GIORGIO DI PIANO RICORDA LA SUA GIULIETTA MASINA di Paolo Micalizzi
Il paese natio della grande attrice l’ha ricordata con un documentario e un libro.
FESTIVAL ED EVENTI
VENEZIA 2021: UNA GRANDE MOSTRA CHE HA SCONFITTO ANCORA UNA VOLTA LA PANDEMIA di Paolo Micalizzi
Una grande Mostra raccontata attraverso i film premiati ed altri significativi emersi dai Premi collaterali. Attenzione alla presenza FEDIC alla Mostra.
AL FEMMINILE LA 69^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
Un’edizione del festival di San Sebastiàn che ha visto il mondo femminile focalizzare quasi tutto il protagonismo dell’evento cinematografico, dai temi narrativi proposti alla conquista dei principali premi. Film con interessanti proposte narrative, visive e fotografiche. C’è stato di tutto, polemiche, critiche e una ripresa del glamour, con protagonisti Marion Cotillard e Johnny Depp che hanno ricevuto i Premi Donostia.
PREMI, ANTEPRIME, CONVEGNIO AGLI INCONTRI DEL CINEMA D’ESSAI DI MANTOVA di Paolo Micalizzi
Una cronaca dell’importante iniziativa che annualmente la FICE svolge a Mantova
PROFILO
DAL “PICCOLO TEATRO” AL GRANDE SCHERMO: IL CINEMA DI RENATO DE CARMINE di Mario Giunco
Più famoso come attore di teatro e di sceneggiati televisivi, Renato De Carmine è stato anche interprete cinematografico, in ruoli marginali e in opere spesso scarsamente valutate dalla critica. La sua filmografia, che copre oltre sessant’anni e annovera registi e attori di prestigio, merita tuttavia di essere conosciuta.
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre
UN CHIEN ANDALOU” di Roberto Baldassarre
Il provocatorio esordio di Luis Buñuel, “Un chien andalou”, non è solamente perfetta espressione cinematografica del surrealismo, ma mostra anche la prorompente forza immaginifica che può avere il cinematografo.
OCCHIO CRITICO
I FRATELLI DE FILIPPO (E QUALCHE ALTRO) di Tullio Masoni
Scarpetta e i De Filippo: dal comico, all’umoristico. Le diverse “patrie” nell’Italia fascista e del dopoguerra.
DUE FILM IRANIANI – “THERE IS NO EVIL” DI MOHAMMAD RASOULOF; “UN EROE” DI ASGHAR FARHADI di Paolo Vecchi
Suddiviso in quattro epsodi, “There Is no Evil” ha come filo conduttore la figura del boia, di chi uccide per lo Stato, oppure di chi rifiuta questo ruolo pagandone le conseguenze. Si tratta dunque di un film duramente politico, in cui l’urgenza del messaggio non va a scapito del rigore stilistico.
L’eroe del titolo è Rahim, in carcere per debiti che, durante un permesso, decide di restituire una borsa di monete d’oro trovata dalla sua nuova compagna anziché impossessarsene per tacitare il creditore. Ma la tempesta mediatica che il suo gesto scatena finisce per rivoltarglisi contro.
GUIDANDO: DUE FILM ROAD MOVIE di Marco Incerti Zambelli
Le uscite pressoché contemporanee de “Il gioco del destino e della fantasia “ e di “Drive my car”, pluripremiati in diversi Festival, confermano il grande talento di Ryusuke Hamaguci, che trascendendo dall’ambientazione giapponese, sa mettere in scena delicate storie internazionali.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
ODIO DUNQUE SONO di Marcello Cella
Il documentario di Valerio Nicolosi “I Fili dell’odio”, scritto da Tiziana Barillà, Daniele Nalbone e Giulia Polito e prodotto dalla Copperative Il Salto e dallo Zerostudio’s di Michele Santoro, indaga sulle radici dell’odio on line e sui suoi bersagli preferiti: le donne, gli ebrei, i diversi e perfino Papa Bergoglio.
LA MEMORIA DEL CINEMA
“LA STRADA“ DI FELLINI di Tullio Masoni
CREDITS
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
L’ENIGMA DOLOROSO
IL CINEMA DI MAURO JOHN CAPECE
di Marcello Cella
“Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario”
George Orwell
Pochi registi come Mauro John Capece sanno creare narrazioni così violentemente realistiche e allo stesso tempo così drammaticamente fantastiche e ambigue, al limite dell’horror. Anche se l’orrore che racconta il regista abruzzese classe 1974 è qualcosa che conosciamo bene, che ci appartiene perchè lo frequentiamo da molto tempo. E’ l’orrore dei rapporti di forza che continuamente si rimodulano nelle società occidentali tardo capitalistiche, delle miserie che corrodono le relazioni umane e sociali, della solitudine degli esseri umani atomizzati e abbandonati a sé stessi nella corrente impetuosa della competizione globale, l’orrore di una cultura quasi completamente mercificata che non lascia spazio alla creatività dei singoli, alla loro riflessione e pretende solo la loro sottomissione senza se e senza ma. I personaggi dei film di Mauro John Capece quasi mai riescono a riscattarsi da questo legame oppressivo con il potere del denaro, ma continuano comunque a combattere per sopravvivere all’indifferenza, all’acquiescenza, alle sottili perversioni del potere e il regista dissemina gli spazi e i tempi narrativi di crepe, di vie di fuga, di zone d’ombra, di ambiguità che lo preservano dalla retorica del cinema apertamente politico senza perdere nulla della violenza della denuncia con cui si scaglia contro lo status quo. Questo approccio realistico ed enigmatico allo stesso tempo è ben presente soprattutto nei film che costituiscono una ideale trilogia, e cioè “La scultura” (2015), “Sfashion. La neoborghese Via Crucis” (2017) e “La danza nera” (2020).
Ne “La scultura” sono già ben presenti tutti i temi su cui Capece riflette nelle sue opere cinematografiche e narrative (è autore anche di cinque libri) da quando ha iniziato il suo percorso artistico all’inizio degli anni 2000. Il film racconta con accenti pasoliniani e sul filo di una radicale sperimentazione linguistica il rapporto che si instaura fra Mosè, uno scultore di talento, ma oberato dall’assillo del denaro che non riesce a guadagnare, e Korinne, una affascinante escort che invece di denaro facile riesce a guadagnarne parecchio con il suo mestiere. Lo scultore affitta una stanza del suo appartamento a Korinne e da quel momento inizia un gioco di attrazioni non dichiarate tra chi frequenta per mestiere una bellezza estetica quasi fuori dal tempo e dai rapporti materiali, ma a rischio di estinzione, e chi prostituisce la propria bellezza per guadagnare denaro facile e adeguarsi ai tempi malsani in cui vive. L’incontro fra i due avrà conseguenze drammatiche per lo scultore che decide di vivere l’esperienza della prostituzione, ma sarà forse la via di salvezza per Korinne che scopre l’esistenza di una bellezza interiore ancora non contaminata dalle miserie della vita quotidiana. In questo primo lungometraggio di narrazione, dopo il documentario del 2012, “In the Fabulous Underground” sulla figura di Anton Perich, grande artista newyorchese di origine croata, assimilabile per certi versi al movimento della Pop Art di Andy Warhol, Capece inizia a proporre alcune costanti tematiche e linguistiche che caratterizzano tutto il suo cinema successivo.
Prima di tutto la riflessione sulla creatività delle persone costrette a vivere una vita, tipica delle società occidentali (e non solo) tardo-capitalistiche, senza spazi per la bellezza scollegata dall’opprimente mercificazione del mondo, il rapporto con il denaro che spesso costringe i singoli a scelte contronatura, disumane e alla fine anche fallimentari. A livello linguistico invece Capece inizia quella ricerca minuziosa sugli spazi, sulle superfici, sulle geometrie che rendono la materia narrativa assolutamente realistica e assolutamente ambigua allo stesso tempo, come se la simmetria esibita, “troppo” esibita, la mancanza apparente di chiaroscuri fossero di per sé rivelatori di un secondo livello di significato, non dichiarato apertamente, sfuggente e misterioso.
Allo stesso modo in “Sfashion” Capece racconta la vicenda drammatica di Evelyn, una imprenditrice elegante, colta, creativa, al timone di una storica azienda di moda ereditata dal padre e dal nonno, che si trova improvvisamente a fare i conti con un mercato dei prezzi completamente stravolto dalla globalizzazione finanziaria e da una tassazione iniqua. Una specie di Far West senza legge e senza regole, dove ai killer non servono le pistole per uccidere gli avversari, ma basta strangolarli lentamente per farli fallire. Evelyn, interpretata, come in tutti i film di Capece, dalla magnifica Corinna Coroneo, presenza forte e inquietante, vera musa e alter ego del regista, nonché sceneggiatrice e collaboratrice preziosa, cerca in tutti i modi di resistere al tracollo finanziario, con l’aiuto concreto di un amministratore fidato, Bartolomeo, e di una sorta di presenza spirituale incarnata da un antico ulivo, piantato sul terreno di famiglia quando lei era bambina, che lei chiama Antoine, a cui confida segretamente le proprie angosce e fragilità. Alla fine la donna, abbandonata da tutti, non potrà fare altro che prendere atto del fallimento imprenditoriale e personale ed iniziare, forse, una nuova vita altrove. Restano negli occhi e nel cuore dello spettatore un senso profondo di solitudine, incarnato dall’ostinata e silenziosa disperazione di Evelyn, che attraversa gli enormi ambienti della fabbrica come se cercasse una risposta al proprio disorientamento, una via di fuga dall’alienazione della produzione industriale e dai suoi meccanismi feroci che hanno distrutto la sua vita, i suoi affetti, la sua storia. Una presenza che accomuna in qualche modo la Evelyn di Capece a tante protagoniste femminili, inquiete e sfuggenti, dei film di Michelangelo Antonioni.
Il terzo film della trilogia, “La danza nera”, racconta a tinte noir, la ferocia del precariato lavorativo che travolge la vita di una ballerina, Manola, laureata, lesbica e senza fissa dimora che decide di farsi giustizia da sé con il rapimento del sindaco a cui aveva chiesto aiuto in passato ricevendone solo vaghe promesse e avances non richieste.
Franco Nero nel film “La danza nera”
Anche in questo caso le rigida simmetria degli spazi disegnati dalla fotografia di Capece alludono ad una sofferenza inespressa, compressa nelle ipocrisie della politica-spettacolo odierna, attenta solo alla manipolazione dei media in funzione dell’acquisizione del consenso, disinteressata ai problemi concreti della gente comune e che, proprio per questo stato di cose, esplode con maggiore violenza nel momento in cui saltano tutte le mediazioni possibili. Il rapimento e la tortura del sindaco da parte di Manola è chiaramente un’azione senza futuro, destinata ad un drammatico fallimento e alla morte, un atto di ribellione prepolitico, ma un urlo di disperazione drammaticamente reale. Capece evita le trappole del film di aperta denuncia politica per raccontare in modo viscerale il drammatico deragliamento esistenziale di una persona profondamente onesta e creativa costretta a vivere in un mondo profondamente ipocrita, violento, disumano e senza neppure l’ombra di una qualsiasi creatività. A questo proposito è significativo il discorso che il direttore del teatro in cui si esibiva Manola, John Butterfly, interpretato da un inquietante Franco Nero, pronuncia sul palco dopo la scomparsa della ballerina: “Una vita non creativa vissuta accanto a persone non sensibili e non creative è forse la peggiore condanna che possa capitare ad una persona insieme alla fame, alla malattia, alla morte”.
L’ultima opera di Mauro John Capece, “Reverse” (2021), vira invece verso il thriller giudiziario con venature horror, quindi verso un cinema più orientato verso un genere codificato, senza però che vengano meno lo stile e la ricerca poetica del regista. Il titolo allude ad una tecnica di interrogatorio utilizzata dalla polizia americana per far confessare i colpevoli di un reato. In questo caso il colpevole è un famigerato serial killer psicopatico che uccide sistematicamente le influencer con un coltello blu.
Ritenuto incapace di intendere e di volere rischia però di evitare la condanna. Un’ispettrice di polizia, convinta che la sua pazzia sia solo una finzione, è incaricata di smascherarlo per ottenere una lucida confessione dei suoi omicidi. Girato quasi tutto in interni durante il lockdown, “Reverse” si avvale di una messa in scena quasi teatrale per attivare un gioco di specchi fra i due protagonisti, interpretati ancora una volta dall’enigmatica Corinna Coroneo e da Adrien Liss, altro attore feticcio del regista abruzzese, in cui vittima e carnefice si scambiano continuamente i ruoli in una sorta di partita a scacchi dove però i giocatori presto si moltiplicano e quelli dietro le quinte assumono presto il ruolo di protagonisti occulti del gioco. In questo film la riflessione sulla verità e sulla finzione, sull’ambiguità delle superfici, delle maschere e sulla misteriosa insondabilità delle passioni umane assume i toni del thriller psicologico con colpo di scena finale che ribalta completamente le convinzioni dello spettatore perchè, come recita la scritta che compare su una delle pareti spoglie in cui avviene l’interrogatorio, nonostante tutti i tentativi di occultamento della verità, “la mente non mente”. Citazione dell’omonimo titolo di un libro della psicologa Antonella Canonico in cui è possibile leggere una affermazione in qualche modo illuminante riguardo al significato profondo di questo film: “Ci sono storie che non vogliono essere raccontate. In parte perchè non voglio essere raccontate. In parte perchè sembrano così assurde che nessuno potrebbe crederci. In parte perchè il loro protagonista soffrirebbe a raccontarle. Eppure un giorno, qualcun altro le racconterà per lui. Spesso una patologia lo costringerà a farlo”.
Filmografia minima di Mauro John Capece:
2021 » Reverse: regia, fotografia
2020 » La danza nera: regia, soggetto, sceneggiatura, montaggio, fotografia, produzione
2016 » Sfashion: regia, soggetto, sceneggiatura
2014 » La Scultura: regia, soggetto, sceneggiatura
2012 » In the Fabulous Underground: regia, sceneggiatura
L’IMPORTANZA DEL SOTTOTESTO E DELL’AMBIGUITÀ –
INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPECE
a cura di Marcello Cella
Prima di tutto volevo sapere qualcosa della tua biografia, perchè ho letto che hai iniziato come scrittore.
Ho iniziato come scrittore però in realtà ho iniziato a fare foto fin da bambino. Però non era la mia strada, come non lo era quella della scrittura. Quando ho iniziato a prendere la telecamera in mano e sono andato a studiare e fare cinema in America ho capito qual era la mia strada. Sono tornato ed ho iniziato a fare film. Considera che i primi tempi della mia formazione a New York c’era Darren Aronofsky, c’era tutto un nuovo cinema d’autore molto complesso e quindi diciamo che quella matrice un po’ indie mi è rimasta un po’ dentro.
E infatti ho notato che nel tuo documentario “In the Faboulous Underground” tu racconti un po’ questa esperienza newyorkese attraverso la figura di Anton Perich, la Pop Art di Andy Warhol…
…Si, questo film è una co-regia. Ho fatto questo film perchè prima di tutto amo tantissimo New York e in quel periodo avevo fondato una specie di factory che si chiamava Minimal Cinema che poi col tempo si è sciolta e mi avevano proposto, Marco Fioramanti e Betty L’Innocente, che sono due accademici esperti della Factory di Warhol, di fare questo documentario. Quindi, con un altro regista, Claudio Romano, siamo andati a Mikulići in Croazia, città natale di Anton, e a New York e lo abbiamo girato. Ovviamente la conoscenza della città di New York e dei suoi meccanismi sono stati molto utili anche per le immagini perchè sapevo dove andare a pescare. Quindi pur essendo una produzione di tre mesi sono riuscito comunque a fare qualcosa di bello sul piano visivo. E’ stata un’esperienza estremamente formativa. Poi Anton è un maestro, crede molto nell’indipendenza di un cinema diverso ed è stato anche questo che mi ha legato molto a lui.
Ho visto che questa riflessione sulla creatività e sul rapporto con la realtà esterna ricorre molto nel tuo cinema…
…Questo è un po’ nel dna di un cinema intellettuale che non esiste quasi più e quindi ho vissuto sulla mia pelle le difficoltà degli artisti. Io sono nato senza televisione in Italia. Io negli anni ’80 -’90 non avevo la tv, amavo il cinema degli anni ’70. Quindi ero una specie di errore perchè i registi della mia generazione volevano fare la fiction, volevano girare le cose in tv, ora vogliono fare le serie. Quindi io che ero legato al cinema, al film, ero un errore palese della mia generazione. Infatti non è un caso che nel 2005 a Rotterdam eravamo io, Garrone, Sorrentino, Gaglianone, Winspeare, e io sono l’unico che non ha fatto carriera, anche se erano tutti registi diversi rispetto a quello che c’è normalmente sugli schermi cinematografici. Quindi da lì parte tutto, dal fatto che volevo fare un cinema impegnato che però, per sua stessa natura, viene sempre finanziato con i soldi pubblici. E quindi c’è stata una questua per diversi anni, finché non mi sono deciso a fare due attività,
cioè dividere la mia carriera commerciale da quella di autore, per sopravvivenza. Per questo mi sono legato agli artisti. Oggi vedo molti artisti in giro, nelle università, che vorrebbero fare qualcosa di impegnato, ma è complesso fare quel tipo di carriera. Ci vogliono più soldi per fare quel tipo di percorso che non una carriera semplice. Quindi ho creato empatia con l’arte, per esempio con la scultura…La difficoltà di uno scultore…Mi sono reso conto che la scultura è una dipendenza al pari dell’eroina perchè devi comprare i materiali, hai bisogno di spazi, di trasporti, di altre persone e non vendi nulla…
…A suo modo è una metafora del cinema…Una cosa che mi ha incuriosito è il tuo modello di ispirazione perchè tu fai meditazione trascendentale e mi chiedevo come entri questa pratica nel tuo processo creativo…
Diciamo che con le mia pratiche notturne e diurne riesco ad avere una chiarezza mentale e ricevo delle immagini. Sembra ridicolo dirlo, ma una mente sana e spirituale ha grandissima facilità di accesso al mondo delle emozioni, del perturbante, del conturbante, cioè riesce a creare con più facilità. E’ una cosa che mi viene naturale. Per esempio, ora sto girando un film su uno script che non è nemmeno mio però ho delle idee che mi derivano dalle location, dai luoghi dove sto e grazie a questa pratica riesco ad interiorizzarle. Inoltre mi dà la possibilità di essere molto calmo. Sono una persona molto calma e non perdo mai la calma neanche rispetto agli eventi atmosferici avversi, alle piogge…L’altro giorno c’è stata un’alluvione sul set e io ho cercato di risolvere il problema senza strapparmi i capelli.
Guardando i tuoi film mi viene in mente la definizione di cinema enigmatico. Ho sempre l’impressione di qualcosa che sfugge nella tua visione della realtà…
… In effetti mi piace molto il sottotesto. Non mi piace una narrazione troppo lineare anche perché questo tipo di narrazione viene richiesta nel documentario o nel cinema semplice, il simple film. A me invece piace sottrarre, mi piace giocare con lo spettatore, creare sottotesti, non essere splatter nell’esporre le cose. Per esempio, ne “La danza nera” nell’intermezzo c’è una foto che è una rielaborazione di quella di Mafia Capitale. Ma come questo ce ne sono molti altri nei miei film. Non mi piace il realismo nel cinema. Per esempio, in “Reverse” a volte mi dicono: “ma una mamma non farebbe mai così male alla sua bambina”, ma invece questa mamma si. La realtà non è poi così interessante da mitizzare. Se facciamo film non dobbiamo sempre giustificare le cose. Quindi col tempo mi sono detto: “nascondiamo alcune cose, creiamo il sottotesto, il non detto”. Le cose della sceneggiatura le incasiniamo ulteriormente e sembrano quasi sbagliate…
…Sicuramente c’è sempre questa sensazione nei tuoi film di qualcosa che sfugge, ma che in realtà ha un significato…
… Io dico sempre una cosa. Il film funziona se tu il giorno dopo ti svegli e ci ripensi. Anche se sul momento non ti piace, se poi ti rimane qualcosa in mente…Ecco, io cerco di fare questo, di fare dei film non concilianti, ma che ti lasciano un qualcosa dentro, che ti apre…Poi il primo passo verso la spiritualità è la perturbazione, la non accettazione di una realtà sensoriale banale.
Tu hai definito i tuoi film “La scultura”, “SFashion” e “La danza nera” la trilogia della riflessione. Come mai?
Perchè questi sono stati film che ho potuto girare con una tranquillità economica, relativa perchè non avevo i budget di Sorrentino o di Garrone, però avevo una tranquillità emotiva, il team giusto, ho scoperto degli attori a cui tengo tantissimo che chiamo sempre nei miei film. Sto anche cercando di creare un piccolo mondo dietro al mio cinema, chiamando sempre le stesse persone per dare continuità ad un’opera…Però io ero partito con l’idea di fare dei film di riflessione e me lo potevo permettere grazie o ad un finanziamento pubblico, o ad un finanziamento privato, o ad un aiuto come progetti culturali. Avevo un budget che potevo utilizzare come mi pareva, non dovevo recuperare. Quindi questa cosa mi ha dato una grande libertà ed ho potuto fare dei film di riflessione. Ora sono nella fase dei film di sensazione perchè chiaramente se devo fare dei film per delle piattaforme che devono recuperare soldi non posso più permettermi di fare “La scultura”. Posso cercare di metterci qualcosa dentro, ma, per esempio, in “Reverse” è veramente complicato trovarci degli elementi fondanti a livello culturale, non c’è quasi niente. Nei due film che sto facendo sto mettendoci dentro una bellissima sceneggiatura di sensazione, ma sono film per una piattaforma. Infatti “Reverse” sta avendo successo, è candidato ai David e credo che abbia recuperato ampiamente però…Ora quindi sono nella fase della trilogia della sensazione, sono in pausa con il mio cervello, sono solo un regista visivo che gira sceneggiature che non scrivo più io fra l’altro, ma sono opera di altre persone.
Comunque anche “Reverse” è pieno di ambiguità con questo ribaltamento dei ruoli fra i due protagonisti, quasi una partita a scacchi, e quella frase scritta sul muro “la mente non mente” che è anche il titolo di un libro della psicologa Antonella Canonico, la cui tesi di fondo riguarda proprio la capacità e nello stesso tempo l’impossibilità di mentire da parte della mente nel rapporto con il corpo che la contiene…
…Si, lì poi ho avuto la fortuna di lavorare con due grandi attori, Corinna Coroneo e Adrien Liss, che riescono sempre ad emozionare me e lo spettatore. Quindi non era nemmeno facile creare un film da due soldi con questa situazione inverosimile di una poliziotta che va dal serial killer per farlo confessare.
Fra l’altro avevamo anche il problema del Covid, quindi non potevamo nemmeno tanto uscire, muoverci, però ho mantenuto alcune suggestioni e ci ho messo il sottotesto dove ho potuto. Nonché un atto d’amore, nel finale, per un certo tipo di cinema degli anni Ottanta, sia nel suono che a livello visivo.
Comunque il tuo è anche un cinema di sensazione. Per esempio, “La scultura” lo trovo un film fortemente sensoriale più che narrativo. Con questi due personaggi, la escort e lo scultore, che più che personaggi di una narrazione, sembrano elementi emozionali…Ho notato poi che nei tuoi film ci sono spesso disseminati degli elementi di denuncia politica e sociale che però non sfociano mai in una denuncia esplicita, ma rimangono sempre all’interno di queste individualità. Ne “La scultura”, per esempio, quando lo scultore dice “l’Italia è un paese senza colore” o ne “La danza nera” nel personaggio di Manola, attrice precaria, impoverita e incattivita…
…Si, la denuncia sociale non mi piace. Spesso in passato ho lavorato come aiuto regista in questo tipo di film e lì le cose venivano dette. A me questo non piace. Preferisco che gli elementi di denuncia sociale vengano dedotti dallo spettatore e soprattutto che rimanga nel punto di vista di un personaggio. Il sindaco de “La danza nera” non è un genio, è un uomo semplice che incarna un po’ la classe politica che abbiamo oggi, ma è lui come personaggio, non rappresenta tutti i sindaci.
Mi piace molto vedere le cose dal punto di vista dei personaggi e non possono essere sempre estremi perchè non sono dei politicanti o dei sindacalisti o degli attivisti politici. Cerco di rimanere sulla storia. Ne “La danza nera” invece mi sono spinto oltre, ho fatto qualcosa nel vecchio stile dal punto di vista della denuncia sociale…
Un altro elemento che trovo nei tuoi film è questa dialettica fra verità e menzogna, spesso attraverso la seduzione, e in questo senso la protagonista dei tuoi film, Corinna Coroneo, mi pare estremamente adatta a dare questo tipo di sensazione di ambiguità…
Si, mi piace molto l’ambiguità. Mi piacciono i colpi di scena. Nel cinema di sensazione i colpi di scena possono essere splatter, mentre nel cinema d’autore può essere qualcosa che riguarda l’animo umano. Fondamentalmente siamo tutti un po’ ambigui, diciamo spesso delle bugie, soprattutto a noi stessi. Quindi mi piace molto…
…Anche questa “lotta di classe”, per semplificare, che potrebbe scatenarsi fra i personaggi dei tuoi film si risolve spesso in uno scontro di linguaggi, di personalità inconciliabili proprio sotto questo aspetto, come accade tra Manola e il sindaco in “La danza nera”….
Si, sicuramente. L’ambiguità nei personaggi del cinema mi piace molto perchè credo che la “santità” nell’umano non esista. C’è bisogno di colpi di scena nell’interiorità dei personaggi. E’ facile far vedere uno con una pistola che spara. E’ più difficile far vedere una persona che fa qualcosa di diverso, che muta durante il film. Pensa a “Taxi driver”, al cambiamento che fa quel personaggio.
Nei tuoi film ho notato che grande importanza hanno i corpi, le superfici, anche la stessa messa in scena con queste inquadrature geometriche che però hanno sempre qualcosa di ambiguo nella loro perfezione…
…Tengo molto alla simmetria e anche all’asimmetria quando serve. In base a come è narrata una scena cerco di essere molto classico da questo punto di vista. Curo molto anche l’illuminazione e spesso faccio io stesso la fotografia perchè cerco di ottenere una luce molto particolare, una resa quasi scultorea delle superfici. Poi curo molto anche le location. Mi piace lavorare in studio ma cerco spesso di trovare delle location adatte alla storia perchè lì si sente la differenza rispetto ad un posto che non è vissuto, che non esiste. La storia di un luogo aiuta molto la scena, quindi di base cerco sempre di trovare delle location interessanti che ispirino prima di tutto me stesso e poi anche lo spettatore.
Trovo abbastanza impressionante la location di “SFashion”, questa azienda enorme e spesso vuota che dà un senso di angoscia. Tra parentesi dove l’avete trovata questa azienda?
Hai notato bene. In questo caso dovevamo trovare un’azienda manifatturiera che avesse determinate caratteristiche, che fosse grande, che avesse un brand perchè era fondamentale. Così cercando abbiamo trovato questo maglificio Gran Sasso che aveva vinto la Triennale di architettura. Poi, certo, a volte bisogna fare i conti anche con il budget. Spesso se vieni finanziato dalle Film Commission, e qui faccio una critica al finanziamento pubblico, ti costringono a girare in quattro regioni diverse, perchè i soldi arrivano da quattro canali diversi, anche se magari non c’entrano niente con il film. E questo è un problema del cinema italiano.
A proposito di “SFashion”, come è nato questo film che forse è uno dei più forti che hai fatto?
Questo film sostanzialmente è nato per parlare della crisi economica dei primi anni Novanta di cui si è parlato molto poco al cinema. Il cinema ha fatto finta di niente
ignorando quegli imprenditori che si ammazzavano in quel periodo o le persone che perdevano il lavoro. I veri problemi della nostra economia sono nati lì, anche nel periodo della conversione lira-euro, quando sono state permesse le delocalizzazioni delle attività economiche strategiche. Era un film politico, chiaramente. Si cerca sempre di fare i film sui drammi che riguardano le forme di disagio più evidenti, che so, sulle persone che fanno l’elemosina alla stazione che costituiscono un dramma incredibile, ma ci hanno fatto sopra almeno quattrocento film. Però anche il dramma di un imprenditore che fallisce è molto interessante perchè dietro c’è un altro tipo di narrazione che in genere nel cinema non si affronta. E non si affronta perchè c’è sempre questo problema italiano della destra e della sinistra. Per esempio, nel mio caso mi hanno accusato di aver fatto un film di destra, ma non è vero perchè poi ho fatto “La danza nera” che racconta una storia opposta. Ma questo riguarda la superficialità di certa critica italiana per cui se fai un film su un imprenditore sei di destra. Questo invece è un film che racconta il fallimento di un imprenditore sommerso dalle cartelle esattoriali…
…di un’imprenditrice che fra l’altro è una figura molto poco raccontata nel cinema italiano…
…che è anche un modo per raccontare l’emancipazione femminile che la puoi fare in due modi o raccontando personaggi femminili o dando lavoro sul set alle donne. Nel cinema italiano invece è una cosa un po’ ipocrita, è una finta emancipazione perchè c’è pieno di truccatrici, costumiste, ecc. e poi non hanno mai i ruoli principali e c’è sempre il maschio alfa dominante come protagonista. Mi piaceva giocare con il ruolo dell’imprenditrice grazie anche alla grandissima interpretazione di Corinna Coroneo. Quando abbiamo presentato il film a Montreal gli spettatori si stupivano e chiedevano: “ma in Italia state messi davvero così male?”. Beh, si, gli dicevo, abbiamo anche queste problematiche. Però era il periodo in cui molti perdevano il lavoro soprattutto nel settore manifatturiero in regioni come Toscana, Marche, Lazio.
Perchè gli hai messo come sottotitolo “La Neoborghese Via Crucis?”
Questo me lo ha voluto suggerire un attore che poi non ha voluto lavorare nel film, Gabriele Lavia. E quella Via Crucis che ho inserito nel film come intermezzo mi è costato come metà film. Ma mi piace inserire degli intermezzi ed è stata una cosa potente da fare.
Anche per quanto riguarda la parte sonora dei tuoi film, ho notato una grandissima cura, come per la musica elettronica di Marco Del Bene in “Reverse” o l’inserimento delle canzoni come “Lilì Marlene” o “La vie en rose” che ascolta la protagonista di “SFashion”. Che ruolo ha la musica nei tuoi film?
La musica narra molto. Diciamo che essendo io una persona che coltiva molto anche la sua anima di artista mi piace molto ascoltare la musica. Non ho dei generi precisi, ascolto tanto anche cose classiche. Poi il mio primo cortometraggio, “Il sopranista”, era un musical. Un musical triste però perchè parlava di un sopranista che veniva schifato da tutti. Quindi la musica è sempre stato un elemento fondamentale nei miei film. La prima cosa che faccio sempre è cercare un compositore con cui dialogare. Voglio conoscerlo quando c’è solo la sceneggiatura, voglio conoscere le cose che fa prima, non dopo la realizzazione del film. Il leit motiv del film lo voglio prima e poi eventualmente inserisco dei prezzi ‘storici’ come per esempio “Lilì Marlene” in “SFashion” con quei rimandi alla Seconda Guerra Mondiale, ai tedeschi, alla Merkel, con quei sottotesti per cui ci stava benissimo.
Un’altra cosa che mi ha impressionato molto dei tuoi film è come racconti la solitudine dei personaggi. E in questo senso le interpretazioni di Corinna Coroneo sono sempre molto intense…
I personaggi che hanno un contrasto con la realtà li vedo un po’ simili a me e agli artisti che conosco. Un personaggio completamente banale, troppo semplice non mi appassiona. Non riuscirei mai a fare un film dove non ci sia questo contrasto forte. Con Corinna mi sono trovato molto bene anche a livello di scrittura. Abbiamo questa cosa in comune. Lei è un’attrice drammatica pura, non la vedrei a fare commedie o a fare film più semplici di quelli che fa. Comunque per me la solitudine è importante. Poi da amante della meditazione una vita senza solitudine mi sembrerebbe anche noiosa per certi versi, anche se non è facile stare soli. Anche i miei personaggi quando sono soli, si sentono soli, soffrono. Per esempio, in “SFashion” quando la protagonista perde il suo confidente crolla tutto…
…però questi personaggi hanno una profondità che li riscatta dalla solitudine in cui vivono. Mentre invece un personaggio come il sindaco di “La danza nera”, che non riesce a stare solo, diventa una macchietta…
…quando i personaggi non hanno profondità diventano delle macchiette. E questo è anche un modo un po’ snob di vedere la questione. Ma oggi il problema principale che abbiamo in Europa è l’educazione. C’è stato un decadimento drammatico dell’educazione dovuto ad anni di tv spazzatura, di vecchi inutili, per cui i giovani fondamentalmente non hanno più la voglia di ricercare qualcosa. I personaggi che incarnano questo decadimento sono macchiette e mi piace farli vedere ancora più piatti di quello che sono, li carico molto. Mentre i personaggi più colti sono più affascinanti, più sexy, più belli, li fotografo meglio. C’è una cura diversa.
In questo libro “La mente non mente” che ho avuto sotto mano in questi giorni c’è una cosa che in qualche modo ricollego ai tuoi personaggi perchè l’autrice sottolinea il ruolo fondamentale della sofferenza per lo sviluppo mentale. Anche i tuoi personaggi sono profondi perchè soffrono…
…la sofferenza è purificazione, è una parte della nostra vita che va accettata, va vissuta. E anche il Covid ce l’ha fatto capire. La sofferenza nobilita sia l’uomo che i personaggi…
…Io invece da educatore sono sempre molto colpito dal fatto che i giovani rifiutano totalmente questa dimensione della sofferenza…
…non hanno il piacere della malinconia, non riescono a vivere pienamente sentimenti come la nostalgia…
…forse perchè non riescono mai ad essere veramente soli con questa connessione direi quasi patologica con i mezzi elettronici…
…però stanno portando lo spettatore dove volevano loro. Pensa che anche il nuovo 007 è diventato una specie di ‘mammo’. Anche il cinema commerciale sta diventando sempre più semplice…Lo vedo anche parlando con certi produttori perchè oggi il cinema con il multiculturalismo deve essere targhetizzato anche sul livello di paesi che sono usciti dal feudalesimo solo cento anni fa. Quindi devi per forza cambiare codici. Dovevano creare una livella culturale e l’Europa con il suo livello culturale era un problema.
SAGGI
IL COLLEZIONISTA DI CARTE: LA MORTE DELLA LUCE (E IL SUO RISORGERE)
di Francesco Saverio Marzaduri
“Per alcuni giocatori anche la fortuna è un’arte.”
Da Il colore dei soldi
Durante la serata conclusiva di un festival, un critico di cui chi scrive non svelerà il nome raccontò che, nel tentativo di avvicinare “l’uomo misterioso” Paul Schrader – per riutilizzare la sua definizione – e proporgli una serie di enigmatiche domande, il cineasta rispose “I’m totally confused”, forse pensando all’omonimo brano musicale del cantautore Beck. Diciamolo una volta per tutte: qualsiasi critico e/o appassionato “cinephile”, imbattendosi nell’universo schraderiano, desidererebbe individuarne da vicino i più reconditi segreti, perlopiù legati al nitore dell’immagine nella propria concezione all’origine, estetica e filmografica. Basterebbe la celebre riflessione dell’autore, che accosta gli stilemi dei tre diversi e da lui maggiormente amati e imitati maestri, a dire come il “transcendental style” sia ormai un imprescindibile assioma per chi tenti di restituire l’universalità, entro molteplici possibilità di espressione che prendono corpo nella forma dello schermo. Se il “trascendente” può essere isolato, estrapolato dalle proprie manifestazioni, disaminato e definito ad opera del critico, lo svolgimento della sua rappresentazione si svolge entro prestabilite dinamiche temporali. Un concetto sacro del fotogramma, attiguo al senso mistico dell’esistenza, così come la dannazione e la conseguente catarsi si riconfermano le due imprescindibili modalità per il conseguimento dell’estasi, nella misura in cui tangibili nella loro astrazione si fanno l’ineffabile e l’invisibile. Sicché, mirare troppo oltre l’intangibile equivarrebbe a indebolire l’arcano: dunque, spetta all’esegeta e alla sua sensibilità leggere tra le maglie della visione, come i profeti dei testi religiosi. E comprendere perché l’ultima creatura dell’universo in oggetto, un ex galeotto che ha trascorso un decennio dietro le sbarre, scelga di leggere a fondo le meditazioni di Marco Aurelio e, “ipse dixit”, impari a giocare, o meglio a contare le carte – secondo l’originale titolo, di cui la traduzione è un convenzionale svilimento – tenendo traccia d’ogni carta giocata durante una partita.
La qual cosa serba uno strano sapore “rétro”, il cui gusto – proprio perché da tempo non più attinente all’odierno mercato cinematografico – apparenta il film a una confezione “vintage” anni Ottanta, fuori tempo e anacronisticamente senza tempo, talvolta comprovato da una combinazione “démodé” di dissolvenze su nero, benché non desista a qualche tocco “new age” riconducibile alla fattura postmoderna (le cifre in sovrimpressione sopra il mazzo, con la voce fuoricampo a commentare). Inevitabile, dunque, che l’indifferente pubblico ignori una simile operazione, ed è altrettanto inevitabile che il “counter” William Tell, denominandosi come il leggendario eroe svizzero, sia l’ennesimo “alter ego” del regista-sceneggiatore: creatura icastica, solitaria e taciturna, la cui abilità nei tornei di poker dei vari casinò statunitensi non ne scalfisce l’ascetico stile di vita, in linea con la propria schiva personalità, la propria repulsa verso il mondo e le imperfezioni morali di esso: rifiuta il caffè appena preparato, e puntualmente avvolge in panni bianchi i mobili delle squallide stanze nei motel ove alloggia, in modo da filtrare e depurare il contatto con gli oggetti. Il che, al di sopra d’ogni sospetto, gli consente di stare sopra quella retta dell’onestà che ogni volta spezza l’uniforme cerchio del gioco (e prima ancora della sevizia): non si fa cacciare dai gestori perché sa mantenere obiettivi modesti, punta poco e vince – o perde – poco, e quando il gioco si fa duro preferisce allontanarsi. Del resto “Il giocatore” – tra i più autobiografici scritti di Dostoevskij, la cui ultima trasposizione sullo schermo, firmata John Dahl, slitta al ’98 – ha per protagonista un demonizzato dal vizio che, impassibile, subisce vincite e perdite accettando la sorte benevola o avversa, con identica imperturbabile indifferenza. Anche il carcere, quanto la morte, assurge ad etico sollievo perché la vita è un rischio in prima istanza: quale che sia la scelta, ecco giungere il Fato a reclamare il dovuto.
Materia, questa, che il recente cinema statunitense – da Eastwood a Zemeckis – sembra tenere in ragionevole considerazione, pensando a eventi storici ancora tiepidi, dove un “pamphlet” su valori collettivi in crisi restringe il campo a psicologie individuali. Di conseguenza le colpe da scontare, fardelli di responsabilità troppo gravosi, implicano ineluttabilmente una redenzione singola a raggio più ampio. Lo riporta anche l’ottimo Stefano Santoli nel fresco volume “Fabbrica di sogni, deposito di incubi”: la dissertazione su un’America opulenta e indifferente, indotta a far i conti con (anti)eroi o ciò che ne resta, restituisce un calcolo aritmetico sin troppo nitido. Stando a ciò, lo spettatore non trasecola di fronte a tropi e ossessioni inerenti il peccato e la redenzione, cui il settantacinquenne Schrader abitua la propria filmografia aggiornandola in era postmoderna: tutto, in questo suo ventunesimo lungometraggio, conserva una fantasmatica parvenza ch’è nemico invisibile, al contempo rovescio e prosieguo della geniale riflessione sulla trascendenza (e non a caso il prodotto è un “noir”, fulcro d’una famosa disamina datata ’71 e da sempre genere prediletto), acquisendo un fondamento anche maggiore. Spiace che la disquisizione del Nostro sui “social network” verso colleghi quali Fincher o Malick, sovente, rischi di fare il passo più lungo della gamba, anche se il parere s’arena alla semplice polemica o alla canzonatura, talora ridondante in ambedue i casi. Le sale cinematografiche in disuso di “The Canyons” si fanno annullamento umano in figure chiuse in sé stesse, da Evan Lake al reverendo Ernst Toller, che coronano l’opera dell’autore in modo testamentario; e, per quanto indispensabili, feticci quali la narrazione “off” in chiave di diario su cui far confluire le impressioni, la scritta tatuata sulla schiena di Tell (“Affido la mia anima alla Provvidenza, affido la mia anima alla Grazia”) o l’inclusione di fisionomie familiari (Willem Dafoe) contano meno della loro applicazione in senso spettrale. Così pure le strade buie che il “counter” – se si vuole, un potenziale Travis Bickle in chiave attualizzata – attraversa esorcizzando l’insonnia: lo sguardo di Schrader nei confronti del vessillo a stelle e strisce, tanto più indagatore quanto più dubbioso e lucido nel proprio reazionarismo, non cessa d’esser coerente.
Il cineasta sa perfettamente come gli errori (e orrori) dei personaggi derivino da una scelta all’origine: sicché il gioco contempla codici e canoni elevati a filosofia esistenziale, ove l’annullamento di creature ridotte a salme ambulanti impone rilanci minimi (e minime perdite), contentandosi di poco, lontani da luci appariscenti o caotiche “bagarre”. “Non mi piace giocare sotto i riflettori, il gioco d’azzardo mi piace anonimo”, dichiara Tell a Cirk, figlio d’un torturatore suo ex commilitone nell’esercito. Paradossalmente è il deleterio paradigma dell’azzardo a consentire alle pedine di restare in ballo: se la sete di rivalsa che accomuna i due protagonisti, in una sorta di rapporto paterno-filiale, richiama quelli de “Il colore dei soldi”, non c’è da meravigliarsi non tanto e non solo perché Scorsese – qui tra i produttori esecutivi – è storico collaboratore per Schrader, ma anche perché i movimenti fluidi e sinuosi della m.d.p. lungo le lisergiche sale o sul tavolo verde fanno de “Il collezionista di carte” un “Casinò” più teorico, sottile e introspettivo: e anche qui fa capolino una prorompente finanziatrice che, in cerca di un mago delle carte, propone a Tell di entrare a far parte della squadra e lo convince ad alzare la posta. Si accennava a Dostoevskij nella psicologia caratteriale e nella rispettiva differenza di veduta: “Tu vivi così?”, la medesima battuta declamata dal mentore William e dal discepolo Cirk, indica una specularità esistenziale (e due verità) che impongono un’univoca via di fuga: il rigore, ovvero l’ordine. Ma l’allegorico delitto commesso dal primo – il coinvolgimento nelle torture dei prigionieri ad Abu Ghraib, per i quali sconta tre anni di carcere, e la consapevolezza dell’impunità di chi tali torture ha ordinato e permesso – si fa incubo trasposto in forma di caleidoscopico girone infernale, attanaglia l’anima e obbliga a un castigo ch’è definitivo regolamento di conti: dietro la maschera del maggiore John Gordo, l’assassinio del comune padre putativo da parte di quello spirituale, entrambe facce d’una medaglia, è una violenza spogliata d’ogni cruento “quid”, che Schrader sceglie di non mostrare, lasciato trapelare da ellittici strilli e gemiti fuoricampo. E il torturato, in finale di partita, è colui che per primo insegnò come torturare.
Se un gatto nero di passaggio è sintomatico fattore sin troppo palese, il costo rimane quello della solitudine, negli interni e negli esterni, che l’iperrealismo hopperiano sublima nella fotografia di Alexander Dynan, le sinistre melodie (di Robert Levon Been e Giancarlo Vulcano) contrappuntano e il monito moralista richiama quale ineludibile presenza: ecco il ritorno alla purezza, restituito in un bicchiere d’acqua, nell’istante in cui Tell sollecita Cirk a riallacciare con la madre e gli consegna il denaro necessario a riprendere gli studi. In analoga maniera, il proposito di formare squadra fissa fa del rapporto simil-affettivo tra il Nostro e i compagni d’avventura una specie d’insolito nucleo familiare, tanto da insegnare a Cirk come vivere nello strenuo tentativo di distoglierlo da distruttivi progetti di vendetta. Pure, affinché il gioco non sia più univoco interesse, la finanziatrice di colore cerca di aggiungere nuove prospettive alla vita di Tell, prima che la loro relazione si trasli in un vero e proprio legame; l’usuale contatto tra dita diviso dal vetro d’un parlatorio, che aggiorna “American Gigolo” e “Lo spacciatore”, s’allunga all’infinito, sulle note di “Mercy of Man”, prima e dopo i titoli di coda, sino all’eternità. Allo spirare della luce sopperisce il risorgere di questa: l’esistenza e l’amore per essa ricominciano. Una volta tanto l’autoreferenzialità non è fuori luogo, nella continuazione di un tragitto onanistico in superficie: l’amore ne esce vincitore, quello del cinema nella propria trascendenza – esito catartico in un’immanenza che sostituisce la realtà – trionfa sulla vita. Potenza dell’estetica, nella sua estasi e nel suo tormento. E nella sua afflizione.
ALDO BUZZI, L’IRONIA DELL’AIUTO REGISTA
di Roberto Baldassarre
“A Fellini ho insegnato a mettersi calze nere invece dei corti calzini fantasia. Da allora non ha più avuto problemi (in questo campo)“.
La dichiarazione di Aldo Buzzi posta in esergo è stata estrapolata dall’intervista rilasciata a Paolo Mauri “Ho un debole per quasi tutto” (La Repubblica, 17 marzo 2000, p. 44), realizzata per l’imminente pubblicazione del libro “La lattuga di Boston” (2000, edito da Ponte delle Grazie). Cominciare da questa dichiarazione è utile perché in due righe è concentrato tanto il tagliente spirito ironico dello scrittore comasco (e in questo caso è Fellini a farne le spese), quanto il suo flirt con il cinema, o per meglio dire con alcune personalità del cinema. Di scrittori di narrativa il cinematografo ne ha assorbiti tanti: a volte erano narratori solo di passaggio, giusto qualche sceneggiatura per incassare sonanti assegni in momenti di magra letteraria; sovente, invece, accettavano coscientemente di restare nell’industria dello spettacolo, lasciando completamente la letteratura oppure pubblicando sporadicamente qualcosa di personale, quasi un atto purifico rispetto al degradante mestiere di sceneggiatore. Ma ci sono stati anche scrittori che sono passati dietro la macchina da presa, come ad esempio attesta la corposa carriera registica Pier Paolo Pasolini, che ha quasi poi prediletto il cinema (medium di massa) rispetto alla letteratura (medium elitario). Anche Aldo Buzzi si cimentò alla regia, incoraggiato da Federico Fellini, con il cortometraggio “America Pagana”, co-diretto con Federico Patellani. Un tentativo non completamente bizzarro, perché Buzzi, nel suo periodo cinematografico, ha prevalentemente ricoperto ruoli di assistente o di aiuto regista, per tanto un passaggio normale.
ALDO BUZZI (1920-2009)
Aldo Buzzi nacque a Como il 10 agosto 1910, da una famiglia economicamente benestante e di profilo intellettuale: il padre era un chimico mentre la madre, tedesca, era una pittrice. A causa del lavoro itinerante del padre, la famiglia cambiò domicilio frequentemente, e Buzzi, dopo i normali corsi di studi, fatti in differenti città, si iscrisse alla facoltà di Architettura, al Politecnico di Milano, conseguendo la laurea nel 1938. Già durante il periodo universitario ebbe modo di poter frequentare spiccate personalità della cultura di quel tempo, in particolare del design (Bruno Munari), ma anche della letteratura (Leonardo Sinisgalli) e del cinema (Alberto Lattuada). In questo periodo ci fu anche il primo incontro, che poi si trasformò in feconda amicizia, con l’illustratore romeno Saul Steinberg (1914-1994), trasferitosi negli anni ’30 a Milano per continuare gli studi universitari. Steinberg sarà sponsor/garante di Buzzi per la pubblicazione di svariati pezzi sul periodico New Yorker (nel 1943 Steinberg ottenne la cittadinanza americana).
Buzzi abbandonò rapidamente la carriera di architetto, perché la considerava una professione castrante, dovendo stare alla mercé delle fisime dei committenti, e per tanto decise di dedicarsi al cinema, collaborando, principalmente, con Alberto Lattuada. A partire degli anni Sessanta Buzzi diede un taglio netto con il cinema, dedicandosi completamente alla scrittura. Pubblicò molti romanzi e collaborò alacremente con quotidiani e riviste, come ad esempio dimostra la proficua collaborazione con la rivista di attualità e cultura “Il caffè”. Tra il 1966 e il 1976, per avere uno stipendio fisso e sicuro, lavorò come editor per la casa editrice Rizzoli. Nel 2000 l’Associazione Culturale Premio Elsa Morante lo incensò con un premio speciale alla carriera. Buzzi morì a Milano il 9 ottobre 1999, per un’emorragia cerebrale.
Tra le sue molte pubblicazioni, degne di nota sono: “Quando la pantera rugge. Memorie interrotte dall’indignazione” (1972) e “Piccolo diario americano” (1974), ambedue impreziositi dalle illustrazioni di Steinberg; “L’uovo alla kok” (1977), suo maggior successo di vendite; “Cechov a Sondrio – Appunti sulla Russia” (1991), testo apprezzato anche all’estero; “Riflessi e ombre” (2001) libro di memorie del suo amico Steinberg.
BUZZI E IL CINEMA
Nella già citata dichiarazione posta in esergo, Buzzi nomina Fellini, ma la sua collaborazione con il regista riminese non è stata di strettissima relazione lavorativa, benché con qualche fondamentale collaborazione e di ricca aneddotica. L’incontro tra i due avvenne attraverso Alberto Lattuada, sul set di “Luci del varietà” (1950), in cui Buzzi svolgeva il ruolo di scenografo e costumista. Ne “Il bidone” (1955), Buzzi fu aiuto montatore, ma non accreditato. Lo scrittore comasco avrebbe dovuto anche partecipare a “La dolce vita” (1960), nelle vesti di aiuto regista, ma la produzione lo rifiutò. Altre collaborazioni con Fellini, risoltesi lontane dai set, erano semplicemente di carattere critico oppure di pareri, come ad esempio durante la complicata gestazione della produzione de “Il Casanova di Federico Fellini” (1976).
Molto più proficua, invece, è stata la collaborazione con Alberto Lattuada, che iniziò con “Giacomo l’idealista” (1942) e terminò con “La steppa” (1961): in totale 13 pellicole assieme. Se nel primo film Buzzi figurava come sceneggiatore (nello specifico fu uno degli adattatori, essendo la pellicola una trasposizione dell’omonimo romanzo di Emilio De Marchi), nelle successive pellicole ricoprì primariamente il ruolo di aiuto regista o collaboratore artistico. Le opere di Lattuada a cui collaborò, tralasciando le tre già citate, sono: “Il bandito” (1946); “Il mulino del Po” (1949); “Il cappotto” (1952); “La lupa” (1953); “La spiaggia” (1954); “Scuola elementare” (1954); “La tempesta” (1958); “L’imprevisto” (1960); “Lettere di una novizia” (1960); “I dolci inganni” (1960).
Le altre collaborazioni cinematografiche sono avvenute con “Proibito rubare” (1948) di Luigi Comencini, che conobbe sempre attraverso Lattuada (i due furono i co-fondatori della cineteca di Milano); “Cuori senza frontiere” (1950) di Luigi Zampa; “Febbre di vivere” (1950) di Claudio Gora; “L’amore in città” (1952), film collettivo in cui Buzzi collaborò all’episodio di Carlo Lizzani, “L’amore che si paga”.
Ma l’aspetto più importante di questo flirt tra Buzzi e il cinema è sintetizzabile con il libro “Taccuino dell’aiuto regista” (1944, poi ristampato nel 2007), in cui l’architetto comasco, alle prese con la sua prima pubblicazione scritta e impreziosito dalla grafica di Bruno Munari, appuntava le sue prime impressioni, con slanci ironici, sul dietro le quinte del cinema italiano. A tutt’oggi il libro è un fondamentale reportage per immergersi nel cinema di quel tempo, ancora pregno di Telefoni bianchi e divismo hollywoodiano.
DA “SCANNERS” A “LA MOSCA”.
MUTAZIONI E MATURAZIONE STILISTICA IN DAVID CRONENBERG
di Roberto Lasagna
Se nei primi titoli di Cronenberg, quali “Il demone sotto la pelle” (1975) o “Brood – La covata malefica” (1979), la dimensione del pericolo si rivelava con premesse che portavano al graduale crescendo di angoscia, in “Scanners” (1981) ci troviamo sin da subito calati in una dimensione allarmante, con gli individui telepatici che permettono al regista di proporre le sue visioni inquietanti e di farci comprendere come il super-potere nella mente del cittadino Cameron si esprima come una dimensione non ancora controllata. Infatti, nella sequenza iniziale, il personaggio provoca una crisi convulsiva ad una donna intenta a parlare con un’amica mostrando toni di disprezzo nei riguardi dell’uomo, che definisce come un “parassita”.
Il potere di Cameron è qualcosa di cui egli non ha dunque piena consapevolezza, e la sua vita sembra costretta alla fuga dalle conseguenze dei suoi stessi pensieri, insieme potenti e persecutori. L’incontro con il dottor Ruth metterà in chiaro come i poteri possano venire direzionati, e Cronenberg segna nei corpi e nelle forme della sua estetica visionaria il terreno di un discrimine tra le forze in campo.
In uno scenario sobillato da presenze ambigue, l’oscurità regna sovrana e la possibile lotta tra il presunto bene (Cameron) e il dichiarato Male (Revok) restituisce alla visione i caratteri allarmanti di un cinema della ribellione, dove il cineasta condensa pagine di un racconto narrativamente essenziale la cui asciuttezza ci porta dentro le maglie di un potere smisurato, al contempo egocentrico e annichilente.
Lo stupore che un film secco e claustrofobico come “Scanners” provoca, arriva grazie alla capacità di farci vivere l’impensabile, come, innanzitutto, l’esplosione di una testa umana sottoposta alla tortura della possessione telepatica da parte del terribile Revok.
“Scanners” sembra non possedere granché dei connotati dell’horror classico, pur attingendo, come sovente in Cronenberg, dalla fantascienza letteraria venerata dall’autore. Eppure, in un cinema che sperimenta le visioni di una realtà governata da forze oscure, il cineasta ci porta dinanzi a quel clima, a lui cinematograficamente congeniale, della sperimentazione scientifica, in atto in varie forme nella società del tempo. In questo caso, i risultati sono andati ben oltre le intenzioni e le aspettative del demiurgo, il dottor Ruth il quale, non appena si è accorto di come gli “Scanners” possano rivelarsi pericolosi per il mondo, ha deciso di occupare il tempo che gli resta per debellare gli effetti nefasti degli uomini dai poteri incontrollati.
Nel personaggio del professor Ruth, portato in scena con impagabile magnetismo dall’attore statunitense di origini irlandesi Patrick McGoohan, si inscrive tutta la doppiezza e l’ambiguità di una condizione, quella dello scienziato da cui discendono sia Cameron che Revok, cioè i due volti opposti di una scienza che sperimenta la lotta senza tregua tra male e bene. E si fa strada in “Scanners” anche una visione più complessa e stratificata rispetto ad altri lungometraggi del cineasta canadese: ai mostri di “Rabid” e “Brood” che portavano al mondo le estreme conseguenze di propositi letali, in “Scanners” prende corpo una visione che, come sarà in ““Videodrome”” (1983) o in “Inseparabili” (1988) prospetta biforcazioni di corpi e menti, tra contorsioni e lotte di potere.
Il potere di questi “Scanners” diviene espressione di un cinema disposto a portare in primo piano il coinvolgimento totale dell’individuo pronto, senza più alcun senso del limite, a penetrare e dominare l’altro, in un possesso che può ribaltarsi contro chi lo direziona.
Il pensiero che incessantemente lavora e produce incubi, s’imbatte, nel film, contro un segnale, la necessità di un’adeguata preparazione affinché la mente possa difendersi da se stessa e dalle invasioni di pensieri del mondo esterno.
Gli scanner come Cameron vengono infatti sovrastati dai pensieri altrui, e i loro tentativi di difendersi dall’invasione annichilente possono risultare devastanti se non controllati.
La riflessione cronenberghiana contempla molto vistosamente anche una polemica contro i pensieri imperanti, specie quelli piccolo borghesi, nei cui confronti una mente come quella del “vagabondo” Cameron rischia di soccombere. La potenza del pensiero, i suoi effetti devastanti, sono ben ravvisabili nelle ritorsioni di Cameron, che naturalmente lo mettono in pericolo.
Cronenberg sembra anche suggerire che ai pensieri comuni è possibile anteporre pensieri più elevati, ma ancora meglio, è la ricerca di una forma-pensiero artistica a offrirsi come una possibilità di armonia e liberazione per l’individuo ossessionato e posto sotto scacco dalla società dei pensieri omologanti.
Significativa, in questo senso, la figura dello scanner scultore, l’artista che Cameron va a trovare e scopre essersi isolato tra le sue sculture. Si tratta chiaramente di una figura d’artista per la quale il gesto creativo si rivela come il tentativo – riuscito – di dar forma ai pensieri e agli incubi, con il deliberato intento di non essere dominato da essi. L’artista-scultore come un alter-ego del regista David Cronenberg, il quale ha deciso di identificare nella messa in forma (che nel film assume una dimensione manuale, volutamente la meno alienata) quella prediletta attraverso cui esprimere la necessità di difendersi dal mondo esterno, dando corpo e volto alle proprie visioni più personali e inquietanti.
Cronenberg dissemina le sue inquietudini portando in scena la trasformazione dei corpi come un artista-modellatore di forme vive, utilizzando gli effetti della prostetica, così disposti, in “Scanners”, a segnare l’estetica del tempo e ad essere un giorno superati dagli effetti speciali digitali. Ma è anche questo un tratto del fascino del film e del cinema del cineasta canadese, che in questo periodo offre testimonianza della centralità di corpi/menti pronti ad essere travolti da una riflessione sul decadimento e la contiguità tra antiquato e avveniristico, sull’attrazione e la repulsione di una condizione dove l’uomo vuole prendere possesso delle forme del reale in un conflitto inesausto.
Il crudo realismo della rappresentazione si coniuga con l’estrema forza cinematografica di alcuni momenti, ad esempio il celebre brano dell’esplosione della testa, quando, ben oltre il suo aspetto splatter, la sequenza vede il possesso di Revok della mente di un individuo disposto a un esperimento dimostrativo, e lo spettatore non si aspetta che possa scatenarsi un tale effetto disturbante. Con un gesto estremo, la vicenda lascia esplodere tutta la minaccia di un personaggio, Revok, che si presenta come un volontario durante una dimostrazione pubblica voluta dalla ConSec, la società che intende sfruttare il potere degli scanner per propri fini. Revok è una vera scheggia impazzita, il quale si presenta al consesso di convenuti pronti ad attendersi una dimostrazione di come le capacità degli scanner possano essere utilizzate nel campo militare e della sicurezza, mentre l’irruzione del potentissimo individuo telepatico lascia intendere la vera gravità della situazione già in atto.
Revok, dopo essersi infiltrato nella ConSec, progetta con il suo gruppo clandestino di uccidere chiunque sia coinvolto nella società, per prendere il potere e frenare la volontà di direzionare gli scanner a fin di bene. Ruvido e disturbante, “Scanners” è un thriller con venature pulp, con cui Cronenberg osa sia tecnicamente (la sequenza della testa tagliata è il risultato di prove sino alla soluzione operata dal responsabile degli effetti speciali: un vero colpo di fucile dietro il manichino che ottiene di far saltare realmente un cranio protesico pieno di frattaglie), sia concettualmente (con gli “Scanners” come Cannon, emarginati sociali in una società piccolo borghese). Il cinema di Cronenberg ha prodotto sino a questo momento opere ferocemente originali, e con “Scanners” si è completato un periodo di pellicole finanziate in buona parte grazie alle leggi fiscali canadesi favorevoli. Il progetto di ““Videodrome”” viene accolto da una grossa casa come la Universal che mette a disposizione un budget molto più sostanzioso, per quello che si propone come un noir disturbante, in grado di portare a una vetta sbalorditiva la capacità di Cronenberg di far confluire generi e stili differenti. Si tratta dell’esito di un’attitudine all’ibridazione che emergeva già vistosamente nei precedenti lungometraggi, dove l’horror e la fantascienza si incontravano offrendo immagini destabilizzanti; pulsioni pronte a scardinare la scena quotidiana dell’uomo videns, che portano adesso il regista a realizzare, con il nuovo film, una rielaborazione originale del noir e della detective story attraverso la vicenda del proprietario di un canale tv che trasmette contenuti violenti e pornografici.
Il principale interesse di Cronenberg, in quello che diventa una sorta di manifesto del suo cinema, è agitare una riflessione allarmante sul rapporto tra l’uomo e i media. La vicenda vede Max Renn (James Woods), proprietario di Civic TV, sempre alla ricerca di nuovi programmi sensazionalistici per la sua emittente, il quale un giorno viene contattato dall’amico e tecnico televisivo Harlan che gli confida di aver captato un canale satellitare dove si trasmette uno show brutale, intitolato ““Videodrome””, video-arena a base di torture e violenze a sfondo sessuale. Max rimane affascinato dagli aspetti estremamente realistici di quelle scene e si mette alla ricerca dei produttori del programma, con l’intento di inserire “Videodrome” nel palinsesto di Civic TV. Durante una diretta televisiva, Max conosce Nicki Brand (Deborah Rarry), una seducente speaker radiofonica, che diviene presto la sua amante e si scopre attratta da pratiche sado-maso. Mentre scorrono i giorni, Max è preda di allucinazioni spaventose, causate dall’esposizione al segnale di “Videodrome”.
Diventa ben presto evidente, per lo spettatore pronto ad attendersi un viaggio destabilizzante nella visione, come il racconto di Cronenberg intenda portare all’eccesso la riflessione sulla natura alienante della televisione, qualcosa di infettivo che il professor O’Blivion, il profeta della televisione, definisce attraverso le sue teorie che parlano di una tv più reale della vita vera, in cui l’immagine dello schermo prende il sopravvento e quello che vediamo prende il posto di quello che siamo. Max si ritrova a sperimentare una completa dispercezione della realtà oggettiva, viene invaso dai contenuti del canale che dà il titolo al film e affonda nell’incapacità di distinguere il reale da quanto è manipolato. Il colpo mortale dato alla percezione porta Max a perdere la sua coscienza, e il personaggio diventa una marionetta di un potere grande a apparentemente inattaccabile.
Offrendosi nelle sue metafore orrorifiche, il successivo “Videodrome”, nonostante l’insuccesso al box office, viene presto riscoperto come il film allarmante di un cineasta che accusa l’influenza devastante della televisione sugli esseri umani, cogliendo nel 1983 il potenziale mefitico di trasmissioni create ad arte per rendere passive e inerti generazioni di spettatori. Il body horror di “Videodrome” non intende tanto stigmatizzare la tecnologia, ma sollecitare una riflessione sul misconoscimento del ruolo dei media sulla nostra esistenza e sulla nostra percezione. Nel proporsi come un film paradigmatico dei primi anni Ottanta, “Videodrome” è di fatto un’opera originale, che sorprende per la forza dell’immaginario, lanciandosi come sguardo sull’epoca delle videocassette, ma anche affondo contro la censura dei film. Il cineasta intende lasciar emergere il lato oscuro e disturbante del desiderio umano che prende corpo attraverso le fasi allucinanti di una detective story oscura e aggiornata ai tempi rampanti degli anni Ottanta, dove Max Renn è un tipo dall’integrità molto discutibile che porta il mondo hard boiled nella dimensione imprenditoriale della nuova epoca. Si tratta di un uomo d’affari vizioso, che sogna di tener alti gli ascolti del suo canale e si trova coinvolto nella losca macchinazione di Barry Convex (Leslie Carlson), sedicente produttore di occhiali della Spectacular Optical: più Max scopre e ci svela gli aspetti inquietanti del programma “Videodrome”, più il suo rapporto con la realtà si frantuma secondo l’indicazione del professor O’Blivion: “Dovrai imparare a vivere in questo mondo così assurdo”. Se la rielaborazione del noir offre in “Videodrome” una Toronto quale ambiente urbano del disorientamento, a tratti evocativa della La Los Angeles de “Il Grande sonno” (di cui Raymond Chandler descriveva anche l’emorragia di moralità), in Cronenberg le influenze plausibili contemplano vari modelli, tra cui probabilmente anche il Philip Dick di “Un oscuro scrutare”, che parte come una detective story e si trasforma in un racconto surreale, e dove la fantascienza crea scenari fortemente disturbanti.
Per “Videodrome” tuttavia, Cronenberg si ispira in definitiva a un’esperienza personale, dei propri ricordi d’infanzia, quando il giovane David cercava con il suo televisore di rintracciare trasmissioni provenienti da emettenti e luoghi lontani. Per dare forma al suo film che riflette sull’ambiguità del vedere, sulle allucinazioni di cui non siamo pienamente coscienti, Cronenberg ci mostra in “Videodrome” come sia pericoloso perdurare in una condizione di passività dello sguardo, perché il rischio è di credere soltanto alle allucinazioni senza cogliere la manipolazione che vi si cela.
Il cineasta conduce la sua riflessione attraverso una trama in cui al protagonista, come allo spettatore, è presto dato di smarrire i contorni, e proprio come in un noir cogliamo aspetti poco plausibili, con una fotografia fortemente contrastata, fughe del personaggio tra i labirinti urbani e un’ambientazione decadente, fino a quel finale che decreta, con enfasi allarmante, il trionfo dell’immagine sulla realtà. Va precisato che il noir di Cronenberg è una personale rivisitazione immaginativa del cinema e della letteratura del passato. Nessuna nostalgia per i bei tempi andati del cinema, ma messa a fuoco disincantata di come, adesso, il campo d’accesso egemone per guardare la realtà è nelle mani di chi programma la televisione, strumento che nel film diviene mezzo per cogliere con tratti inquietanti il confine sottile che separa gli aspetti della realtà.
Di essa, in “Videodrome”, a Cronenberg interessa rivelare gli aspetti che ne marcano una percezione alterata. In questa prospettiva, è particolarmente sinistro e significativo il tumore al cervello di O’Blivion, che sarebbe stato provocato da un’esposizione troppo prolungata su “Videodrome”, ovverosia da uno studio dell’uomo di scienza troppo calato nel programma. Ancora una volta, dopo “Scanners”, troviamo la mente minacciata dall’esposizione a poteri incontrollati, cervelli che si trasformano e rischiano di esplodere, ma questa escrescenza tumorale prodotta dall’esposizione al programma televisivo è annunciata come il momento di un programma-evoluzione dell’uomo. Qualcosa che originando una mutazione-ampliamento del cervello, determinerebbe anche il cambiamento della percezione umana.
Il film di Cronenberg coglie dunque nella televisione quell’emittente in grado di cambiare il modo di essere delle persone, agitando una riflessione che ritroverà tra i suoi elementi anche la scrittura e la stampa ne “Il pasto nudo”, e arriverà alla realtà virtuale in “eXistenZ”. Ma in “Videodrome” la vista ha preso il sopravvento, e la realtà è diventata quello che guardavamo. Se poi guardiamo attraverso la televisione, la nostra percezione è allora inquinata da un potere invisibile, che autorizza un finale nichilista con Max il quale si spara alla testa soltanto dopo aver visto, in televisione, la scena del suo suicidio.
Perché la verità è diventata definitamente la sola immagine e sembra non esserci alcuna via di scampo, nessun ritorno alla realtà una volta entrati in “Videodrome”. L’uomo videns trionfa, e questa autoesaltazione coincide con l’essere divorati in una dimensione che riverbera la fine del contatto fisico, nella deriva di un mondo occidentale in cui ci teniamo occupati in monologhi e prigioni di godimento autoreotico, pronti a lasciar scomparire i rari momenti di relazione sociale ancora possibili.
Schiacciato tra il fondamentale “Videodrome”, che ad inizio anni Ottanta si pone come il film visionario in grado di allarmare circa la società di questi anni e in merito al suo rapporto di simbiosi fagocitante con il mezzo televisivo, e il successivo “La mosca” che pone lo scienziato protagonista al centro di mutazioni irreversibili che lo vedranno ibridizzarsi con un insetto e avviare un dramma senza ritorno verso la perdita di sé e la frammentazione corporea, un titolo enigmatico come “La zona morta” soffre di un’interpretazione che lo vuole un’opera più convenzionale rispetto a quelle già note del cineasta. Un film con attori noti e la fonte letteraria che si pone come il preambolo di un confronto potenzialmente ingombrante.
In realtà si tratta, nel caso del lavoro interpretato da Christopher Walken, di un film ampiamente da riconsiderare, in cui Cronenberg non tradisce se stesso ma anzi accende la sua visione portando la prospettiva kinghiana, di un male annidantesi nel corpo sociale americano, direttamente nelle fattezze di individui singoli e particolari, di cui Johnny intercetta le mosse ergendosi, con le sue scelte, a coraggioso e sacrificale artefice di premonizioni che possono cambiare il futuro per il bene di tutti. Allorquando, nello stesso anno, John Carpenter porta sullo schermo un altro testo di King, “Christine – La macchina infernale” (1983), rimanendo fedele quasi alla lettera all’intreccio dello scrittore del Maine, Cronenberg con “La zona morta”, anche grazie al lavoro dello stesso Jeffrey Boam che riscrive completamente quanto King aveva già adattato personalmente, ci restituisce un film che della fonte letteraria valorizza aspetti in grado di dare espressione alle sue ossessioni di cineasta senza per questo ridimensionare la visione dello scrittore.
L’evento straordinario che muta la vita del professore Johnny Smith finisce per segnare la vita della comunità, lasciando alla coscienza del singolo la scelta di poter decidere da che parte stare. Contro il senso di minaccia imminente che si respira sin dalle prime immagini, e che il volto straordinariamente evocativo di Christopher Walken restituisce durante la sequenza delle montagne russe, prende spazio per improvvisi squarci visionari il disvelarsi di una sensibilità eccezionale, quella del professore pronto a percepire con il suo disagio l’incombere di una mutazione in attesa di manifestarsi. Lasciando kinghianamente spazio anche al fantastico, piuttosto che al sangue della nuova carne di cui il cinema di Cronenberg non ha smesso in questi anni di raccontarci le manifestazioni allarmanti, il regista si concentra sulla sofferenza e il disagio, provato dalle visioni di Johnny, da quelle premonizioni che si traducono in lancinanti convulsioni; qualcosa che ha pur sempre a che fare con il coinvolgimento corporeo e prelude a un decadimento via via più manifesto, tanto a livello cerebrale quanto a livello dei movimenti. L’incidente ha scatenato un nuovo potere della mente, si è incagliato nel corpo di Johnny come un demone sotto la pelle e probabilmente le facoltà eccezionali dell’individuo aspettavano soltanto la possibilità di venire scoperte e scatenate. I cinque anni di coma hanno rappresentato quella permanenza in una “zona morta” che ha generato implacabilmente un mutamento tutto interno, un potere della mente che si attiverà innestando il contatto con altre vite, provocando quella connessione tra sistemi nervosi di cui abbiamo ampie premesse nei precedenti titoli di Cronenberg. Se in King la figura materna, una presenza fanatica, coglieva nella facoltà di Johnny le caratteristiche di un “dono”, il film riassume, in una vigorosa compresenza, ossessioni tanto dello scrittore del Maine quanto del regista canadese, così che la mutazione, questa volta lenta e silenziosa, si offre a scandaglio di una scelta, operata da Johnny Smith il quale, conoscendo la sua condanna, decide di andare fino in fondo seguendo la strada spianata dalle sue facoltà. Quando stringe la mano del politico dal falso sorriso Greg Stilsson, Johnny avverte che la comunità sta per cadere in un grande raggiro, e dopo aver sventato le gesta del serial killer Frank Dodd, è la volta del politico senza scrupoli.
Nonostante la vicenda sia a grandi linee quella del romanzo, mutano molti dettagli e con essa anche la struttura narrativa. Se il libro sviluppa due vicende parallele che convergono nel finale, nel film si sintetizzano molti episodi presenti nel testo restituendo una scansione in tre parti principali; in questo modo si offre più evidente risalto all’evoluzione psicologica del personaggio. King mantiene in una sorta di nebulosità pur colma di dettagli la presentazione della zona morta del titolo, mentre Cronenberg e il suo sceneggiatore danno espressione a visioni che gradualmente assumono chiarezza per lo spettatore pronto ad attendersi il progressivo dipanarsi del mistero. Il cineasta trasforma in materia personale gli spunti kinghiani, e le visioni del personaggio si tramutano in una trance inquietante pronta a sintonizzarsi con il futuro di chi entra in contatto con Johnny, un magnetico Christopher Walken le cui visioni provocano l’inabissamento nella sofferenza fisica ed esistenziale, dovuta tanto al coinvolgimento nella dimensione altra della percezione, quanto all’immersione nella consapevolezza del male sociale.
La scelta di un interprete emblematico di una sensibilità sotto pelle, si rivela talmente indovinata da rendere credibili le mutazioni di un decadimento che vede il personaggio con il corpo ricurvo e il volto traumatizzato. Seguendo le sue vertigini, il racconto mantiene purtuttavia una certa linearità drammatica, ma la mutazione appare ugualmente inesorabile, consuma Johnny seppure in maniera meno spettacolare e animalesca rispetto a quel che sarà dato vivere al protagonista del successivo film del regista. Nonostante ne “La zona morta” la tenuta drammatica sconti una certa episodicità derivante dalla scrittura di Boam, il tono cronenberghiano è avvertibile senza mediazioni anche per via dell’atmosfera invernale inquietante in cui il personaggio sperimenta la sua angoscia esistenziale.
Quel ”La zona morta” del cervello, quel perdurare in un coma per cinque anni, si rivela premessa ed espressione di una mutazione di cui il personaggio sperimenta le trame sconcertanti come possibilità altra di interpretazione del reale una volta tornato in vita. L’estetica obbedisce agli spunti contenuti nel racconto di Edgar Allan Poe che il professor Johnny suggerisce di leggere ai suoi studenti in apertura del film, esortazione che si rivela metafora della sua vita futura, e le vertigini anticipate dalla sequenza sulle montagne russe con la fidanzata sono presagio del suo cammino traumatico. In questo senso, l’insegnante è una figura che si erge a modello di angosce racchiuse nella dimensione corporea, quella zona viva suscettibile di trasformarsi in zona morta o in luogo di confine. Johnny, in quello che appare come uno dei film più accessibili di Cronenberg sino a questo momento, assorbe inoltre angosce e paure contemporanee, fobie e ossessioni che sono manifestazioni della mente umana e non possono evitare di trovare espressione nel corpo, in quella che si declama come la “nuova carne”. E se sino ad oggi demoni e virus hanno intaccato la vicenda esistenziale dei personaggi del cineasta scatenando deliri sessuali e allucinazioni, se menti potentissime hanno causato l’esplosione di cervelli umani, se le mutazioni hanno visto originare video-individui e presto avremo anche uomini-mosche, sempre in Cronenberg la componente visionaria trova uno spazio al confine del delirio, così che lo sguardo sul futuro destabilizzante di Johnny ne “La zona morta” assume la fisionomia di un percorso in cui il corpo si muove via via più faticosamente lungo un’afflizione scatenata anche dalle ipotesi di un futuro non comprensibile. Un’incertezza e un’inquietudine esistenziale che nel futuro cinematografico del cineasta vedrà i corpi umani in balia di ipotesi scientifiche allarmanti, di un costante mutamento nel segno della progressiva invadenza tecnologica. Assieme a Bob Clark e a Williams Fruet, Cronenberg è stato ritenuto il nome di punta del nuovo horror canadese, e Dino De Laurentiis non si lascia sfuggire quello che si propone come l’incontro tra il capofila del cinema del corpo, e il più riconosciuto scrittore del brivido. L’horror diviene estensione visionaria di metafore interne, e le mutazioni dettate dagli scenari futuribili trovano terreno nella nuova corporeità.
Ne “La zona morta” ci lasciavamo con una storia d’amore impossibile, e il sacrificio di uno dei due amanti (Jonny) era qualcosa che potevamo leggere anche nei precedenti titoli dell’autore, da “Rabid” a “Brood”,sino a “Videodrome”.
Con una componente lirica mai così manifesta, il successivo “La mosca” accentua la tensione emotiva a livelli quasi insostenibili, raccontando una storia d’amore con tutto il dramma della mutazione corporea. Assistiamo nel film al programma di Seth alla ricerca di una rivoluzione scientifica senza precedenti: trasferire le cellule da una capsula all’altra, ben oltre il teletrasporto ad uso domestico funzionale. Seth decide di provare molto presto, anzi troppo presto, con la foga e l’ebbrezza di un artista visionario, la sua macchina su di sé. Decide di trasportarsi da una cabina all’altra e sperimentare sulla sua persona il programma di ricombinazione molecolare, dopo che una scimmia, al secondo tentativo (il primo è stato agghiacciante), è tornata sana e salva. Ma con Seth, nella capsula “di partenza”, c’è una mosca di cui lo scienziato non si è accorto. Quello che la macchina teletrasporta è allora alla fine una combinazione dei due corpi, che si ritrovano nella capsula “di arrivo” sotto le sole sembianze di Seth, ignaro che da quel momento ha inizio per lui un processo di metamorfosi; dove in un primo stadio sperimenta un senso di grandiosità e un’ebbrezza che lo fanno sentire in una sorta di estasi ipomaniacale, con comportamenti privi di inibizione, euforia, una forma fisica senza precedenti e grande energia. E se dapprima il suo fisico si dimostra smagliante e le sue prestazioni sessuali non conoscono limite, la sua compagna Ronnie, con cui sino a questo momento Seth ha vissuto una storia d’amore bellissima, si rende conto a un certo punto che qualcosa è andato storto durante l’esperimento: il comportamento delirante dello scienziato è infatti il preludio di un destino crudele per Seth e per il loro amore.
Gran parte del tormento è reso magnificamente dall’intensità dei due interpreti, i quali nella vita diventano marito e moglie e ne “La mosca” restituiscono l’apprensione e il coinvolgimento di due veri amanti. All’euforia succedono lo sgomento e la rabbia, quando il corpo di Seth comincia a mostrare il decadimento, l’irruzione sotto la pelle di un essere che vuole prendere il suo posto, in maniera violenta e sconcertante. E Ronnie, disperata, atterrita, non fugge.
Con il personaggio della giornalista, Cronenberg ci domanda come sia possibile continuare ad amare la stessa persona anche dopo la sua mutazione. Una domanda altissima, matura all’interno di un film “di genere” che è inevitabilmente altro nelle mani di un cineasta filosofo qual è il regista canadese. In questa prospettiva, è inevitabile leggere “La mosca” come un testo-metafora sull’invecchiamento e il decadimento fisico, e sul destino dei nostri sentimenti al cospetto di situazioni inevitabili, congenite alla vicenda umana. Ma calandosi come l’osservatore tra le derive degli incontri che coinvolgono l’uomo e le tecnologie, con “La mosca” David Cronenberg non realizza soltanto un grande horror sul tema della metamorfosi, ma una rappresentazione lancinante e lucidissima sulle gabbie che ci creiamo e ci trasformano in schiavi di trasformazioni nel momento in cui ne diventiamo dipendenti e non possediamo più il controllo della nostra vita.
Nel film le inquietudini passano sotto lo sguardo della scienza, si rapprendono nelle scene inquietanti delle mutazioni e vibrano con il pathos di Ronnie, e con l’empatia che riesce a comunicarci un Seth Brundle trasformato in uomo-mosca e disperato. Pur in una tensione melodrammatica, Cronenberg sa essere coinciso, frenare l’enfasi senza congelare le emozioni, essere secco come nel finale, e lucido, con il pessimismo che riconosciamo all’autore.
Tornano le paure del mondo di Cronenberg, che sono poi quelle dei suoi personaggi capaci di cogliere le inquietudini che originano dal corpo, luogo di metafore organiche pronte a tradursi in figurazioni visive. Come in “Brood”, Ronnie vive l’incubo della larva durante il parto, con l’apparizione dello stesso Cronenberg il quale in sala operatoria aiuta la donna nel suo travaglio; in quanto ginecologo dell’incubo (o della mutazione visiva, come definisce il cineasta Gianni Canova), egli anticipa quella figura che dominerà la scena del successivo film del regista, “Inseparabili”.
Cronenberg presenzia all’incubo che è poi anche quello profondamente diffuso per il difforme, per il non omologato all’estetica del simile. Con “La mosca” e con il successivo “Inseparabili”, il cineasta rivoluziona la prospettiva estetica dominante invitandoci a cogliere il turbamento originante dall’emersione di forme interne, qualcosa che nel film del 1986 prende le sembianze di un’incognita che le parole dello scienziato Seth Brundle accolgono con una sottolineatura politica ironicamente cosciente della mutazione in atto (rivolgendosi a Ronnie, dice “Hai mai sentito parlare di diplomazia degli insetti?”, “Vorrei diventare il primo insetto politico”). Una tensione interna sospinta nella visione di Seth Brundle il quale vede a un certo punto la sua condizione di mosca dalle fattezze giganti come quel fatale lascito, quell’occasione per liberare una forza eccezionale con tutti i potenziali cambiamenti che ne potranno derivare.
Quando David Cronenberg dirige “La mosca”, egli ha quarantatré anni e gli viene proposto di girare, tra gli altri, “Witness”, “Beverly Hills Cop” e “Flashdance”. In quanto remake dell’omonimo film con Vincent Price del 1958 (in italiano, “L’esperimento del dottor K.”), “La mosca” riconcepisce la novella originaria di George Landelann, The Fly, pubblicata sul numero di “Playboy” del giugno 1957, e rielabora il trattamento di Charles Edward Pogue, il quale aveva mantenuto per il film del 1986 una certa atmosfera anni Cinquanta, per rendere più esplicito il carattere di rifacimento di un vecchio film. Cronenberg invece ripensa lo script eliminando i cliché stilistici dell’epoca, come ad esempio il ménage matrimoniale presente nel lungometraggio diretto da Kurt Neumann o alcuni momenti improbabili come la caccia alla “mosca dalla testa bianca” o il gatto che, una volta teletrasportato nel vuoto, lascia ascoltare il suo miagolio. Tutte le sponde sinistre del cinema pauroso più risaputo che vengono lasciate da parte da Cronenberg il quale ricontestualizza la vicenda originaria, aggiungendo dialoghi e momenti della relazione tra Seth e Ronnie necessari per esprimere la tensione per la trasformazione graduale che vediamo nel film.
Con il suo solido impianto drammaturgico, “La mosca” è il film di Cronenberg con il più efficace senso del ritmo, ed è privo di passaggi irrilevanti. Nel racconto si fondono con estrema compattezza narrativa tre dimensioni che sono percorsi in grado di restituire la drammaticità e la tensione: la crescita dell’amore tra Seth e Ronnie, la mutazione progressiva di Seth, la crescente rivalità tra Seth e Stathis. Sono nuclei portatori di tensione psicologica scritti di primo pugno dallo stesso regista. Ma Cronenberg ci restituisce anche sfumature di grande finezza, che impreziosiscono un horror apprezzato altrimenti per gli effetti speciali, per le pose plastiche del fisico scultoreo di Goldblum e per il trucco a cui l’attore si presta senza mai perdere nemmeno un goccio della sua umanità, nemmeno quando le fattezze de ”La mosca” avranno preso il sopravvento. Sopravvive un umorismo del personaggio persino quando è prossimo a disgregarsi, e non è ribadito nel film di Cronenberg il vecchio adagio dei confini che la scienza non dovrebbe mai superare. Dice a questo proposito il regista: “Nei miei film gli scienziati sono sempre degli eroi che spingono la ricerca ai limiti estremi. Esplorano, rischiano di persona, vengono feriti e feriscono, ma questo è ciò che fanno gli esseri umani. Lo si fa quotidianamente, per costume e per cultura. Anche gli artisti lo fanno. E io mi considero uno di loro”.
MITI E STEREOTIPI D’AMERICA NEI FILM ITALIANI DEL VENTENNIO FASCISTA
di Mario Galeotti
Gli stereotipi che, almeno a partire dalla fine dell’Ottocento in concomitanza con i grandi flussi migratori verso gli Stati Uniti d’America, hanno sintetizzato, in tempi diversi ma con sorprendente continuità, la percezione del mito americano si sono concentrati principalmente su pochi e riduttivi aspetti: la verticalità della metropoli coi suoi grattacieli, l’opulenza, le grosse automobili, l’abuso di superalcolici, le stravaganti abitudini. Come ha osservato Federico Romero, in Italia, “più che in altri paesi dell’Europa continentale, le percezioni degli Stati Uniti” hanno conosciuto “una curiosa, paradossale perversione per cui di quel paese ne parlano di più, e con maggiore influenza, quelli che ne sanno di meno, e viceversa”. Romero ha fatto riferimento a una “forte carenza conoscitiva, e spesso una vera e propria ignoranza degli Stati Uniti”, “proprio tra le élite e quei ceti intellettuali che invece dominano e formano la cultura popolare”, originando una lunga serie di raffigurazioni stereotipate “non tanto della società USA (che non conoscono e a cui non sono davvero interessati) quanto di un’astratta ‘civiltà’ (o più spesso inciviltà) americana” (in: A. Giovagnoli – G. Del Zanna, Il mondo visto dall’Italia, VII. Gli Stati Uniti, Guerini e Associati, Milano 2004, pp. 375 – 376).
La figura del tipico americano facoltoso e spendereccio, presente anche nei film italiani realizzati negli anni del fascismo che sono oggetto del nostro articolo, non faceva i conti con una realtà sociale che anche in America era estremamente diversificata. La raffigurazione dei grattacieli, poi, simboli dei grandi spazi urbani degli Stati Uniti che hanno incarnato a lungo l’ossessione di un mondo diverso dal nostro, una giungla d’asfalto inconcepibile per l’Italia di allora, tralasciava del tutto la ben più vasta realtà della provincia americana.
L’automobile, almeno prima che divenisse un mezzo di trasporto di massa anche nel nostro paese negli anni del boom economico, ha funzionato da pretesto per parlare del lusso sfrenato in cui si pensava vivessero tutti gli americani, ma già negli anni Trenta non mancò chi, dalle pagine della rivista «Cinema», mise giustamente in dubbio la validità di un siffatto termine di paragone che non contestualizzava a dovere i rispettivi stili di vita e le diverse esigenze delle società di Italia e d’America:
“Avere una macchina, negli Stati Uniti, non è un lusso. Le macchine costano poco, i ragazzi imparano a guidare fin da bambini, e, d’altra parte, in molte regioni, esse rappresentano il rimedio logico all’isolamento […]. Ne consegue che per i personaggi di un film il possedere una macchina rientra nell’ordine naturale delle cose. Sennonché, la situazione muta negli stati europei, dove l’automobile non è ancora tanto popolare. Ed è qui precisamente che lo spettatore rischia interpretazioni inesatte, perché, in luogo di rendersi conto che la macchina di un personaggio cinematografico americano corrisponde approssimativamente alla propria bicicletta, è portato a considerare l’America come una terra promessa nella quale è possibile conseguire il lusso senza fatica” (W. Bryher, Influenza di Hollywood, in «Cinema», n. 69, 10 maggio 1939).
I due poli entro cui oscillavano più spesso le riduttive rappresentazioni dell’America erano Los Angeles e New York. La prima, perché da lì si irradiava in tutto il mondo il mito di Hollywood, i cui film e divi avevano ormai conquistato il mercato internazionale fin dal primo dopoguerra. New York, perché nella Grande Mela erano concentrati tutti quegli aspetti che originavano, nell’europeo, un’idea limitante e univoca della repubblica a stelle e strisce. Il cinema americano, accusato spesso di fornire una rappresentazione fasulla della realtà, non faceva che rafforzare questi stereotipi. La descrizione che gli americani fornivano di sé stessi, infatti, giungeva da noi soprattutto attraverso i film, andando ad alimentare ulteriormente il bagaglio di miti e luoghi comuni dell’osservatore europeo. John Diggins ha osservato che la preponderante presenza delle pellicole hollywoodiane sul mercato italiano, che avrebbe incontrato un primo vero ostacolo solo con l’introduzione del Monopolio nel 1938 alle soglie della seconda guerra mondiale, poteva rappresentare per il regime anche un’utile arma a fini politici: “l’invasione del sesso e del gangsterismo nei prodotti di Hollywood gli forniva una propaganda già bell’è confezionata di cui si servivano i fascisti per far risaltare gli austeri ideali dell’Italia in confronto con un’America piena di vizi” (J. Diggins, L’America, Mussolini e il fascismo, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 318.). Ricordiamo, però, che nello stesso tempo il regime conservava sempre un’immagine vagamente idealizzata del popolo americano attribuendogli qualità che bene si adattavano alla fisionomia dell’uomo nuovo fascista. Un’ambivalenza che si ritrovava anche in quegli intellettuali che, non propriamente allineati con la politica del fascismo, avrebbero animato i grandi fermenti culturali del secondo dopoguerra: Mario Soldati, Carlo Lizzani, Giuseppe De Santis, Luchino Visconti, Alberto Lattuada. Tutti erano attratti dall’America del New Deal (ma anche il regime stesso intravedeva nella politica sociale del New Deal elementi di affinità con lo statalismo fascista), estimatori della letteratura americana di Steinbeck, Hemingway, Faulkner e del realismo sociale di alcuni film americani del periodo (pensiamo a “Furore” di John Ford, del 1940, tratto dall’omonimo romanzo di John Steinbeck); inseguivano un’idea mitizzata dell’America perché era l’unica alternativa a un mondo (l’Italia fascista, sempre più amica della Germania di Hitler) nel quale faticavano a riconoscersi, ma non rinunciarono a denunciarne anche gli aspetti meno accattivanti. Mario Soldati, ad esempio, in America primo amore aveva parlato di una società standardizzata afflitta da incomunicabilità e solitudine (M. Soldati, America primo amore, Einaudi, Roma 1945): lo stesso sconsolante ritratto che emerge in due film italiani realizzati rispettivamente nel 1928 e nel 1932, “Napoli che canta (Addio mia bella Napoli)” di Mario Almirante, film muto riproposto nel 1930 in una versione sonorizzata, e “Due cuori felici” di Baldassarre Negroni.
La didascalia d’apertura, in “Napoli che canta”, introduce New York con queste parole: “New York. Case moltiplicate per 10, ricchezza per 20, miseria per 50… indifferenza per mille”. Vincenzo Aniello (impersonato dall’attore Carlo Tedeschi) è un napoletano che è riuscito a fare fortuna negli Stati Uniti diventando proprietario di una grossa cartiera. Per rinsaldare ulteriormente la sua posizione, combina un matrimonio di interessi tra suo figlio Jimmy (Malcolm Todd) e Alice (Lilion Lyll), figlia di un importante editore: un matrimonio tra la carta e il giornale. Niente sentimenti, dunque, e con molta disinvoltura i due giovani stabiliscono che, una volta celebrate le nozze, potranno continuare a condurre le proprie vite in libertà, senza dover rendere conto di nulla. Prima, però, Jimmy dovrà adempiere agli obblighi militari in Italia. Sulla nave che lo porterà a Napoli, Jimmy scopre con stupore che anche Alice si è imbarcata per un viaggio di piacere. Dopo aver avvalorato gli accordi già presi, i due giungono a destinazione. Al loro arrivo, Napoli è stranamente cupa, avvolta da grigie nubi che infondono malumore, con grave delusione di Jimmy. Ma manca ancora un mese prima di dover iniziare il servizio di leva a Caserta e il giovane, confidando in un clima migliore, avrà molto tempo a disposizione per visitare la città e i dintorni. Il sole, il mare, il fascino di quei luoghi fanno riscoprire a Jimmy le proprie origini italiane. Alla madre scrive: “Qui ho ritrovato la mia patria… la mia anima vera, quella che mi hai dato tu, mamma mia cara”. L’Italia è per lui il salutare antidoto al freddo materialismo della vita americana. Intanto Alice continua la sua spensierata vacanza. Una didascalia, riferendosi alla poco morigerata condotta della ragazza, dice con sarcasmo: “Mentre Alice approfittava di tutti i suoi diritti di fidanzata all’americana, Jimmy compiva con fervore il suo dovere di soldato italiano”. Lontana dall’atmosfera corruttrice della metropoli americana, però, e a contatto con le bellezze di Napoli, anche la ragazza si ravvede e i due finiscono con l’innamorarsi sul serio. L’Italia li ha arricchiti con una “lezione di sentimento”, come si dice nel film. Dopo un anno, Jimmy e Alice possono fare ritorno a New York, col cuore colmo d’amore reciproco, ma con tanta nostalgia per il paese che ha saputo addolcire i loro animi.
Nel film di Almirante, risulta chiaro come New York sia ancora una volta il pretesto per fornire una descrizione-tipo della vita americana: corsa al successo, frenesia, materialismo, indifferenza, monetizzazione dei rapporti umani. “La bruttezza, la durezza di certe cose di New York”, aveva scritto Mario Soldati, “stringe il cuore fin dal primo momento; ma è un’angoscia che invece di deprimere esalta […] se New York, l’America non fosse anche triste, tragica, brutta, non sarebbe viva, allegra e giovane” (M. Soldati, America primo amore, cit., p. 21). Ma l’America di Napoli che canta non sembra lasciare nessuno spazio alla vivacità e all’allegria: New York, oseremmo dire, appare solo tragica e deprimente.
Il cliché del ricco industriale americano di origini italiane ricompare in “Due cuori felici”, rifacimento di un film tedesco diretto da Max Neufeld (“Ein bisschen Liebe für duch”, 1932). Il protagonista, Mr. Brown (Vittorio De Sica), è il titolare di un’industria di automobili con filiali in tutto il mondo, descritto come un curioso concentrato di difetti americani e di attributi italici. Giunto a Roma per visitare la filiale gestita dall’ingegner Fabbri (Umberto Melnati), si vanta delle proprie origini e dice di conoscere bene l’Italia ma quando gli viene mostrata una cartolina del lago di Garda, crede trattarsi del golfo di Napoli. Nel salone gli impiegati della filiale improvvisano un balletto in suo onore e cantano in coro “How do you do, Mr. Brown?”. L’industriale parla dei frenetici ritmi di vita americani dicendo: “noi americani facciamo tutto alla svelta” e “fare il proprio comodo è molto americano”. Durante la cena in casa Fabbri, disapprova il fatto che lui e sua moglie non abbiano figli e dice, ragionando in termini di produttività ma anche dimostrandosi in sintonia con la politica demografica del regime: “un matrimonio senza bambini è come un’industria improduttiva”. Quando gli viene chiesto se apprezza la musica, risponde di preferire le melodie italiane alla musica americana. Dopo cena, chiede di essere accompagnato in un ritrovo notturno per svagarsi. Giunti al locale, giudica il posto “troppo americano” e preferisce andare in una taverna, dove poter cantare a squarciagola e bere vino di Frascati. Visibilmente alticcio, si esibisce nell’apologia in versi della donna italiana: “non voglio ritornare più solo lassù, ma per campion portare la donna di quaggiù”. E infatti, farà ritorno in America in compagnia della segretaria di Fabbri, rendendo meno traumatico il distacco dalla bella Italia. Prima del suo arrivo in Italia, si era visto il responsabile della filiale italiana redigere una relazione da presentare a Mr. Brown, nella quale si annotava il discreto successo di vendite dell’utilitaria americana e l’introduzione, anche nel nostro paese, del sistema di pagamento rateale (molto in anticipo sui tempi): ma irrompendo nella stanza la segretaria riferiva, con ironia degli sceneggiatori, che un cliente, dopo aver saldato la prima rata, si era rifiutato di continuare a pagare.
Anche nel caso di “Due cuori felici”, il Bel Paese è il luogo dove riscoprire le proprie radici e trovare una valida alternativa all’american way of life, confermando la contrapposizione tra un’Italia modesta e dignitosa, che non deve sottostare a disumanizzanti stili di vita, e un’America che, come ha scritto Michela Nacci, nella figura dell’uomo d’affari newyorchese è criticamente associata “ai grattacieli geometrici, alla totale mancanza di natura nelle città”, “al sistema delle vendite a rate”, “alla meccanizzazione di gesti e comportamenti, alla estensione del sistema di fabbrica alla cultura e alla comunicazione, alla trasformazione delle arti in industria” (M. Nacci, La barbarie del comfort. L’antiamericanismo in Italia e in Francia negli anni Trenta, in: P. P. D’Attorre, Nemici per la pelle, FrancoAngeli, Milano 1991, p. 86).
Critiche agli argomenti più rappresentativi del capitalismo americano, già emerse nei film “Napoli che canta” e “Due cuori felici” e in altri momenti del più ampio dibattito tra americanismo e antiamericanismo, sono al centro anche di altre due pellicole del ventennio, uscite nelle sale italiane rispettivamente nel marzo e nel settembre del 1940: “Centomila dollari” di Mario Camerini e “Dopo divorzieremo” di Nunzio Malasomma.
Nel primo, tratto da una commedia di Carl Conrad e prodotto dalla Astra Film, Amedeo Nazzari interpreta John Woods, un facoltoso industriale in viaggio d’affari a Budapest, accompagnato da uno stuolo di collaboratori lautamente stipendiati. Razionalità, efficienza e tempismo sono i tre principi che costantemente stanno alla base dell’operato di Woods e del suo personale. La sua concezione metodica e meccanica del lavoro e della vita porta Woods a pensare che col denaro si possa ottenere qualunque cosa e per questo motivo offre la sbalorditiva somma di centomila dollari (da cui il titolo del film) solo per avere il piacere di cenare con una telefonista del Grand Hotel, Lily (Assia Noris). La cosa più assurda è che la proposta viene fatta per interposta persona al fidanzato della ragazza, il quale ovviamente rifiuta sdegnato. All’inizio la famiglia di Lily si ritiene profondamente offesa dall’atteggiamento dell’arrogante americano ma poi, riflettendo bene sull’entità della somma di denaro, comincia a pensare che la ragazza debba accettare l’invito. Anzi, i parenti cercano di convincerla con insistenza dicendole che, in fondo, gli americani sono “prepotenti, qualche volta pazzi, ma leali”. Alla fine Lily, a malincuore, acconsente. Inizialmente ostile e scostante, con il trascorrere della serata la ragazza sente crescere dentro di sé un’attrazione per l’industriale e finisce con l’innamorarsene, ricambiata da Woods, il quale però decide di rimettersi in viaggio la notte stessa, col suo aereo privato, per urgenti questioni di lavoro da sbrigare in America. Le condizioni meteorologiche avverse, che rischiano di mettere seriamente a repentaglio la vita di tutti i passeggeri, fanno capire al miliardario che i soldi non sono tutto. Rivolgendo il suo pensiero all’amata, dopo un atterraggio di fortuna Woods decide di ripartire per Budapest a bordo di un nuovo apparecchio, da solo, di fronte allo sguardo attonito dei suoi collaboratori che lo credono impazzito per il troppo lavoro. Dopo un altro burrascoso viaggio, giunge nella capitale ungherese giusto in tempo per impedire l’imminente matrimonio tra Lily e il suo fidanzato e portare via con sé la ragazza. In definitiva, è stato l’amore per un’umile telefonista a fargli riscoprire i valori autentici della vita.
In “Dopo divorzieremo”, tratto dall’omonima commedia di Alessandro De Stefani e prodotto dalla Excelsa Film, ritroviamo Nazzari nel ruolo di Phil Gilder, un musicista spiantato che vive di espedienti. Il proseguimento ideale del miliardario di “Centomila dollari” è rappresentato, piuttosto, dalla figura del direttore di una grossa catena di grandi magazzini di New York che, cominciando come semplice fattorino, è giunto in cima alla scala sociale riassumendo nella propria persona il mito americano del self made man.
Ciò su cui si ironizza, in questo caso, è il falso paternalismo attribuito ai dirigenti delle grandi compagnie americane che, come l’inflessibile direttore dei magazzini, si presentano ai dipendenti in veste di padri premurosi attenti a soddisfare ogni loro necessità, ma in realtà vogliono controllarne la vita privata solo ed esclusivamente per assicurarsi un buon rendimento sul lavoro. Il severo regolamento della ditta, infatti, prevede che il personale femminile non possa intrattenere in alcun modo relazioni di carattere sentimentale, pena il licenziamento, per evitare il rischio di distrazioni dal lavoro. Di conseguenza, l’alloggio che ospita le giovani impiegate è soggetto a un rigido codice di comportamento che vieta, tra le altre cose, di chiudere a chiave le singole stanze. Grace (Vivi Gioi) è una delle commesse costrette a sottostare a queste inique disposizioni. Insofferente a un clima illiberale, esclama: “E’ la mentalità ipocrita di questo paese, detesto New York!”. La situazione si complica quando Grace si innamora del bel musicista impersonato da Nazzari e quando Phil, dopo aver romanticamente suonato il violino sotto la finestra della ragazza in pieno centro di New York (una New York visibilmente posticcia, con piccoli scorci di compensato), si introduce nel suo appartamento spacciandosi per l’idraulico. Scoperta la presenza dell’intruso, per salvare l’impiego a Grace viene inscenato un finto matrimonio: Phil è presentato come il promesso sposo di Funny (Lilia Silvi), coinquilina di Grace, che dal momento che lavora per un’altra società non è soggetta ai medesimi obblighi. Il macchinoso piano prevede che si celebri un vero matrimonio e che, non appena Grace avrà trovato un nuovo impiego che le permetta di sposarsi senza più subire assurde imposizioni, Phil e Funny divorzino in modo da poter celebrare poi le nuove nozze tra i due innamorati. Si scherza chiaramente sulla natura effimera dell’istituto matrimoniale in America e sulla facilità con cui si può ricorrere al divorzio, impensabile nell’Italia di allora. É l’ennesima allusione, dunque, a una aridità di affetti nella società americana. Ma alla fine prevalgono i buoni sentimenti perché, dopo una difficile convivenza, Phil e Funny si innamorano e non ci sarà più bisogno di divorziare. Messa di fronte al fatto compiuto, Grace trova subito con chi consolarsi dimostrando quell’intraprendenza spesso attribuita alle donne americane. La divertente coppia Nazzari – Silvi, già apparsi insieme nei film “Assenza ingiustificata” di Max Neufeld (1939) e “Scarpe grosse” di Dino Falconi (1940), si sarebbe poi riformata in altre tre pellicole: “Scampolo”, sempre diretto da Malasomma (1941), tratto dall’omonima commedia in tre atti di Dario Niccodemi, “La bisbetica domata” di Ferdinando Maria Poggioli (1942), libero adattamento dell’opera di Shakespeare in cui Nazzari è un italiano che ha fatto fortuna emigrando in America, e “Giorni felici” di Gianni Franciolini (1943).
Piero Pruzzo ed Enrico Lancia, autori di un libro dedicato alla carriera di Amedeo Nazzari, hanno avanzato l’ipotesi che, dietro all’ironica rappresentazione di un’America di maniera, si nascondesse in realtà il fatto che i film di Hollywood e con essi le scene di vita americana, la cui presenza in Italia, come abbiamo già accennato, diminuì sensibilmente dopo l’entrata in vigore del Monopolio del commercio di film (reso esecutivo per Regio decreto legge 4 settembre 1938 n. 1389), continuavano ad essere pur sempre “la grande e rimpianta favola popolare” e che la politica autarchica poteva “fornire persino l’alibi per giocare all’America con la scusa di graffiarne i costumi” (P. Pruzzo – E. Lancia, Amedeo Nazzari, Gremese Editore, Roma 1983, p. 60). Negli anni della guerra, quindi, la solita scanzonata critica ai costumi americani era anche l’occasione, al cinema, per imbonire il pubblico con situazioni e personaggi d’America ai quali ormai era troppo abituato per non avvertirne l’assenza crescente dopo l’istituzione del Monopolio. Lo sgangherato antiamericanismo di film come “Centomila dollari” e “Dopo divorzieremo”, cioè,poteva corrispondere paradossalmente anche alla necessità di colmare il vuoto lasciato dalla ridotta presenza di film hollywoodiani sui nostri schermi negli anni del conflitto, riproducendo in chiave umoristica e deformante ipotetiche scene di quotidianità d’oltreoceano. Quest’ipotesi sembrerebbe confermata da un altro film con protagonista il divo Nazzari, “Cose dell’altro mondo” di Nunzio Malasomma (1939), dove la critica all’american way of life era confezionata secondo schemi che si rifacevano in maniera esplicita a modelli della cultura di massa anglosassone e, in particolare, a taluni generi del cinema hollywoodiano.
“Cose dell’altro mondo”, prodotto da Silvestro Mascali per la Consortium Film, è un’opera leggera, dove le atmosfere poliziesche e del gangster moviesono funzionali a un capovolgimento parodistico della realtà che connota, in forma forzatamente grottesca, protagonisti e ambienti.
Secondo quanto riportato da Dino Falconi, “Cose dell’altro mondo” si ispirava a un curioso fatto di cronaca riguardante un carcere in cui il direttore e sua figlia permettevano ai prigionieri di allontanarsi nottetempo dallo stabile e di ricevere visite in cella (D. Falconi, recensione di Cose dell’altro mondo, in «Il Popolo d’Italia», 20 marzo 1940). La singolarità della notizia ispirò gli sceneggiatori del film (tra cui il regista Malasomma e Giacomo Debenedetti), che colsero l’occasione per farne così una spumeggiante, quanto improbabile, rappresentazione dell’ambiente carcerario americano. Le accoglienze della critica furono alquanto fredde. Francesco Càllari commentò che, ostinandosi a voler “presentare uomini e fatti di altri paesi che non siano il nostro”, l’unica cosa in cui il film era riuscito era di aver sfiorato il paradosso (F. Càllari, recensione di Cose dell’altro mondo, in «Film», n. 50, 16 dicembre 1939). Giuseppe Isani, citando il film “Muraglie” (“Pardon Us”, di James Parrott, 1931), primo lungometraggio della coppia Stanlio e Ollio, notò come solo gli americani, meglio di chiunque altro, riuscissero a “colpire certi loro propri atteggiamenti di vita privata e pubblica”, mentre nel film di Malasomma la satira, quella vera che coglie nel segno, era del tutto assente:
“Quando si parla di satire delle carceri americane, o meglio di satire dei film che hanno a sfondo quella vita carceraria, torna in mente subito “Muraglie” con la sua schiacciante comicità, e fioriscono i ricordi. Qui si tratta di tutt’altra cosa. “Cose dell’altro mondo” è un po’ un’America in famiglia; tanto in famiglia da non essere più America e da farne una di quelle scombinate e ingenue scene da teatrini da bambini che vogliono imitare penosamente i grandi” (G. Isani, recensione di Cose dell’altro mondo, in «Cinema», n. 84, 25 dicembre 1939).
I titoli di testa del film scorrono su un collage di immagini stilizzate che ritraggono grattacieli, Statua della Libertà, cowboys, stelline della bandiera americana. L’azione si svolge nel penitenziario di Trinidad, un luogo permissivo dove la vita carceraria dei pochi detenuti è tutto sommato piacevole. Antonio Gandusio interpreta il direttore del carcere, costretto a subire le continue rimostranze della moglie, che si lamenta del fatto che quel luogo sia troppo tranquillo e che non accada mai niente di emozionante, mai una sparatoria o un omicidio. Nel desiderio di condurre una vita più movimentata, la donna dice al marito: “i veri carcerati sono tua moglie e tua figlia!”, esternando un’irrefrenabile propensione all’avventura e al pericolo. L’occasione per evadere dalla routine quotidiana si presenta con l’arrivo di un nuovo recluso, Jack detto “l’uomo mitragliatrice” (Amedeo Nazzari), un tipo particolarmente pericoloso che ha al suo attivo ben quattordici processi nei vari stati della confederazione.
La figlia del direttore rimane subito affascinata dal suo aspetto così “per bene”, tanto che, durante l’assenza del padre, permette a Jack di allontanarsi dal carcere, assieme alle due misteriose donne che lo accompagnano fin dal suo arrivo, per poter conferire (dice lui) con il proprio avvocato. Ma la loro assenza si prolunga ben oltre il previsto. Infuriato per l’incosciente condotta della figlia, nell’imminenza di un’ispezione governativa il direttore è costretto a sostituire i tre fuggiaschi rispettivamente con un detenuto tuttofare, la propria consorte e la figlia. Seguono peripezie di vario genere, sullo sfondo di luoghi e situazioni tipici dei film di gangster rivisitati in chiave comica: strade notturne, tabarin, inseguimenti, pistolettate. Tra scambi di persone e atmosfere corruttrici, la casereccia mise en scene di questo “filmetto buffonescamente giallognolo” (D. Falconi, recensione di Cose dell’altro mondo, cit) si conclude con la scoperta della vera identità di Jack. L’uomo detto “mitragliatrice” altri non è che un ispettore incaricato di constatare il grado di sicurezza delle carceri americane.
Anche la commedia “Cose dell’altro mondo”, dunque, tratteggia i personaggi secondo lo stereotipo di un’America eccentrica, corrotta e caotica, e lo fa ricorrendo alla versione parodiata dei modelli narrativi del cinema poliziesco americano degli anni Trenta, con un approccio che è al tempo stesso di critica esilarante a usi e costumi americani e di riproposizione di alcune delle forme tipiche della cultura di massa americana: ulteriore conferma dell’ambivalenza che ha sempre contraddistinto la percezione del mito americano nell’Italia fascista.
LA PREPARAZIONE AL LUTTO: QUALCHE FILM
di Paola Brunetta
Di recente sono usciti due film che vertono sul tema della preparazione al lutto e che si possono accostare ad un’opera di qualche mese precedente che tratta tangenzialmente questo tema, “The Father – Nulla è come sembra” di Florian Zeller: “Nowhere Special” di Uberto Pasolini e “Supernova” di Harry Macqueen. Naturale quindi entrarci, sia per la delicatezza con cui è in entrambi i casi affrontato l’argomento, che ci parla del valore dei due film, sia per capire che cosa i due registi, e volendo anche Zeller, mettono in evidenza, quale curvatura danno a un qualcosa che generalmente, nella letteratura e nel cinema, viene proposto come elaborazione di un lutto (sto leggendo, a questo proposito, “L’amore che resta” di Fernando Savater). Si guarda cioè al dopo, al post mortem, e non ci si concentra sul prima, come fanno i nostri film. Oppure, secondo un filone che negli ultimi tempi vede spesso come protagonisti gli adolescenti, si parla del prima in termini di malattia, per la persona interessata e per coloro che le stanno vicino (meritevole di attenzione in questo senso, tra le uscite di quest’ultimo periodo, “Babyteeth – Tutti i colori di Milla” di Shannon Murphy). L’altro elemento di interesse dei film di cui sopra, e anche di “The Father – Nulla è come sembra”, è l’aspetto etico: in un caso c’è un padre che, sapendo che a breve morirà, deve trovare (con l’aiuto dei servizi sociali) la famiglia che potrà adottare il figlio di quattro anni, nell’altro c’è il compagno di un uomo malato che si appresta a sostenerlo negli ultimi mesi di vita, mentre questi, anche per evitare di gravare sulla persona a lui più cara, ha programmato il suicidio. Si tratta in ogni caso di film sulla morte (imminente) ma anche di film sull’amore.
Storie d’amore intense e toccanti tra un padre e un figlio, e tra due uomini maturi. Storie di dedizione all’altro, di abnegazione, di dono di sé mai patetiche o drammatiche ma sempre discrete, misurate. Poetiche.
“Nowhere special”, presentato a Venezia 2020 e alla Festa del cinema di Roma dello stesso anno, è il terzo film da regista di Uberto Pasolini, che ne è anche sceneggiatore, e riprende da “Still Life” (2013) l’interesse per il tema della morte come inno alla vita, e all’amore che della vita è l’essenza.
Lì un funzionario comunale andava alla ricerca dei parenti di chi era morto in solitudine, qui un padre, si diceva, affetto da un male incurabile, cerca tra tante la famiglia che dovrà adottare il figlio piccolo, nel momento in cui può ancora farlo. Vuole che il figlio, la cui madre lo ha abbandonato presto, possa vivere bene, accanto a persone che gli vogliano bene e che siano per lui dei riferimenti; e intanto lui vive davvero con il figlio, lo cura, lo accudisce, ci gioca, ci sta insieme. Facendogli percepire quello che è l’amore, tra padre e figlio ma anche tra persone: l’amore puro, l’amore incondizionato, l’amore che non chiede niente in cambio ma che solamente, dà. Lui è un lavavetri e dall’esterno delle abitazioni, mentre esercita il suo lavoro, vede le vite degli altri, anche degli altri bambini, come se non avesse una vita propria; e immagina, le vite degli altri, come immagina quella che il proprio figlio farà senza di lui, di lì a pochi mesi. E’ il suo unico compito adesso, per la persona che ama di più al mondo. E lo svolge in modo semplice, come semplice e composta (senza fronzoli, senza effetti, senza colpi di scena melodrammatici), ma formalmente perfetta, è la regia di Pasolini. E’ anche molto interessante che l’autore non rinunci alla cura formale, trattando un tema di questo tipo che potrebbe anche ammettere uno stile più grezzo: la fotografia, soprattutto, di Marius Panduru, collaboratore fisso di Radu Jude, è notevole fin dai titoli di testa, che da soli basterebbero a rendere l’alone di poesia che caratterizza l’intero film.
La stessa poeticità e la stessa misura/ discrezione/ compostezza nella regia si ritrovano nel secondo film considerato, “Supernova” di Harry Macqueen (presentato a San Sebastián e a Roma nel 2020), che ha per protagonisti due intellettuali di mezza età, un pianista e uno scrittore di successo, il primo inglese il secondo americano, che intraprendono un ultimo viaggio con il camper (in questo ricordando “Ella & John – The Leisure Seeker” di Paolo Virzì) prima che la malattia dello scrittore, una forma grave di demenza, peggiori sensibilmente. Lui ha deciso, adesso che è ancora lucido, di togliersi la vita durante il concerto del compagno, in modo da salvaguardarlo da eventuali accuse e, soprattutto, dallo strazio di doverlo assistere e di vederlo morire, assicurandosi anche che la sorella e il cognato lo supportino, dopo; mentre l’altro, pur con tutte le paure del caso, ha deciso di stargli vicino fino alla fine, accantonando o abbandonando per sempre, dopo il concerto di cui sopra, la carriera pianistica. E in una scena straziante (e ripeto volutamente questa parola, strazio, perché di questo si tratta) glielo chiede, anzi lo supplica di permettergli di assisterlo e di stargli vicino fino all’ultimo giorno, per coronare l’amore che ha per lui. Amore mescolato al dolore atroce per lo stato del compagno e alla paura di non farcela, che fanno dire all’altro, che pure comprende ed è a sua volta straziato, “Non si dovrebbe piangere qualcuno quando è ancora in vita”; perché tutto nel film, lo sguardo sul cielo come la visita alla sorella di Sam e la serata con gli amici più cari, che in realtà ha organizzato Tusker per preparare se stesso e il compagno al distacco, ha il sapore di quest’amore infinito che i due si scambiano e del dolore per come stanno mutando le loro vite che pure, in passato, sono state generose. In tutto questo della malattia di Tusker non vediamo quasi nulla e così è anche nell’altro film, e anche questo mi sembra un grande pregio e un grande segno di compostezza nel trattare, in un film, la drammaticità di alcune situazioni della vita. Senza gridarla o renderla visivamente disperata. Si sa che c’è, quella disperazione. E tanto basta.
Un altro elemento chiave che caratterizza entrambi i film è la maestria degli attori, e dire maestria è dire poco. Nel primo, oltre a Daniel Lamont nel ruolo del bambino, c’è un James Norton a cui basta la presenza intensa e malinconica per essere credibile. Nel secondo si affrontano due mostri sacri del cinema mondiale, Colin Firth e Stanley Tucci, in due ruoli che segneranno le loro carriere.

Sarà chiaro a questo punto il collegamento con il terzo film citato, “The Father – Nulla è come sembra”, che non parla propriamente di morte ma di Alzheimer e di vecchiaia, mostrando comunque un “prima”, quello di un uomo anziano (altro attore magistrale, Anthony Hopkins) che ha perso le proprie coordinate esistenziali e confonde la propria casa con la stanza della casa di riposo in cui è ospitato, la propria figlia con altre donne, le badanti con le infermiere, perdendo la percezione di se stesso e della propria identità. Lo stile qui è diverso, molto più frastornante (lo spiazzamento del protagonista è anche quello dello spettatore) e coinvolgente sul piano delle emozioni, toccante in senso letterale. Ma la discrezione con cui è presentata la situazione e il senso di morte incombente, anche se non mostrata (nonché, ovviamente, la prova attoriale, che riguarda in questo caso pure Olivia Colman), sono gli stessi delle due opere di cui ci siamo occupati sopra.
Chiudo con un’ultima opera, meno asciutta nello stile ma altrettanto malinconica e sicuramente più triste (cupa, forse) di quelle che abbiamo già nominato: “Falling – Storia di un padre” di Viggo Mortensen. Che cito per il senso d’amore con cui un figlio, interpretato dallo stesso Mortensen, segue il padre anziano e malato fino alla fine dei suoi giorni, incurante del disprezzo ostentato, anche se più apparente che reale, che questi gli manifesta.
Un uomo egoista e incattivito dalla vecchiaia e dalla malattia, che ha condizionato pesantemente la vita dei figli e che sembra non gradire le attenzioni che il protagonista gli riserva; e un esempio, questo, di dedizione che fa da contraltare a quello del protagonista del primo film considerato, in un diverso rapporto padre-figlio e in un modo diverso di “accogliere” la morte.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
INAUGURAZIONE DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE STUDI E RICERCHE CINEMA FERRARESE
di Maurizio Villani
Sabato 18 dicembre 2021, alle ore 11.30, nel Salone d’Onore di Palazzo Roverella a Ferrara, si è tenuta l’inaugurazione del Centro Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese. Sono intervenuti Marco Gulinelli, Assessore alla Cultura Comune di Ferrara, Riccardo Modestino Vicepresidente e responsabile culturale del Circolo dei Negozianti, Cinzia Bracci, Presidente C.D.S. Cultura OdV, Paolo Micalizzi, Direttore del Centro Studi. Erano presenti nel salone, gremito di pubblico, molti esponenti del Cinema Ferrarese e film-maker nazionali.
Il Centro Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese nasce a Palazzo Roverella, Sede del Circolo dei Negozianti, su idea del giornalista, critico e storico del cinema, Paolo Micalizzi, che ne assume la direzione. È promosso da CDS Cultura e dal Circolo dei Negozianti di Ferrara e si propone di mantenere viva la tradizione del cinema ferrarese. Si articola sia in un’esposizione permanente di documenti iconografici (manifesti, locandine e fotografie) relativi ai film ed ai documentari professionali realizzati, a partire dal 1902 nel territorio ferrarese, sia in una raccolta di libri e documenti di carattere generale sul cinema ferrarese: film, opere per la TV, documentari, cortometraggi, servizi televisivi, realizzati a Ferrara e nel territorio provinciale, in particolare a Comacchio e nel Delta del Po, luoghi che hanno riscosso grande interesse da parte di tanti registi a livello nazionale ed internazionale. Alcuni nomi legati al territorio di “Ferrara città del cinema” sono: Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini, Mario Soldati, Florestano Vancini, Franco Rossi, Vittorio De Sica, Giuliano Montando, Pupi Avati, Gianfranco Mingozzi, Marco Ferreri (che ha girato alcune scene del film “Chiedo asilo” anche nello Stabilimento Montedison di Ferrara come testimoniato da alcune fotografie e dai saggi di Paolo Micalizzi pubblicati sui due volumi dedicati al Petrolchimico di Ferrara dal CDS Cultura), Luigi Scattini, Giuseppe Bertolucci, Carlo Mazzacurati, Bigas Luna, Ermanno Olmi, Riccardo Donna, Gianni Lepre, Luigi Magni, fino ad arrivare ai nuovi film diretti da giovani autori come Letizia Lomartire, Elisabetta Sgarbi, Claudio Cupellini ed altri, tra cui Marco Melluso e Diego Schiavo che anche a Palazzo Roverella hanno effettuato delle riprese per il loro film su Lucrezia Borgia. Temi che hanno ispirato molti registi sono legati al territorio del Delta padano, a pagine della storia di Ferrara che vanno dal Rinascimento al fascismo e all’antifascismo, alle opere letterarie di Riccardo Bacchelli e di Giorgio Bassani.
Il Centro avrà cura di mettere in evidenza l’attività di registi come Michelangelo Antonioni, Florestano Vancini, Folco Quilici, Carlo Rambaldi, Gianfranco Mingozzi, Renzo Ragazzi, Massimo Sani ed Ezio Pecora; di direttore della fotografia come Antonio Sturla (distintosi anche a livello nazionale e considerato il Pioniere del Cinema ferrarese); di attori come Adriana Benetti, Arnoldo Foà, Gualtiero Tumiati, Pina Gallini, di Bondeno, Livio Pavanelli di Copparo, Milva, Franco Cobianchi, José Greci, Rosy Mazzacurati, Marisa Mantovani, Giuseppe Gandini; di sceneggiatori come Fabio Pittorru e Massimo Felisatti, considerati dalla critica i “padrini del poliziesco italiano”. Vi sono poi altri autori che al cinema ferrarese hanno dato un fattivo contributo, come Paolo Sturla Avogadri, Fabio Medini, Cesare Bomazzini, don Massimo Manservigi e quanti hanno operato nel Cineclub Fedic Ferrara (costituitosi nel 1953 proprio a Palazzo Roverella), tra i quali Marco Felloni, Roberto Fontanelli, Carlo Magri, Andrea Barra, Anna Quarzi e Paolo Micalizzi stesso che nel 1964 ha partecipato alla realizzazione di due documentari.
Paolo Micalizzi è autore, dal 1969 ad oggi, di molti saggi e articoli (questi ultimo pubblicati nel corso di molti anni nell’edizione ferrarese del Quotidiano “Il Resto del Carlino”, sulla Rivista della Camera di Commercio “La pianura”, dove già negli anni Ottanta evidenziava l’importanza del cinema ferrarese). Una ricca produzione, già allora, che vantava una quarantina di film e molti documentari realizzati da personaggi legati al Cinema Ferrarese che hanno avuto rilevanza nella cinematografia italiana.
Farà parte del Centro Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese una ricca collezione di DVD e VHS, relativi alla produzione realizzata nel territorio ferrarese.
Tutto il materiale documentario del Centro è messo a disposizione degli studiosi, delle Università, delle Scuole e di tutti gli appassionati di cinema che vorranno prenderne visione.
Il Centro ha avuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune e della Camera di Commercio e Università degli Studi di Ferrara. Ed anche del SNCCI, SNGCI, AIRSC e della FEDIC Nazionale.
L’iniziativa è stata bene accolta dalla stampa cittadina ed ha avuto anche rilievo sulla stampa nazionale.
SAN GIORGIO DI PIANO RICORDA LA SUA GIULIETTA MASINA
di Paolo Micalizzi
A San Giorgio di Piano, paese natio di Giulietta Masina, sabato 20 novembre, per iniziativa del Comune e del Rotary Club Giulietta Masina ha avuto luogo la presentazione del libro “Lo spirito di Giulietta, storia di un’antidiva” di Fulvio Fulvi (Edizioni La Fronda, Milano), giornalista del Quotidiano “Avvenire”. La manifestazione è stata realizzata con la collaborazione delle associazioni di cultura cinematografica Cinit – Cineforum (rappresentata da Giuseppe Barbanti), Fedic -Federazione Italiana dei Cineclub e Festival Internazionale Sedicicorto di Forlì, rappresentati da Paolo Micalizzi, critico e storico del Cinema nonché responsabile di Fedic Cinema.
E’ stato lui che nell’occasione ha presentato il documentario di Giorgio Sabbatini, filmmaker storico della Fedic, realizzato per Sedicicorto di Forlì dove è stato proiettato nell’ultima edizione di quel Festival. Un titolo molto semplice quello del Video di Giorgio Sabbatini, “Giulietta Masina” appunto, evidenziando anche così la semplicità di un personaggio che ha conquistato il cuore degli spettatori di tutto il mondo. Un video che parte ricordando, con alcune foto e didascalie, dai natali e dalle prime fasi di vita di Giulietta Masina e che continua col mostrare sequenze di alcuni film che ne hanno contraddistinto la prestigiosa carriera. Sequenze molto significative dei film interpretati, in cui la si vede anche al fianco di grandi protagonisti del cinema, dove è diretta da grandi registi del cinema italiano ed europeo. Parlando di Giorgio Sabbatini chi scrive ha evidenziato come esso sia un filmmaker storico della Fedic, Presidente del Cineclub Piemonte di Torino, che ha al suo attivo una sessantina di opere che gli hanno fatto ottenere un ricco palmares di premi, a livello nazionale ed internazionale: opere in 8, super8 e 16 millimetri e in varie forme digitali. Il suo primo film a soggetto risale al 1961, si intitola “Illusione” ed è una storia basata sulle difficoltà incontrate da una persona nel modificare la propria situazione sociale. Il suo cinema si sviluppa infatti, soprattutto su temi sociali ed esistenziali dell’umanità. Sono opere per le quali spesso scrive musiche originali poiché la musica è un’altra sua passione. E continuando a parlare del suo Video su Giulietta Masina ha precisato che le sequenze che Sabbatini mostra iniziano con una relativa al film di Alberto Lattuada “Senza pietà” (1948) che è valso alla Masina un Nastro d’Argento. Un personaggio il suo pieno di umanità che va a trovare in ospedale Carla Del Poggio che nell’inferno della pineta di Tombolo, durante la seconda guerra mondiale si era cacciata in un giro di droga e prostituzione e verrà ferita mortalmente in uno scontro.
E pieni d’umanità sono altri personaggi che vedremo in altri film. In “Luci del varietà” (1950) co-diretto da Alberto Lattuada e Federico Fellini, suo marito, la vediamo perdonare e dare dei soldi a Peppino De Filippo, malgrado lui l’avesse tradita con un’altra ballerina: è il film con il quale già si distingue per aver ottenuto un Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista. In “Europa 51” (1952) di Roberto Rossellini è la vedova con prole che diventa amica della moglie di un diplomatico (Ingrid Bergman) che dopo il suicidio del figlioletto che si sentiva trascurato si dedica ad attività sociali.
Nel documentario di Giorgio Sabbatini anche una significativa Sequenza del film “La strada” (1954) di Federico Fellini, film che la consacrò a livello internazionale. La vediamo nella figura clownesca e innocente di Gelsomina, con Anthony Quinn, il rude Zampanò al quale lei era stata venduta dalla madre e con il quale girava le piazze dei Paesi dove lui si esibiva da giocoliere ed uomo forzuto. Ma anche del film “Il bidone” in cui è con Richard Basehart al quale rimprovera d’essere in un giro di ladri. E poi l’ingenua prostituta di “Le notti di Cabiria” (1957) con il quale conquista la Palma d’Oro al Festival di Cannes ed un Nastro d’Argento come attrice protagonista. La vediamo mentre perdona Francòis Périer del quale si era innamorata mentre lui, in effetti, tendeva a toglierle il suo denaro e per questo, come vediamo nel finale del film, voleva gettarla nel lago durante una gita. Poi, “Nella città l’inferno” (1959) di Renato Castellani dove la vediamo a confronto con un mostro sacro di attrice come Anna Magnani distinguendosi per la sua umanità.
Il viaggio di Giorgio Sabbatini nell’Omaggio a Giulietta Masina prosegue con altri film diretti dal marito Federico Fellini, molto famosi, come “Giulietta degli Spiriti”(1965) di cui nella sua ricerca scopre il making off in cui il Maestro le dà indicazioni circa il ruolo che ricopre che poi vedremo in una bella sequenza. Ed anche in “Ginger e Fred”(1986) con il quale conclude la sua attività artistica con Fellini, dove la vediamo duettare, esibendosi anche come ballerina, con Marcello Mastroianni , suo partner nell’avanspettacolo e famosi negli anni Quaranta nell’imitazione di Ginger Rogers e Fred Astaire, ritrovatisi dopo tanti anni per un programma televisivo. Ed in questa ricerca, molto valore ha anche il portare alla ribalta film interpretati da Giulietta Masina poco conosciuti come “Fortunella” (1958) di Edoardo De Filippo interpretato con Alberto Sordi, “Camilla”( 1976) ,sceneggiato televisivo di Sandro Bolchi, “Frau Holle -La Signora della neve” di Jurai Jakubisco e “Un giorno forse”( 1991) di Jean-Luis Bertucelli con il quale si congeda dallo schermo lasciando, come scrive anche Giorgio Sabbatini, un’impronta indelebile nel Cinema.
Un grande Omaggio a Giulietta Masina è anche il libro del giornalista e scrittore Fulvio Fulvi “ intitolato “Lo spirito di Giulietta Masina, storia di un’antidiva”.
Il libro riferisce, oltre ai grandi successi che l’hanno legato al marito Federico Fellini, alcuni aspetti autentici, spesso nascosti, della personalità dell’attrice, che emergono anche dalle testimonianze raccolte in interviste a parenti ed amici. Nel libro di Fulvi vi è anche una doverosa rivalutazione della donna e dell’attrice, sottolineando che tanti originali sviluppi della vena creativa di Fellini siano derivati dalla sua presenza a fianco del marito. Sono poi approfonditi anche i rapporti con Anna Magnani, segnati spesso da momenti di tensione.
La presentazione del Video di Sabbatini e del libro di Fulvi sono avvenute anche a Villa Orsi per iniziativa del Rotary Club Giulietta Masina.
FESTIVAL ED EVENTI
VENEZIA 2021: UNA GRANDE MOSTRA CHE HA SCONFITTO ANCORA UNA VOLTA LA PANDEMIA
di Paolo Micalizzi
E’ stata una partenza alla Grande quella della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Apertura con la presenza di Roberto Benigni e con il film di Pedro Almodovar “Madre paralelas”. Un imprevedibile comico toscano nel discorso che ha fatto seguito al ricevimento del “Leone d’Oro” alla carriera dove ha auspicato pubblicamente che il Presidente Sergio Mattarella, presente alla partenza della Mostra, rimanga ancora in futuro: ”Presidente rimanga con noi ancora un po’, magari fino ai mondiali in Qatar: lei ci porta fortuna”. E commovente quando dichiara il suo amore per la moglie Nicoletta Braschi:” Non posso neanche dedicarti questo premio perché è tuo, ti appartiene, abbiamo fatto tutto assieme. Quanti anni, trenta, quaranta? Io so che conosco solo una maniera per misurare il tempo: con te e senza di te”. Ed un Benigni scoppiettante alla Masterclass quando una ragazza le dice che le piacerebbe abbracciarlo e lui: “Visto che lei non può venire da me, vengo io da lei” ed abbandonando momentaneamente il tavolo dei relatori corre ad abbracciarla. Ed un Benigni cinefilo che stimolato dal critico cinematografico Gianni Canova, che lo presentava al folto pubblico, ha fatto sfoggio di una grande conoscenza della storia del cinema citando, ma non solo, i grandi Maestri della comicità (Chaplin, Keaton, Tatì). In apertura poi il film di Almodovar che con “Madri parallele” ritorna all’Universo femminile, alla maternità, alla famiglia raccontando la storia di due donne (Penélope Cruz e Milena Smit) che condividono la stessa stanza nell’ospedale in cui stanno per partorire ed uno scambio di neonati cambia in modo clamoroso la loro vita. Nei primi giorni della Mostra, un salto nella fantascienza con “Dune” del regista canadese Denis Villeneuve che riporta sullo schermo il romanzo di Frank Herbert che già nel 1984 David Lynch aveva reso affascinante con gli effetti speciali del ferrarese, di Vigarano Mainarda, Carlo Rambaldi. E che Villeneuve costruisce in questa prima parte con scene di battaglia spettacolari, in attesa di raccontarci l’entrata in scena dei famosi vermi giganti che in quanto a spettacolarità ha elementi da poter sbalordire lo spettatore. Una seconda parte molto attesa. La vedremo.
C’era molta attesa per il verdetto delle Giuria, soprattutto per quella che assegna il “Leone d’Oro”. Le stellette dei critici pubblicate dal Daily “Ciak in Mostra” vedevano come favorito quello di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”. Ma vi figurava anche quello di Mario Martone “Qui rido io”. Si trattava, in effetti, di due film che avrebbero meritato di entrare nel Palmares di “Venezia 78”. Il primo perché è un racconto personale che tocca il tema del dolore, un romanzo di formazione che coinvolge poiché ci si può rispecchiare, Il secondo per la superba interpretazione di Toni Servillo e per portare alla ribalta un personaggio come Eduardo Scarpetta che ha dato lustro al teatro napoletano. Nei primi posti anche “Competencia oficial” con protagonista il cinema, mezzo che un ricchissimo miliardario vuole usare per essere finalmente riconosciuto in circoli culturali ed intellettuali a lui preclusi: e per questo diventa produttore di un film che affida ad una famosa regista ed a due attori di grido. E “The power on the Dog” di Jane Campion, storia di due fratelli in un ranch di inizio Novecento; “Un autre monde” di Stéphan Brizés su un dirigente di un gruppo industriale chiamato a fare tagli al personale nel suo stabilimento di provincia, mentre la sua famiglia si sfalda.
Nelle scelte della Giuria della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è però prevalso il tema dell’aborto su quello dell’intima autobiografia di Paolo Sorrentino. Il film “L’Événement” di Audrey Diwan rischiava di andare in prigione. Un film coraggioso certo, ma molto disturbante e per questo non molto apprezzato da tanti. è la cronaca, spesso cruda nella sua visione, di un aborto illegale nella Francia anni ’60 in cui era proibito.
Mentre il film di Paolo Sorrentino poteva mettere d’accordo tutti con il raccontare se stesso, la sua adolescenza, la perdita dei genitori che lo colpisce da ragazzo, la sua passione per Maradona. La Giuria l’ha premiato con il “Leone d’argento” e attribuendo il Premio Mastroianni, come miglior esordiente, al giovane Filippo Scotti rimasto sorpreso e felice tenendo in mano la statuetta, per lui molto pesante.
Una sorpresa è arrivata dal Premio speciale della Giuria a “Il buco” di Michelangelo Frammartino. Film coraggioso, senza veri attori, senza molte parole e girato nella profondità di una grotta, l’abisso del Bifurto nell’entroterra calabra del Pollino, dove gli speleologi hanno fatto da protagonisti nella loro impresa di raggiungere il fondo del sotterraneo. E la loro storia è raccontata in parallelo con quella di un pastore che appare all’inizio quando arrivano gli speleologici, la cui vita si conclude con la realizzazione dell’impresa in fondo alla grotta. E’ un film che “ha la bellezza assoluta del diamante puro” aveva detto Alberto Barbera nell’annunciarlo e non si può che essere d’accordo con lui. “Leone d’argento” al film di Jane Campion “The Power of the Dog” che racconta il vecchio West di uomini macho e Premio per la migliore sceneggiatura a Maggie Gyllenhaal per il film “The lost daughter”, adattamento cinematografico del romanzo di Elena Ferrante “La figlia oscura”. Pedro Almodovar che era partito da favorito si è dovuto accontentare della Coppa Volpi come miglior attrice a Penelope Cruz presente al Lido anche con un altro film). Ma che un premio andasse alla grande attrice era prevedibile. Il suo film, comunque, conferma l’autorialità del regista spagnolo che qui spinge sui temi del destino, della maternità, del desiderio. Il grande sconfitto è il film di Mario Martone “Qui rido io” che almeno poteva essere premiato con la Coppa volpi per il miglior attore a Toni Servillo, ancora una volta strepitoso nella sua interpretazione di Eduardo Scarpetta. Non vederlo premiato à stata una grande delusione. Niente premi anche per “Illusions perdue” di Xavier Giannoli che, traendo spunto dall’omonimo romanzo di Honoré de Balzac, ambientato nella Parigi del diciannovesimo secolo, porta alla riflessione sul ruolo della stampa costruendo una storia, con protagonista un giovane di provincia arrivato a Parigi nella speranza di avere successo, che dovrà scontrarsi con un giornalismo corrotto che risponde soltanto alla legge del vendere e del comprare, dove dominano le fake news. Una situazione che si rispecchia anche oggi.
Una grande Mostra, comunque, con film di grande livello in tutte le Sezioni, che ancora una volta ha sconfitto la pandemia.
Alcuni film che alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia non hanno avuto alcun riconoscimento dalla Giurie Ufficiali sono stati appagati dai Premi Collaterali che da alcuni anni vengono assegnati da organismi associativi ed altre organizzazioni del mondo del cinema. Scorrendo l’elenco si rileva che film premiati come “L’èvénement” di Audrey Diwan, vincitore del “Leone d’Oro” e “E’ stata la mano di Dio” al quale è stato attributo il “Leone d’Argento”.
Ma anche “Il buco” di Michelangelo Frammartino hanno ricevuto il riconoscimento di alcuni Premi collaterali. Quest’ultimo ne ha ricevuto tre e tra essi il “Premio Fedic” che una Giuria, presieduta da Ferruccio Gard, gli ha assegnato con la seguente motivazione: Per una poetica, originale e sorprendente ricerca della bellezza della natura, che quasi prendono il sopravvento sulla figura umana, rievocata con antiche tradizioni pastorali e un’epica impresa speleologica in Calabria, fra coraggio, luce e oscurità, per esplorare l’ignoto nelle profondità della terra ma anche i temi di vita, morte, rinascita, spiritualità e sentimenti”. Ma ad avere la maggiore attenzione è stato il film “Freaks out” di Gabriele Mainetti (Concorso) che è stato premiato da ben 6 organizzazioni. Il regista Gabriele Mainetti, che ha come fonte di ispirazione il celebre “Freaks” di Tod Browing del 1932, racconta una storia di fenomeni da baraccone, costretti a fare i conti con il mondo esterno dopo che il loro circo è stato bombardato dai nazisti. C’è Cencio (Pietro Castellitto) che parla agli insetti, Fulvio (Claudio Santamaria) un uomo-lupo incredibile, Mario (Giancarlo Martini) che è un clown dotato di poteri magnetici e Matilde (Aurora Giovinazzo) che ha un dono devastante e incontrollabile. Un nazista folle capisce che le loro capacità potrebbero sovvertire i destini della guerra e vorrebbe sfruttarli, senza riuscirci, al servizio del Terzo Reich. Una situazione che poteva cambiare i loro destini e il corso della Storia. Tra gli altri film premiati rileviamo che molto apprezzato è stato anche “Amira” dell’egiziano Mohamed Diab, presentato “Fuori Concorso” che racconta di una diciassettenne palestinese concepita in carcere con il seme di un recluso, trafugato dalla prigione. Per la ragazza, anche se il rapporto con il padre si limita alle visite in carcere, egli rimane il suo eroe. La sua assenza è compensata dall’amore e l’affetto di coloro che la circondano. Ma il suo mondo sarà stravolto da una notizia inattesa. Un Premio anche per “La Caja” del messicano Lorenzo Vigas (Concorso) incentrato su un adolescente di Città del Messico in viaggio per recuperare i resti del padre trovati in una fossa comune.
Hollywood è tornata alla grande alla Mostra, oltre che con “Dune” anche con “The Last Duel”, visto “Fuori concorso”, un Kolossal di Ridley Scott in costume dal sapore dell’epica cavalleresca che racconta, basandosi su fatti realmente accaduti, una vicenda ambientata nella Francia del XIV secolo dove una donna ha il coraggio di denunciare il suo aggressore, rivale del marito, e mettendo a repentaglio la sua vita porta avanti la sua battaglia anche se questi respinge l’accusa.
“Leone d’Oro” alla carriera a Roberto Benigni ma anche a Jamie Lee Curtis, figlia di due grandi attori come Tony Curtis e Janet Leigh, attrice che ha reso sempre personaggi credibili che ricordiamo in film come “Un pesce di nome Wanda”, “True Lies”, “Una poltrona per due”, presente alla Mostra con il film “Halloween Kills” di David Gordon Green presentato “Fuori concorso”.
Nelle due Sezioni collaterali, ed autonome, della Mostra sono poi prevalse le seguenti opere. Nella SIC, giunta alla 36. edizione, ha vinto il film “Zalava” di Arsalan Amiri, un film ambientato in un piccolo villaggio chiamato Zalava, dove nel 1978 gli abitanti sono convinti che tra loro conviva un emonio e alla fine danno fuoco alla casa in cui un sergente si trovava con l’amante che era andata ad arrestare poiché la credeva una esorcista. Nelle “Giornate degli Autori”, ha prevalso “Californie” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, un film su una ragazza marocchina sveglia ed esuberante, che vive in un paesino del Sud Italia, alla ricerca di un suo posto nel mondo.
Visionando qua e là ci piace segnalare alcune opere. Innanzitutto “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, presentato “fuori concorso”, incentrato su un carcere in dismissione, situato in una zona impervia d’Italia, dove rimangono una dozzina di detenuti che dovranno convivere con alcuni vigilanti. Il film costituisce una sfida dietro le sbarre, tra chi è dentro e chi è fuori e si trasforma in un patto alla ricerca di umanità. Un film di atmosfera e di tensione, interpretato superbamente da Toni Servillo e Silvio Orlando. “Fuori concorso” anche “Ennio”, un ritratto di Giuseppe Tornatore sul Maestro Ennio Morricone, Ci piace anche segnalare l’Omaggio a Citto Maselli, in occasione dei suoi novant’anni, con una Cerimonia e la proiezione del film, restaurato, “Storie d’amore” che fu presentato alla Mostra nel 1986 e valse la Coppa Volpi a Valeria Golino. Ma anche il documentario di Antonello Sarno “Pietro il Grande”, omaggio al prematuramente scomparso Pietro Coccia, sempre presente nei maggiori Festival, tra cui Venezia, ad immortalarne personaggi e momenti importanti.
La FEDIC anche nel 2021 è stata presente alla Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia con le iniziative del Premio e del Forum FEDIC. Come per gli anni passati (il Premio Fedic è nato su mia iniziativa nel 1993) le scelte della Giuria del Premio collaterale FEDIC riguardano il Cinema italiano.
La Giuria del Premio FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), giunto alla 29° edizione, era composta da critici cinematografici ed operatori culturali dell’Associazionismo Cinematografico ed era presieduta da Ferruccio Gard( critico cinematografico ed ex inviato Rai alla Mostra del Cinema) e composta, inoltre, da Ugo Baistrocchi( critico cinematografico), Alfredo Baldi( critico e storico del cinema), Carlotta Bruschi (script supervisor), Massimo Caminiti (presidente CINIT), Giuliano Gallini(scrittore), Carlo Gentile( critico cinematografico), Massimo Giraldi( critico cinematografico), Chiara Levorato( docente universitario) , Franco Mariotti( critico cinematografico), Paolo Micalizzi( critico e storico del cinema), Elisabetta Randaccio(delegata internazionale FICC) , Lilia Ricci( segretario generale Associazione Amarcord) e Giancarlo Zappoli( critico cinematografico e presidente CSC). Ha attribuito il Premio FEDIC destinato “all’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore”è stato attribuito al film “Il Buco” di Michelangelo Frammartino (Venezia 78) “Per una poetica, originale e sorprendente ricerca delle bellezze della natura, che quasi prendono il sopravvento sulla figura umana, rievocata con antiche tradizioni pastorali e un’epica impresa speleologica in Calabria fra coraggio, luce e oscurità, per esplorare l’ignoto nelle profondità della terra ma anche i temi di vita, morte, rinascita, spiritualità e sentimenti”.
La Giuria ha assegnato inoltre una Menzione speciale FEDIC al Film “La ragazza ha volato” di Wilma Labate (Orizzonti extra) “Per aver saputo approfondire, con toccante sensibilità e crudo realismo, il drammatico percorso di formazione di una adolescente, chiamata alla scelta se sopravvivere, dopo uno stupro, dimenticando odio e violenza per compiere un volo verso il futuro e l’amore materno.”
Inoltre, una Giuria presieduta da Alfredo Baldi(critico cinematografico, ex dirigente CSC e membro del Comitato Scientifico FEDIC) e composta da Tommaso Calabri(Allievo Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini), Laura Forcella Iascone( Cineclub Kinema Brescia e referente Progetto SicComeDante), Orazio Leotta(Direttivo Cinit), Enrico Rontini(Allievo Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini), Antonella Santarelli(Presidente Saturnia Film Festival), Massimo Spiga( FICC-Federazione Italiana Circoli del Cinema), ha attribuito una Menzione speciale FEDIC per il miglior cortometraggio a “Notte romana” di Valerio Ferrara (Sic & Sic) “Per la capacità di narrare un presunta storia di amore estivo tra un ragazzo ed una ragazza di classi sociali molte diverse che tuttavia non si svela pienamente e ci lascia in una situazione di sospensione e di invito a interrogarci”.
I Premi sono stati consegnati sabato 11 settembre presso lo Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo (Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior/Lido di Venezia).

Messaggi dei registi premiati
MICHELANGELO FRAMMARTINO
“I cineforum sono un’oasi di protezione e salvaguardia dell’immagine nella contemporaneità, dove le sale sono piuttosto diventate dei fast-food, per il consumo vorace di immagini dei film in corso di “uscita”. I cineforum svolgono una funzione importantissima da sempre e ancora di più negli ultimi decenni. Grazie a loro, possono rimanere in vita film delle stagioni precedenti o di un passato più lontano, e tutto il cinema libero e indipendente.
Devo ai cineforum se ho potuto vedere tutti i film che mi hanno formato, durante gli anni ’90. Sono luoghi che ti permettono di arrivare in sala ben prima della proiezione, di gustare la sacralità dell’evento, e poi anche dopo la fine, di restare, per lasciarsi attraversare dentro dall’eco della visione. Come quando vidi “Viaggio in Italia”, e dopo aver goduto dei meravigliosi tempi di Rossellini, ho potuto rimanere sbigottito in sala ad assaporare quelle durate. Perché i cineforum sono luoghi pensati anche per accogliere la reazione di uno spettatore, per permettergli di metabolizzare, senza dover scappare subito dopo aver consumato. Questa mia gratitudine mi rende particolarmente caro il premio di oggi, che mi lega ancora più intimamente al lavoro sotterraneo dei cineforum”.
WILMA LABATE
Nei cineclub ci sono cresciuta, è lì che ho maturato il desiderio di fare cinema, la voglia di andare avanti contro ogni ragione: tanti anni fa e per una donna poi… Quelle sale fané sono state la mia scuola, mi piaceva quell’odore di chiuso, quelle nuvole di fumo che tagliavano a metà lo schermo e si mescolavano al b/n della pellicola, quel parlarsi a voce alta con un vicino sconosciuto: “bella sequenza” senza rispettare la ritualità solo per nutrire il pensiero.
Me la porto ancora dentro quell’esperienza, meglio, quella sapienza e spesso oso pensare che prima o poi ci sarà un ritorno a frequentare assiduamente la sala, luogo di felicità e cura, con un biglietto dal prezzo umano e un pubblico scomposto che urla in favore degli indiani. Ma si sa, noi cineasti siamo sognatori.
Dopo due anni del Premio Fedic è nato il Forum Fedic. A partire dal 1995, quindi, di anno in anno è stato affrontato un argomento che ne mettesse in evidenza aspetti significativi per “Il futuro del cortometraggio”. Nei primi due anni si è messa in evidenza “La politica culturale della Fedic e il suo impegno nel cortometraggio” con una relazione introduttiva dell’allora Presidente Massimo Maisetti, e nel secondo anno si è iniziato a parlare delle varie problematiche del Corto. Infatti, Claudio Zanchi, allora Presidente FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) trattò il tema “Il corto e le leggi del cinema” e l’anno successivo “Il corto nelle sale”. Nel 1998 la Fedic, attraverso una relazione del suo Presidente Massimo Maisetti ha affrontato il tema della situazione del Cortometraggio lanciando l’idea di pensare a “Progetti operativi per un mercato cinematografico e televisivo” e chiamai a trattare “I corti in TV: da “Tema” a “Infinito futuro”, un esperto di vaglia come Italo Moscati. Nel 1999, chi scrive ha relazionato sui risultati di “Gli Stati generali del cortometraggio”, un Convegno che aveva realizzato alla Mostra del Cinema di Montecatini Terme alla quale avevano preso parte, tra gli altri, Massimo Maisetti (Presidente Fedic), Anna Di Martino (critico cinematografico), Giorgio Gosetti (Direttore Italia Cinema), Claudio Bertieri ed Ernesto G. Laura (Direttori di FilmVideo).
Nel 2000 Massimo Maisetti ha posto la questione di “Quando, come e dove vedere il Cortometraggio?” e, chi scrive ha riferito sul Convegno che aveva organizzato al “Valdarno Cinema Fedic”, dove era Direttore artistico, sugli “Scenari per la diffusione del Corto “chiamando ad intervenire sull’argomento Felice Laudadio (Presidente Cinecittà Holding”) , Domenico Dinoia (Presidente Fice), Italo Moscati (Rai Sat Cinema), Roberto Nepoti(autore del libro “Fronte del Corto”, Giovanni Marco Piemontese(Web Italia Cinema). Sono gli inizi di un dibattito nazionale sul Corto che poi è continuato affrontando altri argomenti sul valore del cinema indipendente e la possibilità di vedere il cortometraggio in Sala, anche se non realizzato in 35 millimetri convinti di una sua validità per una cultura sociale e politica ma anche per l’ambiente lanciando anche l’idea di un’apposita Cineteca per il Corto, lanciando anche l’idea di promuovere il corto nelle Università e nelle Scuola valutando la sua validità nell’attività didattica.
Per passare poi ad affrontare il tema del Corto nella Scuola ed il suo impegno per l’educazione all’immagine, la circuitazione nelle Sale dell’Associazionismo a partire dalla Ficc, a valutare il rapporto con i Media e con la produzione e la distribuzione e l’essere filmmaker nell’era digitale. Tutti argomenti che hanno dato un contributo all’evoluzione del Cortometraggio sino ad avere oggi una maggiore attenzione nella sua diffusione.
Quella della Fedic, come ha evidenziato il sottoscritto in una sua relazione, è stata una lunga storia di Autori-produttori ed in tal senso si è posta l’attenzione ad Autori del passato ma anche a quelli del presente proiettando le loro opere al Forum. E tanti sono gli autori in attività (già noti o esordienti) come è possibile rilevare dai Trailer che di anno in anno vengono presentati. Derivando ciò anche dalla formazione che la Fedic attua, così come messa in rilievo dagli interventi dell’attuale Presidente Fedic Lorenzo Caravello.
Al Forum Fedic 2021 ha porto il saluto dell’ANAC il suo Presidente Francesco Ranieri Martinotti, che ha anche riferito sulle attività dell’Associazione Nazionale Autori Cinematografici dichiarando che essa è aperta anche ai giovani autori e augurandosi che dalle iniziative Fedic possano nascere nuovi talenti per il Cinema Italiano.
AL FEMMINILE LA 69° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN
di Alessandra Pighi, Xoxan Villanueva
Donne, registe, attrici, produttrici…… Ecco le principali protagoniste della 69a edizione del Festival di San Sebastián, tenutosi dal 17 al 25 settembre 2021. La giuria, presieduta da Dea Kulumbegashvili, vincitrice della precedente edizione e formata tra gli altri, da Audrey Diwan, Leone d’Oro a Venezia per “L’Événement”, ha assegnato la Conchiglia d’Oro al film rumeno, “Blue Moon”, prodotto da Gabriela Suciu. Un premio che ha suscitato perplessità da parte della critica presente all’evento. Il film di Alina Grigore, quinta donna nella storia del festival ad ottenere l’ambito riconoscimento, è una storia di violenza fisica e verbale in famiglia, che mira a rivendicare la libertà individuale delle donne, a liberarsi da ruoli precostituiti in una società patriarcale e maschilista che le mantiene sottomesse.
Le emozioni di un’adolescente che sogna di uscire dal seno di famiglia e ottenere una certa indipendenza accedendo a un’istruzione in una città vicina è l’argomento trattato in “As in heaven” della danese Tea Lindeburg, ambientato nella Danimarca rurale alla fine del XIX secolo. Il film ha ottenuto due grandi riconoscimenti ufficiali: Miglior Regia e Miglior Protagonista per Flora Ofelia Hofman, ex-aequo con l’attrice americana, Jessica Chastain, per la sua magnifica interpretazione in “The Eyes of Tammy Faye”. La pellicola narra l’ascesa mediatica della tele predicatrice evangelista Tammy Faye e del marito negli Stati Uniti degli anni Ottanta, conclusasi poi in uno scandalo per la corruzione rilevata nella gestione dei fondi raccolti attraverso il loro canale televisivo.
Va notato che il Festival ha eliminato i premi d’interpretazione di genere che sono stati riuniti in un’unica categoria, come hanno già fatto, ad esempio, a Berlino e Mar de Plata. San Sebastián è il terzo grande festival ad adottare questa visione e sembra logico che se si accetta l’uguaglianza di genere senza la distinzione tra premi per regista, sceneggiatore o produttore, non ci sia nemmeno distinzione tra attore e attrice.
Il Premio Speciale della Giuria, considerato il secondo per importanza, è andato all’eccentrico e controverso “Earwig” della regista francese Lucile Hadzihalilovic. Racconta la favola di una ragazza con i denti di ghiaccio, indifesa e intrappolata in un labirinto dal quale è difficile uscire.
Il premio per la Miglior Fotografia, ulteriore protagonista femminile, è stato aggiudicato a Claire Mathon, celebre camerawoman francese per “Enquête sur un scandale d’étatù”. Un film intrigante che, attraverso un infiltrato e un giornalista, indaga e denuncia le grandi reti europee di narcotraffico, in collusione con le forze di polizia francesi di alto rango.
Al film di Jonás Trueba, “Quièn lo impide”, è stata assegnata la nuova Conchiglia d’Argento per la Migliore Interpretazione Non Protagonista. Si tratta di un lungometraggio originale che presenta un coraggioso ritratto dell’adolescenza spagnola contemporanea. Il premio è stato assegnato al cast di giovani attori e attrici studenti partecipanti.
Il premio per la Miglior Sceneggiatura è stato vinto dal regista britannico, Terence Davis, con “Benediction”, una canzone d’amore sull’esistenza disillusa del poeta omosessuale britannico Siegfried Sassoon.
Da segnalare tra i film della sezione ufficiale, l’ultima opera di Zhang Yimou “Yi Miao Zhong”, “Arthur Rambo”, di Laurent Cantet, e “Vous Ne Dèsirez Que Moi” di Claire Simon, basato sulla scrittrice francese Marguerite Duras.
La presenza femminile si è fatta spazio anche nelle altre sezioni parallele del festival, come la multi-premiata “Noche de fuego” di Tatiana Huezo, vincitrice nella sezione Horizontes Latinos. Un film ambientato nella regione messicana di Guerrero, dove una bambina di nove anni cerca di non soccombere alla spirale di terrore creata dai narcotrafficanti e dai paramilitari. Una storia di sopravvivenza per fuggire da un circolo di terrore che interessa le donne del paese, siano esse ragazze, adolescenti o adulte.
Nella sezione Zabaltegi, dedicata alle proposte d’avanguardia, il premio è andato a “Vortex”, del franco-argentino Gaspar Noé. Il film, che ha partecipato a Cannes, racconta la storia di una coppia di anziani gravemente malati che sopravvivono come possono nel loro appartamento parigino. Protagonismo femminile anche nella sezione Nuovi Registi, con il trionfo del film russo “Nich’ya”, di Lena Lanskih. E’ la storia di un’adolescente che sostiene di essere stata messa incinta dal fratellastro. Descrive la sua disperazione ed il rifiuto della propria immagine e della realtà di una società patriarcale che le impedisce di decidere per se stessa.
Ricordiamo infine il premio assegnato all’interessante lungometraggi “Petite Maman” di Céline Sciamma, che ha vinto il Premio del Pubblico battendo proposte firmate da registi affermati come Wes Anderson “The French Dispatch”, Paul Verhoeven “Benedetta” o il nostro Paolo Sorrentino “La Mano di Dio”.
Premio Donostia a Marion Cotillard e Johnny Depp
L’attrice francese Marion Cotillard ha ricevuto uno dei due Premi Donostia assegnati dal festival in questa edizione come riconoscimento della sua lunga carriera professionale. Successi come l’Oscar ottenuto per la sua interpretazione di Édith Piaf nel film “La Môme” (2007), Nell’ambito della cerimonia l’attrice francese ha debuttato come produttrice di un documentario, “Bigger Than Us”, che segue diversi giovani attivisti che si battono contro il cambiamento climatico, la crisi migratoria, i diritti umani, la libertà di espressione, la giustizia sociale e l’accesso all’istruzione o al cibo.
Johnny Depp ha vinto l’altro Premio Donostia. Non sono mancate polemiche provenienti da diverse organizzazioni femministe, visto il coinvolgimento dell’attore in una lunga battaglia legale con la sua ex moglie, Amber Heard, che lo accusa di maltrattamenti. Il festival ha voluto riconoscere con questo premio onorario, l’attore, regista e produttore, per la sua carriera professionale, con film emblematici come “Edward scissorhands”, “Dead Man” o “Donnie Brasco”, tra gli altri.
Infine, possiamo dire che è stata un’edizione onesta e stimolante, con tanti film e temi, in alcuni casi inaspettati e controversi. Un certo glamour ritrovato, come se la pandemia si fosse lasciata alle spalle. Speriamo per il prossimo anno alla sua 70° edizione.
PREMI, ANTEPRIME, CONVEGNIO AGLI INCONTRI DEL CINEMA D’ESSAI DI MANTOVA
di Paolo Micalizzi
Un ricco programma quello svoltosi a Mantova negli Incontri del Cinema d’Essai. Prima della cerimonia di premiazione, tanti gli appuntamenti cinematografici in cui sono stati proiettati in Anteprima alcuni film prima di vedere la luce nelle Sale cinematografiche. E per questo le “Giornate” li hanno mostrati ai numerosi esercenti convenuti a Mantova. Tra essi “Il bambino nascosto” di Roberto Andò ambientato nel mondo della mafia, “A Chiara” di Jonas Carpignano, un film su un quindicenne che scopre all’improvviso che la propria famiglia è coinvolta con la ‘drangheta e che suo padre è immischiato in un traffico di stupefacenti al servizio di un boss locale. Ma anche, per quanto riguarda l’Italia, “Il Paradiso del pavone” di Laura Bispuri incentrato su una famiglia allargata che si riunisce in occasione del compleanno della nonna, che è interpretata da Dominique Sanda, la Micol di “Il giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica; “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, film sull’assurdità del carcere interpretato intensamente da Silvio Orlando e Toni Servillo.
Spagnolo è poi “Competencia oficial” di Mariano Cohen e Gaston Duprat, film che è valso a Penelope Cruz la Coppa Volpi come miglior attrice all’ultima Mostra di Venezia, ma anche “Un autre monde” di Stéphane Brizé sul mondo dei “tagliatori di teste” visto da un manager.
Cineclub Internazionale ha presentato, alla presenza del regista Vincenzo Lauria, il film “Verso la notte” incentrato su due giovani filmmaker iraniani che si incontrano per girare un documentario su una donna senza fissa dimora. E la Cineteca di Bologna ha rimesso in circolazione, restaurato, il film di Jean-Luc Godard “Fino all’ultimo respiro” (1960) che diede l’avvio alla nouvelle-vague, e quello di Mario Fantin “Italia K2” del 1954, oggi riproposto nelle Sale italiane.
Di grande interesse è stato poi il Convegno dal titolo “Che ne sarà di noi – Cosa cambia per il cinema di qualità”, moderato da Piera Detassis. Un confronto tra esercenti, distributori e istituzioni sull’evoluzione del settore. In esso, il presidente Fice Domenico Dinoia ha chiesto, a nome dell’esercizio di qualità, un aumento dei fondi per le sale d’essai e la velocizzazione dei tempi per la determinazione della qualifica d’essai dei film da parte del Ministero. E sulla velocizzazione dei processi di assegnazione dei contributi è intervenuto, via video, anche Nicola Borrelli (Direttore Generale Cinema e Audiovisivo) che ha sottolineato che occorre assolutamente semplificare poiché oggi sono troppo farraginosi ed antiquati.
Altri interventi hanno ribadito la centralità della Sala nel sostegno del cinema di qualità. E Richard Borg (Universal Pictures) ha lanciato la sfida che il cinema di qualità ha tutte le carte in regola per crescere, “Si deve però assolutamente, ha sostenuto, cancellare la percezione di ‘nicchia’ che lo spettatore comune ha di questo segmento”, concludendo che i film di qualità hanno un pubblico potenziale di gran lunga più ampio. Da qui l’invito a tutti, dai distributori agli esercenti, di lavorare per cancellare l’idea che il cinema di qualità sia per pochi, di nicchia appunto. Ed ha anche espresso l’idea che per i film d’autore, la promozione deve partire in anticipo così come fanno le major per i film commerciali, onde costruire l’attesa dell’uscita in Sala.
Nove i premi 2021 che la FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) ha consegnato nei giorni scorsi agli ormai tradizionali Incontri del Cinema d’Essai di Mantova. I più popolari sono Alba Rohrwacher e Silvio di film di Moretti, Bellocchio, Costanzo, Guadagnino, Avati, Mazzacurati, Genovese ed altri ancora e, per ultimo , Laura Bispuri che agli “Incontri” di Mantova ha presentato il suo “Il paradiso del pavone” ed è stata premiata perché il suo è “uno sguardo personalissimo sul ruolo della donna nella società, su nuclei familiari che si scrollano di dosso ruoli prestabiliti o da cui allontanarsi, con una originalità di visione apprezzata in tanti festival di tutto il mondo”. Silvio Orlando è un attore partenopeo che ha legato il proprio nome ad autori come Moretti, Mazzacurati, Luchetti, Salvatores, Piccioni , Greco, Virzì e che a Mantova lo si è visto in “Il bambino nascosto” di Roberto Andò ed “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo , entrambi presentati anche alla recente Mostra di Venezia, che è anch’esso un autore premiato agli “Incontri di Mantova” perché è “uno dei film più intensi ed apprezzati al Festival di Venezia grazie alle riprese geometriche di un carcere in dismissione ed a una costruzione narrativa ineccepibile con l’apporto di Silvio Orlando e Toni Servillo in stato di grazia”. Premiato anche Paolo Pierobon, attore teatrale, presente a Mantova con “Io sono vera” di Beniamino Catena che alla Mostra di Venezia è stato visto in tre film (“Il cattivo poeta”, “Qui rido io” e “Welcome Venice”) ma ha lavorato anche con Claudio Cupellini, Marina Spada e Marco Bellocchio. Ma anche il regista Mauro Mancini che ha esordito alla Mostra di Venezia nel 2020 con il film “Non odiare”, “potente confronto tra un medico ebreo e un nucleo familiare intriso di intolleranza e antisemitismo, con una convincente ambientazione triestina”. Premiata anche l’attrice Barbara Ronchi, interprete del recente “Mondo cane” di Alessandro Celli e “Cosa sarà” di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart. Premiata anche la sceneggiatrice Valia Santella, artista versatile che ha attraversato il miglior cinema italiano degli ultimi anni: Bellocchio, Moretti, Golino, Ozpetek, Di Costanzo e regista di “Te lo leggo negli occhi” con Stefania Sandrelli. Infine, Michele Attanasio, un direttore della fotografia molto versatile per le collaborazioni a film d’autore come di genere: tra essi, “Tre piani”, “Freaks out”, “Lo chiamavano Jeeg Robot”: attualmente è al lavoro in “Caravaggio” di Michele Placido e nel nuovo film di Giuseppe Piccioni. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Bibiena condotta dall’estroso giornalista Maurizio Di Rienzo.
PROFILO
DAL “PICCOLO TEATRO” AL GRANDE SCHERMO: IL CINEMA DI RENATO DE CARMINE
di Mario Giunco
Renato De Carmine (Roma, 23 febbraio 1923 – 18 luglio 2010) è stato attivo nel teatro, dalla metà del secolo scorso, nella prosa radiofonica, in televisione e nel cinema. Dopo la laurea in Giurisprudenza frequenta, nel biennio 1944/45, l’Accademia nazionale d’arte drammatica e i corsi del Centro sperimentale di cinematografia. Nel 1948, appena diplomato, esordisce nel cinema in “Fantasmi del mare” di Francesco De Robertis e in teatro con “O di uno o di nessuno” di Pirandello, con lo Stabile di Napoli. Nel 1952 debutta in tv con “Meridiano spagnolo. Vita e opere di Federico Garcia Lorca”, regia di Alessandro Bissoni. E’ tra i pochi a credere nel nuovo mezzo di comunicazione. Il 3 gennaio 1954 partecipa al primo adattamento di un classico del teatro, “L’osteria della posta” di Carlo Goldoni. Il suo volto diviene noto, grazie ai ruoli in “Piccole donne” di L.M. Alcott, regia di Anton Giulio Majano (1955), “Piccolo mondo antico” di A. Fogazzaro, regia di Silverio Blasi (1957), “La bisbetica domata” di Shakespeare, regia di Daniele D’Anza (1958), “Il costruttore Sollness” di H. Ibsen, regia di Mario Ferrero (1960). Nel 1961 è scritturato da Giorgio Strehler. Sul palcoscenico del “Piccolo Teatro” è fra i protagonisti di allestimenti memorabili, tra cui “I giganti della montagna” di Pirandello, “Il giardino dei ciliegi” di A. Cechov, “L’anima buona di Sezuan” e “Vita di Galileo” di B. Brecht, “Re Lear” di Shakespeare, “La grande magia” di Eduardo. In tv appare in alcuni episodi della serie di Nero Wolf (accanto a Tino Buazzelli), nel serial “La valle dei pioppi”, in “La Piovra 7”, “Linda e il brigadiere”, con Nino Manfredi e Claudia Koll, “La donna del treno” e “Le ali della vita 2”.
Non numerose e quasi tutte in ruoli secondari le apparizioni di Renato De Carmine sul grande schermo. Dal 1948 al 2009 – con una interruzione dal 1974 al 1987 – ha recitato in ventotto lungometraggi e due corti. Ha prestato la sua voce a Rod Taylor. Prediligeva ruoli “eroici” o “tragici”, i classici e i melodrammi. Poco apprezzava parodie, regie “attualizzanti” o “stravolgimenti” di testi di tradizione consolidata. Per questi motivi dissentiva da Luciano Odorisio (“La monaca di Monza”) e da Giovanni Veronesi (“Per amore, solo per amore”). E’ stato diretto in due film da un solo regista (Bernard Borderie) e, oltre ai citati, tra gli altri da Giorgio Pàstina, Carlo Campogalliani, Fernando Cerchio, Vittorio Cottafavi, Guido Salvini, Giacomo Gentilomo, Bruno Vailati, dai fratelli Taviani, Lucio Fulci, Ettore Scola e dal novantaduenne Manoel de Oliveira. Ha lavorato con molti attori, quasi tutti provenienti dal teatro, tra cui Gino Cervi, Gabriele Ferzetti, Lina Volonghi, Rossano Brazzi, Michel Simon, Massimo Serato, Valentina Cortese, Paolo Stoppa, Tino Buazzelli, Elena Zareschi, Umberto Orsini, Roger Moore, Aroldo Tieri, Memmo Carotenuto, Mel Ferrer, James Mason, Alberto Lupo, Enrico Montesano, Alighiero Noschese, Lino Banfi, Mariangela Melato, Marisa Fabbri, Michele Placido, Marcello Mastroianni, Lea Massari, Mimsy Farmer, Laura Betti, Stefano Satta Flores, Bruno Cirino, Franco Nero, Virna Lisi, Pina Cei, Franco Fabrizi, Philippe Leroy, Elio Pandolfi, Diego Abatantuono, Penelope Cruz, Stefania Sandrelli, Alessandro Haber, Mariangela D’Abbraccio, Alberto Sordi, Mario Carotenuto, Giancarlo Giannini, Andrea Jonasson. La sorte ha voluto che il suo ultimo film (“Il nostro Messia” di Claudio Serughetti) fosse ambientato proprio fra aspiranti star. Credeva di non aver dato al cinema quanto era nelle sue possibilità. Si riteneva quasi trascurato. Era stato allontanato dalla Rai per motivi “misteriosi”, nonostante avesse inaugurato le trasmissioni televisive nel 1952. Fra i film interpretati preferiva il lungometraggio d’esordio, “Fantasmi del mare” di Francesco De Robertis e il corto “30 Febbraio” di Sergio Basso: un commiato in perfetto stile cechoviano.
FILMOGRAFIA
FANTASMI DEL MARE – ROTTA SUD (1948)
Regia: Francesco De Robertis (1902-1959). Soggetto e sceneggiatura: Nicola Morabito, Francesco De Robertis, Sergio Pàstina. Fotografia: Carlo Bellero. Montaggio: Francesco De Robertis. Musiche: Mario Nascimbene.
Interpreti e personaggi: Raf Pindi (capo Arena), Nicola Morabito (comandante), Anna Arena (proprietaria della stireria), Gaby Sylvia (moglie del Comandante), Umberto Raho (sottocapo Luigi Serra), Renato De Carmine (Stanislao Kopovich), Raoul Grassilli, Umberto Orsini.
Trama: Un sottufficiale della Marina Militare, custode di una nave in disarmo, rievoca un episodio della Seconda guerra mondiale, accaduto dopo l’8 settembre 1943. A bordo della nave, nella quale è imbarcato anche il figlio del comandante, prende una drammatica decisione riguardante le sorti dell’equipaggio.
Note: Renato De Carmine interpreta il ruolo di un eroico marinaio, che pur essendo malato, finge di star bene per continuare a combattere. Secondo i critici, il montaggio serrato, l’uso espressivo dei primi piani, il disegno preciso delle singole psicologie e i dialoghi ineccepibili suppliscono alla povertà dei mezzi e tengono desta l’attenzione dello spettatore.
GUGLIELMO TELL – L’ARCIERE DELLA FORESTA NERA (1948)
Regia: Giorgio Pàstina. Sceneggiatura: Giorgio Pàstina, Giuseppe Zucca (dal dramma di F. Schiller). Fotografia: Arturo Gallea. Musiche: Gioachino Rossini.
Interpreti e personaggi: Gino Cervi (Guglielmo Tell), Paul Muller (Gessler), Aldo Nicodemi (Rudens), Danielle Benson (Edvige), Allegra Sander (Mathilde), Gabriele Ferzetti (Corrado Hunt), Renato De Carmine (Bertrand).
Trama: L’arciere Guglielmo Tell si ribella al rappresentante dell’imperatore d’Austria. Dopo la prova, in cui colpisce con una freccia la mela sul capo del figlio del governatore, fugge dal carcere e raduna un gruppo di villici, con cui riesce ad ottenere la libertà per il popolo svizzero.
Note: Giorgio Pàstina, che nel dopoguerra diresse sedici film, si dimostra un ottimo artigiano, attento al mutamento dei gusti del pubblico.
LA MANO DELLA MORTA (1949)
Regia: Carlo Campogalliani (1885-1974). Sceneggiatura: Carlo Campogalliani, Paola Ojetti, Vittorio Nino Novarese (dal romanzo di Carolina Invernizio). Fotografia: Tonino Delli Colli, Romolo Garroni. Musiche: Giovanni Fusco.
Interpreti e personaggi: Maria Martin (Satanella), Adriano Rimoldi (Orazio Altieri), Carlo Ninchi (Simone Bossi), Renato De Carmine (Flavio Altieri), Saro Urzì (Marco, lo zingaro), Lina Volonghi (Carmela), Raf Pindi (Schultz, l’usuraio).
Trama: Uno zingaro salva una bambina da un incendio doloso, nel corso del quale muore la madre. La piccola, chiamata Satanella, diviene una famosa danzatrice. Scopre l’assassino della madre, il conte Altieri e si vendica su di lui, coinvolgendo il figlio Flavio.
Note: Per A. Albertazzi (“Intermezzo, n. 18 del 30 settembre 1949) “La mano della morta” è un decoroso prodotto d’evasione. rientrante nel filone del “realismo d’appendice”.
GENTE COSI’ (1949)
Regia: Fernando Cerchio (1914-1974). Soggetto e sceneggiatura: Giancarlo Vigorelli, Leonardo Benvenuti, Giovannino Guareschi, Fernando Cerchio, Giorgio Venturini. Fotografia: Arturo Gallea. Montaggio: Rolando Benedetti. Musiche: Giovanni Fusco. Scenografia: Mario Grazzini, Ernesto Nelli.
Interpreti e personaggi: Adriano Rinaldi (Gian, il contrabbandiere), Vivi Gioi (Teresa,la maestrina), Camillo Pilotto (don Candido, l’arciprete), Renato De Carmine (il biondino), Marisa Mari (la biondina), Saro Urzì (il sindaco Giusà).
Trama: In un paesino dell’alta Lombardia, ai confini con la Svizzera, la nuova maestra elementare entra in contrasto con la mentalità degli abitanti. Si innamora di un contrabbandiere, che, inseguito dalle Guardie di Finanza, precipita in un burrone. Il parroco lo unirà in matrimonio con la donna, rimasta incinta.
Note: Per C. Rossi (“Hollywood”, n. 235/1950) Guareschi e Cerchio non hanno trovato un’intima forza di convinzione e la regia è incostante.
CAPITAN DEMONIO (1949)
Regia: Carlo Borghesio (1905-1983). Soggetto e sceneggiatura: Luigi Bonelli, Carlo Borghesio, Paola Ojetti. Fotografia: Arturo Gallea. Montaggio: Rolando Benedetti. Musiche: Mario Nascimbene. Interpreti e personaggi: Adriano Rinaldi (Capitan Demonio), Maria Martin (ballerina), Otello Toso, Beniamino Maggio, Jole Fierro, Renato De Carmine, Carlo Ninchi, Nella Bartoli.
Trama: Nel 1700, a Firenze, Capitan Demonio salva dalle insidie del Bargello una ballerina, di cui si innamora.
Note: Secondo F. Garbella (“Intermezzo”, n. 9/10 del 21 maggio 1951) l’interprete principale, Adriano Rinaldi, tende a strafare e stona. Nel film ha una parte Nella Bartoli, moglie di Renato De Carmine.
IL BOIA DI LILLA (1952)
Regia: Vittorio Cottafavi (1914-1998).Soggetto: Alexandre Dumas padre. Sceneggiatura: Siro Angeli, Giorgio Capitani, Vittorio Cottafavi. Fotografia: Massimo Dallamano. Musiche: Renzo Rossellini. Scenografia: Giancarlo Bartolini Salimbeni. Costumi: Ruggero Peruzzi.
Interpreti e personaggi: Rossano Brazzi (Conte di La Fère), Yvette Lebon (Anna), Armando Francioli (Erberto), Maria Grazia Francia (Gisella), Jean-Roger Caussimon (mastro Pietro, boia), Nerio Bernardi (Porthos), Massimo Serato (Rochefort), Franco Balducci, Vittorio Sanipoli, Raymond Cordy, Renato De Carmine, Nico Pepe.
Trama: Le avventure di Anna de Breuil (Milady de Winter), nemica dei tre moschettieri, donna crudele dal passato oscuro.
Note: Secondo S. Nati (“Intermezzo”, n. 11 e 12 del 30 giugno 1953) il film non si solleva dalla mediocrità, nonostante l’impegno degli interpreti.
IL MERCANTE DI VENEZIA (1953)
Regia: Pierre Billon (1901-1981). Sceneggiatura: Pierre Billon, Louis Ducreux, Cesare Ludovici, Giuseppe Mangione, Corrado Sofia, Federico Zardi (da Shakespeare). Musiche: Giovanni Fusco. Fotografia: Arturo Gallea.
Interpreti e personaggi: Michel Simon (Shylock), Andrée Débar (Porzia), Massimo Serato (Antonio), Armando Francioli (Bassanio), Giorgio Albertazzi (Lorenzo), Renato De Carmine, Gualtiero Tumiati.
Trama: Antonio, ricco armatore veneziano, chiede in prestito per l’amico Bassanio una somma di denaro all’ebreo Shylock, che gliela concede a condizione che, in caso di inadempienza, gli sia tagliata una libbra di carne dal corpo. La questione si conclude davanti alla Corte di Giustizia, con scorno del creditore.
Note: “La realizzazione è mediocre e l’interpretazione risulta fredda e manierata” (S. Nati, “Intermezzo”, n. 13/14/15 di luglio/agosto 1953).
IL CONTE AQUILA (1953)
Regia: Guido Salvini (1893-1965). Soggetto: Rino Alessi. Sceneggiatura: Guido Salvini, Giuseppe Di Martino. Fotografia: Anchise Brizzi. Montaggio: Dolores Tamburini. Musiche: Bruno Nicolai. Scenografia e costumi: Pier Luigi Pizzi.
Interpreti e personaggi: Rossano Brazzi (conte Federico Confalonieri), Valentina Cortese (Teresa Casati), Paolo Stoppa (Metternich), Leonardo Cortese (Gabrio Casati), Paolo Ferrari (Vitaliano Confalonieri), Elena Zareschi (imperatrice d’Austria), Tino Buazzelli (giudice Menghin), Renato De Carmine, Anna Miserocchi, Silvano Tranquilli.
Trama: Nel 1821 il conte Federico Confalonieri, che prepara un’insurrezione nel Lombardo Veneto, è arrestato dalla polizia austriaca. Il giudice istruttore Menghin, sperando di avere notizie utili, racconta alla moglie di Confalonieri, Teresa Casati, le numerose infedeltà del marito. La donna chiede all’imperatrice la grazia per lui, condannato alla pena capitale. Il conte è rinchiuso nel carcere dello Spielberg.
Note: Il film, nonostante l’impiego di attori di richiamo, di scenografia, costumi e commento musicale adeguati, non ottiene grandi consensi.
UN BRANCO DI VIGLIACCHI (1962)
Regia: Fabrizio Taglioni (1913). Sceneggiatura: Fabrizio Taglioni, Giuliano Carnimeo. Fotografia: Aldo Giordani. Montaggio: Mario Serandrei. Musiche: Aldo Piga.
Interpreti e personaggi: Roger Moore (Enzo Prati), Pascale Petit (Giuditta), Aroldo Tieri (Tassoni), Frank Villard (De Rossi), Luisa Mattioli (Germana), Renato De Carmine (Parenti), Memmo Carotenuto (l’autista), Aldo Bufi Landi (Micheli), Carl Schell (ufficiale tedesco).
Trama: Durante l’ultima guerra, un gruppo di civili è preso prigioniero dai tedeschi. Per lasciarli liberi Il comandante della pattuglia chiede in cambio la giovane Giuditta, che si rassegna a subire la violenza. Arrivano le avanguardie americane e il “branco” – ad eccezione di Parenti (Renato De Carmine) – fornisce una versione totalmente falsa dell’accaduto: loro si sarebbero comportati da eroi, mentre la giovane avrebbe voluto disonorarsi.
Note: Il film ha partecipato al Festival di Mosca del 1963, dove ha vinto il premio come migliore opera straniera. Ha ottenuto un riconoscimento anche al Festival di Vichy per il “complesso interpretativo”. Al critico anonimo di “Nuovo spettatore cinematografico” (agosto 1962) sembra una “polpetta resistenziale, ispirata liberamente al racconto ‘Boule de suif’ di Maupassant”.
I LANCIERI NERI (1962)
Regia: Giacomo Gentilomo (1909-2001). Sceneggiatura: Luciano Martino, Ernesto Gastaldi, Ottavio Alessi, Ugo Guerra. Musiche: Mario Nascimbene.
Interpreti: Yvonne Furneaux (Jassa), Mel Ferrer (Andrea), Leticia Romàn (Mascia), Nando Tamberlani (Principe Stefano), Annibale Ninchi (Principe Nikiev), Franco Silva (Gamul), Mirko Ellis, Arturo Dominici, Claudio Bava, Umberto Raho, Renato De Carmine, Piero Lulli, Jean Claudio (Principe Sergio), Lorella De Luca (Jamal).
Trama: Nelle steppe dell’Asia centrale. Sergio di Tula, che mira a deporre Stefano III, si allea con la regina dei Kirghisi. Lo affronta Andrea, fratello del traditore, a capo dell’esercito del legittimo sovrano.
Note: Film scarsamente valutato dai critici, nonostante l’eccellente commento musicale.
FINCHE’ DURA LA TEMPESTA (1963)
Regia: Bruno Vailati (1919-1990) e Charles Frend (1909-1977). Soggetto: Bruno Vailati, Pino Belli (dal romanzo “Beta Son” di Pino Belli). Fotografia: Gàbor Pogàny. Montaggio: Giancarlo Cappelli. Musiche: Carlo Rustichelli. Scenografia: Giorgio Giovannini.
Interpreti e personaggi: James Mason (cap. Blayne), Gabriele Ferzetti (cap. Leonardi), Lilli Palmer (Lygia da Silva), Alberto Lupo (Magri), Valeria Fabrizi (Susanne), Renato De Carmine (Ghedini), Daniele Vargas (nostromo Brauzzi), Andrea Checchi (Micheluzzi).
Trama: Il film, ispirato a fatti realmente accaduti, narra della conoscenza e del reciproco apprezzamento, a dispetto della guerra, fra il comandante di un sommergibile italiano e di un cacciatorpediniere inglese, che si trovano nel porto neutrale di Tangeri.
Note: Per il critico di “Monthley Film Bullettin” (1963) è un’opera che “sopravvive per l’ottimo cast”.
L’INDOMABILE ANGELICA (1967)
Regia: Bernard Borderie (1924-1978). Soggetto: Anne & Serge Golon. Sceneggiatura: Bernard Borderie, Francis Cosne, Pascal Jardin, Louis Agotay. Fotografia: Henri Persin. Montaggio: Christian Gaudin. Musiche: Michel Magne. Scenografia: Robert Giordani. Costumi: Rosine Delamare e Maria Naselli Rocca.
Interpreti e personaggi: Michèle Mercier (Angelica), Robert Hossein (Jeoffrey), Ettore Manni, Pasquale Martino, Arturo Dominici, Renato De Carmine, Poldo Bendandi.
Trama: Angelica, alla ricerca del marito creduto morto, è catturata dai pirati e venduta come schiava. Comprata a sua insaputa proprio dal marito, divenuto un corsaro terribile e ricchissimo, è nuovamente rapita.
Note: Quarto episodio della serie di Angelica. Il pubblico non abbandona il personaggio.
ANGELICA E IL GRAN SULTANO (1968)
Regia: Bernard Borderie (1924-1978). Soggetto: Anne & Serge Golon. Sceneggiatura: Bernard Borderie, Francis Cosne, Pascal Jardin, Louis Agotay. Fotografia: Henri Persin. Montaggio: Christian Gaudin. Musiche: Michel Magne. Scenografia: Robert Giordani. Costumi: Rosine Delamare e Maria Naselli Rocca.
Interpreti e personaggi: Michèle Mercier (Angelica), Robert Hossein (Jeoffrey), Helmuth Schneider, Jean-Claude Pascal, Ettore Manni, Arturo Dominici, Renato De Carmine, Erno Crisa.
Trama: Angelica, rapita dai pirati e portata ad Algeri, è imprigionata in un harem. Il marito la salva e riprende con lei la ricerca dei loro due figli.
Note: Per il Morandini il film è “ancora più greve e piatto dei precedenti”.
PROBABILITA’ ZERO (1969)
Regia: Maurizio Lucidi (1932-2005). Soggetto: Dario Argento. Sceneggiatura: Dario Argento, Maurizio Lucidi, Giuseppe Mangione, Vittorio Vighi. Fotografia: Aldo Tonti. Montaggio: Alberto Galletti. Musiche: Carlo Rustichelli (dirette da Bruno Nicolai).
Interpreti e personaggi: Henry Silva (Duke), Peter Martell (Sam Trench), Katia Christine (Kristyn), Marco Guglielmi (cap. Kreuz), Renato De Carmine (magg. Horst)
Trama: Nel 1943 un aereo da ricognizione britannico precipita in Norvegia, finendo nelle mani dei tedeschi. Un ufficiale americano ha il compito di recuperare il velivolo, dotato di un nuovo sistema radar.
Note: Secondo il Davinotti “dell’estro di Dario Argento, autore unico del soggetto e co-sceneggiatore, poco si rintraccia. La scarsità dei mezzi è evidente”.
YELLOW – LE CUGINE (1969)
Regia: Gianfranco Baldanello (1928). Soggetto: Augusto Finocchi, Vittorio Metz. Sceneggiatura: Augusto Finocchi. Fotografia: Luciano Trasatti. Montaggio: Bruno Mattei. Musiche: Lallo Gori.
Interpreti e personaggi: Lisa Saagram (Marta), Maurizio Bonuglia (Pierre), Caterina Barbero (Valentina), Franco Ricci (maresciallo Fiore), Renato De Carmine (commissario Saccara).
Trama: Due cugine si contendono l’eredità di una villa. Una delle due è assassinata.
Note: Per la critica è un film dignitoso, che ben rappresenta l’estetica degli anni Settanta.
IO NON SCAPPO … FUGGO (1970)
Regia: Franco Prosperi (1926-2004). Soggetto e sceneggiatura: Castellano e Pipolo. Montaggio: Tatiana Casini Mongi. Effetti speciali: Giulio Molinari. Musiche: Bruno Canfora. Scenografia: Luciano Puccini.
Interpreti: Enrico Montesano, Alighiero Noschese, Lino Banfi, Ignazio Leone, Mariangela Melato, Gianfranco D’Angelo, Renato De Carmine, Daniela Goggi, Stefano Satta Flores.
Trama: Allo scoppio dell’ultimo conflitto mondiale, tre uomini sono uniti dal destino, non sempre clemente con loro.
Note: Nonostante l’impiego di attori di richiamo, la sceneggiatura di Castellano e Pipolo e alcuni momenti azzeccati, le recensioni evidenziano l’inconsistenza del risultato.
LA GUERRA SUL FRONTE EST (1970)
Regia: Tanio Boccia (Amerigo Anton, 1911-1982). Soggetto: Alberto De Rossi, Mario Moroni, Gisella Tempera. Fotografia: Oberdan Troiani. Montaggio: Fedora Zincone. Musiche: Sandro Alessandroni. Scenografia e costumi: Sibilla Geiger.
Interpreti e personaggi: Roberto Maldera (Mario Casavecchia), Katherine Kendall (Marika), Renato De Carmine (il cappellano), Marco Guglielmi (il capitano), Gianni Dei (Giovanni).
Trama: Le avventure di due soldati che, sul fronte greco, si uniscono ad un gruppo di bersaglieri allo sbando. Atti di eroismo, senza lieto fine.
Note: Secondo il Davinotti, Boccia, famoso per i suoi film a basso costo, che gli valsero l’appellativo di “Ed Wood italiano”, pur utilizzando due buoni attori come De Carmine e Guglielmi, ricade in incongruenze, dilatazioni e contrazioni temporali, che sbilanciano la trama.
SETTE SCIALLI DI SETA GIALLA (1972)
Regia: Sergio Pastore (1932-1987). Soggetto e sceneggiatura: Sandro Continenza, Giovanni Simonelli, Sergio Pastore. Fotografia: Guglielmo Manconi. Montaggio: Vincenzo Tomassi. Musiche: Manuel De Sica. Scenografia: Alberto Boccianti. Costumi: Luciana Marinucci.
Interpreti e personaggi: Anthony Steffen (Peter Oliver), Sylva Koscina (Francoise Valley), Jeannette Cen (Susan), Renato De Carmine (ispettore Jansen), Giacomo Rossi Stuart, Umberto Raho, Annabella Incontrera.
Trama: Delitti misteriosi in un atelier. Un pianista cieco, dapprima sorvegliato dalla polizia, riesce a scoprire l’insospettabile assassino.
Note: “Segnalazioni cinematografiche” definisce il film “un racconto fumettistico, privo di credibilità. I personaggi, usati per incutere terrore, come i consueti ingredienti terrifici della messa in scena, si fanno notare per l’estrema disinvoltura con cui passano dalle massime aberrazioni erotiche agli assassini più efferati. Per conseguenza, oltre che immorale, la pellicola è un pericolo per la salute psichica degli spettatori”.
NON HO TEMPO (1973)
Regia: Ansano Giannarelli (1933-2011). Soggetto: Leopold Infeld. Sceneggiatura: Ansano Giannarelli, Edoardo Sanguineti. Fotografia: Luigi Verga. Montaggio: Velia Santini. Musiche: Vittorio Gelmetti. Scenografia: Giuseppe Mangano.
Interpreti e personaggi: Mario Garriba (Evariste Galois), Fernando Birri (Filippo Buonarroti), Nicola Lombardi (presidente del Tribunale), Marisa Fabbri (madre di Evariste), Paolo Modugno, Ludovica Modugno, Renato De Carmine, Michele Placido, Mario Valdemarin.
Trama: La breve esistenza del matematico francese Evariste Galois (1811-1831) e la sua morte in duello, per difendere una giovane donna che amava. Sicuro di soccombere, la notte precedente cercò disperatamente di riordinare i suoi testi inediti.
Note: Per Gianni Rondolino (Catalogo Bolaffi del cinema italiano 1966/1975) il film “non si ferma a narrare i fatti e ad ambientare scrupolosamente la vicenda, ma suggerisce un’interpretazione politica attuale”. Paolo Mereghetti (“Dizionario dei film” ed. 1994) ritiene “difficilmente sopportabile lo straniamento didattico alla base dell’operazione”.
ALLONSANFAN (1974)
Sceneggiatura e regia: Paolo (1931) e Vittorio Taviani (1929-2018). Fotografia: Giuseppe Ruzzolini. Montaggio: Roberto Perpignani. Musiche: Ennio Morricone (dirette da Bruno Nicolai). Scenografia: Gianni Sbarra. Costumi: Lina Nerli Taviani.
Personaggi e interpreti: Marcello Mastroianni (Fulvio Imbriani), Lea Massari (Charlotte), Mimsy Farmer (Francesca), Laura Betti (Ester Imbriani), Claudio Cassinelli (Lionello), Bruno Cirino (Tito), Renato De Carmine (Costantino Imbriani).
Trama: Di ambientazione risorgimentale, il film è incentrato su un rivoluzionario disilluso, che viene, suo malgrado, coinvolto dai propri compagni in una spedizione per liberare il Meridione.
Note: “I Taviani rimescolano ancora le carte della narrazione tradizionale. Pagine assai belle sono alternate ad altre squilibrate e opache” (il Morandini).
IL RITORNO DI ZANNA BIANCA (1974)
Regia: Lucio Fulci (1927-1996). Soggetto e sceneggiatura: Silvano Ippoliti, Aristide Massacesi. Montaggio: Ornella Micheli. Musiche: Carlo Rustichelli. Scenografia: Giovanni Natalucci. Costumi: Massimo Lentini.
Interpreti e personaggi: Franco Nero (Jason Scott), Virna Lisi (suor Evangelina), John Steiner (Beauty Smith / Forth), Raimund Harmstorf (Kurt Jansen), Renato Cestiè (Bill Tarwater), Renato De Carmine (tenente Leclerq).
Trama: Riduzione del classico di Jack London, in cui si innestano gli stereotipi del western all’italiana. “Zanna Bianca”, cane, ma di origine lupo, viene accusato di un crimine non commesso, scatenando una reazione popolare incontrollata. E’ il seguito del film dello stesso regista, “Zanna Bianca”, di cui riprende i personaggi principali.
Note: Per i critici è un film da recuperare in un contesto da Bmovie. Fulci ha saputo mantenersi sempre su un livello molto dignitoso, a dispetto delle difficoltà produttive.
LA MONACA DI MONZA. ECCESSI, MISFATTI E DELITTI (1987)
Regia: Luciano Odorisio (1942-2020). Sceneggiatura: Gino Capone, Carlo Lizzani, Luciano Odorisio, Piero Chiara Gino Capone, Carlo Lizzani, Luciano Odorisio (da “I Promessi Sposi” di A. Manzoni). Fotografia: Romano Albani. Montaggio: Enzo Meniconi. Musiche: Pino Donaggio.
Interpreti e personaggi: Myriem Roussel (Virginia De Leyda), Alessandro Gassman (Osio), Renato De Carmine (cardinale Federico Borromeo), John Karslen (don Carlo), Augusto Zucchi (don Paolo), Alma De Simone (badessa), Flaminia Lizzani (suor Benedetta), Almerica Schiavo (suor Ottavia), Coralina Cataldi Tassoni (suor Candida).
Trama: La monaca di Monza rappresentata come una ragazza sprovveduta, vittima della famiglia e delle autorità religiose. Chiusa in convento contro la sua volontà, si innamora di un avventuriero, che la coinvolge nei suoi misfatti, tra cui un omicidio. Lui è ucciso, lei murata viva per tredici anni.
Note: I giudizi della critica sono positivi. “Attento nella scenografia e nei costumi, nelle ambientazioni quasi gotiche, il film ha un buon ritmo, sostenuto dalla fotografia di luci e ombre, dalla valida colonna sonora e dalle capacità espressive del regista, al quale, tuttavia, si confanno piuttosto i toni agro-dolci dei film precedenti, come ‘Sciopèn’ o il rigore di ‘Educatore autorizzato’” (“il Corriere della Sera”, 12 dicembre 1987).
UN UOMO DI RAZZA (1989)
Regia: Bruno Rosia. Soggetto: Bruno Rosia. Sceneggiatura: Bruno Rosia, Massimo Felisatti. Fotografia: Angelo Filippini. Musiche: Giusto Pio. Montaggio: Paolo Boccio. Scenografia: Giuseppe Pirrotta
Interpreti e personaggi: Maria Grazia Bon (Rosa), Pina Cei (la tata), Bruno Corazzari (Sandro), Renato De Carmine (Toni), Filippo De Gara (Giorgio), Mino Bellei (Santini), Franco Fabrizi (Radames), Francesca Ferrè (Mercedes), Angela Lavornia (Maryam), Philippe Leroy (Giulio Romano), Susanna Forgione (Delia), Elio Pandolfi (Vittorino).
Trama: Un ingegnere italiano, fuggito per le sommosse politiche dall’Africa, vi ritorna alla ricerca di un figlio di cui ha appreso l’esistenza.
Note: Distribuito solo nel 1993, i film è considerato dalla critica “l’ennesima variazione sul mal d’Africa”. Lodati gli interpreti.
PER AMORE, SOLO PER AMORE (1993)
Regia: Giovanni Veronesi. Soggetto: Giovanni Veronesi, Ugo Chiti, Pasquale Festa Campanile. Sceneggiatura: Giovanni Veronesi, Ugo Chiti. Fotografia: Giuseppe Ruzzolini. Montaggio: Nino Baragli. Musica: Nicola Piovani. Scenografia: Enrico Fiorentini. Costumi: Gabriella Pescucci.
Interpreti e personaggi: Diego Abatantuono (Giuseppe), Penelope Cruz (Maria), Stefania Sandrelli (Dorotea), Alessandro Haber (Socrates), Renato De Carmine (Cleofa), Antonino Juorio (Manasse), Mariangela D’Abbraccio (Tamara).
Trama: Giuseppe è visto come un uomo comune, prima scapolo irriducibile, curioso della vita e del mondo, poi sposo appassionato di Maria, al punto da accettarne la misteriosa gravidanza, a costo di perdere il senno e morire.
Note: Considerato un disinvolto tentativo di commedia all’italiana su tema sacro e attaccato dagli ambienti cattolici. Per Alberto Crespi (“L’Unità”, 3 novembre 1993) “è un film irrisolto e indeciso, complice la zuccherosa onnipresente musica di Piovani”.
ROMANZO DI UN GIOVANE POVERO (1995)
Regia: Ettore Scola (1931-2016). Soggetto e sceneggiatura: Giacomo Scarpelli, Ettore Scola, Silvia Scola. Fotografia: Franco Di Giacomo. Montaggio: Raimondo Crociani. Musica: Armando Trovajoli.
Interpreti e personaggi: Rolando Ravello (Vincenzo Persico), Alberto Sordi (Aldo Bartolini), Isabella Ferrari (Andreina, fidanzata di Vincenzo), Mario Carotenuto (il tipografo Pieralisi), Renato De Carmine (avvocato Cantini), Gianfelice Imparato, Barbara D’Urso, Nathalie Caldonazzo, Aida Billarelli.
Trama: Il trentenne Vincenzo Persico, insegnante disoccupato, tramite un amico è coinvolto in quello che si ritiene un delitto. Riconosciuto innocente, preferisce rimanere in prigione, per esercitare finalmente la sua professione.
Note: Presentato in concorso alla LII Mostra del cinema di Venezia (1995). Coppa Volpi a Isabella Ferrari migliore interprete non protagonista. Ultimo ruolo per Mario Carotenuto. Critica tiepida. Scrive Gian Luigi Rondi (“Il Tempo”, 2 ottobre 1995): “Nonostante i modi di rappresentazione che puntano decisamente sulla cronaca realistica, tutto resta smorto e quasi atono, con scarsi appigli sia per divertire, sia per favorire tensioni. Al centro c’è però Sordi, che da solo basta a fare un film”.
ULTIMO BERSAGLIO (1996)
Regia: Andrea Frezza (1937-2012). Soggetto e sceneggiatura: Andrea Frezza. Fotografia: Franco Di Giacomo, Martin Cohen. Montaggio: Roberto Perpignani, Rita Triunveri. Musica: Stefano Marcucci. Scenografia: Lucia Mirisola.
Interpreti e personaggi: Giancarlo Giannini (Leo Steiner), Silvia Cohen (Micol Basevi), Andrea Jonasson (Norma Berkowitz), Pietro Biondi (Alvise Jesurum), Cosimo Cinieri (Jacopo Finzi), Giacomo Piperno (Simone Basevi), Urbano Barberini, Renato De Carmine.
Trama. Venezia. Un omicidio dietro l’apparente suicidio di un docente universitario. La figlia indaga e scopre la verità nascosta nel passato del padre, sopravvissuto all’Olocausto e al lager di Birkenau.
Note: Per Lietta Tornabuoni (“La Stampa”, 29 giugno 1997) “il film riporta alla vita un tema che pareva logorato, mentre non finirà mai di essere angosciosamente, dolorosamente presente”.
PAROLA E UTOPIA (2000)
Regia: Manoel de Oliveira (1908-2015). Sceneggiatura: Manoel de Oliveira. Fotografia: Renato Berta. Montaggio: Valérie Loiseleux. Musica: Carlos Paredes, Massimo Scapin.
Interpreti e personaggi: Lima Duarte, Luis Miguel Cintra, Ricardo Trepa (padre Antonio Vieira), Leonor Silveira (Cristina, regina di Svezia), Renato De Carmine (padre Jeronimo Cattaneo).
Trama: La vita del gesuita portoghese Antonio Vieira, vissuto nel XVII secolo.
Note: “Un film non biografico in perenne equilibrio tra l’aspirazione a focalizzare la parola come momento di riflessione e comprensione, sottraendole forza comunicativa, e un’impostazione visiva da cui è bandita ogni superficiale ricostruzione d’epoca” (Lietta Tornabuoni, “La Stampa”, 27 luglio 2001).
30 FEBBRAIO (2004)
Cortometraggio (9’). Regia: Sergio Basso. Sceneggiatura: Sergio Basso, Josella Porto. Fotografia: Valentina Summa. Montaggio: Filippo Montemurro. Musica: Umberto Smerilli, James Newton Howard, Tomas Newman.
Interpreti: Renato De Carmine, Antonella Sini.
Trama: Un anziano esce di casa e prende l’ascensore. Nel suo viaggio verso il pian terreno il destino gli concederà un’ultima danza con una sconosciuta.
Note: Premio della Giuria degli studenti al 29° Festival internazionale delle scuole di cinema di Poitiers “Rencontres internationales Henri Langlois” (2006).
LA PACIFICAZIONE (2006)
Cortometraggio (16’). Regia: Tommaso Rossellini. Sceneggiatura: Tommaso Rossellini, Morgan O’Hara.
Interpreti: Renato De Carmine, Clemenza Fantoni, Mila Poliakine, Tommaso Rossellini.
Trama: Un giovane italo-americano si reca in Italia per la prima volta, portando con sé le ceneri del nonno, che ha chiesto di essere sepolto nel suo paese d’origine. Scopre un segreto di famiglia, risalente alla Seconda guerra mondiale e incontra un amore imprevisto.
IL NOSTRO MESSIA (2008)
Regia: Claudio Serughetti. Sceneggiatura: Claudio Serughetti, Luisa Mazzetti. Fotografia: Stefano D’Amadio, Marco Carosi. Montaggio: Giovanni Ziberna. Musica: Claudio Serughetti, Daniele Falangone.
Interpreti: Claudio Serughetti, Sarah Maestri, Vanessa Scalera, Veronica Barbatano, Sarah De Marchi, Maria Rita Cardella, Tinto Brass, Dolcenera, Stefano Salvi, Rosalinda Celentano, Marcello Prayer, Fabrizio Rongione, Renato De Carmine, Fioretta Mari, Guido Roncalli.
Trama: Cinque ragazze, in diverse condizioni di precarietà, condividono un appartamento a Roma. Tutte aspirano a diventare attrici.
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO
“UN CHIEN ANDALOU”
di Roberto Baldassarre
Regia: Luis Buñuel; Sceneggiatura: Salvador Dalì, Luis Buñuel; Cast: Simonne Mareuil, Pierre Batchef; Riprese: Duverger; Durata: 22 minuti (18 fotogrammi al secondo)
Il cortometraggio “Un chien andalou” – “Un cane andaluso” (1929) di Luis Buñuel include una delle immagini più iconiche della storia del cinema: l’occhio di una donna (in realtà è di un bovino, come si può facilmente evincere) squarciato dalla lama di un rasoio. Un’immagine aggressiva, vera azione provocatrice dell’autore nei confronti degli spettatori. Però questo close-up grandguignolesco non ha solamente la funzione di shockare, ma anche quella di violenta metafora per simboleggiare l’apertura dell’occhio umano, da parte del regista (infatti l’uomo con il rasoio è impersonato dallo stesso Luis Buñuel), verso altre realtà oniriche e inconsce. Non a caso quest’immagine viene inserita da Buñuel proprio come premessa alla storia che seguirà: l’amour fou tra i due protagonisti, rappresentata attraverso scene scaturite dall’inconscio. In poche parole, sullo schermo sarà rappresentato tutto ciò che in una pellicola d’amore normale non si vede. “Un chien andalou” è riconosciuta come l’opera che meglio espone cinematograficamente le tematiche del surrealismo, e al medesimo tempo rappresenta al meglio le prorompenti potenzialità evocative del cinema, che può sfruttare agevolmente metafore e simbologie.
Il surrealismo
Il primo manifesto surrealista, in cui venivano declamati gli intenti espressivi del nuovo movimento, fu pubblicato nell’autunno del 1924 da André Breton. Questa corrente artistica d’avanguardia, evoluzione del dadaismo e prevalentemente di carattere pittorico e letterario, attingeva le proprie tematiche dalle teorie scientifiche di Sigmund Freud. Breton, il vero teorico del surrealismo, rimase affascinato dal saggio L’interpretazione dei sogni (1899), nel quale Freud spiegava come l’attività onirica fosse fondamentale per comprendere la psiche e gli atti umani. Per tanto lo scrittore francese ritenne che la creazione artistica del Novecento dovesse sorgere dall’inconscio, rappresentandolo senza censure logiche e sociali. Così Breton descrisse, nel suddetto manifesto, quale sarebbe stato l’operato artistico prefissato: «Automatismo psichico puro, attraverso il quale ci si propone di esprimere, con le parole o la scrittura o in altro modo, il reale funzionamento del pensiero. Comando del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale».
In ambito pittorico le tecniche maggiormente utilizzate furono: il frottage (strofinamento); il grattage (raschiamento); il collage; l’assemblage; il dripping (sgocciolamento). Invece, le tematiche cardine del movimento, e che compaiono prepotentemente anche nel cortometraggio di Buñuel, sono: l’amore; il sogno e la follia; la liberazione. Tra i massimi artisti che hanno aderito al movimento, oltre ai già citati, ci sono: Salvador Dalí (1904-1989), René Magritte (1898-1967), Joan Miró (1893-1983), Max Ernst (1891-1976), Antonin Artaud (1896-1948), Louis Aragon (1897-1982).
“Un chien andalou”
Seguendo le tre tematiche principali del surrealismo, citate in precedenza, “Un chien andalou” può essere così riassunto: una storia d’amore composta di sogni e follia, con una liberazione finale (che non avverrà). Il cortometraggio fu ideato congiuntamente da Buñuel e Dalí, che decisero di dare corpo ad alcune loro visioni oniriche: ad esempio la mano piena di formiche è di Dalí, mentre Buñuel aveva sognato un rasoio che tagliava in due la luna.
Ugualmente, gli intenti di sfida provocatrice degli autori sono di mettere in scena, attraverso grottesche simbologie, sferzanti critiche contro la chiesa, la borghesia e le istituzioni scolastiche. Atto “goliardico” ravvisabile anche nella scelta del titolo, che non ha nessuna attinenza con quanto rappresentato e, anzi, rimarca quel senso di straniamento, successivamente alimentato dalle didascalie che scansionano il racconto, riportando date casuali (questa scelta è anche una parodia delle logiche didascalie presenti nei film di narrazione classica). La musica, invece, venne aggiunta soltanto nel 1960, seguendo le indicazioni dello stesso Buñuel, riprendendo le musiche usate durante le proiezioni del 1929. La colonna sonora contiene il Liebestod (Amare la morte) tratto dall’opera lirica Tristano e Isotta di Wagner, e due tanghi argentini.
La passione amorosa tra i due protagonisti, fatta di attrazione e repulsione, è intrisa di perversione e non di gioia, con la sessualità rappresentata attraverso differenti simbologie. Già all’inizio l’uomo, sopra un abito borghese, ha uno strano travestimento bianco, che lo fa sembrare tanto una suora quanto uno spermatozoo. La pedalata felice dell’uomo verso la sua amata può essere interpretata come uno spermatozoo che cerca di raggiungere la donna e fecondarla. Significativa anche la scena in cui una donna, dai lineamenti androgeni, osserva e giocherella con una mano mozzata rinvenuta per la strada. La mano, metaforicamente, rappresenterebbe l’organo sessuale maschile, e per tanto la donna sta giocando con l’arto mancante (non a caso poi lo raccoglie e lo mette dentro una scatola che porta con sé). Per inciso, questa donna rappresenta il lato femminile dell’uomo (evidenziato dalla medesima scatola che hanno ambedue). La morte di questa donna (quindi l’eliminazione della parte femminile del protagonista), che i due amanti hanno visto attraverso la finestra, scatena nell’uomo un raptus sessuale, come evidenzia lo sguardo folle e la bava al lato della bocca (bava che ha un colore tendente al rosso sangue). L’uomo insegue per la stanza la donna che scappa, perché vuole possederla, e quando riesce a raggiungerla e bloccarla contro il muro, in modo libidinoso palpeggia violentemente i seni, che diventano poi natiche (a simboleggiare le affini rotondità sessuali). Sessualità espressa anche con l’immagine dell’ascella pelosa della donna (paragonata in sovraimpressione a un riccio di mare), che verso il finale si stampa sulla bocca di lui (e scompare dall’ascella della donna), a significare il suo fremente desiderio.
“Un chien andalou” è pervaso anche da un fitto sentore di morte. L’uomo, che pedalava beato per raggiungere la sua donna, cade dalla bicicletta e muore sotto l’appartamento di lei, non riuscendo a raggiungere l’agognato orgasmo (essendo lui vestito da pseudo spermatozoo, potrebbe essere interpretato come un coitus interruptus). La già citata mano mozzata e la conseguente morte, per investimento, della donna androgina. L’uccisione del doppelgänger da parte del “doppio” dell’uomo, a simboleggiare l’assassinio della propria coscienza. Le formiche sulla mano, che raffigurano la decomposizione del corpo umano. E poi gli animali morti: dall’occhio bovino, alle carcasse dei due asini stese dentro i due pianoforti, fino alla donna che osserva su una parete l’inquietante farfalla denominata “sfinge testa di morto”. Infine, il finale, in cui i due amanti, dopo essersi ricongiunti in riva al mare, giocano come due adolescenti (liberazione dalle convenzioni sociali). È un classico happy end, ma ecco che, come un taglio di rasoio, uno stacco di montaggio ce li fa vedere morti e sepolti, per metà, sotto la sabbia.
Prorompenti anche le simbologie contro le istituzioni religiose e scolastiche/culturali, che inibiscono le pulsioni (sessuali e artistiche). La donna ci viene presentata intenta a leggere un libro, in cui è contenuta la riproduzione del quadro La merlettaia di Jan Vermeer. Se inizialmente la donna osserva il quadro con un certo interesse, appena sente arrivare il suo amato getta il libro con disgusto sul tavolo (la pulsione sessuale vince sulla castità). Il quadro di Vermeer raffigura la donna come angelo del focolare, completamente sgombra da pensieri peccaminosi. Quando l’uomo sta infine per braccare la donna e possederla, il suo avvicinarsi a lei si fa improvvisamente lento e pesante, perché porta con sé il peso delle proprie convenzioni sociali. Le due corde che trascina sono legate alle tavole dei 10 comandamenti, a due pianoforti (espressione borghese) e a due preti (tra cui uno è Dalí). Infine, il doppio dell’uomo, pervaso da ardori sessuali, viene redarguito e fatto mettere faccia al muro dal suo doppelgangër, che rappresenterebbe al medesimo tempo la figura di padre e di professore (nella stanza appare un banco scolastico). Nella stessa sequenza, il libro che il sosia consegna al doppio, si trasforma in pistola, a simboleggiare come la cultura può trasformarsi in arma.
Il surrealismo cinematografico
“Un chien andalou” e “L’âge d’or” (1930) sono i più fulgidi esempi di surrealismo cinematografico, e sebbene nelle successive pellicole Buñuel abbia adottato narrazioni più lineari, permane in ogni suo film l’elemento onirico e simbolico; oltre agli usuali beffardi fendenti contro la borghesia. Basterebbe citare la metafora de “L’angelo sterminatore” (“El ángel exterminador”, 1962), alcune visioni presenti in “La via lattea” (“La voie lactée”, 1969), oppure la scena in cui il gruppo di borghesi cammina senza meta, in “Il fascino discreto della borghesia” (“Le charme discret de la bourgeoisie”, 1972), per comprendere come il regista spagnolo non abbia perduto il tocco visionario. In ogni modo, anche altri artisti si sono espressi con il cinema, utilizzando le tecniche e le tematiche del surrealismo, benché non raggiungendo le qualità visive e contenutistiche di Buñuel. Il poliedrico Man Ray (1890-1976), di passaggio nel movimento surrealista, si è cimentato anch’esso con il cinematografo, realizzando prettamente dei cortometraggi sperimentali. “L’étoile de mer” (1928), che segue i “precetti” surrealisti, è la sua opera cinematografica più nota. La stella del titolo, immagine poetica che a volte appare in sovraimpressione (per tanto subliminale), simboleggia la bellezza perfetta.
Salvador Dalì
Molte decadi dopo, altri autori, che non hanno mai aderito al surrealismo per ovvi motivi anagrafici, hanno raccolto le idee del movimento. Interessanti e affascinanti i contributi, benché discontinui, dello spagnolo Francisco Arrabal (1932) e del cileno Alejandro Jodorowsky (1929). Il primo, maggiormente noto come scrittore e drammaturgo, in “Andrò come un cavallo pazzo” (“Iré como un caballo loco”, 1972) e “L’albero di Guernica” (“El árbol de Guernica”, 1975) con Mariangela Melato, ha saputo mettere in immagini simbolismi visivi d’ascendenza letteraria e connessi alla storia spagnola sotto dittatura. Jodorovsky, autore che da sempre ha diviso la critica, ha calato la simbologia in plot di genere. Ad esempio “El topo” (1971) è uno “spaghetti western”, al cui interno ci sono molte derive metaforiche e/o oniriche. Ingmar Bergman, completamente avulso dal surrealismo, ne “Il posto delle fragole” (“Smultronstället”, 1957) riesce a rappresentare perfettamente per immagini una visione onirica, ovvero l’incubo che ha il Professore Isak Borg (Victor Sjöström).
In ambito nostrano, escludendo i filmini sperimentali, due autori hanno (ri)utilizzato i concetti del surrealismo, per poi essere copiati da molti registi a seguire. Federico Fellini ha sempre usato nei suoi film, soprattutto in quelli “autobiografici”, l’aspetto onirico. L’incipit di 8½ (1963) è l’esempio più lampante, ma anche “Giulietta degli spiriti” (1966), per i suoi toni spiritici e per il lisergico uso del colore, ha dei tocchi molto surrealisti. Pier Paolo Pasolini ha utilizzato l’aspetto onirico in Accattone (1961), ovvero l’incubo di Vittorio Cataldi che prefigura la sua morte.
OCCHIO CRITICO
I FRATELLI DE FILIPPO (E QUALCHE ALTRO)
di Tullio Masoni
Il film di Sergio Rubini, fuggevolmente passato per le sale e trasmesso in Tv, arriva subito dopo Qui rido io di Mario Martone che, a sua volta, nel 2019 aveva ripreso in chiave “contemporanea” un testo assai controverso dell’Eduardo maturo: “Il Sindaco del Rione Sanità”. Coincidenze? La cultura napoletana pone forse esigenze dell’oggi, pur se sotterranee? Dare una risposta è azzardato, specie in un momento nel quale ogni intenzione è oggettivamente deformata dalla pandemia; sembra certo, però, il bisogno di tornare, da parte di autori e interpreti meridionali, a un “vissuto”, più che a una tradizione, le cui risonanze linguistiche si avvertono ancora. In altri termini Rubini, Martone, Sorrentino, o per altro verso Carlo Cecchi, potrebbero tendere alla protezione di un patrimonio culturale in pericolo e, al tempo stesso, tanto ricco da venire costantemente ripreso ed esplorato.
Sergio Rubini compie con I fratelli De Filippo una lunga ricerca storica e memoriale da cui ha tratto la convinzione che l’avventura di Eduardo, Peppino e Titina sia da leggere nel segno di un riscatto: «Volevo raccontare i De Filippo – dice in un’intervista – come fossero i Beatles; a me Scarpetta non interessava, era solo una sorta di Mangiafuoco…» I figli (mai riconosciuti, sappiamo) contro il padre-padrone. Eppure il personaggio Scarpetta che ha portato sullo schermo ha un notevole rilievo, sia come emblema della napoletanità che i figli volevano superare, che come mezzo drammatico, cioè maschera oscena mediante la quale Giancarlo Giannini ha offerto una prova delle migliori. Un emblema, quindi, di cinismo patriarcale e violenza, di demagogia volgare e lucida gelosia: «Tu – ammette contrariato rivolgendosi a Eduardo che gli ha fatto leggere un copione – m’hai arrubbàto l’arte!».
Il riscatto dei figli (ma sempre in conflitto – la rottura sarà irrimediabilmente sancita nel 1944) è dunque concepito sul distacco dall’umore plebeo del teatro paterno (forse collocabile tra la farsa e la sceneggiata) e dalla lingua. Eduardo guardava a Pirandello, ne assunse la distinzione umoristica, e, come ha scritto Nicola De Blasi, nutrì assai presto una vocazione nazionale: «Non c’è dubbio che da un punto di vista linguistico il *teatro eduardiano sia un teatro naturalista, nel senso che dialetto e lingua nelle commedie si affiancano, si alternano e si combinano secondo modalità perfettamente credibili se confrontate con quelle della realtà extrateatrale.»
***
Subito dopo “Il Sindaco del Rione Sanità” (ho scritto una recensione per “Carte di Cinema” alla quale rinvio per non ripetermi) Martone comincia a girare “Qui rido io”, risalendo da Eduardo autore al padre e alla sua “strana” famiglia.
Il personaggio di Rubini è impietrito nella propria fama residuale; irrimediabilmente vecchio, velenoso. Quello di Martone porta i caratteri dell’altro ma recupera, difendendosi in tribunale, la vitalità di chi inventa un ruolo recitando a soggetto. All’inizio del film c’è il palcoscenico coi tanti modi di ricrearlo che la mdp esalta, alla fine il teatro è l’aula, ben oltre la metafora classica e mediante un clamoroso recupero dell’istrione di strada. Scarpetta/Servillo, insomma, si stacca con brutalità dalle indulgenze “descrittive” cui la regia aveva un poco ceduto nella parte centrale e, nella scena disadorna del giudizio, impone una risolutiva energia d’attore.
Anche Martone si occupa dei figli-fratelli, ne rileva il rancore e i contrasti, ma il protagonismo di Scarpetta spinge il resto ai margini.
Di rancore verso il padre, contrasti non solo caratteriali tra i fratelli, e conseguente disordine famigliare, si nutre invece, fin dall’inizio, il biopic di Rubini. Da un lato c’è il grave e incancellabile disagio di Peppino, staccato dagli altri due e preso in affido da contadini, dall’altra l’oscillante “dissenso” dello stesso Peppino verso le ambizioni autoriali di Eduardo. Come già accennavo, Eduardo aspira a un teatro pirandellianamente umoristico, mentre Peppino, pur condividendo la necessità di fare compagnia contro il padre, è incline a un comico più tradizionale. Eduardo ammette la “fuga in avanti”, cioè il tentativo fallito di affermare la compagnia lontano da Napoli e avventurosamente, ma al tempo stesso non rinuncia all’idea di impegnarsi su esiti nazionali di significativa innovazione.
Il film di Rubini risente un poco della committenza televisiva, tuttavia credo si qualifichi, per molti aspetti, come opera preziosa anche nella testimonianza – a proposito della strana e diseredata famiglia De Filippo – e nell’interpretazione: «…Tanti anni fa, quando avevo vent’anni – racconta Rubini – lavoravo in un compagnia napoletana con dentro tanti attori di livello, tra cui Francesco De Rosa, il quale mi raccontò che tutti i pomeriggi alle tre da Palazzo Scarpetta veniva fuori un cameriere con un vassoio e poi percorreva quattrocento metri esatti per portare da mangiare alla famiglia De Filippo…».
Insiste anche, Rubini, a collocare la vicenda dei fratelli, in particolare quella di Eduardo autore, nel solco originario del neorealismo. Credo che, al di là delle esperienze verificabili nelle filmografie, egli abbia buone ragioni se, dalla concezione stretta di neorealismo il campo si allarga al cinema popolare del dopoguerra e della ricostruzione. Fino a tutti gli anni cinquanta e alla prima metà dei sessanta, il cinema delle seconde visioni – destinato ai quartieri periferici e alla provincia – fu del neorealismo una tangibile, non programmatica applicazione socio-merceologica. Da un lato la farsa: Totò, poi Franchi e Ingrassia, il genere canzonettistico, dall’altra il melodramma popolare di Matarazzo. Un “cinema d’appendice” con prevalenti caratteri meridionali che da Scarpetta e dai De Filippo ebbe fonti, materia e tipologie. E, soprattutto, rappresentò la lenta e diseguale evoluzione del pubblico italiano davanti ai propri specchi.
DUE FILM IRANIANI
“THERE IS NO EVIL” DI MOHAMMAD RASOULOF; “UN EROE” DI ASGHAR FARHADI
di Paolo Vecchi
Febbraio 2020. “There is no Evil” vince l’Orso d’Oro al Festival di Berlino. Il direttore, Carlo Chatrian, è costretto a mostrare sullo smartphone la fotografia dell’autore, Muhammad Rasoulof. Il regista é’ infatti agli arresti domiciliari e non ha ricevuto dalle autorità iraniane il visto per l’espatrio. Conoscendo anche solo in maniera superficiale il contesto in cui opera, da esplicito oppositore, il fatto non stupisce più di tanto. Ottavo titolo di una filmografia che a questo punto vorremmo conoscere in toto, e che ha come filo conduttore la condanna a morte, e chi é incaricato di eseguirla, o rifiuta di farlo assumendosene le pesanti conseguenze. Si divide in quattro episodi anche perché, come ha dichiarato Rasoulof, la frammentazione delle sceneggiature consente di sfuggire con maggiore facilità alla censura preventiva. Il primo, quello più duro, si sofferma sulla natura impiegatizia del protagonista, colto nella sua banalità quotidiana, mentre accompagna la moglie in banca, sposta la macchina per non intralciare il traffico, va a fare la spesa al supermercato, prova la pressione alla suocera, tira l’aspirapolvere e porta la figlia a mangiare la pizza. Ma l’orologio che lo sveglia alle tre del mattino rafforza i sospetti affacciatisi nella sequenza iniziale, quando carica nel bagagliaio un grosso involto che dice contenere la razione familiare di riso.
Dopo avere dato per un attimo l’impressione di esitare davanti a un semaforo verde – invenzione di regia che sospende efficacemente il tempo della narrazione – torna infatti nel parcheggio sotterraneo dell’incipit, che evidentemente serve come suo ufficio e, dopo essersi preparato il caffé, schiaccia una serie di pulsanti che fanno scattare il meccanismo di una forca multipla. La breve agonia dei condannati, dei quali vediamo solo le gambe, è mostrata nell’atrocità di tremiti e deiezioni, come prima l’avevamo vista solo in “Breve film sull’uccidere” (1988), versione lunga del “Decalogo 5” di Kiéslowski. Gli altri tre capitoli, ambientati rispettivamente nelle stanze e nei corridoi di un carcere, struttura che il regista dice di conoscere bene essendone stato ospite per più di un anno, in un paesaggio verdissimo che si presterebbe all’idillio e in una fattoria incastonata tra montagne severamente brulle, sviluppano con rigorosa coerenza l’assunto del primo. Rasoulof ha dichiarato che, dopo avere fatto ricorso alle metafore per aggirare i divieti della censura nei suoi lavori precedenti, era venuto il momento di assumersi la responsabilità di un linguaggio più diretto, essendo ovviamente conscio che ne avrebbe pagato lo scotto. Il suo cinema diventa così politico in maniera scoperta, utilizzando a mo’ di commento sonoro una sorprendente “Bella ciao” in versione operaia, cantata da Milva nel finale del secondo episodio, ripresa nell’arrangiamento orchestrale in quello del quarto. Ma l’urgenza del messaggio non va a scapito del rigore stilistico e della sua funzionalità. Coprodotto da World Cinema Fund di Amburgo, acquistato per la distribuzione dalla benemerita Arte, il film dovrebbe a breve uscire anche da noi, non sappiamo se in sala o su una piattaforma e con quale titolo.
Luglio 2021. “Un eroe” di Asghar Farhadi vince il Gran Premio della Giuria a Cannes, ex aequo con il graziosissimo “Scompartimento n.6” del finlandese Juho Kuosmanen. Fonti attendibili ci dicono che Rasoulof ha stigmatizzato il collega perché nelle dichiarazioni di circostanza non ha speso una parola sulla situazione del suo Paese, dove le manifestazioni per la crisi idrica sono state represse con un numero di morti incalcolabile perché occultato.
Al di là di risvolti difficilmente percepibili da un osservatore lontano, la polemica investe una differente concezione del ruolo dell’artista in un clima politicamente difficile. Come ha dimostrato anche nei suoi film precedenti, infatti, l’atteggiamento di Farhadi nei confronti della società iraniana, pur non corrivo, appare comunque improntato ad un’attenta mediazione. Ma non é solo per questo che il film offre il fianco a più di una critica.
L’”eroe” del titolo è Rahim, in carcere per debiti, che, durante un permesso, decide di restituire una borsa contenente 17 monete d’oro trovata alla fermata d’autobus dalla sua nuova compagna anziché impossessarsene per tacitare il creditore. La tempesta mediatica che il suo gesto scatena finisce per rivoltarglisi contro. Certo memore di “Close-Up” di Kiarostami per l’ambiguo discrimine che separa menzogna e verità, il film dispiega il solito abile meccanismo di incastri e deviazioni. Quello di Farhadi, lo sappiamo, è un cinema basato innanzitutto su sceneggiature ferree, servite da una altrettanto sicura direzione di attori, solitamente molto bravi. Il rischio che corre é che lo script diventi una sorta di soffocante camicia di forza. Più che in “Una separazione” o “Il cliente”, per non parlare del mediocre “Tutti lo sanno”, é quello che accade a “Un eroe”, dove ogni svolta della narrazione ha qualcosa di macchinoso, di un troppo – nella vettorialità, nei colpi di scena, nell’evoluzione dell’atteggiamento dei personaggi – che finisce per ingolfarla. Si fatica poi a tollerare la figura del figlio balbuziente, che dovrebbe fare da controcanto alla disinvoltura nella loquela di tutti, a partire ovviamente da chi lavora nei media, risultando viceversa un espediente improntato ad un pietismo un po’ facile.
GUIDANDO: DUE FILM ROAD MOVIE
di Marco Incerti Zambelli
Gli stravolgimenti che la pandemia ha imposto anche alla produzione ed alla distribuzione cinematografica hanno portato alla uscita pressoché contemporanea delle ultime due opere di Ryusuke Hamaguci, “Il gioco del destino e della fantasia”, che ha vinto l’Orso d’argento 2021 a Berlino, e “Drive my car”, presentato a Cannes 2021 dove ha guadagnato il premio per la miglior sceneggiatura e vincitore del Golden Globe 2022. Meritatamente la Tucker Film li ha fatti uscire in quasi contemporanea nelle sale italiane. Il regista giapponese, che ebbe una prima notorietà grazie al fluviale (più di cinque ore) “Happy Hour” (2015), prezioso resoconto della amicizia tra quattro donne e delle loro vicissitudini, aveva già partecipato a Cannes nel 2018 con “Asako 1&2”, delicata e melanconica narrazione di una educazione sentimentale e contribuito con la scrittura della sceneggiatura alla conquista del Leone d’argento a Venezia di “La moglie della spia” di Kiyoshi Kurosawa, si conferma uno dei più interessanti autori contemporanei.
“Il gioco del destino e della fantasia”, in originale “Coincidenze ed immaginazione”, è un trittico, i primi tre episodi di un progetto che ne prevede sette, nei quali è il dialogo a fare da trama e ordito degli avvenimenti, a disegnare itinerari nei quali pare alle protagoniste di potere trovare una seconda possibilità, di superare gli errori e i rimpianti della vita ordinaria. La prima storia inizia con un lungo piano sequenza con camera fissa all’interno di un taxi, dove le confidenze tra due amiche svelano la coincidenza che l’uomo che una sta cominciando a frequentare è l’ex (non dimenticato) dell’altra ed è ancora una coincidenza, il passaggio dell’uomo davanti alla vetrina di un bar, a dare l’estro al Regista di concludere la storia con un sospeso doppio finale tra Bunuel e Kiesslowski, elegantemente messo in scena grazie ad un semplice movimento di macchina.
Nel secondo episodio il tentativo di Nao, una ex studentessa adultera, di far cadere in una trappola di seduzione Segawa, famoso docente universitario vincitore di un prestigioso premio letterario, colpevole di avere stroncato la carriera accademica dell’amante di lei, è frustrato dal fatto che l’incontro nell’ufficio del professore avviene “a porte ben aperte” come recita il titolo del frammento. Segawa si mostra del tutto riluttante e a nulla serve la lettura di Nao di un brano assai erotico del libro del professore. E tuttavia la confessione della donna apre la possibilità di un rapporto reale tra i due, il dialogo tra loro si trasforma in un reciproco conoscersi e cercarsi, come due anime ugualmente sole che hanno bisogno uno dell’altra nella ricerca di un qualcosa di più misterioso e complicato di un rapporto sessuale. Ma sarà ancora una coincidenza, un errore di battitura nell’indirizzo di una email a scompaginare le loro vite.
La coincidenza si coniuga alla immaginazione nel terzo frammento, l’incontro tra due donne in un distopico futuro prossimo nel quale un virus ha reso inutilizzabili gli strumenti di comunicazione digitali, rendendo pubbliche tutte le email, rivelando così segreti inconfessati. Riconosciutesi all’incrocio di scale mobili, quasi una metafora dei tanti incroci che costellano il film, trascorrono il pomeriggio insieme, ripensando al loro passato del Liceo, amori inconfessati e amicizie perdute, per accorgersi progressivamente dell’equivoco di una passata conoscenza inesistente. Ma se il passato non è esistito, se è irrecuperabile, il presente è reale e può essere ancora un dono, l’offerta di un affetto e di una amicizia profondi.
I ritratti, le vicende narrate, confermano il talento dell’Autore, che rimanda alla sensibilità di Rohmer nell’immergersi nell’universo della sensibilità femminile, nel non criticare, non giudicare i suoi personaggi, pur mettendoli in scena con empatia, sottolineandone con tenerezza le complesse emozioni, aiutato dalle perfette performances dei suoi attori.
Se “Il gioco del destino e della fantasia” è un riuscito mélange di piccoli racconti in sé conclusi, per il successivo “Drive my car”, Hamaguci parte da una breve novella di Murakami dallo stesso titolo, dilatandola e arricchendola, senza tuttavia stravolgerla. Brevi istruzioni per la visione dovrebbero innanzitutto prevedere di rileggere “Zio Vania” di Cechov, magari grazie alla bella versione cinematografica di Konchalowskij del 1970, e solo dopo il film la lettura della short story contenuta nel volume “Uomini senza donne”, regalandosi alla fine l’ascolto dell’omonima canzone, ennesima citazione beatlesiana dello scrittore giapponese, che nulla ka a che vedere con la vicenda ma che è sempre un bel sentire. Nel lungo prologo, una sorta di primo atto (i titoli di testa compaiono solo dopo 40 minuti) l’attore e regista di successo Yusuke Kafuku (ottimamente interpretato da Hidetoshij Nishijima) pare condividere con la sensuale moglie Ota, sceneggiatrice televisiva le cui trame sono ispirate dai felici scambi erotici con il marito, un legame profondo, capace di superare anche la tragedia della perdita della piccola figlia, avvenuta 20 anni prima. Il ritorno imprevisto a casa un pomeriggio, gli fa scoprire il tradimento di Ota con un fascinoso giovane collega. Kafuku non sa decidersi ad affrontare la situazione e la improvvisa morte della moglie impedisce ogni chiarimento.
Passano un paio di anni, uno dei tanti salti temporali che costellano il cinema di Hamaguci, e il protagonista accetta di mettere in scena ad Hiroshima una versione multilingue di Zio Vania, con i sottotitoli proiettati sul palcoscenico ad accompagnare la babele degli idiomi ed addirittura il linguaggio dei segni. Nella scelta del cast sceglie per il ruolo di Vania (un suo cavallo di battaglia che decide di non interpretare perchè: ‘Cechov è terribile, quando pronunci la batture tiri fuori il vero te’), proprio Koshi, il giovane ex amante della moglie. A causa di un precedente incidente, la produzione dello spettacolo gli impone una autista, Misaki (ben impersonata dalla giovane Toko Miura) a guidare la sua amata Saab Rossa, luogo rifugio, abitato, grazie ad una cassetta registrata dalla moglie, dall’incessante ripetersi delle battute di “Zio Vania”, in uno scambio continuo tra Kusaki ed Ota. Il lungo viaggio verso la elaborazione del lutto di Yusuke attraversa l’instaurarsi di un ambiguo cameratismo con Koshi, gli incontri /scontri con il cast teatrale costretto ad interminabili letture e rilettura del testo di Cechov e soprattutto il lento dispiegarsi del rapporto con la silenziosa Misaki, che progressivamente si approfondisce, instaurando una melanconica condivisione di antichi dolori, sugellata da un pellegrinaggio nel nevoso estremo nord del Giappone e iconicamente fotografata dalle sigarette nella mani dei due, affacciate al finestrino della Saab. Hamaguci dichiara che certe conversazioni, conversazioni intime, possono nascere solo in quello spazio chiuso e in movimento che è l’interno di un auto, e in “Drive my car” la macchina è sì luogo di parole ma anche di eloquenti lunghi silenzi: a differenza dei film precedenti, ricchissimi di raffinati dialoghi, in quest’opera “il silenzio è semplicemente un’altra forma di comunicazione” afferma l’Autore , che non a caso affida al linguaggio dei segni la più emozionante riproposizione dei ricorrenti versi finali della cechoviana Sonya, sorta di epigrafe all’intera vicenda: ‘abbiamo sofferto, abbiamo pianto, la vita era difficile… E poi, finalmente riposeremo’
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
ODIO DUNQUE SONO
di Marcello Cella
L’odio è un sentimento profondamente radicato nell’essere umano fin dalla sua comparsa sulla Terra. Basti pensare alla parabola di Caino e Abele. Così come l’amore del resto. Odio e amore, due sentimenti che abitano quasi sempre i poli opposti delle nostre emozioni e del nostro stesso rapporto con il mondo. Ma forse non c’è mai stata un’epoca in cui l’odio, in tutte le forme più o meno oscure e violente in cui si manifesta abitualmente, sia stato così popolare e diffuso fra gli esseri umani. Tanto da aver causato la creazione di un termine estremamente dispregiativo, “buonista”, per chi invece si ostina a professare il bene ed a praticare azioni di solidarietà verso il prossimo, soprattutto verso i più deboli. In tutto questo è ormai opinione diffusa che internet e i social come Facebook, Twitter, Telegram, Instagram ecc. abbiano ampliato e amplificato in modo abnorme le possibilità di diffondere messaggi di ostilità, più o meno oltraggiosi, verso chiunque si discosti da un certo pensiero dominante che non prevede solidarietà alcuna per i più deboli o che mostri apertamente la propria diversità rispetto alla visione del mondo oscurantista, xenofoba e reazionaria che viene sostenuta con larghi mezzi economici e mediatici da una parte della politica italiana e internazionale con finalità oscure e spesso eversive.
Ma chi sono gli autori di questi messaggi di odio? Da cosa nasce la loro ostilità verso chi è diverso da sè? Chi utilizza, organizza e canalizza questa rabbia e questo rancore e perché? E perchè proprio gli strumenti di diffusione del pensiero apparentemente più aperti e democratici si sono trasformati in veicolo privilegiato di questi messaggi verbali così violenti? Questi sono alcuni dei temi di cui si occupa l’inquietante documentario di inchiesta di Valerio Nicolosi, “I fili dell’odio”, scritto da tre scrittori-giornalisti, Tiziana Barillà, Daniele Nalbone e Giulia Polito, e prodotto dalla cooperativa giornalistica di Roma, Il Salto, e dallo Zerostudio’s di Michele Santoro, avvalendosi della testimonianza di scrittori, giornalisti, esperti dei media, personalità politiche pubbliche che hanno spesso assaggiato sulla loro pelle gli effetti di questa ostilità così violenta, oltraggiosa e nello stesso tempo così anonima.
Perchè quindi l’odio on line privilegia questi canali? Una possibile risposta la dà uno degli intervistati, l’esperto dei social media Matteo Flora, quando afferma: “E’ più semplice generare odio on line che nella realtà, proprio come era più semplice sparare al nemico da lontano che infilzarlo con la baionetta e poi guardarlo morire. Non vediamo la vittima soffrire, e questa è la terrificante libertà che permette all’odio on line di nascere e proliferare”. Quindi pare di capire che uno dei motivi per cui l’odio si scatena in modo così incontrollato sui social media sta proprio nel paradosso da essi creato, la distanza di sicurezza da cui si può colpire il proprio bersaglio senza vederne gli effetti, senza percepire la sofferenza generata da questi messaggi-pallottole, e , nello stesso tempo, l’apparente vicinanza illusoria su cui si fonda il paradigma che sta alla base della loro creazione e della loro capillare diffusione, del loro successo per cui siamo tutti “molto più vicini” e abbiamo migliaia di amici sparsi per il mondo.
Il problema è che se ogni tre mesi Facebook cancella in media almeno 7 milioni di messaggi di odio, allora è evidente che più che usare i social per cercare amici, li si usa per cercare nemici, e i commenti non sono spesso per l’altro, ma “contro l’altro”, e le immagini caricate non sono frutto dell’affetto, ma della volontà di denigrare l’altro. E, come afferma la scrittrice Michela Murgia, “le parole generano gesti”. Spesso gesti violenti, come purtroppo testimoniato dalle cronache. Ma chi sono i bersagli degli “haters”, gli oliatori di professione? Il documentario di Valerio Nicolosi in questo senso è molto chiaro e preciso, quasi didascalico nella sua incalzante struttura narrativa. Come confermato da diversi testimoni, lo schema ricorrente dello ”hate speech”, il discorso d’odio, non ha quasi mai una vittima casuale, ma è sistematicamente diretto contro uno specifico e determinato gruppo di persone che ne rivela le origini ideologiche: donne, soprattutto se si tratta di donne che rivestono un ruolo pubblico nella società, come è il caso della parlamentare Laura Boldrini, della sindaca di Barcellona, Ada Colau, o della scrittrice Michela Murgia, persone di origine ebraica come Liliana Segre o stranieri, soprattutto se poveri ed extracomunitari, e perfino papa Francesco, oggetto da anni di una martellante campagna di denigrazione e di bugie mediatiche prodotte da chi vede nella sua figura così popolare una minaccia per la propria visione del mondo. La matrice ideologica di questi messaggi è quindi abbastanza chiara ed è riconducibile a xenofobia, antisemitismo, misoginia, intolleranza religiosa.
E gli autori di questi messaggi d’odio sono personaggi dall’elevato profilo politico o criminale? Tutt’altro. Come affermano Laura Boldrini e Michela Murgia nelle loro testimonianze, si tratta spesso di esseri anonimi, persone qualunque, apparentemente inoffensive come un vicino di casa che cova grandi rancori dietro la propria grigia esistenza. E il riferimento ad un’opera come “La banalità del male” della filosofa tedesca Hannah Arendt sulla violenza nazista che si nasconde dietro la facciata della mediocrità più insulsa è senz’altro immediato. Ma “le parole sono pietre” e possono generare gesti violenti, come i femminicidi che spesso nascono e si sviluppano proprio in contesti come i social media, come conferma anche Silvia Brena, co-fondatrice di “Vox – Osservatorio italiano sui diritti”.
Ma oltre alle frustrazioni e alle rabbie sociali e individuali all’origine dell’odio on line, esistono centrali d’odio ben più organizzate, pericolose e potenzialmente eversive, che rischiano di condizionare, manipolare e di intaccare la struttura politica delle nostre democrazie, le stesse basi sociali della nostra convivenza. Alex Orlowski, esperto di propaganda online, ha le idee piuttosto chiare in proposito e racconta di come i gruppi politici di estrema destra americani ed europei siano molto attivi in questo senso e godano di cospicui finanziamenti occulti, quasi sempre non tracciabili perchè in bitcoin, celandosi spesso dietro identità fittizie o apparenti attività commerciali come quelle legate all’abbigliamento e alle mode culturali giovanili, più difficili da reprimere da parte delle forze dell’ordine. Poi ci sono le centrali d’odio legate a potenze statuali interessate a manipolare a proprio vantaggio gli accadimenti politici altrui e qui necessariamente il discorso si fa più complesso e più che su fatti certi per forza di cose bisogna ragionare sulle ipotesi.
Ma quale può essere l’antidoto a questo mix malsano di messaggi d’odio e notizie false? La risposta apparentemente è semplice: fare solo discorsi di verità. Già, ma chi lo decide qual’è la verità? Il rischio è che lo determinino i proprietari delle piattaforme e quindi si porrebbe un problema complesso di agibilità democratica nelle nostre società. L’unico antidoto che non preveda una regressione profonda della nostra vita sociale e individuale, secondo anche la tesi di fondo del documentario, passa attraverso un’assunzione di responsabilità da parte di noi cittadini attraverso l’informazione, la documentazione, la verifica delle fonti. Non è un metodo infallibile, ed è sicuramente faticoso, ma l’unico che non ci faccia sentire così vicini, così amici, e contemporaneamente, così lontani. Così irrimediabilmente nemici.
“I FILI DELL’ODIO”
Regia: Valerio Nicolosi
Autori: Tiziana Barillà, Daniele Nalbone, Giulia Polito
Protagonisti: Michela Murgia, scrittrice, Alex Orlowski, esperto di propaganda online e di analisi OSINT, Matteo Flora, esperto di reputazione online, Silvia Brena, co-fondatrice di “Vox – Osservatorio italiano sui diritti”, Laura Boldrini, deputata, Ada Colau, sindaca di Barcellona, Steven Forti, storico e ricercatore, Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo, Martin Gak, Filosofo e giornalista tedesco, Tomasz Kitlinski, filosofo, attivista, docente dell’università “Marie Curie Sklodowska” di Varsavia.
Produzione: Zerostudio’s e Cooperativa Il Salto
Anno di produzione: 2020
Durata: 44’50”
Web: https://www.youtube.com/watch?v=c7bm5TQ8WY0
LA MEMORIA DEL CINEMA
“LA STRADA” DI FELLINI
(UNA MEMORIA)
di Tullio Masoni
Nel 1954 avevo otto anni.
“La strada” di Fellini uscì anche in provincia, e io mi incantavo davanti alle locandine affisse da uno dei due cinema del paese. Fotografie in bianco e nero, almeno queste ricordo, dalle quali spiccava Zampanò col suo costume da forzuto.
Io non sapevo niente; non avrei visto il film che era “per adulti”, non badavo a Gelsomina, che invece tornava nella compassione delle donne raccolte attorno a mia madre sarta.
Io guadavo e riguardavo Zampanò, il cinturone sul torso nudo e i bracciali, i denti digrignati nel rompere la catena. Guardavo incantato perché non sapevo decidere a che epoca il personaggio appartenesse. Mi sembrava strano, insomma, che quella specie di tartaro o gladiatore fosse circondato da un paesaggio di gente povera – com’ero povero io fra i tanti del periodo – e che il suo motocarro fosse simile a quelli, rumorosi e traballanti, che ogni giorno incontravo nelle vie.
Molti anni dopo, quando in giro non si vedevano più “carovane” di zingari, ebbi quasi una visione: nella via centrale passava un piccolo carro tirato da un piccolo cavallo. Un uomo tarchiato in canottiera, davanti, teneva il morso e posava l’altra mano sul collo di un ragazzino a fianco; il ragazzino, con ogni probabilità suo figlio, indossava una maglietta da calciatore.
Sul piccolo carro, coperto da uno stropicciato telo a volta, mi sembrò di scorgere una donna con uno o due bambini.
Non capii, e rimasi nel dubbio ripensandoci, se la mano dell’uomo che si posava sul collo del ragazzino agisse per affetto paterno o per brutalità.
Forse avevo già visto “La strada”, quando ebbi quella sorpresa, o forse no. Lo avevo sicuramente visto, con “salutare” ritardo, quando lessi in Dieci inverni il brano che Franco Fortini aveva pubblicato nel lontano 1954: «… Sì, d’accordo, i critici francesi sparano grosso; d’accordo, il sentimentalismo di questo film è, non di rado, scoraggiante; ma come negare che se ne esca, almeno un poco, turbati? Siamo sempre allo stesso punto, i minorati psichici, gli asociali, gli “elementi instabili in seno alla classe operaia” (non è questa la formula?), gli ammalati, quale posto occupano nella antropologia marxista?».
Nel buio della sala fui sorpreso dalla prospettiva in fondo alla quale, davanti alla linea retta del mare, sorgeva un circo senza tendone del tutto simile a quello che avevo frequentato da bambino con mio padre.
In quel circo, ormai stanco vecchio e disperato, Zampanò ripeteva i “numeri” di sempre: stesse frasi da imbonitore, stessi gesti.
Stanco, inseguito dai rimorsi; avrebbe chiuso la giornata ubriaco, litigando in osteria con alcuni avventori che, dopo averlo spinto fuori, lo pestarono fino a umiliarlo.
Poi, claudicante, lui avrebbe cercato la spiaggia per bagnare le ferite; era carponi sulla sabbia, quando alzò gli occhi al cielo e sembrò accorgersi, per la prima volta in vita sua, delle stelle.
Anni fa un circolo culturale di Ferrara mi invitò a tenere una conferenza sul primo Fellini. Mostrai in videoproiezione il finale de “La Strada”, e chiesi all’operatore fosse ripetuto. Mentre Zampanò alzava gli occhi al cielo mi avvicinai al microfono e nel buio, improvvisando, lessi le parole che, come semplice richiamo, avevo previsto di pronunciare colloquialmente: …tanto ch’io vidi de le cose belle / che porta ‘l ciel per un pertugio tondo; / e quindi uscimmo a riveder le stelle.
Quando Fellini morì, nell’ottobre del 1993, in TV trasmisero “I vitelloni”. Una domenica pomeriggio, mi sembra di ricordare.
Mentre il gruppo degli sfaccendati camminava in fila, quasi danzando sulla battigia, spostai gli occhi verso la porta-finestra: grigio del mare invernale sul piccolo schermo, grigio fuori.
CREDITS
Carte di Cinema 26
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E. Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 26 della rivista online, Roberto Baldassarre, Paola Brunetta, Marcello Cella, Mario Galeotti, Mario Giunco, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Alessandra Pighi, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Xoxan Villanueva, Marco Incerti Zambelli.