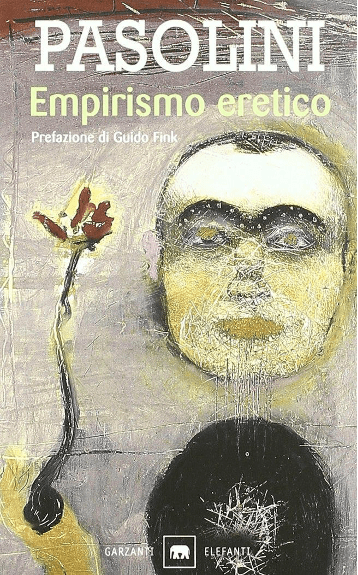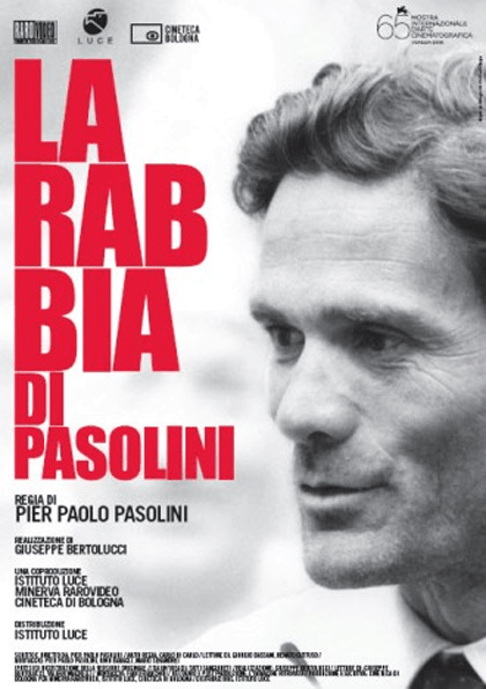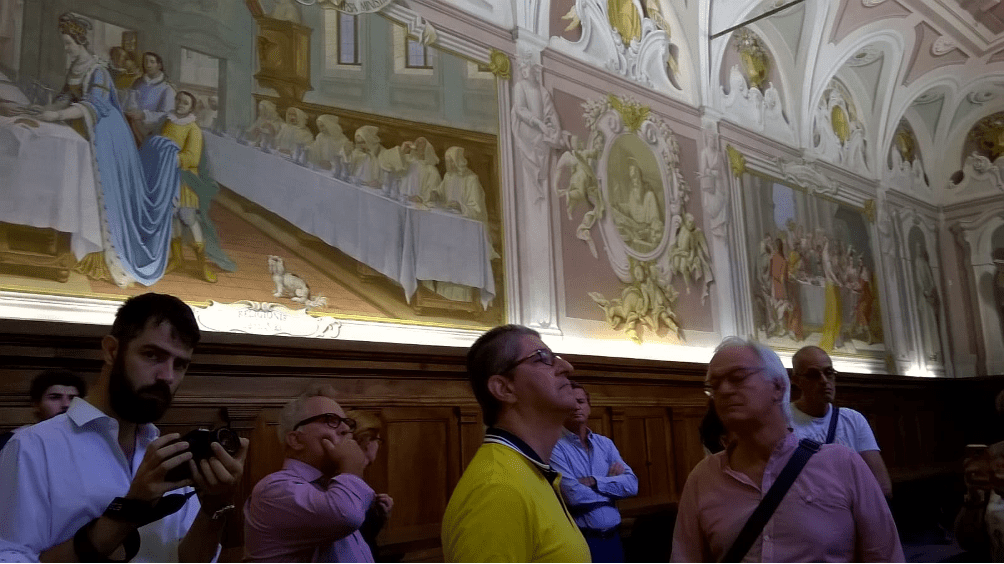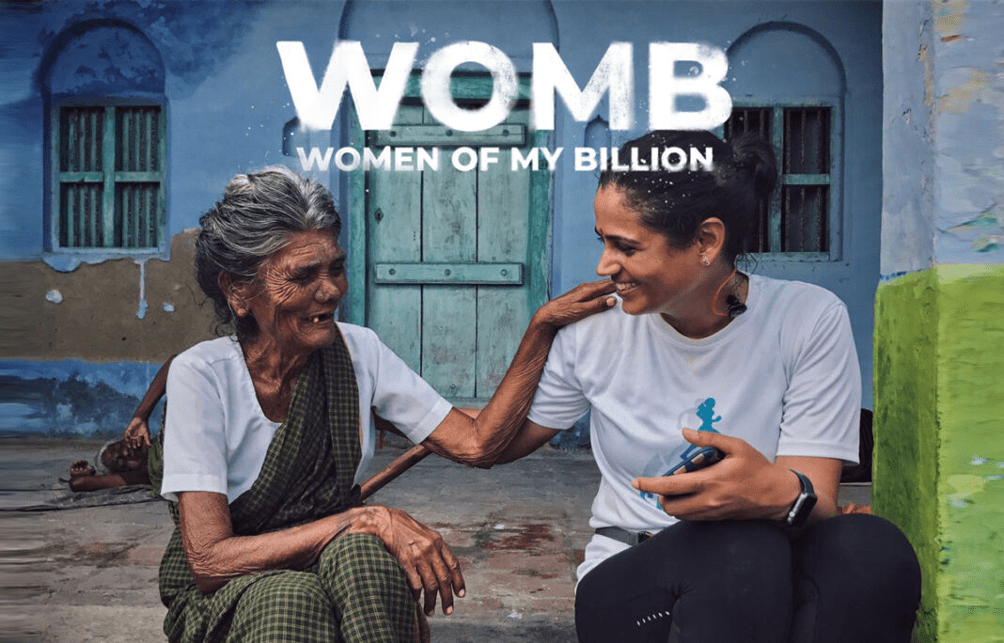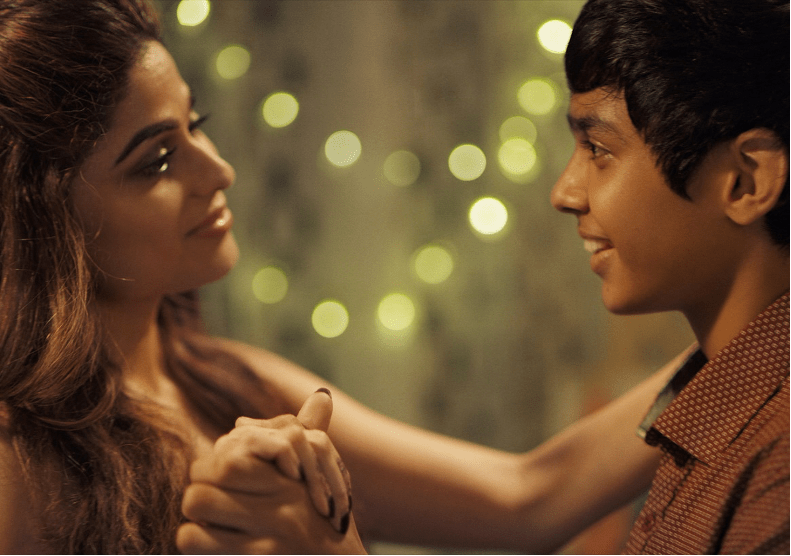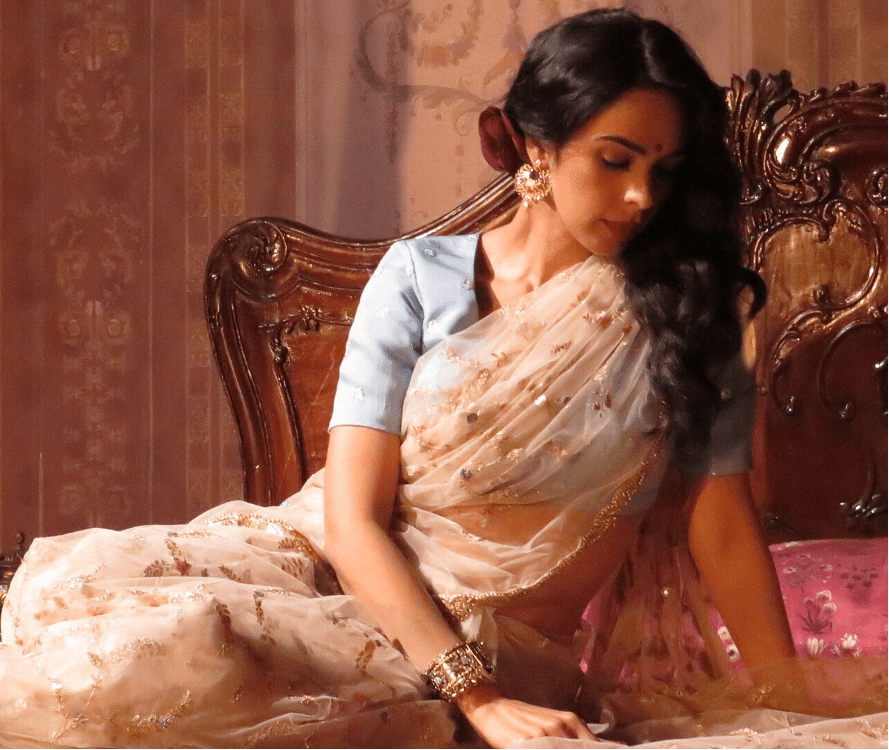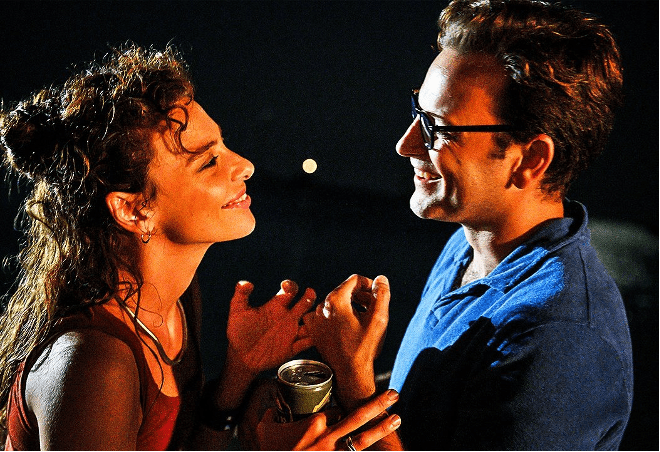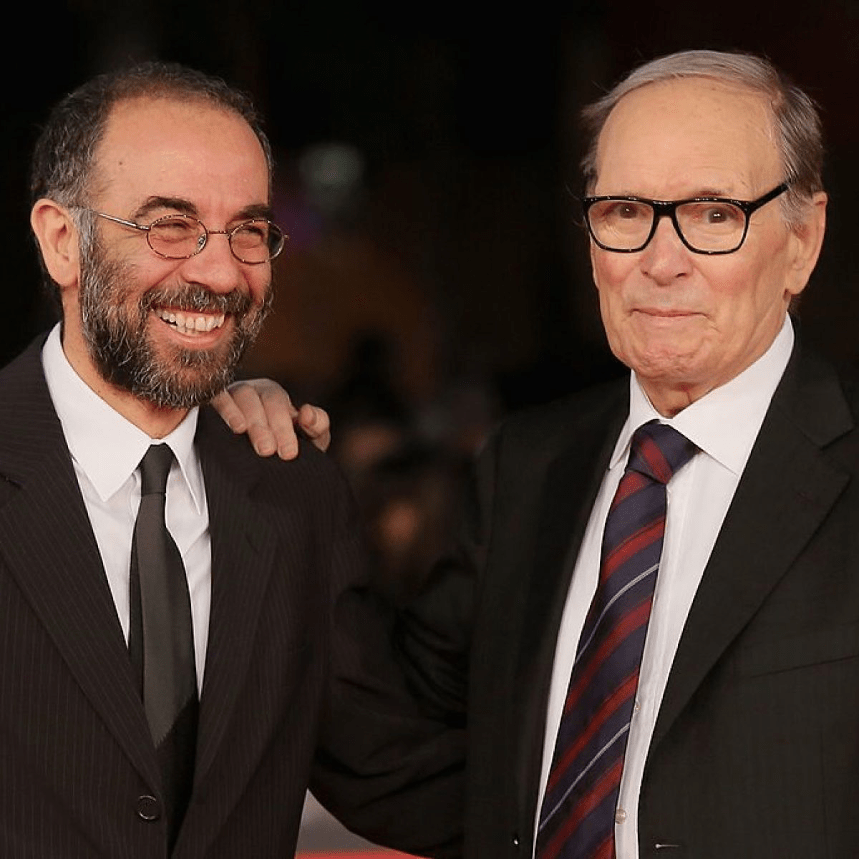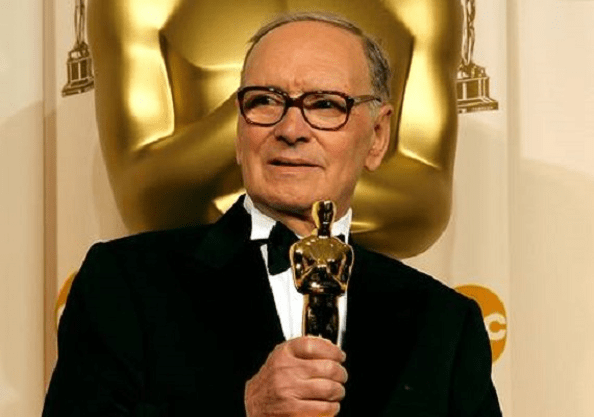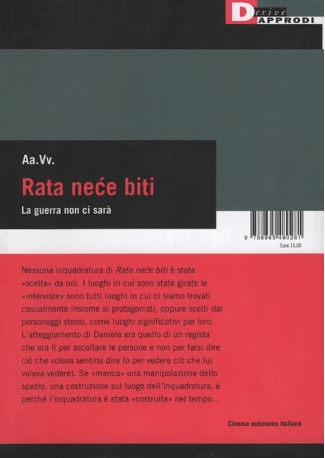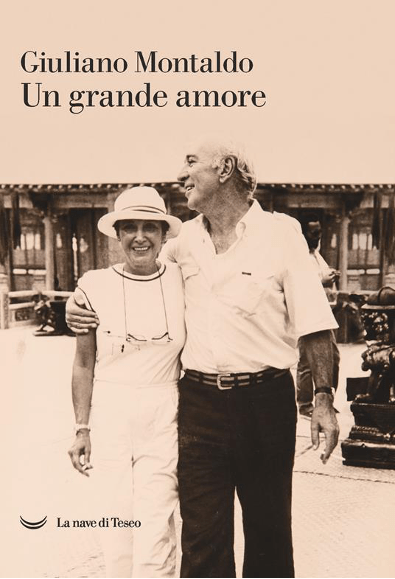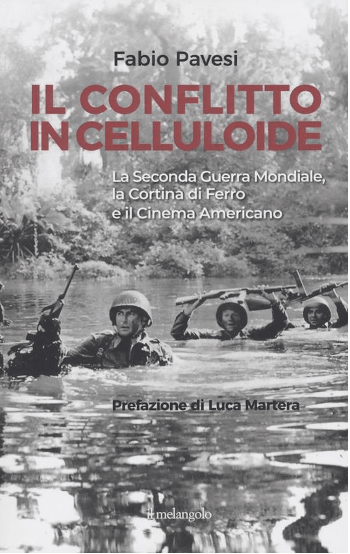Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI – DOSSIER PASOLINI
- 3 SAGGI
- 3.1 L’EREDITÀ DI BAZIN di Francesco Saverio Marzaduri
- 3.2 QUARANT’ANNI DI E.T. L’EXTRA TERRESTRE di Roberto Lasagna
- 3.3 “OSSESSIONE” DI LUCHINO VISCONTI E IL MITO DELLA LETTERATURA AMERICANA di Mario Galeotti
- 3.4 COSA VOGLIO DI PIU’, OGGI RIFLESSIONI (PERSONALI) SU “OTTO ORE NON SONO UN GIORNO” DI RAINER WERNER FASSBINDER di Paola Brunetta
- 3.5 ORE 9, CALMA PIATTA: “DIABOLIK” di Francesco Saverio Marzaduri
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 6 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre
- 7 OCCHIO CRITICO
- 7.1 IL CIMITERO DEGLI ELEFANTI: “OCCHIALI NERI” E “ENNIO” di Francesco Saverio Marzaduri
- 7.2 “L’ACCUSA” DI YVAN ATTAL di Tullio Masoni
- 7.3 LOZNITSA TRA DOCUMENTARIO E FINZIONE “BABI YAR. CONTEXT” E “DONBASS” DI SERGEJ LOZNITSA di Paolo Vecchi
- 7.4 “ATLANTIS” DI VALENTYN VASYANOVYCH: UNA TERRA DISTRUTTA di Marco Incerti Zambelli
- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 9 PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
- 10 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI – DOSSIER PASOLINI
PASOLINI E IL “CINEMA DI POESIA” di Maurizio Villani
L’articolo prende lo spunto dai due interventi che Pasolini fece nel corso dei dibattiti sul linguaggio filmico avvenuti alla Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro del 1965 e del 1966. Tra i temi trattati vi è il rapporto tra “cinema di poesia” e “cinema di prosa” e la polemica semiologica con Metz. Sono poi ripresi articoli critici e polemici dedicati agli stessi temi pubblicati nel 1972 nel volume Empirismo eretico
.
I CENTO ANNI DI PASOLINI di Tullio Masoni
Pasolini è stato profeta? E per quali conflitti verso la società neocapitalista, le ideologie, e verso se stesso? Un film “minore”, “La rabbia”, può dare qualche risposta.
PIER PAOLO PASOLINI E VITTORIO GASSMAN: DA “L’ORESTIADE (1960) A “L’ALTRO ENIGMA” (1988) di Roberto Baldassarre
Nel centenario di Pier Paolo Pasolini e Vittorio Gassman, una panoramica sulla loro particolare – e proficua – collaborazione teatrale. Dalla prima traduzione di Pasolini de L’Orestea di Eschilo (1960), fino alla trasposizione filmica di Affabulazione, nel 1988, da parte di Gassman.
SAGGI
L’EREDITÀ DI BAZIN di Francesco Saverio Marzaduri
Una riflessione su uno tra i decani della critica cinematografica in epoca di mutamenti, analitici e concettuali, inerenti all’immagine e la sua reiterazione.
QUARANT’ANNI DI “E.T.” di Roberto Lasagna
“E. T”. esce quarant’anni fa nelle sale americane, e nello stesso periodo esce anche “Poltergeist” di Tobe Hooper, prodotto dallo stesso regista di “E. T”. La doppia anima del fanciullesco e dello spaventoso si fondono nell’opera di un regista che trasforma il cinema e firma pagine in stato di grazia, accarezzando il linguaggio emotivo dei suoi personaggi e sfoderando un senso della suspense ma anche una notevole attenzione per il mondo interiore dei fanciulli. Quel bisogno di volare che il regista conserverà come un monito anche nel suo cinema futuro attraversato dalle guerre.
“OSSESSIONE” DI LUCHINO VISCONTI E IL MITO DELLA LETTERATURA AMERICANA di Mario Galeotti
“Ossessione”, opera prima di Luchino Visconti diretta nel 1942 e distribuita l’anno successivo, interpretata dai divi Massimo Girotti e Clara Calamai, rappresenta insieme ai film “4 passi fra le nuvole” di Alessandro Blasetti (1942) e “I bambini ci guardano” di Vittorio De Sica (1943) un capitolo fondamentale nella transizione tra il cinema degli anni Trenta e quello del dopoguerra. Ispirato al cupo romanzo americano di James M. Cain Il postino suona sempre due volte che, in quegli anni ancora inedito in Italia, si inseriva nel genere del poliziesco e più precisamente del noir, con ambienti e personaggi decisamente lontani dal miraggio del sogno a stelle e strisce, il film di Visconti è anche un film profondamente italiano. Infatti, spingendosi ben oltre la banale messinscena di altri film italiani del ventennio fascista che in precedenza avevano citato modelli letterari e cinematografici americani, pur scadendo a tratti nel melodramma “Ossessione” ha avuto il merito di annunciare non tanto il cinema neorealista tout court, quanto, nello specifico, quei film neorealisti del dopoguerra (diretti, tra gli altri, da Alberto Lattuada, Giuseppe De Santis, Pietro Germi) che avrebbero sovrapposto le forme narrative del cinema hollywoodiano e di altre espressioni della cultura di massa americana alla rappresentazione di una realtà inconfondibilmente italiana, indagata con intenti di scrupolosa analisi sociologica.
COSA VOGLIO DI PIÙ, OGGI: RIFLESSIONI (PERSONALI) SU “OTTO ORE NON SONO UN GIORNO” DI RAINER WERNER FASSBINDER di Paola Brunetta
Il saggio Cosa voglio di più, oggi è una riflessione sulla serie tv “Otto ore non sono un giorno” di Rainer Werner Fassbinder, datata 1972, restaurata e presentata alla Berlinale nel 2017 e ora trasmessa da Rai3; un’opera che ci mostra un Fassbinder diverso da quello a cui siamo abituati, sia perché si rivolge al grande pubblico (come aveva fatto, del resto, anche in altre occasioni, con film e sceneggiati), sia perché presenta dei personaggi ottimisti e gioiosi, sfrontatamente vitali, e delle situazioni che vengono affrontate, appunto, in maniera positiva e non drammatica. Un Fassbinder che fa ridere o sorridere, dunque, anche quando tratta temi impegnativi come quello del lavoro in fabbrica, e in genere i temi sociali.
La riflessione è condotta attraverso una vicinanza affettiva data dal fatto che i film del regista sono stati quelli che hanno spinto la scrivente verso il cinema d’autore, e da questa vicinanza si genera il confronto tra ieri e oggi, tra la visione di Fassbinder del passato e quella, filtrata dal tempo, del momento presente.
ORE 9, CALMA PIATTA: “DIABOLIK” di Francesco Saverio Marzaduri
Dopo la trasposizione “pop” di Mario Bava, un adattamento più classico del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani: il tentativo dei Manetti Bros. di fare del ladro mascherato un apologo teorico, scrupoloso nei risvolti psicanalitici prima che nel ritmo, non è impresa facile, tenendo conto il proposito di realizzare un film “di” e non “su” Diabolik. Se il rodaggio è il fine ultimo del primo episodio, in attesa dei successivi, prendiamo per buona l’ambiguità dell’esito quale coerente ossequio al “medium”, congelante il dinamismo del fotogramma a favore della staticità della favola.
Se la ventesima fatica di Dario Argento è una favola macabra permeata di tenera senilità, riconducibile a una memoria ludicamente anacronistica più che a una “rentrée” autoriale, l’undicesimo lungometraggio di Giuseppe Tornatore offre al pubblico la possibilità di udire un’ultima volta la voce (umana) di Morricone, seguendo la genesi di molti capolavori, nonché l’esigenza di confezionare un equo tributo a un altro uomo delle stelle. Un uomo, prima che un artista, segnato da glorie e vicissitudini, applausi e rimpianti, umiliazioni e riconoscimenti.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
LO STAGE NAZIONALE FEDIC: “UNA FANTASTICA OPPORTUNITÀ!” di Roberto Merlino
Un docente d’eccezione, Alessandro Grande al prossimo Stage della Fedic. Storia e futuro di un’iniziativa che riscuote un vero interesse.
FESTIVAL ED EVENTI
RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2021 di Maria Pia Cinelli
Per la sua 21a edizione (3-8 dicembre 2021) il festival fiorentino portavoce della cultura indiana è tornato finalmente anche in presenza, con un concorso avvincente e molto attento alle tematiche femminili, del quale presentiamo i titoli più singolari.
CORTINAMETRAGGIO 2022 – NOTE DI UN CRONISTA di Maurizio Villani
Sono riportate le notazioni di cronaca su ospiti e premiati, fatte alla XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri, rivolto alla scoperta dei giovani talenti della cinematografia breve italiana. La manifestazione cortinese ritorna per una settimana a svolgersi tutta in presenza, dopo gli anni del lockdown.
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre
“RENNEN” DI ALEXANDER KLIGE E PAUL KRUNTORAD di Roberto Baldassarre
“Rennen”, il secondo cortometraggio di Alexander Kluge, è stato realizzato poco prima della nascita del Nuovo cinema tedesco. Piccola opera documentaristica che conferma già quello sguardo critico dell’autore verso il mondo.
OCCHIO CRITICO
IL CIMITERO DEGLI ELEFANTI: “OCCHIALI NERI” E “ENNIO” di Francesco Saverio Marzaduri
Se la ventesima fatica di Dario Argento è una favola macabra permeata di tenera senilità, riconducibile a una memoria ludicamente anacronistica più che a una “rentrée” autoriale, l’undicesimo lungome-traggio di Giuseppe Tornatore offre al pubblico la possibilità di udire un’ultima volta la voce (umana) di Morricone, seguendo la genesi di molti capolavori, nonché l’esigenza di confezionare un equo tributo a un altro uomo delle stelle. Un uomo, prima che un artista, segnato da glorie e vicissitudini, applausi e rimpianti, umiliazioni e riconoscimenti.
“L’ACCUSA” DI YVAN ATTAL di Tullio Masoni
Un caso di stupro scomposto e ricomposto fra molti dubbi e contrasti, secondo la modalità del film giudiziario. Il dibattimento porta alla luce differenze, luoghi comuni, cultura di genere e drammi esistenziali.
LOZNITSA TRA DOCUMENTARIO E FINZIONE: “BABI YAR. CONTEXT” E “DONBASS” di Paolo Vecchi
Tra il 29 e 30 settembre 1941, i nazisti fucilarono 33.711 ebrei nella gola di Babi Yar,a nord-ovest di Kiev. Su questo orribile evento, per anni ignorato dai russi e dagli stessi ucraini, Sergej Loznitsa avrebbe voluto girare un lungometraggio di finzione, reso però impossibile dal Covid. Così il regista, bielorusso di nascita ma ucraino di adozione, ha realizzato un film di montaggio su materiali di repertorio.
L’autoproclamata Repubblica di Nova Rossyia, una società dove regnano l’aggressività e la corruzione, raccontata con tonalità grottesche che fatalmente virano al tragico, in 13 episodi, ognuno dei quali é realmente accaduto nei territori occupati nel 2014-2015. Il film, premio per la regia a “Un Certain Regard” di Cannes 2018, arriva oggi sui nostri schermi sull’onda dell’ ”operazione speciale” promossa da Putin.
“ATLANTIS” DI VALENTYN VASYANOVYCH: UNA TERRA DISRUTTA di Marco Incerti Zambelli
“Atlantis” di Valentyn Vasyanovych: una terra distrutta. Vincitore della sezione Orizzonti di Venezia 2019, il film distopico dell’autore ucraino mette in scena con straordinaria agghiacciante intuizione l’ipotetico dopoguerra nel 2025 dello scontro tra Russia e Ucraina nel Donbass, trova finalmente la via degli schermi italiani.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
IL SILENZIO, UN PRETESTO PER VIVERE. “RATA NECE BITI. LA GUERRA NON CI SARÀ” DI DANIELE GAGLIANONE di Marcello Cella
Il documentario di Daniele Gaglianone sul dopoguerra bosniaco racconta in modo radicale e struggente che cosa resta dopo una guerra nell’animo di chi l’ha vissuta sulla sua pelle.
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
Segnalazione – recensione di volumi di Giuliano Montaldo, Giuseppe Mallozzi, Fabio Pavesi e Marco Ballano – Marco Fedalto
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI – DOSSIER PASOLINI
PASOLINI E IL “CINEMA DI POESIA”
di Maurizio Villani

1 Pasolini e il dibattito teorico sul cinema tra gli anni ‘60 e ‘70 del Novecento.
In questo anno celebrativo del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini innumerevoli libri, saggi, articoli, documentari, hanno ricordato dai più diversi punti di vista la figura del più “inattuale” (in senso nietzschiano) degli intellettuali italiani del secolo scorso. Pasolini è stato poeta, romanziere, drammaturgo, saggista, regista, sceneggiatore, attore, documentarista. Si può dire che non gli sia stato estraneo nessun modo di partecipazione al mondo delle arti della comunicazione contemporanea. In questo articolo mi propongo di esaminare un aspetto particolare della sua attività: quella di protagonista del dibattito teorico sul cinema tra gli anni ‘60 e ‘70 del Novecento.
Verranno presi in esame gli interventi che Pasolini fece nelle prime tre edizioni della Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro.
Nel 1965, nell’ambito degli incontri “per una nuova critica”, Pasolini partecipò a una tavola rotonda su “La critica e il nuovo cinema”, dedicata alla critica semiologica del cinema; nel 1966, intervenne in un celebre dibattito con Christian Metz, Roland Barth e Gianni Toti, dal titolo “Per una nuova coscienza critica del linguaggio cinematografico”; nel ’67, partecipò all’incontro su “Linguaggio e ideologia nel film”.
Gli interventi pasoliniani in queste occasioni furono dedicati a un discorso teorico sulla distinzione tra “cinema di prosa“ e “cinema di poesia”(Il “cinema di poesia”, 1965) e al rapporto tra linguaggio cinematografico e realtà (La sceneggiatura come “struttura che vuol essere altra struttura”, 1966; La lingua scritta della realtà, 1966; seguono altri articoli e appendici, tra cui il Discorso sul piano sequenza ovvero il cinema come semiologia della realtà, 1967).
I testi delle comunicazioni fatte a Pesaro sono stati pubblicati nel 1972 in Empirismo eretico, un volume, edito da Garzanti e riedito nel 1991 con la prefazione di Guido Fink, che raccoglie scritti su questioni linguistiche, di critica letteraria e di teoria del cinema.
Nel ’68 il Festival di Pesaro fu contestato dal movimento studentesco, sulla spinta delle proteste che avevano portato all’interruzione a giugno del Festival di Cannes. Grazie anche all’intervento di Pasolini le istanze degli studenti furono accolte: la direzione si dimise e l’assemblea dei contestatori nominò un coordinamento tecnico che consentì la proiezione di tutti i film in programma senza svolgimento delle iniziative collaterali.
Le riflessioni teoriche di quegli anni vanno contestualizzate nel clima culturale che vedeva la semiologia assumere un’importanza crescente nell’interpretazione delle espressioni letterarie ed artistiche e nella critica cinematografica.
Nel 1964 ad impostare il dibattitto sulla interpretazione del linguaggio cinematografico in chiave semiologica fu un saggio di Christian Metz Il cinema: lingua o linguaggio? in cui il critico francese si interrogò se le metodologie semiologiche fossero applicabili al linguaggio del cinema. La sua risposta fu negativa, sintetizzata dalla definizione del cinema come “linguaggio senza lingua”: il cinema non presenta, a suo dire, le condizioni che i linguisti considerano necessarie perché lo si possa definire una lingua. Secondo Metz né le inquadrature corrispondono alle parole, unità minime di significato delle lingue (per il loro statuto assertivo, per il fatto di essere potenzialmente infinite e per il fatto di essere invenzioni del cineasta ‒ sono piuttosto simili a frasi); né nel cinema esiste un corrispettivo del fonema, a cui nella lingua si arriva suddividendo le parole: tagliando un’inquadratura, si troncano al tempo stesso porzioni di significante e porzioni di significato (un pezzetto di cielo che fa da sfondo all’inquadratura o il volto di un personaggio, ecc.). Problematica è anche la presenza del paradigma, ossia della terza condizione richiesta per l’esistenza di una lingua.
Tesi, queste, che saranno condivise da molti studiosi di impostazione semiologica, ma che verranno aspramente criticate da Pasolini, il quale, al contrario, teorizzò la natura del cinema come «lingua scritta della realtà» (di qui l’essere “eretico” del suo pensiero).
2 Il cinema come «lingua scritta della realtà»
Per Pasolini la lingua del cinema corrisponde alla lingua naturale del mondo, fatta di segni visivi. Pur non essendo segni linguistici, le immagini filmiche sono comunicative perché sono costituite dai gesti mimici, che appartenenti ad un patrimonio comune del vissuto umano e che completano la significatività del linguaggio verbale. Scrive Pasolini (1991, pp. 179-180): «Questo “sistema di segni mimici” della comunicazione orale che si intreccia col sistema di segni linguistici e lo integra, può essere isolato in laboratorio; e studiato come autonomo. Si può addirittura presupporre, per ipotesi astratta, l’esistenza di un unico sistema di segni mimici come unico strumento umano di comunicazione (tutti napoletani sordomuti, insomma): è su tale ipotetico sistema di segni visivi che il linguaggio cinematografico fonda la propria possibilità pratica di esistere, di essere presupponibile per una serie di archetipi comunicativi naturali».
Viene in mente il racconto dell’aneddoto che ha per protagonisti Ludwig Wittgenstein e Piero Sraffa. Il grande filosofo austriaco e l’altrettanto grande economista italiano insegnavano ambedue a Cambridge ed erano amici. Si racconta che un giorno, mentre discutevano della teoria raffigurativa del linguaggio elaborata dal cosiddetto “primo Wittgenstein”, teoria che postula un rigido isomorfismo fra linguaggio e mondo, Sraffa abbia posto un’obiezione decisiva, chiedendo all’amico di quale pezzo di mondo poteva mai essere la copia isomorfa di quel famoso “gesto napoletano e siciliano” che consiste nel passarsi le dita di una mano sotto il mento per esprimere rifiuto, disaccordo e/o disinteresse.
Le parole introduttive di Il “cinema di poesia”, (ivi, pp. 178-197), primo saggio di questa sorta di trilogia teorica sul cinema suonano così: «Credo che un discorso sul cinema come lingua espressiva non possa ormai cominciare senza tener presente almeno la terminologia della semiotica. Perché il problema, in parole molto semplici, è questo: mentre i linguaggi letterari fondano le loro invenzioni poetiche su una base istituzionale di lingua strumentale, possesso comune di tutti i parlanti, i linguaggi cinematografici sembrano non fondarsi su nulla: non hanno, come base reale, nessuna lingua comunicativa».
La strada per uscire dall’impasse che pare negare un fondamento al linguaggio cinematografico è offerta da questa osservazione preliminare (ivi, p. 180): «mentre la comunicazione strumentale che è alle basi della comunicazione poetica o filosofica è già estremamente elaborata, è insomma un sistema reale e storicamente complesso e maturo, la comunicazione visiva che è alla base del linguaggio cinematografico è, al contrario, estremamente rozza, quasi animale. Tanto la mimica e la realtà bruta quanto i sogni e i meccanismi della memoria, sono fatti quasi pre-umani, o ai limiti dell’umano: comunque pregrammaticali e addirittura pre-morfologici (i sogni avvengono al livello dell’inconscio, e così i meccanismi mnemonici; la mimica è segno di estrema elementarità civile ecc.). Lo strumento linguistico su cui si impianta il cinema è dunque di tipo irrazionalistico: e questo spiega la profonda qualità onirica del cinema, e anche la sua assoluta e imprescindibile concretezza, diciamo, oggettuale».
Se le cose stanno in questi termini, allora le operazioni creative dell’autore cinematografico e quelle dello scrittore differiscono: quest’ultimo, infatti, lavora solamente all’interno del sistema dei segni linguistici, trasformandoli secondo la sua invenzione estetico-culturale; diversamente dallo scrittore, l’autore cinematografico deve compiere dapprima l’operazione linguistica di organizzare il sistema dei segni-immagine in modo che acquistino una valenza significativa (mimetica, spaziale, onirica, mnestica, ecc.), poi aggiungere ai segni-immagine le qualità espressive. Mentre l’operazione dello scrittore è un’invenzione estetica, quella dell’autore cinematografico è prima linguistica poi estetica.
3 “Cinema di poesia” e “cinema di prosa”
In una lunga lettera scritta da Pasolini a Bellocchio in occasione dell’uscita del film “I pugni in tasca” (1965) si legge questo passo, in cui è bene sintetizzato il concetto pasoliniano di “cinema di poesia”: «Qual è la differenza fondamentale tra questi due tipi di cinema, il cinema di prosa e il cinema di poesia? Il cinema di prosa è un cinema in cui lo stile ha un valore non primario, non appariscente, non clamoroso: mentre lo stile del cinema di poesia è l’elemento centrale, fondamentale. In parole molto povere, nel cinema di prosa, non si sente la macchina da presa e non si sente il montaggio, cioè non si sente la lingua – la lingua traspare sul contenuto e ciò che conta è quello che viene narrato. Nel cinema di poesia invece si sente fortemente la macchina da presa, si sente fortemente il montaggio» (Pasolini, 1965).
Se sul piano dei valori estetici non pare dubbio che la lingua del cinema sia fondamentalmente una «lingua di poesia», sul piano storico Pasolini osserva che, in concreto, dopo alcuni tentativi all’epoca delle origini, subito troncati, la tradizione cinematografica che si è formata sembra essere quella di una «lingua della prosa» (naturalistica e oggettiva), per cui ne consegue che il cinema «ha una doppia natura: è insieme estremamente soggettivo e estremamente oggettivo. I due momenti di tale natura coesistono strettamente, non sono separabili neanche in laboratorio» (ivi). Ciò posto, Pasolini nota però che la tendenza della produzione filmica a lui contemporanea va verso un «cinema di poesia».
Fatta questa osservazione, Pasolini si pone la domanda come sia teoricamente spiegabile e praticamente possibile, nel cinema, la «lingua della poesia»? La risposta a questa domanda va cercata, a suo dire, fuori dell’ambito strettamente cinematografico, ossia sbloccando la situazione e agendo con la libertà assicurata da un rapporto particolare e concreto tra cinema e letteratura. Ne consegue una trasformazione della domanda: da «È possibile nel cinema una lingua della poesia?», alla domanda: «È possibile nel cinema la tecnica del discorso libero indiretto?».
Per intendere il senso di questa trasformazione della domanda occorre ricordare che in Il «cinema di poesia», affrontando la questione della duplice natura delle immagini cinematografiche, – le immagini dei sogni e dei ricordi, che rappresentano il versante soggettivo del linguaggio filmico e danno origine al “cinema di poesia” e le immagini naturalistiche e oggettive della realtà, di cui è costituito il “cinema di prosa” – Pasolini ha come fonte di ispirazione della dicotomia la critica letteraria. La scelta delle due definizioni di cinema rimanda alla corrispondenza tra tecniche di ripresa cinematografiche e pratiche di scrittura. Come in letteratura è possibile il “discorso libero indiretto”, così nel cinema è possibile usare un procedimento analogo, che Pasolini chiama “soggettiva libera indiretta”, ossia «l’immersione dell’autore nell’animo del suo personaggio, e quindi l’adozione, da parte dell’autore, non solo della psicologia del suo personaggio, ma anche della sua lingua».
Osserva al riguardo Daniela Angelucci: «L’adozione del punto di vista di un personaggio da parte dell’autore, da sempre usata in letteratura, incontra tuttavia nel cinema l’ostacolo di non potersi realizzare nella lingua, come accade nei romanzi, ma soltanto attraverso le immagini, dunque soltanto a partire dallo stile. Per esempio, l’analogo cinematografico del discorso diretto, tutto ciò che in un romanzo viene scritto tra virgolette, si traduce nel film in un gesto non linguistico ma stilistico, cioè nell’inquadratura “soggettiva”, che mostra allo spettatore la porzione di spazio che il personaggio stesso sta guardando.
Pur riconoscendo al cinema una doppia natura, di poesia e di prosa, è proprio un’ispirazione autenticamente lirica, fondata su nuove convenzioni stilistiche riunite in una nascente tradizione, che Pasolini riscontra nelle tendenze cinematografiche più recenti rispetto alla sua riflessione, da Rossellini alla Nouvelle vague. I film di Michelangelo Antonioni (in particolare, “Deserto rosso”)e di Bernardo Bertolucci (“Prima della rivoluzione”), come anche quelli di Godard (cui Pasolini riconosce una qualità più «brutale»), hanno come caratteristica tecnica centrale quella che in gergo si definisce la capacità di “far sentire la macchina”: ovvero far sì che lo spettatore avverta come presente il mezzo della cinepresa, restituendogli quella visione interiore che può chiamarsi “soggettiva libera indiretta”» (Angelucci 2013, p.151).

La teorizzazione del cinema come «lingua scritta della realtà» è presentata nel saggio Discorso sul piano sequenza ovvero il cinema come semiologia della realtà in cui Pasolini illustra quella che per lui è la differenza fondamentale tra cinema e film. Il cinema è la langue ossia l’insieme potenzialmente infinito di tutti i piani-sequenza possibili; i film sono la parole, ossia il risultato della scelta che l’autore compie all’interno degli infiniti piani-sequenza possibili, modifica a seconda delle sue esigenze espressive (soprattutto tramite il montaggio).
È superfluo ricordare che questa distinzione pasoliniana riprende, adattandola al linguaggio cinematografico, la classica teoria, esposta da Ferdinand de Saussure nel suo Corso di linguistica generale, che stabilisce la dicotomia linguistica tra langue e parole (termini francesi intraducibili in lingua italiana): il termine langue si riferisca ad un sistema significante indipendente e preesistente al singolo utente, comprendente tutte le regole, le convenzioni e i principi del linguaggio, senza i quali nessuna espressione significativa sarebbe possibile; il termine parole sta ad indicare l’atto linguistico singolare e irripetibile del parlante, la concretizzazione della langue che ogni utente fa nell’uso individuale del linguaggio e nella sua particolare e unica esecuzione.
4 «Il montaggio opera sul materiale del film quello che la morte opera sulla vita»
La riflessione sulla funzione del montaggio, fatta da Pasolini nel saggio del 1967 Osservazioni sul piano-sequenza (1967), propone un inquietante confronto tra il montaggio cinematografico e la morte. «Nella prospettiva che potremmo definire allegorica di questa riflessione (come scrive Bernardi, 1994, p. 106), che accomuna i segni visivi e mimici del cinema alla vita intera “nel complesso delle sue azioni”, la funzione del montaggio è quella di una chiusura e insieme di una produzione di senso paragonabile all’effetto che produce la morte sul racconto della vita di un essere umano» (Angelucci 2013, p. 152). Il saggio si apre con queste parole, a commento ad un film amatoriale girato al momento della morte di Kennedy: «Osserviamo il filmino in sedici millimetri che uno spettatore, tra la folla, ha girato sulla morte di Kennedy. Esso è un piano-sequenza; ed è il più tipico piano-sequenza possibile. Lo spettatore-operatore, infatti, non ha compiuto scelte di angoli visuali: egli ha semplicemente filmato da dove si trovava, inquadrando ciò che il suo occhio meglio che l’obiettivo vedeva. Il piano-sequenza tipico è dunque una “soggettiva”» (Pasolini 1991, p. 250).
Parrebbe un discorso “tecnico” sul cinema, ma, in realtà, ciò che preme a Pasolini è di sviluppare una vera e propria meditatio mortis a partire dal confronto tra cinema e vita. Così scrive: «È dunque assolutamente necessario morire, perché, finché siamo vivi, manchiamo di senso, e il linguaggio della nostra vita (con cui ci esprimiamo, e a cui dunque attribuiamo la massima importanza) è intraducibile: un caos di possibilità, una ricerca di relazioni e di significati senza soluzione di continuità. La morte compie un fulmineo montaggio della nostra vita: ossia sceglie i suoi momenti veramente significativi (e non più ormai modificabili da altri possibili momenti contrari o incoerenti), e li mette in successione, facendo del nostro presente, infinito, instabile e incerto, e dunque linguisticamente non descrivibile, un passato chiaro, stabile, certo, e dunque linguisticamente ben descrivibile (nell’ambito appunto di una Semiologia Generale). Solo grazie alla morte, la nostra vita ci serve ad esprimerci. Il montaggio opera dunque sul materiale del film (che è costituito da frammenti, lunghissimi o infinitesimali, di tanti piani-sequenza come possibili soggettive infinite) quello che la morte opera sulla vita» (Pasolini 1991, p. 254).

A commento di queste meditazioni, drammaticamente profetiche di Pasolini, meritano di essere citate queste riflessioni di Guido Fink, scritte nella Prefazione all’edizione di Empirismo eretico del 1991. Riferendosi all’uso di coppe alternative di concetti, ricorrente il Pasolini in modo quasi ossessivo, Fink scrive, citando anche alcuni esempi cinematografici: «Olmi come esempio di montaggio denotativo e Bertolucci come esempio di montaggio connotativo, il neorealismo dove “ciò che è insignificante, è” contrapposto a certo New American Cinema (Warhol?) dove “ciò che è, è insignificante”: e via fra questi (a) e questi (b), fra opposizioni e «biunità», fino ad arrivare alla grande e angosciosa scoperta (quasi) finale “o essere immortali e inespressi o esprimersi e morire” che rimanda al cinema (e alla vita, suo doppio e matrice omologa) come piano-sequenza potenzialmente infinito, insidiato dal “senso”, dalla durata e dalla morte solo al momento in cui si assoggetta alle scansioni del montaggio».
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA MINIME
Angelucci D. (2013), Filosofia del cinema, Carocci, Roma.
Bernardi S. (1994), Introduzione alla retorica del cinema, Le Lettere, Firenze.
Metz C. (1964), Cinéma: langue ou langage? in “Communications”.
Pasolini P.P. (1965), Pasolini scrive a Bellocchio, in Pasolini scrive a Bellocchio – Il Cinema Ritrovato
Pasolini P.P. (1991), Empirismo eretico [1972], Garzanti, Milano.
Pasolini: “Il mio cinema di poesia” – video – Rai News (Intervista in cui Pasolini distingue tra cinema di prosa e cinema di poesia)
Saussure de F. (1967), Corso di linguistica generale (Cours de linguistique générale, 1916) introd., trad. e commento di Tullio De Mauro, Bari, Editori Laterza.
I CENTO ANNI DI PASOLINI
dI Tullio Masoni
Rivendicare il centenario pasoliniano come parte tangibile della nostra realtà non è una forzatura. Pasolini ha vissuto il fascismo, la guerra, la speranza democratica della Resistenza e la delusione provocata dai mutamenti antropologici del paese. E’ stato ucciso nel 1975 e proietta, oltre il passaggio di millennio, la disperazione per il trionfo del “pensiero unico” avviato dal neocapitalismo e portato alle estreme conseguenze con l’identificazione fra politica e finanza.
In una trasmissione radiofonica Walter Siti, curatore dei Meridiani dedicati al poeta e della più recente edizione di Petrolio, ha sostenuto essere il romanzo – diseguale, sul piano stilistico volutamente ibrido, e largamente provvisorio – un contrappunto di ciò che l’autore esprimeva pubblicamente sui giornali nel periodo. In altre parole al Pasolini corsaro, e “razionale” nella polemica, avrebbe corrisposto una sperimentazione letteraria il bilico fra romanzo, pamphlet, requisitoria politica, ed erotismo “perverso”. Siti, insomma, vuole tener presente un conflitto irriducibile, cioè i contrari che il poeta ha sempre alimentato nell’opera e nella testimonianza; un conflitto che, a mio avviso, attinge a una forte vocazione profetica sulla quale Siti preferisce distinguere: «Quanto a Pasolini profeta – ha detto nella trasmissione radiofonica di cui sopra – ricorderete che aveva denunciato la scomparsa delle lucciole…Be’ le lucciole ci sono ancora.»
Il centenario ha, per così dire, riaperto il “dossier Pasolini” e ovunque si sono organizzate rassegne, convegni; la tv ha messo in onda materiali audiovisivi “storici”, si sono pubblicati libri e speciali giornalistici. E’ difficile, quindi, non cadere nel già detto e scritto. Sulla reale o presunta vocazione profetica, però, vale qualche ripensamento, che vorrei tentare approfittando del dvd pubblicato dalla Cineteca di Bologna. Esso comprende il recupero del materiale non utilizzato da Pasolini nel 1963 – quando accettò, dopo un iniziale rifiuto, che la seconda parte della “Rabbia” (1) fosse affidata a Giovannino Guareschi – la copia restaurata della prima parte, una raccolta di spezzoni satirici anti-pasoliniani Incom, e interventi dello stesso poeta, fra cui uno sulla ribellione di Socrate.
Pasolini si oppone alla Tv già da quando il nuovo media è in fase sperimentale: «…voce dell’insincerità, voce della menzogna…la voce che contrappone ironia a ideale, scherzo alla tragedia, il buonsenso degli assassini agli eccessi degli uomini miti…».
Parole, e azione, nel proprio tempo – cioè fra un passato sommariamente rifiutato dallo sviluppo e un futuro al quale la società efficiente aspira con cecità e malefico affanno – che davvero, a mio parere, rivelano la profezia. Una vocazione spesso definita dallo stile “manicheo” dei veggenti – anche questo è il caso – siano essi religiosi o laici.
Incline all’invettiva e a trasporre le modalità del tragico, Pasolini rinuncia perciò al comico – che, come testimoniano certi suoi acuti: “Uccellacci”, i corti, “Decameron”, gli è tutt’altro che estraneo (2) – in favore di una cupezza-severità assai funzionale al bisogno di provocazione e sfida. Come già accennato egli respinge in un primo momento l’idea di Gastone Ferranti, il produttore che con le due parti della “Rabbia” intendeva creare uno scoop da rotocalco contrapponendo il poeta all’umorista del Candido, ma poi accetta. Tragedia e scontro nell’immediato appaiono allora come due facce dello stesso pessimistico tormento: la denuncia in negativo dell’omologazione neocapitalista – che avrebbe potuto comportare una totale, sdegnata e “aristocratica” resa – e il bisogno di ricorrere al dialogo paradossale, allo scandalo. Non sarebbe successo anche nella polemica con gli studenti del sessantotto?
«Il nuovo problema del mondo si chiama colore». Con questa frase, nella “Rabbia”, Pasolini introduce la propria osservazione dei cambiamenti che, negli anni sessanta, ebbero al centro la fine della dominazione colonialista in Africa. Una libertà fragile e, al tempo stesso, una speranza. Su questi temi, pochi anni dopo, avrebbe offerto uno dei suoi più notevoli incompiuti: “Appunti per un’Orestiade africana”, un’opera che coniuga la verità della tragedia classica e l’ipotesi di una emancipazione moderna, ma rispettosa dell’arcaica identità.

…scenderà da Algeri, / su navi a vela e a remi. / Saranno con lui migliaia di uomini / coi corpicini e gli occhi / di poveri cani dei padri… (3) Così Pasolini vide le migrazioni che oggi sconvolgono la falsa coscienza dell’Europa, e, al tempo stesso, si ribellò a certo “luddismo” del Gruppo ’63. Fu, a proposito e per sfida, un postmoderno ante-litteram, ma “a rovescio”, ne “La ricotta”, dove seppe mostrare con sorprendente azzardo l’altra faccia dell’ibrido stravagante, cioè appunto la tragedia…guardo i crepuscoli, le mattine / su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, / come i primi atti della dopostoria, / cui io assisto, per privilegio d’anagrafe, / dall’orlo estremo di qualche età / sepolta. Mostruoso chi è nato / dalle viscere di una donna morta. / E io, feto adulto, mi aggiro / più moderno di ogni moderno / a cercare i fratelli che non sono più. (4)
“La ricotta”, del 1963, è considerato da quasi tutta la critica come il film più bello di Pasolini, o fra i più belli. “La rabbia”, girato subito dopo, è invece rimasto per molti anni in umori dubbiosi e spesso negativi. Cause di ciò furono la scarsa circolazione, l’“equivoco” accostamento al menzionato Giovannino Guareschi, la griglia ideologica pesante (il manicheismo che al poeta era polemicamente “necessario”), la fatale lateralità rispetto alle opere maggiori.
Fra i non molti critici che vollero occuparsene indicherei Adelio Ferrero il quale, in una monografia pubblicata nel 1977, scriveva: «…un’insolita polarità moralistica di indignazione generica, fioca e disarmata quanto più il timbro verbale si fa alto ed eloquente, e di “pietà” sempre troppo accorata e intenerita: sia che si pieghi a considerare, con apprensione, dei figli di padri troppo giovani, severi ed eroici, cresciuti fra prove e delusioni tremende, sia che si compianga, nella morte di Marylin, la scomparsa della bellezza dal mondo in quello che resta, comunque, il “capitolo” più equilibrato in un excursus in cui una delle componenti più flebili e monotone della personalità pasoliniana, l’inclinazione al lamento, altrove trattenuta e contrastata con energia polemica, appare scoperta e incontrollata…» (5)
Mettendomi nei suoi panni e considerando una collocazione coeva condividerei il giudizio in molti punti. Dall’oggi, invece, cioè dal declino in cui versa un mondo sempre segnato dalla guerra, dalla paura, e dal colpevole smarrimento politico civile e culturale, il conflitto pasoliniano – come dicevo, una sfida rivolta anche contro se stesso e un lamento eccessivo, certo, ma testimone dell’asfissia universale – può assumere una verità inusitata. Il “capitolo” su Marylin Monroe apparve a tanti come un’unica, felice parentesi poematica (…sciocca come l’antichità – Marylin – crudele come il futuro…), ma il brano con la morte di Pio XII e la successione di Giovanni XXIII – il Papa è immortalato da un ritratto affettuoso, nitido e “irriverente” – mi sembra superiore.
Sfugge poi a Ferrero, forse, che “La rabbia” vuole essere soprattutto un poema in forma di documentario. L’efficacia del montaggio, se si tiene conto delle preferenze linguistiche del regista nelle opere di finzione, appare sorprendente; il rapporto fra reperti visivi e parole tenderebbe infatti a superare la canonica amalgama per proporre scarto e, talvolta, provocatoria disarmonia. Di ciò si era ben accorto, nel 1965, Luigi Faccini: «…”La rabbia” è un film (…) intimamente pasoliniano…in quanto se esiste, ed esiste, un Pasolini specifico, oltre il suo variegato eclettismo, quello è il Pasolini politico: il poeta politico, l’unico che l’Italia moderna abbia, in cui possa riconoscere la propria crisi, costretto a soffrire il rimpianto di una rivoluzione mai avvenuta, a soffrire un ormai impossibile congiungimento fra gli anni ’40 e gli anni ’60…». (6)
Condivisibile e coraggioso, quindi controcorrente, il parere di Faccini eccede forse nell’attribuire il titolo di poeta politico al solo Pasolini – un lieve torto a Franco Fortini, per fare un nome – tuttavia usa il termine “eclettismo” con precisa ragione. Perché Pasolini è eclettico nel senso della ricerca di linguaggio e della drammaturgia; poi per la tendenza all’incompiuto, alla verifica di stili e maniere col ricorso, talvolta vitalissimo, alla forma semigrezza.
Per Pasolini la vera tragedia contemporanea è la scomparsa della civiltà contadina; ciò vale per i paesi capitalisti industrializzati, e per quelli socialisti che, scontando enormi limiti ideologici, si trovano costretti a rincorrere. Civiltà contadina come “cuore antico”, tradizione alta e autenticità del passato. Quel passato che secondo il commento della “Rabbia” – un richiamo a Lenin? – solo la rivoluzione può salvare.
Questa “verità” dolorosa alligna nel suo film già dall’intensa e sospetta rievocazione dei fatti d’Ungheria: le “colpe di Stalin”, che la voce di Giorgio Bassani nomina ricorrentemente, hanno come sfondo visivo la violenza esplicita delle sommosse e quella delle manifestazioni di destra, ma altresì una violenza nascosta di migrazioni dalle terre, di oblio e identità calpestate. Nella “Rabbia” il poeta si abbandona come sempre alla contraddizione, la stimola e ne assume le conseguenze. Così trascorre dall’avvenimento di importanza primaria (“strutturale”, si diceva a quei tempi), alla nota di costume; oppure alterna contrasto a simbiosi. E non si dimentichi, soprattutto, la sua improba, direi perfino angosciata volontà di mantenere il contatto con le linee di analisi dell’allora Partito Comunista; un tentativo fallito perché la libertà poetica, oltre le forzature imposte alla propria materia e una sincera intenzione di darsi speranza, non poteva davvero combinare con l’ordine di Alicata.
A questo punto viene in primo piano la contraddizione – la debolezza, se si vuole – implicita a una scelta di schieramento nel dibattito dell’arte. Pasolini sceglie il versante “realista” contro gli astrattisti. Non ci sono facili equilibri da tenere. Già amico di un pittore come Toti Scialoja – che da un personale espressionismo di ascendenza romana ancora figurale (Mafai…) aveva intrapreso una ricerca affine a quella compiuta dai Pollock, De Kooning, Rotko – il poeta, nella “Rabbia”, sembra affidare consapevolmente la polemica anti-astratta a Renato Guttuso. Se il discorso si fermasse qui, cioè a una inaccettabile identificazione fra il “fascino” visivo del fungo atomico e le superfici segniche di un Fautrier (un esercizio formale senz’anima) ci si dovrebbe rassegnare alla pura delusione, o deprecare un mai superato revanscismo moralista, ma qui, grazie al cielo, il discorso non si ferma.
Ricercando volti antichi e sguardi umili – c’è nel poeta una instancabile volontà di guardare oltre le necessarie conquiste sociali per ritrovare, quasi francescanamente, l’essenza del povero – Pasolini osserva l’impatto della modernità sulla tradizione russa, ci mostra vegliardi tolstojani davanti al televisore, ci accompagna in visita al museo in cui si celebra il “realismo socialista”: luogo dove anche i poveri possono finalmente entrare e che tuttavia appare al poeta nella luce dubbia del trionfo – staliniano, pur sempre – e dell’imbalsamazione. Così, pur cedendo a un equivoco anti-astrattista che lo avvicina, per quanto concerne le arti figurative, al sarcasmo strapaesano del Guareschi della seconda parte, Pasolini riesce ad affacciarsi su una suggestione nuova.
L’impresa di Gagarin, accompagnata da un entusiasmo collettivo di festa campestre e da un Kruscev dall’aspetto patriarcale-contadino è sublimata, nel finale della “Rabbia”, da un incanto di visioni spaziali. Una alternativa al fascino insano del fungo atomico, certo, ma al tempo stesso una proposta di forme inusitate, grandiose quanto essenziali: astratte. Vero è che Pasolini, e non poteva essere diversamente, si sforza di far rientrare l’impresa in un certo quadro di ortodossia – Gagarin è pur sempre un figlio della Rivoluzione d’Ottobre – ma l’azzardo visionario mi pare assai più forte che non la preoccupazione ideologica.
Riprenderei a proposito, per trovare conforto, il testo di una poesia poco nota, pubblicata nel 1962, in una cartella di disegni guttusiani: C’è un colore antico come tutti i colori / del mondo. Quanto l’abbiamo amato / quasi incarnato nel legno di miracolose / predelline, in refettori romanici, / nel buio di cantorie nell’Appennino estivo! (…) Ora eccolo nelle nostre mani / non più incarnato nelle tele o ai legni / in macchine di bellezza sublime, richieste / dal meriggio della potenza. / Un ingenuo rosso maldestro, appiccicato / alla carta o al compensato / come un baffo o uno sgorbio, legato / alla freschezza casuale e arbitraria / di un atto espressivo che non si vuol esaurire. / Illegittimo, incompiuto, grezzo, / non consacrato dalla tecnica che incute / venerazione al devoto, all’umile…/ Un’altra sensualità, un altro mistero…/ Ma è fatale che oltre questi anni / il casuale diventi intero, / l’arbitrario assoluto. / I significati diverranno cristalli: / e il rosso riprenderà la sua storia / come un fiume scomparso nel deserto. /Il rosso sarà rosso, il rosso dell’operaio / e il rosso del poeta, un solo rosso / che vorrà dire realtà di una lotta, / speranza, vittoria e pietà. (7)
Ecco dunque, l’impuro pasoliniano si forma nei travagli epocali per cercare una nuova comunione tra vita e arte. Guttuso viene compreso e superato, la schiettezza di un’arte autenticamente umana passerà per il gesto visibile, per la testimonianza del corpo, per la casualità che travalica i codici e guarda l’infinito. Non con la memoria di Togliatti e le cadute nazional-popolari, non fra le perversioni della guerra fredda, e neppure con la faccia contadina di Kruscev, dovremo immaginare la sublimazione pasoliniana. La sua elevata ambiguità andrà sempre riportata alla coscienza di uno sterminio culturale che dura e si espande con velocità sempre maggiore. La rivoluzione sovietica è fallita e resta la ricordata frase da Lenin sul passato da salvare; o la sentenza amara che, sempre nella “Rabbia”, si propone ancora per l’oggi: «…Quando il mondo classico sarà esaurito, quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani, quando l’industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione e del consumo, allora la nostra storia sarà finita…».
Quasi vent’anni dopo, col “Decameron”, il poeta sembra avere un sussulto di risposta alla deriva della società industrial-borghese e al modo con cui l’aveva rappresentata nell’opera propria. Ma la vitalità del “Decameron”, subito insidiata dai toni lugubri del “Canterbury” e dai rovesci di violenza del “Fiore delle mille e una notte”, appare come un sogno nel passato: « …Napoli è la porta dell’Africa, dell’Oriente e del Terzo Mondo – scrive Massimo Raffaeli – è cioè un luogo non ancora adulterato e massacrato dalla cosiddetta civiltà dei consumi. Il poeta, che nel film tiene per sé il ruolo metalinguistico di un allievo settentrionale di Giotto mentre sta affrescando Santa Chiara, sente il bisogno di filmare un meraviglioso popolo di sopravvissuti, di ascoltarne le voci, gli strepiti, i canti.» (8)
Post-scriptum
In un brano di intervista raccolto nell’appendice del dvd pubblicato dalla Cineteca di Bologna, Pasolini parla delle persecuzioni subite e le attribuisce a un senso comune nazionale moralista e, al tempo stesso, qualunquista. Come anticipavo, l’appendice riporta poi spezzoni satirici d’epoca: Pasolini inedito; E per finire, dalla Settimana Incom 1961 e 1960, Obiettivo sulla cronaca, da Celeidoscopio Ciac, 1962, e una scenetta da Scanzonatissimo, uno spettacolo di rivista firmato da Dino Verde nel 1963, con Elio Pandolfi, Antonella Steni e Alighiero Noschese.
Sulla volgarità della satira non vorrei dilungarmi ma, in tema di persecuzione – e di modalità della stessa – posso dare una piccola ma significativa testimonianza.
Nel 1964 abitavo a Roma in via Nomentana Nuova, un quartiere impiegatizio, perlopiù, ma non lontano da Pietralata. Avevo diciotto anni scarsi e di Pasolini, come di politica, non sapevo niente. Uscendo dal portone notai dei volantini sparsi a terra e ne raccolsi uno. Chi è Pasolini? Recitava il titolo, cui seguiva un elenco di processi e denunce – cinque assoluzioni, un proscioglimento – volto a illustrare la personalità culturale e morale del poeta. Il volantino, dopo aver riportato qualche frase “borgatara” da Una vita violenta chiudeva con le parole: “Questo è l’uomo e lo scrittore che viene spacciato nei fatti come interprete autentico del divino messaggio evangelico”.
Un volantino sparso per strada, come accadeva in campagna elettorale, che prendeva di mira una persona singola: un comunista, ateo e omosessuale, e protestava in nome della buona creanza cattolica. A promuovere l’iniziativa era una non meglio nominata Associazione Romana. Una sigla – ripensai tempo dopo – che teneva assieme l’allusione alla maggiore organizzazione cattolica e la qualifica “imperiale” del ventennio fascista.
Note
- La rabbia di Pasolini. A cura di Giuseppe Bertolucci, 2008
- Negli ultimi anni Pasolini confidava che avendo perso ogni speranza sarebbe stato un “vecchietto arzillo”.
- La poesia, scritta presumibilmente nel 1962 e dedicata a Jean-Paul Sartre, fu inclusa nella raccolta Poesia in forma di rosa, 1964, e successivamente nel volume Alì dagli occhi azzurri, Garzanti 1965.
- I versi sono declamati da Orson Welles nel film La ricotta, 1963. Poi inclusi in Poesia in forma di rosa, cit.
- Il cinema di Pier Paolo Pasolini, Venezia, Marsilio, 1977
- Filmcritica n.161, 1965
- Roma, Editori Riuniti, 1962
- Il manifesto/ Alias domenica, 20 marzo, 2022
PIER PAOLO PASOLINI E VITTORIO GASSMAN:
DA L’ORESTIADE (1960) FINO A “L’ALTRO ENIGMA” (1988)
di Roberto Baldassarre
Pier Paolo Pasolini (1922-1975) e Vittorio Gassman (1922-2000), due dei massimi esponenti della cultura italiana del Novecento, che condividono l’anno di nascita (e correlato centenario), hanno avuto un rapporto collaborativo che si è compiuto soltanto in ambito teatrale. Una cooperazione, però, a tutto vantaggio di Gassman, che ha divorato con il suo estro – da intendere come bravura – i testi di Pasolini, ovvero Affabulazione e la traduzione dell’Orestea di Eschilo. Questo superamento fa tornare alla mente quanto diceva il corvo ai due protagonisti plebei di “Uccellacci e uccellini” (1966): «I maestri sono fatti per essere mangiati… in salsa piccante. Devono essere mangiati e superati, ma se il loro insegnamento ha un valore, ci resterà dentro».
Gassman ha mangiato in salsa piccante Pasolini, e lo ha digerito superandolo, ma non in un senso completamente giusto, poiché l’attore ligure a portato il pensiero dello scrittore nel suo campo, conservando soltanto alcuni aspetti “pasoliniani” e poi riadattandolo alle sue specifiche di recitazione/regia. Questo atteggiamento di appropriazione fa anche comprendere come la collaborazione tra i due non si è mai potuta concretare direttamente in pellicola. Cogliendo quanto Gassman si fece incidere –con l’usuale punta di egocentrismo – come epitaffio sulla tomba, conscio di questa sua bravura istrionica: ATTORE “Non fu mai impallato”!. L’attore, capace di passare dal drammatico al farsesco, non sarebbe mai stato capace, o avrebbe accettato, di farsi “impallare” da Pasolini e dal personaggio che avrebbe dovuto interpretare; a differenza di Totò, Anna Magnani (che comunque in Mamma Roma eccedeva un poco con l’accademismo), Ugo Tognazzi e finanche Orson Welles, che si sono amalgamati perfettamente.
L’ORESTIADE (1960)
Sul finire del 1959, Vittorio Gassman chiese a Pasolini di preparargli un’innovativa traduzione della trilogia dell’Orestea di Eschilo, per l’imminente trasposizione teatrale che si sarebbe tenuta al Teatro greco di Siracusa, sotto la regia di Luciano Lucignani, a maggio del 1960. Inizialmente restio, poiché non interessato alla scrittura teatrale, sebbene in gioventù avesse redatto alcune piéces, tra cui I Turcs tal Friùl (redatta nel 1944, ma rinvenuta e pubblicata soltanto nel 1976), Pasolini approntò una traduzione che si allontanava dagli usuali schemi accademici. Questo nuovo adattamento, che raccolse molti applausi e fu annoverato fra le migliori interpretazioni teatrali di Gassman, suscitò molti malumori nei filologi greci, proprio per quell’approccio polemico distante dai canoni classici. Il testo, che con il passare del tempo divenne uno dei più utilizzati per i futuri allestimenti dell’Orestea, fu pubblicato contemporaneamente in due edizioni: una propria attraverso l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, che serviva anche da depliant per l’evento; l’altra dall’Einaudi, accompagnata dai bozzetti di Theo Otto.
L’Orestiade, che si tenne al Teatro greco di Siracusa il 19 maggio del 1960, si svolse dalle due del pomeriggio fino al tramonto, senza cali d’attenzione da parte del pubblico. Il merito di questo tour de force scenico fu di tutta la troupe. La regia fu co-firmata da Luciano Lucignani e Vittorio Gassman; le scenografie e i costumi furono ideati e curati da Theo Otto; e le musiche erano di Angelo Musco. Mentre il ricco cast che attorniava il mattatore Gassman (Agamennone-Oreste) era composto, tra gli altri, da: Olga Villi (Clitennestra), formidabile interprete delle tavole del palcoscenico, poiché abile nel passare dalla commedia al dramma, nel cinema la si ricorda, al fianco di Totò, nel mesto dramma “Yvonne la nuit” (1949) di Giuseppe Amato; Valentina Fortunato (Cassandra-Elettra-Atena), altra nota attrice del teatro italiano, fu poco utilizzata nel cinema, e il suo ruolo cinematografico più “importante” fu il doppiaggio di Annie Girardot in “Rocco e i suoi fratelli” (1960) di Luchino Visconti; Andrea Bosic (Egisto), mirabile attore di prosa, nel cinema veniva prevalentemente usato in produzioni di serie B, ma nel 1959 aveva avuto qualche scena comica con Gassman nel film “La cambiale” di Camillo Mastrocinque; il giovane Mino Bellei (componente del coro maschile), in futuro sarà un apprezzato commediografo, e dirigerà – e interpreterà – per il cinema l’inusuale queer “Bionda fragola” (1980).
Per comprendere, a distanza di decadi, la rilevanza di questo allestimento scenico, riconosciuto dagli storici come uno dei vertici del teatro italiano del Novecento, è utile guardare il breve documentario-saggio “Gassman, Pasolini e i filologi” (2005), realizzato da Monica Centanni e Margherita Rubino. In questo corto, montato attraverso il ripescaggio di raro materiale d’archivio video e l’aggiunta della scansione di recensioni tratte dai periodici dell’epoca, si ricostruisce tanto l’applaudito successo ottenuto dall’allestimento, quanto le aspre critiche tuonate dai “tromboni” delle accademie contro la traduzione effettuata da Pasolini.
IL VANTONE (1963)
Rimasto soddisfatto della propria “scandalosa” traduzione dell’Orestea, e avendo apprezzato la recitazione istrionica di Vittorio Gassman, Pasolini decise di dedicarsi alla traduzione di un altro testo classico, per poi proporla a Gassman. L’idea pasoliniana era quella di tradurre il Miles Gloriosus di Plauto, una delle più note commedie latine, utilizzando il dialetto romano. Dopotutto, il protagonista del testo di Plauto è l’archetipo dei bulli di fine Ottocento e dei seguenti smargiassi ragazzi di vita. Senza dimenticare che dalle commedie plautine molti sceneggiatori hanno attinto per le proprie sceneggiature, aggiornando il contesto ma conservando i caratteri di quei personaggi.
Gassman, benché ligure, era capace di calarsi facilmente in un romano di borgata, come può attestare il suo Peppe “er Pantera” ne “I soliti ignoti” (1959) di Mario Monicelli, che segnò il suo esordio nel cinema comico, dopo anni di ruoli drammatici, film avventurosi e figure di villain all’americana. Queste sue enormi doti istrioniche sarebbero state perfette per vestire i panni di uno spaccone romano, che non vuole essere mai impallato.
Il vantone, questo fu il titolo finale, purtroppo non fu interpretato da Vittorio Gassman, per questioni poco chiare (impegni lavorativi o disaccordi sul contratto), e il primo allestimento scenico, nel novembre del 1963 con la regia di Franco Enriquez, vide come protagonisti Glauco Mauri affiancato da Valeria Moriconi. Questa trasposizione teatrale non ottenne molto successo. Un vero allestimento scenico pasoliniano, però, si ebbe nel 2015, durante il Festival dei due mondi di Spoleto, quando Il vantone ebbe come protagonista Ninetto Davoli. L’attore feticcio di Pasolini, visto dallo scrittore come un personaggio innocente e angelico (il taglio d’inquadratura flou che Pasolini gli dedica in “Il Vangelo secondo Matteo”, esordio di Davoli), ha interpretato giovani borgatari vantoni: “Uccellacci e uccellini” (le sparate per concupire la giovane ragazza); nell’episodio “La sequenza del fiore di carta” del collettivo “Amore e rabbia” (sbeffeggia gli operai); ne “Il Decameron” (si pavoneggia); e in “Il fiore delle mille e una notte” (si crede un adone).
Infine, da mettere in evidenza che Daniele Ciprì e Franco Maresco, due autori post-pasoliniani, recuperando giocosamente il titolo “Miles Gloriosus”, lo utilizzarono per il loro tributo a Miles Davis, nell’omonimo documentario realizzato nel 2001. Il trombettista americano, in fin dei conti, fu un vantone, benché le glorie di cui si vantava erano tutte meritate.
AFFABULAZIONE (1977)
Affabulazione fa parte di quei sei abbozzi di tragedie che Pasolini scrisse di getto nel 1966, nel periodo di convalescenza dopo l’emorragia da ulcera che lo colpì in primavera. Le altre tragedie abbozzato erano: Orgia, Pilade, Porcile, Calderón, Bestia da stile. Anche “Teorema”, inizialmente, era stata pensata come una piéce teatrale, ma i pochi dialoghi della storia convinsero Pasolini che il pezzo sarebbe stato molto più funzionale come sceneggiatura cinematografica e come romanzo speculare. Affabulazione è una rilettura contemporanea del Complesso di Edipo, traslando il tema dell’incesto in ambito omosessuale. Fu pubblicato inizialmente su “Nuovi argomenti” (numero luglio-settembre) nel 1969, e poi definitivamente da Einaudi nel 1977, accorpandolo a Pilade e con un’introduzione di Attilio Bertolucci. Fu proprio questa edizione quella che lesse e ammaliò Vittorio Gassman.
Stando a quanto afferma lo stesso attore, in un’intervista rilasciata a Paese Sera il 14 gennaio 1986 (“Nascosto nei versi del poeta”), Gassman s’innamorò di Affabulazione mentre era in aereo per andare a New York. Una epifania letteraria molto simile a quella che ebbe Pier Paolo Pasolini, che (ri)scoprì “Il Decameron” in un viaggio aereo, dopo il cocente insuccesso di “Medea” (1969). Gassman, sebbene rilevasse nel testo delle cadute di stile e degli inutili ghirigori espressivi, apprezzava l’asperità dei dialoghi, oltre alla scandalosa tematica.
La regia fu curata dallo stesso Gassman, e il cast era composto da: Luca Del Fabbro (il figlio), giovane attore di teatro e doppiatore (Mr. Pink in “Le iene” di Quentin Tarantino), e che recitò anche in “Caro Michele” (1976) di Mario Monicelli; Corrado Gaipa (l’ombra di Sofocle), noto doppiatore e famoso per il ruolo di Don Tommasino ne “Il Padrino” (1971); Attilio Cucari (Il prete e il commissario), divenuto cinematograficamente popolare poiché Vittorio Gassman in “La raccomandazione”, secondo episodio de “I mostri” (1963) di Dino Risi, raccomanda telefonicamente a un altro regista teatrale tale Cucari; Roberta Paladini (la ragazza), anch’essa più attiva nel campo del doppiaggio, un paio di anni prima doppiò Jodie Foster per l’edizione italiana di “Taxi Driver” (1975) di Martin Scorsese; Vanna Polverosi (la negromante), usualmente doppiatrice di personaggi di secondo piano, nel cinema ha avuto pochissime occasioni, ricoprendo sempre ruoli di contorno. Nel folto cast, figura anche Alviero Martini (1950), divenuto poi molto più noto – e ricco – come stilista.
Questo allestimento, che esordì al Teatro tenda di Roma nel novembre del 1977, facendo sempre sold out, divenne una tappa fondamentale nella carriera di Vittorio Gassman, che lo consacrò maggiormente come formidabile interprete e regista teatrale. Un successo che andava al colmare il calo interpretativo che Gassman stava subendo, nel medesimo periodi, al cinema: ruoli poco interessanti e non da protagonista. Ad esclusione della sua formidabile interpretazione nel plumbeo dramma “Anima persa” (1977) di Dino Risi.
Il trionfale esito di Affabulazione, inoltre, spinse i produttori Gianfranco Piccioli e Mauro Berardi a “costringere” Sergio Citti a utilizzarlo come co-protagonista, assieme a Philippe Noiret, in “Due pezzi di pane”. L’idea dei produttori, rivelatasi stilisticamente errata, era quella di rendere più “pasoliniano” il film di Citti, cavalcando tanto il recente trionfo di Gassman con Pasolini, quanto il fatto che Citti fu collaboratore insostituibile dello scrittore.
AFFABULAZIONE (1986)
All’inizio del 1986, Vittorio Gassman riprese il testo di Affabulazione per apportarvi un completo restyling, attraverso alcune modifiche ai dialoghi, alla messa in scena (con scenografie e costumi di Gianni Polidori), e a un totale cambio di cast, che fu ridimensionato. L’aspetto più interessante di questo nuovo allestimento, è che per il ruolo del figlio Gassman scelse suo figlio Alessandro, in versione biondo platino, che aveva debuttato proprio con il padre nel film “Di padre in figlio” (1982). Anche questa nuova trasposizione, che utilizzava pezzi di Franz Mahler e Benjamin Britten (a differenza del 1977, in cui le musiche erano di Giovanni Gabrielli riarrangiate da Fiorenzo Carpi), ottenne molti consensi, facendo si che Affabulazione divenisse sempre più un’opera di Gassman, più che di Pasolini. Il resto del cast era composto da: Paila Pavese (la moglie e la negromante), nota per aver dato la voce a Jessica Rabbit in “Chi ha incastrato Roger Rabbit” (“Who Framed Roger Rabbit”, 1988) di Robert Zemeckis; Sergio Meogrossi (il prete), giovane attore cresciuto artisticamente nella bottega di Gassman, e che poi lo seguirà in molti altri allestimenti; Giusi Cataldo (la fidanzata del figlio), la si ricorda cinematograficamente per aver preso parte al corale “Compagni di scuola” (1988) di e con Carlo Verdone, ed esser stata la protagonista di “Corsa di primavera” (1989) di Giacomo Campiotti.
“L’ALTRO ENIGMA” (1988)
Corroborato dall’ottimo esito di questa seconda messa in scena, e sempre più affezionato al testo di Pier Paolo Pasolini, Gassman, nel medesimo 1986, decise di ricavare da Affabulazione un film per la televisione, attraverso il patrocinio della Rai, e apportando ulteriori modifiche al testo (per renderlo abile al racconto cinematografico) e soprattutto al cast. Inizialmente la pellicola doveva intitolarsi “Doppio enigma”, ma poi prese il nome di “L’altro enigma”, e Gassman lo co-diresse assieme a Carlo Tuzii. Del cast originale del 1986 rimasero soltanto Vittorio e Alessandro Gassman, Giusi Cataldo, e Sergio Meogrossi. Le nuove ricche aggiunte, imputabili anche alla co-produzione francese, sono: Annie Girardot (la moglie), che aveva lavorato con Vittorio Gassman in “La guerra segreta” (“The Dirty Game”, 1965) e lavorerà con Alessandro Gassman nel Tv-Movie “Nuda proprietà vendesi” (1998) di Enrico Oldoini; Fanny Ardant (la negromante), che aveva affiancato Vittorio Gassman in “La famiglia” (1987) di Ettore Scola; Carlo Monni (il commissario), ormai staccatosi da Roberto Benigni e divenuto caratterista a tempo pieno; e Ninetto Davoli (il barbone), vero omaggio a Pier Paolo Pasolini, e che diviene quasi simbolo di un residuo di una lontana epoca che permane, gettata per strada, nel presente.
SAGGI
L’EREDITÀ DI BAZIN
di Francesco Saverio Marzaduri
Cosa lascia André Bazin, a più di sessant’anni dalla sua scomparsa? Stando al lavoro certosino firmato da Hervé Joubert-Laurencin e all’impegno della casa editrice Macula – che ne han reso possibile il complessivo riesame con la pubblicazione, in patria, di testi ormai poco frequentati e reperibili – il pensiero di questo decano della critica cinematografica rivela come la propria attualità non abbia smarrito una virgola dell’originaria freschezza nell’esegetica, né di un modo di concepirla. Nella fattispecie, la ridefinizione d’un linguaggio fattosi tratto distintivo da oltre mezzo secolo a questa parte, soprattutto in relazione alla recente produzione audiovisiva e alla conseguente rimodulazione della pratica cinematografica contemporanea, consente di riflettere sullo stato attuale dell’arte, e su talune possibili traiettorie individuabili nell’odierna produzione audiovisiva di cui, alcune, legate a doppio filo alle intuizioni baziniane. Invero non basterebbe un capitolo, a racchiudere la genialità di tale sintesi. Sciocco sarebbe, anzi, cercare di condensarne il nocciolo in una sorta di aggiornato bignami. Eppure, scorrendo il magma di pagine da lui dedicate alla cinematografia, si resta colpiti dalla concezione di “sacralità”, futura materia – se non privilegiata fonte di studio – dei numerosi discepoli destinati a seguitarne il percorso e, se possibile, senza venir meno alla doverosa considerazione, ridiscuterlo. La necessità di rammentare Bazin, nell’era in cui web e piattaforme paiono aver abolito e sostituito il fotogramma cinematografico a scapito d’idee, è resa più necessaria dal crescente disinteresse nei confronti del paradigma critico che propone: benché la terminologia impiegata dal francese possa suonare oggi troppo elaborata, ridondante, faticosa in disamine e dettagli, non può esservi confronto con alcun parametro dozzinale svilito da troppi vaniloqui di dubbia lucidità, quando non di artefatta insignificanza.
Seguendo l’inversa logica, e nel tentativo di applicare un ragionamento di Bazin a un esempio tra centinaia, si prenda uno spezzone tratto dal morettiano “La stanza del figlio”: nel vano tentativo di esorcizzare la tragica, assurda scomparsa dell’adolescente Andrea, il padre Giovanni (impersonato dallo stesso Moretti) ascolta “Synchronising” di Michael Nyman e a un certo punto – telecomando in mano e sguardo perso nel vuoto – a più riprese riavvolge il brano riportandolo a un medesimo punto, anelando di oscurare la dolorosa realtà con un impossibile “coming back”. Ciò che in superficie potrebbe apparire fuorviante, o blandamente fuori contesto, riporta alla mente l’inchiostro del teorico relativo alla concezione di “morte”, dissertata come qualcosa di “pudico” nel senso etimologico del termine. Bazin lo ricorda all’interno del parametro documentaristico, eleggendo a prototipo un filmato sul mitico “toreador” Manolete: ne “La Course de taureaux”, prodotto e diretto da Pierre Braunberger, diabolica abilità nell’articolazione dei piani e discreta attenzione dell’osservatore impediscono di accorgersi d’un furbesco artificio di moviola. “Pervenire alla verosimiglianza fisica del ‘découpage’ e insieme alla sua malleabilità logica”, è il principale fine del montaggio offerto dall’operazione: un “quid” che di lì in pochi anni, non ultimo in Italia, avrebbe costituito uno schema discorsivo restituito nel suo opposto, prostituendo la purezza in embrione e travisandola nella spettacolarizzazione nuda e cruda della materia documentata, finalizzata a un mercimonio estremo quanto gratuito. La dipartita è, in sintesi, fattore da mantenersi casto, inalterato quanto l’immagine ortograficamente computata, in cui l’ambizione del riadattamento letterario o la contrapposizione ontologia-linguaggio, attraverso una raggiera di spunti analitici, emergono quali parti integranti d’una comune matrice.
Il “pattern” asettico rimane pressoché la lente d’ingrandimento tramite cui filtrare l’assortito genere o l’arte nel proprio complesso, all’occorrenza sbugiardando l’eventuale disonestà nelle scelte di campo adottate: si tratti del mito imponente d’una figura storica, della radiografia di un’icona o della trasfigurazione di essa, sorprendente e unilaterale, e della verosimiglianza più o meno speculare alla realtà del tempo. Sicché il documentario, in modalità ancora maggiore rispetto alla “veridicità”, appare forse il “milieu” più confacente in cui, proprio perché in costante evoluzione, è possibile testare la mutazione linguistica, ma pure l’assoluta attualità della notazione baziniana in materia di “realismo”. L’ostentazione linguistica di quell’oggetto sfuggente e complicato che appunto è la realtà. Nella misura in cui la trascendenza della confezione, che implica una relazione con oggetti quasi sempre refrattari a possibili restrizioni all’interno di generi o forme linguistiche codificate, rende specificamente ontologico il parallelo cinema-verità, nella sua “essenza” prima ancora che nella resa tecnico-linguistica. Logico che la rassegna di “report” bellici “Why We Fight” o lo stesso Neorealismo risaltino come lembi d’una dissertazione univoca, in linea con una trasformazione epocale che, giusta o errata, è l’esito semi-naturale d’un ordine nelle cose (e l’itinerario al capolinea, complici Rossellini prima e Fellini poi, impartisce che “santi lo si è solo dopo”). Persino i troppi anni di trasformazione avvenuti in ogni settore – non ultimi la cinematografia e la critica – attraverso sfumature inconcepibili nel periodo in cui la generazione di Bazin scriveva e teorizzava, risultano fenomeno tutt’altro che artefatto. Cambia il metodo analitico, cambia la ricerca, di conseguenza il tessuto sociale di volta in volta testimone: il che delinea su un piano bifronte una nuova apertura mentale, ma pure uno svilimento concettuale, dovuto in questo caso a un’ottimizzazione tecnologica con annesso armamentario strumentale, ove la fantasia è servita senza scrupolo di ragionamenti culturali o socio-politici.
Fondato sul riavvolgimento del flusso temporale entro l’assunto narrativo, e adibito a modificarne il registro, il campione d’incassi “Tenet”, a prescindere dall’effigie ludica, esemplifica il tradimento del dogma baziniano: dietro l’opposto peregrinare dell’emisfero parallelo, trovata stratosferica sulla carta, la direzione temporale a duplice strato squaderna ben presto l’intento, arrancando senza che l’osservatore (e l’acuto “cinephile” prima di lui) si sorprenda granché. E si ripensa a un celebre aforisma secondo il quale, smentendo Godard, “la macchina da presa mente in continuazione, mente ventiquattro volte al secondo”. Ogni era ha la sua tecnica, ogni tecnica la propria voce in capitolo: l’aforisma di Lavoisier, da un pezzo è legge assodata. La metamorfosi dell’immagine, ogni quando perfezionata, è un franco “modus operandi”; così pure la sua trattazione, non esente da dubbi, critiche, detrazioni. Ma è altrettanto figlio d’un percorso unilaterale, dove l’onestà – primigenia componente – risiede in chi lo mette in pratica. Ecco l’altro irrinunciabile indizio cui non venir meno, al quale i noti alunni di Bazin, cresciuti a pane e Settima Arte, restavano fedeli (“Spudoratamente ambiziosi, spudoratamente sinceri”). E il decano dei teorici, certo, non ha bisogno di righe in cui il divulgativo incappi nel convenzionale, a rimarcarne l’eponimia superiore a tutto questo, al contempo schiva ed enigmatica. Ma siamo tutti un po’ figli di Bazin, e un po’ no. Ed è giusto così.

QUARANT’ANNI DI E.T. L’EXTRA TERRESTRE
di Roberto Lasagna
Il giorno 11 giugno del 1982 esce nelle sale statunitensi “E. T. l’extra-terrestre”, il film in cui Spielberg riflette sul tema dell’amicizia tra un bambino e un extraterrestre, dove l’amicizia è un sentimento assoluto, di osmosi e piena corrispondenza dei sensi al di là dei linguaggi. Il film, che commuove milioni di spettatori, si porta nel terreno delle avventure del piccolo alieno lasciato per caso sul pianeta dai suoi compagni, che presto si rivelerà capace di poteri e sensibilità che lo eleveranno a presenza fraterna per i piccoli personaggi.
“E.T”. è il trionfo della Hollywood neo-classica e il punto di avvio di una nuova fase nella produzione spielberghiana, dove i toni intimi e personali sono il terreno pregnante di vicende incentrate sulle disavventure dei protagonisti, pronti ad attraversare la Storia in vicissitudini che si alternano alle avventure di personaggi ormai cinematograficamente celebri (Indiana Jones), o della narrativa popolare (Peter Pan), e trovano cittadinanza in titoli come “Il Colore viola”, “L’impero del sole”, “Amistad” o “Schindler’s list”. Se gli anni Settanta sono stati quelli della fantascienza politica, della riaffermazione di un sistema produttivo cinematografico di massa, ma anche quello delle innovazioni tecnologiche, gli anni Ottanta decretano il trionfo degli effetti speciali e il mutamento dell’immaginario fantascientifico; ne derivano trasformazioni sensibili tanto nel modo di raccontare, quanto nei contenuti: dalle metamorfosi esibite in film come “La cosa” (“The Thing”, 1982) di John Carpenter, all’elaborazione tecnica dei film di Spielberg e Lucas, le inquietudini intestine e le suggestioni spettacolari obbediscono tante volte alle nuove possibilità della tecnologia che affina nei casi migliori anche il linguaggio, mentre si affermano la pratica del sequel (che affonda le sue radici nelle origini del grande schermo, e negli anni Ottanta viene letteralmente ingurgitato dal predominio televisivo) e quella del remake, il vero banco di prova della continuità col passato, che sfodera una miriade di film doppi imbevuti del culto nostalgico per un cinema che è stato grande e che, un po’ semplicisticamente, le nuove tecnologie permettono di vedere riproposto in salsa simil-fumettistica per le attuali generazioni. Se risulta facile oggi rileggere molti film del periodo come espressioni del “reaganismo” imperante in tutta la produzione industriale, giova nondimeno riconoscere nella favola buona di “E. T.” l’espressione di un sentimento non in linea con un tale atteggiamento, per un film che anzi porta l’amicizia intensa e lo sguardo intimo al cospetto di avventure che segnano l’immaginario di un’utopia fraterna e solidale, quando avremo presto, nel futuro cinematografico del regista, vere e proprie incursioni nella Storia dei diritti e delle rivendicazioni dei popoli. E lo stesso Spielberg, in quella fortunata estate cinematografica del 1982, sarà il produttore di “Poltergeist – Demoniache presenze”, il film diretto da Tobe Hopper che vede particolarmente attivo sul set il produttore-sceneggiatore Steven Spielberg. L’estate del 1982 si rivela come l’estate cinematografica di Spielberg, il quale attraverso i due film sembra evocare una doppia strada per il genere fantastico, di contro a chi invece vede nell’approccio spielberghiano toni univoci e, comunque, tranquillizzanti. “Poltergeist” è un film che rappresenta il lato più spaventoso e hitchcockiano di Spielberg, così come “E. T.” ne riflette invece il controcanto più ottimistico e positivo.
Riallacciandosi direttamente a “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, di cui “E. T.” rappresenta una sorta di seguito sulla Terra, Spielberg procede con un’idea precisa: ogni incontro di culture diverse è possibile, deve essere possibile, e il cinema è chiamato direttamente in causa a funzionare da grande mediatore. Il regista, di fede ebraica, avrà modo di dimostrare con il tempo la sua dedizione per un cinema di saldi principi etici. Ma la favola di “E. T.”, a ben vedere, è la quintessenza di un discorso che vede nell’incontro tra spiriti liberi, tra infanti di mondi diversi, la realizzazione di un sogno di solidarietà capace di alleviare temporaneamente gli animi dalla consapevolezza della solitudine che accomuna gli esseri del cosmo. Una consapevolezza temperata proprio dal riconoscimento delle capacità affettive e comunicative degli esseri. L’ideale cosmopolita trova piena realizzazione nel lungometraggio che rilancia la fortuna del film di buoni sentimenti e degli effetti speciali votati al favolistico. Il film più visto negli anni Ottanta e uno dei più grandi successi commerciali del cinema, è concepito nei dettagli per evocare il senso di un’esperienza planetaria. Un’avventura cosmopolita in cui il goffo E. T., creatura antropocentrica costruita dall’italiano Carlo Rambaldi il linea con una tensione espressiva che in questi anni richiede una visibilità nuova e stupefacente dell’alieno (che qui ha fattezze antropomorfe come in “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, diversamente da quanto accade nel cinema delle mutazioni dello stesso periodo, quello incarnato in maniera esemplare da “La cosa di John Carpenter”, il cui mostruoso essere metamorfico esprime con raccapriccianti soluzioni visive la malattia insita nella comunità intera secondo quello che è il più evidente attacco all’american way of life del cinema horror contemporaneo), è un alieno che sembra una vecchietta ma anche un ibrido di animali diversi. La sua voce è un sibilo che porta voci già sentite. Ma la natura meticcia di E. T. non legittima una lettura banalmente semplificante del film, realizzato anzi in pieno stato di grazia dal regista che “sente” e dimostra di conoscere il linguaggio emotivo dei suoi personaggi, sfoderando un ottimo senso della suspense e una notevole attenzione per il mondo interiore degli infanti.
Il film è di certo il trionfo dell’aspirazione fanciullesca (“ho atteso questo momento da quando avevo 10 anni”, dice uno degli scienziati accanto al protagonista Elliot), ma la sua struttura oppositiva non deve essere letta in un modo riduttivo: lo scarto tra la vita e il sogno, tra il reale e il fantastico, tra il mondo degli infanti e quello degli adulti, si risolve nel film attraverso una compenetrazione di elementi inclini a fondersi e completarsi in un disegno sentito e, a tratti, divertito sulle virtù della giovane età. Ed è questo uno dei punti di forza di un film che supera, per le qualità del racconto, la “prova” dei quarant’anni.
Come in altri casi, Spielberg recupera dai film dell’infanzia i caratteri e i modelli dei suoi personaggi. Elliot, Michael e Gertie, i bambini di “E. T.”, ricordano gli infanti di altri due film americani, entrambi del 1953: Wendy, John, e Michael del “Peter Pan” disneyano e Joey Starrett, il piccolo interprete de “ Il Cavaliere della valle solitaria” di George Stevens. Proprio “E. T.”, il piccolo extra terrestre che “inciampa” sulla terra, finisce per destabilizzare gli equilibri di questa famiglia di fratelli (dove il padre è assente, come nella vicenda personale del regista), diventando anzi il detonatore del confine tra magia e realtà, tra sogno e ordinarietà (un aspetto che, evidentemente, conosciamo sin dalle strade di “Duel”).
E. T. pullula di elementi favolistici e di proiezioni psicanalitiche, ma finisce per mettere in scena soprattutto significati primari; il mondo dei grandi, ad esempio, è visto proprio attraverso gli occhi dei più piccini, dunque è naturale che nel film manchino implicazioni politiche precise (ad esempio sul destino dell’alieno una volta che è stato catturato) e perfino il personaggio del vigilante – interpretato da Peter Coyote – che dovrebbe rappresentare l’ingerenza della sfera civile e politica, finisce per assumere il ruolo di un adulto finalmente felice di poter tornare bambino nell’incontro con il nuovo amico venuto dallo spazio. In questo sguardo ad altezza di fanciullo, Spielberg dà il meglio di sé attraverso un film notevolmente sinfonico (celeberrime le partiture di John Williams) che deve il suo enorme successo all’entusiasmo riposto nella corsa dei fanciulli, nella fuga-viaggio dentro l’immaginazione più sfrenata e, al contempo, intima e privata, quasi come se il film si svolgesse all’ombra dei grandi eventi mondiali e vivesse dentro le pagine di un diario. Qui, nel suo film più popolare e insieme personale, Spielberg può esprimere liberamente l’utopia di un incontro di culture lontane. Il piccolo Elliot/Henry Thomas condivide con “E. T.” la comprensione e la pazienza, impara a leggere nei suoi pensieri prima che l’alieno cominci a parlare.
Come in “Incontri ravvicinati” del terzo tipo, la comunicazione tra gli esseri di altri mondi è un fatto che trascende gli ordinari schemi di riferimento: quasi una sorta di predestinazione al contatto che si esprime attraverso i modi più primitivi e magici, virtù di individui-esseri straordinari (e Spielberg, per una volta, vuole che il bambino viva legittimamente le sue sensazioni-virtù eccezionali-naturali che, agli occhi dei più grandi, sono semplicemente sensazioni ingenue).
Elliot, come Peter Pan, conosce l’ebbrezza del volo, grazie alla bicicletta destinata a raggiungere, nel cielo, i contorni della luna. Realizza che gli adulti non riescono più nemmeno lontanamente a riconoscere i personaggi che popolano la vita fantastica dei bambini (la madre di Elliot non vede mai E. T., anche quando questi gira libero per la casa in compagnia della piccola sorella di Elliot – Drew Barrymore – che lo accudisce teneramente). E. T., dal canto suo, capisce che la terra non gli è ostile ma che è troppo, davvero troppo frenetica. Un luogo dove comunque l’amicizia è possibile, a patto di rimanere disponibili all’ascolto.
Diversamente da quanto si pensi, “E. T.” non è un film dai toni esclusivamente concilianti. Il finale appassionato, strappalacrime eppure non disfattista, riflette il senso di un’amicizia davvero sentita, ma è anche espressione di un’inquietudine che unisce tutti gli esseri sotto il comune denominatore della solitudine cosmica e delle angosce patite anche in tempo di pace. In un certo senso, il film è una favola horror. Lo stesso alieno è una caricatura (disneyana) di un mostro. Quando è vestito da fantasma per la notte di Halloween incontra una presenza che sembra riconoscere. Dice infatti “casa”, fermando per strada un bambino vestito e truccato da Yoda, il maestro Jedi di “Star Wars” (un ammiccamento al cinema dell’amico Lucas e una controprova di come l’immaginario spielberghiano certifichi attraverso il contatto con il collega la prevalenza di un mondo fantastico ricreato dal nuovo cinema con l’utopia fantastica di popolare la quotidianità dei più giovani di personaggi tratti dal mito e dalla leggenda). La vocazione parodistica si stempera poi quando il registro diventa tipicamente avventuroso, con gli amici di Elliot i quali, fuggendo in bicicletta per portare E. T. nel luogo destinato all’incontro con i compagni alieni che presto verranno a riprenderlo, salgono in volo e gridano di gioia, obbedendo ad una suggestione in stile “Mary Poppins”. Altrove, il tono è tipicamente orrorifico, come quando un uomo dell’esercito, che ha investigato sull’arrivo dell’alieno, vestito come un astronauta di 2001: “Odissea nello spazio”, spalanca la porta dell’abitazione dove si trovano E .T. ed Elliot senza forze, paralizzando tutti i familiari. Nondimeno, Spielberg ha la sensibilità di utilizzare toni divertiti e a questo proposito non dimentica di ironizzare sui suoi thriller, su “Lo squalo” soprattutto (Elliot ha una vaschetta di pesci e all’interno ci mette anche un bastoncino dotato, ad un’estremità, di una testa di squalo di gomma, l’animale più terribile), ma anche sui film fantastici dei suoi amici registi e produttori (sfilano alcuni pupazzetti della saga di “Star Wars”, ma alla fine lo squalo è sempre la figura più temibile, è come l’orco che si mangia tutti).
Se altre volte Spielberg sembra realizzare film per un pubblico maggiormente adulto, in realtà “E. T.”, film adatto ad ogni pubblico ma sicuramente vicino ai gusti dei più piccoli, è l’opera che meglio esprime, sino a questo punto della sua vicenda artistica, la tensione per l’assenza delle figure familiari fondamentali come il padre. In questa prospettiva, il film è davvero una favola-horror dai reconditi significati esistenziali. Una mancanza-assenza non solamente simbolizzata, ma avvertita come reale, dolorosa, inevitabile. Se l’alieno è così anche una figura familiare sostitutiva, ciò rientra pienamente nella dimensione poetica del regista, prima che in un supposto predominio della componente “buonista”. E. T. capisce che l’uomo può anche arrivare a dare tutto per l’altro. Elliot, di fatto, entra in simbiosi con E. T. Non solo intuisce quello che l’alieno pensa, ma afferra quello che lui sente. È una chiara sottolineatura empatica, quasi la raffigurazione di un rapporto fra fratelli elettivi. Ci sembra molto riuscita la sequenza con Elliot a scuola il quale, dovendo sezionare una rana come suoi compagni, si comporta condividendo le sensazioni di E.T., ubriaco ed elettrizzato di fronte alla televisione di casa: libera allora tutte le rane intrappolate, prende per mano la compagna preferita e, con l’aiuto di un bambino seduto a mo’ di sgabello, arriva all’altezza del viso di lei e la bacia, un po’ come John Wayne bacia Maureen O’Hara con i capelli al vento in una sequenza di “Un uomo tranquillo” di John Ford, il film dinanzi al quale E. T. si trova appunto a sognare.
Contrariamente a Roy Neary in “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, Eliot non sale sull’astronave venuta per salvare E. T.; non farà un viaggio verso la galassia sognata. L’avventura che ha potuto vivere gli ha già dato molto. D’altronde, Elliot, anche attraverso il rito dell’incontro con l’altro, può diventare uomo. È un bambino a cui è richiesto di essere genitore di se stesso. Roy Neary invece, è un uomo che ha bisogno di sentirsi ancora bambino. Se le parti paiono invertite, è chiaro che le situazioni sono parallele: un giorno, forse, E.T. tornerà da Elliot adulto. Quando Elliot rivolgerà di nuovo lo sguardo altrove. Domani o domani l’altro. E Spielberg realizza il sogno antico di un cinema che sappia far pensare ai personaggi anche dopo il termine della proiezione.
“OSSESSIONE” DI LUCHINO VISCONTI E
IL MITO DELLA LETTERATURA AMERICANA
di Mario Galeotti
“Ossessione”, opera prima di Luchino Visconti diretta nel 1942 e distribuita l’anno successivo, interpretata dai divi Massimo Girotti e Clara Calamai, rappresenta insieme ai film “4 passi fra le nuvole” di Alessandro Blasetti (1942) e “I bambini ci guardano” di Vittorio De Sica (1943) un capitolo fondamentale nella transizione tra il cinema degli anni Trenta e quello del dopoguerra.
Ottenuto il benestare della censura per mancanza di elementi esplicitamente sovversivi, il film circolò in misura molto limitata perché fu boicottato dalle autorità locali e dalla Chiesa, fino ad essere vietato del tutto e distrutto. Fortunatamente il regista ne salvò una copia. La fonte di ispirazione era la letteratura americana degli anni Venti e Trenta, la stessa che aveva influenzato fortemente intellettuali come Elio Vittorini e Cesare Pavese. Il soggetto di “Ossessione”, infatti, è liberamente tratto dal romanzo poliziesco noir di James M. Cain Il postino suona sempre due volte (The Postman Always Rings Twice, 1934; la prima edizione italiana del romanzo risale al 1946), anche se adottato come semplice canovaccio. Per la mancata acquisizione dei diritti letterari, il romanzo di Cain non è citato nei titoli del film.
A proposito di romanzieri statunitensi e della diffusione delle loro opere in ambito europeo, alla fine degli anni Trenta Emilio Cecchi, critico e scrittore tra i più stimati della prima metà del Novecento, aveva intravisto nel crescente interesse per la narrativa americana in Italia un nuovo capitolo nella storia della diffusione dei modelli culturali degli Stati Uniti d’America:
“l’America è riuscita a stimolare ed accaparrarsi la curiosità europea. Un episodio decisivo fu la Grande Guerra; durante la quale l’imitazione americana in Europa inconsciamente si spande e organizza […]. Ed ecco un fatto curioso. Faulkner, Cain, Caldwell che, insieme ad alcuni altri, rappresentano le forze più autentiche dell’odierna narrativa americana […] son noti ed apprezzati più in Europa che in America; dove le loro opere e i nomi rimangono mezzo sommersi nella sterminata produzione dei lettori dozzinali” (E. Cecchi, Film e romanzo americano, in «Cinema», n. 84, 25 dicembre 1939)
In merito a questo culto per la letteratura americana, è importante sottolineare come nel ventennio fascista non avesse preso forma solo l’immagine (in negativo e in positivo) di un’America vista esclusivamente attraverso l’occhio di una cultura che potremmo definire ufficiale, non necessariamente militante ma comunque mai in aperto disaccordo col clima di quegli anni. Proprio attraverso i libri dei più influenti autori statunitensi, l’America ha rappresentato a lungo anche un rifugio ideale per gli intellettuali meno allineati all’ideologia fascista.
Ma anche in questo caso, come per la cultura più ufficiale, si deve parlare di un approccio tutt’altro che univoco. All’avido consumo di romanzi americani e all’esaltazione di un New Deal portatore di un moderato senso di giustizia sociale (aspetti del New Deal, va detto, furono osservati con interesse anche dal regime), si affiancava una critica ai mali della società americana, critica però che nel caso di questi intellettuali meno compromessi con il fascismo non si alimentava dei soliti luoghi comuni ormai largamente condivisi e abusati (la metropoli newyorchese e i ricconi americani eccentrici, presenti anche in alcuni film del periodo) e che erano il segno di un approccio semplicistico, ma al contrario pretendeva maggiore chiarezza e approfondimento. Gli spunti per un’analisi meno superficiale e stereotipante andavano cercati proprio nelle pagine dei grandi narratori o in quei film di Hollywood meno riduttivi, che si pensava riuscissero a svelare un volto più autentico dell’America. Vittorini e Pavese tradussero le opere di alcuni dei maggiori scrittori americani (Lawrence, Poe, Saroyan, Faulkner, Powys, Steinbeck, Defoe, Caldwell) e contribuirono in questo modo a diffondere un nuovo mito dell’America. Non deve stupire, dunque, che l’antologia di Vittorini Americana, pubblicata da Bompiani nel 1941, fosse stata subito sequestrata dalla censura fascista, che ne contestò duramente non tanto le opere tradotte, ma le note critiche.
L’anno successivo venne ricollocata sul mercato, ma con l’eliminazione quasi totale delle note. Un articolo pubblicato da Cesare Pavese nell’immediato dopoguerra rievocava quel senso di ambiguo rifugio ideale che la letteratura americana aveva rappresentato per lui e per altri giovani intellettuali maturati negli anni del fascismo. Non a caso il pezzo era intitolato Uno spiraglio di libertà:
“Verso il 1930, quando il fascismo cominciava ad essere ‘la speranza del mondo’ accadde ad alcuni giovani italiani di scoprire nei libri d’America, un’America pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda, greve, di tutto il passato del mondo, e insieme giovane e innocente. Per qualche anno questi giovani lessero, tradussero e scrissero con una gioia di scoperta e di rivolta che indignò la cultura ufficiale, ma il successo fu tanto che costrinse il regime a tollerare per salvare la faccia […]. Il sapore di scandalo e di facile eresia che avvolgeva i nuovi libri e i loro argomenti, il furore di rivolta e di sincerità, che anche i più sventati sentivano pulsare in quelle pagine tradotte, riuscirono irresistibili ad un pubblico non ancora del tutto intontito dal conformismo e dalla accademia […]. Per molta gente l’incontro con Caldwell, Steinbeck, Sorayon, e persino col vecchio Lewis, aperse il primo spiraglio di libertà, il primo sospetto che non tutto della cultura nel mondo finisse con i fasci” (C. Pavese, Uno spiraglio di libertà, in «L’Unità», 2 agosto 1947)
Il critico Guido Aristarco, a distanza di quasi quindici anni dall’uscita del film “Ossessione”, notava che “si può dire per il Visconti quanto Pavese scrisse di se stesso: che c’era in lui qualcosa che gli faceva cercare gli americani, e non soltanto una supina accettazione” e che anche Visconti, come Pavese, era stato accusato di aver, “con questa amorosa simpatia per i forestieri, portato a un tradimento della nostra presunta realtà nazionale e sociale” (G. Aristarco, “Ossessione”, in «Cinema Nuovo», n. 120 – 121, 15 dicembre 1957). Alla sceneggiatura del film avevano lavorato, insieme a Visconti, Mario Alicata, Gianni Puccini, Giuseppe De Santis, Antonio Pietrangeli (tutti storici redattori della rivista «Cinema») e, non accreditato, lo scrittore Alberto Moravia. Notevole è anche l’influenza del cinema francese, in particolare di Jean Renoir, maestro del cinema francese che Visconti aveva conosciuto a Parigi nel 1936 e del quale era stato assistente e costumista nel film “Una gita in campagna” (“Une partie de campagne”). Fu proprio Renoir a proporgli la lettura de Il postino suona sempre due volte, non ancora uscito in Italia, in una traduzione francese dattiloscritta. In quel soggiorno francese, Visconti iniziò ad avvicinarsi alle posizioni progressiste della sinistra e conobbe anche alcuni antifascisti fuoriusciti dall’Italia.
I protagonisti di “Ossessione” sono un disoccupato vagabondo di nome Gino Costa (Massimo Girotti), Bragana (Juan De Landa), insignificante borghesuccio che gestisce uno spaccio, e la sua giovane moglie Giovanna (Clara Calamai). La storia si svolge nella bassa ferrarese. Eccone brevemente la trama. Gino giunge casualmente al casolare della coppia. Giovanna se ne innamora e i due diventano amanti. Bragana, ignaro di tutto, offre una sistemazione al giovane. Deciso a fuggire da quel pericoloso triangolo, Gino parte per Ancona. Qui, a distanza di poco tempo, rincontra Bragana che, accompagnato dalla moglie, deve partecipare a un concorso come baritono dilettante. Gino viene convinto a fare ritorno nel ferrarese e i due ritrovati amanti decidono di assassinare Bragana simulando un incidente stradale, in modo da riscuotere anche il premio di un’assicurazione sulla vita. Riescono nel piano, ma la polizia si insospettisce.
I personaggi di Gino e di Giovanna trasmettono un senso di attesa, di ricerca di un rinnovamento. Giovanna, in particolare, è frustrata, desidera un’altra vita e l’occasione giusta sembra presentarsi con l’arrivo del vagabondo. Bragana, invece, incarna proprio quel mondo provinciale dal quale la coppia di amanti clandestini vuole evadere: mediocre, autoritario, maschilista, razzista. L’importanza e l’originalità del film stanno nell’aver impiegato i modelli narrativi del cinema francese e della letteratura americana ai fini di una rappresentazione inconsueta di ambienti e psicologie dell’Italia del tempo, facendo di “Ossessione” un’opera estremamente innovativa. Fu in riferimento al film di Visconti che il montatore Mario Serandrei coniò il termine “neo-realistico”. Nonostante il carattere a tratti melodrammatico, il realismo delle immagini e l’inedita descrizione di rapporti familiari e sociali sembravano preannunciare una nuova fase del cinema italiano, la fase neorealista già timidamente anticipata da alcuni film degli anni Trenta, come “1860 – I Mille di Garibaldi” di Alessandro Blasetti (1934), che si era imposto all’attenzione della critica per l’uso inconsueto del paesaggio, degli attori non professionisti e per l’impiego del dialetto nei dialoghi: quel cinema del neorealismo, cioè, che nell’immediato dopoguerra si sarebbe concentrato su un mondo meno artefatto, su ambienti delle classi subalterne e dei lavoratori, con riprese realizzate sempre più in esterno e l’impiego frequente di attori presi dalla vita quotidiana. All’epoca Pietro Bianchi, pur mettendone in luce anche i difetti e l’assenza di poesia, parlò di “Ossessione” come di “un’opera insolita e ricca di pregi”:
“pregi che vanno da una condotta tecnica senza difetti, all’impegno che ha mosso tutti i collaboratori verso la realizzazione di un film vero, privo di qualsiasi residuo piccolo-borghese, di compromessi con il pubblico grosso o con le cosiddette esigenze del noleggio. La fotografia è eccellente, non ci sono fondali di cartapesta, né trucchi di nessun genere. Quanto agli attori, basterebbe l’avere intuito che in Clara Calamai c’era in potenza un personaggio da sfruttare per lodare il regista Visconti del suo intuito. E’ una delle poche volte, insomma, che in Italia ci si è avvicinati al cinematografo con la stessa seria mentalità che muove pittori, scultori, musici e scrittori al loro assunto” (P. Bianchi, recensione di “Ossessione”, in «Il Bertoldo», 18 giugno 1943).
Mussolini in persona aveva autorizzato la circolazione di “Ossessione” ma, come abbiamo detto, a livello locale scatenò le reazioni inferocite di vescovi e prefetti, che giudicarono la pellicola scabrosa e improponibile. La storia di adulterio e amour fou, la sensualità sprigionata da Massimo Girotti che per la prima volta faceva del corpo maschile un evidente oggetto di desiderio sessuale (un aspetto ben visibile soprattutto nelle scene in cui Girotti indossa una canottiera attillata), le recondite allusioni omosessuali nel personaggio dello Spagnolo (Elio Marcuzzo) e non ultima la nuova, disadorna veste (messa giustamente in luce anche da Pietro Bianchi) nella quale si presentava la diva italiana degli anni Trenta e Quaranta Clara Calamai, fecero di “Ossessione” un’opera anticonvenzionale, coraggiosa, trasgressiva.
Lo Spagnolo è un girovago con il quale Gino stringe amicizia durante la sua permanenza ad Ancona e, oltre a suggerire una cauta espressione di valori proletari in armonia con le idee politiche di Visconti, in più di un momento il suo atteggiamento lascia intendere una possibile attrazione fisica per il protagonista. Una delle scene più controverse è quella in cui vediamo i due uomini condividere lo stesso letto in una stanza in affitto. Non succede nulla, ma sono le parole e gli sguardi dello spagnolo ad andare fortemente controcorrente per i canoni del tempo. Gino si è confidato, parlando della sua relazione con Giovanna, e l’amico cerca di convincerlo a dimenticare per sempre la donna, a non tornare indietro e a fermarsi ad Ancona con lui, senza ripensamenti. Poi, quando Gino chiude gli occhi per dormire, dopo aver spento la luce lo spagnolo accende una sigaretta e approfitta della poca luce irradiata dal fiammifero per volgere un mesto (e con ogni probabilità, desideroso) sguardo al corpo virile dell’amico. Una nota dolente riguarda l’attore che interpretava questo ruolo, il giovane Elio Marcuzzi: la sua carriera cinematografica durò meno di un decennio, fino al 1945 quando, da poco finita la guerra, fu impiccato da un gruppo di partigiani, insieme a suo fratello, in un paese nella provincia di Treviso, perché sospettato di collaborazionismo con il regime di Salò. In realtà Marcuzzi era di idee antifasciste e si era rifiutato di aderire alla breve e deludente esperienza di un’industria cinematografica allestita a Venezia durante la Repubblica Sociale Italiana.
Clara Calamai, invece, fino a quel momento si era imposta all’attenzione del grande pubblico con oltre venti film, tra cui ricordiamo “Ettore Fieramosca” di Alessandro Blasetti (1938), “Il fornaretto di Venezia” di Duilio Coletti (1939), “Addio giovinezza!” di Ferdinando Maria Poggioli (1940), “Caravaggio, il pittore maledetto” di Goffredo Alessandrini (1941), “L’avventuriera del piano di sopra” di Raffaello Matarazzo (1941) e il salgariano “I pirati della Malesia” di Enrico Guazzoni (1941), con il quale il pubblico aveva già potuto avere un piccolo saggio dell’erotismo sprigionato dalla coppia Calamai – Girotti. Ma l’attrice era ricordata soprattutto per il seno nudo e per le pose alla Marlene Dietrich nel celeberrimo “La cena delle beffe” di Blasetti (1942): pose del tutto assenti in “Ossessione”. A proposito della sua inedita immagine nel film di Visconti, il critico Antonio Costa ha parlato di una “rottura delle convenzioni fotografiche del cinema italiano prodotta dal modo in cui Aldo Tonti, sotto la direzione di Visconti, ha ripreso Clara Calamai […] distruggendo letteralmente la precedente immagine, levigata e leziosa, della diva” (A. Costa, Saper vedere il cinema, Bompiani, Milano 2000, p. 196).
Analizzando il film, Carlo Lizzani scrisse:
“In “Ossessione” c’è un preannuncio di quello che sarà un certo mondo torbido del dopoguerra e insieme una denuncia della rottura profonda che esisteva già allora nella società italiana tra la facciata aurea dell’ufficialità e la crudezza della vita quotidiana, tra gli ordini del giorno e gli appelli alla forza e le inquietudini e il malessere della gente della strada.
Visconti convogliava in un’unica opera, le ambizioni, le proteste, l’ironia e le polemiche di tutto un gruppo di intellettuali, avidi di saggiare e di scoprire quel mondo che per tanti anni il fascismo aveva tentato di nascondere. E questo gruppo portava a maturazione la esigenza trapelata qua e là, a bagliori improvvisi, nei film italiani migliori” (C. Lizzani, Il cinema italiano 1895 – 1979, Editori Riuniti, Roma 1979, p. 103).
In conclusione, “Ossessione” di Luchino Visconti è un film ispirato a un cupo romanzo americano che, ancora inedito in Italia, si inseriva nel genere del poliziesco e più precisamente del noir, con ambienti e personaggi decisamente lontani dal miraggio del sogno a stelle e strisce, ma è anche un film profondamente italiano, non solo per aver cambiato nomi e luoghi del racconto originale.
Come aveva osservato Guido Aristarco, “Visconti cerca di dare a questo paesaggio una atmosfera e caratteri nazionali, strettamente legati ai personaggi, alla loro mutata nazionalità” (G. Aristarco, “Ossessione”, cit.). Spingendosi ben oltre la banale messinscena di altri film italiani del ventennio fascista che in precedenza avevano citato modelli letterari e cinematografici americani (pensiamo alle commedie “Cose dell’altro mondo”, 1939, e “Dopo divorzieremo”,1940, dirette da Nunzio Malasomma o al film “Harlem” di Carmine Gallone, 1943), pur scadendo a tratti nel melodramma “Ossessione” ha avuto il merito di annunciare non tanto il cinema neorealista tout court, quanto, nello specifico, quei film neorealisti del dopoguerra che avrebbero sovrapposto le forme narrative del cinema hollywoodiano e di altre espressioni della cultura di massa americana alla rappresentazione di una realtà inconfondibilmente italiana, indagata con intenti di scrupolosa analisi sociologica. Alcuni dei film firmati da Alberto Lattuada, Giuseppe De Santis, Pietro Germi dopo il 1945 – ricordiamo almeno “Il bandito” (1946) e “Senza pietà” (1948) di Lattuada, “Caccia tragica” di De Santis (1947), “Gioventù perduta” (1948) e “In nome della legge” (1949) di Germi – in concomitanza con la fine del Monopolio (provvedimento ch’era diventato esecutivo con il Regio decreto legge 4 settembre 1938 n. 1389 e che aveva portato a una vistosa contrazione delle importazioni cinematografiche dagli Stati Uniti) e con una nuova invasione del mercato italiano da parte delle pellicole hollywoodiane, avrebbero fatto abbondante utilizzo di schemi e atmosfere di generi americani tanto cari al pubblico, come il poliziesco d’azione, il noir o il western, per descrivere aspetti importanti della società italiana di quegli anni: la lotta partigiana, il reducismo, la Ricostruzione, il disagio giovanile, il banditismo meridionale, i primi tenui sintomi di modernizzazione. Un apparente contrasto che, come spiegava Lizzani in un’intervista, dipendeva da considerazioni di carattere puramente commerciale: per raggiungere le grandi masse con tematiche sociali forti, era opportuno attirare l’attenzione di un vasto pubblico strutturando il film “con le stesse astuzie hollywoodiane” (M. Galeotti, Quell’America di Carlo Lizzani, in «Film D.O.C.», n. 66, gennaio – febbraio 2006). Ed è proprio quello che era già avvenuto negli anni tra le due guerre, anche se con modalità e sfumature differenti. Nel corso del ventennio fascista, infatti, anche i rappresentanti più convinti di una cultura che non correva certo il rischio di apparire esterofila avevano dovuto fare i conti col forte richiamo esercitato dal mito americano, in particolare nelle forme dettate dalla cinematografia, e ammettere che quello di Hollywood, pur tra le tante critiche che avevano animato il dibattito di quegli anni, era il modello da seguire se si voleva dar vita ad un’industria cinematografica italiana competitiva che fosse in grado di attirare l’attenzione di un pubblico ormai affezionato ai ritmi e al linguaggio dei film che provenivano dall’America. Quell’America che tra le due guerre, come ha ricordato Gian Piero Brunetta, “colpisce a migliaia i giovani in camicia nera, ma non li indebolisce: anzi ne rafforza le difese immunitarie e, in un certo senso, è il vaccino e il sistema profilattico più efficace contro la diffusione dei germi mussoliniani” (G. P. Brunetta, Buio in sala. Cent’anni di passioni dello spettatore cinematografico, Marsilio, Venezia 1989, pp. 203 – 204).
COSA VOGLIO DI PIU’, OGGI RIFLESSIONI (PERSONALI) SU
“OTTO ORE NON SONO UN GIORNO” DI RAINER WERNER FASSBINDER
di Paola Brunetta
Fassbinder è stato il mio primo amore cinematografico, il motivo per cui ho cominciato seriamente (dopo un battesimo d’eccellenza con “Roma città aperta”, ma sono gli amori adolescenziali quelli che contano) ad andare al cinema. “Il diritto del più forte”, in particolare. Un inizio bello tosto. A cui sono seguite decine di altri film (lo sappiamo, il nostro era prolifico): ho visto praticamente tutto, sfruttando per quello che mi mancava la retrospettiva che si è tenuta a Roma e a Milano nel 1992, a dieci anni dalla morte. Scriveva, in quell’occasione, Giovanni Spagnoletti sul “Manifesto”: “[Quelle di Fassbinder] sono immagini che ci ricordano, ad esempio, che la gente è di carne e ossa, soffre e gioisce […] oppure che la Storia intrecciata alle piccole storie quotidiane reclama i suoi diritti” (1). Ecco, nel ripensare a Fassbinder a quarant’anni (questo giugno) dalla morte e nel vedere, dopo il restauro e la presentazione nel 2017 alla Berlinale (dove tra l’altro, proprio quest’anno, Ozon ha portato la sua personale versione di “Le lacrime amare di Petra von Kant”), la sua serie tv “Otto ore non sono un giorno”, datata 1972, la sensazione è stata proprio questa, insieme a quella di un’attualità sconcertante: che l’autore ci voglia mostrare la gente in carne ed ossa, questa volta più nella gioia che nella sofferenza (ma su quest’aspetto torneremo), e che la grande e la piccola storia, per citare Manzoni, si intreccino qui come non mai, anzi non solo la storia, ma la politica e la società.
L’opera, composta da cinque episodi che dovevano essere otto, ha come sottotitolo “Una serie familiare” e presenta la storia della famiglia Krüger, che vediamo all’inizio intenta a festeggiare il compleanno di nonna Oma, forse la vera protagonista dell’opera, sicuramente il suo deus ex machina, o meglio la “fata” che tutto risolve; ma una fata sui generis, ottimista, spiritosa, ridanciana, sempre pronta a escogitare idee per far fronte ai problemi familiari e sociali, in modo non sempre ortodosso: il fine (buono) giustifica i mezzi. L’altro protagonista è suo nipote Jochen che nel primo episodio si innamora di Marion e poi la sposa, portando nel racconto tutta una serie di altri personaggi e situazioni. E poi, oltre alla famiglia e agli amici dei suoi vari componenti, abbiamo i compagni di lavoro di Jochen, che vedremo essere i protagonisti di un altro filo narrativo. Ma lasciamo la parola a Fassbinder stesso: “Ci sono talmente tante persone nel film, oltre a Jochen, Marion, la nonna. C’è Monica, Harald. C’è Gregor, poi Wolff e Käthe, Manni e Sylvia, c’è Franz, Peter, Jürgen, Rolf, Manfred, Irmgard, Rüdiger… tutti l’uno diverso dall’altro, ingenui e sempliciotti, affettuosi e crudeli, buoni e stupidi e furbi; io li amo tutti. […] Credo che farebbero bene a restare quelli che sono. O per lo meno a non cambiare troppo” (2). Un’opera corale quindi, che a livello familiare segue sia le vicende di Jochen e Marion, sia quelle di Oma e Gregor, l’uomo che ha conosciuto in un parco e che diventa il suo compagno di vita, sia infine quelle di Monika, l’infelice sorella di Jochen, con annessi e connessi anche a livello di personaggi, mentre a livello sociale (e politico, ça va sans dire) segue le alterne vicende dei compagni di lavoro di Jochen, operai in uno stabilimento di componentistica industriale, che contrattano con il proprietario della fabbrica la possibilità di organizzare autonomamente il lavoro; ma della citazione è interessante soprattutto l’amore di Fassbinder per i propri personaggi, visti nei loro aspetti positivi (l’allegria sfacciata della nonna, l’ottimismo e il ribellismo istintivo di Jochen, il buon senso e la sensibilità di Marion) ma anche nella loro ingenuità, nella loro impertinenza e nella loro debolezza. Però, dice sempre Fassbinder, “ciò che differenzia Jochen, Marion, la nonna, Gregor e un paio d’altri ancora dal tipo dell’operaio che ci si immagina di solito, e che viene spacciato in televisione o altrove, è che loro non sono dei disperati. […] Comunque, un barlume di utopia loro ce l’hanno, Jochen, Marion, la nonna e un paio d’altri. Quel barlume che in alcuni casi sembra essersi spento e in altri non è vera utopia, ma solo spensieratezza, o menzogna” (3).
Quindi amore per dei personaggi che non sono dei disperati, e che hanno un barlume di utopia; per personaggi ingenui e sempliciotti; per personaggi insomma, e qui arriviamo al punto, non drammatici. Fassbinder ci ha abituato a ben altri personaggi e a ben altre storie, e quest’opera tra l’altro, che è, si diceva, del 1972, si colloca nella fase dei melodrammi che hanno reso famoso il regista, “Il mercante delle quattro stagioni”, “Le lacrime amare di Petra von Kant”, “Selvaggina di passo”,prima, “La paura mangia l’anima”, “Martha”, “Effi Briest”, “Il diritto del più forte” e molti altri, dopo. Film non facili fatti di personaggi che distruggono (per amore) e si distruggono, la cui fragilità sta nei sentimenti che vivono a fior di pelle e significa rovina e annichilimento; personaggi, anche, spesso tragicamente ingenui, che si fanno sopraffare da chi è più cinico e quindi più forte, perché ama di meno. In “Otto ore non sono un giorno”, niente di tutto ciò. Il regista lo ha motivato così, rispondendo in un’intervista a una domanda di Christian Braad Thomasen: “Perché tutti i film e i drammi che ho scritto erano indirizzati a un pubblico intellettuale. Nei confronti di questo si può benissimo essere pessimisti e lasciare che un film si concluda nell’impotenza. Un intellettuale è del tutto libero di lavorare sul problema con tutte le sue capacità intellettuali. Nel caso del pubblico più ampio che può essere raggiunto con un serial TV, sarebbe stato reazionario, perfino criminale, dare un’immagine disperata del mondo. Il tuo primo obbligo è di dare al pubblico forza, dirgli “Hai ancora delle possibilità. Puoi usare il tuo potere, poiché chi ti reprime dipende da te”. Cos’è un padrone senza un lavoratore? Nulla. Ma si può benissimo immaginare un lavoratore senza un padrone. Per la prima volta ho realizzato qualcosa di positivo, qualcosa pieno di speranza, sostanzialmente per effetto di un’analisi di questo tipo. Con un pubblico di 25 milioni di persone comuni, non ti puoi permettere di fare altro” (4). Sicuramente il mezzo ha un peso: una serie tv è diversa da un film, lo vediamo bene oggi, e il pubblico televisivo (oggi quello delle piattaforme) è diverso da quello cinematografico, o meglio cinefilo, anzi intellettuale come dice il regista. Ma mi piace di più pensare a quella che lo stesso autore ha definito “estetica della speranza” (5), questa volontà di dare al pubblico (televisivo, ampio) la possibilità di diventare consapevole del proprio potere, e di usarlo per cambiare le cose. Nell’opera lo vediamo molto bene: Oma e Gregor fondano un asilo abusivo, poi riconosciuto dal Comune, nello spazio che ospitava una biblioteca di quartiere, facendosi aiutare da un gruppo di casalinghe che mobilitano la stampa al fine di sensibilizzare le istituzioni, riuscendo nel loro intento e riuscendo, anche, in questo modo a trovare i soldi per l’appartamento che desideravano; gli operai dello stabilimento di Jochen riescono, con tenacia, impegno e con un atto di ribellione, a ottenere il premio di produzione revocato, il caposala che hanno scelto e, addirittura, un’organizzazione autonoma del lavoro approvata dalla dirigenza; Monika, aiutata da Marion, da Oma e un po’ dal caso che sorride a chi ha fiducia nella vita, riesce alfine a separarsi dal marito e a ritrovare l’amore; e sono solo alcuni esempi.
Io credo che Fassbinder, al di là del pubblico diverso che aveva in questo caso (ricordo, peraltro, che serie tv, o sceneggiato televisivo che dir si voglia, era anche “Berlin Alexanderplatz”, di tutt’altri toni ed atmosfere emotive, e che un film per la tv era anche il drammatico “Martha”), abbia davvero voluto realizzare un’opera “positiva” e aperta alla speranza, che mostra un mondo in cui le utopie si possono in qualche modo realizzare perché ci sono persone che, quelle utopie, le hanno nel cuore come hanno nel cuore una società più giusta, più a misura d’uomo; anche in relazione a questioni apparentemente irrilevanti, o comunque di minor impatto rispetto a quella del lavoro operaio, quali il rincaro degli affitti e dei trasporti urbani, la custodia dei bambini e il ruolo sociale degli anziani, le differenze sociali (c’è anche un cenno al tema dell’immigrazione, italiana e turca) e la questione femminile. Quest’ultima è toccata nella subalternità al marito del personaggio di Monika, che riesce però alla fine ad emanciparsi, e nell’indipendenza del personaggio di Marion, oltre che di quello della nonna: donne innamorate del proprio compagno ma non sottomesse ad esso, e fiere dell’autonomia (anche economica) che hanno saputo crearsi. Interessante anche il tema dell’educazione dei figli (Sylvia VS Manni), in un momento, i primi anni ’70, di grandi cambiamenti sociali.
Ma in questo senso il tema chiave è naturalmente quello del lavoro in fabbrica, che Fassbinder, lo abbiamo visto, non affronta in maniera classicamente politica (o, almeno, classicamente politica per quel momento storico) ma coniuga in maniera originale, aprendo a possibilità altre grazie a elementi come l’ingegno, la determinazione coraggiosa e lo spirito di squadra. Questo è stato uno dei motivi dell’affossamento della serie nel momento della sua messa in onda (tra ‘72 e ’73) da parte della critica e della direzione dell’emittente che la trasmetteva, nonostante il successo di pubblico, affossamento che ne ha decretato l’interruzione al quinto episodio: non si accettava il fatto che il sindacato non avesse un ruolo attivo nelle trattative operaie e, soprattutto, che le questioni del lavoro fossero intrecciate a quelle, anche un po’ futili e comunque allegre e, spesso, virate in chiave di commedia, della vita quotidiana dei protagonisti, quindi del loro privato. Tra pubblico e privato era in sostanza più importante il pubblico, cosa che Fassbinder, in questo caso (o forse sempre), non accetta. A questo proposito riporto le parole di Wilhelm Roth, che individua l’interesse di quest’opera proprio nella commistione equilibrata di pubblico e privato che riesce a creare: “Contrariamente alla maggior parte dei documentari politici, i personaggi nel serial di Fassbinder appaiono non come delle vittime bensì come i possibili eroi della propria storia; si tratta a mio giudizio del solo film tedesco in cui il “messaggio” politico non sia il pretesto per un esercizio di stile destinato a un pubblico già politicizzato; si tratta di un’opera pedagogica realizzata realmente per coloro che non hanno ancora preso coscienza” (6).
Non si pensi, però, che si stia descrivendo un Fassbinder improvvisamente buonista, solo perché costretto a confrontarsi con un mezzo, e con un pubblico, diversi da quello teatrale o cinematografico. Lo spirito del regista emerge anche qui, nell’irriverenza di Oma, nella ribellione degli operai alle decisioni della dirigenza, nella contestazione del sistema (polizia, enti pubblici), nella polemica nei confronti della burocrazia e del moralismo spicciolo. Più volte viene pronunciata questa frase: “Il desiderio è il padre del pensiero”, per dire che è il desiderio a guidare l’uomo nelle azioni e nelle scelte, non quello che viene imposto, magari dall’alto; e a proposito di educazione, quando Jochen rimprovera Manni dicendo a Marion: “E’ proprio maleducato tuo fratello”, lui risponde: “Non sono né meglio né peggio di come mi educate”. C’è poi la spontaneità gioiosa dell’amore tra Jochen e Marion, con il bacio che si danno sulle strisce pedonali all’inizio del quarto episodio, bloccando tutto il traffico, perché, come viene detto più volte, quello che conta è la felicità (mentre Harald, l’unico personaggio veramente negativo, dice che potrà essere, volendo, felice “quando tutto sarà in ordine”); l’allegria sfacciata e irriverente, ma anche amabile e affettuosa, della nonna di Jochen e Monika, le discussioni tra Marion e la sua collega che terminano nella “conversione” di questa, insomma il mondo vero di Fassbinder è l’amore, l’amore che ha caratterizzato tanti suoi film, nel “Cosa voglio di più” che Jochen dice a Marion, dopo che si sono sposati e si sono stesi, insieme, sul materasso della loro nuova casa. Ci sono gli attori fassbinderiani: Gottfried John, Hanna Schygulla, Kurt Raab, Irm Hermann, i camei di Margit Carstensen, Eva Mattes, El Hedi ben Salem. E c’è la musica: Neil Young, Janis Joplin, Leonard Cohen, i Rolling Stones, i Velvet Underground, Elvis Presley e Little Richard, addirittura Morricone… sullo sfondo di Jens Wilhelm Pedersen. Prevale insomma quella vitalità che in altri film di Fassbinder non troviamo, quell’adesione alla vita spontanea e naturale, rappresentata dai bambini che giocano in strada nel secondo episodio, che io, tornando a me per concludere come abbiamo iniziato, ora sento come imprescindibile e che sono felice di scoprire in un autore di cui conoscevo, in passato, solo il lato più drammatico. Il tempo serve anche a questo.
NOTE
1) Giovanni Spagnoletti, Bunker di celluloide, in “Il Manifesto”, 16 febbraio 1992, p. 30.
2) “Otto ore non fanno un giorno”. Qualche riflessione estemporanea su Jochen, Marion e…, in Rainer Werner Fassbinder, I film liberano la testa, a cura di Giovanni Spagnoletti, Ubulibri, Milano 1988, p. 23.
3) Ivi, p. 22.
4) Davide Ferrario, Rainer Werner Fassbinder, La Nuova Italia, Firenze 1984, pp. 45-46.
5) Ivi,p. 46.
6) Wilhelm Roth, 1972 – Acht Stunden sind kein Tag, in Tutti i film di Fassbinder, a cura di Enrico Magrelli e Giovanni Spagnoletti, Ubulibri, Milano 1983, p. 99.
ORE 9, CALMA PIATTA: “DIABOLIK”
di Francesco Saverio Marzaduri
Nulla a che vedere col thriller di Phillip Noyce: chi scrive, giocosamente anticipa di un’ora l’esatto titolo giacché l’iniziale aspettativa per il nuovo “Diabolik” – dopo la solita tornata di spot ritardante la proiezione, prevista mezzora prima – non ha corrisposto ai risultati effettivi. In tale circostanza, la grama affluenza del pubblico non spiega completamente un triste fenomeno su cui molto vi sarebbe da dire; senza dubbio, l’allarmante diserzione dalle sale durante le recenti festività è tanto attribuibile alla collettiva pandemia quanto all’avvento delle più comode piattaforme, senza che il piccolo schermo restituisca identica emozione. Nel gramo menù, lodevoli si sono mostrati i propositi, contando, tra i pezzi grossi, sul caso Gucci in satirica versione “dark” o sul “reboot” griffato Spielberg di “West Side Story”, in aggiunta al catastrofico “Don’t Look Up” o al ritorno di Spider-Man, prevedibile asso pigliatutto al “box-office”. E in tema di fumetti, eccoci arrivati al punto: l’ambizione d’un “cinecomic” italiano che si distanzi dalla prima trasposizione del ’67, senza alcunché da invidiare ai più competenti colleghi d’oltreoceano, s’impegola in un anelito dal faticoso aggiogamento: troppi i ghiotti percorsi da carezzare, fingendo per un istante di non sapere che il cinema di genere, coniugato al mero intrattenimento, rischia d’inciampare in azzardi eccessivi (lo dimostra il dittico dedicato da Salvatores al “Ragazzo invisibile”). Col solito esito del topolino scaturito dalla montagna.
Nonostante il COVID-19 abbia ritardato l’uscita della loro settima fatica, i Manetti Bros. avrebbero dovuto far tesoro dei giudizi altalenanti su “Freaks Out”, tuttavia – in concomitanza con la lavorazione del film di Gabriele Mainetti – l’idea di riadattare il fantomatico “re del terrore” creato da Angela e Luciana Giussani, alla soglia del dodicesimo lustro, era in essere già da tre anni. Altre due puntate della saga sarebbero in cantiere, ciò non toglie che la confezione popolare non sia operazione da concepire a tavolino, ché il segreto risiede nella primigenia componente del “fantasy”: l’ingenuità. Nella prima settimana d’uscita “Diabolik” ha conquistato, con onore, il terzo posto al botteghino e il primo tra le produzioni italiane; c’è da dubitare che i dieci milioni di “budget” siano giustificati da unanimi consensi: il tentativo di fare del ladro mascherato un apologo teorico, scrupoloso nei risvolti psicanalitici prima che nel ritmo, rimane imbrigliato nella medesima tela concettuale dedotta dall’ispettore Ginko (un Valerio Mastandrea la cui cerata fisionomia lo fa sembrare Christopher Lee). Si potrebbe cavarne materia per parlare di un altro e non nuovo fenomeno che gli ultimi giorni sembrano aver ribadito: la critica scissa tra stampa e “social”, ridotta a mega-circo di massa in cui la gara a chi la dice più lunga (o più grossa), pro o contro, sopperisce all’effettiva qualità. Nel caso specifico, non ci si trova di fronte a una fanfaronata, eppure tocca constatare come la tenuta d’insieme vanifichi quasi ogni sforzo e, nonostante la meticolosità, il senso d’attesa sia frustrato dalla reale emozione; le molte idee di copione fanno della rivisitazione una sorta di tv-“format” (il che non sorprende: basti l’enorme contributo dei registi-sceneggiatori al piccolo schermo, raggiunto con “Coliandro”), “vintage” ma sfuggente, che priva la magica nostalgia di autentico guizzo.
Ne segue un “polar” nostrano da seguire per ritagli, per gran parte di volenteroso virtuosismo, quanto carente di unità: si va dal flashback a incastro, adibito a ricomporre il mosaico, a trucchi di collaudata ortografia (le tendine, lo “split screen” nelle parentesi più tese, l’impiego d’una m.d.p. ora instabile ora voyeuristica), con inserti rispettosi della carta (il “caveau” del furfante, l’alfabeto Morse esplicato dalle diciture), sino ad artificiosi “coup de théâtre” costantemente tesi a giocare con la verosimiglianza. Memore della confezione d’inchiesta disseminata di citazioni, fa capolino persino la connotazione politica (i documenti segreti del viceministro Caron, interpretato da Alessandro Roja). Virtù che non oscurano topiche quali un’esplicita recitazione sopra le righe – eccezion fatta per una raggiante Miriam Leone, Luca Marinelli è di glaciale imperturbabilità – o alcuni errori di “script”, di forzata macchinosità. Se l’originario spirito del famigerato personaggio è rispettato, è inevitabile non ripensare ai giocattoloni di Fleming (l’accessoriata Jaguar), al Lupin di Leblanc o a Fantômas (si pensi alla fugace apparizione di Claudia Gerini). A uscirne meglio è la patina letteraria, con echi di Conan Doyle, Simenon, Highsmith, e soprattutto debitrice del “feuilleton” francese fine ottocentesco. Detta variante è, fondamentalmente, un “mélo” incentrato sull’incontro tra due anime gemelle, emarginate e similari, cui spetta nel finale una scelta radicale: un rapporto complementare e unico, fondato sul rispetto reciproco prima che sul sentimento, la fiducia e condivisione di un assurdo stile di vita.
Criminale e spesso assassino, Diabolik – al secolo Walter Dorian – è fedele a un codice d’onore che non abbandona mai, le cui malefatte si spiegano con un’imperitura sfida con sé stesso. Vedova d’un ambasciatore sudafricano morto in circostanze misteriose, e forse implicata nella sua scomparsa, Eva Kant delinea un “modus” diverso e moderno di femminilità, emancipato e ambizioso, freddo e coriaceo; ex ballerina e spia industriale, in apparenza gentile, raffinata ed elegante, è proprio lei a salvare il protagonista ribaltando l’usuale canone, animata da un singolare frizzo per il brivido, e, dopo l’incontro con lui, un’energia e un’attrazione incontenibili per il dinamismo (spara dardi con mira infallibile, possedendo destrezza, sangue freddo, amore per la velocità). Il ritratto di Eva è una combinazione di Protea, Lady Beltham, Irma Vep, Diana Monti-Marie Verdier e Contessa Mado, più che le molteplici Serial Queen: dapprincipio capricciosa e gelosa, infelice della propria esistenza ed eccessivamente attratta dal lusso, il suo è un incredibile percorso di crescita che, da mera spalla al servizio del partner, la porta a divenire coprotagonista a tutti gli effetti, libera e indipendente nelle scelte – talvolta, anche di sottecchi dal complice. Una formazione netta, come donna e delinquente: non impiega molto, Diabolik, a rendersi conto del suo valore, concedendole sempre più margine e intuendo quanto necessiti di lei, la rispetti e la ami.
Nondimeno, la “vogue” sensazionalista caratterizzante il mercato cinematografico d’oltralpe, nella seconda metà dei Dieci, sollecitava quel gusto del brivido e fascino, eccentrico e tenebroso, assente nei Manetti. Di tal aspetto, motivato a posteriori da pagine di spiegazioni retrospettive, la sinteticità dello schermo ne esalta il carattere recisamente arbitrario (Diabolik è incastrato perché in possesso dei travestimenti, mentre i salti temporali ne illustrano i retroscena dei colpi). Qui il rischio non è valorizzato, il gusto della libertà non si dà automaticamente quale gusto del pericolo: manca il piacere dell’intrigo, l’azione movimentata di risultato incerto, il sapore del brivido e della “suspense”. Se poi la catastrofe è l’emblematico “topos” che l’istante singolare assume nell’“action movie”, ovvero l’effigie del “climax”, ciò manca a un adattamento che, parsimonioso, predilige l’istante in oggetto – escludendo l’inseguimento in apertura – senza che vi sia sperimentazione sulle figure dell’azione o elaborazione nell’estetica del “thrilling”, né “cliffhanger” tra i passaggi o sfruttamento intensivo del “climax”. E l’apporto della costumista Ginevra De Carolis, nello svolgere un compito troppo attiguo a “Al paradiso delle signore”, profuma di arbitrario.
Impresa non facile, insomma, tenendo conto il proposito di realizzare un film “di” e non “su” Diabolik, volto a soddisfare gli “aficionados”, malgrado qualche licenza. A favore della riscrittura, però, trapela una dichiarata onestà intellettuale degli autori (“La cosa più vicina al raggiungimento di un sogno, ottenuto attraverso il lavoro, la pianificazione, la perseveranza”), indotti da un desiderio di “mise-en-scène” in linea con un’interpretazione e uno stile naturali, ma – seppur fedeli al terzo albo della serie, “L’arresto di Diabolik” – distanti dalla pagina e più adiacenti a un esperimento cinematografico; a coronare il progetto il coinvolgimento “in primis” di Mario Gomboli, erede artistico delle ideatrici del fumetto. “Non volevamo girare un’opera ambientata negli anni Sessanta – continua Antonio – ma un film girato come negli anni Sessanta”. E ancora: “Nel corso della nostra carriera, il termine ‘alla Diabolik’ è sempre stato un modo d’impostare alcune scene, la scelta di un certo tipo di “location” o alcuni espedienti narrativi. Il nostro lavoro è pieno di queste suggestioni. La fedeltà non esiste: quando metti in scena un fumetto che ami, in realtà fai un lavoro soggettivo”. Ed ecco una sequela di riprese che, ostentando l’immaginaria Clerville, alterna gli scenari di Courmayeur a quelli di Bologna e Milano, concludendosi nel Ravennate, con qualche scorcio di Trieste a raffigurare Genf. Il tutto innesca un’impressione di surrealismo urbano, percorsa da un’anonima folla come un dedalo: una realtà parallela, popolata da uno spettrale ladro e una dinamica ragazza, ch’è una doppia esposizione dello spazio quotidiano della città. Un’ esperienza estetica non più circoscritta all’aureo consumo di un prodotto artistico, ma estesa a un’area fenomenologica allargata a una situazione di tipo nuovo, in cui la surreale superficie si traduce in dominio dei fan, a cominciare dagli stessi Manetti; merito di una collaudata “équipe” di sodali (Francesca Amitrano alla fotografia, Noemi Marchica per le scenografie, Pivio e Aldo De Scalzi alle musiche, Michelangelo La Neve co-sceneggiatore, e via elencando) con cui i cineasti romani hanno creduto di ripetere i fasti di “Song’e Napule” o “Ammore e malavita”.
Se il rodaggio è il fine ultimo del primo episodio, in attesa dei successivi, prendiamo per buona l’ambiguità dell’esito quale coerente ossequio al “medium”, congelante il dinamismo del fotogramma a favore della staticità della tavola – opzione azzardata, stando al tradizionale “heist” tutto prontezza e montaggio frenetico. Soltanto, non avrebbe guastato quel “quid” aggiuntivo (il bianco e nero al posto del colore) che avrebbe calcato il prototipo traslandolo in balocco “cinephile”; e un po’ si rimpiange l’eccesso “pop” che, nella prima versione di Bava, leniva rutilante il tradimento come le immancabili parodie. Perché la verità – per dirla con Manuel Agnelli nel brano in chiusura – si può cambiare. Si può travestire.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
LO STAGE NAZIONALE FEDIC:
“UNA FANTASTICA OPPORTUNITÀ!”
di Roberto Merlino
Uno degli stagisti mi disse: “Avete creato una fantastica opportunità! Ho fatto altri corsi -decisamente più costosi- e il materiale tecnico lo facevano vedere in fotografia, mentre qui lo si tocca e, addirittura, lo possiamo mettere in funzione, sotto la guida di veri maestri!”
Era l’8.a edizione (2010) dello Stage Nazionale FEDIC di Formazione e Approfondimento. Le lezioni si svolgevano dentro un enorme capannone, a Cascina (PI), con un vero e proprio “arsenale” di materiale illuminotecnico a disposizione, monetizzabile in parecchie decine di migliaia di euro.
Mi piace, poi, ricordare il caso di un Socio “storico” della FEDIC che, partecipando per la prima volta allo Stage nel 2013 (11.a edizione), sentenziò “Ma come ho fatto a perdermi dieci anni di questa grande esperienza?!”
Ecco… potrei raccontare tanti altri episodi che dimostrano la nostra voglia di mettersi al servizio degli stagisti, per rendere avvincente e concreto il percorso che vengono ad intraprendere. Non ci basta fare un “buon corso”: vogliamo offrire il massimo di quello che le nostre possibilità e competenze ci consentono.
In quest’ottica, anche quest’anno, avremo un docente d’eccezione: Alessandro Grande, vincitore del David di Donatello nel 2018 con il corto “Bismillah” e rappresentante italiano agli Oscar di Los Angeles del 2019. Laureato in Storia, Scienze e Tecniche dello Spettacolo, lavora come autore per programmi televisivi Rai, Mediaset e Sky. Nel 2010, col corto “In my prison”, ha ottenuto 40 riconoscimenti, tra cui il Premio Amnesty International e il Premio del pubblico al Festival di Tokyo. Nel 2013 ha poi realizzato “Margerita”, entrato nella cinquina finale dei Nastri d’Argento e vincitore di 81 premi nel mondo. Nel 2020 ha realizzato il suo primo lungometraggio, “Regina”, vincendo il Ciack d’oro come miglior regista esordiente, il Ciack d’oro Cult movie e il premio Graziella Bonacchi del “Nastro d’argento”, dove è stato anche candidato nella categoria miglior soggetto. A luglio 2021 ha ottenuto la candidatura come miglior opera prima al 61° “Globo d’oro”, rientrando nella terzina finalista. Oggi insegna all’Accademia di Belle Arti di Frosinone.
Alessandro Grande è ormai una “vecchia conoscenza” per lo Stage Nazionale FEDIC: la sua prima presenza risale al 2014, quando fu invitato come “ospite d’onore”, per presentare il suo “Margerita”, a cui avevamo attribuito il “Premio CTC”. Tornò nei due anni successivi in veste di docente, realizzando con gli stagisti la sceneggiatura di un corto (nel 2015), che fu poi realizzato durante lo Stage del 2016. Dopo due anni di pausa, Alessandro è poi tornato nel 2019, come docente di sceneggiatura.
Anche lo Stage di quest’anno avrà la sceneggiatura come argomento di studio, ma il percorso sarà diverso da quelli precedenti, in un modo molto pratico e concreto, con un approccio che, in un certo senso, potremmo anche definire “sperimentale”.
Lo Stage, fin dalla prima edizione, è stato pensato e organizzato come una sorta di “vacanza-studio” in cui, oltre a una indiscussa qualità del corpo docente, si pone particolare attenzione ai momenti ludici e spettacolari: stando insieme ventiquattro ore su ventiquattro per più giorni, è fondamentale contribuire alla creazione di un clima sereno e di complicità, mettendo i partecipanti a proprio agio con una offerta diversificata di “momenti extra” (serate -aperte al pubblico- con proiezione di cortometraggi e dibattito; escursioni guidate, ecc.). Nell’ottica dello “star bene”, non poteva mancare la componente gastronomica e, allora, andiamo a proporre una cucina genuina ed equilibrata, accompagnata da buon vino, caffè e quant’altro occorra per alzarsi da tavola appagati e sazi.
E’ molto importante la poliedrica conformazione dei partecipanti: alcuni provengono da diversi Cineclub (e hanno modo di conoscersi, intrecciando collaborazioni); altri, che non fanno parte di alcuna associazione, seduta stante vengono iscritti a un Cineclub FEDIC a loro scelta. Lo Stage, insomma, rappresenta concretamente un punto di incontro concreto, foriero di conoscenze e scambi.
C’è poi la differenza di età e di esperienza: elementi giovanissimi e alle prime armi lavorano insieme ad ultrasettantenni con decine di anni di video-cinema alle spalle. Potrà sembrare un controsenso ma – lo abbiamo riscontrato fin dalla prima edizione! – questo è un grande plus valore, perché unisce la linfa vitale e la conoscenza informatica degli uni alla preparazione “canonica” degli altri, in una sorta di passaggio osmotico che fa bene a tutti!
L’ultimo punto di forza dello Stage è senza dubbio rappresentato dal “costo politico” che, da sempre, lo caratterizza: grazie al lavoro gratuito di organizzatori e tecnici, oltre alla ricerca di sovvenzioni e sponsor, si chiede un contributo di partecipazione che è circa un terzo di quanto si paga in esperienze di pari livello.
Tutto questo fa sì che, da anni, lo Stage è sempre pieno, con mesi di anticipo e persone che si prenotano addirittura da un anno all’altro.
FESTIVAL ED EVENTI
RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2021
di Maria Pia Cinelli
Può succedere che la notizia di una brutale aggressione avvenuta in patria, uno stupro di gruppo ai danni di madre e figlia sotto gli occhi del marito[1], sia la classica goccia che induce una giovane indiana di stanza a Hong Kong a lasciare una professione ben avviata, far rientro nel proprio paese, passare da un attivismo da scrivania a un impegno concreto. E a mettersi in marcia. Letteralmente. Partita nel settembre 2017 da Kanyakumari nello stato meridionale del Tamil Nadu, nell’arco di 230 giorni Srishti Bakshi percorre a piedi ben 3.800 Km fino a raggiungere il Kashmir nel Nord dell’India, con l’obiettivo di raccogliere via via le esperienze di più donne possibile, indagare le ragioni della violenza di genere, fornire elementi per l’emancipazione e sensibilizzare l’opinione pubblica grazie al sostegno dei media, cassa di risonanza dell’iniziativa.
Il caso vuole che Srishti abbia per sorella Apoorva Bakshi, produttrice della serie Netflix “Delhi crime”[2] – poi vincitrice di un Emmy nel 2020 – pronta a fornirle una piccola troupe per tenere traccia dell’intero viaggio, e che in seguito Ajitesh Sharma, uno degli assistenti alla regia della stessa serie, visionando il materiale ne afferri il potenziale cinematografico.
Così è nato “Womb: Women of My Billion”, premiato come miglior documentario al 21° River to River Florence Indian Film Festival, tenutosi nel capoluogo toscano dal 3 all’8 dicembre 2021 in forma ibrida, con spettatori in sala e online.
Dalle oltre 1000 ore di girato a coprire 85.000 incontri, 300 interviste, 100 workshop, per la sua opera prima Sharma riesce a estrapolare un racconto ben al di là del diario di bordo, facendone radiografia antropologica di un mondo che fatica ad affiancare allo sviluppo economico un equivalente progresso civile.
Il film si mantiene lontano dal sopra le righe a cui il soggetto potrebbe portare, in sintonia con la sobrietà delle testimonianze. Le donne di varia estrazione che tappa per tappa si avvicinano al movimento espongono in modo lineare storie di ordinaria sottomissione e casi limite, ma non rari, di ragazze stuprate quindi arse vive, volti sfregiati dall’acido per una proposta di matrimonio rifiutata, violenze domestiche sminuite dalle autorità, quali estreme conseguenze di un’educazione patriarcale che famiglia e istituzioni perpetuano assegnando di default già alle bambine un ruolo secondario. L’alta partecipazione al progetto di Srishti Bakshi mostra che la rassegnazione atavica inizia a incrinarsi sotto l’urgenza del cambiamento e fa ben sperare che il miliardo del titolo, riferito ai passi collettivi della marcia, divenga presto misura del cammino in avanti contro abusi e disuguaglianza.
Una figura muliebre altrettanto pregnante dell’ingegnosa attivista la troviamo nel personaggio di finzione al centro di “Nazarband (Captive)”, proclamato vincitore del festival che, ricordiamo, ha da sempre il pubblico come giuria. Un pubblico quest’anno particolarmente sensibile alla questione femminile, dato che anche il cortometraggio finito nel palmarès, “Kanya” di Apoorva Satish, è il difficile coming of age di un’aspirante nuotatrice. Ciò non toglie che le opere premiate emergano in primis per meriti intrinsechi, come appunto il toccante “Nazarband (Captive)” di Suman Mukhopadhyay[3], esponente di spicco dell’ambiente culturale bengalese.
Ispirato al racconto “Chhuti Nakoch” di Ashapurna Devi[4] il film segue l’odissea di Vasanti, che uscita dal carcere non trova ad attenderla il marito – il vero colpevole, scopriremo – né alcuna traccia dello slum dove abitava, spazzato via dalla gentrificazione durante i cinque anni di prigionia. Con l’aiuto di Chandu, un pregiudicato di mezza tacca tornato in libertà lo stesso giorno, dapprima intenzionato a venderla a una cosca per saldare un debito, si mette in cerca del nuovo recapito della famiglia, scoprendo ahimè che una nuova donna le ha preso il posto di moglie e madre.
Il peregrinare della coppia accidentale ci porta a conoscenza dell’altra protagonista, Calcutta, in un ruolo somigliante alla Parigi di “Due o tre cose che so di lei” di J.L. Godard. Il risvolto sentimentale – topos classico: all’inizio si detestano, alla fine si amano – funge da ossatura per descrivere la resilienza di reietti approdati da zone rurali a un contesto metropolitano incapace di assimilarli [5]. Esplorata in lungo e largo dai quartieri alti ai suoi anfratti più oscuri, segnata da un profilo cangiante con palazzi lussuosi che soppiantano intere borgate popolari, la città si fa specchio della realtà socio-economica che opprime i due emarginati.
Per accentuarne il senso di straniamento, anziché in bengali Mukhopadhyay ha preferito girare in hindi, lingua madre dei personaggi in quanto immigrati, e di rinunciare ad attori celebri già consolidati nell’immaginario degli spettatori, dando spazio a Indira Tiwari (Vasanti) al suo debutto e all’emergente Tanmay Dhanania (Chandu), artefici di una recitazione ben calibrata, ricca di sfumature introspettive.
Degna di nota si rivela anche la performance di Rudhraksh Jaiswal nel racconto di formazione “The Tenant” di Sushrut Jain al suo esordio nel lungo di finzione [6]. Noto a livello internazionale come parte del cast dei due “Extraction” di Sam Hargrave per Netflix Usa, pur diciassettenne all’epoca delle riprese Jaiswal si è calato benissimo nei panni del tredicenne Bharat alle prese con la scoperta dell’eros, incarnato da Meera (Shamita Shetty), la nuova inquilina trasferitasi dal centro a una zona periferica di Mumbai.
Oltre ad accendere la fantasia di ogni condomino facente capo al sesso forte, l’arrivo della ragazza, emancipata nel vestire e nel comportamento, turba altresì la routine del versante femminile, rassegnato alla tradizione e maldisposto verso stili di vita che non può permettersi. In questa crepa si compie la maturazione di Bharat, diviso fra il maschilismo dell’educazione ricevuta e i nuovi modelli culturali che l’amicizia con Meera gli prospetta.
La crescita emotiva, tuttavia, non è un’esclusiva dell’adolescenza. E’ infatti adulto – ma non troppo – il protagonista di “Wingman (The universal irony of love)”, addetto di un ipotetico call-center di appuntamenti per cuori solitari, incapace per contrappasso di curare le ferite del proprio dopo che la fidanzata gli ha dato il ben servito.
Il giovane Anuj Gulati tinge di toni malinconici la sua opera prima con lunghe scene notturne a descrivere la cupezza interiore di Omi (Shashank Arora), fermo a un paradiso perduto che tenta di riesumare importunando di continuo la sua ex, nonostante una nuova relazione. Non è una storia d’amore, ma il pedinamento di una crisi in cui si cade quando lo sviluppo mentale si blocca e si seguita a girare su noi stessi, non potendo – o non volendo – guardare avanti.
Nel thriller psicologico “Chehre” [7] diretto da Rumi Jaffery [8] un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e un boia aspirano invece a guardare oltre. Oltre il pensionamento dovuto all’età, oltre il verdetto dei tribunali a lungo frequentati. Se ‘il mantello della giustizia è sepolto sotto secoli di polvere‘, per mettere al punto giusto l’ago della bilancia il quartetto gioca ad allestire processi casalinghi, purché ci sia qualcuno disposto a fare da imputato, come il pubblicitario rampante travolto da una tempesta di neve, che accolgono in una villa isolata dall’aspetto vagamente orrorifico. Solo un divertissement innocente per anziani nostalgici? Chissà.
Si tratta chiaramente di una delle tante trasposizioni [9] del romanzo “La panne. Una storia ancora possibile” di Friedrich Dürrenmatt pubblicato nel 1956, che Jaffery ambienta ai giorni nostri, mantenendosi fedele all’assunto di fondo e avvalendosi di un cast stellare capeggiato da Amitabh Bachchan, la star indiana per antonomasia, nelle vesti del pubblico ministero.
Al manager di “Chehre” inguaiato dal maltempo purtroppo non è data la possibilità concessa al Mahboob en abîme dell’arguta commedia “Rk/Rkay”, vale a dire darsela a gambe. Vecchia conoscenza di River to River, il bengalese Rajat Kapoor scrive/dirige/recita in un lungometraggio che parla di Rk, sceneggiatore/regista/attore di un gangster movie anni ’50/’60 dove il Mahboob da lui interpretato rifiuta la morte prevista dal copione e fuoriesce dal girato. Mentre il personaggio fa la conoscenza del mondo reale, Rk inizia a dialogare con Gulati (Mallika Sherawat), l’amata di Mahboob, e subendone il fascino entra nell’universo filmico da lui stesso ideato, passando non dal grande schermo ma attraverso un semplice monitor. L’esperienza avrà dei risvolti fondamentali per entrambi i fuggiaschi.
“La rosa purpurea del Cairo” di alleniana memoria è solo il più evidente dei molti riferimenti presenti in questa produzione a budget limitato, raccolto grazie al crowdfunding, che fa di scarsi mezzi virtù e tocca con leggerezza temi esistenziali quali il doppio, il rapporto fra l’inconscio dell’autore e la sua creazione e il contrasto realtà / finzione con echi pirandelliani. Considerando che Rk è il monogramma di Rajat Kapoor, ci auguriamo che la fase critica che il primo attraversa sia sul piano personale che professionale – tra l’altro è al suo ottavo film e nella sala montaggio compare la locandina de “La dolce vita” – non rispecchi affatto la biografia del secondo.
Note:
[1] Episodio avvenuto nel 2016 a opera di 12 malviventi armati che aggredirono una famiglia in viaggio sull’autostrada Delhi-Kanpur, violentando le due donne e malmenando l’uomo; noto come il caso Highway 91, impressionò molto l’opinione pubblica indiana.
[2] Anche la serie si basa su un simile fatto di cronaca, una giovane infermiera stuprata, torturata e uccisa in un autobus da una gang nel 2012 a Delhi. Evento di grande risonanza in India, ha ispirato il film “Anatomy of Violence” (2016) di Deepa Mehta. La serie si focalizza sull’indagine poliziesca subentrata al crimine.
[3] Figlio del celebre regista teatrale nonché attore Arun Mukhopadhyay, anche Suman affianca alla regia e scrittura cinematografica e televisiva una vasta attività in teatro.
[4] Celebre scrittrice e poetessa bengalese scomparsa nel 1995. Molti dei suoi racconti sono stati adattati sia per il grande che per il piccolo schermo.
[5] Nonostante la multiculturalità diffusa, permane nel Bengala la tendenza a non considerare parte integrante della comunità chi ha origini diverse, indipendentemente dalla loro classe sociale.
[6] In precedenza ha girato vari corti e il documentario “Beyond all Boundaries”.
[7] Traduzione letterale: Volti.
[8] Attivo da molti anni nell’ambiente cinematografico indiano in varie vesti, soprattutto in quelle di sceneggiatore.
[9] Fra le quali ricordiamo “La più bella serata della mia vita” di Ettore Scola, produzione italo-francese del 1972 con Alberto Sordi nel ruolo dell’imputato.
CORTINAMETRAGGIO 2022
NOTE DI UN CRONISTA
di Maurizio Villani
Domenica 20 marzo, con la cerimonia inaugurale all’Alexander Girardi Hall, si è aperta la XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri, rivolto alla scoperta dei giovani talenti della cinematografia breve italiana. La manifestazione cortinese è ritornata per una settimana a svolgersi tutta in presenza, dopo gli anni del lockdown. Maddalena Mayneri, in un’intervista di presentazione del Festival, ha ricordato le difficoltà incontrate nell’organizzare questa edizione, dopo due anni di pandemia, ma poi ha ribadito che «l’impegno di Cortinametraggio è quello di scoprire i talenti e creare le connection, cercando proprio di mettere insieme produttori, registi, sceneggiatori e presentare i ragazzi che sono qua in concorso. Sono i corti di questi giovani registi che il festival si impegna a far conoscere. Ieri sera alcuni di loro hanno avuto la fortuna di capitare a caso al tavolo della MG production con Morena Gentile: lei una produttrice e i ragazzi parlavano per conto loro e non si facevano notare. Io mi sono arrabbiata con loro e gli ho detto che avevano la possibilità di creare i contatti e dovevano lanciarsi.»
Il Festival ha visto la direzione artistica di Niccolò Gentili e la presidenza onoraria di Marcello Foti. A decidere a chi assegnare i premi tra i 25 corti selezionati la giuria, presieduta da Christian De Sica e composta da Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il regista David Warren e le attrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel.
«Ho guardato i corti con un grande rispetto e attenzione, detto Christian De Sica in un’intervista fatta al termine dei lavori della giuria. Per alcuni mi sono arrabbiato, per altri invece mi sono entusiasmato. È una grande cosa che esista un Festival che dia una visibilità a dei giovani capaci. Tra quelli che ho visto posso dire che ce ne sono alcuni che potrebbero farcela».

Nel corso delle giornate del festival, presentate da Roberto Ciufoli e Irene Ferri, c’è stata una serie di eventi speciali tra cui l’omaggio a Monica Vitti con “Vitti d’arte, Vitti d’amore” di Fabrizio Corallo che lo ha presentato sul palco. Presentato anche in prima assoluta il corto “Babbale”, prodotto da MG Production di Morena Gentile e realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore a Cortinametraggio. È una storia romantica, girata in tre giorni a Roma di notte, in collaborazione con la Polizia di Stato.
Non è mancata anche una parentesi sportiva dedicata al curling: allo Stadio Olimpico del Ghiaccio gli autori dei corti in concorso al festival e gli altri ospiti sono stati iniziati allo sport che ha visto di recente la coppia mista italiana, con la cortinese Stefania Constantini, vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2022.
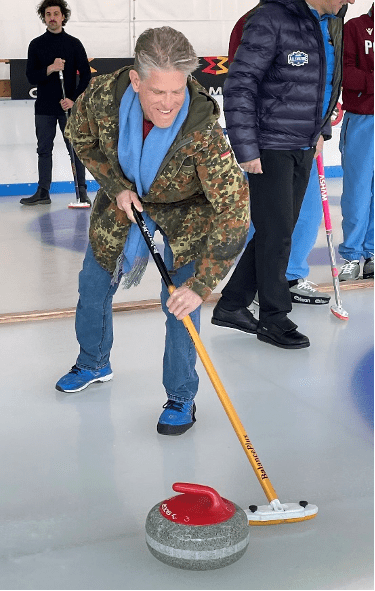
Tornando al cinema, molto emozionante è stata la proiezione del film “Supereroi” di Paolo Genovese, che proprio a Cortinametraggio iniziò la sua carriera vincendo con un corto nel 1999. Il film, costruito con un sapiente montaggio e ottimamente interpretato da Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, racconta la storia dell’amore di Marco e Anna: lui è un professore di fisica convinto che tutto abbia una spiegazione, lei una fumettista con un carattere impulsivo e nemica delle convenzioni. A tenerli insieme è qualcosa che nessuna formula può svelare: servono superpoteri per amarsi tutta una vita.
Altra proiezione apprezzata dal pubblico è stata quella del cortometraggio di Christian Marazziti “Amici di Sempre”. Dodici amici si ritrovano dopo anni a causa della pandemia, anche se non si erano mai persi di vista sin dai tempi del Liceo. A riportarli insieme è Valentina, che nel corso della cena fa un annuncio scioccante: sta per morire per un tumore e l’invito è in realtà un ultimo saluto agli amici di sempre. Si crea una forte tensione drammatica che il gesto involontario di un giovane commensale rompe, restituendo al gruppo di amici momenti di gioiosa spensieratezza.
Sabato 26 marzo si è giunti alla premiazione dei vincitori del festival: Miglior Corto Assoluto MG Production è risultato “L’Uomo Materasso” di Fulvio Risuleo che ha vinto anche il Premio Miglior Colonna Sonora FM Records Music
Il corto, presentato a Cortina in anteprima mondiale, interpretato da Edoardo Pesce, Irene Casagrande, Marco Colli, Tonino Risuleo, è un falso-documentario che indaga la psicologia di Guerrino Pau, il quale da vent’anni vive nel suo letto. Non ha nessun problema che lo costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua è una scelta e per questo motivo è stato soprannominato: L’Uomo Materasso.
Fulvio Risuleo, regista e fumettista, è nato a Roma nel 1991. Si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2013. Il suo corto di diploma “Lievito madre” vinse il terzo premio alla sezione Cinèfoundation del Festival di Cannes e con il corto successivo “Varicella” nel 2015 si è aggiudicato il premio alla Semaine de la Critique sempre al Festival di Cannes. Nel 2017 ha realizzato il suo primo lungometraggio dal titolo “Guarda in alto” a cui ha fatto seguito “Il colpo del cane” nel 2019.
L’elenco degli altri premi vede: Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico a “Buon compleanno Noemi” di Angela Bevilacqua. Il premio assoluto del pubblico a “InCONTROtempo” di Manuel Amicucci e a “Buon Compleanno Noemi” di Angela Bevilacqua. Miglior Attore è Lorenzo Aloi per “Notte Romana” di Valerio Ferrara. Miglior Attrice è Rita Abela per “Big” di Daniele Pini.
Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a “Chiusi alla luce” di Nicola Piovesan. “Le buone maniere” di Valerio Vestoso è il Miglior Corto Commedia Lux Vide e vince il Premio Ann’Amare. Il Dolomia Beauty Film Award a “Grow” di Vittorio Badini Confalonieri. Il Premio ANEC – FICE a “Big” di Daniele Pini. Il Premio Bagus a “InCONTROtempo” di Manuel Amicucci. Il Premio Novamarine a Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi.
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO RIDOTTO
di Roberto Baldassarre
“RENNEN”
Regia: Alexander Kluge, Paul Kruntorad; Sceneggiatura: Hans Neuffer; Speaker: Mario Adorf; Montaggio: Bessy Lemmer; Durata: 8:52 (24 fotogrammi al secondo)
Alexander Kluge (1932), autore di Artisti sotto la tenda del circo: perplessi (Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos, 1968), pellicola con cui vinse il Leone d’oro, è uno dei padri fondanti del Nuovo cinema tedesco. Nel 1962, durante l’annuale festival del cortometraggio che si svolgeva a Oberhausen, fu uno dei ventisei firmatari del “Manifesto di Oberhausen”, atto nel quale si dichiarava la morte del vecchio cinema tedesco e la necessità di fondarne un altro, emancipato nel linguaggio e non assoggettato al mercato. Questa netta presa di posizione rivoluzionaria, in verità, non segnò un vero spartiacque nel cinema di Kluge, poiché il regista tedesco fino a quel momento aveva realizzato soltanto due cortometraggi documentaristici, classici nell’impostazione (esporre in modo didattico l’argomento), ma “contestatori” nel soggetto: il nazismo e le corse automobilistiche.
Brutalität in stein (1961) co-diretto assieme a Paul Schamoni e Rennen (1961) realizzato con Paul Kruntorad, sono le prime prove registiche di Kluge, con cui si affacciò al linguaggio cinematografico. Se il primo è una disamina sull’architettura nazista, sulla staticità e gravità di queste pietre che rispecchiano la freddezza dell’ideologia hitleriana, il secondo è uno sguardo sul movimento. Rennen letteralmente significa correre, e all’uomo contemporaneo il brivido del gareggiare, della velocità e dei motori, crea enorme eccitazione.
LA VELOCITÀ COME EMOZIONE
Nel cortometraggio, di poco meno di dieci minuti di durata, ci sono quattro didascalie, che scandiscono il materiale raccolto e montato. Sono diciture lapidarie e sferzanti. 1) “Le persone vogliono andare sempre più veloci, per raggiungere altre persone o per superarle. La macchina rende possibili entrambi”; 2) “L’obiettivo dei corridori è la vittoria”; 3) “Il sorpasso inizia non appena si parte. È il significato vero di ogni corsa”; 4) “Chi si diverte a sorpassare perde. Il vincitore è chi supera tutti e ottiene la gloria”. La prima didascalia è quella che apre il cortometraggio, ed la premessa fondante a quanto verrà mostrato e dimostrato. A quest’appunto introduttivo, segue una sequenza tratta da una vecchissima comica del cinema muto, in cui due poliziotti inseguono una folle auto, molto veloce e che ha il dono – tramite i prodigi effettistici del cinema – di poter magicamente correre sopra una città.
Questo lacerto è la conferma di come il cinema, che propriamente significa movimento, abbia raccolto e amplificato sin da subito la forte attrazione degli uomini – che sono spettatori – verso la velocità delle auto. Un estratto cinefilo che assume, però, anche il carattere di stoccata ironica, per come il cinema sia fantasmagoria spiccia, lontana dalla realtà e che può alimentare fantasie distorte. Le scene a seguire di Rennen, sono spezzoni di competizioni automobilistiche, prevalentemente di Formula 1, incastonate nelle restanti tre didascalie. Vediamo i preparativi, gli inseguimenti, i sorpassi, gli spettatori, gli staff tecnici, le premiazione e gli incidenti. Come se fosse un servizio giornalistico, abbiamo il sunto di una corsa automobilistica, con tutti i suoi rituali atti a formare il grande spettacolo.
LA COLONNA SONORA DI RENNEN
Benché sia un cortometraggio basato sulle immagini, la colonna sonora crea un ulteriore valore significativo. La voice over dello speaker, l’utilizzo di un solo strumento musicale e il suono del rombo dei motori sono i tre aspetti che creano questo piano uditivo. La voce del commentatore (Mario Adorf) è quella di spiegare, a volte con toni critici, il mondo delle corse automobilistiche. Un intervento esteriore, dall’alto, tipico della narrazione didattica (presente anche in Brutalität in stein). La musica, che utilizza soltanto il martellante battere di un tamburo, crea un suono che evidenzia tanto la combattività (un ritmo di guerra) quanto la ritualità della tribù (un suono liturgico). Il rombo dei motori, invece, è la voce agguerrita e animalesca delle auto, un tono di sfida e supremazia che rimbomba negli autodromi e alimenta la libidine negli spettatori.
CONNESSIONI CON IL NUOVO CINEMA TEDESCO
La relazione di Rennen con il prossimo Nuovo cinema tedesco, che si affermerà a livello internazionale dalla seconda metà degli anni Sessanta, anche grazie ai lungometraggi di Alexander Kluge, è principalmente legata alla presenza, nel cast tecnico, di due artisti che collaboreranno con altri registi tedeschi: Peter Berling (1934-2017) e Mario Adorf (1930). Berling, qui nelle vesti di co-produttore, sarà uno dei coraggiosi produttori (circa 20 produzioni) della Nouvelle Vague tedesca, e soprattutto attore per le folle imprese di Werner Herzog, ad esempio Aguirre, furore di Dio (Aguirre, der zorn Gottes, 1972) e le nevrotiche storie di Rainer Werner Fassbinder, come Attenzione alla puttana santa (Warnung vor einer heiligen Nutte, 1971). Inoltre, fu anche un quotato caratterista per il cinemabis italiano.

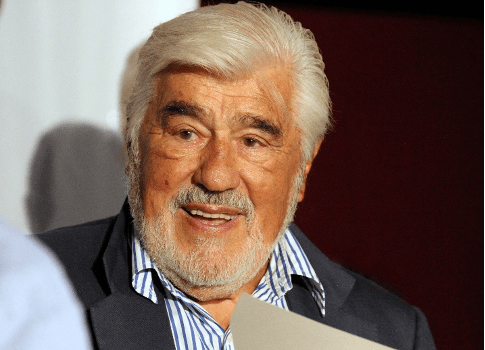
Mario Adorf, svizzero di origini calabresi, principalmente noto per le sue interpretazioni nel cinema di genere italiano, come attesta il cult di Quentin Tarantino Milano calibro 9 (1972) diretto da Fernando Di Leo, ha presenziato in un paio di pellicole di Volker Schlöndorff, che fu uno dei firmatari del “Manifesto di Oberhausen”, e ha lavorato con Fassbinder. Adorf appare ne: Il caso Katharina Blum (Die verlorene Ehre der Katharina Blum, 1975), co-diretto da Schlöndorff con Margarethe von Trotta; Il tamburo di latta (Die blechtrommel, 1979), opera che vinse, ex-aequo con Apocalypse Now, la Palma d’Oro; e in Lola (1981).
OCCHIO CRITICO
IL CIMITERO DEGLI ELEFANTI: “OCCHIALI NERI” E “ENNIO”
di Francesco Saverio Marzaduri
“Occhiali neri”
Sgombriamo il campo dagli equivoci: non fosse per i consueti passaggi dati i quali si reputa di culto, anche nelle operazioni più detestabili, la filmografia di Argento, “Occhiali neri” proseguirebbe tranquillo la senilità del suo autore. Ciò che da sempre colpisce gli “aficionados” del genere orrifico risiede nella disinvoltura di stilemi tramite i quali il desiderio di raccapriccio sfiora il punto di fusione con l’antica tradizione leggendaria, all’occorrenza costellata di abbondanti sfumature gotiche o, nello specifico caso, “dark”. L’opera di Argento non è che un’ininterrotta fiaba macabra, ribadita da ipertesti narrativi precisi che, prima di questa ventesima prova cinematografica, riadattano Bram Stoker o, in precedenza, Poe e Leroux: nomi tutelari chiamate a rammentare come la voluttà del brivido, la brama di ribrezzo sopita nei più reconditi anfratti dell’incognito Nulla, eredità d’una memoria irrinunciabile, non svanisca mai completamente. Figurarsi dunque se la componente-cecità, strumento che nell’avversa sorte agevola la soluzione d’un enigma, non si ripresenti aggiornata, a mezzo secolo di distanza da quel “Gatto a nove code” in cui il cineasta romano la utilizza per la prima volta. Materia ghiotta per i cultori del genere, giustificata da un meditato ritorno alla regia dopo due lustri, per il quale Argento riprende uno “script” di vent’anni prima, firmato a quattro mani col sodale Franco Ferrini; e al pari di “Phenomena”, primo lavoro del sodalizio, in “Occhiali neri” fa capolino un denominatore comune: non tanto l’opzione d’una figura incosciente, e dunque “non vedente”, quanto quella di ambientare l’apologo nei pressi d’un bosco che obbliga i protagonisti a sfuggire all’assassino, nonché teatro di un’aggressione – in verità gestita infelicemente – in uno stagno infestato da serpi. A prescindere da tale scelta di campo, la presenza faunesca cui spetta un ruolo di demiurgico salvatore (qui un cane da guardia, che richiama l’aiuto da parte d’uno sciame di insetti, d’uno scimpanzé o uno stormo di corvi) concorda con un luogo, la foresta, che è sfondo di assunti “fantasy” secondo il collaudato cliché favolistico, con tanto di capanno disabitato; né manca l’inserto dei cacciatori che i personaggi incontrano durante la fuga. La stessa inclusione d’un ragazzino cinese, a pensarci, conduce “Occhiali neri” lungo il sentiero della mitopoiesi infantile, come altrove sperimentato in una parentesi di “Opera”. Sicché l’esito senza infamia né lode conferisce una sensazione di patetico trasporto, riconducibile a una memoria ludicamente anacronistica più che a una “rentrée” autoriale. Tempo addietro si rimproverava ad Argento l’abitudine di costruire il racconto per agglomerazione; l’assenza di qualsiasi pretesa nel tentativo di agganciare lo spettatore a lacunose spiegazioni dell’arcano, col senno di poi, è divenuta una cifra tanto ricorrente da indurre il sospetto, più che lecito, che la quantità (commerciale) sulla qualità (artistica) sia luogo canonico ricercato a bella posta, quando non standardizzato.
Se si affermasse che quest’ultimo prodotto non fa eccezione, si trascurerebbe un dato non irrilevante: la confezione thrilling a base di eccessi e truculenza, ove il comparto pauroso fa perenne leva sull’epidermico anziché sulla coscienza, non basta a tener insieme un aneddoto buono, tutt’al più, per una serie televisiva in cui le giunture, poliziesche o intimiste, goffamente s’insinuano nell’armamentario grandguignolesco. Non si nega la disinvoltura (e la faciloneria) con cui il regista-sceneggiatore ostenta fin troppo generosamente gli effetti speciali del fido Sergio Stivaletti, accompagnati dall’incalzante musica di Arnaud Rebotini. A latitare è ancora una volta una sceneggiatura irta di assidui passaggi forzati e inutili lungaggini, in cui le cadute di ritmo (aggravate dalla colpevole quanto abborracciata volontà di spiegare quanto risulti poco chiaro) accentuano l’evidente inverosimiglianza, come la presentazione di Diana e della sua “professione”, illustrate in modo sbrigativo, o l’agguato automobilistico in cui la “escort” perde la vista. Né costituisce novità che una recitazione pedestre non sia l’aspetto cui Argento guardi maggiormente, data l’involontaria ilarità di situazioni e dialoghi. Semmai, “Occhiali neri” è un lavoro da godere per assaggi, minuto per minuto, in un “climax” di tensioni che non si fondono l’una all’altra: anche se dopo meno di mezzora si capisce tutto, il risultato giunge come un pezzo d’antiquariato, in cui la mano del maestro che fu si rintraccia nella reiterazione di “fondu”, soprattutto in una prima metà scissa in capitoletti; tanto che il nero, da subito, è componente cromatica di diegetica rilevanza, pensando all’eclissi solare prima dei titoli di testa, in cui la notte sostituisce la luce del giorno (speculare all’abito bianco di Diana nel finale), nella misura in cui l’abbaiare dei cani, nemmeno di sottecchi, amplifica il sinistro presagio, compresa la cecità della protagonista. Cocci d’una bottiglia semivuota, insieme al noto feticcio di architetture e luoghi geografici (il quartiere dell’EUR), relativamente al quale nomi altisonanti della critica, per contingenza estetica e/o per geometrico disegno, apparentano il film ad Antonioni (e c’è chi da un pezzo sostiene che “Blow-Up” abbia ispirato “Profondo rosso”). Nel rapporto materno-filiale tra la prostituta e Chin, malinconicamente destinato a concludersi, s’individua però una componente d’insolita morbidezza: lo sguardo argentiano s’è fatto via via meno misogino e più tenero (la stessa figlia Asia, qui anche produttrice esecutiva, si ritaglia il ruolo di un’operatrice ausiliaria, anch’ella vittima). E magari non è un caso che l’immissione d’un allevatore di cani, dopo il riadattamento del “Canaro” a firma Garrone, suoni un’apocrifa variante: come un passaggio di consegne tra generazioni registiche. In attesa di vederlo interprete dell’imminente “Vortex”, diretto dal discepolo Gaspar Noé – nemmeno a dirlo, un aneddoto pessimista incentrato su un’esistenza al crepuscolo – l’anziano Dario si congeda davanti all’inappellabile mutamento, testimoniato dalla solitudine della “escort” col proprio cane nell’ultimo fotogramma. E chi scrive, tardando a visionare la celere uscita di “Occhiali neri” in sala, s’è dovuto accontentare di riesumarlo su piattaforma, altro allarmante monito.
“Ennio”
Sarebbe stato imperdonabile buttar giù quattro banalità commemorative, il giorno in cui Morricone è scomparso: era necessario, prima, “sentire” che la magna opera del maestro – l’amore e la passione alla ricerca d’una sperimentazione ogni volta maggiore, lungo un intero arco esistenziale – non fosse cessata di colpo con la sua morte. Perché, come insegnava Fellini, il sogno ha bisogno di continuare e, cosa buona e giusta, la parola “fine” non deve spezzare l’incanto. Tanto più se si tratta del “milieu” musicale e di un autore a cui molto deve il cinema “tout court”, quello internazionale e non solo italiano: quello che tardivamente ha realizzato di non avergli riconosciuto per tempo la debita grandezza. Undicesimo lungometraggio di un Tornatore non al suo primo documentario, “Ennio” è la testimonianza di quanto sia possibile coniugare le due citate ragioni, offrendo al pubblico la possibilità di udire un’ultima volta la voce (umana) di Morricone, dunque la migliore offerta – e l’estrema corrispondenza – per ascoltare molti suoi capolavori seguendone la genesi, nonché l’esigenza di confezionare un equo tributo a un altro uomo delle stelle; un uomo, prima che un artista, segnato da glorie e vicissitudini, applausi e rimpianti, umiliazioni e riconoscimenti. Del resto, non poteva essere che un cineasta da sempre fedele al prototipo leoniano a tentare l’impresa, inaugurata sette lustri prima, quando Tornatore conosce il musicista romano per “Nuovo Cinema Paradiso” e la cui collaborazione sarebbe proseguita in altre occasioni.
Quasi tre ore di spettacolo senza che la durata minimamente s’avverta, in cui “session”, prove, concerti si (con)fondono con interviste assortite e filmati d’archivio, inediti e rarità, a confezionare una sinfonia audiovisiva pressoché perfetta. Se l’esperimento, riassunto in poche righe, potrebbe risultare convenzionale (e ironicamente parafrasarsi “La leggenda del trombettista sull’oceano”), il reale colpo d’ala consiste nel ribadire il crescendo dell’arte morriconiana, mentre fotogrammi di celebri pellicole musicate dal Nostro, da “C’era una volta in America” a “Mission”, si mescolano incessanti ad immagini dello stesso, assorto nella direzione orchestrale, e alle testimonianze: il tutto, architettato come una scena madre, giunge dritto al cuore dello spettatore, come una rinnovata epifania. È come assistere visivamente a un’ulteriore composizione musicale, riconsegnandole identica epicità e offrendo un esaustivo ritratto storico sul secolo di un Paese ove cultura e cinema, dominando la scena ancora una volta, ebbero voce in capitolo. Il solito discorso della piccola ghianda da cui nasce la grande quercia? La risposta già è nell’incipit, poco prima dei titoli di testa: mentre volti di cartello (Paoli, Morandi, Caselli, Argento, Bertolucci, Wertmüller, Eastwood, Metheny, Springsteen…) sfollano condensandone la grandezza, un metronomo in movimento scandisce le azioni d’un Ennio intento a far ginnastica, radunare pensieri, meditare idee, muovere perennemente le mani al centro d’un maestoso studio strabordante di volumi, spartiti, fogli d’album. Il senso del ritmo e del tempo, rispettivamente forma e contenuto, costituiscono il senso imprescindibile dell’operazione decretandone appieno la riuscita, essendo le chiavi principali della perfezione melodica. Sono il “magico accordo” che consente a Morricone, ancora fresco dell’esperienza-canzonetta (è lui, “in extremis”, a salvare dal fallimento l’RCA), di rincontrare un vecchio compagno di scuola, Sergio Leone, e forgiare l’arcinoto sodalizio.
Perché “Ennio” è anche un apologo sul senso di riscatto da ingiuste umiliazioni: se il secondo dichiarò di cimentarsi nell’esecrata regia per risarcire il padre, considerato un mestierante da poco, il primo – rilasciando aneddoti che non sempre ne frenano la commozione – confessa quanto successo e denaro ne abbiano sminuito la formazione classica. Pure nel caso del compositore romano fa capolino la componente paterna (il babbo lo introduce alla tromba, vanificandone l’aspirazione medica), ma la conoscenza con Goffredo Petrassi gli conferisce quella vocazione e quel talento che colleghi e amici del medesimo ambito gli invidiano e, sulla cresta dell’onda, rinfacciano. Persuaso che comporre musica per lo schermo equivalga a prostituirsi, Ennio prende di petto la sfera eufonica quale esigenza di rivalsa, nella strenua ricerca del tocco che abbini prosa e poesia (“Le note sono come mattoni per un palazzo, ma i palazzi non vengono uguali”). Una magnifica ossessione che l’obbliga a provarsi in ogni genere, a cominciare dall’inclusione di citazioni colte nei 33 giri: il trampolino di lancio per “Il federale” di Salce, in aggiunta a qualche precedente innesto (la scherzosa ninna nanna del “Giudizio universale”), conduce alla svolta nello “spaghetti western” con lo pseudonimo Dan Savio, e al conseguente trionfo col tema di “Per un pugno di dollari” (che, riascoltato anni dopo, non piacque né a lui né a Leone). Soprattutto la novità del rumore assurto ad armonia, ispirato dalle composizioni post-weberniane, che ne fa un innovatore del “pop” nostrano, nella misura in cui i “leitmotiv” e il conseguente record di vendite finiscono per sovrastare le pellicole cui appartengono, divenendo film a loro volta. “Questo mi ha un po’ isolato”, afferma, dispensando vergogna quando De Laurentiis e Huston, licenziato Petrassi, lo chiamano per “La Bibbia”, prima che l’RCA annulli la cooperazione; persino Kubrick lo contatta per “Arancia meccanica” ma Leone, pur di tenerselo stretto, inventa la scusa ch’è all’opera con “Giù la testa”, benché la partitura sia pronta da un pezzo. Nel monumentale affresco i cui retroscena vanificano aspri giudizi critici (“Novecento”) e disegni registici sfocianti in un’involontaria quanto ineludibile autoreferenza (si pensi ai temi pressoché identici de “I cannibali” e “Queimada”), ne emerge il ritratto di uno studioso enigmatico e schivo, perennemente combattuto dall’anelito della perfezione sonora, tormentato da una messa in gioco che lo trasforma in attento psicologo verso i cineasti per i quali, di volta in volta, si pone al servizio (“Lo scrivo io, l’articolo in tua difesa”, ribatte Zurlini), e la cui passione per gli scacchi, da esplicita allegoria, giustifica la scommessa con l’esistenza e il desiderio del potenziamento. A impreziosire il prodotto pensano alcune belle idee narrative: dai primissimi piani del protagonista che s’intrecciano con quelli dei vari ospiti, in sedute diverse, a conferire dinamismo partecipativo, alla fotografia a colori (da “Indagine su un cittadino” a “Sacco e Vanzetti”) che sublima nel bianco e nero, restituendo nuovo valore semantico al documento storico.
O ancora, lo “split screen” in due parti su Ennio nell’illustrare i rispettivi paradigmi compositivi, quasi fosse una forma a due voci. Chi perseverasse nel dubitare delle capacità di Tornatore, altrove tradite da esiti altalenanti, sarebbe qui smentito da un genuino atto d’amore verso il cinema (e la vita), ancora capace, secondo il collaudato tropo delle scatole cinesi, di fare capannello, stringere un coro nel segno della mitopoiesi e dirompere l’“escalation” conclusiva in una collettiva “standing ovation”. Indipendentemente da ciò, il miracolo si compie a raggio completo, trasmettendo la lezione che fu (e sarà, e seguiterà ad essere) anche a fresche leve. “Un grande artista non è mai povero”, sigla candidamente Babette, “abbiamo qualcosa di cui gli altri non sanno nulla”. La meta da conseguire è qualcosa di sfuggente anche al più solenne tra i virtuosi? Basti e avanzi l’esempio a sancire che non è mai la fine, quand’anche si reciti il proprio commiato. E portare avanti la missione d’incantare gli angeli.
“L’ACCUSA” DI YVAN ATTAL
di Tullio Masoni
Alexandre è un ottimo studente dell’università di Stanford. Torna a Parigi per una cerimonia in onore del padre, un noto giornalista televisivo. Invitato a cena dalla madre, una matura e radicale femminista che si è separata dal padre poco tempo prima, il ragazzo conosce Mila, figlia diciassettenne del nuovo compagno della madre, e la porta con sé a una festa. Il giorno dopo Alexandre, avendo Mila sporto denuncia, viene arrestato per stupro.
Tratto dal libro Les choses humaines di Karine Tull, “L’accusa” (brutto il titolo scelto dalla distribuzione italiana) è la messa in scena di un caso giudiziario che gli autori pongono allo spettatore per coinvolgerlo nei contrasti e nei dubbi man mano sollevati dalle udienze. Cosa è successo la notte della festa? In che modo il fatto si inserisce nell’ampia problematica delle violenze di stupro? Come riflette il senso comune, la crisi dei protagonisti e l’esposizione mediatica?
Yvan Attal – anche co-sceneggiatore – crea un congegno efficiente, intrecciando alla ritmica drammaturgica del processo (giudici, avvocati) le diverse versioni dei personaggi-testimoni. L’udienza in aula diventa così un confronto di tesi e sentimenti nel quale, oltre la ricerca di una “verità oggettiva” e di un rispetto delle garanzie – cioè di una formale indagine che sappia andare davvero a fondo riflettendo l’esigenza protettiva dei diritti – le certezze di partenza si fanno sempre più esili. Come spesso accade nei drammi giudiziari lo spettatore è preso dalla continua tentazione di parteggiare per uno o per l’altro, nonché a cambiare e ricambiare secondo le emergenze di prova, le sfumature, la solidità o fragilità dei principi da cui era partito. Attal lavora su questo per presentare la vicenda in ambiti vieppiù complessi, cioè per esercitare una tensione crescente sulle facoltà di giudizio. Il coinvolgimento sentimentale e morale si fa allora più severo: un crescendo regolato dall’andamento filmico, non meno che dalla scansione fenomenologico-rivelatoria indotta dalle procedure, dai legali che le organizzano e dai protagonisti che, con la loro emotività, ne accentuano gli effetti drammatici. Tutto nella convenzione di genere, ripeto, ma il regista impegna un particolare sforzo di abilità e per di più (sia corretto o meno) tocca circostanze familiari che sono anche sue: il giovane che interpreta l’imputato è infatti il figlio Ben, e la madre – Charlotte Gainsburg, sempre brava – chiede di essere ascoltata nel processo appunto come madre, non come intellettuale femminista.
Il ritmo fondato su inchiesta e dibattimento processuale s’incrocia quindi con l’uso di flash-back che tornano alla notte dello stupro. I brani però spiegano solo in parte, o meglio creano sospensione e nuove domande. Tutto ciò al fine di allargare il discorso e approfondirlo fornendo allo spettatore sempre nuovi elementi di conflitto: coi valori, il costume sociale diffuso, i rapporti di forza fra maschile e femminile, con la sensibilità di ciascuno, messa nelle condizioni di verificarsi spregiudicatamente. Fra i luoghi comuni che saltano in aria ne resta uno, e riguarda la definizione del “prodotto”. Mi riferisco a una specie di parentesi erotica, quella in cui l’anziano giornalista televisivo è in camera e a letto con una giovane stagista – si vedrà in seguito che la tresca ha avuto conseguenze, cioè la nascita di un bambino – aperta nel film con lo scopo di dimostrare l’inveterato maschilismo. Una parentesi (anzi due) che allunga i tempi, appare superflua e, forse, compiaciuta nel mostrare la bella ragazza col bolso libertino che, cinicamente, la possiede. Alla bisogna sarebbero bastate, se si tiene conto del clima creato dal regista, un paio di precise battute. Nel caso, però, avremmo avuto davanti agli occhi – ed è proibito dall’abitudine del cinema corrente – un po’ di sesso in meno.
“L’accusa” (“Les choses humaines”) – di Yvan Attal – con: Ben Attal, Charlotte Gainsburg, Suzanne Jouannet, Mathieu Kassovitz – Sceneggiatura (dal romanzo di Karine Tuil): Yvan Attal con Yaël Langmann – Francia,2021
LOZNITSA TRA DOCUMENTARIO E FINZIONE
“BABI YAR. CONTEXT” E “DONBASS” DI SERGEJ LOZNITSA
di Paolo Vecchi
Tra il 29 e 30 settembre 1941, i nazisti fucilarono 33.711 ebrei nella gola di Babi Yar,a nord-ovest di Kiev. Su questo orribile evento, per anni ignorato dai russi e dagli stessi ucraini in quanto ad esso avevano partecipato i collaborazionisti di Stepan Bandera, Sergej Loznitsa avrebbe voluto girare un lungometraggio di finzione, reso però impossibile dal Covid. Così il regista, bielorusso di nascita ma ucraino di adozione, ha realizzato una sorta di sinopia, “Babi Yar. Context”, premio “L’Oeil d’Or” a Cannes 2021, optando per un lavoro di montaggio su materiali di repertorio, come nel magnifico, agghiacciante “Blokada” (2005), sull’assedio di Leningrado. “I nostri ricercatori hanno lavorato all’Archivio di Stato russo a Krasnogorsk, al Bundesarchiv e in una serie di archivi regionali in Germania, e siamo riusciti ad accedere anche ad alcune collezioni private”, ha dichiarato Loznitsa. “Alcuni filmati sono stati sepolti negli archivi per decenni, nessuno li aveva mai visti. Nemmeno gli storici specializzati nell’Olocausto in URSS”. Questo imponente found footage, in bianco e nero ma anche a colori, ricostruisce il massacro a partire dal suo prologo. Così, tra bombardamenti aerei, colpi di cannone e fumo nero che si staglia sullo sfondo di campi popolati da branchi di oche spaventate, i nazisti entrano in Ucraina, dapprima a Lvov poi a Kiev, tra ali plaudenti di folla e bambini e ragazze che offrono mazzi di fiori ai “liberatori”, mentre le gigantografie di Stalin vengono fatte a pezzi e sostituite da quelle di Hitler. Una serie di esplosioni che distruggono alcuni palazzi uccidendo dei civili, opera di agenti dell’NKVD, l’antenato del KGB, vengono attribuite agli ebrei, per i quali si prepara una rapidissima “soluzione finale”.
Due anni dopo, nel novembre 1943, le truppe sovietiche riconquistano Kiev, i manifesti del Fuehrer sono stracciati, su un palco si festeggia la rinata amicizia tra ucraini, polacchi e russi mentre un gruppo folkloristico balla il trepak. Nel 1946 si celebra il processo ai responsabili dell’eccidio, con l’interrogatorio di uno dei graduati nazisti e le testimonianze dei pochi sopravvissuti, tra i quali una donna sfuggita alle pallottole, lasciatasi cadere nel mucchio dei cadaveri e allontanatasi col favore delle tenebre per evitare di essere sepolta viva. Impressionante la sequenza dell’impiccagione dei colpevoli, alla quale assiste un mare di folla stipata in una grande piazza della capitale.
Ma l’odissea di questo massacro non termina qui. I russi, per cancellare una memoria che non corrisponde alla loro visione storica, anziché ipotizzare un Memoriale, costruiscono a Babi Yar una fabbrica di mattoni e una diga. L’ultima immagine del film, davvero agghiacciante oltre che significativa, mostra un trattore che spiana letteralmente l’altura, a seppellire per sempre ogni traccia. D’altronde, anche la Sinfonia n.13 op.113 “Babi Yar” di Shostakovich venne inizialmente proibita da Kruscev nel 1962 per il testo di Yevtushenko, critico nei confronti della politica antisemita in URSS. Loznitsa, come in “Blokada”, integra la colonna sonora con i rumori aggiunti dal suo tecnico del suono Vladimir Golovnitski, escludendo la musica extradiegetica e non sovrapponendo nessun commento alle immagini se non qualche cartello puramente esplicativo. Fa eccezione, per il suo alto valore poetico, “Ucraina senza ebrei”, un lungo epicedio delle vittime, puntigliosamente categorizzate, scritto nel 1943 da Vasilij Grossman, futuro autore del magnifico “Vita e destino” ma anche di “Tutto scorre”, un capitolo del quale è dedicato al genocidio degli ucraini, fatti morire per fame da Stalin all’epoca della NEP.
Loznitsa si é dedicato anche alla storia recente del suo Paese, sia raccontando il dopo ’89 in uno straordinario lungometraggio di finzione come “Scast’je moje” (t.l.: La mia gioia, 2010), sia documentando momenti chiave di svolta politica, come in “Maidan” (t.l.: id. 2014), sulle manifestazioni di popolo che hanno portato alla caduta del governo filorusso di Viktor Janukovich. Alla fiction, ma sempre con taglio semidocumentaristico, appartiene “Donbass” (2018), premio per la regia a “Un Certain Regard” di Cannes, che arriva oggi sui nostri schermi sull’onda dell’ ”operazione speciale” promossa da Putin a partire dal 24 febbraio. Loznitsa, decisamente schierato, parla dell’autoproclamata Repubblica di Nova Rossyia come una società dove regnano l’aggressività e la corruzione e dice di avere selezionato 13 episodi, tutti collegati fra loro, ognuno dei quali é realmente accaduto nei territori occupati nel 2014-2015.
Il registro é quello di un grottesco forse non del tutto nelle corde dell’autore, anche se quasi sempre il racconto volge in tragedia, in momenti cupi come la perlustrazione dei sotterranei dove vivono i reietti del nuovo regime, o di una tensione ai limiti della sopportabilità, come nella sequenza in cui un volontario dell’esercito regolare ucraino viene legato a un palo ed esposto al ludibrio del pubblico, che dall’insulto e allo sputo trascende ben presto a un tentativo di linciaggio vero e proprio. Per questo siamo curiosi di vedere come una parte della nostra contorta opinione pubblica lo accoglierà. Forse anche Loznitsa verrà accusato di essere nazista, lui che ha diretto film come il succitato “Babi Yar” e “Austerlitz” (2016), sulla profanazione di un lager da parte di turisti che si comportano come fossero in un parco divertimenti. A proposito della sua posizione in merito, traduciamo di seguito la lettera, ci sembra molto significativa, che ha inviato a “Positif”. “Il 24 febbraio 2022, quando i reggimenti russi avevano appena invaso l’Ucraina, il primissimo messaggio che ho ricevuto veniva dall’amico Viktor Kossakovski, regista russo: ‘Perdonami. E’ una catastrofe. Provo tanta vergogna’. Poi, più tardi, Andrej Zvyagintsev, ancora molto debole dopo una lunga malattia, registrava il suo in video. Numerosi amici e colleghi, cineasti russi, si sono levati contro questa guerra insensata. Quando sento, oggi, degli appelli che tendono a proibire i film russi, sono queste persone che mi vengono in mente, gente per bene, gente degna. Sono come noi vittima di questa aggressione. Quello che si dipana in questo momento sotto i nostri occhi é orribile, ma io vi chiedo di non sprofondare nella follia. Non bisogna giudicare la gente in base al passaporto. La si può giudicare solo in base ai suoi atti. Un passaporto é dovuto solo al caso della nascita, mentre un atto é quello che definisce di per se stesso l’essere umano”. Per queste sue dichiarazioni Loznitsa é stato da poco espulso dall’Accademia dei Cineasti dell’Ucraina, con l’accusa, tra le altre, di cosmopolitismo, tristemente nota già ai tempi di Stalin.
“ATLANTIS” DI VALENTYN VASYANOVYCH: UNA TERRA DISTRUTTA
di Marco Incerti Zambelli
Quando sugli schermi del Festival del cinema di Venezia 2019 apparvero le immagini di Mariupol, delle acciaierie Avostal, pressoché nessuno le riconobbe e ben pochi erano a conoscenza che sotterranea continuava una guerra nel Donbass. ‘2025, due anni dopo la guerra’, la distopica didascalia iniziale di quel film, “Atlantis” di Valentyn Vasyanovych, apriva un racconto spietato delle conseguenze di quella tragedia sugli uomini, sulle cose, sull’ambiente. Nonostante la meritata vittoria nella sezione Orizzonti, quell’opera ha trovato la via degli schermi italiani solo nell’aprile di quest’anno, grazie a Wanted Cinema, che qualche settimana prima ha distribuito l’ultimo lavoro del regista, “Reflection”, anch’esso meditazione su quel dramma.
Nonostante l’Ucraina appaia come vincitrice, Vasyanovych non mostra nulla della guerra se non nel prologo, nel quale una ripresa con gli stranianti infrarossi mostra la uccisione di un uomo, non esamina cause e risultati del conflitto e si limita al commento di un suo personaggio che afferma: ‘Ci sono voluti 10 anni per ripulire questa regione dalla propaganda e dai miti sovietici’. Mette in scena il percorso di Sergiy, interpretato dall’attore Andriy Rymaruk, che ha combattuto lui stesso nella resistenza, nel ruolo di un veterano che rievoca la sua esperienza in tempo di guerra sparando a sagome di ferro con un compagno, che come lui soffre di stress postraumatico. L’amico non regge alla tensione, il suo malessere lo porterà ad un tragico suicidio precipitandosi nel metallo fuso nell’acciaieria dove lavorano; Sergiy onorerà la sua morte assistendo inerte allo sversamento dei residui incandescenti di lavorazione, come in una sorta di allucinata cerimonia funebre. In una sequenza mirabile arriva l’annuncio che lo stabilimento verrà chiuso e smobilitato: il regista, con una lunga inquadratura fissa, mostra gli operai, ammassati come i lavoratori di “Metropolis”, convocati dal direttore che si intravede sul palco ma che li domina da un grande schermo come una sorta di Grande Fratello, che in inglese, a segnare la distanza e probabilmente lo sfruttamento dell’Occidente, tradotto da un’interprete, dichiara la fine dell’acciaieria, invita i dipendenti a brindare mentre sullo sfondo vengono proiettate immagini di “Entusiasmo” un documentario degli anni ‘30 di Dziga Vertov, inneggiante alla potenza industriale ucraina , che suona come un sarcastico contrappunto ai litigi ed alla disperazione dei lavoratori.
Sergiy accetta il lavoro di fornire con un veicolo ex militare serbatoi d’acqua nelle aree periferiche dove l’ambiente è stato reso tossico dalla guerra, nella cosiddetta “zona”, citazione esplicitamente rivendicata dall’autore da “Stalker” di Tarkovskij. È un viaggio in un paesaggio devastato, il cui recupero alla vita appare impossibile, i rifiuti dei pozzi hanno inquinato la terra, le infrastrutture sono state distrutte e acri di miniere allagate hanno avvelenato i fiumi, attraversato da rari mezzi pesanti, infestato da mine inesplose la cui rimozione pare essere l’unica, per quanto inane, attività possibile. In quel contesto tuttavia lavora un’associazione umanitaria, il cui scopo è il recupero dei cadaveri abbandonati, nel tentativo di dare un nome o almeno una degna sepoltura alle vittime della guerra, indipendentemente dalla loro nazionalità, e Sergiy incontra Katia, militante di quella organizzazione e decide di aggregarsi a loro. Il recupero delle salme porta ad un’analisi fredda, dettagliata, straniante di quei corpi mummificati e sconvolti, il cui risultato è spesso solamente l’attribuzione di un numero con cui seppellirli. La fissità della messa in scena delle autopsie, nelle quali le uniche parole pronunciate sono la gelida sequenza di apparentemente indifferenti constatazioni di morte e distruzione, trasmette uno spietato e disperato orrore; eppure l’umanità che comunque trasuda da quella missione, che rimanda al rigore etico di Antigone come alla poesia de ”L’Arpa Birmana”, pare risvegliare nei protagonisti la possibilità di tornare alla vita, nella nascita di un amore sottolineato da una sequenza ad infrarossi speculare ed opposta a quella inziale, nella coscienza certo della tragedia vissuta, della terribile realtà che li circonda ma che comunque anche quello può essere ‘un buon posto per gente come noi’.
Vasyanovych – autore anche della sceneggiatura, della fotografia e del montaggio – compone con geometrica precisione le 28 sequenze del film, la camera ferma tra campi medi e lunghi in un paesaggio dilaniato, attraversato a tratti da pesanti mezzi militari, rarissimi i movimenti di macchina, esili e rari e dialoghi, un’algida fotografia giocata con maestria tra grigi e verdi, solcati da bagliori di fuochi rossi e gialli, ad evocare Atlantide come mito di una civiltà andata in rovina, della quale non restano che macerie, nella quale, tuttavia, miracolosamente, forse la vita può essere ancora possibile.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
IL SILENZIO, UN PRETESTO PER VIVERE “RATA NECE BITI.
LA GUERRA NON CI SARÀ” DI DANIELE GAGLIANONE
di Marcello Cella
“Don Tonino Bello amava ripetere che i conflitti e tutte le guerre trovano la loro radice nella dissolvenza dei volti. Quando cancelliamo il volto dell’altro allora possiamo far crepitare il rumore delle armi. Quando l’altro, il suo volto come il suo dolore, ce lo teniamo davanti agli occhi, allora non ci è permesso sfregiarne la dignità con la violenza”
Papa Francesco, “Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace”
Quello che rimane dopo una guerra è il silenzio. Anche dopo una battaglia. E’ quello che raccontano i civili scampati al massacro dell’Azovstal a Mariupol in Ucraina. Quando dopo settimane di assedio hanno potuto uscire dai sotterranei del complesso industriale bombardato incessantemente dai russi ed evacuare verso luoghi più sicuri la cosa che più li ha colpiti è stato il silenzio. Lo raccontano tutti. Il silenzio delle armi e delle bombe. Anche Daniele Gaglianone in questo documentario datato 2008, “Rata nece biti. La guerra non ci sarà”, parte da questo elemento, il silenzio. Gaglianone racconta un’altra guerra, quella che ha dilaniato l’ex Jugoslavia negli anni ’90, in particolare la Bosnia, utilizzando il silenzio per far emergere le parole dei dieci protagonisti di questa narrazione che riguarda la sopravvivenza dopo una guerra, i cambiamenti emotivi, psicologici, sociali che sempre avvengono sia a livello individuale che collettivo dopo un sanguinoso conflitto armato. “Rata nece biti” è un documentario lungo (dura quasi tre ore) e la narrazione si svolge lenta, come il fluire delle acque della Drina, il fiume bosniaco che accompagna spesso i racconti dei dieci personaggi, sopravvissuti alla guerra proprio in quelle zone di frontiera segnate dal suo corso, fra Sarajevo e la Serbia.
Il silenzio e le parole, i volti sono i protagonisti del documentario, il silenzio dopo la fine della guerra che non è ancora pace anche perché a certe latitudini il passato non è ancora passato e il presente fatica a colorarsi di futuro. “Volevamo indagare il presente. Ma poi ci siamo accorti che il presente non esiste perché il passato sembra non riuscire a passare e quindi ci siamo ‘arresi’ e, come dice uno dei nostri personaggi, “qui non è finita la guerra, semplicemente non si spara più”, afferma Andrea Parena, autore del soggetto e della fotografia del film.
E’ questa quotidianità malata, malinconica, pervasa da un senso struggente e ineluttabile di perdita che Gaglianone indaga con grande sensibilità, seguendo i suoi personaggi, il filo non sempre coerente dei loro pensieri, i loro racconti frammentati e dolorosi, il senso di un esistere che già di per sé è già una forma di resistenza. La forza e l’attualità del bellissimo lavoro del regista torinese sta proprio in questa posizione di ascolto senza preconcetti, concedendo ai personaggi il tempo necessario per trovare il filo delle parole e dei pensieri e raccontarsi. Raccontarsi dentro una guerra. Il tempo prima della guerra, durante la guerra e dopo la guerra. “Ci vuole tempo: il tempo di incubazione che prepara queste guerre, poi c’è il tempo necessario a fare la guerra, ma poi c’è anche la lunghezza di questo dopoguerra infinito. (…) Questo documentario è un viaggio anche nel tempo. C’è l’immobilità del tempo interiore che, per il singolo individuo si è fermato in un certo giorno (…) ed è importante il tempo in cui io sono adesso: sono tutto immerso nel passato, quindi riesco ad essere nel presente? Posso immaginare il futuro? Ogni spostamento in questa cronologia è anche una parte della propria biografia” (Nicole Janigro).
“La questione del tempo è centrale. La sensazione che si ha quando si è lì è di una sospensione pazzesca: il passato non è ancora passato, il presente non è ancora partito. Loro vivono in un tempo interiore che è rimasto fermo al tempo della guerra (…) Questo fa parte della sospensione della storia, dove le storie personali non riescono a trovare un’eco nella storia pubblica” (Daniele Gaglianone).
“Rata nece biti. La guerra non ci sarà” si/ci immerge in questa sospensione temporale, in questo spazio incerto dove l’affermarsi degli opposti nazionalismi ha fatto terra bruciata delle precedenti identità individuali e collettive utilizzando parole di guerra, manipolando linguaggi fino a deformare non solo palazzi, città e villaggi con le bombe, ma anche il senso più profondo del vivere, del vissuto quotidiano. Una vita senza punti di riferimento, senza un luogo che puoi chiamare casa o patria, straniero ovunque.
“Karahasan appartiene a gente che si è sempre pensata Europa e scopre di non essere europea, che è stata pensata Oriente e non si è mai considerata Oriente, gente che è stata un po’ austriaca, un po’ turca, un po’ serba, un po’ balcanica. Non sono mai stati una cosa unica e un’identità monolitica: sono coinvolti in una guerra di sterminio basata sul principio di identità, e l’identità non ce l’hanno. Dovrebbero appartenere a qualcosa e non appartengono a niente” (Luca Rastello). E’ l’eterna storia dei Balcani, si dirà. E forse di tutta l’Europa dell’est, un mondo così vicino e così lontano, pieno di misteri per chi come noi occidentali si considera il centro del mondo e lontano dal pantano intriso di sangue e merda delle guerre che in quel mondo si consumano. “Per quelli della nostra generazione la guerra doveva essere altrove”, ancora Luca Rastello.
Il merito del documentario di Gaglianone è proprio quello di deragliare progressivamente da un presunto centro narrativo per decentrarsi fisicamente e mentalmente in compagnia dei suoi personaggi in uno struggente viaggio di conoscenza che si snoda parallelamente allo sviluppo delle relazioni umane. I paesaggi principali del documentario, non a caso, sono i volti delle persone che raccontano, le emozioni che si disegnano sui loro volti e dentro i loro occhi perchè è lì il segreto più profondo di esistenze segnate da una guerra. E del resto già il vecchio maestro John Ford affermava che “il paesaggio più interessante del mondo è la faccia di un essere umano”. Anche le immagini di repertorio sono quasi inesistenti e gli eventi della storia pubblica sono evocati soprattutto mediante alcuni brani tratti dai discorsi dei politici dell’epoca inseriti solo a livello sonoro. Poche le immagini di Sarajevo e di Srebrenica che il regista centellina in una sorta di pudore che lo tiene a debita distanza da qualsiasi morbosità giornalistica da ‘turismo di guerra’. Per raccontare l’orrore di vite spezzate bastano le parole dei sopravvissuti, il racconto della loro quotidianità che non sarà mai più quella innocente e banale di prima della guerra, perché, come dice uno dei personaggi del documentario, “la guerra è una cosa che accade mentre stai guardando i Simpson”. E dopo non riuscirai più a vedere quel cartone animato con gli occhi di prima.
Così “Rata nece biti. La guerra non ci sarà” progressivamente azzera la distanza fra chi osserva e chi è osservato e la sensazione che lo spettatore ha alla fine del film è quella di aver partecipato personalmente e profondamente ad una delle esperienze umane più forti che si possano immaginare, quella dei sopravvissuti ad una guerra, che hanno perso tutto, casa, lavoro, amicizie, affetti, progetti per il futuro e vivono in un presente che è quasi una condanna. Nulla sarà mai come prima. E anche la comoda posizione equidistante dello spettatore lontano dalla guerra non è una soluzione possibile.
“E’ più comodo avere equidistanza, pensare che sono tutti uguali. Quindi è più comodo mettere in campo la pietà generica per la vittima generica. Me la spiego anche come una specie di pigrizia morale che trova più comodo acquietarsi dentro questo sentimento, l’orrore per la guerra, la pietà per le vittime della guerra, entrambi sentimenti generici, piuttosto che affrontare i problemi nuovi che quella guerra mette di fronte a noi” (Gianfranco Bettin).
Perchè in fondo, come dice uno dei personaggi che Primo Levi incontra nel suo viaggio nell’inferno dei lager nazisti raccontato nel suo romanzo “La tregua”, “guerra è sempre”.
“Rata nece biti. La guerra non ci sarà”
Regia: Daniele Gaglianone
Con: Zoran Herceg, Haira Catic, Mohamed Bektic, Haira Selimovic, Aziz, Sasha, Jasmina Mameledzma, il personale dell’ICMP
Fotografia: Andrea Parena, Daniele Gaglianone
Montaggio: Enrico Giovannone
Suono: Vito Martinelli
Fonico: Angelo Galeano, Davide Favargiotti
Organizzazione: Michele Biava
Riprese: Daniele Gaglianone, Francesca Frigo, Pierpaolo Abbà, Andrea Parena
Produzione: BabyDoc Film, Gianluca Arcopinto, Daniele Mittica
Distribuzione: Derive Approdi
Nota: le citazioni inserite nell’articolo sono tratte dal libro “Rata necé biti. La guerra non ci sarà” di Aa. Vv., Derive Approdi, 2011.
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
Giuliano Montaldo
UN GRANDE AMORE
La nave di Teseo editore, Milano – 2021
Pagg. 188, Euro 18
“Un grande amore” è il titolo del libro di Giuliano Montaldo. Il grande amore è quello per la moglie Vera , sua collaboratrice come aiuto regista e presenza indispensabile e costante nel suo cinema sin da quando la vide nello studio del fratello Leo Pescarolo, produttore cinematografico: segnalo, per inciso che entrambi sono figli della grande attrice di teatro e del cinema muto Vera Vergani. Questo incontro lo racconta nel suo libro, lo stesso Giuliano Montaldo. Attraversava un momento di sconforto perché il suo film d’esordio nel cinema “Tiro al piccione” presentato nel 1961 alla Mostra di Venezia fu accolto “ con applausi calorosi e convinti, ma il giorno dopo venne massacrato dalla critica”. Furono ferite , malgrado la solidarietà di tanti amici, che lo colpirono in profondità al punto di pensare di lasciare il lavoro di regista ma anche il mondo del cinema nel quale aveva dato ottima prova di attore, prima in “Achtung! Banditi”(1951) di Carlo Lizzani, e poi recitando anche per Luciano Emmer e Valerio Zurlini. A quel punto gli arriva una telefonata di Leo Pescarolo che lo invita n andare a trovarlo nel suo Ufficio per discutere una proposta di lavoro. Scrive Giuliano Montaldo: “ Sono davanti alla porta dello studio di Pescarolo. Dalla stanza accanto si sente una voce maschile: Avanti si accomodi. Ma l’immagine che ho davanti agli occhi mi impietrisce. Una creatura splendida, il portamento elegante , lo sguardo intenso. Una giovane donna che sorride. Sorride a me. Avanzo incerto, senza riuscire a staccare gli occhi da quella meraviglia. Il produttore si accorge che continuo a guardare quella deliziosa visione. Si sieda e guardi me mi ordina mentre lancia uno sguardo severo a lei, che si sta avvicinando lentamente alla scrivania. Poi, finalmente, cambia tono: Vorrei offrirle un lavoro per la Rai e un gruppo americano. Dimenticare quel giorno che mi avrebbe cambiato la vita, conclude questo episodio Giuliano Montaldo, è impossibile. Una proposta di lavoro e un colpo al cuore. Da allora Giuliano Montaldo iniziò a collaborare con Leo Pescarolo ed ogni occasione per lui era buona per andarlo a trovare in Ufficio. Lui aveva capito però che lo faceva soprattutto per andare a vedere sua sorella, ed un giorno gli disse che lei era a Sorrento per lavoro, e poi sarebbe andata a Procida dove aveva una casa. A sorpresa un giorno Giuliano Montaldo andò a trovarla e conobbe anche la mitica Vera Vergani. Fu invitato a pranzo e all’improvviso, mentre lei gli serviva il dolce, le disse :” Io ti amo”. Una frase, scrive nel suo libro, che ebbe un effetto dirompente e tutti si girarono a guardarlo. Successivamente si sposarono e da allora trascorrono insieme una vita fatta di amore e cinema che li ha portati a realizzare film in tutto il mondo. Una bellissima favola.
A cura di Giuseppe Mallozzi
PIER PAOLO PASOLINI
Ali Ribelli Edizioni, Gaeta – 2022
Pagg. 213, Euro 15
Un volume della Collana Visioni di Cinema dei Quaderni di Visioni Corte Film Festival che vuole essere, per l’autore, “un omaggio a questo grande regista , cantore di un personalissimo ‘cinema di poesia’, il cui messaggio è ancora oggi attuale”. Un libro che confuta l’idea sostenuta “ erroneamente” dalla critica che il passaggio al cinema da parte di Pasolini costituisca un proseguimento della sua attività letteraria descrivendo nei film “Accattone”, “Mamma Roma” e in parte anche “La Ricotta” quel sottoproletariato tanto caro al poeta. L’autore del libro, sostiene invece che non sia “propriamente così” rilevando che Pasolini si avvicina al cinema dapprima come spettatore fin da giovanissimo, avendone sempre una certa passione, ed in seguito quando nel 1949 approda nella Capitale e farà esperienza di comparsa a Cinecittà e di recensore per riviste, per poi passare a scrivere soggetti e sceneggiature. Un lavoro, febbrile, scrive ancora l’autore, che lo porta a collaborare, tra gli altri, con Mario Soldati, Mauro Bolognini, Franco Rossi ed anche con Fellini per il quale si occupa della revisione del parlato romanesco di “Le notti di Cabiria” e scrive poi una scena , non utilizzata, per “La Dolce vita”. Uno sforzo creativo incredibile che va di pari passo con le sue opere letterarie. Dando la parola allo stesso Pasolini, Giuseppe Mallozzi, sottolinea che la “vocazione” cinematografica di Pasolini ha radici lontane e risale a prima della Guerra quando pensava che sarebbe andato a Roma a fare il Centro Sperimentale di Cinematografia: idea arenata fino a quando ha avuto l’occasione di esordire nel cinema. Pasolini invita anche a rendersi conto che nella sua letteratura esiste una forte dose di elementi cinematografici. E se si è deciso a fare dei film è perché voleva farli esattamente a come scrive poesie o romanzi. E che il passaggio della letteratura al cinema non è un semplice capriccio ma la ricerca di un altro linguaggio con il quale proseguire la sua creatività . Concetti , riproposti dall’autore del libro, che poi vengono sottolineati nei Saggi che lo compongono. Roberta Verde si occupa del cinema di poesia Francesco Saverio Marzaduri dei film della borgata romana, Mallozzi stesso di “Il Vangelo secondo Matteo”, Gordiano Lupi, in cinque capitoli del libro, della ricerca di Pasolini di un nuovo linguaggio, del “Poema del Terzo Mondo”, dei film contro la borghesia,
della Trilogia della vita e di “Salò o le 120 giornate di Sodoma”. Vi sono anche Gianmarco Cilento che si occupa di “Totò e Pasolini” e Davide Persico di “Mitografie della modernità: Pasolini e la sacralizzazione del classico tra cinema e teatro”. Il libro è completato dalla Filmografia e da alcune note biografiche degli Autori dei Saggi.
Fabio Pavesi
IL CONFLITTO IN CELLULOIDE
Il nuovo Melangolo, Genova 2022
Pagg.392, Euro 32
Un volume in cui l’autore, a cui si deve già “Propaganda a Hollywood: la minaccia nazista, la censura e lo studio system”(editrice Le Mani, 2013), prende ora in esame i film americani di propaganda degli anni della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda “dando risalto al legame inscindibile fra storia e cinema”, proponendo documenti inediti che mettono in evidenza la straordinaria efficacia delle pellicole di Hollywood come forma comunicativa. Ma racconta anche la settima arte con un taglia prettamente storico arricchito da curiosi aneddoti sullo studio system. E lo fa utilizzando nella sua interessante ricerca i rapporti epistolari tra le majors, l’Ufficio di censura e il Pentagono. Fonti assolutamente importanti e inediti. Luca Martera nella sua prefazione sottolinea come Hollywood, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, onde sconfiggere il razzismo e le dittature, va alla guerra veicolando quotidianamente sul grande schermo nuove parole e immagini basate sul modello capitalista della democrazia a stelle e strisce. Un lato oscuro della fabbrica dei sogni, che secondo Martera, Fabio Pavesi espone molto bene. L’intento di Hollywood, evidenzia, era quello di recapitare il messaggio della libertà e lo faceva attraverso personaggi, battute, gesti e situazioni “inconcepibili” nella vecchia Europa: una donna in pantaloni che zittisce gli uomini, un piccolo impiegato che manda a quel paese i suoi superiori, uno studente che fuma e poggia i piedi sul tavolo. Una comunicazione evidenziata nel che si scontrerà poi con la brutale realtà della Guerra, ma che Hollywood continua a perseguire attraverso gli agenti dell’OWI e del PWB incaricati di selezionare i film yanchee che con le navi vengono trasportati a centinaia con le navi nei territori occupati o liberati. Una cura del pacifismo attraverso il cinema, afferma Martera, che il saggio di Fabio Pavesi evidenzia analizzando alcuni film . E di ciò non sono esenti anche alcuni film del Neorealismo . Fino a che soldati e sergenti americani non appaiono , esplicitamente cattivi in alcune commedie italiane e l’imperialismo americano non viene messo sotto accusa con altri realizzati negli anni Settanta. Il mito degli “americani brava gente” ritorna negli anni ’90. Sono segnalazioni , quelli di Martera, molto stimolanti per approfondire meglio le varie situazioni attraverso la lettura del libro di Fabio Pavesi che fornisce centinaia di curiosità e fatti poco conosciuti sul lato oscuro di Hollywood, arrivando fino alla guerra del Vietnam raccontata da “ I Berretti verdi” di John Wayne. Una cavalcata attraverso tanti film, ma anche attraverso la storia delle major americane e la memoria visiva di alcune locandine, immagini e riproduzione di documenti molto significativi.
Marco Bellano – Marco Fedalto
L’OCCHIO CHE ASCOLTA
Diastema editrice 2021
Pagg. 566, Euro 38
Un volume che ha come sottotitolo“ Itinerari di storia e analisi tra musica e immagini in movimento” che ci porta ad approfondire il binomio cinema – musica e che parte dall’ipotesi di immaginarsi un film senza la musica. Perderebbe per il regista Massimo Privitera, che dirige anche la Rivista “Colonne sonore.net”, l’80 o perfino il 90 % di quella valenza emotiva e inventiva che permette a una pellicola di entrare prepotentemente nell’immaginario collettivo. Ciò perché moltissimi film, sia di qualità che poco validi, sono rimasti nel cuore degli spettatori e dei cinefili proprio grazie alla colonna sonora che li accompagnava. Il lavoro analitico di Marco Bellano (docente universitario e studioso di animazione e musica per film) e Marco Fedalto( compositore e pianista” ci immergono nella storia del cinema in cui il rapporto cinema -musica ha avuto un ruolo importante attraverso il cinema muto e quello sonoro con uno sguardo attento ai film cult arrivando ad un’opera come “L’estate di Kikujiro” del 1999 diretto da Takeshi Kitano che si avvale della colonna sonora di Joe Hisaishi. Una musica che i due autori del libro analizzano attraverso le partiture, così come fanno con tanti altri film. Un lavoro per specialisti, si direbbe. Ma credo anche per chi quei film li ha visti che dall’analisti di Ballano e Fedalto possono entrare meglio nello spirito che li guida. Il libro è edito con la collaborazione di Cinit-Cineforum Italiano
CREDITS
Carte di Cinema 27
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E. Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 27 della rivista online, Roberto Baldassarre, Paola Brunetta, Marcello Cella, Maria Pia Cinelli, Mario Galeotti, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Roberto Merlino, Paolo Micalizzi, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Marco Incerti Zambelli.