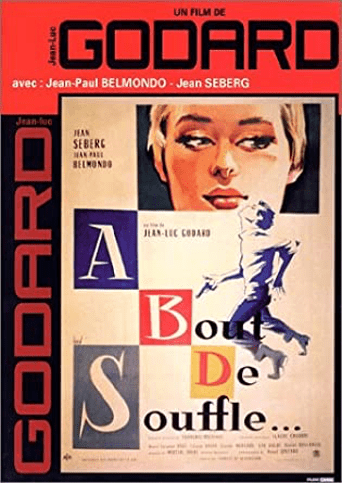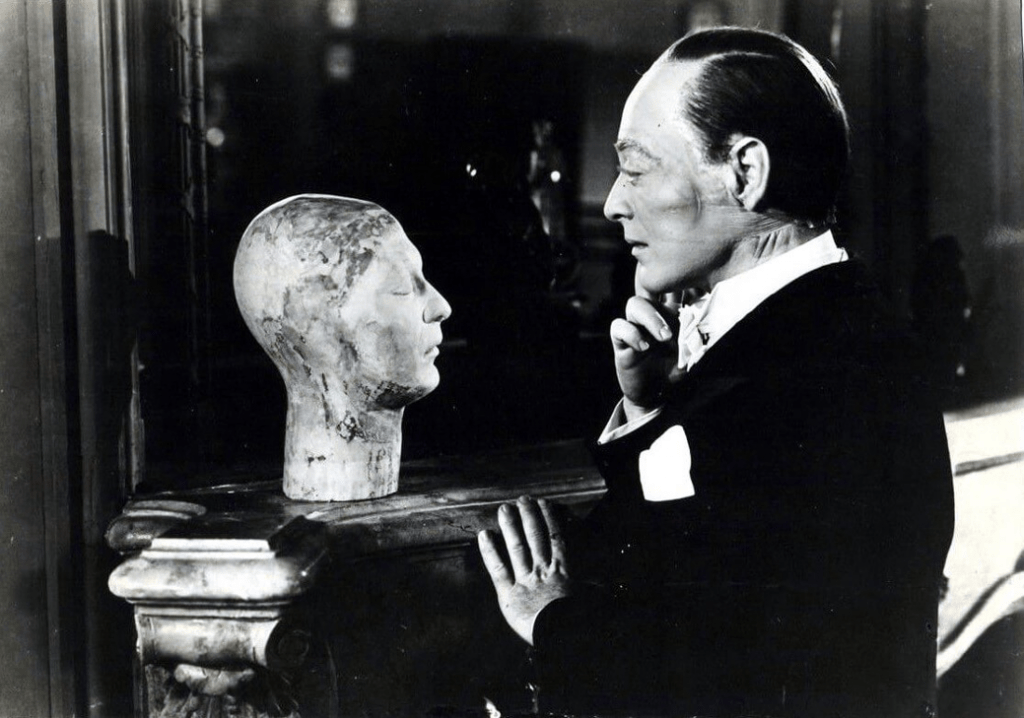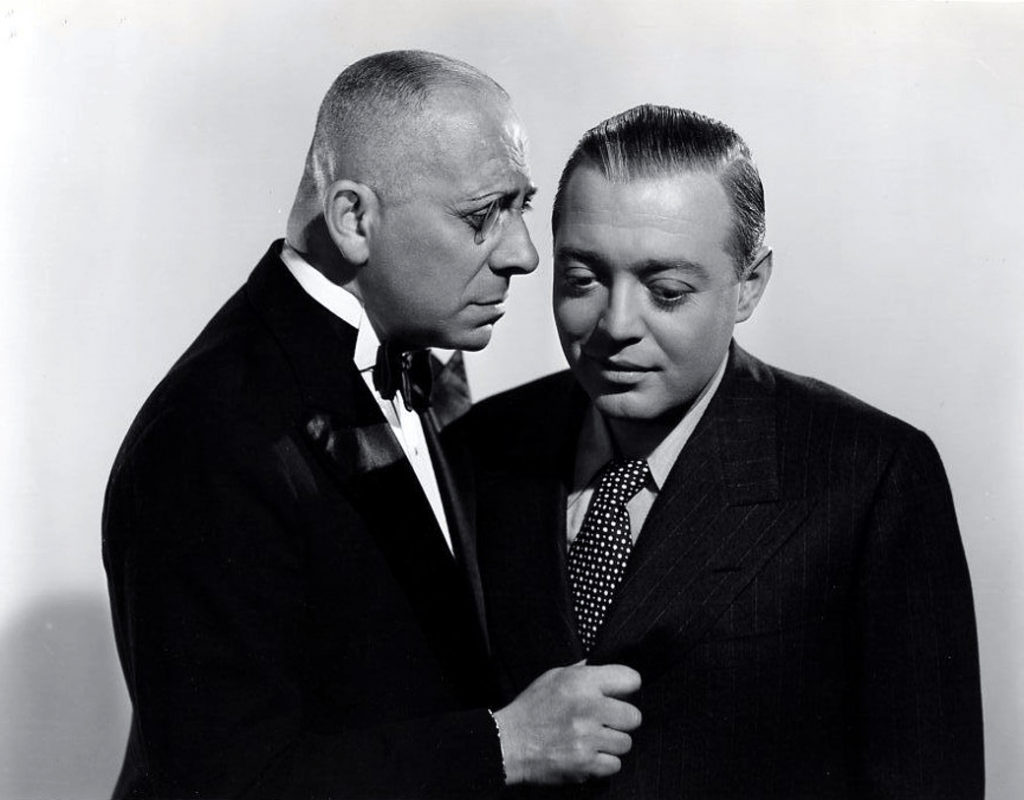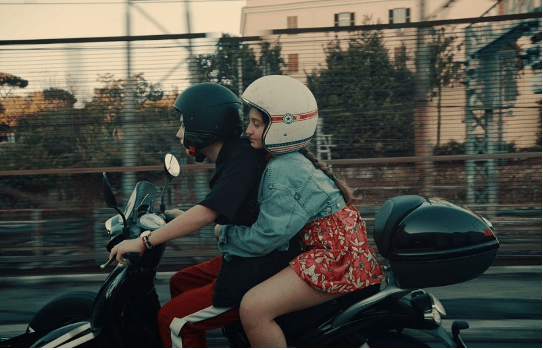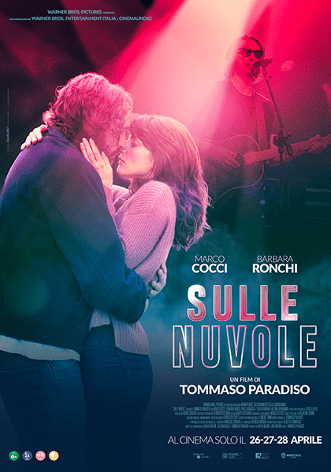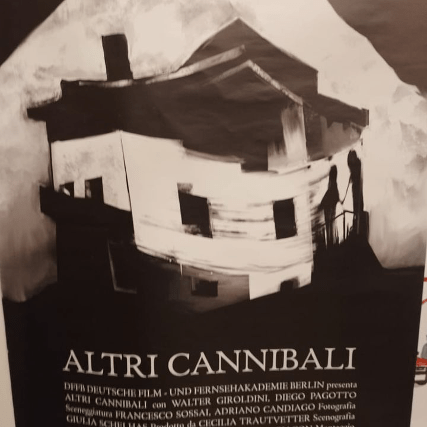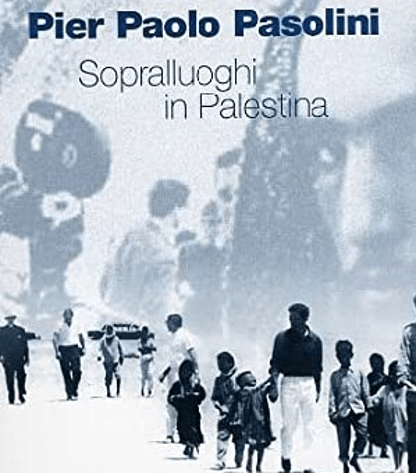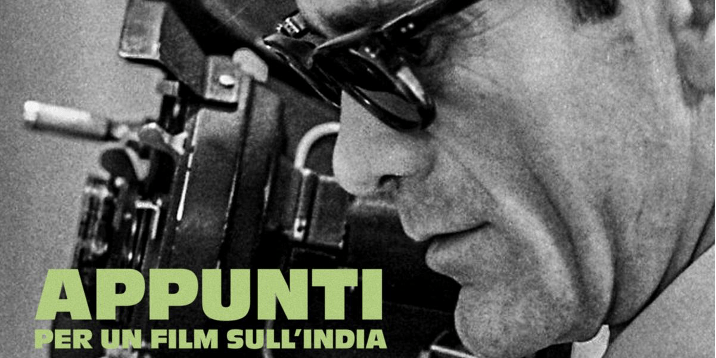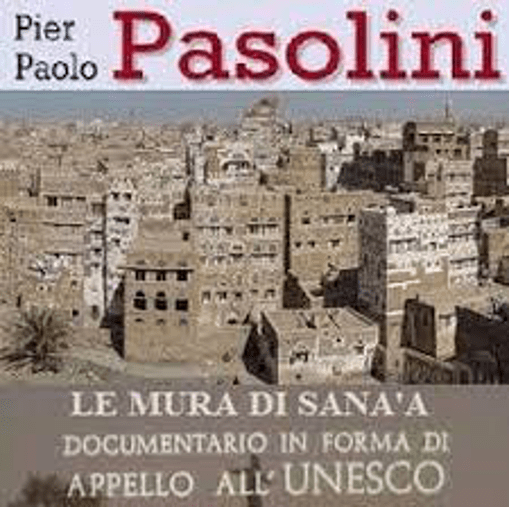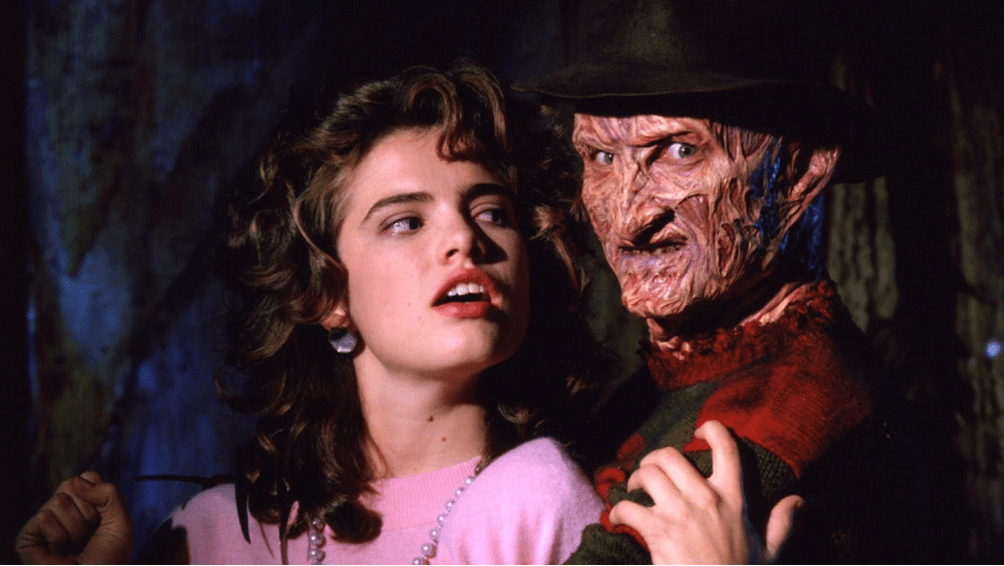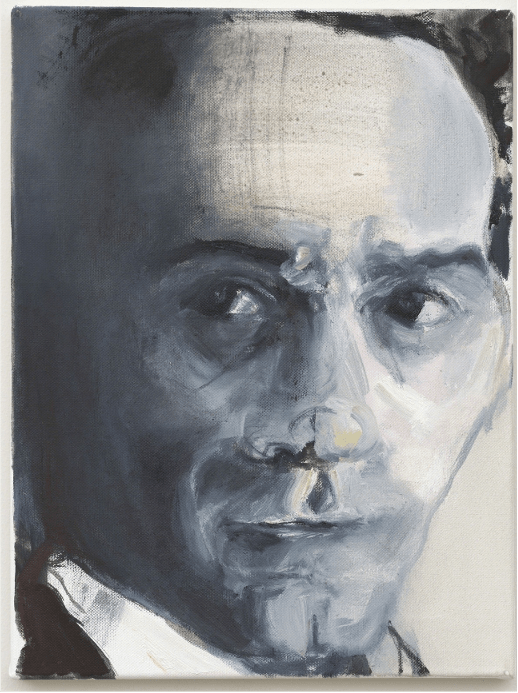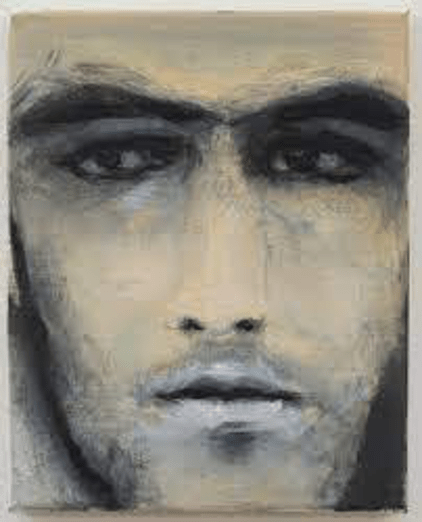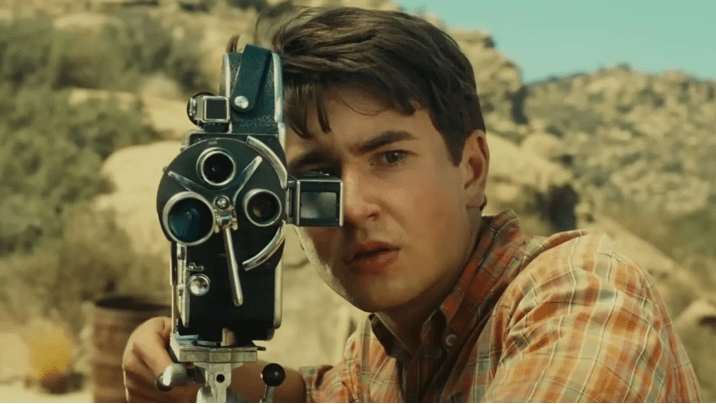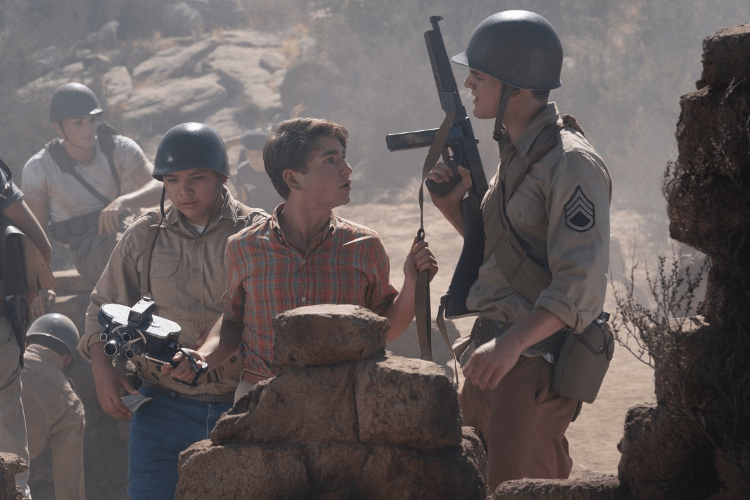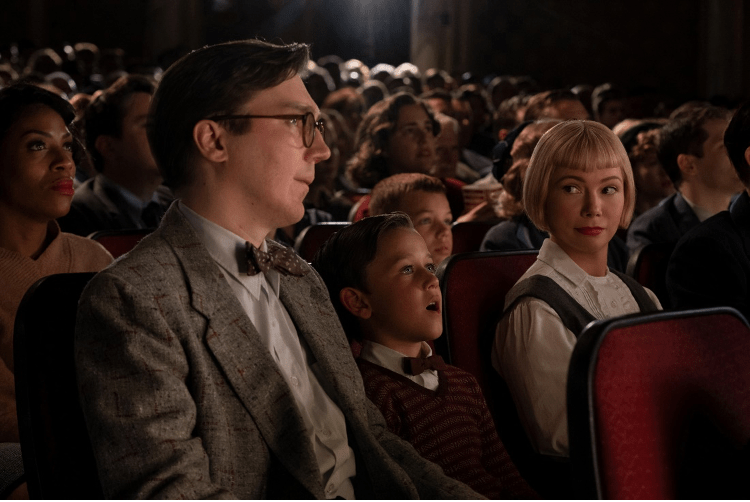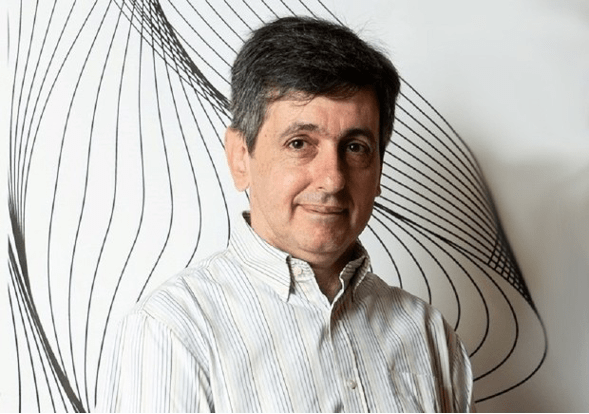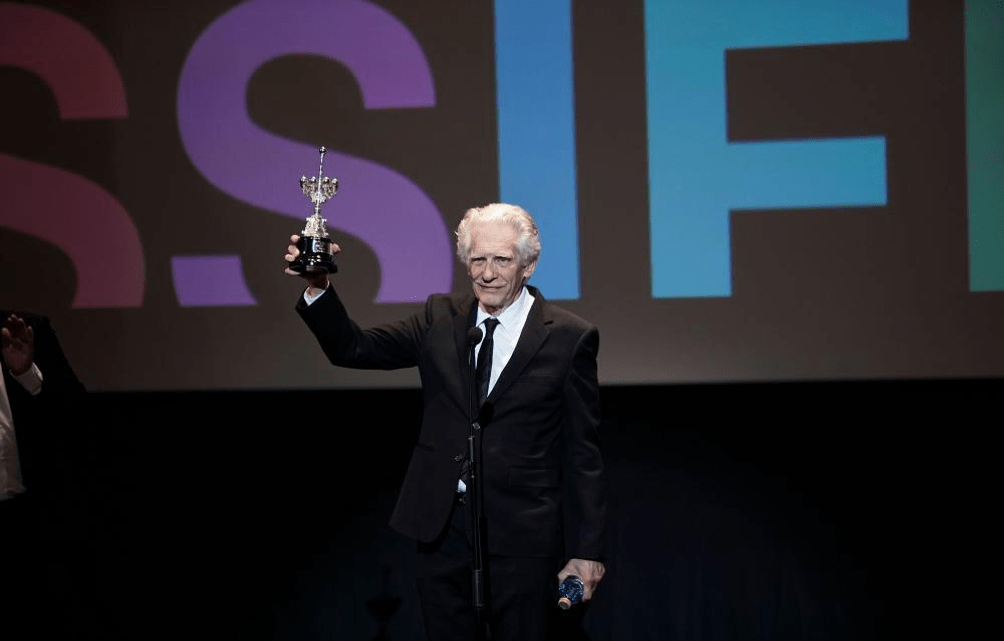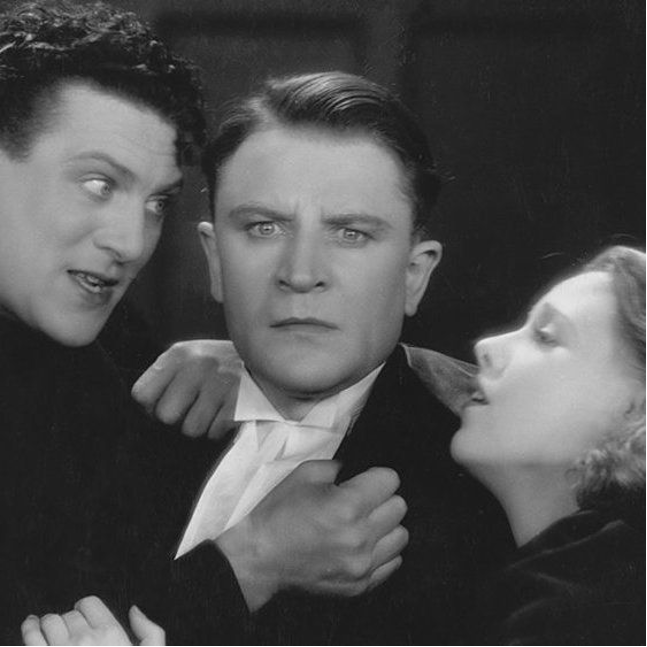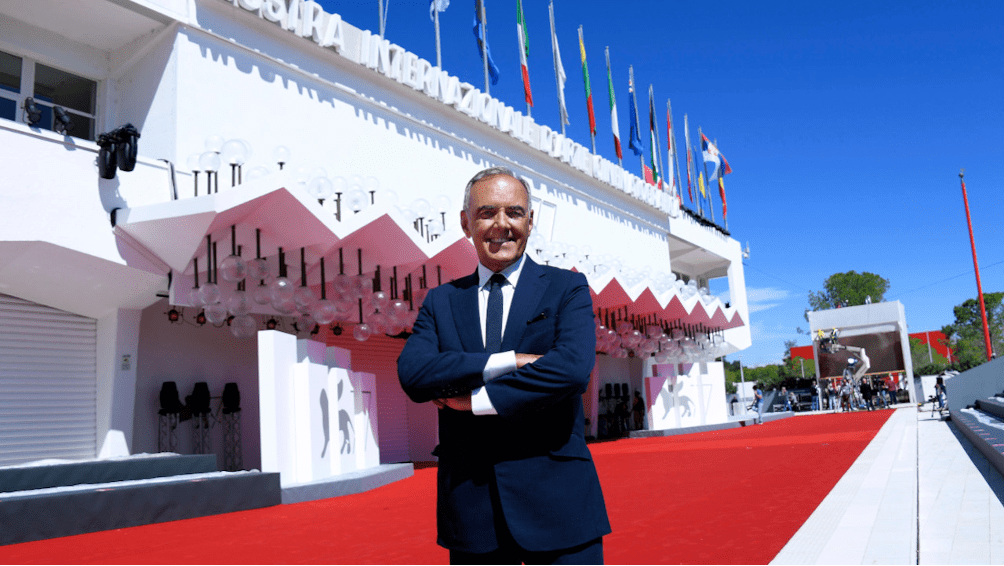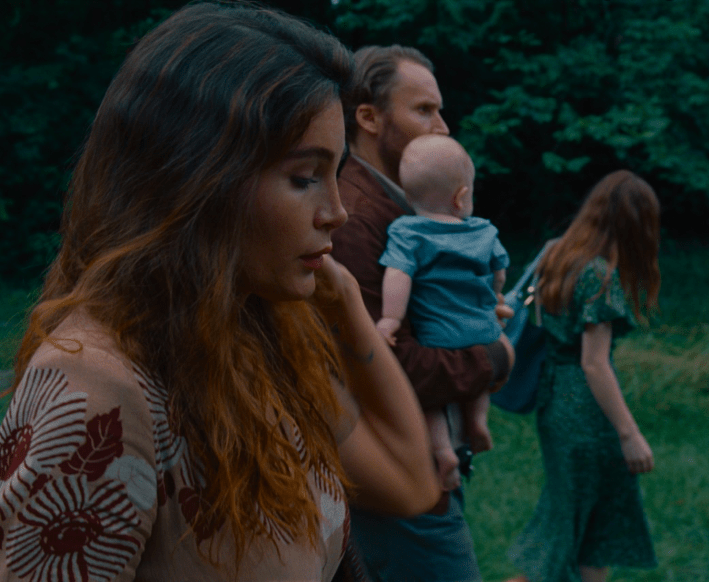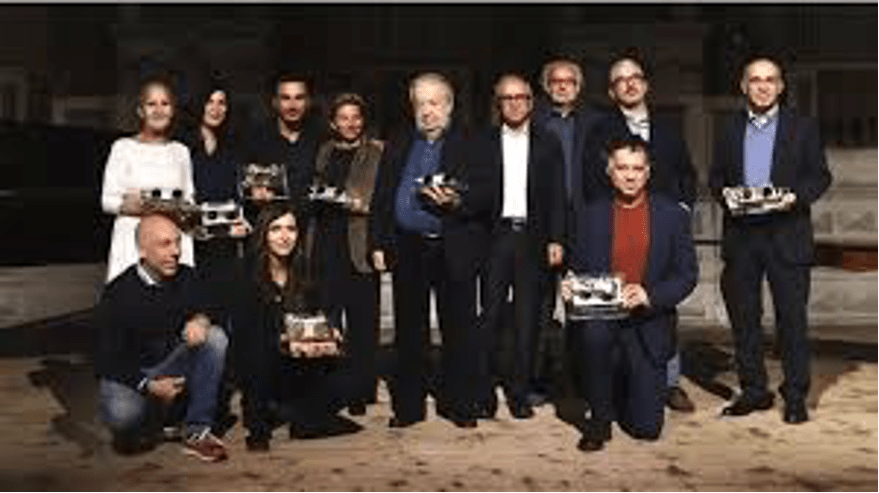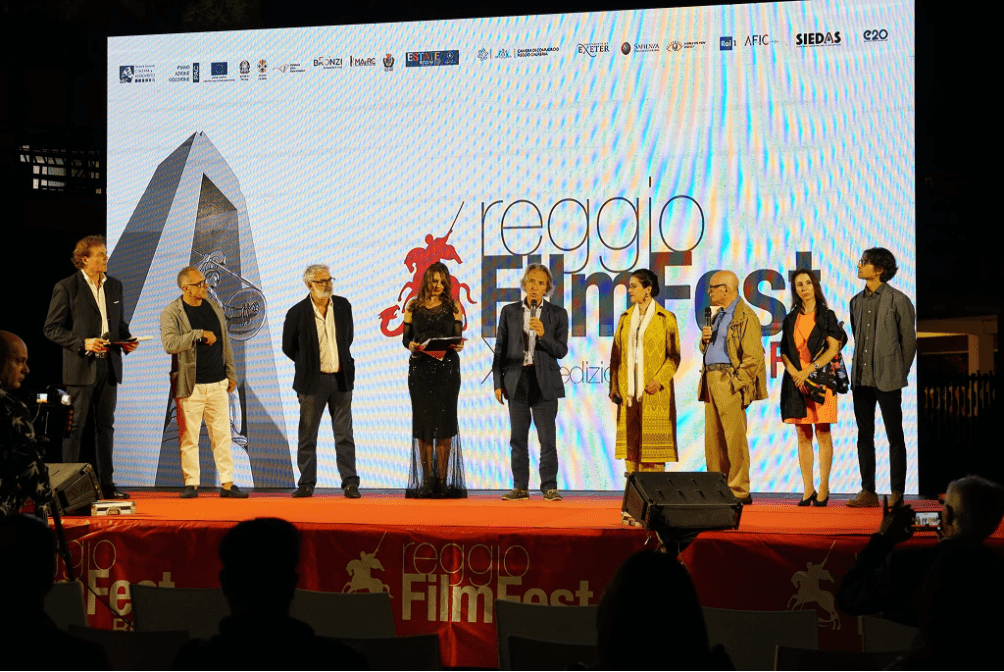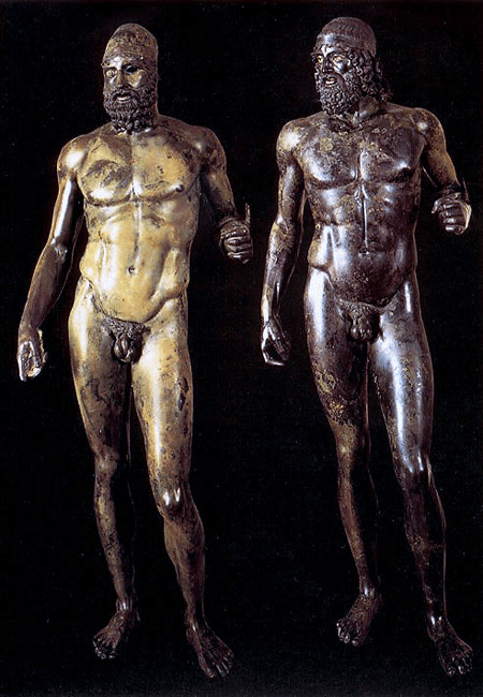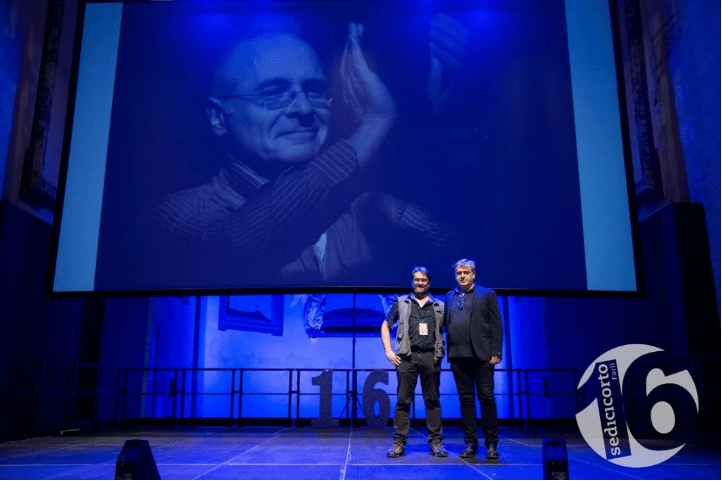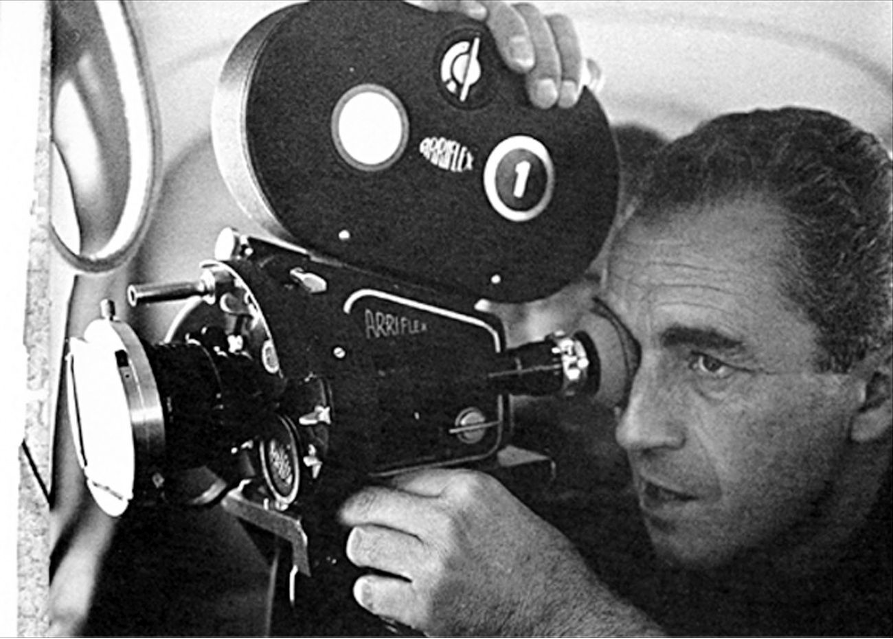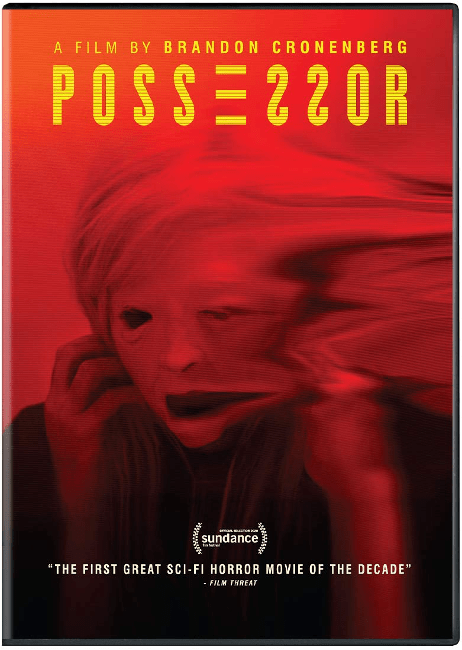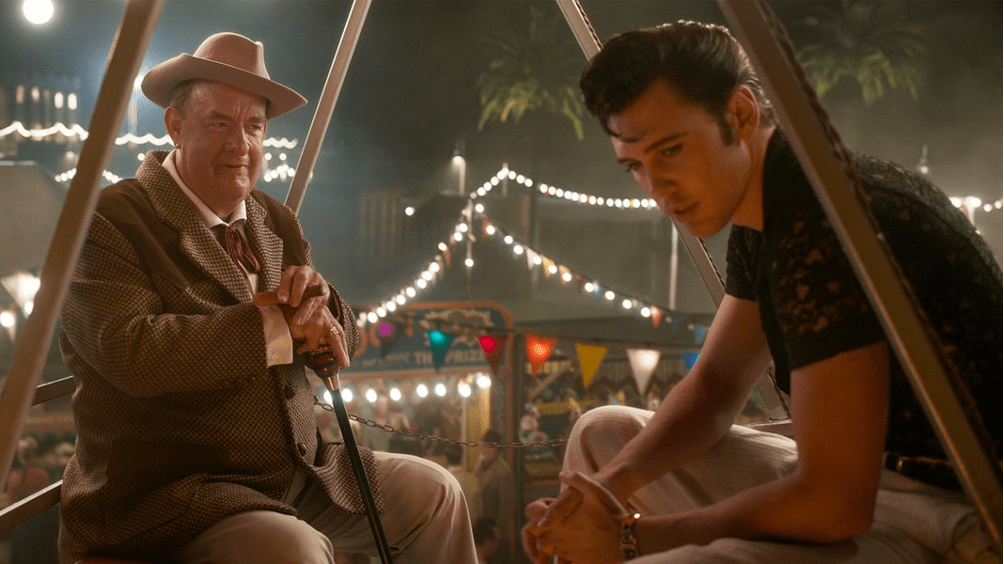Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 3.1 LORRE(ALISMO), LO SGUARDO DIETRO LA MASCHERA di Francesco Saverio Marzaduri
- 3.2 SETTE FILM, ANZI OTTO, PER UN NUOVO INIZIO di Paola Brunetta
- 3.3 DALLA REALTÀ AL PENSIERO: PASOLINI DOCUMENTARISTA di Danilo Amione
- 3.4 NIGHTMARE – IL RITORNO DELLA NOTTE di Roberto Lasagna
- 3.5 MARLENE DUMAS, PIER PAOLO PASOLINI: INCROCI di Maurizio Villani
- 3.6 “THE FABELMANS”: OVVERO COME STEVEN DIVENNE SPIELBERG, E PERCHE’ E’ IMPOSSIBILE NON AMARE IL CINEMAdi Roberto Baldassarre
- 4 INTERVISTA
- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 6 FESTIVAL ED EVENTI
- 6.1 “LOS REYES DEL MUNDO” DELLA REGISTA COLOMBIANA LAURA MORA VINCE LA 70° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
- 6.2 PORDENONE 41 Le Giornate del Cinema Muto di Paolo Vecchi
- 6.3 ALCUNI FESTIVAL NEL RESOCONTO DI PAOLO MICALIZZI
- 6.3.1 79. VENEZIA: UNA BELLA E QUALIFICATA EDIZIONE di Paolo Micalizzi
- 6.3.2 “INCONTRI” DI SUCCESSO QUELLI DELLA FICE A MANTOVA di Paolo MIcalizzi
- 6.3.3 REGGIO CALABRIA FILMFEST, NELLA CORNICE DELLE CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DEI BRONZI DI RIACE di Paolo Micalizzi
- 6.3.4 UN RICCO E VARIEGATO PROGRAMMA AL DICIANNOVESIMO SEDICICORTO FORLÌ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL di Paolo Micalizzi
- 6.3.5 PRESTIGIOSI OSPITI E RICCO PROGRAMMA AL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE di Paolo Micalizzi
- 7 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO
- 8 OCCHIO CRITICO
- 8.1 “LICORICE PIZZA”: QUANT’È BELLA GIOVINEZZA… di Francesco Saverio Marzaduri
- 8.2 IL SIGNORE DELLE FORMICHE DI GIANNI AMELIO di Tullio Masoni
- 8.3 CRONENBERG PADRE E FIGLIO “CRIMES OF THE FUTURE”, DI DAVID CRONENBERG; “POSSESSOR”, DI BRANDON CRONENBERG. di Paolo Vecchi
- 8.4 L’IMBONITORE E L’INTRATTENITORE: ELVIS, UNA STORIA AMERICANA di Marco Incerti Zambelli
- 9 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 10 PANORAMA LIBRI
- 11 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
BOB RAFELSON, INVERSIONE DI MARCIA di Francesco Saverio Marzaduri
La filmografia di Bob Rafelson, scomparso lo scorso luglio, si potrebbe interpretare come un’ininterrotta deviazione tradotta in una soluzione di continuità verso un cinema più commerciale, in apparenza privo di “politique” ma non d’omogenea direzionalità, nella misura in cui l’ultimo viaggio è l’unica fuga possibile.
È MORTO JEAN LUC GODARD di Marco Rosati
Adieu au Godard. Il Re è morto, evviva il Re.
SAGGI
LORRE(ALISMO), LO SGUARDO DIETRO LA MASCHERA di Francesco Saverio Marzaduri
La retrospettiva che “Il Cinema Ritrovato” di Bologna dedica a Peter Lorre è il tentativo, storicamente delicato, di spiegare come l’eclettica gamma di personaggi interpretati – tra dolenti introspezioni e tormentate sensibilità, prestazioni sottostimate e progetti non corrisposti – non corrisponda all’ingiusta etichetta affibbiata da “studios” e critici all’attore ungherese d’origine ebraica.
SETTE FILM, ANZI OTTO, PER UN NUOVO INIZIO di Paola Brunetta
In questo saggio di parla di cinema italiano e si parla di esordi nel lungometraggio da parte di registi che sono, magari, passati per i corti e per il cinema documentario. Con temi forti e importanti (“Il legionario” di Hleb Papou e “Una femmina” di Francesco Costabile), con temi particolari come in “Piccolo corpo” di Laura Samani, con la voglia di sperimentare come in “Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis o con una classicità di fondo come in “Settembre” di Giulia Steigerwalt e in “Sulle nuvole” di Tommaso Paradiso, o con una leggerezza, ancora in “Settembre” ma soprattutto in “Marcel!” di Jasmine Trinca, che fa sperare in un rinnovamento del nostro cinema “giovane”, che si accompagna a quello, importante, del documentario (tre titoli per tutti sempre in relazione all’anno in corso, “Io resto” di Michele Aiello, “La città delle sirene” di Giovanni Pellegrini e “Brotherhood” di Francesco Montagner, al confine tra finzione e documentario). A cui si aggiunge, nonostante, contrariamente agli altri, non sia ancora uscito in sala, l’interessante “Altri cannibali” di Francesco Sossai. Un cinema italiano fresco e “leggero”, nuovo, fatto da registi a tutti gli effetti ma anche da cantanti o da attori che si cimentano nella regia.
DALLA REALTA’ AL PENSIERO: PASOLINI DOCUMENTARISTA di Danilo Amione
Finora poco studiato, il percorso documentaristico del grande artista friulano ci regala momenti di grande cinema, innovativo e profondo tanto quanto quello di finzione, per il quale egli è universalmente noto. Dal primo lavoro del 1963, uno dei due episodi de “La rabbia”, al 1974, anno dell’uscita dell’ultimo, “Le mura di Sana’a”, Pasolini analizza con gli strumenti, solo in apparenza lontani, della poesia e dell’inchiesta tutti i temi a lui cari, dalla scomparsa del mondo arcaico all’analisi impietosa del mondo borghese e occidentale.
NIGHTMARE – IL RITORNO DELLA NOTTE di Roberto Lasagna
Nightmare – Dal profondo della notte è uno dei titoli più significativi dell’estetica horror anni Ottanta, disposta a permeare i gusti privilegiati degli spettatori con un tipo di cinema che Craven confeziona per post-adolescenti còlti in una fase di passaggio dell’esistenza; soprattutto per loro, angosce, paure e pulsioni assumono un aspetto inquietante, e si manifestano proprio quando il controllo cosciente viene meno.
MARLENE DUMAS, PIER PAOLO PASOLINI: INCROCI di Maurizio Villani
L’articolo prende spunto da una mostra di Marlene Dumas a Palazzo Grassi a Venezia e presenta l’incontro tra la pittura della artista sudafricana e il cinema di Pier Paolo Pasolini. Una serie di dipinti che rappresentano il regista e i protagonisti di suoi film e che attestano una sensibilità comune dei due artisti.
“THE FABELMANS”: OVVERO COME STEVEN DIVENNE SPIELBERG, E PERCHÉ È IMPOSSIBILE NON AMARE IL CINEMA di Roberto Baldassarre
Con “The Fabelmans” Steven Spielberg non soltanto narra, con toni cinematografici, la sua infanzia e la sua adolescenza familiare, ma trasmettere, attraverso il suo rudimentale percorso registico, perché il cinema è epicamente immaginifico.
INTERVISTA
INTERVISTA A PAOLO MINUTO, FIGURA DI SPICCO DELL’ASSOCIAZIONISMO CINEMATOGRAFICO di Elisabetta Randaccio
Intervista a una figura rilevante dell’Associazionismo cinematografici oggi responsabile della distribuzione cinematografica indipendente con il “Cineclub Internazionale”.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
79. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA LA BIENNALE DI VENEZIA: APPUNTI E IMPRESSIONI DI UN SOCIO FEDIC di Luciano Volpi
Resoconto quotidiano della Mostra di Venezia attraverso appunti a testimonianza del coinvolgimento sulla Rivista di soci della Federazione Italiana dei Cineclub.
UN’ESPERIENZA COINVOLGENTE di Roberto Merlino
Il riferimento è allo Stage nazionale FEDIC, organizzato da Corte Tripoli Cinematografica a Calci (Pisa), che nel 2022 ha riguardato “Progettiamo insieme film corti” con lezioni del regista Alessandro Grande sulla sceneggiatura.
FESTIVAL ED EVENTI
“LOS REYES DEL MUNDO” DELLA REGISTA COLOMBIANA LAURA MORA VINCE LA 70° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
Un’edizione che ha premiato il film colombiano “Los Reyes del Mundo”, la storia di cinque ragazzi (attori non professionisti), che scappano in cerca di fortuna. Degni di nota sono anche i vari film d’esordio premiati, oltre ai giovani attori protagonisti. I due Premi “Donostia” sono stati assegnati all’attrice Juliette Binoche e al regista David Cronenberg.
PORDENONE 41- LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO di Paolo Vecchi
La quarantunesima edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, aperta da un capolavoro, “The Unknown”, dell’impagabile coppia Tod Browning&Lon Chaney, chiusa da “The Manxman”, ultimo silent movie di Hitchcock, ha presentato come al solito un programma di straordinario interesse. Tra le numerose sezioni della rassegna particolare rilievo ha assunto l’omaggio a Norma Talmadge, diva a suo tempo amatissima dal pubblico, la cui recitazione essenziale, assai poco da muto, colpisce ancor oggi per la sua modernità.
CINQUE FESTIVAL NEL RESOCONTO DI PAOLO MICALIZZI:
79 VENEZIA: UNA BELLA E QUALIFICATA EDIZIONE di Paolo Micalizzi
“INCONTRI” DI SUCCESSO QUELLI DELLA FICE A MANTOVA di Paolo Micalizzi
REGGIO CALABRIA FILMFEST, NELLA CORNICE DELLE CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DEI BRONZI DI RIACE di Paolo Micalizzi
UN RICCO E VARIEGATO PROGRAMMA AL DICIANNOVESIMO SEDICICORTO FORLÌ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL di Paolo Micalizzi
PRESTIGIOSI OSPITI E RICCO PROGRAMMA AL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE di Paolo Micalizzi
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre
“N.U. – NETTEZZA URBANA”. di Roberto Baldassarre
“Nettezza urbana”, secondo cortometraggio di Michelangelo Antonioni, è la prima svolta sperimentale del regista verso un proprio e definito linguaggio espressivo. Un abbozzo che contiene già alcuni spunti che saranno sviluppati successivamente.
OCCHIO CRITICO
“LICORICE PIZZA”: QUANT’È BELLA GIOVINEZZA…di Francesco Saverio Marzaduri
Caramella (o meglio, chewing-gum) di oltre due ore, il nono lungometraggio di Paul Thomas Anderson è un perenne tira e molla irto di incontri-scontri, dispetti, ripicche, liti, riappacificazioni, puntellato di sorrisi, attriti, riabbracci, nel prolungato tentativo di ritardare la condizione adulta, quand’anche la brama di emularne la trasgressione rientra in una dimensione meramente ludica.
“IL SIGNORE DELLE FORMICHE” DI GIANNI AMELIO di Tullio Masoni
La storia dell’amore proibito fra il prof. Aldo Braibanti e un suo allievo. La persecuzione e il processo celebrato nel 1968 a seguito di una denuncia sporta dalla famiglia del giovane (maggiorenne) poi esorcisticamente rinchiuso in manicomio.
CRONENBERG PADRE E FIGLIO: “CRIMES OF THE FUTURE”, DI DAVID CRONENBERG; “POSSESSOR”, DI BRANDON CRONENBERG.di Paolo Vecchi
Film in qualche modo testamentario, “Crimes of the Future” ripropone i temi cari a Cronenberg come l’osmosi uomo-macchina o la chirurgia come sesso del futuro. Ma l’accumulo non ha come contraltare un significativo alleggerimento sul piano narrativo, i dialoghi appaiano sentenziosi e assertivi, l’abituale sapienza della messa in scena non riesce a sottrarlo alle secche del déja vu.
Rispetto a quello di Cronenberg senior quello del figlio é un film più scopertamente di genere che, raccontando di una killer seriale che uccide entrando in corpi altrui, alterna momenti di tensione a passaggi a vuoto, confermando tuttavia una già solida professionalità.
L’IMBONITORE E L’INTRATTENITORE: ELVIS, UNA STORIA AMERICANA di Marco Incerti Zambelli
A dieci anni da “Il Grande Gatsby”, Baz Luhrmann torna sul grande schermo con una pirotecnica messa in scena della vita di Elvis Presley. Grande spazio anche al suo produttore, Colonnello Tom Parker, factotum ed anima nera del re del Rock and Roll. Grandi attori e grande musica.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
LA BELLEZZA SCACCIA LA VERGOGNA“LETIZIA BATTAGLIA. SHOOTING THE MAFIA” di Marcello Cella
Il film della documentarista inglese racconta con emozionante sobrietà la vita e l’opera della fotoreporter Letizia Battaglia, scomparsa il 13 aprile scorso.
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
Gian Piero Brunetta, LA MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA. 1932 – 2022.
Paolo Speranza, DANTE E IL CINEMA
A cura di Nicole Bianchi, DE SICA, IO E IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI. DIARIO INEDITO DEL PROTAGONI-STA
A cura di Marco Antonio Bazzocchi, Roberto Chiesi, Gian Luca Farinelli, PIER PAOLO PASOLINI“FOLGORAZIONI FIGURATIVE”
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
BOB RAFELSON, INVERSIONE DI MARCIA
di Francesco Saverio Marzaduri
Ripartiamo ancora una volta da “Easy Rider”, pellicola-simbolo, prodotta da quella Raybert nata a metà dei Sessanta dal sodalizio fra il trentaduenne Bob Rafelson, maestranza presso la compagnia Screen Gems, e il collega Bert Schneider, in seguito rinominata BBS: nel proprio mitico discorso sui Venusiani, sotto il completo effetto della marijuana, l’avvocato etilista Jack Nicholson menziona l’amico Rafelson raccontando ai compagni di viaggio gli avvistamenti, fatti in sua compagnia, di misteriosi oggetti volanti, sostenendo di averne contati ben quaranta. Tralasciando il bizzarro significato di ciò che forse è un semplice e prodigioso arcano, accentuato dall’istrionismo dell’interprete, si potrebbe leggere la filmografia di Rafelson come un’ininterrotta deviazione che, in pieno periodo di mutamento sociopolitico e fervore contro-culturale, si fa strumento orientativo teso a fendere l’apatia dell’istituzione borghese – l’“American Way of Life” cosiddetta – immettendo un nuovo “climax” libertario e ribellista. Sintomatico che il “cult” di Dennis Hopper, la futura firma di “Cinque pezzi facili” e la presenza del feticcio Nicholson, giungano quale “unicum” dentro e fuori la finzione: al pari degli “hippies” condannati a una brutta fine, e ancor prima dell’aleatoria presenza dei Venusiani, così pure la carriera di Rafelson procede lungo un dicotomico binario di apparizione-sparizione in cui l’inversione di marcia, nemmeno a farlo apposta, si eleva a filo conduttore.
Come riassumerne in chiave diversa l’avventurosa gavetta che lo vede, quattordicenne, abbandonare la famiglia e cimentarsi nei più disparati impieghi tra rodei, transatlantici e orchestre jazz, prima di iscriversi ai corsi di filosofia del Dartmouth College? E ancora: il sapore del picaresco non è forse già presente nella parentesi militare in Giappone, dove alternandosi all’attività di disc jockey muove i primi passi nel cinema per la società Shochiku? Il resto appartiene al florido bagaglio esperienziale (è produttore associato alla Universal, prima di passare alla Revue, alla televisiva Desilu e infine alla succitata Screen Gems), ma non si può non notare come il senso del mitologico, prima che del mitico, costituisca sufficiente DNA per corroborare un’esistenza cinematografica alla fonte, ove biforcazioni del Fato, aspettative, delusioni rientrano in un gioco ch’è insito nelle cose. In uno dei lavori più insolitamente ambiziosi di Rafelson, il roboante “Le montagne della luna”, tematiche e tropi si rilanciano come nelle pellicole anni Settanta, ancorché al servizio d’un disegno commerciale per un pubblico aperto a tutti i generi; eppure il valore dell’amicizia incappa in un rancido tradimento che, riveduto e aggiornato, porta avanti la natura mendace del Sogno Americano (sebbene l’azione si sposti tra l’Africa e la Gran Bretagna dell’Ottocento), e l’aura spavalda del rocambolesco cede il passo a mitomania e inganno, sino alla tragedia.
Nulla di più normale che sia il “noir”, il genere che meglio permette a Rafelson di restituire tali “topoi”, colpi di scena compresi, portandone le regole alle estreme conseguenze: sicché ne “La vedova nera”, tra gli esiti migliori, i profili dell’assassina Theresa Russell e della poliziotta Debra Winger costantemente si rovesciano e ripresentano quali intercambiabili riverberi di un’identica moneta, in un torbido gioco di sotterfugi e complicità, mentre i fotogrammi delle Hawaii, fondale dell’intreccio, non sono vagheggiati rispetto a “Il re dei giardini di Marvin” ma ostentati quale “milieu” al contempo infido e sinuoso. Lo “script” di Ronald Bass e la luce di Conrad Hall fanno la differenza nella misura di David Mamet e Sven Nykvist, un quinquennio prima, per la quarta trasposizione del celebre “Il postino suona sempre due volte”: nonostante l’accuratezza non lasci soddisfatti appieno, se si esclude l’ottima fattura (il copione, qui, sembra il più fedele all’inchiostro di Cain), l’adattamento di Rafelson conduce allo stremo, lungo il versante d’un abrasivo pessimismo, i luoghi canonici del cineasta. La California impoverita, disperata e violenta al punto da indurre i personaggi alla più aberrante delle azioni, individua nelle anime dannate dell’intrigo, il sodale Nicholson e Jessica Lange, gli autentici punti di forza, evitando i cliché del “loser” e della “dark lady” a favore della tonalità realista e d’uno stile asciutto. Il prodotto – riporta Giovanni Grazzini – “ha momenti riusciti quando rappresenta il tira e molla della passione, della paura, del rancore, e conferisce un’aureola enigmatica ai protagonisti”, che la debita provvidenza castiga quand’anche il prospetto di un’unione domestica aggiusterebbe tutto; la perenne deviazione del Caso, sin dall’inizio, è dietro l’angolo.
Sulla stessa falsariga, non sorprende che la “mise–en–scène” dell’incompiuto romanzo di Chandler, “Poodle Springs”, coroni un capitolo crepuscolare presentando un Marlowe prostrato e, consapevole dell’età avanzata, accasato. È la sorte, però, a disporre dell’esistenza altrui: non è forse possibile che l’antieroe “hard boiled” per antonomasia divida a mezzo lavoro e talamo, e la decisione della moglie di seguirlo – memore degli enumerabili altarini in famiglia – suona romantico “happy end”, concepibile sullo schermo, che tradisce l’intenzione narrativa. L’impianto ribadisce l’innegabile fedeltà a un’idea di poetica nostalgica ch’è sale di un’operazione teneramente senile, dovendo contentarsi dello schermo via cavo, lungi mille miglia dalla sfera New Hollywood ormai a fine percorso, per concretizzare un’effimera scintilla “démodé”. Ciò vale anche per quel mix di thriller, “noir”, melodramma ch’è “Blood & Wine”, col quale Rafelson approda al termine d’un percorso iniziato anni prima con “Cinque pezzi facili” e proseguito con “Marvin”: mettendo nuovamente in luce gli aspetti più foschi e tetri del nucleo familiare medio, il regista-sceneggiatore riprende l’odierna amoralità d’una torrida Florida, avida e opulenta, ove l’univoco interesse dei personaggi è il sempiterno dio danaro, di fronte al quale ciascuno a suo modo è privo della minima umanità; la pietà è bandita e, denudata dalle circostanze, non camuffa cinismo e peggiori istinti, dalla vendetta all’egoismo. Accentuato da inquadrature intense e un marcato utilizzo del primo piano, alla ricerca d’una possibile verità velata dalla caratterizzazione, l’accurato lavoro di scavo sui volti degli attori è la maggior dote d’un cinema “rétro” ma coraggioso, ove la deriva dei generi va a braccetto con un forte sguardo etico sulla realtà, ancora in grado di scuotere. Radiografia di prototipi e situazioni, verità psicologica e varietà di tipi umani di cui, in tema di disfacimento, fa parte pure “No Good Deed – Inganni svelati”, che, fuori tempo massimo, riadatta Hammett per gli attuali gusti postmoderni; ma l’ulteriore parabola di corruzione, ove il sentimento (l’amicizia, l’amore) è una sbiadita reminiscenza a favore d’un gioco prevaricante di falsità e terrore, è senza slancio né identità, carente nel ritmo e nell’approfondimento psicologico.
Non sempre, in sostanza, il recupero sortisce identici effetti: lo sviamento è un bastone tra le ruote capace di trasformare la fortunata serie televisiva “I Monkees” – avventure dell’omonimo, strampalato gruppo “beat” sulla falsariga dello scoppiettante “nonsense” dei Beatles – da Rafelson co-finanziata e di cui dirige tre episodi nell’esordio per il grande schermo, “Sogni perduti”. E, viceversa, mostrare la magra versatilità col registro brillante, pensando a “Il gigante della strada”, in cui figurano i giovani Arnold Schwarzenegger e Robert Englund, e a “La gatta e la volpe”, per il quale il cineasta torna ad affidarsi alla fedele Carole Eastman (dietro pseudonimo di Adrien Joyce), unanimemente disprezzato come “dog a film”. Un effettivo divario che trasmuta il miraggio del successo in un’inafferrabile Fata Morgana, riecheggiando, nel più volte citato “Marvin”, l’anelito dell’estroso pubblicitario sul proprio fantomatico progetto – creare un regno del gioco d’azzardo nelle Hawaii – contrapposto alla tempra dell’introverso fratello, “entertainer” radiofonico in continua lotta con sé stesso e incapace di qualsiasi speranza nell’avvenire. L’opaco sfondo di un’Atlantic City invernale e fatiscente è mecca per troppe promesse (mancate) che giocano a Miss America, puntando sulla propria sensualità e rilasciandosi a una labile illusione di vittoria, laddove la descrizione del luogo acquista patetico spessore quanto la sua spiaggia, eliotiana “waste land” su cui le ex reginette di bellezza, scoprendosi appassite, danno fuoco ai loro abiti seppellendo creme e rossetti. E se anche gli antieroi non smettono di giocare o fantasticare, la mancanza di valori comporta lo smarrimento dell’identità rendendo comico l’esistere; il grande teatro vuoto, ove simulare per un istante, è il medesimo dello “speaker”, nell’epilogo, mentre vende domande senza risposta a un’invisibile folla. Il tocco di Rafelson consiste in uno stile scarno sino all’icasticità che, in una pellicola triste e affettuosa (non a caso priva di colonna sonora), trova compiuta formulazione esibendo “i caratteri dell’incubo (…) camuffato sotto l’apparenza della vita immediata”, i cui figuranti “emergono finalmente oppressi da un isolamento che ricorda da vicino la visione dello spazio cara alla pittura iperrealista.”[1]
La memoria del tempo senza ritorno è, con assoluta probabilità, il tralignamento più insistito con cui, volenti o nolenti, far i conti, dai filmini amatoriali proiettati sulla porta di casa nel buio d’una stanza (coi fanciulli impegnati a costruire castelli di sabbia) alle istantanee di familiari in posa concertista, immortalate da un “long take” con Chopin in sottofondo, intonato al pianoforte. I ricordi di un’epoca ormai inesistente, dal punto di vista concettuale, risultano l’equilibrio tra istanze maniacali e nevrosi personali: ecco che in “Cinque pezzi facili”, l’opera più ispirata di Rafelson, l’inversione di rotta calza perfettamente con l’“on the road” d’un disadattato in crisi esistenziale, che s’allontana dall’estrazione alto-borghese alla ricerca di un’alternativa alla “Way of Life”. Autobiografico a partire dal nome del protagonista, l’affresco della vita quotidiana a stelle e strisce è un’esegesi di modelli attraverso una galleria di segmenti in cui è instabile la ruota della differenza socioculturale: un quadro decisamente contraddittorio, che dietro regole e costumi imposti dal rigido conservatorismo esplicita incertezze, ipocrisie, chimere atte a spiegare i non rari scoppi di violenza cui abbandonarsi, e l’implicito rifiuto d’un ordine dove tutti, inibiti e depressi, diffidano del prossimo e s’avvelenano a vicenda. Complici “un rigore eccezionale, un’estrema economia figurativa (pur nell’abbondanza dei particolari d’ambiente), e un’invidiabile sicurezza di costruzione e concezione”[2], “Cinque pezzi facili” è il mosaico d’una deviazione perpetua (la stessa California, ruvida e desolata, smentisce il comune stereotipo di terra promessa), palese “leitmotiv” in cui il carattere sfaccettato di Bob Dupea è paravento di un malcelato malessere, che non vede chiaro dentro di sé e, perseverando nella provvisoria stabilità, brucia i ponti alle spalle optando per il nomadismo, definitiva via di fuga (“Sto bene… Sto bene”, è l’ultima battuta prima di allontanarsi). La fuga impossibile dei “dropout” Seventies – tradotta in una soluzione di continuità verso un cinema più commerciale, in apparenza privo di “politique” ma non d’omogenea direzionalità – è l’itinerario d’uno spirito anticonformista per il quale, nella stragrande parte dei casi, non esiste margine. La cui scomparsa è l’unica plausibile evasione, a bordo d’un destino nelle fattezze di camion, verso l’Altrove. E la libertà.
[1] LA POLLA, Franco: Il nuovo cinema americano. Venezia, Marsilio, 1978. Pag. 183.
[2] LA POLLA. Contenuto in: CANZIANI, Alfonso (a cura di): Cinema di tutto il mondo. Milano, Mondadori, 1978. Pagg. 366-367.
È MORTO JEAN-LUC GODARD
di Marco Rosati
E’ morto il corpo ma non la sua eredità. Un corpo destinato a svanire nella polvere, ma non il suo messaggio, non il simbolo che ha rappresentato profondamente dentro il cuore del cinema. Lui era il cinema, la sua massima interpretazione artistica. Ha seguito la propria visione fino all’ultima pellicola. Adieu au Godard. Il Re è morto, evviva il Re.
Potremmo discutere adesso della sua filmografia, spulciare un titolo alla volta e farne un necrologio. Se ripercorriamo la sua storia tutto ha inizio con una volontà ferrea di filmare e mostrare diversamente. Con pochi mezzi, lontano dalle grandi produzioni imbellettate, lui ha fatto ciò che voleva sin da subito e questa necessità gli ha permesso di essere identificato come una nuova ondata, la nouvelle vague. “Fino all’ultimo respiro” ha dimostrato che essere anti cinema accademico lo ha portato ad essere oggetto di studio, giocando con la materia filmica con la freschezza di un bambino.
Profondo conoscitore del cinema, di tutto il cinema, gli studenti francesi nella sua epoca urlavano no a John Ford, si a Jean-Luc Godard! La volontà di rendere realtà la rappresentazione cinematografica è stata per lui motivo per renderla ancor più finta, quindi i suoi personaggi parlano allo spettatore, si vedono gli oggetti di scena, la musica diventa motivo di disturbo.
Ha saputo individuare ogni singola idea della macchina cinematografica e l’ha sezionata per capirne i reali sviluppi e significati. Sapeva descrivere l’importanza di un ralenty e ne derivava il corretto uso.
Puro, purista. Ha dimostrato di saper fare il cinema da botteghino e proprio per questo ha potuto essere libero di poter compiere la sua missione: fare l’altro cinema.
Coerente, non ha mai tradito lo spettatore, regalandogli proprio quella unicità che poteva dare. La Sua visione.
Le ultime produzioni sono la conferma che il suo sguardo è sempre stato oltre e sempre attuale. Proprio di quell’attualità conforme al percorso storico del cinema, libero dal pantano del prodotto sicuro. Non un cinema usa e getta ma luce che rimane. A distanza di tempo ogni suo film può essere visto e non invecchia. Nemmeno lui è mai invecchiato, almeno nello spirito. Ha mantenuto quella scintilla di genialità e saggezza fino all’ultimo film ed ha tracciato una via per percorrere la strada del cinema come forma d’arte, artificio personale. Lui ci è riuscito. W il Re.
SAGGI
LORRE(ALISMO), LO SGUARDO DIETRO LA MASCHERA
di Francesco Saverio Marzaduri
“Lorre è la voce alta dentro di noi che ci fa capire di essere stati strappati da ogni contesto, sviliti”
ELFRIEDE JELINEK
La precedente e forse anche unica retrospettiva dedicata a Peter Lorre – all’anagrafe Ladislav Löwenstein – risale più o meno a trent’anni fa, nell’ambito della 13a edizione del “Mystfest” di Cattolica, accompagnata da una ormai rara “brochure” generosa di informazioni sull’attore ungherese d’origine ebraica. A beneficio dei cinefili, la 36a “kermesse” de “Il Cinema Ritrovato” di Bologna ripete tale monografico omaggio nel tentativo, storicamente delicato, di spiegare come l’eclettica gamma di personaggi interpretati, perlopiù psicopatici o “villain”, non corrispondesse a quell’ingiusta etichetta che “studios” statunitensi e parte della critica tendevano ad affibbiargli. Certo, “M – Il mostro di Düsseldorf” è l’ineludibile origine d’un più articolato percorso intriso di sfumature, sottigliezze, accenti di cui Lorre avrebbe fornito testimonianza anche in operazioni inconsuete, coraggiose quanto sventurate, dato che l’accoglienza loro riservata risultava il contrario dell’intento originale. Buon per noi che l’austriaco storico del cinema Alexander Horwath – chiamato a introdurre “L’uomo perduto”, unica e per l’appunto infelice regia di Lorre – oculatamente scelga tre annate tese a scandire altrettanti decenni, a partire dal 1931: la rivelazione nei panni di Hans Beckert (pluriomicida pedofilo che nel celeberrimo soliloquio finale tuttora trasmette un sentimento d’umana “pietas”) spalanca le porte della Settima Arte al protagonista, ancora legato al “milieu” teatrale, per amore del quale rifiuta un più sicuro impiego in banca, rompendo giovanissimo con legami familiari e convenzionalità quotidiana. Proprio la celluloide, a differenza del palco, sembra la sfera in cui il ventisettenne Peter individua la finestra sul mondo, concedendo corpo e volto a più di settanta film, ancorché innegabile sia la moltitudine tra horror, “spy-story”, thriller, il cui principale interesse risiede semplicemente nella sua partecipazione. Una fortuna e una dannazione, che Lorre pagherà in prima persona tra dolenti introspezioni e tormentate sensibilità, prestazioni sottostimate e progetti non corrisposti; e se negli anni Trenta, s’aggiunga, la “politique” attoriale non è ancora così accesa come lo diverrà nei lustri successivi, anche la star non fa mistero di maturare giudizi (e più tardi sincere convinzioni) nei confronti d’una realtà in costante mutamento: il sodalizio col drammaturgo Brecht, seguito alle lodi di quest’ultimo per l’appropriata “performance” di “Un uomo è un uomo”, basterebbe a comprovarlo.
Viso sinistro e infantile, timbro vocale al contempo suadente e languido, l’effigie di Lorre fatica un bel po’ prima che l’inconfondibile fisionomia da batrace esoftalmico, la bassa statura, la querula e lagnosa vocetta, trovino una compiuta valorizzazione, anche se ruoli da divo – al pari d’un Bogart o d’un Price, coi quali sovente condivide la scena – ne ottiene di rado, ambizione troppo ardita e limitante per le proprie capacità. E quando accade, vedi caso, le ragioni alimentari hanno la meglio sull’approfondimento psicologico al di là della professionalità, rischiando, come mostra la fortunata serie dell’investigatore giapponese Mr. Moto, d’imprigionarlo nella gabbia (nemmeno troppo dorata) della confezione di genere. La fortuna d’una rassegna compensa lo spettatore dell’ingrata cernita tra i succulenti titoli in cartellone, complici le repliche delle pellicole in programma, quasi tutte in bobina – con l’unica eccezione de “L’uomo che sapeva troppo”, che può far leva, manco a dirlo, sul richiamo della firma registica. Altrettanto inevitabile è l’inclusione d’un documentario televisivo (“Das Doppelte Gesicht”, girato a quattro mani da Harun Farocki e Felix Hoffmann), atto a gettare una luce significativa sugli alti e bassi professionali dell’artista: pure, senza la necessità di incomodare un “format” di pregio, reo di liquidare un po’ troppo sbrigativamente i sette anni dell’attore alla Warner e l’ampio contributo al cinema popolare anni Quaranta, emerge parimenti un ritratto amaro ed eloquente, la cui carriera nel prodotto d’autore quasi cessa nell’istante in cui comincia, senza che si tenga conto, dietro la duplice facciata, di un raffinato intellettuale amante delle belle arti, provvisto della preparazione e “souplesse” d’un completo professionista che gli consentono, con intelligenza, di cambiare registro.
Analizzare l’assortimento di cui è costituita la figura artistica di Lorre implica rintracciarne ogni volta un tassello biografico, e il mosaico compositivo che ne emerge fa il paio con una giovinezza turbolenta, colma di lavori occasionali per finanziare la propria aspirazione, prima di conoscere l’esistenza “bohémienne” e, qualche anno dopo, debuttare a Zurigo recitando per sette anni a Breslavia, Vienna e Berlino, in adattamenti da Galsworthy, Fleisser, Büchner. È in quel periodo che, diciannovenne, s’inventa il noto nome d’arte dietro suggerimento dell’inventore dello psicodramma, Jacob Levy Moreno, sperimentando il trasformismo, che da semplice strumento della filodrammatica perfezionerà man mano. Se le produzioni conoscono restrizioni ai confini nazionali, indipendentemente dai permessi di lavoro, per uno dei paradossali casi in cui il successo non arride alla stella, né in Germania né all’estero, il capo-attentatore Abbott – anima nera del complotto, nel sopracitato film di Hitchcock – è un raffinato e sottile binomio di cultura e malvagità, che fa di Lorre uno tra i volti più richiesti in un genere di eterna attualità. Un aspro antipasto, soprattutto, dell’incombente “climax” di ansia e paura che obbliga il mondo a stare all’erta (d’origine ebraica egli stesso, Lorre deve far fagotto seguendo la corrente di molti colleghi mitteleuropei). Ma un discreto esordio nel lungo esilio, che gli garantisce un contratto con la Columbia e una fortuna rara per interpreti della medesima scuola; nondimeno, la personificazione più amata, e fortemente voluta, si rivela la meno corrisposta dal pubblico anche a causa della magra convinzione del tycoon Harry Cohn, che dispone d’un budget irrisorio, di pochi interni spogli e un cast privo di nomi di punta. Racconta Lorre su “Ho ucciso!”: “Josef Von Sternberg ha diretto il film con tocco da maestro. Speravo che le scene e i costumi non risultassero un po’ troppo esotici, siccome ritenevo che quella storia avrebbe potuto succedere a qualunque tipo di persona e in qualunque posto; quindi un’enfasi eccessiva sui costumi e le scene sarebbe risultata distraente. Dissi a Mr. Von Sternberg che speravo che gli spettatori rientrando a casa non avrebbero ritenuto che avvenimenti simili potessero succedere soltanto a dei russi vissuti all’epoca di Dostoevskij.”[1]
Giovanni Buttafava, nell’elencare gli innumerevoli difetti nell’esito, constata un clamoroso esempio di “miscast” reputando lo stesso divo “un handicap non da poco”[2]; se si eccettua un copione riduttivo, carente di autentici guizzi ambigui e tale da non suscitare stimoli, si tratta d’un fallimento d’eccezione “da imputare soprattutto alle preoccupazioni di rispetto della Cultura”[3], rimpolpato da segmenti che conferiscono una possibilità di “riscatto” del materiale. A conti fatti, quel che dovrebbe costituire un “trait d’union” fra due prestigiose carriere dà l’impressione d’un solido “mélo” a tinte mai abbastanza fosche, che si limita ad anestetizzare i risvolti più estremi della pagina onde evitare noie con la censura. Tralasciando alcuni essenziali compromessi, senza ledere essenzialità o ramificazioni psicologiche, il Raskòl’nikov qui offerto persegue un accurato, predefinito progetto personale: in un inglese ancora incerto (ma distante dal fonetismo del cospiratore Abbott), l’attore si esalta al centro d’una trasposizione marcatamente teatrale-dialogica, conferendo sfumature emotive al timido sunto della maschera letteraria. Il pedinamento tra lo studente pervaso d’idee superomiste, desideroso di compiere il gesto “utile”, e l’ispettore di polizia Petrovič è condotto lungo una sapiente scacchiera, ove la zona grigia e morale tra le pulsioni violente dell’essere umano s’interseca con le convenzioni, non meno violente, della società; la posizione di chi si crede intoccabile, di fronte alla lezione etica dell’umiltà e dell’amore, frana lentamente sotto i piedi del personaggio (sino alla cosa giusta da fare) attraverso tracce disseminate, forse all’occorrenza, per indurre il reo a confessare e la legge a sbugiardarlo. Già campanello d’allarme premonitore del gangsterismo politico che conduce Hitler al potere, ciclico perdura il rapporto tra l’individuo trasformato in assassino e il Sistema che ne innesca l’ossessione omicida. Il disegno di Raskòl’nikov, da un lato, anticipa d’una buona decina d’anni quello degli studenti omosessuali di “Nodo alla gola”, e dall’altro, stando a Lorre, quasi replica il Beckert nel capolavoro di Lang, che scrive alla polizia lettere anonime incrementando le ricerche (da par suo il maestro, ispirato da articoli su episodi realmente accaduti e dalla spietata lucidità della tendenza artistica “Neue Sachlichkeit”, accentua lo spunto all’origine). E un parallelo, per altri motivi, si rintraccia nel bizzarro “noir” statunitense “L’idolo cinese”, co-sceneggiato da John Huston (che già lo aveva voluto ne “Il mistero del falco”) e co-interpretato dal corpulento Sydney Greenstreet, già al suo fianco nel medesimo film. Il Fato cinico e baro, riservato alla triade di complici ingolositi da un biglietto della lotteria, si mostra più tenero del consueto verso l’alcolista impersonato da Lorre, incarcerato per un crimine non commesso, che scampando per un soffio alla morte, e rimesso in libertà, rinuncia al bottino e opta per il piacere dell’onestà e dell’amore, timoroso che il feticcio perseveri nella sequela di sciagure.
Fare della filmografia dell’interprete una specie di specchio autobiografico, impone di tornare alla menzionata cronologia decennale di Horwath – sua la rassegna intitolata “Straniero in terra straniera” – e capire quanto alcuni tratti fondamentali del lavoro di Lorre risaltino, neanche troppo sottesi, ne “L’uomo dalla maschera”: una confezione di serie B ch’è calzante definizione, ancor più geniale in originale, da leggersi quale ironico monito a un’esperienza hollywoodiana scissa tra attese e delusioni, ove la particolarità fisica priva della possibilità di condurre un’esistenza normale. La deformazione, da carta vincente, si tramuta in etichetta ingiusta pressoché collettiva.
“Un emigrante giunge alla meta dei suoi desideri. Tuttavia lì perde la faccia, la nuova patria gioca duro con lui. Deve prender quello che gli danno. Più tardi, quando le sue capacità vengono distorte e incanalate in una tipizzazione criminale, non può più tornare indietro. Accetta la maschera provvisoria, se la mette come se fosse il proprio viso deformato. Forse la maschera diventerà carne e il nuovo volto sarà migliore del primo. Ma egli non si libererà più di quel che doveva essere un ripiego momentaneo.”[4]
Hoffmann sigla osservando che quasi tutta la “fabula” gioca con la metà superiore del volto di Lorre, il che basta e avanza per sbarcare il lunario. Eppure fatalismo e angoscia, dubbia morale borghese e sfumature di sradicamento nel prototipo dell’immigrato (e non del rifugiato) s’insinuano, disinvolti, in una miscela di generi dove le ristrettezze di “budget” si traducono in stilemi, conservando una cifra originale e melanconica (“Possiamo sovrapporre questo ‘volto’ a quello di “Kaspar Hauser” – progetto sognato per tutta la vita e mai realizzato”, ipotizza Horwath, “e vederlo come un trovatello”). Come disaminare l’apologo di Robert Florey se non come una parabola tristemente sarcastica sull’avversa fortuna, camuffata da guscio protettivo, degli ometti beffati dalle circostanze? Potenziale Conte di Montecristo, orrendamente sfigurato in seguito a un terribile incendio, lo Szabó del film è temuto da tutti, senza lavoro né compagnia, e per campare si ritrova a indossare un facsimile elastico del viso color carne, organizzando una banda di piccoli delinquenti e capeggiandola con mente lucida e mani abili. Ancora una volta, è l’amore a suscitare una crisi di coscienza nel piccolo ex orologiaio, e per giunta il sentimento si rivolge a una ragazza cieca, graziosa e onesta com’era egli un tempo. E altrettanto sfortunata (muore in un’esplosione a lui destinata dai propri sgherri). Se la conclusione, corredata di vendetta catartica, ribadisce l’archetipo “à la” Dumas col supplemento d’un suicidio, pure il breve rapporto tra i protagonisti pare un calco dei “ménage” coniugali di Lorre, forniti di villetta, giardino, automobile, cane da guardia, e non meno sfociati in separazioni o divorzi. Né è azzardato ripensare alla fioraia di matrice chapliniana – e il creatore di Charlot non fa mistero di considerare Peter “il più grande attore vivente” – mentre il finale in un deserto senza scampo riporta alla Death Valley dell’amico Von Stroheim che, nel ’40, fa coppia col Nostro nel rifacimento d’una pellicola francese: “I Was an Adventuress” preserva e valorizza l’arguzia delle messinscene di Weimar e dell’esilio dalla Francia in quella che, per altri versi, è essenzialmente un “reboot” hollywoodiano della Vecchia Europa. A dispetto delle patetiche partecipazioni in età avanzata, perlopiù parodie del passato, qui il brillante istrionismo di Lorre è sapientemente impiegato in una non semplice gara di bravura, attenta a non azzerare un’innata propensione verso il sentimentalismo (“Credo di essere un caso patologico. Sono un debole. Come tutta la mia famiglia”).
Peccato che il Lorre maggiormente richiesto coincida con le incursioni nell’horror gotico: ecco che Florey gli regala un ulteriore “villain” nell’ultimo titolo per la Warner, “Il mistero delle cinque dita”, elogiato dalla critica ma inchiodato in un “milieu” senza le cui ombre e chiaroscuri è impensabile evadere o esser corrisposti. Anche perché il sinistro segretario Cummins, esperto di occultismo, per buona parte è debitore del più famoso dottor Gogol di “Amore folle”, altro innamorato non corrisposto che, responsabile del trapianto di mani d’un omicida su un pianista, inutilmente spera di conquistare le attenzioni della di lui moglie. Nel Florey di dieci anni dopo, una mano ambulante strangola Lorre vendicandosi come un mai sopito spettro (invero l’autore dell’idea, Buñuel, non può far causa alla “major” che gliela sottrae senza riconoscimenti né compensi).[5] E il passato che ritorna è fulcro dell’esperimento più ambizioso e malavventurato: con “L’uomo perduto”, suggerisce Horwath, si chiude il trittico cronologico, estrema tappa d’un percorso ove l’ascesa del nazismo, quale riverbero all’inverso, cede il passo a un inarrestabile declino. Il ritorno in Germania dopo diciott’anni di esilio all’estero sterza verso la (psic)analisi della coscienza d’un Paese, il cui motore-chiave è un “verlorene” dentro e fuori l’artificio, indotto a rimirare un luogo e una realtà non propri, che opta per un mosaico volutamente avviluppato e trasversale: quasi fosse l’“unicum” d’una prospettiva interna alla (sconfitta della) patria, eppur estranea al problema. Un’estrema contaminazione di generi e assunti, dallo spionistico al thriller, ch’è sostanzialmente un dialogo a due voci in dichiarato squilibrio sulla contrapposizione tra uno scienziato – con un trascorso da killer – e l’assistente – ex spia del Partito – in un campo di rifugiati ed ex internati, concepito a mezza strada tra lo psicodramma e il “report” documentaristico (l’autore, dichiara una didascalia in apertura, s’ispira a una pagina di cronaca avvenuta ad Amburgo).
Un fedele ritratto della verità che resuscita il “Lorrealismo”, così genialmente definito da qualcuno, stimolato dalla caterva di impulsi e idee creative soffocatigli dalla Hollywood finta culla, lungo una struttura fedele alla miglior tradizione del cinema bellico d’anteguerra, nonché alla sovrapposizione di realismo ed espressionismo che avevano caratterizzato “M”. Sicché il film è un “noir” sociale che, tracciando il diagramma psichico di un criminale, indaga sull’ambiguità morale seguita alla fine del “Dodicennio nero” e le etiche conseguenze lasciate in eredità dal regime di Hitler (peraltro mai menzionato) alla coscienza dei superstiti. Un’opera prima e unica antesignana d’una cinematografia impegnata nell’elaborazione del passato, destinata a restare quasi appartata nella produzione tedesca dell’epoca votata totalmente, o quasi, all’intrattenimento puro e semplice. Soprattutto un prodotto sulla morte e l’ossessione di essa, contestualizzata entro la diabolica macchina della guerra e del nazismo, che, a due anni dalla cessazione del conflitto, fa della personalità-cardine il frantumato esito d’un tragitto che attraversa modernismo e fascismi europei, tossicodipendenza ed esilio, cultura della fama e del denaro, su cui si riflettono volti e maschere del periodo. Un “perduto”, appunto, coerente con sé stesso perfino in un piglio recitativo di disarmante contenutismo, basato sull’aderenza fisica e psicologica, a sua volta appesantita dall’età e segnata dagli umori, coniugata a una proverbiale improvvisazione. Non sorprende che nell’anatomia d’un assassino obbligato a tener testa a un intero popolo di assassini, e a confrontarcisi in un “plot” di fine intellettualismo, s’insinui Shakespeare, avendo il dottor Rothe attinenze con Otello (e un Lorre ancora ignaro dell’insuccesso accarezza un Macbeth ambientato nella Germania contemporanea). Lì è però l’incedere degli eventi a piombare sull’apolitico scienziato, determinando uno stato di totale confusione. All’impulso di uccidere non seguono accuse: è il potere di Stato a prevaricare l’essere umano, sottraendogli i pochi giorni rimasti, e il destino a reclamare il dovuto. Non ci si sottrae al trascorso, né interessa la sensazione di disfatta sulla liberazione: l’unica via è l’estremo gesto. “Non esistono più affari privati, e anche morire non è cosa privata”.[6]
In un ritaglio, tra gli enumerabili di cui la pellicola dispone, si carpisce come la cinetica attoriale sia tutt’uno con uno spirito apolitico e tormentato, destinato a non trovar collocazione: non potendo più parlare all’interlocutore – cui ha sparato, tanto incolmabile è la distanza – il protagonista getta addosso al cadavere la pistola e un pacchetto di sigarette, non prima di averne estratta una. Oggetti destinati a esser seppelliti col morto, come le cose che in vita permettono di esercitare il potere. Quelle della realtà esteriore parlano da sé. E il progetto di un’esistenza si cinge nell’identica incomprensione con cui l’arte di Peter Lorre, nel solco più intimo, è solitamente accolta: illuminato da uno splendido bianco e nero, “L’uomo perduto” è un oggetto isolato, a lungo invisibile, destinato a deprimere la vena creativa del cineasta sino a demotivarla. Senza più voce in capitolo, il Nostro campa con generose ospitate in confezioni a basso costo, anacronistici “cameo” d’una produzione ormai tramontata: il mistero del Lorre tangibile, tuttora, resta tale a quasi sessant’anni dalla scomparsa. Un enigma, come la “Valigia di Mr. O.F.” nell’omonima satira musicale del ’31, in cui veste i panni del redattore Stix: divertimento senza pensieri frutto di un’epoca lontana mille miglia, ora restituito nel proprio contrario. “Chi può sapere come sono fatto dentro?”, secondo una sua celebre battuta. E nel rispondere, magari, non si può che prenderlo in parola quando, diabolico, accetta il rimprovero del canagliesco Von Stroheim, truffatore come lui: “Senza di me saresti perso in questo mondo sofisticato di uomini scaltri e donne intelligenti”. E Peter: “Sì, sono solo un bimbo nel bosco”.
[1] HOFFMANN, Felix, YOUNGKIN, Stephen D., Peter Lorre, Rimini, Mystfest, 1992. Pag. 41.
[2] BUTTAFAVA, Giovanni,Josef Von Sternberg, Firenze, La Nuova Italia, 1976. Pag. 63.
[3] Idem.
[4] HOFFMANN, YOUNGKIN, cit. pag. 35.
[5] Oltre a ritrovarsi nel dittico de “La famiglia Addams”, l’“escamotage” della mano mozzata assassina sarebbe stato utilizzato nel secondo lungometraggio di Oliver Stone, appunto intitolato “La mano”.
[6] HOFFMANN, YOUNGKIN, cit. pag. 39.
SETTE FILM, ANZI OTTO, PER UN NUOVO INIZIO di Paola Brunetta
Mi è capitato di vedere, di recente, due film di esordienti italiani a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro e ho pensato di scrivere qualcosa su questi esordi, su questo cinema, cioè, italiano fresco e “leggero”, nuovo, fatto da registi a tutti gli effetti ma anche da cantanti o da attori che si cimentano nella regia. Sto parlando di “Settembre” di Giulia Steigerwalt e di “Sulle nuvole” di Tommaso Paradiso, ma altri film interessanti sono apparsi quest’anno sulla scena, “Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, “Piccolo corpo” di Laura Samani, “Il legionario” di Hleb Papou, “Marcel!”di Jasmine Trinca, “Una femmina” di Francesco Costabile; di esordienti assoluti o di esordienti nel lungometraggio, passati per i corti e magari anche per il documentario (Rigo de Righi e Zoppis, per esempio). Con temi forti e importanti (“Il legionario” e “Una femmina”), con temi particolari come in “Piccolo corpo”, con la voglia di sperimentare come in “Re Granchio” o con una classicità di fondo come in “Settembre” e in “Sulle nuvole”, o con una leggerezza, come in “Settembre” ma soprattutto in “Marcel!”, che fa sperare in un rinnovamento del nostro cinema “giovane”, che si accompagna a quello, importante, del documentario (pochi titoli per tutti sempre in relazione all’anno in corso, “Io resto” di Michele Aiello, “La città delle sirene” di Giovanni Pellegrini e “Brotherhood”di Francesco Montagner, al confine tra finzione e documentario, o, per andare sullo sperimentale, “Dal pianeta degli umani”di Giovanni Cioni). Vediamoli, quindi, più da vicino questi sette film, cominciando da quelli che mi hanno suscitato queste riflessioni. E chiudendo con un cenno ad “Altri cannibali” di Francesco Sossai, che contrariamente ai precedenti non ha ancora una distribuzione ma che mostra un talento maturo e originale.
“Settembre” è diretto da Giulia Steigerwalt, classe 1982, che ha studiato filosofia in Italia e cinema negli Stati Uniti e che prima di esordire alla regia ha lavorato come attrice (primo film “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino, 1999, a cui “Settembre” sicuramente guarda) e come sceneggiatrice (i film di Godano e “Il campione” di Leonardo D’Agostini), cosa che qui si nota: i pregi maggiori dell’opera sono infatti il lavoro degli e con gli attori, e la naturalezza della scrittura.
A rendere “Settembre” così fresco e leggero, godibile pur nella complessità dei temi che affronta, sono appunto in primo luogo gli interpreti, tutti in stato di grazia: Barbara Ronchi, bravissima nel delineare lo scontento sottile di una donna non vista né valorizzata dal marito e la preoccupazione seria per un problema di salute che le consentirà di guardare con occhi diversi alla vita; Thony, già apprezzata in un film “minore” ma lieve e toccante di Paolo Virzì, “Tutti i santi giorni”, cantautrice passata al cinema che firma anche due brani della colonna sonora, che si avvale peraltro di pezzi di Bob Dylan e dei Velvet Underground; Fabrizio Bentivoglio, perfetto nel rendere l’apatia esistenziale di un uomo che sembra aver perso tutto ciò che è importante nella vita, ma che le persone e le situazioni “giuste” sanno risvegliare, in relazione a ciò che lui stesso dà loro; e gli attori più giovani, Teresa Litvan, Enrico Borello, Margherita Rebeggiani e Luca Nozzoli, la giovinezza e la preadolescenza ritratte con pochi tocchi significativi, nell’apertura alla vita. La scrittura è appunto fluida, lineare; si dipana con leggerezza una storia corale, di personaggi collegati tra loro da rapporti di parentela o di amicizia o professionali, che a partire da elementi casuali o che non sono quello che sembrano (l’infedeltà di Alberto, il tumore di Francesca), ma che arrivano al momento giusto nella loro vita, li portano a dei cambiamenti o a delle prese di coscienza, più o meno minimali. L’atmosfera, prodotta anche dalla musica che si diceva, ricorda quella dei primi film di Francesca Archibugi e di alcuni film di Silvio Soldini, in particolare “L’aria serena dell’Ovest”, che è meno leggero nel tono ma che mostra, allo stesso modo, l’importanza del caso nella vita di più personaggi e la loro capacità di accogliere ciò che la vita offre, se hanno l’apertura per farlo. Apertura anche come assenza di pregiudizi.
Barbara Ronchi, attrice poliedrica e generosa scoperta da Marco Bellocchio in “Fai bei sogni”, dove interpreta la madre del protagonista, anche se il suo primo ruolo cinematografico è precedente (1), e vista anche in un film di Francesco Bruni, “Cosa sarà”, che per certi versi è assimilabile a “Settembre”, è la protagonista anche di “Sulle nuvole”, esordio alla regia di Tommaso Paradiso, classe 1983, cantautore con laurea in filosofia, ex frontman dei Thegiornalisti, che racconta la storia di un musicista, Nic Vega, caduto nell’oblio dell’autodistruzione da alcol e droga dopo una folgorante carriera giovanile, che, tornato a Roma, ritrova il proprio amore di gioventù e riesce a tornare sulle scene. Una storia poco originale quella del “bello e dannato” perduto che si redime, che ricalca, tra l’altro, quella di “Crazy Heart” (Scott Cooper, 2009), ma raccontata in modo realistico e verosimile grazie soprattutto all’interpretazione degli attori. Abbiamo parlato di Barbara Ronchi ma in questo caso la performance migliore è quella di Marco Cocci, il Tommaso di “Ovosodo” (Paolo Virzì, 1997), a sua volta musicista (e passato di recente, come Tommaso Paradiso, dall’appartenenza ad una band alla carriera solista), che rende naturalissimamente i tormenti di Nic, passato e presente, gioie e dolori, nei vari ambiti della sua vita, evitando di cadere, come sarebbe stato facile in un ruolo di questo tipo, negli stereotipi del genere.
E insieme a loro citiamo Paolo Briguglia, che rende perfettamente le sfumature del personaggio del marito di Francesca, un medico idealista, serio e forse un po’ ingenuo, che accoglie Nic in casa senza rendersi in effetti conto di ciò che questo avrebbe provocato, nella moglie e nella famiglia tutta. Certo qualche obiezione può sollevarla il finale, con il ricongiungimento dei due che sarebbe stato molto più efficace se fosse rimasto temporaneo e strumentale alla ripresa della carriera dell’uomo; forse Paradiso si fa prendere la mano dalla storia dei suoi personaggi, e in un esordio ci può stare; quello che conta però è la sincerità dell’opera, che non è un film d’essai ma che come opera rivolta al grande pubblico, anche quello delle piattaforme, ha una sua dignità e una sua bellezza.
Con il terzo film di cui ci occupiamo, “Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, cambiamo decisamente orizzonte e intenzioni: questo è un vero film d’autore, originale e sperimentale, e gli autori sono Matteo Zoppis (Roma, 1986), che ha studiato giurisprudenza tra Roma e Parigi e poi regia a New York e che negli Stati Uniti ha lavorato come direttore della fotografia, cameraman e montatore video, e Alessio Rigo de Righi (Jackson, Mississippi, USA, 1986), che ha studiato cinema e letteratura a New York e a Roma per poi trasferirsi a Buenos Aires, dove tuttora vive. I due si sono conosciuti nel 2013 per il documentario “Belva nera”, e hanno appunto esordito nel lungometraggio di finzione nel 2021 con questo “Re Granchio”, coproduzione italo/ argentina/ francese presentata a Cannes nella Quinzaine des Réalisateurs e poi al Torino Film Festival, che presenta, in effetti, molti elementi documentaristici nel raccontare la storia di un personaggio eccentrico, Luciano, un anarchico, ribelle, alcolista e ossessionato dalla sete di conoscenza e di scoperta, che vive in un borgo della Tuscia a fine Ottocento, inviso alla comunità per il suo stile di vita e per il suo senso della libertà.
“Un pazzo, un nobile, un santo, un ubriacone” (2) o forse, più semplicemente, un innamorato. E proprio a causa dell’amore per una donna che il principe del luogo (che secondo alcune dicerie è il suo stesso padre) gli contende, Luciano commette un atto che lo costringe a fuggire e si reca “in culo al mondo” (come titola il secondo capitolo della vicenda) nella Terra del Fuoco, dove si mette, nei panni di un missionario ucciso dagli indios, a cercare un mitico tesoro, diventando preda dell’avidità in una sorta di delirio lucido. Il film prende avvio dal documentario del 2015 dei due registi, “Il Solengo”, ambientato nelle stesse terre della prima parte sulla scia delle narrazioni degli stessi uomini, e si basa appunto sulle narrazioni popolari, che parlano di quest’uomo vissuto tra fine Ottocento e inizio Novecento presso Vejano, di cui si sa poco o niente (perché, si dice, le storie che cominciano con 10 parole e finiscono con 50 passando di bocca in bocca, chissà se sono poi del tutto reali), al punto che la base storico-documentaristica, sia pur leggendaria nel senso che si diceva, si colora di un alone di mistero, di un’aura misticheggiante e a tratti magica che permette ai due registi di spaziare e di raccontarci Luciano come meglio credono, uomo del suo tempo ma anche eroe, pazzo e disturbato dall’alcol ma soprattutto folle di una sorta di titanismo superomistico, come molti personaggi dei film di Herzog (regista a cui “Re Granchio” si ispira esplicitamente, sia nella figura del protagonista sia nelle ambientazioni della seconda parte, paurosamente maestose). Quello che colpisce di più è però la resa cinematografica del film, che utilizza ambientazioni naturali, i boschi della Tuscia nella prima parte e le distese superbe della Patagonia nella seconda, per mostrare lo spaesamento anche esistenziale del protagonista, e questi paesaggi li ritrae in maniera antinaturalistica, straniata, visionaria, con un uso originale del colore (la fotografia è di Simone D’Arcangelo) e con un senso di sospensione e di tragicità che diventa la cifra stilistica, oltre che tematica, dell’opera. Senza contare l’interpretazione straniata e potente di Luciano di Gabriele Silli, artista romano dalla formazione filosofica. Riportiamo, per concludere, la motivazione della designazione dell’opera come Film della Critica da parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, nel novembre 2021: “Re Granchio porta in luoghi lontani nel tempo: nella Tuscia di fine ’800, terra ancora feudale dove un principe governa il destino dei propri sudditi, e all’altro capo del mondo, in una Patagonia dalle atmosfere quasi soprannaturali. Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis ricostruiscono un racconto orale ammantato di leggenda e realizzano un cinema avventuroso e insieme spirituale, capace di stupire lo spettatore e di accompagnarlo in territori inaspettati, tra la magia e la dannazione”.
In un analogo ambito d’essai, anche se in senso meno sperimentale, e in un analogo tema di ricerca, in un luogo naturalistico reale ma anche archetipico, da parte di un personaggio “anomalo” o comunque guardato con sospetto dalla comunità di appartenenza per il suo comportamento troppo libero ed originale, si muove “Piccolo corpo” di Laura Samani, presentato a Cannes nella Semaine de la Critique. Racconta la storia di Agata, la cui figlia muore subito dopo la nascita e non può essere per questo battezzata (siamo in un isolotto del Nord-Est a inizio Novecento); ma la donna non accetta che la figlia viva nel Limbo, senza un nome e senza una consacrazione, come un’anima dannata, e accoglie il consiglio di un uomo che le dice che più su, nelle montagne del Nord, c’è una chiesetta in cui si fanno resuscitare i morti per un momento, per poterli battezzare prima che tornino nel sonno eterno.
Agata affronta un viaggio periglioso per raggiungere questo posto, senza sapere se si tratti di leggenda o di realtà (ma in effetti poco importa, anche ai fini del film), e si fa aiutare da un ragazzo che incontra nel bosco, che vorrebbe in cambio la sua scatola, senza sapere che contiene il corpo della neonata. Un viaggio pieno di insidie e avversato da tutti, e che la protagonista compie, appunto, in solitudine, con un senso di spiritualità che è religione e superstizione insieme. E la regista, classe 1989, laureata in Arti e Comunicazione oltre che in regia al CSC di Roma, ci accompagna in questo viaggio con maestria, facendoci “sentire” il paesaggio, sul piano dei sensi e degli elementi (Paola Casella recensendo il film parla di “aria, terra, acqua e fuoco, ma anche legno, luce, pietra, neve, fumo, lana, latte” (3)) come su quello storico, catapultandoci in un passato che, al pari di quello di “Re Granchio”, è realistico (i dialetti, gli attori quasi tutti non professionisti, i piccoli accadimenti legati alla realtà contadina e montana del tempo) ma anche mitico, favoloso. Però vivo, reale. E molto italiano (Olmi, i Taviani ma anche Alice Rohrwacher). Scrive Raffaele Meale: “Piccolo corpo non ha paura delle notti buie, non ha timore di affrontare un cunicolo dal quale nessuno è uscito vivo, e si arrischia con gran coraggio a sfidare il naturalismo, e la supposta oggettività del reale. Nelle profondità acquatiche, un attimo prima dell’assideramento, Samani sa ancora trovare il calore dell’umano che sopravvive nel sogno a ogni lutto. E lì, quasi occhieggiando all’onirismo di Vigo, ritrova la vita, e dunque il cinema” (4); che ci pare una conclusione interessante.
Su un terreno diverso ci porta invece “Il legionario” di Hleb Papou, regista bielorusso nato nel 1991, cresciuto e formatosi in Italia (al CSC di Roma) e vincitore, con questo film, del premio come miglior regista emergente al Festival di Locarno; il terreno del realismo, del realismo impegnato, del realismo sociale in riferimento al tema degli edifici occupati abusivamente nei centri delle città, in questo caso a Roma, tra l’altro prendendo in considerazione lo stesso stabile di cui si è occupata Sabina Guzzanti in “Spin Time – Che fatica la democrazia!” (2021): un palazzo di sette piani e diciassettemila metri quadrati nel quartiere Esquilino, in precedenza adibito a uffici statali, poi di proprietà di un fondo immobiliare, in cui dal 2013 convivono centottanta nuclei familiari di venticinque nazionalità diverse: rifugiati politici, singoli indigenti, persone che per vari motivi si ritrovano senza casa e che si autoregolamentano attraverso turni di servizi comuni e riunioni settimanali.
Il palazzo di cui Papou si era occupato in un cortometraggio del 2017 dallo stesso titolo, ora sviluppato in lungometraggio. Il film ha come protagonista Daniel, agente di polizia di origine africana, apparentemente ben integrato nella realtà italiana (il lavoro e il cameratismo dei colleghi, la casa, la fidanzata), membro dei reparti mobili che operano gli sgomberi, che si trova a dover liberare il palazzo in cui vivono la madre ed il fratello, che è uno dei leader dell’occupazione, e che si trova di conseguenza a scegliere tra la fedeltà al suo “corpo” e quella alla sua famiglia, alle sue radici e forse, anche, alle sue idee. Scrive Roberto Manassero: “Innegabilmente, il film ha il coraggio di sporcarsi le mani con un dramma sociale e umano che mostra un’Italia vera, operaia e in agonia, e per questo nascosta agli occhi. Un’Italia complessa perché contraddittoria, dove gli stranieri rappresentano il tessuto reale della società, la sua rete di supporto solidale, e i poliziotti chiamati a stroncarli sono uniti da un cameratismo di marca fascista che offre però a suo modo analoghe possibilità di supporto e riconoscimento identitario” (5). Il film infatti, al di là del tema principale dell’emergenza abitativa e del diritto alla casa, mostra alcuni aspetti della realtà sociale italiana e soprattutto ci parla di immigrazione, del ruolo che gli immigrati hanno come lavoratori ma anche come categoria sociale in difficoltà, e guarda agli immigrati nel discrimine che separa il loro passato (l’attaccamento alla famiglia e alla tradizione) dal loro presente (ciò che hanno costruito nel paese che li ha accolti, il lavoro che fanno, il ruolo che svolgono). Per Daniel, nella fattispecie, il lavoro in Polizia è fondamentale perché il suo reparto lo ha “adottato”, pur senza sapere niente di lui e del suo passato e pur chiamandolo con un nomignolo dovuto al colore della sua pelle, e soprattutto lo ha adottato “Aquila”, il suo capo, che ha improntato i rapporti della squadra al cameratismo di marca fascista di cui parla Manassero; cameratismo che dà però a Daniel il senso di appartenenza di cui ha bisogno, come ha bisogno della “struttura” data dal senso dell’ordine che la Polizia rappresenta. Papou ha voluto quindi rompere gli schemi per fare “un cinema di genere che intrattenga e diverta ma che inviti e consenta un ragionamento, che racconti la società attuale con i suoi problemi, un cinema di genere col cervello, che racconti in modo crudo, d’impatto, di scontro” (6). Come quello di Ken Loach o di Jacques Audiard: caldo, grezzo, diretto, impegnato e pregno di emozione; anche se il riferimento più diretto sul tema specifico è lo Stefano Sollima di “ACAB – All Cops Are Bastards” (2012) o gli ultimi (strepitosi) film francesi sull’argomento, “I miserabili” (Ladj Ly, 2019) e “BAC Nord” (Cédric Jimenez, 2020).
Un tema importante è anche quello trattato in “Una femmina” da Francesco Costabile, classe 1980, laurea al DAMS di Bologna e diploma al CSC di Roma, attivo nella realizzazione di cortometraggi e documentari dal 2001 ma con esperienze anche diverse, come la cura del casting e della documentazione per “Felice chi è diverso” di Gianni Amelio (2014) o la produzione esecutiva del film di Carmine Amoroso “Porno e libertà” (2016).
Molti dei suoi lavori affrontano tematiche Queer ma in questo, “Una femmina”, Costabile torna nella sua Calabria per parlare di mafia e in particolare di una donna, Rosa, che si ribella ai codici della ‘ndrangheta e che quando, successivamente, vi si trova invischiata completamente, li ribalta dall’interno uccidendo la persona che ha sposato, che è il nuovo boss del posto. Il film, presentato alla Berlinale, nasce da un’idea di Edoardo De Angelis e Lirio Abbate ed è tratto dal libro inchiesta “Fimmine ribelli”, scritto da Abbate, sulle donne vittime di violenza all’interno dell’organizzazione mafiosa. La donna, infatti, che “disonora” la famiglia deve morire, meglio se con un “suicidio”, come accade alla madre della protagonista; la ribellione, quindi, delle donne che oggi si affidano “allo Stato, ovvero al nemico” per cercare di scampare a un destino infernale, produce un effetto dirompente perché sgretola l’immagine di compattezza del clan, mette in dubbio i valori del sistema ’ndrangheta, rivela l’impotenza dei boss incapaci di “tenere in riga” le loro donne. E, soprattutto, accende nelle altre “fimmine” la consapevolezza della propria condizione e il desiderio di scrollarsela di dosso (abbiamo parafrasato, per amor di precisione, le parole di presentazione del libro da parte dell’editore Rizzoli). Il film comincia con l’uccisione della madre di Rosa da parte del fratello mafioso, con la correità silenziosa della madre, delitto che la bambina vede e non vede, o meglio vede, in parte, ma non può comprendere, per cui nella prima parte del film sono presenti molte sfocature, le immagini sono parziali, i primi e primissimi piani impediscono allo spettatore di cogliere l’insieme e quindi di farsi un’idea chiara di ciò che sta succedendo, e tutto è virato al nero, per rendere l’oscurità del luogo e della situazione, anche se sarebbe più corretto dire che l’oscurità è quella dei personaggi, ovvero degli affiliati alla ‘ndrangheta. Il luogo, tra l’altro, è un paese del cosentino che Costabile ha scelto per il suo aspetto labirintico e chiuso, come chiuso nell’inconscio e quindi vago rimane, per una parte del film, il ricordo che Rosa ha della morte della madre. Quando però Rosa comincia a “comprendere” e a capire che non è quello il contesto in cui lei vuole vivere, il film si apre anche stilisticamente e da thriller dell’anima diventa un film d’azione o meglio ancora un melodramma ambientato in un contesto umano aspro e crudele, pregno, come scrive Ilaria Feole (7), di una violenza arcaica e brutale; una favola nera che Costabile definisce come “un film che osa dal punto di vista immaginario, [che] non vuole essere una pura documentazione realistica. E un film che gioca con i generi cinematografici, ed è in un equilibrio molto sottile tra thriller, melodramma, o anche horror psicologico. Ci sono delle sfumature con la luce ed il suono. Il tutto intende scavare nell’immaginario dello spettatore” (8). In effetti luce e suono sono usati in maniera insistita, forse sovrabbondante, specie nella parte iniziale e in quella finale del film, che si sostanziano di questo aspetto stilistico “ad effetto” che va di pari passo con lo scavo psicologico dei personaggi e in particolare della protagonista e che dà sicuramente al film un originale tono melodrammatico che rimanda ad “Anime nere” di Francesco Munzi (2014), a cui si affianca uno stile più semplice e lineare nella parte centrale del racconto, quella più legata alla denuncia sociale (curioso tra l’altro, a proposito di riferimenti, che il film sia stato girato contemporaneamente ad “A Chiara” di Jonas Carpignano, un altro film che parla, in modo diverso, di una donna, anzi di un’adolescente, che pian piano comprende la realtà in cui la sua famiglia si muove e decide, quella realtà, di rifiutarla; sempre con riferimento alla ‘ndrangheta, a Gioia Tauro). Un altro elemento importante del film è la recitazione di Lina Siciliano, scovata sul posto ed efficacissima nel tratteggiare il travaglio di Rosa, tanto da meritare il premio del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.
Il nostro settimo film, “Marcel!” di Jasmine Trinca, presentato fuori concorso al Festival di Cannes, ci porta in territori ancora diversi, quelli della favola, o meglio del realismo magico, dell’equilibrio (difficile) tra immaginazione e realtà. Jasmine Trinca, classe 1981, è un’attrice che ha esordito con “La stanza del figlio” di Nanni Moretti (2001) e che, come altre attrici italiane (un esempio per tutti Valeria Golino, che compare in un cameo anche in questo film), ha deciso di passare dietro alla macchina da presa. Lo aveva già fatto due anni fa con un cortometraggio, “Being My Mom”, che è una sorta di prequel di “Marcel!” in quanto già tratteggia, con le stesse due attrici, un difficile rapporto madre – figlia in una Roma assolata e deserta, bellissima. E in quanto vi si vede, anche, la matrice autobiografica sottesa al nostro film: “Tutto questo parte da una fotografia. Ritraeva mia madre che mi teneva per mano sul ciglio di un bosco. Dietro di noi un paesaggio assolato, ma davanti? Il colore di quella foto lo avrei definito il colore della memoria. Non della nostalgia, come una foto a colori virata seppia, ma proprio un colore indefinibile e sfumato, bruciato dal sole, appena attraversato e ispirato dalla “selva oscura” pronta ad accogliere e proteggere quel passo a due. Tra sogno e realtà. È qui che si situa questo film. Una rielaborazione fiabesca o meglio favolistica del vissuto, cercando di comprenderlo, esorcizzarlo, renderlo universale.
Panni sporchi che non si lavano in casa ma che diventano bandiere da sventolare, inni programmatici: «All’arte si deve la vita». In fondo, tutto quel vissuto, quel bagaglio pesante impossibile da lasciare, sarà pure servito a qualcosa” (9), ha dichiarato la regista. La matrice del film in effetti è molto psicologica, e racconta la sofferenza di una bambina per l’indifferenza che la madre manifesta nei suoi confronti, o meglio, nei confronti di tutti tranne che del suo cane, Marcel, che utilizza per gli spettacoli di strada con i quali si guadagna da vivere, intitolati “Pour toujours Marcel!”, e che fa mangiare in tavola, oltre che dormire nel proprio letto. Una sorta di sostituto del padre della figlia, un pittore defunto perennemente evocato da sua madre, la nonna della piccola. I personaggi tra l’altro non hanno nomi, solo Marcel ne ha uno. E qui vediamo i primi riferimenti: a Marceau per il nome del cane, ma anche a Pirandello. Quindi all’arte, al teatro, l’unica cosa, secondo la madre, che salva la vita, e alla rappresentazione nel senso del rapporto tra realtà e finzione (che sia il teatro classico o il circo o gli spettacoli di strada), e qui entriamo negli altri riferimenti possibili che sono più cinematografici, Fellini e Chaplin sicuramente, ma anche Rivette. L’arte, però, e il sogno, e la magia, possono davvero salvare la vita? O sono altre, le cose che contano? La bambina, interpretata splendidamente da Maayane Conti come splendidamente Alba Rohrwacher dà volto e corpo a sua madre, nonostante suoni il sassofono per poter partecipare agli spettacoli materni e avere da questa un po’ di attenzione, non la pensa così e commette un atto forte, l’uccisione dell’animale, accadimento che innesca la seconda parte del film, un viaggio nella campagna (la prima parte è statica e suggestiva, ambientata nella Garbatella degli anni ’80 ripresa quasi sempre in notturna) che vedrà le due donne, come in “Being My Mom”, incrociare varie situazioni tra cui un circo e il mare, luogo in cui avverrà la ricomposizione finale. Un omaggio al cinema quindi (come dimostra l’utilizzo di attori “del passato” quali Giovanna Ralli e Umberto Orsini), all’arte (la musica rétro) ma soprattutto alla vita, agli affetti, ai sentimenti profondi, e al superamento dei conflitti. Come nella scena finale del cortometraggio, con quell’acqua che passa di bocca in bocca a suggellare un ritrovamento, duraturo o temporaneo che sia.
Non si può non ricordare in chiusura, nonostante non sia uscito nelle sale perché ancora privo di distribuzione, “Altri cannibali” di Francesco Sossai, feltrino, classe 1989, studi a Roma (lingue straniere) e Berlino (regia), prodotto dalla Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlincome saggio di diploma che sviluppa un lavoro precedente, presentato al Torino Film Festival e in altre Rassegne.
Un film che parla di cannibalismo ma, come da titolo, di un altro cannibalismo. Di altri cannibali. Quelli che hanno bisogno di pensare ad un gesto estremo come mangiare un proprio simile perché vorrebbero mangiare, afferrare la vita, cosa che non riescono a fare. Per inettitudine, per problemi personali, perché troppo cerebrali e quindi poco vicini a quella che è l’essenza delle cose; l’essenza fatta di carne, appunto. Il film è notevole perché al di là dell’originalità della storia e del tema che tratta, è girato in un bianco e nero astratto, rarefatto, che indica distanza ma al contempo è più reale del colore e rende appunto l’idea della verosimiglianza allo stesso modo dei volti e dei dialoghi, molti dei quali sono in dialetto. Ci sono due personaggi, Fausto e Ivan, che si incontrano per mettere in atto un proposito mai esplicitato e che, anche se questo non prende forma, per qualche giorno condividono qualcosa con qualcuno, rompendo un’atavica solitudine e, in un certo senso, compenetrandosi; e, per Fausto, anche subendo un’evoluzione. E ci sono i luoghi della montagna, le osterie, gli alpini con i loro cori, i vecchi del paese che bevono e giocano a carte; c’è l’uccisione del maiale, ripresa nella sua “naturale” brutalità. Ma dietro a questo realismo c’è un’inquietudine sottile, direi più esistenziale che psicologica, che colora il film di una tinta horror (oltre che grottesca) che non è mai gridata, ma resta sottesa. Fa da sfondo, crea un’atmosfera. E ci porta a scoprire questi personaggi e questo ambiente montano rude, ma anche tenero. Attraverso una fotografia magnifica e una cura dei dettagli per cui nulla è lasciato al caso, anche se sembra spontaneo; e qualunque impeto del cuore è sviscerato e soppesato, grazie anche alla camera a mano che segue i personaggi da vicino, penetrandoli. E attraverso due interpreti, Walter Giroldini e Diego Pagotto, che esprimono perfettamente quel vuoto fatto di noia e di inquietudine che “richiede” un gesto estremo, ma che quel gesto estremo non riesce a compierlo. Forse anche perché non potrebbe bastare a sconfiggere un cannibalismo di altro tipo ma altrettanto pervasivo e duro, quello della società di oggi.
NOTE
1) “La città invisibile” di Giuseppe Tandoi, 2010.
2) Marco Romagna, “Re Granchio” (2021), in www.cinelapsus.com, 29/11/2021.
3) Paola Casella, “Un film miracoloso dove il classico viaggio dell’eroina è fatto di carne viva, dolore e di un’oscurità di straziante bellezza”, in www.mymovies.it, 10/07/2021.
4) Raffaele Meale, “Piccolo corpo”, in www.quinlan.it, 07/10/2021.
5) Roberto Manassero, “Il legionario”, in “FilmTv”, anno 30, n. 8, 22/02/2022, p. 23.
6) Silvio Grasselli, “Hleb Papou, per un cinema dello scontro”, in www.ilmanifesto.it, 31/07/2021.
7) Ilaria Feole, “Una femmina”, in “FilmTv”, anno 30, n. 7, 15/02/2022, p. 33.
8) Teresa Vena, “Francesco Costabile – Regista di “Una femmina”, in www.cineuropa.org, 17/02/2022.
9) Citiamo dalle note di regia inserite nel pressbook del film.
DALLA REALTÀ AL PENSIERO: PASOLINI DOCUMENTARISTA
di Danilo Amione
“La rabbia”, di Pier Paolo Pasolini e Giovanni Guareschi, Italia, 1963.
“La rabbia” è il primo film documentario di Pier Paolo Pasolini. Esso è suddiviso in due parti, distinte e contrapposte, dirette l’una dall’artista friulano, l’altra dal giornalista e scrittore emiliano Giovanni Guareschi, noto, universalmente, come l’autore del romanzo “Don Camillo”, da cui l’omonimo e celebre film del francese Duvivier. Entrambi gli episodi del film sono stati realizzati con un montaggio di filmati storici, dai cinegiornali fino a diversi documentari provenienti da ogni parte del mondo. Ovviamente, l’idea del produttore Gastone Ferranti era quella di contrapporre il punto di vista, sulla realtà dell’epoca, di Pasolini (notoriamente di sinistra) a quello di Guareschi (notoriamente di destra).
Ne venne fuori un film anomalo, e non soltanto per il panorama cinematografico di allora, che ebbe esiti disastrosi al botteghino, al punto da essere ritirato dalla distribuzione nel giro di pochi giorni. Perché ancora oggi questo film fa discutere la critica, tale da diventare, spesso, oggetto di polemica non soltanto cinematografica? Visionato il film, appena montato, Pasolini si accorse di essere caduto dentro una brutta trappola. Avallare con il suo contributo la circolazione delle idee di Guareschi, che avevano prodotto quello che lo stesso poeta definì “Non solo un film qualunquista o conservatore, o reazionario. È peggio. (…) C’è tutto: il razzismo, il pericolo giallo, e il tipico procedimento degli oratori fascisti, l’accumulo di dati di fatto indimostrabili”. E Pasolini cosa raccontò, invece, nel suo episodio? Reduce dalla trilogia del sottoproletariato, l’autore di “Accattone” ribadì i temi fondamentali della sua poetica di sempre. Partendo dalla domanda: ”Perché la nostra vita è dominata dalla scontentezza, dall’angoscia, dalla paura della guerra, dalla guerra?”, il regista mise in contrapposizione cinegiornali e documentari reazionari con altri da lui montati in maniera tale da opporli ai primi in quanto a temi e contenuti. I commenti alle immagini da lui selezionate furono recitati per la parte poetica da Giorgio Bassani e per la parte in prosa da Renato Guttuso. L’anima del suo episodio è così concentrata nel parallelismo tra ciò che l’Occidente è (ed era) e ciò che lui avrebbe voluto fosse. In questo contesto, egli inserisce la critica contro la gioventù falso moderna e iperconsumista (in anticipazione di quella che sarebbe stata la sua iconoclastica polemica contro il ’68), e la difesa della tradizione e della società “vera” dei padri, esaltata dalle immagini degli operai e contadini sovietici, che conservavano, per lui, ancora quell’innocenza dalla nostra parte del mondo oramai perduta. Non dimenticando, inoltre, di inserire le lotte di liberazione terzomondiste (viste come l’avanguardia di una necessaria emancipazione globale degli oppressi), come pure l’attacco al veterocomunismo monolitico dell’oligarchia russa e all’imborghesimento del Partito comunista italiano (che gli costò l’ennesimo ostracismo da parte di tutta la sinistra politica italiana). Spaziando anche oltre oceano, come nel poetico ritratto di Marilyn Monroe (quasi a volere coreografare la sua celebre e stupenda poesia a lei dedicata, “Marilyn”), scomparsa tragicamente l’anno prima, ed elevata a simbolo di una innocenza primordiale perduta per mano di un potere massificante e spersonalizzante. Ma ancora più incisivo si fa il dire di Pasolini quando, inserendo immagini di Gagarin e della sua prima conquista dello spazio, egli ci regala una prospettiva metastorica, fatta di una speranza di cambiamento per l’uomo che non passi soltanto attraverso i mutamenti politico-sociali ma soprattutto attraverso un nuovo sguardo culturale dell’uomo sull’uomo, cristiano e capace di superare per sempre l’altrimenti inevitabile lotta di classe imposta dalla Storia. E come non citare, a questo punto, anche l’uso sapiente, e talvolta commovente, che egli fa di immagini di Giovanni XXIII, il Papa contadino, che nel suo volto antico e buono racchiudeva tutto il senso dell’anelito pasoliniano verso un passato da conservare e di cui fare tesoro, pena l’annullamento dell’Umanità stessa. Insomma, anche questo breve film di Pasolini si distingue per originalità poetica e profonda partecipazione politica, le due anime che hanno contraddistinto l’intera opera dell’immenso autore de “Le ceneri di Gramsci”.
“Comizi d’amore”, di Pier Paolo Pasolini, Italia, 1964.
Con Alberto Moravia, Cesare Musatti, Giuseppe Ungaretti, Oriana Fallaci.
In questo film-inchiesta sul tema della sessualità in Italia, argomento ancora tabù per l’epoca, Pasolini si conferma polemista illuminista. Il suo intento è quello di disvelare quanto di falso c’è dietro la presunta emancipazione sessuale degli italiani negli anni del boom.
E lo fa muovendosi per tutta la Penisola, da Palermo a Milano, passando per Crotone, Napoli, Roma, Firenze, Viareggio, Bologna e Venezia, intervistando giovani, anziani, intellettuali, operai, contadini, studenti, commercianti. Pasolini usa un tono semiserio, e a tratti scanzonato, proponendo domande semplici ma spiazzanti e, a volte, per qualcuno anche imbarazzanti. La prima volta, il matrimonio, il divorzio, l’omosessualità, sono tutti temi che al nostro cinema erano ancora sconosciuti, o peggio tabù, e che costarono all’opera anche una distribuzione nelle sale vietata ai minori di 18 anni. E’ sulle risposte date alle sue domande da questa folta platea di “protagonisti” che Pasolini veicola il suo pensiero sul nostro Paese. Le intellettuali femministe Camilla Cederna ed Oriana Fallaci sono facilmente dispensatrici di nuove verità sul ritardo della liberazione sessuale delle donne italiane, entrambe un po’ lontane da una realtà più composita e meno scontata. Infatti, la nuova borghesia neocapitalista e consumista, soprattutto settentrionale, risponde alle domande dell’intellettuale friulano legandosi ad una emancipazione vissuta come semplice necessità di omologazione, e portata avanti anche per luoghi comuni, mentre il mantenimento di antiche abitudini e tradizioni caratterizza le risposte, anche impacciate ma sempre vere e autentiche, dei meno abbienti, soprattutto del Meridione. Dunque, quella sincerità, spontaneità e istintività del “popolo semplice”, tanto caro al regista, emerge inevitabilmente, a conferma di una frattura sociale ed ideologica tra le classi sociali che soltanto pochi anni dopo sarà ricomposta nel nome di una omologazione oramai irrefrenabile. Non sfugge a Pasolini anche l’importanza del dato estetico del suo film, con le facce dei contadini, arcaiche e scavate dalla fatica, contrapposte ai visi strafottenti e sicuri dei giovani studenti piccolo borghesi della grande città. Gli interventi di intellettuali come Alberto Moravia e Giuseppe Ungaretti o di studiosi come lo psicanalista Cesare Musatti sono corollari importanti di una ricerca antropologica accurata e mirata, strettamente legata alle tematiche di sempre di Pasolini, che attraverso l’uso dell’immagine riesce a coniugare al meglio, per l’ennesima volta, narrazione, talvolta anche poetica, e analisi sociale.
“Sopralluoghi in Palestina”, di Pier Paolo Pasolini, Italia, 1965.
Con la partecipazione di Don Andrea Carraro.
Il documentario nasce in occasione del viaggio compiuto da Pasolini in Terra Santa, tra il giugno e il luglio del 1963, alla ricerca dei luoghi che sarebbero serviti come set per il suo “Vangelo secondo Matteo”.
Ad accompagnare Pasolini fu Don Andrea Carraro della Pro Civitate Christiana. Entrambi commentano, dialogando anche tra di loro, i siti che la cinepresa riprende sul momento. Già dai dintorni di Tel Aviv, Pasolini si accorge degli ormai irrevocabili segni della modernità della nuova Israele neocapitalistica, arrivata ad inficiare, con le sue industrie, anche i paesaggi arcaici che caratterizzavano quelle zone. Kibbuz, capannoni e palazzi fanno dire a Pasolini che tutto è così lontano dall’antica Nazareth. Ma non solo i panorami ed i paesaggi sono oggetto di delusione del cineasta friulano, anche l’abbigliamento e i volti delle genti che le abitano. Tutto ha acquisito le forme di una contemporaneità che ha lasciato ben poco a cui appigliarsi per una eventuale ricerca filologica necessaria al suo film da fare. Proprio nel mentre di queste sue delusioni, e nonostante esse, Pasolini accenna a Don Andrea di quanto siano sconvolgenti i panorami che stanno visitando, nelle loro prospettive orizzontali e nelle linee improvvise disegnate dalle montagne di fronte alle quali ci si sente inermi e annullati. Insomma, Pasolini non ha trovato nulla che lo potesse aiutare a girare lì il film, ma ha avuto una folgorazione estetica, che egli vorrà cercare altrove ancora intatta e priva di quelle impurità ed inestetismi. Il poeta e Don Andrea si sposteranno ancora verso Betlemme e Gerusalemme, e le impressioni ricavate saranno sempre quelle di una magia oramai contaminata e da ritrovare altrove, in luoghi che hanno mantenuto pienamente la loro arcaicità. E già durante il viaggio, Pasolini accenna a certi luoghi della Calabria, della Sicilia, della Basilicata e della Puglia come possibili “surrogati” a ciò che di straordinario e di inarrivabile egli stava vedendo. Saranno proprio questi posti a fare da set al suo capolavoro cristologico che si appresta a girare. In particolare, Matera sarà il punto di riferimento estetico di Pasolini, che troverà in essa quella magia oramai inutilizzabile della Palestina da lui vissuta e registrata in questo splendido diario di lavoro.
Un poema sul Terzo Mondo: prima parte.
“Appunti per un film sull’India”, di Pier Paolo Pasolini, Italia, 1968.
Gli anni Sessanta sono gli anni delle guerre di liberazione del Terzo Mondo dall’Occidente colonialista e Pasolini ha in mente di realizzare un progetto articolato che comprenda più episodi legati a cinque aree del mondo (Paesi Arabi, Africa, India, Sudamerica, ghetti del Nord America) in cui le contraddizioni della Storia e della contemporaneità sono più forti ed evidenti.
Programmaticamente, lo intitola “Appunti per un poema sul Terzo Mondo”. Realizzerà solo due episodi di questa potenziale pentalogia, uno dedicato all’India ed uno all’Africa. Il film sull’India non sarà di facile realizzazione a causa della difficoltà di reperire risorse finanziare adeguate. La buona occasione arriva grazie alla Rai, che propone a Pasolini di girare uno speciale per il settimanale TV7 dedicato appunto all’India, una sorta di aggiornamento del grande lavoro fatto in quel paese, sempre per la Rai, alcuni anni prima da Roberto Rossellini. Nasce così “Appunti per un film sull’India”, una sorta di block-notes per un film da fare, con una impostazione diaristica stile “Sopralluoghi in Palestina”. Pasolini darà al suo lavoro la forma ultima di un documentario poetico sulle tante contraddizioni di un paese approdato da poco alla libertà e alla democrazia. Il tutto partendo dall’idea originale, ribadita dall’artista nel prologo, di fare un film su “un film sull’India”. I temi affrontati saranno quelli della religione e della fame. L’approdo in India consente a Pasolini di muoversi in un ambito sociale e culturale ancora arcaico, un mondo da lui anelato e cantato in contrapposizione alla modernità destruens dell’Occidente consumista e materialista da lui aborrita. Per mettere in campo il suo pensiero su questo vasto Paese ancora tutto da scoprire, egli si muove più su un piano estetico che sociologico o politico. Pasolini deve verificare in loco la possibilità di realizzare il suo futuro film sull’India, avente come soggetto la storia di un maharajah che, nell’India pre-indipendenza, offre il proprio corpo per salvare dei cuccioli di tigre che stanno morendo di fame, come una usanza arcaica imponeva. Così, egli chiede a diverse persone se sarebbero disposte a donare il proprio corpo per salvare dei tigrotti dalla morte per fame. Un maharajah della Bombay contemporanea gli risponde che questo gesto oggi non sarebbe più possibile. Il film continua con il racconto dell’antico maharajah che si dà la morte per salvare i cuccioli della tigre, e con la sua famiglia che si estingue perché priva di ogni sostentamento. Qui finisce la prima parte del film da fare, quella sulla Preistoria dell’India, afferma Pasolini. La seconda parte sarà dedicata all’India moderna, ai suoi grandi problemi come le caste, la fame e la sterilizzazione, e, soprattutto, al suo modo di porsi dinnanzi alla modernizzazione, sinonimo di industrializzazione, senza perdere la sua identità. L’occhio del poeta cineasta, intanto, sembra incantato dai volti incontrati e dai luoghi attraversati, dal suo amore per i reietti e gli intoccabili, per gli abitanti degli antichi villaggi dell’interno, per l’arcaicità del mondo rurale. Sta, dunque, in queste immagini il meglio di questo “film su un film da fare”, che significativamente si chiude con una frase detta dallo stesso Pasolini: ”Un occidentale che va in India ha tutto, ma non dà niente. L’India, invece, che non ha nulla, in realtà dà tutto. Ma cosa?”. La risposta sta a noi occidentali. Di sicuro, il timore più grande del poeta friulano era quello della scomparsa di uno degli ultimi mondi umani allora ancora intatti.
Un poema sul Terzo Mondo: seconda parte.
Appunti per un’Orestiade africana, di Pier Paolo Pasolini, Italia, 1970-1973.
Questo documentario nasce da un viaggio di Pasolini in Uganda e Tanzania, dove il poeta si era recato per cercare ispirazione per il suo progetto di un film sull’Orestiade di Eschilo ambientato nell’Africa di oggi. Si ripete, dunque, l’impostazione formale del documentario precedente sull’India, “un film su un film da farsi”. Anche quest’opera si compone di una prima parte “arcaica” e di una seconda “contemporanea”. Nella prima, Pasolini si muove alla ricerca di luoghi e volti che diventeranno i protagonisti del dramma di Eschilo, ambientato in un villaggio africano, dove l’azione di Oreste si intreccerà a quella di tutti gli altri protagonisti della tragedia. Lo sguardo di Pasolini si sofferma sull’essenza preistorica dell’Africa nera, rimasta intatta fino ad allora, e che egli cattura con l’occhio predatore di chi sa di avere dinnanzi le ultime forme di quell’umano che altrove è in via di estinzione.
A legare questa prima parte alla seconda, la contemporanea, è l’intervento in commento voice over dello stesso Pasolini, il quale afferma di non volere trascurare di inserire nel film anche la parte moderna dell’Africa, quella delle fabbriche e delle scuole. A questo punto, l’azione si sposta a Roma, dove Pasolini incontra alcuni studenti universitari africani, ai quali racconta della sua intenzione di realizzare un film tratto dall’Orestiade, e ai quali chiede, chiedendosi anche, se questo debba essere ambientato nel 1970 o, invece, nel 1960, quando un gran numero di paesi africani conquistò la propria indipendenza. Intendendo porre con questa domanda il quesito sulla giusta evoluzione o meno del processo democratico in quel Continente. Sottotraccia, la vera questione posta da Pasolini ai giovani africani di oggi riguarda la possibilità che il loro Continente venga inesorabilmente occidentalizzato. Uno studente avanza l’ipotesi che le due anime africane, l’antica e la moderna, saranno in grado di convivere perché la prima sarà sempre legata alla sfera delle emozioni, che, per sua natura, si opporrà, inevitabilmente, alla piena razionalità. La voce fuori campo di Pasolini lascia intendere che ogni conclusione è sospesa, forse in attesa delle decisioni della Storia.
“12 dicembre”, ideazione di Pier Paolo Pasolini, regia di Giovanni Bonfanti, Italia, 1972.
Il film è un’opera collettiva, che trova in Pasolini l’ideatore del soggetto e l’autore di alcune riprese. Secondo la testimonianza del regista e saggista Maurizio Ponzi, le sequenze opera di Pasolini sono, certamente, quelle girate a Carrara, Sarzana, Reggio Calabria e alla “Bussola” di Viareggio. Il documentario è incentrato, come recita il titolo, sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Diretto dall’allora direttore responsabile del giornale Lotta Continua, Giovanni Bonfanti, il film è ricco di testimonianze e narrazioni ancora molto vive e pregnanti, essendo passati soltanto tre anni dal tragico episodio milanese. Pasolini, seppur occupato nel suo progetto sui “Racconti di Canterbury”, fu molto coinvolto nella realizzazione di questo lavoro. A Sarzana, egli intervistò un gruppo di ex partigiani che avrebbero voluto farsi giustizia da soli, sentendosi traditi da uno Stato che loro stessi avevano contribuito ad edificare. A Carrara, Pasolini incontrò gli operai delle cave di marmo intervistandoli a proposito delle numerose “morti bianche”, in montaggio parallelo con le immagini delle tombe delle vittime.
A Reggio Calabria, Pasolini arriva nel periodo in cui gli scontri per l’elezione della città a capoluogo regionale erano al culmine, investendo anche i gruppi dell’estrema sinistra rivoluzionaria. Egli riprende la formazione delle barricate, l’arrivo della polizia, le barricate in fumo, la guerriglia urbana contro le forze dell’ordine, e realizza anche alcune interviste sulla questione di “Reggio capoluogo”. Sono molti i critici e gli studiosi che hanno riconosciuto l’occhio di Pasolini, a conferma di una ricerca estetica molto forte anche quando l’impegno politico e di testimonianza sembrava dovesse prevalere su tutto.
“Le mura di Sana’a”, di Pier Paolo Pasolini, Italia, 1974.
Si tratta di un cortometraggio documentario di eccezionale bellezza, realizzato da Pasolini alla fine delle riprese de “Il fiore delle mille e una notte”, nella città di Sana’a, capitale dello Yemen del Nord. Perché il regista sente la necessità di girare questo piccolo film? Lo spiega lui stesso in un suo scritto sul “Corriere della sera”: “…i problemi di Sana’a li sentivo come problemi miei. La deturpazione che come una lebbra la sta invadendo, mi feriva con un dolore, una rabbia, un senso di impotenza e nel tempo stesso un febbrile desiderio di far qualcosa, da cui sono stato perentoriamente costretto a filmare”. Pasolini alla fine del film lancia un appello all’Unesco per la salvezza della città medievale yemenita, le cui mura erano già andate inesorabilmente distrutte per l’incuria dell’uomo. Il suo grido di dolore per immagini diventa un ammonimento al mondo intero perché ciò che la civiltà industriale e consumistica sta distruggendo venga preservato, in nome di una memoria che non può essere cancellata, pena la disumanizzazione e l’annientamento di ogni valore degno di questo nome. Ciò che più fa riflettere di questo film è la pietas che muove il regista, che con la sua cinepresa sembra accarezzare ogni edificio di questa incantevole e fantasmatica città, che sembra uscita da una di quelle millenarie fiabe orientali che hanno arricchito la nostra fantasia infantile.
Il commento accorato di Pasolini lo ascoltiamo sopra le sue lente panoramiche su pietre che sovrapposte l’una sull’altra diventano palazzi già nati monumenti. La sospensione delle sue parole diventa religioso silenzio capace di allargare a dismisura ogni inquadratura che egli ci regala, lasciandoci basiti dinnanzi a tanta bellezza. L’appello di Pasolini fu infine accolto e, nel 1986, per le sue rare e preziose peculiarità artistiche, la città vecchia di Sana’a fu dichiarata patrimonio dell’umanità.
“Pasolini e… la forma della città”, di Paolo Brunatto, Rai Tv, 1974.
Con Pier Paolo Pasolini e Ninetto Davoli.
All’interno di un programma storico della Rai anni ’70, “Io e…”, inventato dal grande Luciano Emmer, Pasolini sceglie di raccontare due città italiane, e laziali in particolare, che sente a lui vicine, Orte e Sabaudia. La prima è una città medievale che l’artista friulano evoca allo spettatore televisivo in compagnia di uno dei suoi attori feticcio, Ninetto Davoli. Nello stesso anno era già andato sugli schermi, “Le mura di Sana’a”, il suo film in forma di appello all’Unesco per la città medievale nord-yemenita del titolo, e la sua scelta di Orte per il programma Rai non fu certamente casuale. Come a dare un seguito a quel suo splendido cortometraggio, Pasolini ritorna sull’argomento a lui caro della salvaguardia dei beni materiali, e lo fa a beneficio di un’altra città medievale, Orte per l’appunto, per lui a forte rischio di degrado. Basti pensare all’incipit del documentario, quando egli allarga l’inquadratura della panoramica della città e fa notare a Ninetto Davoli e a noi telespettatori come la prospettiva originaria di Orte sia già compromessa dalla presenza di palazzi di nuova fattura. Oppure, come non citare la sequenza in cui il regista friulano si muove con Ninetto Davoli sull’acciottolato rurale della città, ricordandone il grande valore simbolico di luogo vissuto da contadini che vi hanno speso sopra la loro vita, e che non può scomparire senza compromettere la memoria di ciò che è stato. Per Pasolini la perdita del passato implica un vuoto di conoscenza e consapevolezza pericoloso per la sopravvivenza stessa del concetto stesso di umanità.
La città di Sabaudia, invece, venne scelta da Pasolini perché in essa il poeta friulano vedeva, come spiega egli stesso nel programma Tv, un grande esempio di sviluppo armonioso di una comunità umana, e questo nonostante la città fosse stata eretta per volere del regime fascista. Pasolini afferma come nessun regime avrebbe mai potuto scalfire ciò che di naturalmente umano c’era all’interno di ogni gruppo sociale. E tutto questo si disvela, appunto, in questa armonia di convivenza civile dal sapore antico che si era prepotentemente sovrapposta alle spigolosità dell’architettura razionalista, umanizzando, alla fine, anche questa.
NIGHTMARE – IL RITORNO DELLA NOTTE
di Roberto Lasagna
L’ispirazione del personaggio di Freddy Krueger viene al regista Wes Craven da diverse fonti riconducibili alla sua infanzia, a cominciare al compagno di scuola che, durante il comune compito della consegna dei giornali, lo rese vittima di bullismo. Questa ispirazione fu già presente ne L’ultima a casa a sinistra, dove il cattivo venne chiamato Krug, ma in Nightmare – Dal profondo della notte (A Nightmare on Elm Street, 1984) il bullo viene addobbato alla festa dell’horror con vestiti e cappello sporchi somiglianti a quelli di un vagabondo sinistro che scrutò il giovane regista dalla finestra all’età di dieci anni.
Le trattative per realizzare Nightmare – Dal profondo della notte si protraggono per anni, ma quando finalmente iniziano le riprese Craven ha idee chiare e porta a compimento la realizzazione del lungometraggio in appena un mese e con un budget, sotto la media, di un milione e ottocentomila dollari (che il film recupererà nel solo week-end di apertura).
Immaginando l’Ohio attraverso la villetta posta al 1428 di Elm Steet – che in realtà si trova a Los Angeles, al 1428 di North Genesee Avenue – Craven architetta scenografie sospese nel terrore, dove il confine tra sogno e realtà è perennemente sotto scacco, sia per la giovane protagonista Nancy (Heather Langekamp), sia per lo spettatore a cui Craven dedica un viaggio in cui la percezione si confronta con la minacciosa presenza rappresentata dall’oscuro protagonista di incubi virali e collettivi.
Sin dalle prime immagini ci troviamo in un contesto realistico dalle tinte infernali, con la giovane Tina (Amanda Wyss) perseguitata dal serial killer; costui appare come un essere ustionato e pronto ad automutilarsi per incutere disgusto e lasciar intendere come nulla possa frenare la sua fame di crudeltà. Il mostro cerca di uccidere Tina, ma la ragazza se la cava con qualche taglio. Però è fuori di sé, e il giorno dopo si confida con gli amici, Nancy e Glen (un giovanissimo Johnny Depp) e con il fidanzato Rod (Jsu Garcia). Tutti sembrano minimizzare l’importanza dell’accaduto, perché un incubo non può fare troppo male, ma gli amici decidono comunque di starle vicino, di farle compagnia per la notte. Tuttavia saranno presto testimoni di un evento sconcertante e inspiegabile, la morte orrenda di Tina per mano di una spaventosa presenza invisibile che la lancia in aria, la fa fluttuare e la percuote dilaniandola e facendone a pezzi il corpo. Lo scempio convince i giovani di essere tutti in pericolo e perseguitati da Freddy Krueger, il maniaco che infesta i loro sogni e dietro alle cui raccapriccianti sembianze sembra conservarsi la figura di un maniaco infanticida che, come confesserà la mamma di Nancy alla figlia, dopo aver ucciso tanti bambini venne linciato da un gruppo di genitori mentre sembra essere tornato dall’infermo per continuare le sue gesta sanguinarie fuoriuscendo dalla dimensione onirica. L’inconscio del singolo adolescente diventa il luogo della possessione in cui l’orrendo Freddy può, con la violenza e l’orrore, deturpare la psiche e riaffacciarsi sul mondo dei corpi.
Tra i film di Craven, Nightmare – Dal profondo della notte scatena una mutazione dei codici del cinema horror introducendo un’ibridazione linguistica nuova e disposta a carburare autoalimentadosi, a vivere di citazioni e di assimilazioni, producendosi come una summa dello slasher che assume qui una connotazione sovrannaturale e metafisica, e portando a compimento quell’apoteosi del massacro che ha avuto tra i suoi anticipatori Mario Bava sin dagli anni Settanta (con titoli come Reazione a Catena del 1971), ma che anche il Tobe Hooper di Non Aprite quella porta (1974) e soprattutto Halloween – La notte delle streghe (Halloween, 1978), caposaldo che diede un grande successo al filone disegnandone le caratteristiche portanti. La maschera dell’uomo senza volto viene qui raccolta da Freddy Kruger il quale, dopo essere stato uno sterminatore di bambini, sceglie come sue prede per l’immaginario adolescenziale e post- adolescenziale attraversato dal film, giovani ragazze sulla strada del desiderio, apparendo come una figura sadica pronta a comparire non appena le pulsioni trovano espressione (e in una sequenza celebre vediamo le lame di Freddy emergere sinistramente dall’acqua della vasca da bagno in cui è immerso il corpo nudo di Nancy). L’Uomo nero, archetipo infantile della paura, si veste dunque da spauracchio per gli adolescenti che vedono al cinema e in TV gli horror di cui, nel futuro Scream (id. 1996), si citeranno a memoria le sequenze. E questa figura sadica di persecutore è, appunto, l’abitante di un mondo di sogni pronto a diventare una figura seriale, che sarà arduo e improbabile vedere definitivamente debellato. Se un tempo egli fu mortale, in Nightmare – Dal profondo della notte appare evidente che lui non lo è più da tempo, abitando una dimensione spettrale, e anche questo è un aspetto singolare del lavoro di Craven, che declina in chiave strettamente horror un’attitudine che il suo cinema precedente collocava tra note da thriller, per quanto attraversato dai tratti cruenti, lasciando ferite e sfoderando una furia omicida annegata in dettagli di squartamenti e varie mutilazioni.
Freddy, che nel film fa paura lasciando soltanto trapelare tratti grotteschi che faranno del personaggio un popolare archetipo della paura, nella sua singolare dimensione onirica e per il fatto stesso di popolare i sogni di più individui, si professa come figura che trova appigli nel passato, tra le raffigurazioni che sin dalla classicità abitano il mondo onirico e trovano espressione nelle civiltà antiche, tra le dottrine buddiste o tra le arcaiche lingue scandinave, sino a quella dimensione dell’incubo che presenta persino una celebre rappresentazione pittorica nel quadro Incubo di Henry Fuseli. Questa dimensione arcaica e archetipica si coniuga con la volontà di bagnare il thriller di atmosfere che la logica ordinaria non governa, e, nel guardare a molteplici modelli e meccanismi di seduzione per lo spettatore, Craven struttura un racconto che sovverte di continuo i quadri di riferimento, dandosi come opera post-moderna che chiama a rapporto la commistione dei linguaggi (e finanche delle barriere che delimitano gli orizzonti esperienziali permettendo di definirli come reali oppure onirici) coniugando e avvicinando riferimenti e consuetudini espressive alte e basse.
In questa estetica post-moderna sapientemente rappresentata dal film, Freddy Krueger è la maschera in grado di raccogliere eredità arcane ed elitarie ma al contempo di propendere per quella popolarità che presto farà di lui un paladino del pop-horror. Se a tratti l’estetica del film sembra obbedire al disegno di un’operazione di commistione interdisciplinare, scolastica seppure innovativa, occorre sottolineare che il film vive di una sua freschezza, di una sua virulenza che lo eleva tra i film dall’impatto visceralmente disturbante del filone slasher, essendone anche un caposaldo teorico.
Il thriller e l’horror trovano un terreno di proficua congiunzione in quello che rimane uno dei titoli più significativi dell’estetica horror anni Ottanta, disposta a permeare i gusti privilegiati degli spettatori con un tipo di cinema che Craven confeziona per post-adolescenti còlti in una fase di passaggio dell’esistenza; soprattutto per loro, angosce, paure e pulsioni assumono un aspetto inquietante, e si manifestano proprio quando il controllo cosciente viene meno. Quando Nancy si ritrova a scuola a cade nel sonno, la ragazza nel corridoio porta sugli abiti i colori con cui abbiamo conosciuto Freddy Krueger, indizio di una presenza onirica e demoniaca che attende Nancy. Krueger è dunque già lì, abita la scena e i meandri della rappresentazione, e nella realtà divenuta sogno i colori sono quelli della tessitura paranoide che lascia tracce ed è governata dal corpo potenzialmente proteiforme del mostro. Questi è una figura in stato di perenne deformazione, mutante che nei sequel accentuerà le trasformazioni, ma che qui intensifica il senso di una minaccia che invade la psiche e fa (anche) della sessualità una fonte di pericolo, coerentemente con la scoperta delle pulsioni vissute dall’età dei giovani protagonisti. Nancy e Tina sono adolescenti desiderate dai coetanei ma abituate a rapporti problematici con i genitori, tanto che la madre alcolista e il padre poliziotto di Nancy si ergono a paladini dell’incomprensione quando non addirittura della mancanza di fiducia, mentre Tina è trascurata dalla madre la quale invece si dedica all’amante, mentre del padre non c’è traccia essendosi egli dato a gambe levate qualche anno prima. Nancy, diversamente da Tina, è però spaventata dal rapporto sessuale con il fidanzato, e il suo bagno ristoratore nella vasca da bagno lascerà scorgere le lame persecutorie (della colpa?) proprio dal basso delle sue gambe, mentre la morte di Tina, il suo squartamento da parte di Freddy che la farà volteggiare sul soffitto della sua stanza tra lacerazioni profonde e urla senza sosta, farà rammentare le inquietanti contorsioni di uno stupro selvaggio. La violenza si scatena seguendo le conseguenze di colpe che dalle debolezze e dagli errori degli adulti finiscono per gravare sui figli, adolescenti malati di indifferenza subita, inascoltati dai grandi (e i genitori di Glen mandano a morte il figlio proprio evitando di passargli la fidanzata al telefono), portatori di un malessere che Krueger incarna come voce di una coscienza malata. Lui stesso, nella sua emanazione paranormale, è il frutto di un gesto di vendetta di un gruppo di genitori che decisero di annientarlo sbarazzandosi del suo corpo, in quanto assassino di bambini lasciato libero dalla legge a causa di un vizio di forma durante un processo.
Dei grandi, dunque, c’è ben poco da fidarsi, e lo stesso padre di Nancy la inganna quando la insegue per catturare il sospettato omicida, e non crede alla figlia, dando voce, nel confronto con Nancy, ad uno scontro in cui la generazione della ragazza dovrà a tutti i costi uscirne a testa alta. Nancy, interpretata dalla ventunenne Heather Langekamp che nel film assolve il ruolo di una quindicenne, è la ragazza della porta accanto affidabile che si confronta con il sonno della ragione, e per questo tenta di tenere a bada il suo stesso sonno, quando persino le pareti della sua abitazione cedono come teli di un quadro deformato dalle spinte di Freddy, mentre il mostro non è soltanto una presenta ectoplasmatica ma lascia persino in dono il suo cappellaccio a Nancy.
Lo spettro lascia tracce con sinistro autocompiacimento, come quando i colori dei suoi abiti si posano su quelli di una compagna di scuola di Nancy, e a questo proposito Craven ci spaventa più volte facendoci saltare sulla sedia, unendo toni comici e forza sadica, per lasciar voce a una creatura infernale che prende il posto di padri immancabilmente assenti. E i genitori in Nightmare – Dal profondo della notte sono i veri individui problematici, che non sanno ascoltare i figli e tantomeno intendono ergersi a modello condivisibile, ma che con il loro negazionismo diventano pericolosi perché non vedono concretamente le faccende che riguardano la nuova generazione. Più spesso, questi genitori perseguitati dalla colpa si affidano all’alcool per tornare protettivi con i figli, e tra le colpe ci sono anche quelle diffuse tra le ombre del disagio collettivo, con Elm Street che si ricorda anche come il luogo in cui, il 22 novembre del 1963, fu assassinato John Fitgerald Kennedy. La comunità pacifica vive allora nel film i tagli e le lacerazioni dedicati a un angolo di provincia solo apparentemente protetto e sereno, e con stile diretto e cangiante Craven propone una ricostruzione d’ambienti teatro di una verità che un film come Nightmare – Dal profondo della notte, labirinto post-moderno della mente, intende mostrare con inventiva e shock visivi, affidandosi a situazioni che faranno scuola, come le pareti di casa piegate dalle pressioni del Male o i gradini appiccicosi che rallentano la corsa di Nancy in fuga dal carnefice.
Craven scrive di suo pugno la filastrocca con cui prende avvio e su cui si chiude il film, in un’illusoria progressione che ha invece il sapore della circolarità: “L’uomo nero non è morto, ha gli artigli come un corvo, fa paura la sua voce, prendi subito la croce. Apri gli occhi, resta sveglio, non dormire questa notte”.
MARLENE DUMAS, PIER PAOLO PASOLINI: INCROCI
di Maurizio Villani
«È stato il film a insegnarmi le regole dell’immaginazione, non la realtà, né la pittura».
Marlene Dumas
Molteplici sono le forme attraverso le quali espressioni di arti diverse interagiscono fra di loro o attraverso l’influenza degli stilemi formali o attraverso la convergenza di elementi contenutistici. Il caso che ci proponiamo di esaminare presenta un incrocio di entrambe queste modalità e vede coinvolti la pittura di Marlene Dumas e il cinema di Pierpaolo Pasolini. A proporre questo rapporto sono due mostre aperte in Italia e dedicate alla pittura di Marlene Dumas: la personale ospitata alla Fondazione Stelline di Milano nel 2012 e la mostra intitolata “open-end”, in corso a Palazzo Grassi di Venezia fino all’8 gennaio 2023.
Marlene Dumas nasce nel 1953 a Cape Town, in Sud Africa, dove cresce e studia belle arti durante il regime dell’apartheid. Nel 1976 si trasferisce in Europa per proseguire gli studi e si stabilisce ad Amsterdam, dove ancora oggi vive e lavora. Nei primi anni della sua carriera è conosciuta per i suoi collage, poi buona parte della sua produzione è costituita da ritratti che rappresentano la sofferenza, l’estasi, la paura, la disperazione.
Il suo lavoro è stato inserito nella tradizione dell’Espressionismo e paragonato a quello di Edvard Munch, Emil Nolde e Francis Bacon. A causa della sua visione ironica e consapevole della produzione e della ricezione dell’arte, la sua pittura è stato anche considerata come una forma di neo-concettualismo.
I temi ricorrenti nelle opere della Dumas sono l’amore e la morte, le questioni di genere e razziali, l’innocenza e la colpa, la violenza e la tenerezza. Le affinità con la figura di Pier Paolo Pasolini si giustificano alla luce di queste tematiche, ritrovabili sia nella produzione filmica del regista italiano, sia nella sua tormentata esperienza esistenziale. L’attenzione che la pittrice sudafricana ha rivolto al mondo pasoliniano si è espressa nei ritratti di Pasolini e della madre Susanna Maria Colussi Pasolini e alla riproduzione di immagini di interpreti di alcuni suoi film, segnatamente “Mamma Roma” e “Il Vangelo secondo Matteo”. La curatrice della mostra di Palazzo Grassi Caroline Bourgeois sintetizza con questo giudizio il rapporto dialettico di affinità e differenze tra i due artisti: «Pasolini ha osato indagare le tante e diverse derive umane. Allo stesso modo Marlene Dumas osa molto nel suo lavoro, sia nei soggetti che dipinge, sia nella tecnica e nella materia pittorica che predilige».
La Dumas raffigurò in disegni e in dipinti ad olio Pasolini (1922-1975) a partire dagli anni Ottanta, includendolo in varie serie di composizioni. Questo ritratto, coevo a quello della madre, fu dipinto nel 2012 per la Mostra di Milano intitolata Sorte (da intendersi nel significato di “scritto nelle stelle”). L’autrice in quell’occasione scrisse che l’attraeva in Pasolini «il suo sensuale uso della luce e del buio, l’”irrealismo” narrativo dei suoi film. Il modo in cui i suoi personaggi appaiono e scompaiono. Il fatto che non si fida di se stesso».
La madre di Pasolini, anch’essa ritratta nel 2012, fu maestra elementare con la passione per la lettura che trasmise al figlio. Rappresentò una figura fondamentale nella vita di Pier Paolo, da lui amata profondamente, ricordata in diversi componimenti poetici, il più celebre dei quali è Supplica a mia madre (1962), in cui si trovano questi versi: Tu sei la sola al mondo che sa, del / mio cuore, ciò che è stato sempre, / prima d’ogni altro amore. / Sei insostituibile. Per questo è / dannata alla solitudine la vita che mi / hai data.
Pasolini volle la madre come attrice, nel ruolo della Madonna in “Il Vangelo secondo Matteo” (1964), e in “Teorema” (1968).
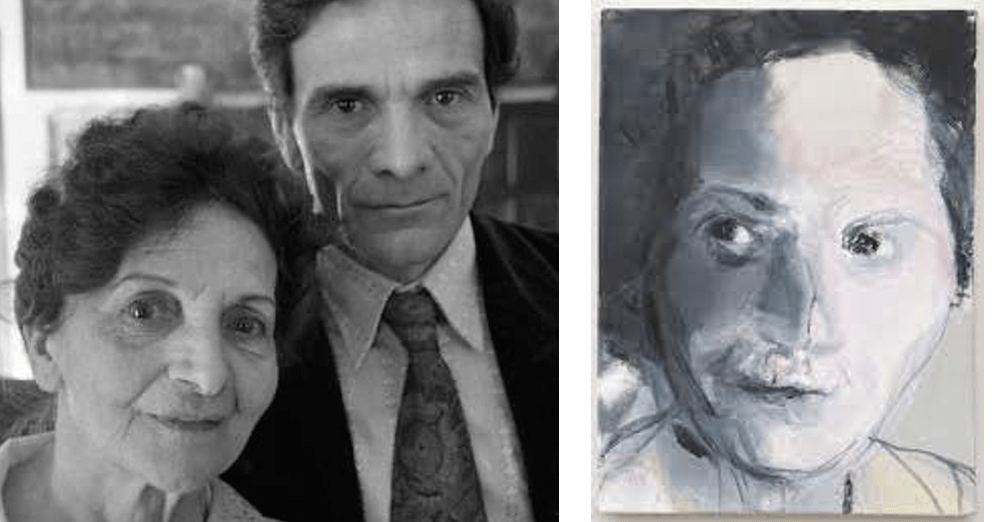
Nelle due mostre italiane, di cui già si è detto, compaiono altri due dipinti della Dumas che afferiscono al mondo pasoliniano: sono il ritratto di Anna Magnani in una scena di “Mamma Roma” e quello di Enrique Irazoqui, interprete di Gesù nel “Vangelo secondo Matteo”.
Anna Magnani in “Mamma Roma”
Girato nel 1962, “Mamma Roma” è il secondo film di Pasolini dopo “Accattone” e ha per interpreti principali Anna Magnani e Ettore Garofolo. Racconta la storia di Mamma Roma, prostituta che decide di diventare una rispettabile piccolo-borghese, trasferendosi con il figlio Ettore da Guidonia in un appartamento della periferia romana. Ma qui è obbligata a tornare a prostituirsi. Il figlio, saputa la verità su di lei, riprende a rubare; viene arrestato e muore in carcere per i maltrattamenti subiti, legato a un letto di contenzione. Conosciuta la sorte del figlio, Mamma Roma con un grido di disperazione si getta sul letto di Ettore, tenta il suicidio, ma poi desiste guardando la cupola di San Giovanni Bosco. Secondo il Morandini il film è «fondato sulle figure retoriche dell’ossimoro e della sineciosi (in cui s’affermano, di uno stesso oggetto, due contrari); su una morale dell’ambiguità (gli angeli impuri); sul principio di non contraddizione (tematico e stilistico); sul tempo che non muta e si ripete; sulla continuità tra padri e figli; sull’idea tragica della morte, l’unica che all’uomo dà una vera grandezza». La Dumas ha colto la tragicità di questa vicenda, magnificamente interpretata dalla Magnani e sintetizzata dal fotogramma del suo grido disperato, che ha fatto da modello al ritratto dipinto nel 2012.
A sinistra un fotogramma, tratto da “Mamma Roma”, che mostra una tragica immagine di Anna Magnani che emette un urlo di disperazione per la morte del figlio. A destra l’olio su tela Mamma Roma: è il ritratto della Magnani basato su quel fotogramma, dipinto da Marlene Dumas nel 2012 (Pinault Collection). L’opera pittorica, pur di piccole dimensioni (30 x 40) e realizzata quasi esclusivamente in toni bianchi e neri, riesce a trasmettere il senso angosciante del grido sofficcato dall’intensa emozione che sconvolge la protagonista.
I rapporti di “Mamma Roma” con la pittura sono numerosi e particolarmente significativi. Il film contiene questa dedica: A Roberto Longhi, cui sono debitore della mia «figurazione figurativa».
Di Longhi Pasolini fu allievo nei primi anni Quaranta del ‘900 all’Università di Bologna, quando seguì il corso sui Fatti di Masolino e di Masaccio e decise di chiedergli la tesi, che poi non poté completare causa la guerra. Il magistero di Longhi restò una tappa fondamentale nella formazione del giovane Pasolini. Nel volume su “Mamma Roma” scrisse: «il mio gusto cinematografico non è di origine cinematografica, ma figurativa. Quello che io ho in testa come visione, come campo visivo, sono gli affreschi di Masaccio, di Giotto — che sono i pittori che amo di più, assieme a certi manieristi (per esempio il Pontormo). E non riesco a concepire immagini, paesaggi, composizioni di figure al di fuori di questa mia iniziale passione pittorica, trecentesca, che ha l’uomo come centro di ogni prospettiva» (Pier Paolo Pasolini, Mamma Roma, Milano, Rizzoli. 1962, p. 149).
Proprio Longhi fu chiamato in causa da Pasolini a proposito della scena di “Mamma Roma“ in cui Ettore muore, legato a un letto di contenzione. Secondo molti critici le inquadrature di Pasolini avevano preso spunto dal “Compianto al Cristo Morto” del Mantegna. Scrivendo su Vie Nuove (n. 40, 4 ottobre 1962), così replica Pasolini: «Ah, Longhi, intervenga lei, spieghi lei, come non basta mettere una figura di scorcio e guardarla con le piante dei piedi in primo piano per parlare di influenza mantegnesca! Ma non hanno occhi questi critici? Non vedono che bianco e nero così essenziali e fortemente chiaroscurati della cella grigia dove Ettore (canottiera bianca e faccia scura) è disteso sul letto di contenzione, richiama pittori vissuti e operanti molti decenni prima del Mantegna? O che se mai, si potrebbe parlare di un’assurda e squisita mistione tra Masaccio e Caravaggio?»
A sinistra il Cristo morto di Andrea Mantegna, tempera su tela (68×81 cm), databile tra il 1470-1474 ca. o al 1483 ca. Pinacoteca di Brera a Milano. A destra l’immagine di “Mamma Roma”, che conclude l’agonia di Ettore nella cella di segregazione. È la scena n. 50 della sceneggiatura, in cui si legge: «Ettore è immobile, sopra il tavolaccio, stretto dalle inutili cinghie. Non si muove, non parla, non respira. La luce del sole ha invaso l’orribile cella».
“Il Vangelo secondo Matteo”
Marlene Dumas disse che ammirava in Pasolini la capacità di far interagire il sacro e il profano. Ne “Il Vangelo secondo Matteo” questa interazione è colta appieno. In un’intervista del 2012 la pittrice affermò a proposito de “Il Vangelo secondo Matteo”: «Ho preso come riferimento anche il film di Pasolini. Ho pensato al personaggio che interpreta Gesù e come il regista ha costruito l’intero film. (…) Dalla scelta di sua madre per il ruolo di Maria sotto la croce, fino all’utilizzo della voce di Odetta che canta: “Sometimes I feel like a motherless child” (“A volte mi sento un bambino senza madre”). E questa è un’altra connessione con l’orfanotrofio, con l’assenza della madre e con la Pietà». (video-intervista alla Dumas realizzata da Undo.net, in http://noname.casatestori.it/2012/03/marlene-dumas-attreversa-per-pier-paolo-pasolini/)
L’omaggio della Dumas a “Il Vangelo secondo Matteo” si è espresso nel ritratto di Enrique Irazoqui, che Pasolini volle nel ruolo di Gesù. Nel 1964 Pasolini era alla ricerca dell’interprete principale del “Vangelo”. Irazoqui aveva 20 anni, era un giovane militante comunista catalano, arrivato in Italia per far conoscere la causa degli antifranchisti a qualche intellettuale “impegnato”. Incontrò Pasolini quasi per caso, ma appena il regista lo vide emise un grido guardando il ragazzo: “È lui!”. Pasolini gli chiese se voleva essere lui il suo Gesù che da tanto stava cercando. Voleva un volto che ricordasse i Gesù dipinti da El Greco, con qualche eco preraffaellita.
Giuseppe Frangi – che ha ricostruito in uno scritto del 2012 la vicenda ora riassunta (https://www.ilsussidiario.net/news/cultura/2012/4/7/pasqua-pasolini-la-pittrice-e-quell-attore-per-sbaglio-che-fece-la-sua-parte/265713/) – osserva che Marlene Dumas ha rappresentato il volto di quel ventenne in «un piccolo quadro stupendo e serratissimo: è un volto dallo sguardo profondo, di un uomo dagli occhi scuri e dalle sopracciglia folte, molto mediterranee, che si staccano dall’incarnato che l’artista con le sue pennellate ha voluto insistentemente pallido. È un ritratto che cattura lo sguardo per la sua densità umana: si percepisce che la pittrice con questo volto ha avuto un rapporto non episodico e non casuale. (…) Nel piccolo spazio del quadro esposto alle Stelline è riuscita a condensare tutto il senso di questa storia nei pochi centimetri quadrati di questa tela. Quel volto non è semplicemente la rappresentazione realistica del Gesù pasoliniano, è la restituzione sintetica e intensissima di un’esperienza vissuta».
“THE FABELMANS”: OVVERO COME STEVEN DIVENNE SPIELBERG, E PERCHE’ E’ IMPOSSIBILE NON AMARE IL CINEMA
di Roberto Baldassarre
Alla 73º edizione del Festival di Berlino Steven Spielberg riceverà l’Orso d’Oro alla carriera, meritata onorificenza che evidenzia come sia stato uno degli autori (l’ultimo?) ad aver reso immaginifico il cinema. Un autore che nella sua lunga e corposa carriera ha affrontato quasi tutti i generi, e ha saputo coniugare il grande spettacolo con l’autorialità. Benché la sua filmografia sia fitta di kolossal (per budget e durata), Spielberg è principalmente un realizzatore di un cinema umano, in cui quello che conta sono i personaggi e le loro emozioni. E oltre a queste doti di affabulatore, va anche menzionata la particolarità di essere stato un innovatore, di aver fatto progredire la tecnologia cinematografica. In tal caso è sufficiente citare “Jurassic Park” (1993), che impose un nuovo utilizzo della computer grafica.
“The Fabelmans” è al momento la sua ultima opera, ed è una sentita quanto ironica autobiografia, sebbene utilizzi personaggi fittizi su vicende reali. Un kolossal sotto l’aspetto della “mastodontica” durata, ma una storia del tutto minimale, un classico bildungromans in cui Spielberg ricrea la sua vita familiare – e cinefila – d’infante e adolescente. Una pellicola, con una lunga gestazione meditativa da parte di Spielberg, utile per capire tutto il suo cinema precedente, come ad esempio le influenze cinefile e i laceramenti familiari raccontati nelle altre pellicole; ma dall’altro “The Fabelmans” conferma di come Spielberg stia recuperando una narrazione di stampo classico, lontano dai ritmi visivi odierni. I magri incassi, come quelli del precedente “West Side Story” (2021), non vanno recepiti come il fallimento di un regista che non sa più recepire i gusti del pubblico, perché “Ready Player One” (2018) è la prova di come Spielberg se vuole sa come restare in linea con le nuove platee, ma questa sua ultima opera conferma che il regista di Cincinnati può realizzare tutto quello che vuole, e così poter continuare a concretizzare tramite il cinema i suoi sogni.
01 “The Fabelmans”, viaggio nei primordi filmici di Spielberg
Alla fine di “Un secolo di cinema – Viaggio nel cinema americano” (1995), documentario cinefilo con cui Martin Scorsese omaggia il cinema americano, l’autore, guardando in macchina, spiega del perché la sua narrazione si fermi alla prima metà degli anni Sessanta, e non continui con la New Hollywood. Questa la motivazione data da Scorsese: “A questo punto dobbiamo fermarci, non posso proseguire oltre. Voglio dire: numero 1 non abbiamo tempo; numero 2 siamo arrivati a un’altra epoca, la fine degli anni ’60, anni in cui ho cominciato a fare cinema, ma questo mi pone sotto una luce diversa”. Quanto dice Scorsese è perfettamente applicabile anche a “The Fabelmans”, che è un viaggio personale nella preistoria di Spielberg. L’interesse del regista di Cincinnati, coadiuvato in sceneggiatura dal fidato Tony Kushner, è quello di raccontare soltanto i suoi primordi, per svelare al pubblico, tramite il formato film, il suo passato pre-cinema. Lo Spielberg divenuto regista professionista, fa già parte di un’altra epoca, è la storia è già nota.
02 “The Fabelmans”: riproduzione-remake
Lo sverginamento cinematografico del piccolo Sammy (Stefano Matteo Smith), portato dai suoi genitori per la prima volta in una sala cinematografica, avviene con la visione de “Il più grande spettacolo del mondo” (1952) di Cecil B. DeMille. Di questo magniloquente film circense, Sammy (alias Spielberg) rimane affascinato, tra stupore e terrore (Fear & Desire, i due principali poli emotivi che suscita il cinema), dalla scena dello scontro tra il treno e l’auto. Una scena palesemente finta, con treno e auto – oltre al paesaggio circostante – realizzato con i vistosi modellini. Questa scena spettacolare permane nella memoria di Sammy, e diviene per lui un’ossessione. Quando il padre Burt (Paul Dano) gli regala il trenino, uno dei giocattoli più ambiti da un infante, Sammy vuole ricreare quello che aveva visto sullo schermo, e quindi fa scontrare il trenino con una macchinina (a cui ha aggiunto il pupazzetto di Babbo Natale).
Un gioco ossessivo che si ripeterebbe altre volte, se non fosse che la madre Mitzi (Michelle Williams) gli insegna, prendendo la piccola cinepresa del marito, che quello scontro non è necessario ricostruirlo ogni volta, ma è sufficiente riprenderlo in pellicola e così poterlo rivederlo e riviverlo infinite volte. È questa epifania, la riproducibilità filmica, che spinge Sammy a interessarsi alle immagini in movimento, perché gli consentono di poter rifare e rivedere quello che gli piace. E a questo punto che “The Fabelmans” diviene un perfetto esempio su cosa sia la riproducibilità filmica, quale è uno degli aspetti magici del cinema.
Già “The Fabelmans” stesso è una riproduzione, ovvero il regista ha ricostruito cinematograficamente – indubbiamente con licenze poetiche – il proprio passato, ma i primi esperimenti filmici di Sam/Steven che vediamo, sia in versione “making of” e sia in versione finale (proiettati sullo schermo), attestano quel concetto di duplicazione che ha affascinato il protagonista sin dalla più tenera età. I cortometraggi amatoriali “The Last Gun”, “Escape to Nowhere” e “Ditch Day 1964” mostrano come Sam voglia rifare i generi che poco prima aveva visto al cinema: nel primo caso un western, nel secondo un War Movie e nel terzo un Beach Movie (genere in voga nella prima metà degli anni Sessanta). E aspetto ancor più affascinante, che rende ancor più stratificato il concetto di riproduzione, è che in “The Fabelmans” Spielberg rifà quei primitivi suoi lavori, sebbene li faccia firmare/filmare da Sam Fabelmans (Gabriel LaBelle).
Il rifare è una delle consolidate prassi dell’industria cinematografica, e il termine tecnico è remake. Nella filmografia di Spielberg, di forte ascendenza cinefila, la riproduzione si può rintracciare in ogni sua opera. Da un lato c’è la ricreazione di un genere (ad esempio la saga di Indiana Jones), l’omaggio a una singola scena (nella scena del tornado si auto-cita, ricreando il proprio “La guerra dei mondi”), o anche la ricreazione dell’atmosfere del cinema classico (“Il ponte delle spie”, per fotografia e tagli d’inquadratura è molto debitore del cinema di Powell e Pressburger). Dall’altro lato c’è però il vero e proprio remake. Spielberg ha diretto ben tre remake, veri e propri omaggi a quelle pellicole che lo emozionarono quando era un semplice spettatore: “Always – Per sempre” (1988), rifacimento di “Joe il pilota” (1943) di Victor Fleming; “La guerra dei mondi”, (2005), remake dell’omonimo film (1953) di Byron Haskin; e “West Side Story”, omaggio all’omonimo musical (1961) di Jerome Robbins e Robert Wise.
03 “The Fabelmans”: il cinema come epicità
Dopo la proiezione del documentario scolastico “Ditch Day 1964”, il bullo Logan Hall (Sam Rechner) domanda a Sam perché lo ha ritratto in modo così epico, quasi a divinizzarlo, sebbene lo avesse sempre trattato malamente, giungendo anche a mollargli un sonoro pugno sul naso. Sam gli spiega che lui ha solamente ripreso quello che accadeva, quindi non ha falsato nulla. Quanto dice il protagonista è in parte vero, perché lui si è soltanto limitato a riprendere gli accadimenti e le vicende dei suoi compagni di college sulla spiaggia (e al massimo creare delle scene divertenti con il gelato spacciato per guano di gabbiano che cade sui volti dei ragazzi che prendono il solo), ma l’epicità viene data dal cinema, da quegli artifizi che possono amplificare una determinata scena. Assemblare in un determinato modo due scene, usare il ralenti o velocizzare i fotogrammi, mettere un adeguato commento sonoro o semplicemente scegliere un taglio d’inquadratura, sono accorgimenti che, se usati con sapienza, possono rendere epico il film. Non a caso quella scena de “Il più grande spettacolo del mondo”, realizzata da DeMille con dei modellini, diviene drammaticamente grandiosa attraverso il montaggio e l’uso della musica. E “The Fabelmans”, sebbene storia intima, è al contempo epico, per la narrazione adottata da Spielberg, che riesce a rendere quelle scene di vita quotidiana Bigger than life.
04 “The Fabelmans”: Stop, cut…
Hitchcock diceva che “Il cinema è la vita senza le parti noiose”, mentre Godard affermava che “Il cinema filma la verità 24 volte al secondo”. In “The Fabelmans” queste due dichiarazione son ben presenti nella narrazione, e nel percorso di crescita privato e professionale di Spielberg. Il cinema, tramite la pellicola, consente di poter registrare e quindi fissare la realtà, da intendere come verità. La cinepresa (ormai divenuta video) raccoglie quello che inquadra, e a posteriori noi possiamo anche guardare e riguardare aspetti periferici che ci erano sfuggiti. Nel montare il filmino del campeggio, Sam, che aveva ripreso in primo piano le due sorelle giocare, vede sullo sfondo dell’immagine della madre amorevolmente passeggiare con lo “zio” Bennie (Seth Rogen). Ripassa nella sua piccola moviola, avanti e indietro, quei 24 fotogrammi di verità, soffrendo per quanto vede e nella realtà non se ne era accorto.
Nel filmino montato e terminato e proiettato in famiglia, quelle scene sono state espunte, ma messe da parte e congiunte per farle vedere alla madre e rimproverarla. Ecco, i film certamente consentono di poter ricreare la vita (e riproporla all’infinito), ma tramite il montaggio si possono togliere quelle parti noiose e/o dolorose e lasciare soltanto i momenti gioiosi, e tramandare così una memoria in gran parte falsata. Ma ugualmente si potrebbero tagliare i momenti belli e lasciare soltanto quelli brutti, come fa Sam con la madre. Tagliando e giuntando pezzi di pellicola, il protagonista capisce che sarà lui a poter decidere cosa raccontare oppure omettere, come un demiurgo potrà creare, distruggere o migliorare la vita dei personaggi che racconta.
05 “The Fabelmans”: John Ford/David Lynch
A impersonare John Ford, e ricreando così il famoso aneddoto che Steven Spielberg ha sovente raccontato (ed è visionabile su YouTube), David Lynch. Certamente una scelta fisionomica, poiché Lynch incanutito ha nei tratti quella ruvidezza e rudezza di Ford, ma sorprende perché sono due autori agli antipodi. John Ford è fautore di un cinema classico, lineare e senza increspature nel montaggio; un cinema con una morale.
Mentre David Lynch è il creatore di un cinema disturbante, altisonante e quindi non dritto, e per nulla morale (i finali ambigui, non chiusi). Però, se si scandaglia la sua filmografia, una delle migliori opere di Lynch è “Una storia vera” (1999). Prendendo il titolo originale “The Straight Story”, e lo traducessimo alla lettera, il film è effettivamente una storia dritta, schietta e, giocando anche con l’accezione teatrale, classica. Lynch con “Una storia vera” è stato più fordiano di Ford, con l’anziano protagonista Alvin Straight che in sella a un piccolo trattore solca le lunghe strade americane. Un vecchio e malridotto cowboy (non a caso Richard Farnsworth interpretò diversi western e fu anche stuntman) che tappa dopo tappa vede cittadine tipiche americane, incontra gente di ogni tipo (e qui a volte appare il grottesco di Lynch), e sullo sfondo del suo lungo viaggio per raggiungere il fratello, la magnificenza dell’orizzonte e dei grandi paesaggi.
INTERVISTA
INTERVISTA A PAOLO MINUTO, FIGURA DI SPICCO DELL’ASSOCIAZIONISMO CINEMATOGRAFICO
di Elisabetta Randaccio
Paolo Minuto è stato una figura rilevante dell’associazionismo cinematografico sia in Italia sia internazionalmente. Sin da ragazzo, ha frequentato i circoli del cinema della sua città, Reggio Calabria, dove la sua passione per la settima arte ha incontrato la necessità dei diritti del pubblico, l’impegno culturale e sociale. Docente all’Università per stranieri di Reggio, ha ricoperto per anni la carica di presidente della FICC (Federazione italiana dei Circoli del Cinema) e dell’IFFS (International Federation of Film Societies). Da dieci anni, ha scelto una nuova avventura, quella della distribuzione cinematografica indipendente con il “Cineclub Internazionale”, ottenendo risultati significativi, mai abbandonando la sua passione per il cinema di qualità. Lo incontriamo per farci raccontare la sua esperienza in questo ambito.
Quali sono gli obiettivi della tua distribuzione cinematografica “Cineclub Internazionale”?
“Si potrebbe partire dal suo nome commerciale derivante dalla mia lunga esperienza nell’associazionismo, nei circoli del cinema, nei cineclub, che mi ha insegnato a non avere confini dal punto di vista culturale, a rispettare qualsiasi diversità culturale. Anche questo, ha fatto nascere in me l’idea di diventare un “editore cinematografico”. Sottolineo questo termine, perché la parola distributore è stata utilizzata nel cinema per una serie di vicende storico linguistiche, ma, a tutti gli effetti, il distributore è un vero e proprio editore, simile a quello librario. In questo senso, si prende un film, lo si cura, lo si distribuisce nelle sale in prima visione e, in seguito, nei circoli, nelle associazioni culturali, seguendo sempre una precisa linea editoriale”.
Dunque, quale è la tua linea editoriale?
“A differenza dell’esperienza associativa, che ho fatto per tanti anni, la quale, secondo me, è pratica unica consigliabile nella formazione culturale e umana di chiunque, ne volevo attuare una più individuale, perché il catalogo editoriale cinematografico risponde a un’idea artistica personale. Infatti, così come il regista sceglie i soggetti da realizzare, l’editore cinematografico risponde a una sua specifica visione del mondo, che, per me, nel presentare un film nelle sale, si sovrappone anche al rispetto per il pubblico; infatti, il mio obiettivo centrale è il pubblico. In questo senso, mi impegno affinché, durante almeno i primi giorni in cui un mio film esce nelle sale, gli stessi registi incontrino gli spettatori. Per esempio, quando a Cagliari è stato presentato “Storia di amore e desiderio”, la sua regista Leyla Bouzid ha partecipato alla prima proiezione. Quando, poi, non è possibile avere il regista in presenza, cerchiamo di organizzare dei collegamenti online o supportiamo la pellicola con l’aiuto di esperti. Certo, quando seleziono un film, devo esserne convinto e coinvolto. Non sempre si può opzionare un’opera che ti piace, perché magari ha tante richieste ed è appannaggio di chi ha elevate risorse finanziarie, ma anche mi interessa cercare l’inedito, l’insolito, soprattutto film provenienti da paesi “periferici” – considerati tali dalla geopolitica – e, a parità di condizioni, preferisco film realizzati da donne. In questo senso, nel mio listino, si trovano opere firmate piu da registe che da registi”.
Nel percorso del distributore indipendente sono presenti tanti ostacoli, non solo economici…
“È evidente che alcuni film sono appannaggio di distributori più strutturati. Può accadere, però, che, come nel caso di “Storia di amore e desiderio”, presentato al Festival di Cannes, la regista, di cui avevo distribuito l’opera prima (“Appena apro gli occhi”, 2015) abbia avuto piacere di affidarmi questo suo nuovo lavoro. Infatti, per le ragioni suddette, mi capita, molto spesso, di distribuire opere prime. Il problema della distribuzione indipendente è accentuato dal fatto che, in Italia, le sale “libere”, quelle gestite da esercenti che, attraverso un dialogo con chi presenta i film, decidono di sceglierli autonomamente non sono molti, si tratta di una percentuale molto bassa, meno del 20%. I restanti cinema sono programmati da circuiti e l’accesso a questi ultimi è assai costoso, per cui i piccoli distributori, almeno quelli delle mie dimensioni, hanno poco spazio. Per quanto mi riguarda, mi dedico a questa attività per una mia esigenza di espressione personale, ma ho anche un altro lavoro, sono, infatti, un docente, per cui riesco a tamponare col mio stipendio eventuali mancanze nella chiusura del budget; ma se dovesse essere il mestiere principale, credo non sarebbe sostenibile economicamente. Ovviamente, poi, può capitare che qualche film vada bene e produca degli utili, ma questi ultimi devono subito essere investiti in uno successivo, il quale, magari, non ne produce altrettanti. In ogni caso, questo va, comunque, bene, perché la mia impresa non è di tipo capitalista: infatti, è basata sul credito bancario e su mie risorse, però, questa è stata la mia scelta, non solo economica, ma pure editoriale, da “cinema publisher”, come ormai viene definito il mio tipo di lavoro, a livello internazionale. Certo, esistono anche altro tipo di distributori, che lo fanno come service non come editori, cioè si fanno pagare per piazzare i vari film. Si tratta di una attività lecita e trasparente, distributori in senso stretto, i quali selezionano i prodotti meno dal punto di vista editoriale. Un ruolo, insomma, diverso dal mio”.
Nonostante i vari problemi, però, l’esperienza del “Cineclub internazionale” si può, facendo un bilancio, definirla molto positiva con, ormai, un suo posto specifico nella distribuzione cinematografica indipendente…
“Effettivamente sono soddisfatto, appagato per come abbiamo approcciato seriamente questo lavoro. Tale proposta culturale, dopo dieci anni di attività, è sfociata in un primo bilancio positivo, anche perché posso constatare una certa stima persino dagli spettatori, i quali, spesso, riconoscono il simbolo del “Cineclub internazionale”, perché hanno avuto l’opportunità di vedere altri film del mio marchio, che sono piaciuti. Questo l’ho riscontrato nel pubblico frequentante i cinema d’essai in varie regioni d’Italia e ciò porta un grande gratificazione, che sottolinea come il lavoro sia stato realizzato con coerenza e professionalità. Certo, se gli spazi fossero più ampi, sarebbe possibile portare in sala più opere. Il problema è che ci sono troppi film in troppe sale. Mi spiego: spesso troviamo pellicole le quali occupano, per esempio, 400 sale anche inutilmente. Facendo un esempio pratico: se “Spider-man” esce in 500 cinema, sicuramente riesce a reggerli, perché, in ognuno di questi, almeno nelle prime settimane, avrà effettivamente sempre un discreto incasso. Al contrario se, per fare un esempio recente, un’opera come “Licorice pizza”, scambiato erroneamente da molti esercenti per un blockbuster, esce in 400 sale, la metà di queste soffriranno, perché il regista Paul T. Anderson è assai particolare nella sua produzione e non è possibile trattare il suo film come un’opera esclusivamente industriale, commerciale. Come conseguenza è stato tolto spazio probabilmente ad altri film. Un maggiore equilibrio nella distribuzione si potrebbe ottenere con un intervento pubblico, come accade in altri paesi quali la Francia o la Spagna; sarebbero necessari presidi pubblici, che consentirebbero di perequare la situazione, perché, se è sicuro come si sia dipendenti dal libero mercato, si dovrebbe anche pensare all’attività culturale cinematografica come un diritto del pubblico, che può scegliere un particolare film solo se gli viene data tale opportunità, quindi l’intervento pubblico dovrebbe servire perché, a prescindere dai risultati di mercato, alcune opere possano essere proposte, magari una per provincia, per esempio. Questo potrebbe aiutare pure la diffusione di un cinema sconosciuto o, comunque, penalizzato. In seconda battuta, è importante l’intervento dell’associazionismo capace di valorizzare quei film che hanno avuto meno riscontro nelle grandi sale. In questo modo, si potrebbero acquistare film artistici. Comunque, correggere in questo senso la distribuzione, si può realizzare solo con l’intervento pubblico, che dovrebbe limitare lo strapotere della logica del mercato”.
Puoi anticiparci le nuove uscite di “Cineclub internazionale”?
“Sì. Intanto, segnalo un film, che ho deciso di ricollocare tra settembre e ottobre, anche perché in questo momento, non riscontriamo una buona affluenza di pubblico. Si tratta di un’opera a cui tengo molto, perché è stata bloccata in questi due anni di pandemia. È stata presentata al Festival di Venezia alle “Giornate degli autori”. È l’opera prima di una regista ungherese, che già dal titolo è estremamente curiosa: “Preparativi per stare insieme in un periodo indefinito di tempo”. A giugno, invece, uscirà un film su Emily Dickinson, un lungometraggio americano di una regista indipendente, un’opera raffinata, interessante su un aspetto anche inedito della storia della grande poetessa. Spero sia un bell’evento e, chissà, magari anche l’autrice riuscirà a presentarlo a Cagliari”.
Articolo pubblicato per gentile concessione della Redazione di “Teorema”, Rivista sarda di cinema e con il consenso di Paolo Minuto
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
79. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
Appunti e impressioni di un socio FEDIC
di Luciano Volpi
Bella edizione con molti film tematici contemporanei e storie vere rappresentate molto bene.
Molto pubblico, in particolare stranieri e tantissimi giovani assiepati anche fino dal mattino a prendere posto davanti alle transenne per vedere i protagonisti sul Red Carpet ed a caccia degli agognati autografi.
Molte le presenze di attori e registi con pochissime defezioni se si esclude l’ultimo premio Oscar Anthony Hopkins.
Nonostante la grande presenza di pubblico nelle sale con il ritorno alle regole libere del 2019, tutto si è svolto nella più normale pratica, anche con le prenotazioni del nuovo gestore Vivaticket.
Come sempre la concentrazione massima è stata sui film in Concorso con un occhio ai Fuori Concorso che per incognite ragioni alcuni sono relegati o per ritardo nelle iscrizioni per cause tecniche come montaggi e corse contro il tempo per la realizzazione o per pura scelta delle Giurie di preselezione.
Inoltre è doveroso cercare con la dovuta dovizia nella categoria Orizzonti perché sicuramente ci saranno dei film molto meritevoli di essere visti.
Capitolo a parte il settore SIC & SIC di cui faccio parte come Giuria dei Corti a cui spetterà il Premio Fedic e che questo anno ha visto primeggiare “Albertine Where Are You?” di Maria Guidone.
Adesso per ogni film visto, una breve critica basata su molti aspetti, come contesto della trama, interpretazioni, soggetto del film e suo scopo sociale, fotografia e l’agognata regia che per il Leone d’Oro è lo scopo principale, ma spesso non lo è per il pubblico delle sale italiane.
Una lode al Direttore Artistico Alberto Barbera che negli anni ha dimostrato di interpretare molto bene il suo ruolo nella accoglienza e nella disponibilità ad accompagnare i protagonisti di ogni film ed il cast sia sul Red Carpet che in Sala, per fare accogliere dal pubblico tutti i personaggi ed omaggiarli direttamente, non facendosi mancare anche nei vari appuntamenti nelle varie sale per le manifestazioni collaterali.
“WHITE NOISE – RUMORE BIANCO” di Noah Baumbach(film di apertura in Concorso)
Bel film- commedia che affascina per i contenuti, tiene attaccati allo schermo per gli avvenimenti e coinvolge nelle discussioni della famiglia, con un superlativo Adam Driver e la bravissima Greta Gerwig. Credo che piacerà nelle sale anche italiane questo film americano girato molto bene.
“PRINCESS” di Roberto De Paolis – ORIZZONTI (film di apertura)
Film italiano girato a Roma ed interpretato oltre che da attrici ed attori non conosciuti, da personaggi reali della storia che viene raccontata. Un plauso al regista per aver messo sul piatto questa realtà che è un misto fra sfruttamento e disagio sociale di ragazze africane in cerca di se stesse e di una vita migliore.
“TAR” di Todd Field – IN CONCORSO
La splendida Cate Blanchett, che prende il premio come migliore attrice protagonista, interpreta la vita di una famosa direttrice di orchestra di musica classica, Lydia Tar che giunta all’apice della sua carriera incredibile, complice la sua vita privata fatta di amicizie femminili importanti con anche un suicidio, la porterà al definitivo abbandono.
“BOBI WINE: GHETTO PRESIDENT” di Christopher Sharp e Moses Bwayo – FUORI CONCORSO
Film documentario sulla vita reale di Bob Wine e sua moglie Barbis che dal ghetto di Kampala in Uganda arrivano fino a sfidare il regime trentennale sfiorando la vittoria alle presidenziali, sconfitti soltanto dalla corruzione dilagante. Bel lavoro documentaristico e girato molto bene anche se in condizioni difficili.
“LIVING” (“VIVERE”) di Oliver Hermanus – FUORI CONCORSO
Bel film girato nella Londra anni settanta, molto piacevole da vedere anche se molto commovente, girato molto bene, preso da un capolavoro umanista di Kurosawa, un maestro del cinema.
E’ una storia sulla vita e sul valore di semplici tracce lasciate da tutti noi nel corso della nostra esistenza. Da vedere sicuramente, se ci sarà la possibilità.
“BARDO, falsa cronica de unas quantas verdades” (“CRONACA FITTIZZIA DI UNA MANCIATA DI VERITA’”) di Alejandro G. Inarritu – IN CONCORSO
Uno dei film messicani, che come sempre se non vincono lasciano il segno per la regia sublime, per le storie che raccontano, per le interpretazioni e la fotografia spettacolare. In questa sceneggiatura c’è la memoria e la sua insoddisfazione che non è veritiera ed è derivante dalle emozioni, tra realtà ed immaginazione. Sublime film da vedere se capita l’occasione.
“UN COUPLE” – “UNA COPPIA” di Frederick Wieseman – IN CONCORSO
Se non fosse per la costa della Bretagna, la storia fra Leo Tolstoj e sua moglie, che solo lei la racconta in un monologo. Il film è purtroppo noioso.
“A COMPASSIONATE SPY” di Steve James – FUORI CONCORSO
Film- documentario sulla storia vera di Ted Hall, fisico americano che contribuisce alla creazione della bomba atomica per arrivare prima dei tedeschi, poi passa le informazioni alla Russia. La moglie ha spinto alla realizzazione del documentario per l’amore della sua vita e che corse insieme a lei rischi incredibili quando faceva parte del Progetto Manhattan.
ATHENA di Romain Gavras – IN CONCORSO
Il regista greco figlio di Kostantin, amante delle tragedie greche che gli hanno ispirato il film ambientato nelle banlieue parigine, affascinato dal suo significato simbolico per tradurlo in immagini e creare una esperienza cinematografica immersiva. Bel film, girato bene, violento ma anche visibilmente accettabile.
“BONES AND ALL” (“FINO ALL’OSSO”) di Luca Guadagnino – IN CONCORSO
Il regista ha dichiarato che è attratto dai diseredati, coloro che vivono ai margini della società, e quindi si commuove e li ama, e secondo lui il cuore del film batte teneramente ed affettuosamente nei loro confronti. Si dimentica che il film lo vedranno anche gli spettatori e che non possono, specialmente i giornalisti e addetti alla comunicazione e puri mortali, voltarsi in sala, turarsi gli orecchi e gli occhi per non vedere e sentire. Nonostante questo ha ricevuto il Leone d’Argento premio per la migliore regia.
Peccato perché i panorami mozzafiato sono incredibilmente stonati a confronto di chi fino dall’inizio mangiano dita, orecchi e corpi ancora viventi, cannibali e cannibalismo esasperato che oscura attori del calibro di Mark Rylance e l’osannato Tymothee Chalamet che quando avrà deciso cosa vuole fare da grande per fare un buon film (per lui) e non da eventuale cassetta, ma ne dubito. Cosa ci voleva a togliere il cannibalismo ed il film sarebbe da vedere, ma non eccelso ugualmente. Alla prossima Guadagnino.
“MONICA” di Andrea Pallaoro – IN CONCORSO
Bel film italiano con una sorprendente Trace Lysette che è il ritratto intimo di una donna che esplora temi universali dell’abbandono e dell’accettazione, del riscatto e del perdono.
“ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED” (“TUTTA LA BELLEZZA E LO SPARGIMENTO DI SANGUE”) di Laura Poitras – IN CONCORSO – (LEONE D’ORO)
Il vincitore del Leone D’Oro narra la storia documentaria di Nan Goldin, artista ed attivista di fama internazionale, attraverso diapositive, dialoghi intimi, fotografie rivoluzionarie e rari filmati della sua battaglia per ottenere il riconoscimento della responsabilità della opulenta e ricchissima famiglia Sackler per le morti di overdose da farmaco, i crimini e le denunce alla famiglia Sackler ed alla Purdue pharma, produttrice dell’ossicodone, causa di migliaia di morti.
“VERA” di Tizza Covi e Rainer Frimmel – ORIZZONTI
Premiato per la migliore regia della sezione Orizzonti è un film normale girato con attori sconosciuti ma ha una storia vera con Vera Gemma figlia di Giuliano Gemma premiata nella sezione Orizzonti come migliore attrice, incatenata nel personaggio del padre ma con il film dimostra molta semplicità.
“ARGENTINA” di Santiago Mitre – IN CONCORSO
Ispirato alla vera storia di Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, procuratori che nel 1985 osarono indagare e perseguire i responsabili della fase più sanguinosa della dittatura militare argentina.
Bel film da vedere sicuramente.
“MASTER GARDENER” di Paul Schrader – IN CONCORSO
Il regista è stato premiato con il Leone d’Oro alla carriera per la sua lunga attività di regista e sceneggiatore. Con l’occasione si presenta con questo magnifico film assolutamente da vedere con Joel Edgerton e Sigourney Weaver splendidi protagonisti in un contesto floreale di orticoltura e devozione per i terreni.
“THE KIEV TRIAL” di Sergei Loznitsa – FUORI CONCORSO
Facendo delle ricerche il regista si è imbattuto nei filmati dimenticati del processo di Kiev ed ha deciso di farne un film documentario che ricostruisse l’intero processo.
“L’IMMENSITA’” di Emanuele Crialese – IN CONCORSO
Penelope Cruz è stata coinvolta in questo semplice film, anche girato bene in una Roma anni ’60, ma non mi ha coinvolto ed entusiasmato.
“LES ENFANTS DES AUTRES” di Rebecca Zlotowski – IN CONCORSO
Bel film francese come al solito, tocca gli affetti ed il desiderio di amore che spinge ad andare avanti nella famiglia di un altro, compreso i figli.
“IN VIAGGIO” di Gianfranco Rosi – FUORI CONCORSO
Bellissimo documentario su Papa Francesco in giro per il mondo, un ritratto che ci fa guardare oltre e riflettere su temi universali, la sfida è stata di trasformare in linguaggio cinematografico filmati realizzati per esigenze televisive. Con il montaggio è maturata l’esigenza di far dialogare il racconto con i viaggi del Papa, materiali di archivio storico e frammenti altri film del regista. Inoltre seguendo altri viaggi affronta nuovi temi e nuove riflessioni.
“LOVE LIFE” di Koji Fukada – IN CONCORSO
Splendido film giapponese, drammatico ed universale per l’argomento principale che non è la tristezza di una coppia per la perdita di un figlio, ma la solitudine che prova per l’incapacità di condividere il dolore, infatti secondo il regista la tristezza è personale ed unica mentre la solitudine è tipica della condizione umana. Film profondo da meditare.
“THE BANESHEES OF INISCHERIN” (GLI SPIRITI DELL’ISOLA) di Martin McDonagh – IN CONCORSO
Premio miglior attore a Colin Farrel che insieme a Brendan Gleeson recitano in una isola remota al largo della costa occidentale dell’Irlanda e segue le vicende di due amici di vecchia data.
Premio per la migliore sceneggiatura a Martin McDonagh, il regista è anche commediografo con varie opere teatrali di successo, l’ultimo film pluripremiato “Tre Manifesti a Ebbing”, capolavoro assoluto, e questo la dice lunga sul suo ultimo film. Da vedere assolutamente.
“DON’T WORRY DARLING” di Olivia Wilde – FUORI CONCORSO
La regista con questo film basato sulla nostra immaginazione non mi ha soddisfatto. Girato nel deserto in una città piccola costruita a modello, personaggi strani ed interpretazioni classiche, non lascia la bocca dolce.
“TI MANGIO IL CUORE” di Pippo Mezzapesa – ORIZZONTI
La curiosità mi ha spinto a questo film in bianco e nero accentuato, l’inizio è spietato e racconta tutto il film, poi l’ingresso di Elodie capo faida del Gargano la dice tutta. Non sono riuscito a finire di vederlo. Mi dispiace!
“THE ETERNAL DAUGHTER” (“L’ETERNA FIGLIA”) di Joanna Hogg – IN CONCORSO
Bellissimo film, l’interpretazione di Tilda Swinton è superlativa e basta ed avanza, la storia è bellissima, girato splendidamente e tratto da una storia personale della regista e sua madre.
Da vedere.
“DEAD FOR A DOLLAR” (“MORTO PER UN DOLLARO”) di Walter Hill – FUORI CONCORSO
L’aspettativa era alta per la partecipazione di due attori come Christoph Waltz e Willem Dafoe, ma il film è troppo leggero e come western non eccelle.
“IL SIGNORE DELLE FORMICHE” di Gianni Amelio – IN CONCORSO
Bellissimo, già nelle sale e da vedere assolutamente, interpretazioni fantastiche di Luigi Lo Cascio ed Elio Germano come sempre sublime ed il superlativo Leonardo Maltese stella nascente oltre a Sara Serraiocco bravissima.
Che dire di più, basterebbe questo ma se si aggiunge la regia del grande Gianni Amelio, con la fotografia e la storia vera che suggestiona, con la violenza e l’ottusità della discriminazione, con l’amore sottomesso al conformismo ed alla malafede, è indubbio il migliore film italiano in circolazione.
“SAINT OMER” di Alice Diop – IN CONCORSO
Bel film drammatico dove la regista avendo assistito al processo di una donna che aveva ucciso la figlioletta abbandonandola sulla spiaggia in Francia con l’alta marea, decide di scrivere questo film con protagonista una giovane scrittrice che assiste al processo. Da vedere.
“DREAMIN’ WILD” (“SOGNANDO SELVAGGIAMENTE”) di Bill Pohland – FUORI CONCORSO
Bel film, Casey Affleck non delude con questa storia vera dove i sogni possono avverarsi anche a distanza di trenta anni, possiede una tranquilla semplicità. Se capita è da vedere.
“THE SON” (“IL FIGLIO”) di Florian Zeller – IN CONCORSO
Per me il migliore in assoluto, cast eccezionale con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, la sorpresa di Zen McGrath ed Antony Hopkins.
Film sul senso di colpa, sui legami familiari e sull’amore: è da lacrima facile alla fine tanto è commovente. Il regista voleva realizzarlo da tanto tempo ispirato da emozioni da lui conosciute e voleva condividerle con il pubblico riuscendoci sicuramente.
“SHAB,DAKELI, DIVAR – BEYOND THE WALL” (“OLTRE IL MURO”) di Vahid Jalivand – IN CONCORSO
Bellissimo film Iraniano, sulla rinascita della speranza perduta di un famoso poeta iraniano che dice ” senza speranza, non troveremo mai la forza di alzarci…non c’è aria fresca da respirare…non c’è più vita da vivere “. Se capita in Italia, ma la vedo dura, è da vedere.
“THE MATCHMAKER” di Benedetta Argentieri – FUORI CONCORSO
Secondo la regista l’idea di questo film nasce dall’esigenza di raccontare le donne che si sono unite allo Stato islamico andando al di là degli stereotipi che le vogliono o vittime possibilmente di un uomo, oppure fanatiche che inneggiano alla jihad. Bel film documentario – intervista.
“BLONDE” di Andrew Dominik -IN CONCORSO
L’attrice Ana de Armas spicca su tutto il resto, ma il film è fatto molto bene, raccontato molto bene, tratto da un romanzo, ma effettivamente la storia di Marilyn Monroe con la sua vita fino dall’infanzia si chiama Norma Jeane, confonde i confini tra realtà e finzione per esplorare la crescente divisione tra il suo io pubblico e quello privato. Bel lavoro, complimenti ad Andrew Dominick e con Adrien Brody e Bobby Cannavale superbi.
“SICCITA’” di Paolo Virzì – FUORI CONCORSO
L’unico film che ho voluto vedere due volte e che lo rivedrò molto volentieri perché sono sicuro che ogni volta scoprirò qualcosa di nuovo tante sono le sfumature, i dialoghi, le curiosità in questo film pieno di un turbinio di emozioni, sensazioni e racconti separati ma insieme legati ad un avvenimento atmosferico attuale.
Il cast è notevolissimo e pieno di talenti nostrani di cui non saprei trovare il migliore se non cadere su Valerio Mastrandrea e Silvio Orlando, Max Tortora, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi. Ma anche tutti gli altri sono meritevoli. Capolavoro di Paolo Virzì.
“LES MIENS” (“OUR TIES”) (“I NOSTRI LEGAMI”) di Roscdy Zem – IN CONCORSO
Bel film francese, divertente girato bene, avrà successo in Francia sicuramente, attori bravissimi, ero in sala alla serata con i protagonisti ed alla fine standing-ovation.
“NUCLEAR” di Oliver Stone – FUORI CONCORSO
Il cambiamento climatico ci ha costretto brutalmente a ripensare i modi in cui produciamo energia come comunità globale. Bel documentario molto attuale.
“KHERS NIST” (“NO BEARS”) (“NIENTE ORSI”) di Jafar Panahi – IN CONCORSO
Il regista e sceneggiatore Iraniano riceve il Premio speciale della Giuria per questo film che ritrae due storie d’amore parallele ed in entrambe gli innamorati sono tormentati da ostacoli nascosti ed ineluttabili, la forza della superstizione e le dinamiche del potere.
“CHIARA” di Susanna Nicchiarelli – IN CONCORSO
La storia di Santa Chiara e San Francesco: il film non mi ha entusiasmato.
“THE HANGING SUN” (“SOLE DI MEZZANOTTE”) di Francesco Carrozzini – FUORI CONCORSO ( Film di chiusura )
Bel film ambientato nell’estremo nord Europa, con Alessandro Borghi bravissimo, tratto da un romanzo.
Cosi è finita la 79 esima edizione con molti film interessanti, belli, documentari da tutto il mondo, culture diverse, come i sentimenti seppure uguali ma diverso il modo di viverli, conoscenze più disparate, come diverso il modo di raccontare perché la vita in ogni Continente è diversa.
Per questo vivere questo ambiente multiculturale aggiunge ai nostri animi cose sempre nuove.
Arrivederci al 2023 all’80 esima edizione
UN’ESPERIENZA COINVOLGENTE
di Roberto Merlino

Enzo Bruno (Genova)
Due anni dall’ultimo stage a cui abbiamo partecipato. Avremmo ritrovati gli stessi amici di allora? Ne avremmo fatti di nuovi? Lo stage sarebbe stato anche stavolta interessante? E Alessandro Grande, che nel frattempo è diventato sempre più un affermato professionista, sarebbe rimasto l’amico di due anni prima? Poi arrivi ai “Felloni” e capisci che il tempo potrebbe averci un po’ ingrassati, ma ha avuto un grande rispetto per le nostre emozioni…
Juana Cattunar (Torino)
Splendide l’organizzazione e l’accoglienza.
Tanto studio e lavoro, ritmi incalzanti, ma anche molto divertimento.
Alcune piacevoli novità, variazioni sul tema della sceneggiatura.
Grande condivisione e convivialità.
Entusiasmo alle stelle, dopo due anni di pausa forzata.
Tiziana Graziano (Genova)
Ho partecipato per la prima volta allo stage con mille dubbi perché pensavo di non essere all’altezza e di sentirmi un pesce fuor d’acqua, invece sono rimasta piacevolmente sorpresa dallo spirito collaborativo e dall’ambiente che mi ha fatto sentire subito a casa.
Giuseppe Squarcio (Torino)
Subito dopo pranzo, si parte per il viaggio di ritorno. Arrivo alla stazione appena in tempo per prendere il treno che mi porterà a Torino. Trovato il posto assegnato, mi siedo e subito dopo mi sembra di percepire come un vociare di persone allegre, che si spostano da una parte all’altra delle stanze di una struttura in miniatura posta alle mie spalle. Che bello! La gioia che percepisco mi contagia, sorrido dentro me e lo sguardo è come fisso su questo quadretto. Una piacevole sensazione che mi accompagna durante il viaggio finché l’annuncio di arrivo alla stazione, mi fa tornare alla realtà.
STAGE NAZIONALE FEDIC 2022
Calci (Pisa) 25-29 agosto 2022
18.a edizione
Ho voluto iniziare con alcuni dei commenti pervenuti dai partecipanti, perché mi è sembrato il modo più “genuino” di iniziare il racconto di queste cinque magnifiche giornate.

Il programma di quest’anno (“Progettiamo insieme film corti”) era, in buona sostanza, un percorso di sceneggiatura ma, al contrario di precedenti esperienze, seguiva un itinerario molto “particolare”, che si potrebbe definire “sperimentale”.
Il docente, Alessandro Grande, è stato molto bravo nel condurlo, confermando una professionalità indiscussa (non è un caso se ha vinto il David di Donatello!) che, unita alla notevole capacità comunicativa, gli ha conquistato stima e consenso da tutti i partecipanti.
Al termine delle cinque giornate di lavoro sono state realizzate tre differenti sceneggiature che, messe in rete, saranno disponibili per chiunque voglia utilizzarle per fare uno o più cortometraggi. I film, così realizzati, potranno partecipare gratuitamente ad un Concorso che avrà il suo momento culmine e la premiazione in occasione dello Stage del 2023.

Com’è tradizione, lo Stage si è aperto all’esterno con tre serate nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Calci, sempre piena e partecipe. L’Amministrazione Comunale di Calci era presente con la Vice Sindaco, Valentina Ricotta, e l’Assessora alla Cultura, Anna Lupetti.
Nella prima serata, sono stati proiettati, e discussi col pubblico, alcuni cortometraggi realizzati dagli stagisti:
“I curvi” di Marco Rosati e Luca Meazzini
“La mia Toscana” di Monica Chiarioni
“Tutto in una notte” di Giacomo Bernardi
“Ciao Bianca” di Daniele Murgia
“Selva oscura” di Fabio Ravioli
“Sì, lo voglio” di Enzo Bruno, Vincenzo Cirillo e Rocco Oliveri
La seconda serata è stata dedicata ad Alessandro Grande e sono stati proiettati e commentati tre suoi cortometraggi:
“Bismillah” (David di Donatello 2018)
“In my prison”
“Margerita”
Tutti e tre i lavori, vincitori di oltre 100 Festival in giro per il mondo, hanno riscosso notevoli consensi e calorosi applausi.
L’attento e curioso pubblico ha coinvolto Alessandro in un serrato e avvincente dialogo, ricco di curiosità, aneddoti e spiegazioni.

Nella terza serata, dedicata allo sponsor ACQUE SpA, l’evento clou è stato “Marine Rubbish”, un documentario sull’inquinamento marino. La ricercatrice del CNR Silvia Merlino si è intrattenuta con un uditorio particolarmente colpito dalle immagini e dalle argomentazioni.
Nella stessa serata, sempre in tema “acqua”, sono stati proiettati quattro “cortissimi”, realizzati dai partecipanti allo Stage (che erano stati cimentati in un mini-percorso di doppiaggio); sono state visionate una quindicina di locandine sul “consumo oculato dell’acqua” e, dulcis in fundo, tre attori (Lorella Ghelli, Piero Panattoni e Sabrina Valentini) hanno letto brani con argomento “Acqua”.
Quest’anno è mancata quella “escursione domenicale” che puntava alla visita della magnifica Certosa di Calci o, in alternativa, al Museo di Storia Naturale (uno tra i più importanti in Europa!). Questo perché il ritmo di lavoro era talmente serrato che questo diversivo, pur ambito, avrebbe rischiato di compromettere la giusta conclusione del progetto.
Non sono mancate, invece, le gustose sedute culinarie, le chiacchierate al fresco della sera e … le partite a scopone!
Il tutto in un clima di sereno, propiziato dall’amena collocazione dell’agriturismo ospitante (“I Felloni”) e dalla sua proprietaria, Caterina da Cascina.
Dopo la consegna degli attestati di partecipazioni e le foto di gruppo, il tutto si è chiuso col pranzo finale, a cui hanno partecipato il Presidente Nazionale FEDIC, Lorenzo Caravello, il Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, la Vice Sindaco, Valentina Ricotta e il Responsabile dell’Ufficio Comunicazioni del Comune di Calci, Guido Bini.
Non possiamo tralasciare il fatto che, se la partecipazione allo Stage richiede una quota estremamente contenuta, è dovuto al lavoro gratuito di tanti volontari e ai contributi di FEDIC, Acque SpA, Comune di Calci e Agriturismo “I Felloni”.
Hanno partecipato 22 stagisti, provenienti da 7 regioni (Emilia, Friuli, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana e Sardegna): Nicola Barsottelli, Giacomo Bernardi, Enzo Bruno, Andrea Camerotto, Juana Cattunar, Monica Chiarioni, Oliviero Cini, Andrea Fenu, Gabriella Gatti, Serenella Gatti, Tiziana Graziano, Dario La Rocca, Rosa Liparuli, Luca Meazzini, Giuseppe Modestino, Daniele Murgia, Luca Noli, Maura Oliva, Walter Pagliacci, Carlo Panna, Fabio Ravioli, Giuseppe Squarcio.
Ha diretto lo Stage Roberto Merlino; segretario Maurizio Palmieri; riprese e collaborazione tecnica Roberto Carli, Marco Rosati, Antonio Tosi; supporto logistico e trasporti Giulia Cardinali, Marilena Checchi, Luigi Ducci, Laura Fusi.
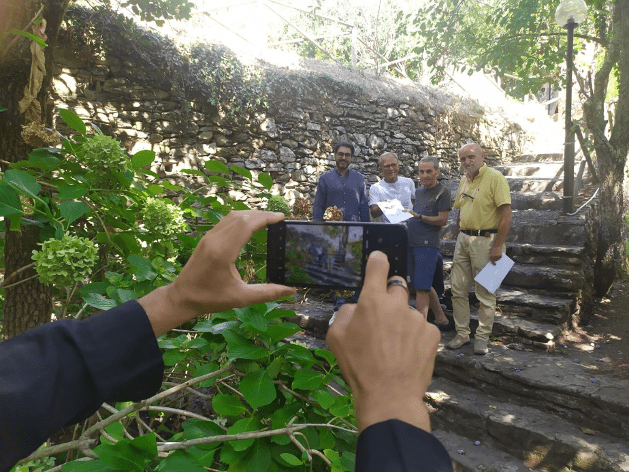
FESTIVAL ED EVENTI
“LOS REYES DEL MUNDO” DELLA REGISTA COLOMBIANA LAURA MORA VINCE LA 70° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN
di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
Per il terzo anno consecutivo, la 70° edizione del San Sebastian Film Festival, tenutosi dal 17 al 25 settembre 2022, ha premiato una regista, la colombiana Laura Mora, con l’ambita Conchiglia d’oro per il miglior film, “Los Reyes del Mundo”, il suo secondo lungometraggio. E’ la storia di cinque giovani sfortunati e tossicodipendenti (attori non professionisti, reclutati dalle strade), che fuggono da Medellín in cerca di fortuna e di futuro. Un viaggio di speranza per uscire dall’umiliazione e dalla miseria ereditate. La giuria, presieduta dal produttore argentino Matías Mosteirín (è subentrato all’attrice americana Glenn Close, assente per gravi questioni familiari), ha premiato un film modesto, solido, crudo e tenero a lo stesso tempo, poetico e ricco di momenti sublimi come il ballo con alcune vecchie prostitute.
Il premio speciale della giuria, il secondo come importanza e a parer nostro discutibile, è stato consegnato a “Runner”, opera prima della statunitense Marian Mathias. Praticamente con pochissimi dialoghi, il film parla di una giovane diciottenne che deve caricarsi il peso di un padre distrutto e malato. Il merito del lungometraggio è la capacità di evocare attraverso piani fissi, un paesaggio interiore spaccato e doloroso. Un’altra opera prima, la giapponese “Hyakka” di Geki Kawamura, si è meritata la Conchiglia d’Argento per la miglior regia. Il film racconta, mediante lunghe sequenze di scatti, la storia di una madre sofferente di Alzheimer con un figlio racchiuso in traumi infantili. Il premio alla miglior sceneggiatura è stato riconosciuto a Wang Xao e Dong Yun per un classico del cinema drammatico cinese “Kong Xiu”. Ambientato durante la rivoluzione culturale cinese, segue la vita di una donna che non si accontenta, supera due matrimoni falliti e lotta per la sua felicità senza voltarsi indietro. Un film dall’estetica molto potente, ma tiepido e poco passionale.
Conchiglia d’Argento alla miglior interpretazione, ex aequo, sono stati consegnati a due interpreti molto giovani, che vestono i panni entrambi di adolescenti che devono affrontare le difficoltà della vita. La debuttante spagnola Carla Quilèz, ha gradevolmente sorpreso la critica per l’ interpretazione di una madre adolescente nel film “La Maternal”, di Pilar Romero. Allo stesso modo, Paul Kircher per “Le lycéen” che, a 20 anni, si impossessa dello schermo con forza, mentre ricrea la trance di affrontare il trauma della morte del
padre in un incidente stradale. Un premio doveroso al film di Christophe Honoré, senz’altro una delle opere più interessanti della sezione ufficiale, che vede Juliette Binoche come la madre del protagonista. La Conchiglia d’Argento alla miglior interpretazione non protagonista è stata consegnata a la piccola attrice, Renata Lerman , del film argentino “El Suplente”, di Diego Lerman. Un ‘insegnante che si occupa di una supplenza, in una scuola di un’area marginale, e le sue difficoltà nel gestire i rapporti con gli adolescenti a cui insegna e con la stessa figlia.
Un segnale di trasgressione in questa edizione del festival è stata il premio alla miglior fotografia a Manue Abramovich, per su discusso e polemico film “Pornomalinconia”. Le difficoltà di un attore porno a causa del lavoro sessuale, la sua salute mentale, l’HIV, la solitudine e malinconia, lo sfruttamento del corpo, il rapporto familiare. Tuttavia, sono stati ignorati film interessante come “Il Boemo”, di Petr Vàclav, “Resten Af Livet” di Frelle Petersen, “The Wonder” de Sebastiàn Lelio o “Walk Up” di Hong Sang-Soo. Spiccano anche
altri premi provenienti dalle diverse sezioni del festival, come il film “Fifi”, di Jeanne Aslan e Paul Saintillan, nella sezione Nuovi Registi. “Tengo sueños eléctricos”, della costaricana Valentina Maurel, in Horizontes Latinos. Il film “Godland”, dell’islandese Hlynur Pálmason, nella sezione Zabaltegi. Il Premio del Pubblico a “Argentina, 1985”, di Santiago Mitre. Il Premio della Gioventù, “A los libros ya las mujeres les canto”, di María Elorza.
I premi Donostia sono stati assegnati a Juliette Binoche, la grande star del cinema d’autore europeo. L’unica attrice ad avere un Oscar, come migliore attrice non protagonista “The English Patient”. Un César, un Bafta ei premi di recitazione dei tre maggiori festival cinematografici europei: Cannes, Venezia e Berlino.
L’altro Premio Donostia è andato al regista e sceneggiatore canadese David Cronenberg, il maestro delle atmosfere inquietanti, con una ventina di film alle spalle, tra cui opere diventate dei classici in generi come la fantascienza, l’horror, il thriller o il dramma psicologico.
La prima mondiale del film “Marlowe”, di Neil Jordan, ha completato una 70° edizione che è stata un sincero e coraggioso impegno per il cinema emergente. I premi vinti da diverse opere prime o seconde, oltre a un’edizione in cui si sono verificate sorprendenti e piacevoli rivelazioni di giovani attori. Tutti i premi per la recitazione sono stati ottenuti da attori di età inferiore ai 21 anni. Vedremo cosa ci riserverà la prossima edizione del festival, appena iniziata.
PORDENONE 41
Le Giornate del Cinema Muto
di Paolo Vecchi
Apertura sontuosa per la quarantunesima edizione delle Giornate del Cinema Muto. Al Teatro Verdi è stato infatti proiettato “The Unknown” (“Lo sconosciuto”, 1927), copia restaurata e accompagnata dalla partitura di José Maria Serralde Ruiz, che ha diretto l’Orchestra San Marco di Pordenone. Sesto in ordine cronologico dei dieci film interpretati da Lon Chaney per la regia di Tod Browning, racconta di Alonzo, un artista circense dall’oscuro passato che finge di essere senza braccia, avendole in realtà legate dietro la schiena. Innamorato della sua partner, Nanon, disgustata da tutti gli uomini che cercano di abbracciarla e toccarla, decide di farsele amputare per poter diventare suo marito.
Il geniale Browning, che aveva praticato il circo prima di approdare alla settima arte sotto l’ala protettrice di David Wark Griffith, con intuizione felliniana ante litteram lo assume come metafora sia della società che del cinema stesso, anticipando in maniera già compiuta alcuni dei temi che innerveranno il suo capolavoro, “Freaks” (1932), adorato tra gli altri dal grande storico della letteratura americana Leslie A. Fiedler, che scriverà un libro con lo stesso titolo. Qui la mostruosità dei normali, generata dalla sete di denaro, si contrappone alla commovente umanità dei cosiddetti fenomeni da baraccone. Il perturbanteChaney, l’uomo dai mille volti, come veniva chiamato ai suoi tempi e come titola il biopic su di lui diretto nel 1957 da Joseph Pevney e interpretato da James Cagney, si contrappone magistralmente alla sinuosa fisicità di una Joan Crawford ventiduenne, sospendendo la narrazione in un’atmosfera onirica che avrebbe incantato i surrealisti, i cultori della psicoanalisi e i cinéfili di più di una generazione, da François Truffaut, che lo cita testualmente in “La signora della porta accanto” (1981), a Guillermo Del Toro, che ne ricrea le atmosfere in “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley”, Leone d’Oro a Venezia 2021. La risata di Alonzo quando, dopo l’intervento chirurgico, scopre che Nanon ha superato la sua fobìa ed é intenzionata a sposare il forzuto Malabar, é ancor oggi una delle immagini più terrificanti che il cinema ci abbia offerto. Il tema della vendetta, con il protagonista che cerca di far squartare il rivale dai cavalli con i quali si esibisce, alla maniera di François Ravaillac, l’attentatore di Enrico IV, anticipa poi “La bambola del diavolo” (1936), cosceneggiato tra gli altri da Eric Von Stroheim e interpretato da un sulfureo Lionel Barrymore, penultimo film e, di fatto, magnifico passo d’addio di Browning, talento incompreso dalla critica e dal pubblico del suo tempo, perciò destinato ad un precoce quanto immeritato oblìo.
Altri titoli di spicco il classico “Nanook of the North” (“Nanuk l’eschimese”, 1922) di Robert Flaherty accompagnato dalla partitura composta e diretta da Gabriel Thibaudeau eseguita da un ensemble che prevedeva un paio di voci di gola Inuit, il meno conosciuto “Borgsaegtens Historie” (“La storia della famiglia di Borg”, 1920), fluviale saga islandese di Gunnar Sommerfeldt, con lo score di Thordur Magnusson affidato ancora una volta all’Orchestra San Marco diretta da Bjarni Frimann Bjarnason, e “Up in Mabel’s Room” (“Nella camera di Mabel”, 1926), di E. Mason Hopper, con la diva Marie Prevost, una pochade piuttosto modesta fatta lievitare dalla dai trascinanti umori swing della partitura composta da Guenter Buchwald che ha diretto la brillantissima Zerorchestra.
Un discorso a parte, se non si rischiasse di sfondare porte ampiamente spalancate, meriterebbe “The Night Owls” (“Ladroni”, 1930) di James Parrot, recuperato dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” nell’ambito del progetto ”S.O.S Stanlio e Ollio: salviamo le versioni italiane di Laurel&Hardy”, sonorizzato con rumori e qualche battuta, quasi a dimostrare che la strepitosa comicità della coppia avrebbe fatto tranquillamente a meno dei dialoghi a venire.
Da segnalare che la fotografia é firmata da George Stevens, che poco più tardi si sarebbe dedicato alla regia.
Tra le numerose sezioni della rassegna particolare rilievo assumeva l’omaggio a Norma Talmadge(1894-1957). Diva a suo tempo amatissima dal pubblico, tanto che il suo nome veniva considerato garanzia di successo al pari di quelli di Chaplin, Fairbanks e la Pickford, e da venire eletta star più popolare di Hollywood da un referendum indetto nel 1921 dalla rivista “Moving Picture World” (seconda arrivò la sorella Constance). Nel 1916 aveva sposato Joseph M. Schenk, futuro presidente del consiglio di amministrazione della United Artists, legame che le attribuì una posizione di forza anche nelle scelte produttive. La sua recitazione essenziale, assai poco da muto, un po’ come quella di Lillian Gish, accompagnata da una versatilità che le consentiva di passare senza sforzo dai ruoli comici a quelli (melo)drammatici, colpisce ancor oggi per la sua modernità, e lascia interdetti la scarsa considerazione in cui gli storici l’hanno tenuta per decenni. Tra i lungometraggi proiettati a Pordenone, caratterizzati quasi sempre da una sottesa carica sociale e da una certa spregiudicatezza sul piano dei rapporti sessuali, segnaliamo “Yes or No”(“Tentazioni”, 1920) di William Neill, in cui la Talmadge interpreta il doppio ruolo della signora frustrata dell’alta borghesia e della moglie fedele e laboriosa di una famiglia povera, che “non ha tempo per annoiarsi”, ”Within the Law” (“L’onestà vittoriosa”, 1923) di Frank Lloyd, dove è una commessa ingiustamente condannata per furto che, uscita di carcere, vuole vendicarsi del proprietario dei grandi magazzini per il quale lavorava e, soprattutto, “The Lady” (“Una vera signora”, 1925) del grande Frank Borzage, dove è la tenutaria di un locale equivoco che in un lungo flash-back racconta ad un cliente la sua disperata ricerca del figlio che aveva dovuto dare in adozione dopo essere stata abbandonata dal marito.
L’evento conclusivo delle Giornate é stato “The Manxman” (1929), ultimo lungometraggio muto di Alfred Hitchcock, con la partitura di Stephen Horne eseguita ancora una volta dall’Orchestra San Marco diretta da Ben Palmer. Anche se non al punto da giustificare il grottesco titolo italiano di “L’isola del peccato”, si tratta di un mélo con tutte le sue costanti pressoché obbligate.
Pete, rozzo ma generoso pescatore di Man, ama Kate, figlia del gestore del pub del villaggio, che non lo vede di buon occhio perché povero e rifiuta il consenso al matrimonio nonostante la mediazione Philip, amico del giovane, studente di legge con l’ambizione di diventare giudice. Pete allora parte per l’Africa in cerca di fortuna, affidando l’amata alle cure di Philip. Tra i due nasce l’amore, contrastato dalla madre di lui, che ritiene disdicevole che il figlio si faccia vedere con una ragazza di umili origini. Quando arriva la notizia della morte di Pete i due si sentono finalmente liberi, Kate si concede a Philip rimanendo incinta. Ma Pete é vivo e torna al villaggio.
Come si può facilmente arguire anche da questa breve sinossi, “The Manxman” allinea quasi tutti gli stereotipi del genere. Ci sono infatti il triangolo amoroso, l’amicizia tradita, le differenze di classe, la difficile scelta tra sentimenti e carriera, il colpo di scena del decesso solo presunto, il figlio della colpa e la necessità dell’espiazione, un contesto di indigenza e un paesaggio la cui natura aspra sembra funzionare da controcanto all’esplosione dei sentimenti. Hitchcock ebbe più di un contrasto con l’autore del romanzo di partenza, Sir Hall Caine, che alla fine ripudiò il film. Che, pur non essendo certo una pietra miliare nella carriera di Hitch, testimonia della sua già acquisita disinvoltura professionale nel misurarsi con un tema non proprio nelle sue corde. Anny Ondra, nome d’arte della ceka Anna Sophie Ondrakova, intensa Kate, sarà la protagonista del ben diversamente significativo “Blackmail” (“Ricatto”, 1929).
ALCUNI FESTIVAL NEL RESOCONTO DI PAOLO MICALIZZI
79. VENEZIA: UNA BELLA E QUALIFICATA EDIZIONE
di Paolo Micalizzi
Una Mostra che nel complesso è estata una bella edizione, confermando ancora una volta la validità della Direzione artistica affidata ad Alberto Barbera che ritorna in questo ruolo a partire dal 2012 dopo averlo ricoperto da 1998 al 2002.
Un buon inizio della Mostra con la proiezione, come pre-apertura, di “Stella Dallas” un capolavoro del 1921 diretto da Henry King con protagonisti Belle Bennet e Ronald Colman in una storia incentrata su una madre pronta al sacrificio per salvare il futuro della figlia. Ed inaugurazione poi con “White Noise” di Noah Baumbach con protagonista Adam Driver nel ruolo di un professore di studi hitleriani che vive in una città del Midwest, con la quarta moglie (Greta Gerwig) e diversi figli, le contraddizioni della società contemporanea finchè la vita di tutta la Comunità non viene sconvolta da un incidente tossico che avvolge la loro area con una nube letale e minacciosa. La proiezione è stata preceduta dalla premiazione con il “Leone d’Oro” alla carriera a Catherine Deneuve, un monumento del cinema. Tra i film visti nei primi giorni della Mostra “Princess” di Roberto De Paolis che affronta il tema spinoso dello sfruttamento illegale della prostituzione nigeriana, raccontando le esperienze di alcune di loro ed in particolare di Princess, interpretata, in maniera convincente, da Glory Kevin, attrice non professionista. Ma anche “Bardo” di Alejandro Gonzales Inarritu in cui il regista messicano, già presente alla Mostra di Venezia con film importanti tra cui “Roma” che nel 2018 gli è valso il “Leone d’Oro”, ritorna a girare a Città del Messico raccontando la storia di un noto giornalista e documentarista messicano che torna nella sua terra per affrontare una crisi esistenziale, chiarire ogni dubbio sulla propria identità e le relazioni familiari, tra ricordi confusi del passato e un Paese che gli offre una realtà completamente nuova.
In concorso anche “Tàr” di Todd Field che racconta la vita di una violinista londinese (una straordinaria Cate Blanchett) che deve affrontare, in un ambiente maschilista, come quello di un’orchestra classica, tante difficoltà e dimostrare le proprie competenze di musicologa. Difficoltà anche nella vita privata, visto che s’innamora di due musiciste.
Luci e ombre nel verdetto ufficiale della 79. Mostra del cinema di Venezia
Ormai è un classico. Le previsioni della critica, e non solo, sui premi attribuiti alla Mostra di Venezia vengono spesso deluse dalle decisioni della Giuria. In pole posizion era il film di Jafar Panahi “Gli orsi non esistono” che avrebbe meritato di più di un Premio speciale della Giuria, assegnato sicuramente per il fatto che il cineasta iraniano si trova ancora in prigione in un carcere a Nord di Teheran ed in quel luogo con molto coraggio continua a fare cinema raccontando con l’aiuto del Web, il clima asfissiante del regime iraniano mescolando storia e realtà. “Gli orsi non esistono” è incentrato su due storie d’amore parallele dove gli innamorati sono tormentati da ostacoli nascosti ed ineluttabili dovuti alle dinamiche del potere.
“Leone d’Oro” quindi, attribuito dalla Giuria presieduta dall’attrice Julianne Moore, al film “All the Beauty” della statunitense Laura Poitras incentrato sulla storia della fotografa Nan Goldin e della sua lotta militante contro la famiglia Sackler della Purdue Pharma che con un suo medicinale devastante per crisi di overdose ha causato la morte di centinaia di persone.
Un film molto interessante certamente ma premiato forse perché diretto da una donna, un concetto ormai diventato di moda nel dare riconoscimenti. Perché “All the Beauty” più che un film è un documentario, e su questo niente da dire, ci mancherebbe. Il fatto è che non possiede, come invece li possedeva “Sacro Gra” di Gianfranco Rosi, giustamente premiato nel 2013 con il “Leone d’Oro”, dei valori cinematografici che dovrebbero essere alla base di un film. Li possiedono invece altri film, fra cui, per esempio, “Bones and all” (Fino all’osso) di Luca Guadagnino che si è dovuto accontentare, e meno male che un premio l’ha ricevuto, del “Leone d’Argento” Migliore regia.
Il film di Guadagnino è una storia d’amore e cannibalismo ambientata ai margini della società americana: è valso anche all’attrice Taylor Russell il premio Marcello Mastroianni dedicato ad una giovane interprete emergente. C’era anche “Gli spiriti dell’Isola” di Martin McDonagh, ambientato su una remota isola irlandese con protagonisti due amici di vecchia data in cui all’improvviso uno dei due (Colin Farrell che per questa sua interpretazione ha ottenuto la Coppa Volpi come miglior attore) rifiuta l’amicizia dell’altro poiché ha deciso di concentrare tutta la sua attenzione alla musica. Anche questo film è stato accontentato con il premio alla migliore sceneggiatura.
Un po’ troppi due premi a “Saint Omer” della francese Alice Diop: bastava forse quello del “Leone del futuro Opera prima” anche se assegnato da altra Giuria. Ma tenendo conto dei rumors, la Giuria ufficiale di Venezia 79 poteva forse tenerne conto. In zona premio potevano benissimo esserci anche gli italiani Gianni Amelio con “Il signore delle formiche” ed Emanuele Crialese con “L’immensità”, ma sono stati esclusi completamente dal Palmares.
Coppa Volpi per la migliore attrice alla Cate Blanchett di “Tàr” in cui riveste il ruolo di una direttrice d’orchestra gay che abusa del suo potere molestando una musicista, e viene travolta quindi da uno scandalo alla Metoo. Un premio forse un po’ scontato.
Numerosa e qualificata presenza del cinema italiano
Cinque film italiani in Concorso a “Venezia 79.”, ma anche un’altra ventina erano spalmati nelle altre Sezioni comprese le due manifestazioni autonome della SIC (Settimana Internazionale della Critica) e di “Le Giornate d’Autore”. Una ricca presenza che, secondo il Direttore Alberto Barbera, significa che il cinema italiano ha realizzato dei film che per la loro qualità meritano di essere presentati ad un Evento importante come quello che a Venezia si svolge sin dal 1932. Sul film di Luca Guadagnino “Bones and Hall” ci siamo espressi ed abbiamo anche scritto che, secondo noi, in zona premio erano “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio e “L’immensità” di Emanuele Crialese.
Il primo è incentrato sulla vicenda del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti che fu condannato a 9 anni di reclusione con l’accusa di plagio, l’aver cioè sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il quale subì per volere della famiglia l’elettroshock e l’ospedale psichiatrico. Una vicenda che Gianni Amelio ricostruisce attraverso la figura di un giornalista (Elio Germano) che seguì il processo a Braibanti (Luigi Lo Cascio) cercando di dire la verità malgrado le censure del periodo. L’altro, ambientato nella Roma degli anni ’70, è un film sulla famiglia e sul rapporto con i figli che tengono unito un matrimonio in crisi. Ma è soprattutto un film sulla madre che riversa tutto il proprio desiderio di libertà sui figli, attentissima ai loro stati d’animo, fra cui c’è Adriana che rifiuta il suo nome, la sua identità, e vuole convincere tutti di essere un maschio. Un’opera sull’innocenza dei figli, e sulla loro relazione con la madre, che ha anche un grande punto di forza nell’interpretazione dai toni molto sensibili di Penelope Cruz.
Da non sottovalutare anche “Monica” di Andrea Pallaoro, con protagonista una ragazza (l’attrice americana transgender Trace Lysette) che torna per la prima volta nella casa della sua famiglia in Ohio, dopo una lunga assenza, per prendersi cura della madre morente. Ma questa che l’aveva sempre rifiutata per il suo essere diversa farà prevalere il suo amore materno.
Un’opera in cui Andrea Pallaoro esplora le complessità della dignità umana e le difficoltà nel guarire le proprie ferite emotive e psicologiche. In Concorso anche “Chiara” di Susanna Nicchiarelli che pone attenzione sulla figura di Chiara che nell’Assisi del 1211 scappa di casa per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia poiché si concentra sulla povertà e sul condurre l’esistenza sempre dalla parte degli ultimi, ai margini di una società dominata dalle gerarchie e da meccanismi di potere. L’intento della regista è di fare di Chiara una figura di ribelle. “Fuori Concorso” un posto di rilevo ha occupato il film di Gianfranco Rosi “In viaggio” che racconta, in forma documentaristica, alcuni viaggi di Papa Francesco, ripercorrendoli visionando i filmati che li documentano.
Ne scaturisce il ritratto di un testimone della sofferenza del mondo guardando cosa vede, cosa ascolta, cosa dice. Un viaggio confortato dalle sue parole e dalla sua presenza in cui sperimenta anche le difficoltà di poter fare di più per l’intera umanità.
In questa Sezione era presenta il film Fiction “Siccità” di Paolo Virzì con una Roma dove non piove da tre giorni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Una Roma, che in questa situazione vede muoversi un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori in cerca della propria redenzione. In questa galleria di personaggi emerge quello di Silvio Orlando. Nella “Non Fiction” figura anche il film di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo “Gli ultimi giorni dell’umanità” che la Giuria del Premio Fedic ha premiato perché “in un alternarsi tra storia personale e del cinema, anni di lavoro premiati dall’aver saputo documentare con straordinaria creatività e profonde riflessioni un panorama delle variegate vicende umane e della natura. E in un turbinio di immagini e di situazioni il film si chiede se gli ultimi giorni dell’umanità sono già fra noi o stanno per arrivare”. Un film dal linguaggio innovativo che Ghezzi ci ha già fatto conoscere attraverso programmi come “Schegge“e “Blob”.
La Fedic ha anche premiato il film di Pippo Mezzapesa “Ti mangio il cuore”, presentato in “Orizzonti”. Ambientato in una Puglia arsa dal sole e dall’odio, nel promontorio del Gargano si riaccende per un amore proibito una faida tra due famiglie da molto tempo rivali: tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss di Camporeale, nasce l’amore e i clan ritornano in guerra. Sarà Marilena (Elodie, la cantante qui in veste di attrice) ad opporsi con forza, desiderosa d’avere un destino diverso. La Fedic lo ha premiato con una Menzione speciale “per aver rappresentato con crudo realismo, in un coinvolgente bianco e nero, un fatto di cronaca legato alla malavita organizzata pugliese lasciando uno spiraglio di positività”.
Premi collaterali alla mostra di Venezia
I premi collaterali assegnati alla Mostra di Venezia hanno da sempre il ruolo fondamentale di porre l’attenzione su alcuni film di particolare interesse, collocati nelle varie sezioni, che i riconoscimenti ufficiali non hanno premiato. Come, ad esempio. “Athena” di Romain Gavras, figlio del regista dell’indimenticabile “Z – L’orgia del potere” Costa Gavras. Un film che mette in evidenza come la Francia, dopo la Rivoluzione del 1789, sia ancora terra di lotte e tensioni ed i valori di libertà, uguaglianza e fraternità non sono realmente applicati e goduti da tutti. Protagonista Abdel che dopo la morte del fratello minore a causa di un presunto scontro con la polizia viene richiamato a casa dalla prima linea e ritrova la sua famiglia devastata. Intrappolato dal desiderio di vendetta e gli affari criminali del fratello maggiore cerca a fatica di calmare le tensioni sempre più aspre, ma la situazione degenera e la piccola comunità di Athena si trasforma in una fortezza sotto assedio.
L’Arca Cinema Giovani lo ha ritenuto il miglior film in Concorso, mentre ha ritenuto come miglior film italiano “Monica” di Andrea Pallaoro. Premiato dal CICT -Unesco “Enrico Fulchignoni” il film “Nuclear” in cui Oliver Stone riflette sull’altra grande fonte di energia, quella nucleare, ripercorrendone la storia partendo dal suo utilizzo bellico per poi passare a quello civile, con la costruzione delle centrali. Un argomento che è sempre stato al centro di grandi polemiche, in parte alimentate anche dai cartelli petroliferi che ovviamente vedrebbero la loro leadership indebolita nello scacchiere mondiale. Premiato dalla Giuria Fipresci, cioè la Federazione internazionale dei Critici, ma anche, con una Menzione, dalla Giuria Signis, Associazione cattolica, il film di Santiago Mitre “Argentina, 1985”, presentato nella Sezione “Orizzonti”. Un film in cui il regista scava nel passato più vergognoso della Storia della propria nazione per tornare sulla dittatura militare che la soggiogò dal 1976 al 1983. Un dramma politico nel quale si racconta la vera storia degli avvocati Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo che osarono investigare sulla “Junta Militar” per ottenere giustizia e vedere riconosciute le sofferenze delle tante vittime di quegli anni.
Premiato dal 10th Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue il film “The Whale” di Darren Aronofsky, che ha anche ricevuto il Premio per il miglior film straniero da parte di Critica sociale. Il film racconta la storia di Charlie, un professore d’inglese che dopo la morte del compagno ha iniziato a mangiare bulimicamente per lenire il suo dolore, arrivando a pesare 266 Kg e isolandosi dal mondo. Il suo unico desiderio è ricostruire un rapporto con la figlia diciassettenne Ellie, abbandonata quando scoprì la propria omosessualità. Per dimostrarle quanto lei sia importante per lui e sia anche l’ultima speranza di riscatto in una vita distrutta.
A ciò di cui ci siamo occupati vi sarebbero da aggiungere tante altre cose essendo stato molto ricco il Programma della Mostra. Non possiamo però non segnalare la Giornata dedicata all’Ucraina con la proiezione di tre film e il pieno sostegno ai tre registi iraniani arrestati (Panahi, Rasoulof, Al-Ahmad). Un chiaro sostegno da parte della Mostra alla libertà di espressione in tutto il mondo.
“INCONTRI” DI SUCCESSO QUELLI DELLA FICE A MANTOVA
di Paolo MIcalizzi
“Incontri”, quelli della FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai a Mantova) che di anno in anno riscuotono sempre più successo. Oltre 500 quest’anno sono stati gli accreditati alla manifestazione e ben 29 le anteprime, film cioè di prossima programmazione. Numeri evidenziati dal Presidente FICE Domenico Dinoia che ha sottolineato anche una grande partecipazione del pubblico cittadino e fatto dichiarare come l’appuntamento FICE sia ormai diventato imprescindibile per i professionisti del settore, aggiungendo anche che nonostante le difficoltà del momento ,tra la ripresa del mercato e il forte aggravio dei costi energetici, è emersa con evidenza la comune determinazione a rilanciare il cinema su grande schermo, con una ricca offerta di qualità per i prossimi mesi. Ed a Mantova, appunto, se ne è vista un’anticipazione.
Ci piace iniziare dal documentario di Francesco Zippel. già apprezzato alla Mostra di Venezia, “Sergio Leone. L’italiano che inventò l’America” che omaggia il visionario regista nel 30° anniversario della scomparsa. Un documentario che ne ripercorre la carriera artistica ed umana attraverso sequenze di suoi film, e le testimonianze della sua famiglia e di icone hollywoodiane come Clint Eastwood, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Eli Wallach, tanto per citarne alcuni, oltre a chi ha contribuito a renderlo celebre scrivendone le musiche, cioè Ennio Morricone. Tanta attesa anche per “Brado” il nuovo film di Kim Rossi Stuart, che anche lo interpreta nel ruolo di un padre che convince il figlio ad addestrare dei cavalli per farlo diventare un campione. E ciò crea la nascita di un rapporto d’amore che era turbato da rancori e ribellioni da parte del ragazzo. Un film tratto da un racconto della raccolta “Le guarigioni”, dello stesso regista. Un film di grande durezza è “Prison 77” del regista iberico Alberto Rodriguez. Ambientato nella seconda metà degli anni ’70 durante la transizione dalla dittatura di Franco alla democrazia, il film trae ispirazione dalla tentata evasione di 45 detenuti dal carcere di Barcellona, puntando l’attenzione soprattutto su un anziano detenuto e un giovane compagno di prigionia. Un film che mostra la durezza della prigionia e la mancanza di umanità da parte dei sorveglianti. Atteso anche “Acqua e Anice” di Corrado Ceron con una straordinaria Stefania Sandrelli nel ruolo di una leggenda del liscio che a 70 anni decide di ritornare sui luoghi che l’hanno resa una star per avere anche l’occasione di rivedere le persone che l’hanno amata. E per questo intraprende un road movie con una donna, timida e impacciata, che le fa da autista e che alla fine scoprirà che il vero scopo dell’ex cantante era di recarsi in una clinica svizzera per l’ultimo atto della sua vita. Un film che nel nostro territorio è atteso anche perché girato nella zona di Comacchio. Interesse anche per “Saint – Omer”, Gran Premio della Giuria e Leone del Futuro all’ultima Mostra di Venezia, con protagonista una giovane scrittrice incinta che segue il processo a una donna accusata di aver ucciso la figlioletta. Un film che porta alla riflessione sulla maternità. Ed ancora un altro film proveniente dalla Mostra di Venezia dove Colin Farrell ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore ed il film è stato premiato con il Leone d’Argento per la migliore sceneggiatura. Si tratta di “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh, apprezzato autore di “Tre manifesti a Ebbing”, che è ambientato in un’isola remota dell’Irlanda dove un’amicizia di vecchia data viene interrotta per volere di uno dei due (Colin Farrell) provocando così una serie di eventi imprevedibili.
Pupi Avati, Giuseppe Tornatore, Fabrizio Gifuni e Francesco Di Leva, sono quattro dei dieci personaggi eccellenti del cinema italiano insigniti quest’anno del Premio FICE alle Giornate del Cinema d’Essai svoltesi a Mantova, giunte alla XXII edizione. Due registi che quest’anno ci hanno regalato dei film importanti come “Dante” ed “Ennio”. Il primo sul Sommo Poeta raccontato attraverso il personaggio di Boccaccio (Sergio Castellitto) ed il secondo su un genio indiscusso come Ennio Morricone. E due attori come Fabrizio Gifuni, straordinario protagonista di “Esterno notte” di Marco Bellocchio in cui ci ha restituito un Aldo Moro perfettamente verosimile. Ma anche Francesco di Leva, particolarmente apprezzato in “Nostalgia” di Mario Marone e “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa.
Tra gli altri che hanno meritato il riconoscimento FICE, la regista franco – svizzera Ursula Meier, di cui in anteprima a Mantova è stato presentato “La ligne – La Linea invisibile “, una regista definita una “visionaria del quotidiano”, talvolta impietosa nel mettere a nudo disfunzioni e sfaldamenti familiari come nel caso della protagonista Margaret che ha un provvedimento restrittivo per aver picchiato la madre(Valeria Bruni Tedeschi) e l’attrice Rosa Palasciano rivelazione del film “Giulia” di Ciro De Caro, anche lui premiato per questo film , grazie al referendum del pubblico. Un film, “Giulia”, che racconta le vicende di una giovane donna irrisolta, piena d’ombre. Altra attrice premiata, Aurora Quattrocchi, protagonista in questi ultimi anni di film d’autore come “Nostalgia” di Mario Martone. Tra i registi, premiata anche Giulia Steigerwalt che con “Settembre” ha realizzato un film di grande finezza psicologica con protagonista una ragazza di 14 anni che finalmente viene notata da un ragazzo di cui è sempre stata innamorata. Poi due autori appartenenti alla sezione “Categorie tecniche”, due grandi professionisti come il montatore Jacopo Quadri e la direttrice della fotografia Daria D’Antonio. Il primo vanta collaborazioni con registi di grande livello come Bernardo Bertolucci, Mario Martone, Paolo Virzi e Gianfranco Rosi, un autore spesso al fianco di esordienti anche nel cortometraggio. La seconda, una professionista che dopo essersi fatta notare al fianco di giovan autori si è distinta ultimamente in “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. I premi sono stati consegnati al Teatro Bibiena in una serata condotta dal giornalista Maurizio Di Rienzo. Alle “Giornate FICE”, tante anteprime e due Convegni sull’ esercizio cinematografico.
Interessante anche l’incontro dal titolo “Non c’è cinema senza sala” in cui sono stati forniti i risultati dell’indagine effettuata nei mesi scorsi presso 150 sale d’essai per analizzare attività, dimensioni e tipologie di programmazione dopo il forzato evento della pandemia.
“Incontri”, quelli della FICE a Mantova, che hanno avuto la presenza in cartellone di nove registe donne e la presentazione di ben 10 opere prime. Un buon segnale del positivo ricambio in corso nel cinema d’autore.
REGGIO CALABRIA FILMFEST, NELLA CORNICE DELLE CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DEI BRONZI DI RIACE
di Paolo Micalizzi
Un ricco programma alla sedicesima edizione del Reggio FilmFest, che ha come Direttore generale Michele Geria e Presidente il regista Mimmo Calopresti. Hanno fatto spicco l’incontro con l’attrice Francesca Neri e l’Omaggio a Raffaella Carrà, ma vi sono state anche alcune masterclass, tra cui quella di Christian Marazziti relativa a Regia e recitazione. Poi una bella selezione di cinema indipendente, proiettata nell’area Waterfront del Lido comunale Genoese Zerbi, a cui la Giuria, presieduta da Massimo Spano, ha attribuito i seguenti riconoscimenti: premio film a “Removable” di Shu – Ying Chung perché “Riesce a farci entrare nell’universo dell’immigrazione e della violenza in profondità, facendoci riflettere sulla complessità di questi due fenomeni così tano dibattuti”; premio Presidente di giuria a “La prova” del crotonese Gaetano Crivaro “per lo sguardo sul territorio che lo circonda raccontando la trasformazione antropologica del territorio stesso”: al cortometraggio è stato attribuito anche il premio come miglior film perché “la scelta di raccontare con uno stile rigoroso, preciso, interiore, con pochissimi movimenti di macchina, nell’essenzialità dell’immagine, riesce ad emozionarci, a farci comprendere meglio la storia che racconta e lascia un segno profondo”; premio della giuria a “Cadde la notte su di me” di Bruno Ugioli e Riccardo Menicatti, un cortometraggio contro la violenza sulle donne che “con una metafora violenta ci racconta le angosce, le disperazioni, di un mondo che ci avvolge sempre di più”. Premiati anche attrici ed attori. Per l’attrice protagonista la scelta è caduta sull’attrice Yi Liu di “Removable” perché “l’essere inquadrata in un primo piano profondo, avvolgente, lascia a questa meravigliosa attrice la possibilità di raccontarci il suo dramma interiore ed esteriore con una scelta sottile che ci fa entrare nel suo dramma, nella violenza subita e nella solitudine percepita”; attore protagonista, Giovanni Esposito di “Le Buone Maniere” di Valerio Vestoso perché “ con una capacità mimetica e nello stesso tempo di controllo preciso dei movimenti, della voce e dei suoi sguardi ci trasmette tutta la solitudine ma anche il riscatto di un bambino ormai adulto che ha subito una delle tragedie più forti che si possa subire: la perdita della madre”. Film e attore sono stati anche premiati dalla giuria della Critica del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) composta da Paolo Micalizzi, Davide Magnisi e Michela Manente perché “la forza interpretativa di un ex telecronista sportivo (resa magistralmente da Giovanni Esposito) rivela, in chiave grottesca, il tessuto sociale di stampo camorristico, superando un discorso stereotipato su quel fenomeno”. La giuria, presieduta da Massimo Spano, ha anche premiato la migliore attrice non protagonista in Natalie Shinnick per “Contrariety” di Sebastiano Pigazzi e Natalie Shinnick perché “con pochi gesti rende il racconto di una famiglia che si sta sgretolando sotto le devianze di una società che gli vive intorno. Asciutta, essenziale, con uno sguardo a volte profondo e a volte languido, ci fa capire il disfacimento di una famiglia”. Ma anche il miglior attore non protagonista in Massimo Dapporto di “Pappo e Bucco” di Antonio Losito perché “con pochi gesti, poche parole, nell’essenza dell’arte attoriale, ci fa capire un tempo passato senza vedere il futuro”.
Spazio anche al “Reggio Film Factory”, una novità assoluta, un vero e proprio “incubatore di idee” dedicato ai giovani under 35, autori, attori, attrici e filmmaker calabresi. Sono state anche presentate le attività della Scuola Cinematografica della Calabria diretta da Walter Cordopatri. Il Direttore Generale del Reggio FilmFest Michele Geria , in un incontro moderato dal Direttore Artistico Gianni Federico e dall’avvocato Giovanna Suriano, ha lodato i giovani attori presenti incentivandoli allo studio e alla formazione “sul campo” specialmente in Calabria , obiettivi anche dell’attuale Film Commission, al fine di attrarre con la propria professionalità le opportunità di partecipare alle produzioni di serie, film e così via dicendo. Auspicando altresì il supporto delle istituzioni e l’incentivo alla formazione delle arti e mestieri cinematografici.
Importante poi è stato l’evento “Dentro le mura” presso l’Istituto Penitenziario di Arghilà, alla presenza di significative Autorità, dove si è discusso di diritti umani, della condizione rieducativa e di reinserimento sociale delle persone private della libertà personale.
Un Festival che si è svolto nel momento in cui a Reggio Calabria si celebravano i 50 anni del ritrovamento dei Bronzi di Riace, alla cui Mostra nel Museo della Magna Grecia, su iniziativa della manifestazione cinematografica, gli ospiti hanno potuto assistere partecipando ad un’intensa emozione culturale di fronte alla visione dei due aitanti guerrieri di bronzo.
UN RICCO E VARIEGATO PROGRAMMA AL DICIANNOVESIMO SEDICICORTO FORLÌ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
di Paolo Micalizzi
Centotrentasei film provenienti da 51 Paesi, scelti tra i 3024 giunti da 118 Paesi, oltre 100 anteprime, 7 Sezioni competitive, 2 “Fuori Concorso”, per 29 programmi di proiezione. Queste le cifre della 19.a Edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival a cui devono aggiungersi 10 Concerti, 9 Industry meeting e spettacoli coreografici che hanno dato vitalità musicale e culturale a questo Festival che sempre più occupa un posto di rilievo nel panorama dei Festival italiani. Ma anche in quello internazionale, grazie alla presenza di numerosi filmmaker provenienti da vari Paesi che ben s’inseriscono nel gruppo di circa 150 professionisti che quest’anno hanno frequentato il Festival forlivese.
Un Festival che il Direttore artistico Gianluca Castellini ha presentato nella Conferenza Stampa, prima dell’inaugurazione, in questo modo: “E’ la passione la leva su cui è stata impostata l’edizione corrente. Una programmazione che tiene salda la certezza della qualità competitiva, con la varietà delle proposte da un mondo ancora capace di storie avvincenti.

Gli argomenti di quest’anno sfiorano diverse aree: si tocca la profondità di strati sociali che combattono una vita quotidiana di sopravvivenza di stenti e di ingiustizie. Si passa alle visioni oniriche di film che attraverso simbolismi più o meno evidenti rispecchiano alcune tradizioni peculiari di alcuni Paesi. Si affrontano i conflitti in ambito lavorativo per fare prevalere i propri diritti e le attitudini personali. Non mancano i protagonisti del mondo adolescente, con le loro ansie, preoccupazioni, i desideri di affermarsi in contesti spesso improbabili, il loro rapporto con un mondo adulto spesso controverso e tormentato, con necessità generazionali diverse e complesse”.
Gianluca Castellini ha anche sottolineato che “il Festival in generale è un trasmettitore di impulsi ed un sistema di aggregazione dove è possibile scambiare idee, confrontarsi sui temi, dialogare con esperti. Un contatto e clima di affiatamento che favorisce una sempre maggior possibilità di crescita del pubblico”. Una situazione che possiamo testimoniare in senso positivo frequentando questo Festival da alcuni anni. Nel corso del Festival vi sono stati incontri fra filmmakers che hanno affrontato temi che riguardano il mondo di chi fa cinema, ma anche fra persone che si occupano di cinema a Forlì allo scopo di creare fra loro una maggiore aggregazione. E tante altre iniziative di arricchimento culturale come quella su “Il centenario” in cui Enrico Gaudenzi si è soffermato su quattro film realizzati nel 1922. Da “Femmine folli” di Erich von Stroheim: un capolavoro “maudit” sul falso splendore di un mondo fasullo di sedicenti aristocratici di cui il regista austriaco sottolinea la meschinità umana e l’ipocrisia sociale a “Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau, un horror – film liberamente ispirato al “Dracula” di Stoker con forti richiami metaforici e simbolici dove il vampiro rappresenta una metafora della tirannia. Ma anche “Hasan – La stregoneria attraverso i secoli “del danese Benjamin Christensen e “Il dottor Mabuse”. Il primo è un’opera, tra il documentario e il dramma, che suscitò scandalo per i contenuti (specie presso le organizzazioni cattoliche) e interesse tra gli studiosi per l’originalità della struttura e il prestigio formale delle immagini, mentre il secondo è uno dei film più celebri del cinema espressionista tedesco: capolavoro della paura, molto inquietante. Ma anche il Cine Book, programma di cineletteratura a cura di Gabriella Maldini, che ha reso omaggio a Pier Paolo Pasolini attraverso l’evidenziazione dei film “Accattone”, “Il Vangelo secondo Matteo” e “Medea”. Iniziative anche sul doppiaggio, sull’animazione, sul cinema iraniano ed ucraino. Ma anche all’autore FEDIC Giampaolo Bernagozzi, di cui è stato presentato “Italicus”, realizzato nel 1974 insieme a Pier Luigi Buganè, un documentario sulla strage del treno Italicus, avvenuta il 4 agosto 1974 a San Benedetto Val di Sambro, realizzato con materiale documentario di manifestazioni dell’epoca.
Cinque le Giurie per l’assegnazione dei Premi della 19.ma edizione del Sedicicorto International Film Festival. Il Premio Movie è stato attribuito al documentario “Alì e la sua pecora miracolosa” di Marythem Ridha(Iraq) incentrato sulla decisione di Alì di sacrificare la pecora Kirmeta che però soffre nel viaggio di 400 chilometri fino allo sfinimento.
Ma grazie alle preghiere della nonna accadrà un evento miracoloso che la renderà una pecora speciale. Una favola, secondo la Giuria, che descrive un viaggio verso la salvezza, contrapponendo la delicatezza dell’animo fanciullesco alla brutalità della guerra irachena. L’”Animalab” ha premiato “Una volta c’era il mare” della polacca Joanna Kozuch, un corto d’animazione sulla memoria da parte degli ultimi testimoni di Mo’ynoq: le sponde originarie del lago d’Aral, oggi prosciugato, che oggi è un deserto di sale. Il Premio “Cortitalia” è appannaggio di “Mammarranca” di Francesco Piras. Protagonisti due bambini che vivono a Sant’Elia, un quartiere popolare della periferia di Cagliari, la cui vita sembra poter cambiare improvvisamente quando il biglietto di un gioco a premi finisce in modo rocambolesco nelle loro mani. Premiata per essere una storia di amicizia, complicità e collaborazione raccontata attraverso lo sguardo puro e libero che caratterizza l’età dell’infanzia, oltre che per la sua qualità stilistica e tecnica. Premio Cortoinloco, cioè ad opere prodotte in Emilia -Romagna, a “Un giorno di vento” di Enrico Poli, riflessioni di un uomo sulla morte che non consente ormai di cambiare un mondo ormai condannato dall’inquinamento. Un modo originale di affrontare una realtà drammatica. Altri premi ancora. Quello attribuito dalla FEDIC, che è stato assegnato alla miglior Opera del Festival, è andato a “Insieme a loro” di Tommaso Ferrara che racconta il rapporto conflittuale di un giovane con la madre mettendo in evidenza con delicatezza un sentimento adolescenziale ricco di pathos e sguardi profondi.
Premi “Animare” all’italiano Maurizio Forestieri per “Hanukhah – La Festa delle Luci”, un corto ambientato nella Roma del secondo dopoguerra dove alla mancanza del necessario per realizzare la festa di Hanukkah, vincerà l’amicizia e la solidarietà. Premio di Cinemaitaliano.info a Laura Samani, regista del film “Piccolo corpo” e Premio del Pubblico al polacco “First” di Adam Hartwinski incentrato su una donna che decide di partorire lo stesso malgrado abbai scoperto che il bambino che aspetta ha una malattia genetica incurabile e, probabilmente, morirà dopo la nascita.
Il cinema d’animazione ha avuto al Sedicicorto International Film Festival un ruolo importante. Gli incontri di Lapix, che hanno avuto luogo al Circolo Aurora, sono stati frequentati da moltissimi giovani interessati a conoscere il mondo dell’animazione. Ed un omaggio è stato reso alla memoria di Giannalberto Bendazzi, che sul cinema d’animazione italiano ha pubblicato alcuni volumi che sono un assoluto riferimento per studiosi ed appassionati. In sua memoria sono stati proiettati sette filma cui lui era particolarmente legato.
L’evento, che è stato presentato da Eric Rittatore che ha ricordato l’importante percorso di Giannalberto Bendazzi nel cinema d’animazione, faceva parte di uno spazio speciale realizzato in collaborazione con le due Associazioni di Cultura Cinematografica CINIT-CINEFORUM e FEDIC.
Ospiti del Festival di Forlì due personaggi molto noti dello spettacolo, gli attori Leo Gullotta e Massimo Foschi, che hanno ricevuto il Premio alla Carriera ed hanno tenuto ciascuno un’interessante masterclass seguita da un numeroso pubblico. Il primo, attivo nel cinema, in teatro ed in televisione ha anche partecipato a numerosi cortometraggi e svolto attività di doppiatore. Un ruolo, quest’ultimo in cui si è particolarmente distinto Massimo Foschi, la cui carriera, come ha ricordato, risale al ridoppiaggio di “Quarto potere” di Orson Welles e vanta anche l’aver dato la voce a Rutger Hauer in “Ladyhawke”.

Di particolare interesse la Mostra su Pier Paolo Pasolini “Cent’anni di luce”, da una frase di Oriana Fallaci nell’intervista fatta allo scrittore – regista, che è stata curata in modo originale dal Direttore artistico del Festival Gianluca Castellini utilizzando opere di artisti internazionali che hanno rielaborato immagini dell’indimenticabile Pier Paolo Pasolini. Tra esse la Sindone Art Tatouage di Gabrio Tassinari, raffigurante il viso di Pasolini con un procedimento di inchiostro impresso in un lenzuolo di lino bianco. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con CINIT-CINEFORUM e FEDIC.
In omaggio al regista è stato proiettato “La ricotta”, episodio del film del 1963 “Ro.Go.Pa.G.” (Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti), con presentazione di Roberto Chiesi, Marco Antonio Bazzocchi e Roberto Cernero.
Un ricordo anche di Giampaolo Bernagozzi, figura storica di grande rilievo nella crescita culturale della FEDIC, anche come autore di alcuni cortometraggi all’insegna dell’antifascismo. Uno di essi “Italicus” del 1974, realizzato con Pier Luigi Buganè, presentato nel corso del Festival suscitando ancora intensi sentimenti di sdegno per il tragico attentato.
PRESTIGIOSI OSPITI E RICCO PROGRAMMA AL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE
di Paolo Micalizzi
Erano dieci i film in Concorso che si sono contesi “L’Ulivo d’Oro Premio Cristina Soldano” alla XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce diretto con passione e capacità da Alberto La Monica, in programma dal 12 al 19 novembre.
L’ulivo d’oro – Premio Cristina Soldano per il miglior film è stato appannaggio del film “A Room of My Own” del georgiano Joseb Bliadze, per decisione della Giuria presieduta da Pascal Diot. È incentrato su Tina, una giovane donna che si è innamorata dell’uomo sbagliato, risultando così “colpevole” per la società, e se ne va a vivere in affitto in una stanza che divide con la vivace Megi. Sarà quest’ultima a farle capire cosa significa essere liberi e poter prendere le proprie decisioni senza dover dipendere dagli uomini. Un film ambientato nella Tbilisi contemporanea che vuole evidenziare come malgrado tutto sia ancora possibile diventare l’artefice del proprio destino.
Il premio del pubblico, e di Cineuropa, è stato attribuito al film Lituano, “9th Step” di Irma Puzauskaite che racconta la storia di formazione di un giovane padre e della sua figlia adolescente. Linas è un padre, dipendente dall’alcol, che rimane isolato e che si riprende quando è attratto dalla migliore amica della figlia, e ciò si trasforma lentamente in un’ossessione. Deciderà allora di focalizzarsi sull’essere un padre migliore per la propria figlia. Il premio Fipresci, cioè della critica internazionale, è stato assegnato al turco “Zuhal” di Nazli Elif Durlu, incentrato su una donna disturbata dal continuo miagolio di un gatto che continua a sentire nel suo appartamento. Un miagolio che nessuno dei vicini di casa sente, ma lei decide lo stesso di andare alla ricerca del felino. La giuria lo ha premiato perché trattasi di “un’idea originale con uno sviluppo intelligente di una storia ingannevolmente semplice, che parte dalla ricerca assurda di un gatto in un condominio dell’alta borghesia”.
Menzione speciale Cinecittà News – Cinema & Realtà, rassegna di documentari italiani in anteprima regionale che intende dare visibilità a temi sociali e culturali di rilievo, a “Milva” di Angelo Domenico Capogna perché è riuscito “ad affermare la capacità del cinema di creare sogno, pur narrando la stringente attualità”. Si tratta di un mockumentary ambientato nel futuro, precisamente nel 2036, un prossimo futuro in cui l’Ilva di Taranto è diventata una fabbrica per la produzione di canapa. Ciò grazie alla riqualificazione dei suoi edifici che porta alla creazione del Museo Milva per lasciare una traccia, una memoria storica di ciò che l’uomo non deve più commettere.
Premio SNGCI “Miglior Attrice/Attore Europeo” alla bosniaca Marija Pikic, protagonista del film “A Ballad” di Aida Begic.
Premi anche nella sezione “Puglia Show”. Per la giuria il miglior corto è stato “San Vito Rock” del salentino Fausto Romano perché trattasi di “una danza narrativa lieve e giocosa, con la tradizione della pietra forata di San Vito a Calimera, che assicura fertilità e benessere”. Menzione speciale a “L’ultimo giorno d’inverno” di Renata La Serra che si aggiudica anche il Premio Unisalento (la regista è nata a Corato, in Provincia di Bari). Ma anche a “Endless Warting” di Francesco Lorusso.
Il Premio Mario Verdone, è la tredicesima edizione, assegnato dai figli Carlo, Silvia e Luca, è stato attribuito al film “Settembre” di Giulia Steigerwait, che racconta alcune storie di amori perduti ed incontri inattesi come quello di Maria che al ritorno dalle vacanze viene finalmente notata dal ragazzo che le piace, il quale attraverso un amico, Sergio, le fa sapere che vuole andare a letto con lei: una proposta che accetta. Un’altra storia riguarda la madre di Sergio che si sta avvicinando ad un’amica con la quale nascerà un rapporto nuovo e più autentico. Un film, secondo la Giuria, tra poesia, malinconia e surreale.
Per il Premio Mario Verdone erano in competizione tre film. Oltre a “Settembre“ di Giulia Steigerwait, “Piccolo corpo” di Laura Samani con protagonista una giovane che , in un’isoletta del Nord Est, partorisce una bimba morta che il prete della comunità di pescatori non battezza. Non accettando questa condizione, la ragazza, su segnalazione di un uomo, porta la figlioletta in una chiesa in cui, dice, vengono risvegliati i bambini nati morti e “Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis che è interpretato da giovani attori ed è ambientato nell’Italia dei giorni nostri in cui alcuni vecchi cacciatori ricordano la storia di Luciano , un ubriacone che viveva alla fine dell’Ottocento in un borgo della Tuscia, che per essersi ribellato al dispotico principe locale è stato reso un reietto per il resto della Comunità: commetterà un atto scellerato che lo costringerà a fuggire in esilio nella Terra del Fuoco al fianco di marinai senza scrupoli alla ricerca di un mitico tesoro che per lui potrebbe significare un’opera di redenzione ma che invece costituirà momenti di tradimento, avidità e follie in terre desolate Premio Emidio Greco a “La vera storia della partita di nascondino più grane del mondo” di Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo e Davide Morando. Un film ambientato a Serravalle Langhe dove la tradizione vuole che ogni anno si giochi una partita in cui tutti si nascondono per onorare la memoria dei partigiani, che durante la Resistenza furono costretti a darsi alla macchia per salvare se stessi e tutto il paese.
In programma Anteprime ed Eventi. Ma anche una Vetrina della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia con una selezione di lavori e film – diploma degli allievi di quel Centro. Alla presenza della Presidente del C.S.C. Marta Donzelli è stato anche presentato, per ricordare Ugo Tognazzi, il film, restaurato, “La voglia matta” (1962) di Luciano Salce. Nell’occasione Ricky Tognazzi ha presentato, intervistato da Laura Delli Colli il libro di Ugo Tognazzi “Il Rigettario – Fatti, misfatti e menù disegnati al pennarello” (Fabbri ediz. Illustrata, 2022). La collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma potrebbe, come anticipato dalla Presidente Marta Donzelli, portare alla nascita a Lecce di una seconda sede, gemella di quella storica romana, in quanto a percorsi formativi. Non una succursale distaccata, ha precisato come le altre già presenti nel Nord Italia e settoriali, ma un vero nuovo Centro Sperimentale di Cinematografia pensato per il Mezzogiorno.
Una notizia, manco a dirlo, accolta con grande entusiasmo da tutti. Alla giornalista Laura Delli Colli si deve anche la presentazione del suo libro “Monica, vita di una donna irripetibile” (Rai Libri, 2022), un ritratto affettuoso e intimo di una grande protagonista del cinema.
Ospiti illustri del Festival il regista – attore Sergio Rubini e la regista francese Claire Denis. Il primo , come protagonista del Cinema Italiano che è stato omaggiato con una Retrospettiva dei film più interessanti della sua carriera e l’altra come protagonista del Cinema Europeo, che oltre ai titoli più interessanti della sua cinematografia è stata omaggiata con la proiezione del suo ultimo film “Incroci sentimentali” nelle sale italiane con Europictures dal 17 novembre, con l’attrice Juliette Binoche divisa tra l’uomo che ama da una vita, interpretato da Vincent Lindon, e l’amante del passato che si rifà vivo inaspettatamente. Ospiti anche Raoul Bova e Violante Placido che hanno presentato in un incontro, coordinato da Enrico Magrelli, insieme al regista Alberto Ferrari il film “The Christmas Show” in Sala a Natale, una commedia natalizia, girata Lecce in piena pandemia 2022, divisa tra reality e meraviglia del quotidiano.
Sostegno all’Ucraina da parte del Festival con una Rassegna di cinque film e un incontro con cineasti, interpreti, produttori e il direttore del Molodist di Kyiv Andriy Khalpakhchi. Ma anche con la regista Solomila Tomashchuck, i registi Andriy Kokura e Maryan Bushan , l’attrice Anastasia Karpenko e la produttrice Olga Matat. Un’opportuna occasione per conoscere attraverso il cinema questa Nazione di cui conosciamo gli ultimi tragici eventi. Gente di cinema che non dimentica però la propria Patria. “Se siamo qui, ha detto la giovane protagonista del film “How is Katia” Anastasia Karpenko , lo dobbiamo al nostro Esercito, ai nostri soldati , che combattono anche per noi”. Proprio il film di cui Anastasia è protagonista ha vinto il premio speciale della Giuria. Racconta di Anna, un paramedico di 35 anni, madre single della dodicenne Katia e mamma a carico, che conduce una vita modesta in un piccolo condominio. Un giorno Katia, scendendo dall’autobus che l’ha portata a scuola, viene investita da un’auto e finisce in coma. A guidare l’automezzo è la figlia di una donna, benestante, candidata a Sindaco della città che fa di tutto affinché la ragazza non sia incolpata. Un film su un’ingiustizia sociale che riflette il dramma di una madre, quella di Katia.
A Lecce il Festival, ideato da Cristina Soldano nel 2000 procede con successo guardando al futuro. Ed il Premio Mario Verdone ben lo rappresenta poiché di anno in anno porta alla ribalta nuovi talenti. Un Festival ben radicato nel territorio come è testimoniato dalla fortissima presenza di spettatori, oltre agli addetti ai lavori. Ed è anche un Festival apprezzato dai Media che, grazie alla squisita ospitalità lo segue con entusiastica attenzione. Un Festival a cui credono convintamente le autorità regionali e locali, come espresso dalla consigliera alla cultura della Regione Puglia Grazia Di Bari che afferma che il Festival del Cinema Europeo di Lecce “rappresenta un motivo d’orgoglio per la Puglia intera” e che esso è “un momento importante di confronto e dialogo tra culture” e “un momento che rende ancora più importante il valore del cinema come racconto e formazione per le giovani generazioni”. O quella del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini che sottolinea come il Comune sia ancora al fianco degli organizzatori del Festival che costituisce anche un’opportunità sotto il profilo turistico – ricettivo.
Sull’importanza del Festival si esprime anche il Direttore artistico Alberto La Monica che ne sottolinea il valore del dialogo, dello scambio culturale e dell’incontro di punti di vista, elementi che rappresentano l’unica arma che il Festival del Cinema Europeo vuole impugnare “proponendosi al cuore dell’Europa come un’offerta culturale posta sull’altare del confronto e della pace”. Sottolineando ancora che “è questa un’edizione che si lascia alle spalle un periodo di paure, limitazioni, e contenimenti dolorosi e che recupera la serenità del ritrovarsi in una sala cinematografica tutti insieme, per celebrare un rito fatto di arte, cultura, confronto e incontro”.
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO
Storia del cinema in formato ridotto
“N.U. – NETTEZZA URBANA”
di Roberto Baldassarre
Regia: Michelangelo Antonioni; Fotografia: Giovanni Ventimiglia; Consulenza musicale: Giovanni Fusco; Organizzazione: Vieri Bigazzi; Durata: 11:04 (24 fotogrammi al secondo)
“N.U. – Nettezza urbana” (1948) è un tassello fondamentale nello sviluppo della filmografia di Michelangelo Antonioni, poiché segna una prima sperimentazione di linguaggio. Un “cortometraggio ponte”, che collega il “primordiale” periodo dell’autore ferrarese, ancora legato agli stilemi e ai contenuti del Neorealismo, alla fase in cui, di pellicola in pellicola, il regista lavorerà pervicacemente sulla ricerca espressiva. Un’opera non del tutto compiuta formalmente, perché acerba (è il secondo lavoro come regista per Antonioni) e perché le due anime (forma documentaristica e sperimentazione visiva) non si amalgamo sempre adeguatamente.
Michelangelo Antonioni
Nato a Ferrara il 29 settembre 1912, e morto a Roma il 30 luglio 2007, Antonioni è stato uno dei maggiori autori del cinema, che ha dato prestigio, con le sue pellicole, alla cinematografia italiana. Un autore che ha saputo scansare sin da subito il provincialismo narrativo, vezzo di molti registi nostrani, e raccontare storie, di livello internazionale. Antonioni si è distinto anche sul versante della tecnica (di ripresa, di montaggio e di fotografia), stando al passo con i tempi e, a volte, in anticipo (purtroppo con il fallimentare “Il mistero di Oberwald”, del 1980). È stato etichettato come “regista della crisi”, poiché le sue storie hanno per protagonisti personaggi inquieti, ed è stato definito anche come “regista dell’incomunicabilità”, per la difficoltà degli stessi personaggi a rapportarsi con gli altri. Una filmografia corposa e unica, che va dal travagliato documentario “Gente del Po” (1943-1947) fino al cortometraggio muto “Lo sguardo di Michelangelo” (2004). Nel mezzo, opere a volte diseguali nel risultato – diverse aspramente contestate dalla critica – ma accomunate da quell’inclinazione di raccontare quelle tematiche con procedimenti differenti, che possano esprimere al meglio il disagio esistenziale del personaggio, come ad esempio il colore in “Il deserto rosso” (1964) oppure la scena finale di “Professione: reporter” (1975), realizzata con un complesso piano sequenza.
Crisi che ha colpito anche la sua carriera, poiché la prima fase che va da “Cronaca di un amore” (1950) a “Il grido” (1957), è stato soltanto un susseguirsi – ingiusto – di insuccessi commerciali. E “Il grido”, una delle vette espressive di Antonioni, è la perfetta maturazione di quella ricerca abbozzata in “N.U. – Nettezza urbana”. Lungometraggio d’ambientazione proletaria, quindi d’origine neorealista, in cui il regista indaga i sentimenti dei personaggi, pertanto creando un differente approccio all’argomento: nel Neorealismo si creava una cronaca esterna (le condizioni sociali), mentre ne “Il grido” una cronaca interna (la crisi). Maggior fortuna ebbe con la seconda fase, avviata con “L’avventura” (1960), Premio della Giuria a Cannes e terminata con “Il deserto rosso”, Leone d’oro a Venezia. Fase legata anche alla collaborazione con Monica Vitti, musa ispiratrice e compagna di Antonioni. Questo periodo è principalmente noto per la “Trilogia esistenziale”, composta da “L’avventura”, “La notte” (1961) e “L’eclisse” (1962). Opere in cui prevale sempre più l’alienazione tra personaggi e ambiente, oltre alla difficoltà di rapportarsi con gli altri, causa incipiente aridità dei sentimenti.
Sempre alla ricerca di nuovi stimoli espressivi, Antonioni va a indagare la crisi dell’individuo e l’alienazione all’estero, come evidenzia la parabola filmica che va da “Blow Up” (1966) a “Professione: reporter”. Un percorso che sottolinea anche come il regista sia attento alle realtà sociali che possono coinvolgere gli individui, e cerca di capirle. “Blow Up” si svolge in piena Swinging London; “Zabriskie Point” (1970) prende avvio dalla contestazione giovanile; “Chung Kuo, Cina” (1972) è un personale reportage di uno straniero in terra straniera. “Professione: reporter”, invece, sebbene sia girato in differenti ambienti peculiari (Africa, Londra, Monaco, Barcellona), fa risaltare la difficoltà del personaggio a sentirsi parte dell’ambiente, quasi come ne “Il grido”.
Infine, l’ultima fase, che va da “Il mistero di Oberwald” fino a “Lo sguardo di Michelangelo”. Un lungometraggio realizzato da solo, “Identificazione di una donna” (1982) e uno co-diretto con Wim Wenders, l’episodico “Al di là delle nuvole” (1995), mentre le restanti opere sono cortometraggi, con cui Antonioni comunque sperimenta ancora. In più, il videoclip “Fotoromanza” (1986), dell’omonima canzone di Gianna Nannini, in cui il regista si approccia al nuovo formato e “gioca” con l’arcaica computer grafica. Una fase “avara” di realizzazioni anche a causa dell’ictus che lo colpì a dicembre del 1985, e che lo rese quasi completamente invalido.
N.U. – Nettezza urbana
Il cortometraggio è la cronaca di una tipica giornata di lavoro dei netturbini romani, che va dall’alba fino alla sera. Questo è lo sfondo della storia, e anche l’avanzamento della narrazione, ma su questo punto di partenza documentaristico, Antonioni abbozza i primi esperimenti visuali. Permane lo sguardo neorealista, facilitato anche da una Roma post-guerra e dalla committenza Luce, ma l’intenzione del regista è quello di mettere in risalto l’interiore di questi netturbini. Questi “paria” che si muovono per la città, e sono fondamentali per la città, alienati dalla medesima città. Un’alienazione ancora primitiva, poiché va tenuto in conto anche la classe a cui appartengono i netturbini: proletari e sottoproletari.
Il principale aspetto documentaristico, ossia la voce fuori campo che ci presenta l’argomento in maniera didattica, viene rapidamente eliminata, e successivamente il commento alle immagini sarà lasciato a un tappeto musicale minimale: qualche accordo di sax o pianoforte. Colonna sonora composta da Giovanni Fusco, che sarà un fondamentale collaboratore del regista, fino a “Il Deserto rosso”, e che vinse un Nastro d’argento per le musiche di “Cronaca di un amore” e “L’avventura”. Una musica di commento scarna e quasi “metafisica” che fa risaltare maggiormente la solitudine dei netturbini e l’ambiente alienante della Capitale. C’è ancora qualche scena legata – troppo – al neorealismo, come ad esempio il netturbino che guarda la vetrina dei salumi, oppure il piccolo “diverbio” tra un netturbino e un barbone, ma prevalgono anche quelle scene anticipatrici del cinema maturo di Antonioni. Il pranzo tra gli spazzini, che sebbene in gruppo, quasi tutti stanno per fatti loro; l’uomo e il bambino che raspano tra la spazzatura su di un camion, e l’uomo trova una vecchia maschera di carnevale e la indossa. L’espressione della maschera e lugubre e, al contempo, parodica. Ma la scena più emblematica è quella finale, in cui uno spazzino si avvia verso casa. Il taglio dell’inquadratura, un campo lungo, predilige l’ambiente desolato (una lunga strada desolata, popolata solo da un lontano edificio e una fila di pali), e il netturbino è soltanto una piccola e anonima figura rispetto a ciò che lo circonda. Una scenografia alienante e arida, che anticipa le scene finali de “L’eclisse”, che si soffermano, attraverso i dettagli, su particolari minuti dell’ambiente.
Così Michelangelo Antonioni si espresse riguardo il suo secondo lungometraggio, in un lacerto contenuto nel volume monografico curato da Giorgio Tinazzi, per Il castoro: “ […] sentivo il bisogno di eludere certi schemi che si erano venuti formando e che pure erano allora validissimi… Cercai di fare un montaggio assolutamente […] libero poeticamente, ricercando determinati valori espressivi non tanto attraverso un ordine di montaggio che desse con un principio e una fine sicurezza alle scene, ma a lampi, a inquadrature staccate, isolate, a scene che non avessero nessun nesso l’una con l’altra ma che dessero semplicemente un’idea più meditata di quello che io volevo esprimere e di quella che era la sostanza del documentario stesso; nel caso di N.U., la vita degli spazzini in una città”.
OCCHIO CRITICO
“LICORICE PIZZA”: QUANT’È BELLA GIOVINEZZA…
di Francesco Saverio Marzaduri
“Sai quelli che non ci voglion bene
È perché non si ricordano
Di esser stati ragazzi giovani
E di avere avuto già la nostra età…”
GIANNI PETTENATI
Che funzione ha, prima d’ogni altra, quel chewing-gum da sempre associato alle più giovani fasce d’età? Quella di masticarlo incessantemente, spesso più del necessario, immemori del tempo che scorre dietro quel vizio ed eventualmente surrogandone altri meno salutari. Il sapore sbiadisce via via, finché la ripetitività dell’atto non si fa meccanica e priva di gusto. Un po’ come il “grande freddo” della sfera adulta. Nel caldo magma di recensioni inerenti “Licorice Pizza”, nono lungometraggio di Paul Thomas Anderson, l’accostamento non s’ipotizza immediato. Come suggerisce la “poetica della nostalgia”, ereditata da quel Nuovo Cinema Americano di mezzo secolo fa mai del tutto accantonato, i tropi impiegati dal cineasta nella restituzione della San Fernando Valley del ’73 si muovono su un asse spaziotemporale tanto inestricabile, nell’iperrealista effigie, da trasmettere la sensazione che l’anno in oggetto non trascorra mai. Quand’anche cospicuo sia il corollario di eventi immortalato, e l’autunno dell’età dietro l’angolo. Magari è questo, nel film, il segreto della riuscita giacché, coinvolto nelle vicissitudini dei due giovani protagonisti, lo spettatore si rilascia romantico auspicando che succeda dell’altro e la conclusione si tenga il più lontano possibile. Il prodotto, per celia del Fato, esce nelle sale italiane nell’identica settimana in cui scompare William Hurt: il che rammenta come ogni generazione serbi i propri iconici volti, nella misura in cui si sottovaluta il corso del tempo e tardivamente se ne lamentano i mutamenti. Caramella (o meglio, chewing-gum) di oltre due ore, “Licorice Pizza” trasmette una sensazione d’immediata empatia dal frizzante sapore, la cui effervescenza non sortirebbe il medesimo effetto senza le tipologie al suo centro: figurine ordinarie all’apparenza e tuttavia non comuni, le cui fisionomie – nonostante un incipit da classico “teen movie” – non rispondono a quelle tradizionali, appariscenti e fantomatiche. Caschetto castano tutto lentiggini l’uno, avvenenza compromessa da un naso arcuato l’altra, divisi da dieci anni d’età, Gary e Alana suscitano la simpatia del pubblico in virtù di imperfezioni caratteriali e antitetiche scelte, la cui inspiegabile vicinanza rende complementari e spinge a cercarsi con sentimento ogni volta maggiore (“Io non ti dimenticherò e tu non mi dimenticherai”, chiosa uno dei due). Di fatto, il lavoro di Anderson non è che un perenne tira e molla irto di incontri-scontri, dispetti, ripicche, liti e riappacificazioni, puntellato di sorrisi, attriti e riabbracci, nel prolungato tentativo di ritardare la condizione adulta, quand’anche la brama di emularne la trasgressione, compreso l’atto di fumare, rientra in una dimensione meramente ludica (la canzonatura di Gary ai danni d’una vanesia star del palco). Luogo canonico caro anche a Baumbach, qui tra l’altro manifestato da un simulacro di Herman Munster mentre concede autografi in uno stand, la recita della (e con la) vita informa di sé l’intero assunto, permettendo a entrambi i personaggi di atteggiarsi a ciò che non sono, giocando alle persone mature senza esserlo, ignari delle disillusioni a venire; irremovibile resta la voglia di scherzare, beffare (e beffarsi), godendosi ogni attimo d’irripetibile freschezza. Non per nulla, senza trascurare “long take” o lenti “zoom”, il regista-sceneggiatore ostenta l’irresistibile verde età prediligendo “ralenti” speculari a marcatissimi primi piani, in cui i “faccia a faccia” della schermaglia finto-adulta sono vanificati, nell’impellente fatica di crescere, dal genuino anelito della spensieratezza (l’ipotetica vita su Marte intonata dal “Duca Bianco” Bowie nell’assortita colonna musicale). Un transito da dissipare in fretta, scandito dai timbri di Sonny e Cher in “But You’re Mine”, senza consentire di valicare il limite (la riluttante Alana accetta di mostrare i seni a Gary, non permettendogli di toccarli); e altrettanto ineluttabile è la paura di fronte a una repentina infrazione “bigger than life”, quando, catechizzata dall’amico nel tentativo di vendere un materasso ad acqua, Alana fa la provocante al telefono, con le gambe in bella mostra sul tavolo. L’iridata gamma di mansioni accentua l’inversa (inseparabile) tempra, lungo il labile (irreprimibile) filo dell’Assurdo, nell’illusorio sforzo di emergere nel “climax” post-sessantottino: di volta in volta l’uno è liceale, attore, comparsa, imprenditore, e l’altra assistente d’un fotografo, socia in affari di Gary, valletta promozionale e operatrice di campagna elettorale. Quattro sono le volte in cui i personaggi si perdono e ritrovano: segno che l’atteggiamento materno di Alana “vs.” l’infantilismo del partner, dietro la superficiale intraprendenza, non evade da un’usuale condizione di prigionia (la famiglia ebrea di lei: opprimente e sputasentenze nei confronti d’un “boyfriend” ateo, eppure favorevole a Gary), e in analoga misura il rapporto tra i due oscilla come il camion in panne che la ragazza è costretta a guidare in retromarcia, in piena notte, lungo le strade californiane. Che il tempo sia una costante geometrica, e ogni volta l’amichevole “ménage” si rinsaldi attraverso gradazioni superiori, è confermato da un paio di delicati episodi: la reciproca telefonata, sotto lo sguardo dei rispettivi fratelli, cinta da un mutismo insostenibile mentre scorrono i minuti, e l’inquadratura dall’alto che riprende i ragazzi come silhouette su un materasso, volendo quasi accostarne i fisici senza che qualcosa lo concretizzi (“You gave me something / I understand / You gave me loving in the palm of my hand”, canta McCartney in sottofondo). Non insensibile agli affreschi corali, da “Sydney” passando per “Magnolia”, Anderson compone il mosaico sullo sfondo d’un Paese ancora lontano dal revanscismo reaganiano, di lì a non molto testimone della fine della “sporca guerra”, la cui presidenza Nixon è al centro del noto scandalo e la politica, da un pezzo, ha rivelato aspetti poco edificanti: l’embargo sul petrolio fa capolino sin dal titolo in riferimento a una popolare catena di negozi di dischi, giacché il vinile, i materassi, la gomma serbano comune origine; né manca l’aura d’inevitabile paranoia, irrompendo drammatica nell’arresto di Gary per errore (“Divertiti ad Attica, coglione!”, apostrofano gli sbirri). Linea d’ombra che in “Licorice Pizza” incornicia la dolorosa iniziazione all’interno d’un juke-box coloratissimo, pervaso di brani diegetici: la malinconica rievocazione riesuma l’espediente d’una “soundtrack” pressoché ininterrotta, come in tanti illustri antecedenti, fungendo da componente testuale – “frame” e comprimaria a sua volta – nella rappresentazione d’una perduta chimera.[1] E alla fluidità, e all’armonia che fa del film una sorta di “American Graffiti” postmoderno, contribuisce una metabolizzazione cinematografica mai fine a sé stessa: “I ponti di Toko-Ri” o Lucille Ball s’insinuano, anacronistici, come le apparizioni di Tom Waits e Sean Penn nelle caratterizzazioni di Peckinpah e William Holden (qui ribattezzato Jack), laddove il salto in moto sulla rampa infuocata riecheggia lo Steve McQueen de “La grande fuga”. Si tratti di assiomi o ideali proiezioni, Tarantino colpisce ancora nella macchietta dello schizzato parrucchiere impersonato da Bradley Cooper – citazione condita di esorbitanti stramberie, nel quale il “cinephile” individuerà il Warren Beatty di “Shampoo”, modellato su quello vittima della strage di Bel Air. Benché i prototipi non s’arenino, da Bogdanovich a Scorsese e a Cassavetes (i familiari di Alana recano i loro stessi nomi anagrafici), Anderson opta dichiarato per una semplicità in cui “merchandising” e petrolio – elementi non inconsueti nella sua produzione – non camuffano la diabolica parvenza dell’alienazione (i precedenti Barry Egan, Daniel Plainview, Freddie Quell, Lancaster Dodd sono lì a dimostrarlo). E nulla può sostituire quel senso di casuale avventura, finanche venato di orrifica tensione, che obbliga la protagonista ad allontanarsi indurita, pur talvolta sghignazzando sotto i baffi alle balordaggini del compagno. Prima che una cronaca di fallimenti, “Licorice Pizza” è la radiografia del tangibile miraggio ove il fardello della responsabilità, per sfuggire all’imprigionante apatia, s’impelaga in velleitarismi ancor meno appaganti: potenziale quintessenza dell’emisfero maturo, la politica non è l’illuminazione in cui Alana vagheggia il riscatto, ma un’ulteriore utopia di cui diffidare. Non rimane che ritrovarsi sotto una sala che, guarda un po’, proietta “Live and Let Die”: un “magico accordo” del destino ancorché bizzarro, la cui scintilla scocca quando Gary si riverbera, all’inizio, nello specchietto di lei (“Sono sempre stato qui… Sento che dovevo incontrarti”). Il filo nascosto che nell’epilogo – forse per l’ultima volta, forse no – li carpisce “one from the heart”, senza volersi smarrire, ubriachi d’amore; gioiosa, la corsa continua prima che sia di nuovo tardi (“Domani potresti non esser felice”, commenta il relativo brano di Taj Mahal). Esperimento rinascimentale o vizio di forma? Di sicuro, nella rappresentazione d’una cotta importante, Anderson è figura sufficientemente stabile nel neo-umanesimo filmografico: solo chi è stato innamorato, o ha avuto la propria scottatura, può comprendere perché la confezione sia una chicca, semplice in tutta la sua potenza. Anderson è lì per ricordarlo, nella fattispecie in tempi odierni in cui non lo si ricorda mai abbastanza. “Chi vuol essere lieto, sia”…
[1] Non si dimentichi che l’interprete principale è membro del complesso Haim, nel quale suona pianoforte e chitarra, e annovera anche le sorelle Este e Danielle.
IL SIGNORE DELLE FORMICHE DI GIANNI AMELIO
di Tullio Masoni
Felice chi è diverso/Essendo egli diverso/Ma guai a chi è diverso/Essendo egli comune. Dall’aforistica poesia di Sandro Penna, Amelio traeva, nel 2014, un film raro. Sull’omosessualità? Certo. Sulla differenza? Certo. Ma soprattutto, mi sembra, su una umanità finalmente osservata. Finalmente. Cioè dopo il vedere, e dopo il distinguere e il ragionare. Una sorta di scultorea pulizia; l’umano che, osservato, umano ritorna, a dispetto della rumorosa blandizie mediatica a venire (cioè di oggi), dello spettacolo narcisista o, anche, della cronaca nera.
Capita che uno stesso argomento sia affrontato in anni vicini da autori diversi. Nel 2020 fu presentato alla Mostra di Pesaro “Il caso Braibanti”, un film di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese che ebbe il Premio del pubblico. Per Carte di Cinema ne scrissi a suo tempo, ma credo valga un richiamo. Si tratta di un collage audiovisivo condotto dalla testimonianza di un nipote dell’artista: Ferruccio. L’“ibrido” – questo termine, invece che “non fiction”, credo andrebbe usato per classificare i film che non rispondono alle tipologie di finzione, pur integrandole talvolta, né a quelle del documentario classico – spazia sull’eclettica attività creativa di Braibanti (1), oltre che sulla persecuzione, e si conclude con una poesia detta da Lou Castel: un frammento visivo in otto o superotto.
Il film di Amelio, ha dichiarato lo stesso autore nell’intervista/anteprima rilasciata a Emanuela Martini per Cineforum (2), avrebbe potuto essere il documentario che inizialmente fu proposto a Marco Bellocchio. Non convinto del progetto Amelio ha poi accettato di girare un film di finzione. Il fine ultimo, per lui, era comunque raccontare una storia d’amore.
Vale anche ricordare che lo scandalo ebbe nella fase del processo e della sentenza una eco pubblica considerevole. La stampa conservatrice e moderata insisteva sull’omosessualità e sul plagio – cioè la presunta riduzione in schiavitù di due giovani allievi – quasi in controtendenza non solo rispetto ai fermenti del ‘68, ma di un’intera fase, gli anni sessanta, che aveva visto la trasformazione, pur contraddittoria e per certi aspetti paradossale, della cultura di massa giovanile e del senso comune. A favore di Braibanti ci furono appelli di intellettuali illustri (Elsa Morante, Alberto Moravia, Umberto Eco, Cesare Musatti, Franco Fortini, Vittorio Gassman fra gli altri) e testimonianze in aula. A queste ultime parteciparono redattori e collaboratori della rivista Quaderni piacentini; una rivista collocata a sinistra del PCI che nei mesi del processo pubblicò un editoriale e, successivamente, un lungo articolo: Una lezione di violenza, firmato con pseudonimo dallo psichiatra basagliano Giovanni Jervis. Quanto all’impegno delle forze politiche il Partito Radicale di Marco Pannella si batté senza risparmio (di qui, nel film, il cameo dedicato a Emma Bonino) come anche i periodici ABC e Astrolabio, mentre il Partito Comunista – sottolineò lo stesso editoriale dei Quaderni Piacentini – pose fine ai tentennamenti “di tradizione” piuttosto tardi. Con ciò il fondo del direttore dell’Unità Maurizio Ferrara (13 luglio ’68) commentava l’arringa del p.m. Lojacono in modo durissimo: Processo aberrante, fu il titolo di un pezzo che denunciava il «persistere dell’intreccio tra un codice vecchio e classista e una magistratura avviata a formarsi su di esso…» per poi proseguire additando il marciume clerico-fascista italiano e della provincia piacentina in particolare.
Nel già accennato intento di raccontare una storia d’amore, Amelio ha scelto di tenere assieme memoria, melodramma, e creazione di personaggi; la memoria si può riconoscere in un’accorata rivisitazione dei luoghi (Roccabianca, soprattutto, che gli è sembrato un borgo rimasto fermo nei secoli), il melodramma nel commento con brani verdiani – poi l’Aida all’aperto nel finale -, la creazione di personaggi in certa tensione alla teatralità dove il primo piano (sempre amato dal regista) incide con frequenza e durata fino a diventare esplicito mezzo sublimante. A questo si combinano le prospettive e i campi lunghi anche in interno; una costante che riporta, fra altri, all’arretramento di soggettiva nel bellissimo incipit di “Colpire al cuore”.
Funziona, questa difficile scelta drammaturgica? Ed è consona alla personale interpretazione che Amelio vuole applicare ad avvenimenti lontani? A mio avviso solo in parte. Se da un lato sembra infatti subire una certa smagliatura dei tempi d’insieme, dall’altra potrebbe sacrificare l’irrinunciabile recupero di un “clima” sociale e di costume.
“Il signore delle formiche” – signore, cioè, di un’alterità anche scientifica, etica e filosofica – è assai curato nel testo, e con momenti luminosi: « Io non sono come loro, ma sono anche come loro…» cui dà linfa la prova di attori che vanno ben oltre il prestigio e il mestiere. Notevole, infine, l’affidamento ai personaggi femminili. Da “La stella che non c’è” Amelio volge lo sguardo alla donna come a una parte di sé stesso. Qui ci propone la madre di Enrico, la ragazza che avrebbe potuto essere la sua fidanzata, l’attivista, soprattutto la madre di Braibanti (l’anziana e magnifica Rita Bosello); un personaggio epico in una ricerca che è lirica ma non epica; una donna di carattere contadino per la dignità, e amorosa nel sacrificio.
NOTE
1 – Aldo Braibanti – si legge in epigrafe all’inizio del film – ex partigiano, poeta, filosofo, uomo di teatro, nel 1968 fu protagonista di un processo che divise l’Italia (…) divenne il nostro processo a Oscar Wilde. Con un secolo di ritardo
2 – n. 7 (nuova serie), settembre 2022
CRONENBERG PADRE E FIGLIO
“CRIMES OF THE FUTURE”, DI DAVID CRONENBERG; “POSSESSOR”, DI BRANDON CRONENBERG.
di Paolo Vecchi
Tenser pratica una sorta di body art estrema. Con l’aiuto di Caprice, un tempo chirurgo, esibisce le proliferazioni tumorali prodotte dal suo corpo. Per tutelare questa attività si iscrive ad un apposito registro degli organi. In seguito viene a contatto con un’organizzazione sovversiva di mangiatori di plastica, un membro della quale gli propone di fare pubblicamente l’autopsia del figlio, soffocato per vendetta dalla moglie separata. Contemporaneamente, sulle tracce della setta si muove un ispettore dell’unità speciale Nuovo Vizio.
Nel 1970 un David Cronenberg praticamente agli esordi, dopo l’interessante “Stereo” (1969), girato con mezzi di fortuna, aveva realizzato un primo “Crimes of the Future”, su un cancro che induceva nel fisico del protagonista la comparsa di nuovi organi e, di conseguenza, un brusco mutamento dal punto di vista psicologico.
Dirigendo un lungometraggio dallo stesso titolo otto anni dopo, “Maps to the Stars” (2014), il regista canadese sembra voler tornare alle origini, riproponendo temi e stilemi che hanno caratterizzato buona parte della sua cospicua filmografia. Ritroviamo qui, infatti, l’erotizzazione del corpo sconvolto, come lo chiama Ermelinda Campani in un suo saggio, ad esempio quella che ha come tramite gli incidenti d’auto provocati dai personaggi di “Crash” (1996), al fine di esibire ferite e mutilazioni che essi considerano stimolanti dal punto di vista sessuale. O l’idea di viscere perforate dai VHS come in “Videodrome” (1983), per le quali varrebbe la pena di organizzare concorsi di bellezza, come afferma uno dei gemelli interpretati da Jeremy Irons in “Inseparabili”(1988). Servendosi della preziosa collaborazione della scenografa Carol Spier, sua irrinunciabile sodale, crea inoltre uno spazio allucinato il cui arredamento é costituito da inquietanti oggetti di uso più o meno comune quali il letto sospeso OrchidBed, la seggiola Breakfaster che, come suggerisce il nome, aiuta a mangiare e digerire, probabilmente memore dell’analoga macchina per nutrire gli operai del chapliniano “Tempi moderni”, o Sark, un avveniristico sarcofago per le autopsie, oltre a strumenti fallici capaci di penetrare nei ventri, di trapiantare orecchie o creare nuovi orifizi. Forse avendolo pensato come summa, o film testamentario che dir si voglia, con “Crimes of the Future” più che altrove Cronenberg ambisce a considerazioni alte: sull’osmosi uomo-macchina, terreno su cui si spende da tempo certa fantascienza letteraria, sulla chirurgia come sesso del futuro (un Tenser quasi divertito di fronte alle profferte dell’assistente del direttore ormai introdotto microparticelle di plastica nei polmoni di ciascuno. In proposito, il regista, che ha da poco girato un video di un minuto sulla propria morte, ha dichiarato:”Volevo dare l’impressione che tutte le tecnologie del nostro tempo hanno mostrato i loro limiti…sottolineare l’opposizione tra questo mondo della decomposizione e questa tecnologia strana, risultante dalla fusione dell’organico e della meccanica. Piuttosto che fare della science fiction, volevo instillare un sentimento nato da questa combinazione insolita”. Proprio in quanto film definitivo, “Crimes of the Future” ripercorre dunque un repertorio più volte frequentato. Ma, come spesso accade, l’accumulo non ha come contraltare un significativo alleggerimento sul piano narrativo, i dialoghi appaiono sentenziosi e assertivi, l’abituale sapienza fantasmagorica della messa in scena non riesce a sottrarlo alle secche e alle pesantezze del déja vu.
Brandon Cronenberg, classe 1980, arrivato al secondo lungometraggio dopo “Antiviral” (2012), sembra incamminato sulle tracce di tanto padre nell’avventurarsi in un futuro che oggi é quasi d’obbligo definire distopico. Anche la sua opera seconda, “Possessor” (2020), disponibile su Amazon Prime, esibisce una tecnologia che permette di entrare nel corpo e nella mente di un altro.
Più che sugli sviluppi filosofici o metascientifici, tuttavia, sembra concentrarsi su quelli meramente narrativi, con la protagonista-killer che dapprima usa le sembianze di una hostess, poi del fidanzato della figlia di un disgustoso magnate, per compiere i delitti a lei commissionati. A parziale contrappunto, Cronenberg junior racconta come le sue imprese criminali trovino una difficile integrazione con gli affetti familiari. Film scopertamente di genere, “Possessor” alterna momenti di tensione a passaggi a vuoto, confermando tuttavia una già solida professionalità.
L’IMBONITORE E L’INTRATTENITORE: ELVIS, UNA STORIA AMERICANA
di Marco Incerti Zambelli
È il rapporto tra ‘il colonnello Tom Parker’, autodefinitosi ‘the snowman’, letteralmente ‘uomo di neve’ (ma il termine ‘snow’ nello slang significa ‘inganno, falsità’, e diventa ’imbonitore’ nella versione italiana) ed il suo protetto, ‘the showman’ l’uomo spettacolo Elvis Presley, che Baz Luhrmann mette al centro del suo racconto sulla parabola classica (ascesi, trionfo e caduta) della vita del Re del Rock and Roll. Ed è la voce del colonello ad introdurci alle vicende, dal suo punto di vista naturalmente, rifiutando le accuse di brutale sfruttamento e continuo ladrocinio nei confronti del cantante.
I primi venti minuti di “Elvis” sono un susseguirsi frenetico di immagini, lo schermo arriva a divedersi in otto split, intreccia cartoons a sogni e fantasie, i suoni si sovrappongono, i personaggi attraversano tempi diversi delle loro vite in un succedersi caleidoscopico che pare sopraffare lo spettatore. Vengono enunciati tutti i temi portanti della vicenda: il talento naturale di Elvis, il suo irresistibile sex appeal, l’amore profondo per la musica nera, dal blues da bordello ai sacri gospels, la grande stima ed amicizia con i cantati di colore, l’enorme affetto per la madre, una timidezza ingenua non disgiunta dalla certezza del proprio valore , ed anche la diabolica abilità di Parker nell’imbastire affari e nel legare Presley alle sue volontà, il cinismo di uno sfruttamento che utilizza tutti mezzi fino alla dipendenza fisica, l’asservimento del colonello al demone del gioco.
Senza perdere lo stile barocco ed enfatico tipico del regista, il narrare si fa poi più disteso e consequenziale, la irresistibile ascesa di Elvis dilaga dal Sud a tutti gli Usa, grazie anche alle apparizioni televisive ed emerge anche la volontà del cantante di non cedere ai diktat del perbenismo che vorrebbero cancellare la esuberanza erotica delle sue esibizioni, ‘ se non mi muovo non riesco a cantare’, dimostrandosi più lungimirante delle preoccupazione del manager, culminante nel clamoroso successo al concerto di beneficenza nel quale esprime tutta la sua carica sessuale. Luhrmann mostra in questo frammento tutta la sua maestria nel montaggio, alternando immagine della performance, il reazionario discorso del politico conservatore, la preoccupazione del colonello, la partecipazione di Elvis alla musica dei ‘soul brothers’ di colore, da Sister Rosetta Sharp a B.B.King e a uno strepitoso Little Richard, l’esplosione del pubblico giovanile , soprattutto femminile, fino all’irruzione della polizia a bloccare la musica. E poco importa la veridicità storica del racconto, il regista australiano mette in scena il “suo” Elvis, che se da un lato accetta di buon grado la sosta dovuta al servizio militare e il rimanere invischiato nella realizzazione di insulsi filmetti musicali mentre desidererebbe seguire le orme di James Dean o Marlon Brando, rimane capace di sinceramente commuoversi alla uccisione di Martin Luther King e di Robert Kennedy e di imporre la sua visione della sua musica , della sua arte, nel clamoroso ritorno nello speciale del Natale del 1968.
Alla fine comunque sarà la sagace abilità del colonello ad irretirlo definitivamente nella gabbia dorata di Las Vegas, in una lussuosa ma patetica decadenza appena accennata nel film, fino alla morte prematura.
Alvin Butler, alle spalle un po’ di televisione e piccole parti con Jarmusch e Tarantino, è un carismatico Elvis, capace di immedesimarsi nel personaggio al di là della mimesi, con un accurato lavoro di preparazione ed uno studio approfondito nel riprodurre sonorità e accenti nel parlato e nella musica che sarebbero da apprezzare nella versione originale così come l’accento tra il sudista e l’olandese di Tom Hanks, fin troppo caricato di una pesante protesi che comunque non ne inficia la prestazione a conferma dello straordinario talento. Se la fotografia e montaggio, come già accennato, sono all’altezza dello sfolgorante inventiva di Luhrmann, il lavoro sulla colonna sonora è assolutamente prodigioso: non potendo utilizzare le prime incisioni di Presley per la scarsa qualità delle registrazioni, regista ed attore ricostruiscono con maniacale precisione le sonorità della nascita del Rock and Roll per poi progressivamente mixare originale e cover fino alla riproposizione dell’ultima ripresa in video di Elvis, ingrassato e sudato eppure ancora capace di provocare brividi interpretando ‘Unchained Melody’. Da non perdere i titoli di coda impreziositi da un remix di ‘In the ghetto’, un pezzo inedito di Eminem e la cover dei Maneskin di ‘If I can dream’ la canzone impegnata di Presley composta alla morte di Martin Luther King.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
LA BELLEZZA SCACCIA LA VERGOGNA
“Letizia Battaglia. Shooting the mafia”
di Marcello Cella
“Ho cercato di trasformare la realtà, di piegarla a mio favore: la pancia di una donna nuda, sulla quale l’occhio si ferma, davanti ad un uomo ammazzato, che diventa marginale, ti aiuta a dimenticare quel morto, a superare quell’immagine di morte con la vita. In poche parole ho aggiunto ad una foto di morte una foto di vita. La bellezza che cancella la vergogna”
Letizia Battaglia in “Mi prendo il mondo ovunque sia”
C’è una foto, fra le tante della sterminata opera fotografica di reportage di Letizia Battaglia che racconta come poche altre il senso di tutto il suo lavoro sulle immagini della realtà. La foto si intitola “La bambina e il buio” e raffigura, nel suo fortissimo contrasto in bianco e nero, una bambina, ripresa in piena luce, su una strada di Palermo. La bambina è vestita elegante, forse deve partecipare a qualche cerimonia, non sorride ma si rivolge alla fotografa con un gesto di vanità infantile stirandosi la gonnellina plissettata. Di fianco a lei però dal buio vagamente minaccioso emerge una figura maschile. Anche lui è vestito elegante e porta un paio di occhiali scuri da sole che ne nascondono lo sguardo. Anche lui rivolge il suo sguardo verso la fotografa facendo un gesto con la mano sul fianco che ne vuole sottolineare l’autorità, la forza, una forza che si annuncia non amichevole. Dietro di lui, in secondo piano e quasi completamente immersa nel buio si avverte una figura femminile di donna matura, in una posizione che si rivela anche visivamente subalterna. Potrebbero essere i genitori della bambina o forse no. Non è importante saperlo. Quello che è invece importante è che questa fotografia sintetizza tutta l’opera della fotoreporter Letizia Battaglia che ha raccontato come pochi la sua città, Palermo, con una forza visiva impressionante, il contrasto viscerale tra il bene e il male, tra la luce e il buio per l’appunto, in un bianco e nero che non lascia scampo ad inutili estetismi. Kim Longinotto, documentarista inglese, figlia di un fotografo, con una vita tormentata alle spalle come la Battaglia e autrice da sempre attenta alle problematiche del mondo femminile, le dedica un ritratto fedele ed appassionato giocando nel titolo con il termine inglese “shooting” che si riferisce sia all’atto di fotografare, sia a quello di sparare.
Alla mafia. Letizia Battaglia del resto è stata una temibile avversaria della mafia siciliana e soprattutto della cultura mafiosa che ne costituiva il brodo di coltura, con le sue miserie, la sua violenza, la sua sciatteria estetica, la sua ignoranza, la sua povertà culturale e valoriale. Per quanto la fotografa siciliana abbia lavorato a lungo anche a Milano e all’estero viene quasi sempre identificata e conosciuta per la sua impressionante mole di fotografie che ritraggono la sua città a cui l’ha sempre legata un rapporto viscerale di amore e odio. Quasi una malattia, come lei stessa ammette. La regista inglese concentra la sua attenzione soprattutto su questo tratto distintivo della sua opera, ma senza tralasciare altri aspetti altrettanto importanti della sua biografia raccontata in modo emozionante e spesso lancinante dalla sua stessa protagonista. Gli anni giovanili, i sogni spezzati da una cultura maschile violenta ed oppressiva, incarnata prima dal padre e poi dal marito, sposato giovanissima, il malessere psicologico che la conducono prima in clinica psichiatrica e poi in analisi, il rapporto bello e profondo con le sue figlie, l’amore per la sua città e la sua gente, soprattutto la più povera e reietta, e infine la sua salvezza, con la scoperta della fotografia a quarant’anni. Una passione che si trasforma in lavoro nei 19 anni passati al quotidiano palermitano di sinistra “L’Ora” e la possibilità di raccontare l’orrore della violenza mafiosa, la corruzione delle classi dirigenti siciliane colluse con gli uomini di Cosa Nostra e la terribile miseria in cui vivevano le classi sociali più povere. Un’opera, quella di Letizia Battaglia che presto trascende la cronaca nera e quella giudiziaria per raccontare una condizione umana degradata e una città che tutti i giorni deve fare i conti con la sua consolidata malattia impegnandosi nelle sue parti migliori nel tentativo estremo di contrastarla, di sanarla, di far emergere un’altra immagine di sé stessa, un’altra città possibile. E allora ecco le fotografie di Falcone e Borsellino, ritratti nei loro rari momenti di serenità, che poi la Battaglia si rifiuterà di fotografare da morti per rispetto nei loro confronti, ma anche per non fornire alla mafia alcun appiglio visivo della sua forza devastante che potrebbe in qualche modo rafforzarne l’immagine e legittimarla all’interno della società siciliana e palermitana. E poi l’impegno in politica, la partecipazione esaltante alla prima giunta Orlando della cosiddetta “Primavera siciliana”, eletta con i Verdi e assessore alla vivibilità urbana, con i tanti progetti piccoli e grandi realizzati in quel periodo. Ma anche, infine, l’abbandono della politica attiva, quando, eletta all’assemblea regionale si rende conto di essere stata parcheggiata in una dorata e confortevole posizione sociale, priva però di alcun potere nel cambiare la vita delle persone. E quindi il ritorno a tempo pieno alla fotografia, che continua ad essere per lei visione etica e politica, in quel rapporto viscerale con la realtà e con sé stessa che il mezzo consente e spesso pretende. “Penso che con la macchina fotografica si possa esprimere ciò che si è in una commistione unica con la realtà. Riesci ad esprimere te stesso riprendendo il mondo. Lo porti dentro, dentro una macchinetta e riesci a raccontarlo raccontando insieme te stessa.

E’ qui, insomma, in questo duplice racconto, che nasce la bella fotografia”, afferma Letizia. Una bellezza che non nasce dall’estetica, ma dalla necessità di realizzare immagini che possano andare al di là del puro dovere di cronaca per trasformarsi in affresco vitale di una città, della sua storia utilizzando anche tecnicamente quegli strumenti, come il grandangolo, che le possano consentire quel corpo a corpo con la realtà, quel superamento della distanza fra macchina fotografica e realtà che è un tratto distintivo di tutta la sua opera fotografica, debitrice dichiarata del neorealismo cinematografico frequentato da giovane nelle sale cinematografiche palermitane, milanesi e parigine. “Consiglio di fotografare tutto da molto vicino, a distanza di un cazzotto, o di una carezza”, afferma Letizia. Perchè la realtà può essere orribile, ma può anche ritrarre e raccontare la bellezza. Come dimostra tutta un’altra parte della sua opera, quella dedicata alle bambine, a quelle bellissime bambine palermitane vestite di stracci, ma dalla sguardo fiero e severo, che osservano l’adulta che le fotografa con uno sguardo interrogativo e duro come un atto d’accusa. Come uno sparo che infrange il vetro fragile dell’ipocrisia e denuncia senza sconti un mondo adulto che le costringe ad abbandonare i loro sogni e le loro speranze. Non ci sono attenuanti nelle bellissime e spesso terribili fotografie in bianco e nero di Letizia Battaglia, la radiografia di una sconfitta e di una speranza lanciata alle generazioni future, ma c’è sempre un atto d’amore, quello che lei racconta alla regista inglese e che condivide con i suoi amanti-complici delle sue avventure professionali, l’amore per Palermo e per la sua gente, per il suo popolo che non sempre accetta con fatalismo un destino già scritto dai potenti di turno e dai loro sgherri, ma che spesso si ribella e fa emergere la sua parte migliore con Falcone, Borsellino, Peppino Impastato, Rocco Chinnici e i tanti piccoli eroi dimenticati che Letizia racconta in “Shooting the mafia”. “La fotografia la amo e la ringrazio perchè mi ha salvata (…). Mi ha costretta a vedere l’orrore, mi ha invitato a cercare la bellezza”.
“Letizia Battaglia. Shooting the mafia”
Regia: Kim Longinotto
Produzione: Irlanda
Anno di realizzazione: 2019
Anno di uscita: 2020
Durata: 97’
PANORAMA LIBRI
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
Gian Piero Brunetta
LA MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA. 1932 – 2022
La Biennale di Venezia – Marsilio Biblioteca, 2022
Pagg. 1179, Euro 42
Non poteva che scriverla lui una Storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Una Storia che parte dalla prima edizione del 1932, svoltasi sulla Terrazza dell’Hotel Excelsior, ed arriva ad oggi. Lui è Gian Piero Brunetta, un grande storico del cinema italiano, ma non solo avendo curato anche una Storia del cinema mondiale ed un Dizionario dei registi del cinema mondiale, con la collaborazione di altre autorevoli firme internazionali. Questa Storia della Mostra del Cinema di Venezia l’ha scritta da solo
attraverso una ricerca molto impegnativa che ha riguardato “un intreccio di cultura, politica e correnti artistiche che raccontano un secolo d’immaginario del nostro Paese”. Una Storia della Mostra di Venezia che secondo Roberto Cicutto e Alberto Barbera è “Un tentativo di riordinare i ricordi, dare un senso compiuto all’infinità di suggestioni e stimoli suscitati dal susseguirsi implacabile e nondimeno caotico delle edizioni, riportare alla luce fatti, personaggi e soprattutto film di cui si era persa la memoria, che è sempre selettiva e non sempre in maniera corretta e generosa”.
Una Storia monumentale, questa di Gian Piero Brunetta, che attraversa 18.000 film, dall’avvento del sonoro fino alla realtà virtuale raccontata anno per anno senza trascurare i risvolti politici ma anche gli scandali avvenuti alla Mostra, a partire dal nudo integrale di Hedy Lamarr nel film “Estasi” di Gustav Machaty, del 1934. Un libro che riporta alla memoria del cinefilo anche le stroncature subite da tanti film, compresi alcuni insigniti del “Leone d’Oro” come “La strada” (1954) di Federico Fellini fortemente osteggiato allora dalla critica di sinistra.
Una Mostra da cui sono passati tantissimi Divi, celebri e non celebri, a partire dalla prima edizione del 1932 quando sulla terrazza dell’Excelsior si potevano ammirare, tra gli altri, Joan Crawford, Greta Garbo, Clark Gable, James Cagney, John Barrymore, Renè Clair, Frank Capra, King Vidor, Ernst Lubitsch. Howard Hawks.
Suddiviso in sei parti il libro ne racconta storia e storie vissute nei 90 anni di vita. La prima parte riguarda il Progetto del Lido, ed i tre artefici che hanno portato alla “Prima Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica” del 1932 proseguendo con quella del 1934, essendo allora Biennale, ed arrivando al 1942, ultima Mostra di guerra. La seconda parte, prende l’avvio nel 1946 con la direzione Zorzi e la volontà di rinascita per arrivare al 1959 quando vi fu un “Leone condiviso per il cinema italiano”. Il riferimento è a “Il Generale della Rovere” di Roberto Rossellini ed a “La grande guerra” di Mario Monicelli. La terza parte ha inizio dalla Direzione Lonero (“una meteora”) del 1960 a “L’anno della contestazione” del 1968., e la quarta dal 1969 della direzione di Ernesto G. Laura alla “Biennale del dissenso” del 1977. La quinta parte riguarda la direzione nel 1979 di Carlo Lizzani fino al 1997 dove si era “In attesa della riforma”. Ultima parte poi con “La Biennale diventa Società di cultura”, siamo nel 1998, sino al 2020 con il capitolo “Il coraggio di aprire un nuovo capitolo nella storia dei festival internazionali” con la nuova presidenza della Biennale di Roberto Cicutto e la continuazione alla direzione artistica della sezione cinematografica di Alberto Barbera, periodo in cui hanno dovuto affrontare il lockdown.
E ad aiutare nella lettura, la Bibliografia essenziale, l’indice dei film e dei nomi, un grandissimo ed utile lavoro che uno storico come Gian Piero Brunetta non poteva non tenere presente, che rende questa Storia della Mostra un punto di riferimento unico per studiosi ed un’appassionante avventura culturale per il lettore.
Paolo Speranza
DANTE E IL CINEMA
Gremese Editore, 2021
Pagg. 223, Euro 24
Quando si era in attesa di vedere il film su Dante realizzato da Pupi Avati, per conoscere l’attenzione che il Sommo Poeta ha avuto dal cinema era giunto opportuno il libro di Paolo Speranza “Dante e il Cinema”. Contiene una vasta filmografia relativamente ai film ispirati alla vita e alle opere dell’autore della “Divina Commedia”. Il libro edito da Gremese, a cura di Enrico Giacovelli, ripercorre la parabola del filone dantesco nel cinema mondiale lungo le coordinate temporali (dal muto al sonoro) e geografiche, dal cinema americano delle origini a quello italiano, dalla Francia alla Germania, fino ad Hollywood, contestualizzando i singoli film (molti dei quali perduti) secondo la ricezione culturale dell’opera di Dante e l’evoluzione artistica e tecnica del cinema, organizzando i documenti finora disponibili e offrendo ai lettori informazioni inedite e preziose. L’autore, quindi offre ampie informazioni su alcuni film fondamentali nella filmografia che riguarda il rapporto tra Dante e il Cinema. A partire dalla figura di “Francesca da Rimini” che già nel 1907 ebbe una versione cinematografica ad opera della Vitagraph Company di New York che si avvalse come fonte di ispirazione dell’omonima tragedia in cinque atti di Gabriele D’Annunzio( anche se non accreditato nei titoli di testa) che, annota l’autore, dalla “prima” romana del 9 dicembre 1901 continuava a riscuotere un vasto successo nei teatri di tutto il mondo, grazie anche all’interpretazione di Eleonora Duse che negli USA godeva di una popolarità immensa . Nel 1910 vi fu un Remake e nel 1911 l’Italia inviò in America la superproduzione “L’inferno di Dante” che rivoluzionò il nascente cinema hollywoodiano.
Un’altra figura importante è stata Pia de’ Tolomei che nel 1908 fu portata sullo schermo da Mario Caserini con il titolo “La Pia de’ Tolomei” seguita da un’altra versione nel 1910 realizzata dalla FAI e da un’altra nel 1921 diretta e sceneggiata dal produttore e regista Giovanni Zannini. Poi nel 1941 esce un “Pia de’ Tolomei” interpretato da Germana Paolieri per la regia di Esodo Pratelli. E nel 1958 un altro film interpretato da Ilaria Occhini e Jacques Sernas e diretto da Sergio Grieco. Anche la figura di Beatrice all’attenzione del Cinema: tra i film girati ve ne è uno con la Diva Francesca Bertini diretto dall’irlandese Herbert Brenon. Sullo schermo anche “Il Conte Ugolino”: Iniziò Giovanni Pastrone (è l’autore del Kolossal “Cabiria”, 1914) nel 1908 e ha concluso Riccardo Freda nel 1949. Molte le pagine poi dedicate a “L’inferno” prodotto dalla Milano Film (che ebbe come concorrenza quello della Helios Film) che si sofferma anche su “Maciste all’inferno” (1925) di Guido Brignone con interprete Bartolomeo Pagano, un gigante, ex scaricatore di porto, che già lo portò sullo schermo nel già citato “Cabiria”. All’inferno ci è andato anche Totò in un film del 1955 diretto da Camillo Mastrocinque. Non poteva poi mancare “Una vita di Dante”. Ci ha pensato Vittorio Cottafavi che lo realizzò nel 1965 per la televisione chiamando ad interpretarlo Giorgio Albertazzi e Loretta Goggi. Ma tante e tante ancora sono le notizie sui film citati e su altri dell’intera filmografia su Dante e il Cinema che si trovano in questo prezioso libro di Paolo Speranza, fondamentale per conoscere ed approfondire un rapporto che conta anche documentari, film d’animazione e videoarte, come testimoniato dalla Filmografia pubblicata a conclusione del libro, ricchissimo di fotografie.
A cura di Nicole Bianchi
DE SICA, IO E IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI. DIARIO INEDITO DEL PROTAGONISTA
Bietti Cinecittà, 2022
Pagg. 190, Euro 15
Si tratta di un Diario inedito di Lino Capolicchio, scritto di getto al tempo degli accadimenti (quasi completamente nel 1970) in cui l’attore racconta molti episodi inediti sulla realizzazione del film “Il giardino dei Finzi Contini”, tra cui quello relativo a come sia arrivato ad avere il ruolo di protagonista. Un Diario che racconta il capolavoro di Vittorio De Sica prima, durante e dopo la lavorazione in un’ampia intervista raccolta da Nicole Bianchi per Cinecittà negli ultimi due anni di vita dell’attore. In essa vengono ripercorse le tappe e i retroscena private e pubbliche, di un film che per Capolicchio, scomparso durante la stesura del libro, “rimane di una bellezza in cui ancora ti rispecchi”.
Dalle pagine che il grande attore (anche regista e sceneggiatore) scriveva con penne di diversi colori, come avverte la giornalista Nicole Bianchi, prendono vita la dialettica tra set e quotidianità, la lievità insaziabile degli amori, la passione per la musica, pittura e cinema (anche come spettatore), la dedizione a un mestiere intrapreso per talento naturale, sempre coltivato con umiltà e reverenza.
Da questo Diario autobiografico che Lino Capolicchio ha compilato ogni giorno da quando frequentava l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, emerge anche il grande affetto che aveva per la madre Eufemia, “una donna istriana, un pochino rigida, severa nell’educazione: una persona che si capiva che mi amava ma faceva fatica a darmi un bacio, non era scontato, te lo dovevi meritare”. Ed io, scrive nel Diario, vivevo come Proust in questa sorta di ansia domandandomi “Sarò piaciuto a mia madre, abbastanza da meritare il bacio, o no?” Mi sentivo, continua, sempre sotto esame, lei con me non era tenero, le mie eventuali malefatte le sottolineava con la matita rossa! Non concedeva repliche”. Una madre a lui molto vicina, come la nonna, due donne per le quali nutriva un grande affetto. Pagine scritte con sentimento che leggendole rivelano una vita intensa di amori, e di conoscenze del mondo del teatro e del cinema (soprattutto Giorgio Strehler e Pupi Avati) che gli hanno riempito una vita di emozioni vissuta con grande passione.
Per la cronaca segnaliamo che alla Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice Stefania Sandrelli ha rivelato che il ruolo di Micol interpretato da Dominique Sanda doveva essere suo, e per questo motivo aveva fatto un provino. Apprese di non essere stata scelta non dal regista e neanche dal produttore bensì da Dominique Sanda, di cui era amica, che parlando con lei la informò che il prossimo film che avrebbe interpretato sarebbe stato “Il giardino dei Finzi Contini” in cui avrebbe rivestito il ruolo della protagonista, Micol.
A cura di Marco Antonio Bazzocchi, Roberto Chiesi, Gian Luca Farinelli
PIER PAOLO PASOLINI
“FOLGORAZIONI FIGURATIVE”
Edizioni Cineteca di Bologna 2022
Pagg. 311, Euro 23
“Folgorazioni figurative” è il titolo di questo Catalogo relativo alla Mostra su Pier Paolo Pasolini allestita dal 1° marzo al 16 ottobre 2022 nel Sottopasso di Re Enzo a Bologna. Una Mostra organizzata per i 100 anni di Pasolini a Bologna, curata da Marco Antonio Bazzocchi, Roberto Chiesi e Gianluca Farinelli, rispettivamente responsabile dell’Archivio Pasolini e Direttore della Cineteca di Bologna. Le “folgorazioni figurative” sono le immagini delle opere di Masaccio che Roberto Longhi proiettava in aula e di cui Pasolini fu allievo nella città felsinea per vent’anni: il professore di Storia dell’Arte a cui Pasolini dedicò il suo secondo film “Mamma Roma” del 1962. Una Mostra che vuol condurre il lettore attraverso gli anni della formazione di Pasolini, pittore e poeta, fino ai suoi esordi cinematografici ed alla sua fama di intellettuale e regista. Ogni film di Pasolini viene rivisto nella Mostra con l’occhio rivolto a quelle “folgorazioni figurative” della sua formazione. Tenendo presente che attraverso il cinema Pasolini ha espresso la trasformazione antropologica dell’Italia, dal dopoguerra agli anni del neocapitalismo borghese. E le immagini della Mostra, secondo i curatori, sono diventate la forma stessa del suo pensiero di azione politica. Un pensiero che trova nel cinema il luogo dove tornano a vivere le memorie di mondi infiniti e lontanissimi. E l’inizio nacque proprio dalle riproduzioni in bianco e nero che Pasolini studente non ancora ventenne aveva osservato in quella piccola aula di via Zamboni dove il famoso critico d’arte insegnava. Ad approfondire la visione dell’arte che Pasolini ha poi espresso nel suo cinema troviamo nel Catalogo alcuni interventi, che analizzano profondamente il senso delle “folgorazioni figurative”, dovuti a studiosi dell’opera di Pasolini evidenziando ogni aspetto con testimonianze tratte dagli scritti dello scrittore e regista friulano, dovuto alla sua lunga permanenza nell’infanzia a Casarsa, ma che a Bologna dove è nato ed ha vissuto gli anni della formazione. I curatori della Mostra, molto pertinentemente, hanno accostato immagini pittoriche a quelle cinematografiche facendo capire al visitatore le origini di certe inquadrature, evidenziando così come il gusto cinematografico di Pier Paolo Pasolini non sia di origine cinematografica, ispirata a questo o quel Maestro, ma figurativa. E nel Catalogo questi accostamenti valgono come una grande lezione di critica d’arte e di critica cinematografica. Immagini che ripercorrono tutta la filmografia di Pier Paolo Pasolini che comprende favole e parabole, i volti della borghesia, il sogno del presente e il genocidio dell’ultimo film che va considerato come il suo testamento e il ritratto apocalittico dell’intolleranza del potere.
CREDITS
Carte di Cinema 28
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E. Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 28 della rivista online, Danilo Amione, Roberto Baldassarre, Paola Brunetta, Marcello Cella, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Roberto Merlino, Paolo Micalizzi, Alessandra Pighi, Elisabetta Randaccio, Marco Rosati, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Xoxan Villanueva, Luciano Volpi, Marco Incerti Zambelli.