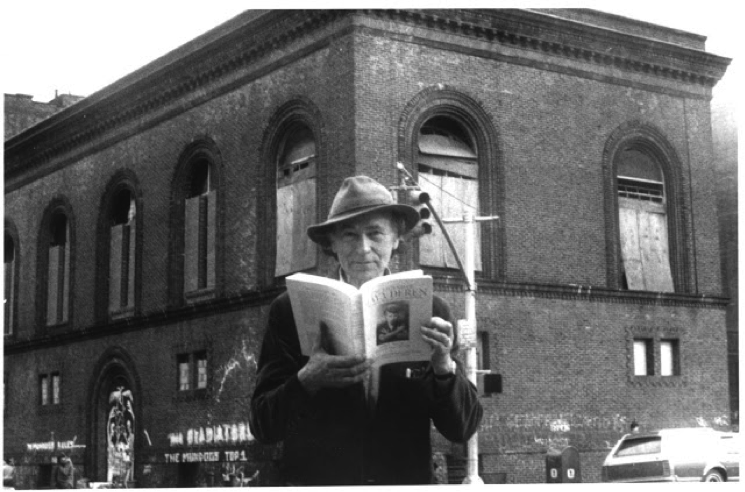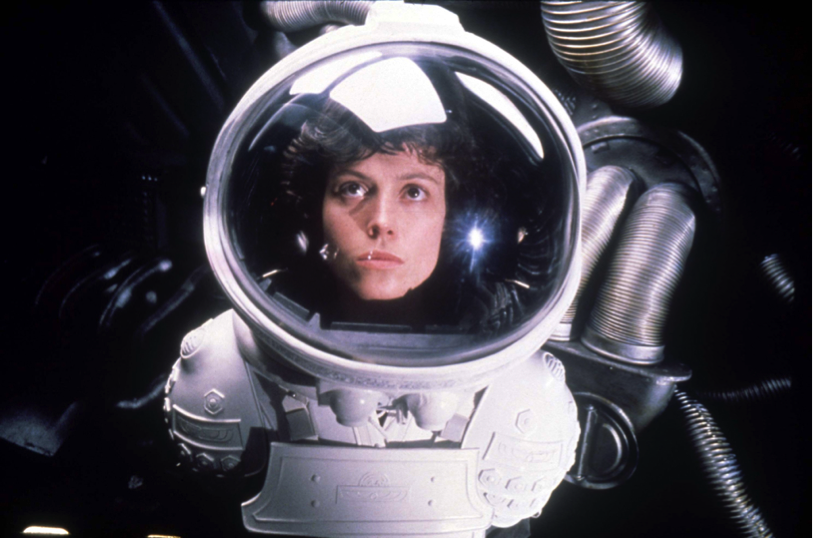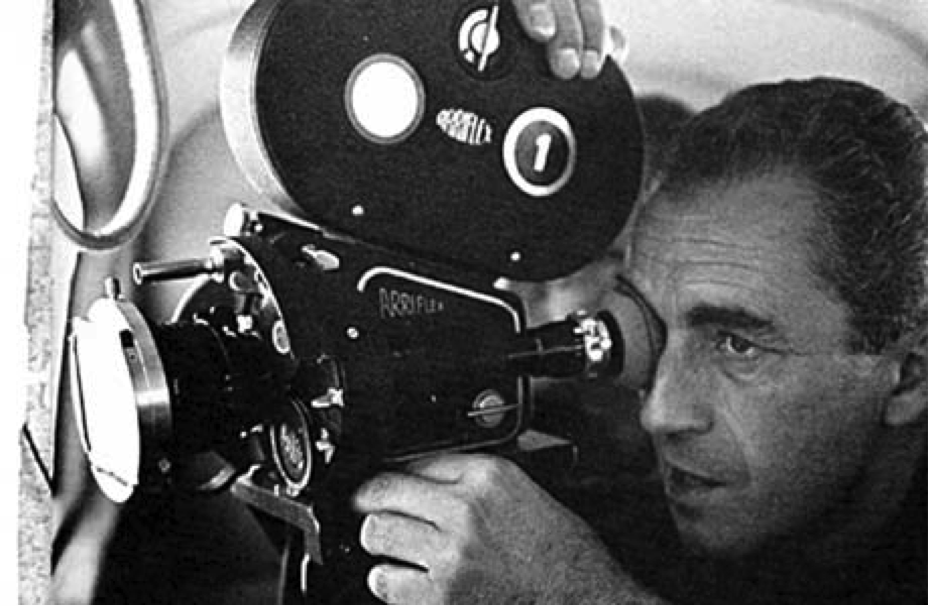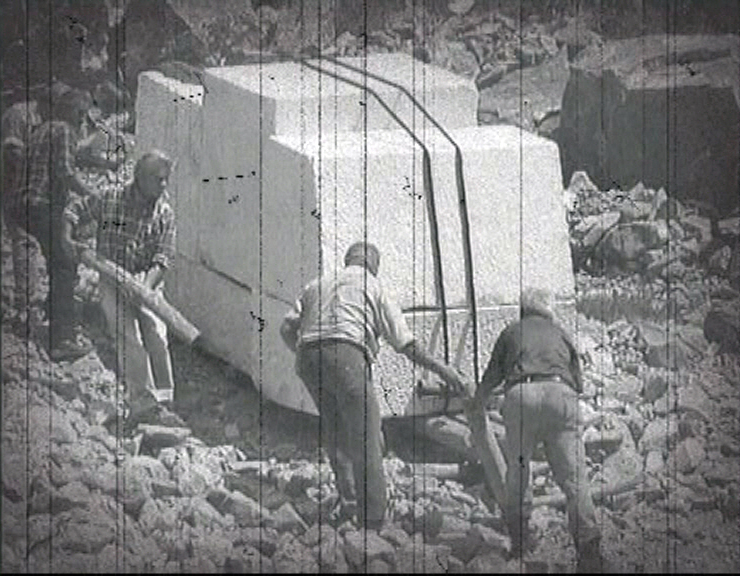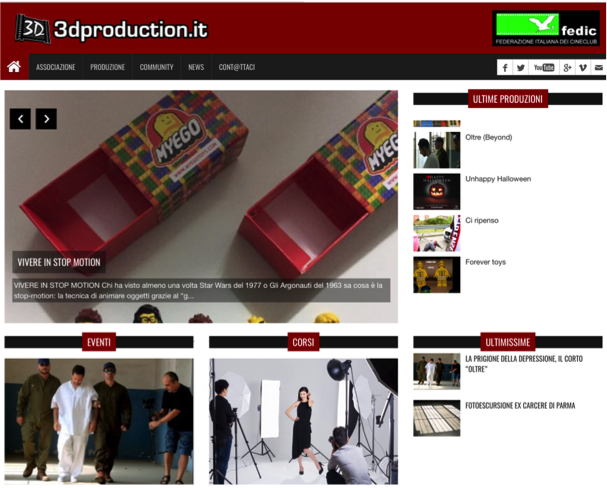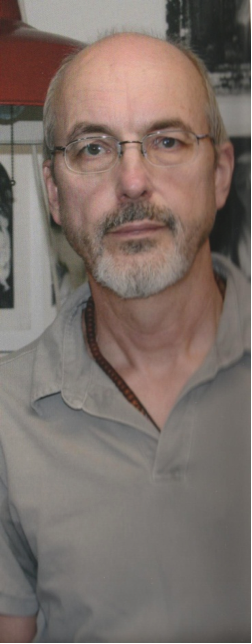Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 4 INCONTRI
- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 6 FESTIVAL ED EVENTI
- 7 OCCHIO CRITICO a cura di Marco Incerti Zambelli
- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 9 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
- 10 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 11 AUTORI (New entry)
- 12 CREDITS
ABSTRACT
JOHN CASSAVETES E IL “NEW AMERICAN CINEMA” di Marino Demata
Il saggio breve cerca di individuare le cause che fanno nascere l’esigenza di un nuovo modo di fare cinema in America alla fine degli anni ’50. Tra queste vanno annoverate le innovazioni tecniche sperimentate con successo nel campo del documentario, e solo successivamente trasferite al cinema.
Viene quindi esaminata la grande carica innovativa di John Cassavetes, nella sua prima opera “Shadows” (“Ombre”) e i rapporti di quest’ultimo con il New American Cinema di Jonas Mekas, che si interruppero del tutto quando il regista decise di girare una seconda versione di “Shadows”.
Viene quindi esaminato quello che può definirsi il film simbolo di Cassavetes, “Una moglie” e i riscontri critici, partendo soprattutto da Roger Ebert.
L’ENFANT CINÉMA di Barbara Grassi
Un omaggio alle prime cineaste africane e alle loro opere più significative, destinate a influenzare le generazioni successive.
LA SAGA DI “ALIEN” – FENOMENOLOGIA DELLO XENOMORFO di Riccardo Poma
La saga di “Alien” è una delle più fortunate ed apprezzate dell’intera storia del cinema. Questo successo è dovuto a diversi fattori: abilità dei registi che vi si sono interfacciati; capacità di trasformare semplici storie dell’orrore in metafore universali; intelligenza nel raccontare eventi futuri riflettendo sul presente. Il saggio ripercorre minuziosamente le sei tappe della serie ufficiale (da “Alien” del 1979 a “Alien: Covenant” del 2017) mettendo in luce queste caratteristiche.
ESSERE COERENTI NON SIGNIFICA ESSERE RIVOLUZIONARI. L’UTOPIA NEGATIVA DI MARCO FERRERI di Roberto Lasagna
Oggi il termine “rivoluzionario” è usato sovente a sproposito. In fatto di cinema capita sovente di imbattersi in un cinema che avrebbe gli attributi del rivoluzionario. Nemmeno Marco Ferreri considerava il suo cinema come rivoluzionario. Questione di consapevolezza.
CHIEDO ASILO: LA RIVOLUZIONE PEDAGOGICA di Francesco Saverio Marzaduri
Per ricordare Marco Ferreri a dieci anni anni dalla scomparsa, una lettura pedagogica e al contempo analitica di “Chiedo asilo”, sua ventesima fatica.
RESIDUI FILMICI NELLA TRILOGIA DI MICHELANGELO ANTONIONI di Stefano Usardi
Michelangelo Antonioni e i suoi film continuano a vivere, e lo fanno principalmente attraverso la mente dello spettatore. Ogni proiezione dei suoi film, in ogni parte del mondo, rivitalizzano costantemente il suo messaggio, la sua visione sul e del mondo. Lo spettatore avvicinandosi all’opera “aperta” di Antonioni ha la possibilità di partecipare all’atto creativo del film, proiettandovi il proprio immaginario. Ogni incontro con un film della cosiddetta trilogia (“L’Avventura”,”La Notte” e “L’Eclisse”) segna indelebilmente il fruitore, lasciandogli un residuo filmico che ne condizionerà la percezione della realtà circostante.
TONINO VALERII: UN ABILE ARTIGIANO DEL CINEMA, SOTTOVALUTATO di Mario Giunco
Sono presentate la figura e l’opera del regista Tonino Valerii (1934-2016), uno degli autori meno prolifici, ma più significativi della stagione del “western all’italiana”. Distaccandosi fin dagli inizi da Sergio Leone – di cui era stato assistente – ottiene esiti originali, nella quale la lezione dei maestri americani si unisce a quella dei classici ed è filtrata da una cultura vasta e profonda. Le “incursioni” in altri generi e quelle televisive. Gli ultimi anni, confortati dalla riscoperta dei suoi film da parte dei più giovani.
INTERVISTA A SUNNY YU di Francesco Saverio Marzaduri
In occasione del “Taiwan Week – Asian Film Festival”, tenutosi a Bologna in giugno, abbiamo incontrato e intervistato Sunny Yu, giovane regista-sceneggiatrice di Taiwan, autrice di “Xiao Hai”, con cui nel 2015 ha esordito nel lungometraggio.
FILMMAKER ALLA RIBALTA: BIGGI – CARAVELLO di Paolo Micalizzi
Un profilo dei soci fondatori del Cineclub FEDIC Gruppo Cineamatori delle Apuane che hanno compiuto, soprattutto, esperienze nel mondo della scuola.
IL GIRO DEI CINECLUB IN 80… CLICK VIA INTERNET di Ettore Di Gennaro
Viaggio nei siti web e presenza dei Cineclub FEDIC sui social.
UTÒPIA 70: IL PROGETTO di Lorenza Corsetti e Rosaria Bonotti e UTÒPIA 70: IL CINEFORUM di Carmine Mezzacappa
Due articoli sull’iniziativa del Gruppo Cineamatori delle Apuane, realizzata con gli studenti di un Liceo di Massa, dal titolo “Utòpia 70”.
Illustrazione del Progetto e considerazioni sul Cineforum effettuato con gli studenti.
REPORTAGE SU TEMI D’ATTUALITÀ A “LE VOCI DELL’INCHIESTA” DI PORDENONE DEDICATO AL CINEMA DEL REALE di Paolo Micalizzi
Premi e tematiche della 10. edizione del Festival di Cinema del Reale “Le Voci dell’Inchiesta”.
“CINEMAMBIENTE” DI TORINO: TEMI D’IMPORTANZA SOCIALE E CIVILE NEL MONDO CONTEMPORANEO di Paolo Micalizzi
Resoconto di un Festival, giunto alla ventesima edizione, molto attivo nell’affrontare tematiche ambientali di grande rilievo sociale e civile.
BILL VIOLA: RINASCIMENTO ELETTRONICO di Maurizio Villani
Rassegna delle opere di Bill Viola esposte alla mostra “Rinascimento elettronico” a Palazzo Strozzi di Firenze, in cui viene proposto il confronto tra alcuni celebri video di Viola con i modelli rinascimentali dei pittori da cui ha tratto ispirazione.
FAMIGLIE di Marco Incerti Zambelli
Dalla Sicilia “Sicilian Ghost Story” e dal Giappone “ Ritratto di famiglia con tempesta”, due film di diverso stile accomunati dalla capacità di meditare con sensibilità e partecipazione sulle dinamiche famigliari.
CANZONI STONATE: “SONG TO SONG” di Francesco Saverio Marzaduri
A sei mesi dall’uscita di “Knight of Cups”, arriva in sala il nono lungometraggio di Terrence Malick, “Song to Song”, con cui il cineasta canadese conclude un’ideale trilogia mistica, iniziata con “To the Wonder”. Austin, Texas, città di musica, artisti, produttori. Musicista e cantautore, BV conosce Faye a una festa nella villa di Cook, giovane e ricco produttore che gioca con i suoni e con le persone. BV non sa che la ragazza e Cook hanno avuto una relazione, non ancora del tutto conclusa. Durante un viaggio insieme, cresce l’amore tra BV e Faye, l’ambigua amicizia con Cook, il ricatto del non detto. Il triangolo si complica quando entra in scena Rhonda, una cameriera, e Cook la sposa condannandola all’infelicità…
“LA TENEREZZA”DI GIANNI AMELIO e “ASSALTO AL CIELO” di Tullio Masoni
Un bisogno forte e al tempo stesso digressivo; come se, talvolta per un soffio, chi la invoca la perda . Un anziano padre che non ama i suoi figli; i figli che lo cercano, forse, per vie sbagliate. Napoli: non la città brulicante, salvo rare eccezioni, e tuttavia autentica, percepibilissma. Amelio, il padre (o i padri) ma anche la madre, cioè un sentire femminile da qualche tempo scoperto e posto in primo piano.
L’autore di “Saimir” e “Anime nere” prova a esplorare il decennio 1967-77 accostando materiali originali di repertorio. Un film di montaggio che usa, esplicitamente, materiali “sporchi” e frammentari. Un tentativo generoso, ma insufficiente. Forse, senza volerlo, equivoco.
A CASA NOSTRA (E ALTROVE): “SOLE CUORE AMORE” DI DANIELE VICARI; “A CASA NOSTRA” DI LUCAS BELVAUX di Paolo Vecchi
“Sole cuore amore” offre un’immagine precisa e attendibile dell’Italia delle nuove povertà, del lavoro precario o della mancanza del lavoro stesso. E, insieme, dell’abnegazione di chi come la sua protagonista riesce a farvi fronte, senza mai lamentarsi ma con dignità e fierezza.
“A casa nostra” affronta in maniera efficace uno dei temi più attuali del panorama politico – sociale europeo e nordamericano: l’attrattiva esercitata su una classe operaia sempre più proletarizzata, o comunque sulle fasce a minor reddito, da parte dei cosiddetti populismi.
SOPRAVVIVERE AI TEMPI DEL COLERA (FINANZIARIO) di Marcello Cella
Il documentario racconta gli effetti delle politiche economiche di austerity sulla vita delle persone attraverso le vicende di una cooperativa sociale di Monterotondo. Con testimonianze di economisti, giornalisti, intellettuali e attivisti come Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, Erri De Luca, Vladimiro Giacchè, Warren Mosler, Stephanie Kelton, Paolo Barnard, Paul de Grauwe, Giuliano Amato, Stefano Fassina, Federico Rampini e la voce narrante di Claudio Santamaria.
“TABOO” di Luisa Ceretto
Otto episodi della durata di cinquanta minuti ciascuno, “TABOO” è la nuova serie ambientata in una Londra cupa e misteriosa di inizio ottocento. Protagonista assoluto e magistrale, Tom Hardy, nei panni di un personaggio animato da amore e vendetta, una sorta di Conte di Montecristo…
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
Segnalazioni-recensioni di libri, recenti, dedicati a Ettore Scola, Vincent Price, l’Umbria sullo schermo.
IL LIBRO
SUSPENSE! IL CINEMA DELLA POSSIBILITÀ – Recensione di Vittorio Giacci
Un’ampia e analitica recensione del volume Suspense! Il cinema della possibilità di Damiano Cantone e Piero Tomaselli.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
John Cassavetes e il
“New American Cinema”
di Marino Demata
Premessa
Il regista premio Oscar de “Il silenzio degli innocenti”, Jonathan Demme, recentemente scomparso, era un grandissimo ammiratore di film e autori innovativi. In particolare ammirava la Nouvelle Vague e Truffaut.
Tra i tanti ricordi e aneddoti , uno dei più significativi è quello riferito in un’ampia e interessante intervista rilasciata nell’ottobre del 2002 a ”Moviemaker” e relativo al film di Truffaut “Sparate sul pianista”, al quale esplicitamente l’autore si richiama nel suo film girato proprio in Francia, “The truth about Charlie” (1). C’è una scena che egli ricorda con grande interesse e piacere nel corso dell’intervista: nel flm di Truffaut due malfattori inseguono Charlie (Aznavour) e lo spingono in un vicolo per chiedergli “stai dicendo la verità”? e Charlie risponde “Sto dicendo la verità. Mi è testimone Dio. E se sto mentendo possa mia madre morire in questo momento”. Subito dopo abbiamo uno stacco e si vede una scena con una anziana signora che cade improvvisamente a terra morta.” E a quel punto Demme ricorda di aver pensato: “Mio Dio, guarda che film che si può fare: nel bel mezzo di una scena drammatica, improvvisamente appare una scena come quella!”
Nell’affermazione di Demme c’era lo stupore misto ad ammirazione per una scena che mai e poi mai si sarebbe potuta realizzare negli studios di Hollywood, gelosi tutori delle sacre regole del cinema classico, che non consentono che in un film si possa repentinamente passare da una scena drammatica ad una tragicomica.
Lo stupore compiaciuto di Demme dimostra due aspetti: innanzitutto la voglia di un regista “classico” come Demme di scoprire e a sua volta creare un cinema trasgressivo rispetto ai canoni hollywoodiani; in secondo luogo la grande popolarità della Nouvelle Vague tra i registi americani più consapevoli, come sinonimo appunto di trasgressività, di progresso e di innovazione. Ma contemporaneamente stupisce anche il non tenere in alcun conto delle altre correnti innovative, più o meno contemporanee alla Nouvelle Vague, che si presentano in varie cinematografie, come quella inglese, italiana, canadese, giapponese e soprattutto americana.
L’approfondimento di tali cinematografie innovative e decisamente polemiche verso i canoni del cinema hollywoodiano ha indotto molti studiosi a limitare l’uso dell’espressione Nouvelle Vague e sostituirlo spesso con New Wawes, che ne è la traduzione in inglese, ma significativamente al plurale, con riferimento appunto alla pluralità delle cinematografi innovative.
Rinviando al nostro saggio breve già uscito qualche mese fa in “Carte di Cinema”, che è una bozza di analisi di tali cinematografie e dei motivi politici e sociali che fanno nascere quasi simultaneamente i movimenti innovativi nei vari Paesi (2), vogliamo invece soffermarci su quanto succede negli Stati Uniti, cioè proprio nella patria di quel cinema classico che sembrava decisamente intoccabile fino alla fine degli anni ’50, non senza meravigliarci che un uomo di cinema attento come Demme abbia ignorato quel fenomeno innovativo che avveniva proprio in casa sua, sotto i suoi occhi.
Quando si parla di cinema innovativo americano non si può non richiamare alla mente New York (in contrapposizione anche geografica a Hollywood), e il movimento del New American Cinema e il cinema di John Cassavetes.
 Sulle ragioni e radici della nascita del movimento newyorkese occorre in primo luogo andare ad esplorare il malessere sociale e politico causato dalla guerra nel Vietnam e gli entusiasmi collegati, proprio alla fine degli anni ’50, al crollo della dittatura di Batista a Cuba e al successo di Fidel Castro. Questi ed altri eventi politici americani di quegli anni aprirono le porte ad un grande periodo contestativo che durerà quasi 10 anni, fino al 1968 e che non poteva non suggestionare i registi indipendenti (innanzitutto da Hollywood) e spingerli alla ricerca di nuove strade.
Sulle ragioni e radici della nascita del movimento newyorkese occorre in primo luogo andare ad esplorare il malessere sociale e politico causato dalla guerra nel Vietnam e gli entusiasmi collegati, proprio alla fine degli anni ’50, al crollo della dittatura di Batista a Cuba e al successo di Fidel Castro. Questi ed altri eventi politici americani di quegli anni aprirono le porte ad un grande periodo contestativo che durerà quasi 10 anni, fino al 1968 e che non poteva non suggestionare i registi indipendenti (innanzitutto da Hollywood) e spingerli alla ricerca di nuove strade.
E accanto a questi corposi motivi politici occorre soffermarsi, più ampiamente in questa sede, sui motivi più interni al mondo cinematografico, sulle nuove idee che maturano e sulle nuove tecniche, spesso invocate proprio dagli stessi registi indipendenti, quasi come “conditio sine qua non” per potere effettivamente dare vita ad un cinema realmente nuovo anche nei contenuti.
Tutto cominciò col documentario
E se andiamo ad analizzare tutto quello che precede, nel campo strettamente cinematografico, che in qualche modo possa aver influenzato lo sviluppo di un movimento come il New America Cinema e poi, con i dovuti distinguo, il cinema di Cassavetes, non possiamo non ricordare che le prime innovazioni vengono portate avanti dagli autori di documentari.
Può sembrare strano l’itinerario che parte dal documentario per arrivare al cinema. Soprattutto se si pensa che, nel sentire comune dell’americano medio dell’epoca il documentario non ha niente a che vedere col cinema. La prima e più importante ragione è che il luogo ove si può vedere un film è il cinema, mentre il luogo del documentario è la TV, che in America ha fatto passi da gigante rispetto ad altre realtà ed ha assunto una propria fisionomia e autonomia. Al contrario ad esempio della Francia ove non sono state in quei tempi ancora abrogate le regole imposte in precedenza dal Governo di Vichy per motivi propagandistici, che prescrivevano che dovesse essere proiettato un documentario nelle sale prima di ogni film.
Eppure il primo a sentire l’esigenza di profonde innovazioni tecniche in America fu proprio un autore di documentari, Richard Leacock, che viveva la perenne frustrazione di dover girare documentari con l’equipaggiamento pesantissimo in uso a quei tempi, costituito dalla macchina da presa e da un registratore separato da essa. La battaglia di Leacock era tesa ad inventare una struttura più leggera che unificasse i due elementi, macchina da presa e registratore. Il risultato delle sue ricerche fu in certo senso rivoluzionario e si chiamò Auricon Filmagnetic, e cioè una struttura che si portava a spalla, ove c’era tutto il necessario. Forse ancora un po’ pesante ma sicuramente molto efficiente e pratica.
Leacock dunque, portando a spalla il nuovo strumento per le riprese, sperimentò la novità in una serie di documentari, fino ad arrivare al suo lavoro più celebre: assieme al suo collaboratore Robert Drew, utilizzò la recente invenzione, già da lui sperimentata, in un documentario-reportage intitolato “Primary”, sulla battaglia alle primarie del Partito Democratico tra Hubert Humphrey e John F. Kennedy. Una nuova strumentazione dunque al servizio di un argomento reale e politico che appassionava l’uomo medio americano. Il risultato fu un grande successo sui canali televisivi dell’ABC.
Oltre a Primary ci furono altri esempi di documentari impostati con gli stessi criteri e questo nuovo modo di lavorare non mancò di influenzare il cinema, che a sua volta in quei tempi stava “sdoganando” negli USA l’espressione francese “Cinema veritè”. Il risultato fu la nascita di un tipo di cinema come forma di giornalismo e col nuovo tipo di camera concepito da Leacock e poi ulteriormente perfezionata, con il suono perfettamente unificato alle immagini, offriva una nuova forma di immediatezza soprattutto nei dialoghi.
In tal modo si comprende bene come il più grande risultato di una tecnologia più leggera, quale quella alla quale pervenne Leacock, fu una grande intimità nelle interviste e più in generale nei reportage.
“Shadows” di John Cassavetes
Ma ben presto questi risultati furono, con grande spirito innovativo, portati avanti anche nei film di finzione.
Il primo esempio fu sicuramente “Shadows”, un film girato in 16 mm dall’attore John Cassavetes nel 1957 e poi ampiamente ri-girato a distanza di un anno e più. “Shadows” inizialmente era una sorta di improvvisazione teatrale nella quale, sotto forma di intervista, si richiedeva a studenti-attori di interpretare i ruoli di tre fratelli, il primo decisamente nero, il secondo e la sorella minore molto più chiari di pelle. L’improvvisazione funzionò così bene che Cassavetes, proprio partendo da quelle che erano poco più che interviste, decise di sviluppare il materiale girato mostrando i tre fratelli alle prese con il lavoro e con l’amore nel bel mezzo di Manhattan. Il risultato non fu soddisfacente, sia per l’inesperienza del cast, sia per il budget veramente risicatissimo, che aveva creato molti problemi e limitato le possibilità del regista. Ma Cassavetes, con la sua caparbietà e innamorato del suo progetto e convinto di aver trovato comunque una nuova forma di cinema, si rimise al lavoro e ricominciò di nuovo da capo, arricchendo lo scarno canovaccio che era stato il prodotto del lavoro precedente con una rudimentale sceneggiatura, che non bloccava l’improvvisazione degli attori, che a loro volta erano diventati un po’ più esperti e sicuri di se stessi. Il risultato fu quella versione di “Shadows” che noi conosciamo: un bellissimo film che all’epoca dovette sembrare a molti scioccante e che lanciava il guanto di sfida al cinema di Hollywood, che da allora in poi non avrebbe potuto mai più identificarsi in toto col cinema americano.
In realtà la storia e la genesi di “Shadows” hanno aspetti romanzeschi. Tutto iniziò ai primi del 1957, allorchè il giovane John Cassavetes fu chiamato alla Radio a fare da testimonial in una trasmissione notturna per pochi nottambuli ad un film che aveva appena finito di girare come attore, un drammone hollywoodiano diretto dal pur bravo Martin Ritt (black listed durante il maccartismo!), intitolato “Edge of the City”, in italiano “Nel fango della periferia”. In quella occasione Cassavetes dimentica (o fa finta di dimenticare) ben presto i sui obblighi promozionali e utilizza lo spazio e il tempo concessigli per lanciare un appello: “«Pensate a quanto sarebbe bello», dice agli ascoltatori, «se a fare film fosse la gente qualunque, e non quei parrucconi di Hollywood che pensano solo al business». E aggiunge: «Volete un film che parli di cose vere, di gente vera? Non avete che da mandarmi i soldi perché ve lo faccia io». La colletta frutterà duemila dollari. Ce ne sarebbero voluti molti altri per produrre e girare ‘Shadow’ ma ormai la pista era stata aperta. Esplicitamente Cassavetes aveva criticato Hollywood coi suoi “parrucconi” ed aveva indicato il suo ideale di cinema, che dovrà parlare di gente vera, della vita, della realtà quotidiana.
Già da questo episodio comprendiamo perché, in una ideale storia universale del cinema scandita dai film che segnano l’innovazione e la rottura rivoluzionaria col passato, sicuramente “Shadows/Ombre” ha un posto di grande rilievo: perché si tratta appunto di un’opera che rompe con la tradizione e che rimette in discussione la natura stessa del linguaggio cinematografico.
Raccontare filmicamente fino ad allora significava ed implicava selezionare (attraverso il lavoro della macchina da presa ed il montaggio) situazioni e scene tutte funzionali allo sviluppo del racconto stesso. Insomma tutto il resto della realtà, non utile nè funzionale al racconto che si vuole narrare, deve necessariamente restare fuori, come inutile o fuorviante, dal film. Con “Shadow” invece la provocazione di Cassavetes consiste nel filmare la realtà così come è, nel suo dissennato accavallarsi di fatti e di episodi che non hanno a loro base alcun disegno funzionale al racconto, nè in sé alcun ordito finalistico o provvidenziale che sia, ma che sono invece semplicemente il regno della accidentalità e delle “ombre”, così come proprio nella vita reale accade.
Dunque: non solo improvvisare (senza alcuna sceneggiatura), ma soprattutto affidarsi alla verità delle emozioni che di volta in volta i fatti suscitano nei personaggi e per essi negli attori, che – lo ha ripetuto spesso Cassavetes – sono l’elemento più importante in un film, essendo ad essi che la storia si deve piegare e non viceversa. Polemizzando con i film “perfetti” di Hollywood (suo perenne bersaglio), Cassavetes fa sua una polemica che è stata anche di Pasolini in Italia ed afferma: “Preferiamo film imperfetti, ma vivi a film falsi…Non vogliamo film rosei: li vogliamo del colore del sangue.”
La storia di “Shadows” è così incredibile e avventurosa, come si diceva sopra, che verrebbe la voglia di farne a sua volta un film. Si pensi alla prima versione di “Shadows”, della quale lo stesso autore rimase profondamente insoddisfatto: la copia di quella versione andò perduta e poi è stata successivamente ritrovata in modo del tutto accidentale.
Jonas Mekas e il New American Cinema
Ma con l’insoddisfazione di Cassavetes non era per nulla d’accordo l’insieme di quel magmatico universo newyorkese di critici, aspiranti registi, scrittori underground che invece erano rimasti entusiasti, per non dire estasiati, dalla prima (e allora unica) versione. Tra gli entusiasti senza limite che salutarono la prima versione di “Shadows”, proiettata in una sala in un paio di tarde serate, spicca il nome di Jonas Mekas, creatore e direttore di una rivista cinematografica di avanguardia chiamata “Film Culture”. Mekas pubblicò una recensione sulla sua rivista nella quale premiò Shadows come the “First Independent Film Award” del 1959.
Altri autori underground furono incoraggiati da “Shadows” a girare nello stesso modo rivoluzionario. E per questo furono segnalati e premiati da Mekas. Nel 1960 toccò alla coppia di registi Alfred Leslie e Robert Frank, autori del film “Pull my Daisy”, significativamente tratto da un racconto di Jack Kerouac. Nel 1961 il gruppo di Mekas premiò il citato documentario “Primary” e poi, nel 1962 fu premiato un altro documentario, “The Connection” di Frank Clarke. E nel 1963 il successo arrise a due film corti del regista di avanguardia Stan Brakhage, “The Dead” e “Prelude”.
Tutte queste scelte potevano sembrare apparentemente casuali, ma in realtà non lo erano. Si trattava di scelte strategiche del gruppo che faceva capo a Jonas Mekas, di cui era diventato l’indiscusso leader, teso a dimostrare che si era ormai formata una nuova, vivace e corposa corrente cinematografica che venne chiamata il “New American Cinema”, insomma un’altra New Wave, che si affiancava, ma con una propria originalità e con proprie caratteristiche, alla varie New Waves europee. La caratteristica del gruppo è che esso è marcatamente Underground e di avanguardia, e rivolto sia alle novità del documentario, sia al film cosiddetto di fiction.
Ufficialmente Jonas Mekas nel 1960, attivissimo più che mai, annunciò la formazione del “New American Cinema Group”, sottoscritto da ben 23 registi indipendenti. E subito dopo, nel 1962, il gruppo di Mekas produsse un manifesto, pubblicato sulla sua rivista “Film Culture” e aprì la rivista stessa ad un dibattito aperto. Il dibattito mise in mostra opinioni molto disparate: tutti erano d’accordo sulla positività del nuovo che stava avanzando, ma pochi erano convinti che potesse realmente darsi vita ad un ampio, coerente ed unitario movimento. Qualcuno, come Amos Vogel, che aveva accolto entusiasticamente nella sua sala cinematografica Cassavetes con “Shadows” (prima versone), nel dibattito promosso da Mekas arrivò a mettere in dubbio che il termine “cinema” fosse appropriato per designare una serie di film più destinati alla Televisione che alle sale.
In questo dibattito non troviamo più il nome di Cassavetes. La rottura con Mekas – e di conseguenza col gruppo del New American Cinema – fu verticale e prese corpo innanzitutto sul giudizio della prima versione di “Shadow”, entusiasta da parte del critico, negativo da parte dell’autore. La rottura avrebbe potuto in qualche modo anche ricomporsi, ma il fatto che Cassavetes si rimettesse dietro la macchina da presa per correggere e in pratica ri-girare “Shadow”, fu accolto da Mekas con grandissimo disappunto e come una sorta di tradimento. Ormai le strade tra il New American Cinema e Cassavetes si erano del tutto separate.
Ma quale era in definitiva la vera materia del contendere? A Mekas piaceva il cinema-verità, fatto di interviste anche sugli argomenti più disparati, con il lievito della più ampia improvvisazione. Un cinema i cui confini col documentario erano diventati sempre più labili, prova ne sia che, come abbiamo visto sopra, gli “awards” che Mekas attribuiva erano di volta in volta destinati a film, o a documentari o a film corti, senza alcuna distinzione.
Cassavetes invece non era d’accordo che in un film non ci dovesse essere una storia, un soggetto racchiuso magari non in una sceneggiatura di tipo tradizionale, ma anche solo in un canovaccio, o in un’idea-madre, che nulla avrebbe tolto all’improvvisazione degli attori nei loro dialoghi. E così “Shadows” diventa, nella seconda versione, la storia di due fratelli e una sorella e del difficile rapporto, per motivi razziali, dei primi due col ragazzo della sorella. Quale era dunque l’idea-madre del film? Ce lo dice in un’intervista colei che ha vissuto più a lungo in compagnia del grande filmmaker, Gena Rowlands. A chi, nel corso di un’intervista le chiese cosa era dunque “Shadows” per Cassavetes, lei rispose, senza esitare, “un film sul razzismo”(3).
Cassavetes dunque vuole conservare i modi della fiction e anzi dargli grande valore ed innestare però sulle sue storie un modo di fare cinema rivoluzionario: un cinema che offre grande libertà agli attori (per lui veri artefici del film), alla loro improvvisazione. “Shadows” è un film girato prevalentemente per le strade di New York, sia di giorno che di notte, con la cosiddetta “tecnica del pedinamento”, tanto cara a Rossellini. Il pedinamento cioè dei protagonisti da parte della macchina da presa, anche attraverso un uso frequentissimo di primi e primissimi piani, in qualche modo favoriti dall’’utilizzazione quasi amatoriale di una camera a 16 mm.
Ma perché mai negli studios di Hollywwod, che Cassavets frequentava come attore, per procacciarsi i quattrini per girare i “suoi” film, quando si gira un film, gli attori non si incontrano mai? La risposta è proprio perché diversa è la funzione dell’attore. Egli dice: “M’è capitato di recitare in un film e di venire a sapere soltanto alla fine che c’era questo o quell’altro attore. Nei miei film ci riuniamo per parecchie settimane, la sera ad esempio, e leggiamo il copione insieme. Ci vogliamo bene, ci conosciamo e lavoriamo insieme da tempo. Gli attori arrivano con dei suggerimenti e io chiedo loro di metterli per iscritto perché talvolta non li comprendo bene. Tutto è discusso, nulla scaturisce solo da me”.
Ma più ancora che di Rossellini, come ispiratore della tecnica del pedinamento, e della grande rilevanza data agli attori, si deve parlare, a proposito della seconda e definitiva edizione di “Shadows”, della omologhe e pressoché contemporanee, se non simultanee, opere del nuovo Free Cinema inglese e della Nouvelle Vague francese. Sergio Arecco, nel suo ormai classico saggio su Cassavetes (4), ci ricorda a tal proposito che già nel 1956 Lorenza Mazzetti inaugura il Free Cinema inglese con una pellicola nata dal “pedinamento” (stavolta in senso proprio letterale) di due sordomuti nei sobborghi londinesi, alle prese con la folla del West End, il lavoro, il chiasso dei pub e dei ragazzini del quartiere. Ne viene fuori un film intitolato “Together”, sul quale mette le mani per montaggio e supervisione colui che viene considerato tra i fondatori del Free Cinema assieme a Karel Reisz, cioè Lindsay Anderson.
E quasi contemporaneamente un’altra regista-donna, Agnes Varda gira in Francia “La Pointe Courte”, vera e propria elegia dei rapporti umani perduti o almeno compromessi all’interno della stagnante e grigia atmosfera della provincia francese. Il film costituisce la logica premessa (direi quasi il prologo) di quel piccolo gioiello che la regista girerà qualche anno dopo, “Cleo dalle 5 alle 7”. Ma sara’ soprattutto Chabrol, dichiarata espressione della Nouvelle Vague, ad influenzare Cassavetes alle prese con la seconda edizione di “Shadows”. Infatti si possono ritrovare medesimi temi e ritmi e pefino affinita’ nella colonna sonora negli Chabroliani “Le beau Serge” e “Les cousins”, entambi del 1959. E del resto giova non dimenticare che il 1959 è anche l’anno in cui esce il primo capolavoro di F. Truffaut, “I 400 colpi”. Tutto questo ragionamento conferma sicuramente la matrice e l’ispirazione in ultima istanza europea del cinema di Cassavetes, se con questa espressione intendiamo però riferirci beninteso al nuovo cinema europeo, quello, erede del neo-realismo italiano, che da’ vita ai movimenti del Free Cinema e della Nouvelle Vague. D’altra parte l’europeismo di Cassavetes lo portò fino a Venezia, ove presentò “Shadows”, che non solo fu bene accolto, ma si guadagnò quell’anno il Premio della critica cinematografica.
E in America? “Shadows” piacque molto al pubblico di New York: il giovane Peter Bogdanovic, che allora curava la programmazione di una sala cinematografica di Manhattan, ricorda che per fare i biglietti per quel film si era formata una fila intorno all’intero edificio (5).
E invece parte importante della critica americana fu molto tiepida, e non solo quella influenzata da Mekas. Ma, a proposito di quest’ultimo, c’è da dire che Il radicalismo polemico del New American Cinema, che pure aveva avuto una grandissima funzione nello scardinare i canoni hollywoodiani, era approdato ad una contrapposizione tra realtà e finzione nel cinema, che cominciava, dopo qualche anno, a diventare stucchevole. Tanto che dal suo osservatorio, il più grande innovatore del cinema italiano, Michelangelo Antonioni, non aveva affatto lasciato cadere il problema, ma espresse pubblicamente la sua veduta, condivisa da molti filmmaker di avanguardia, che la “verità” viene meglio servita e offerta al pubblico attraverso una intelligente fiction, piuttosto che registrando qualunque cosa accada con la camera o col microfono (6).
L’operaio e la donna strana: la rivoluzione di “Una moglie”.
Uno dei film in cui più chiaramente Cassavetes riesce a coniugare alcune delle innovazioni tecniche e comportamentali di cui abbiamo parlato sopra, con un contenuto decisamente rivoluzionario è “Una moglie” del 1974. E proprio per questo vale la pena di soffermarsi su di esso: si può dire che ogni battuta trasuda di spirito anti-hollywoodiano e in qualche caso perfino di odio esplicito verso quel mondo.
Innanzitutto, come assai raramente accade, il mondo descritto nel film è quello della working class. Il protagonista maschile (Peter Falk) è un operaio di origine italiana, Nick Longhetti, che la sera torna stanchissimo dai lavori edili e vorrebbe rifugiarsi nella pace e nella tranquillità della sua famiglia e della sua casa. M questo non è possibile, perché la casa è il teatro di un dramma familiare visto dal suo interno e vissuto con gli occhi della protagonista (una stupefacente Gena Rowlands, nel ruolo di Mabel, candidata all’Oscar per questo film). Un punto di vista che già riconverte e rivoluziona di 180 gradi quanto imposto dai canoni di Hollywood, ove la follia è quasi sempre oggetto e mai soggetto (a meno che non ci sia il riscatto finale!).
Mabel è “strana”, non si adatta ai canoni consueti di una famiglia “normale”, è come se non volesse essere normale. C’è in lei il rifiuto di una vita votata alle mediocrità e al più bieco conformismo. Mabel sente dentro di se che qualcosa non va nella vita che gli è stata propinata e, mancando di una profonda consapevolezza e coscienza, non può andare oltre la “negazione”, il rifiuto istintivo e l’essere “strana” , come la definiscono il marito e gli altri parenti e amici.
Cassavetes a sua volta rifiuta di offrirci con Mabel l’ennesimo dramma psicologico borghese di cui sono pieni i cataloghi degli studios di Hollywood, e, a scanso di equivoci, ambienta il dramma in una famiglia operaia, come si è detto. Questa scelta di Cassavetes ci dà già il senso della “indipendenza” e innovazione: l’essere “strani” non è una prerogativa piccolo-borghese da curare casomai con l’aiuto di un costoso “strizzacervelli”. Mabel è la moglie di un operaio ed è una casalinga e questo rende il suo dramma più intenso e più palpabile. Perché essa è piena di dubbi, vorrebbe accontentare il marito e i parenti, ma proprio non ce la fa, la sua follia è il dubbio, è la mancanza di quelle certezze che invece marito e parenti sfoggiano in ogni momento, quasi sfidando le sue stranezze.
Potremmo sicuramente generalizzare e fare di questa trama e di questa drammatica storia il simbolo dell’intero cinema di Cassavetes. Si perché è tutto il cinema di Cassavetes ad essere un racconto di follia, come unico mezzo per strappare se stessi, i suoi personaggi, alla “normalità”, a quello standard canonico imposto dalla vita borghese (e dai canoni hollywoodiani). Ma per fare questo i suoi personaggi devono mettersi a nudo, devono mostrare le proprie fragilità di anti-eroi, di veri esseri umani in carne ed ossa, all’interno di un tessuto sociale e familiare comune e ordinario, come potrebbe essere quello di chiunque di noi, o del nostro vicino, o del nostro compagno di lavoro. Mabel, come gli altri personaggi di Cassavetes, è parte di una poetica che sarebbe semplicistico riassumere come “poetica dei vinti della vita” o degli sconfitti. È qualcosa di più complesso. Peter Falk ricorda qualcosa di significativo in merito: “La scena del crollo psichico di Mabel (Gena Rowlands) nel film, sono i dieci minuti di cinema tra i più affascinanti, inaspettati, imprevedibili che abbia mai visto. Davvero, in tutta onestà, non la dimenticherò mai.”
Il mondo di Cassavetes è un mondo di anime ferite e le ferite sono procurate da quelli che vengono considerati i capisaldi essenziali del mondo borghese: la società, la famiglia, il perbenismo. Chi osa mettere in dubbio questi valori, chi si ribella ad essi, non può che procurarsi ferite laceranti che lasceranno il segno per sempre, perché quelle “sacre istituzioni” non perdonano chi si ribella ad esse.
Nel contempo “Una moglie” è ricco di novità tecniche e stilistiche, mai fini a se stesse, ma sempre piegate
alle esigenze del racconto: tutto deve essere funzionale a rendere la storia, il film, il dramma in esso raccontato, più vero, più credibile, più vicino alla sensibilità dello spettatore. Solo a questo serve la macchina a mano o la pellicola a volte sgranata e sfocata: una ricerca stilistica che è innovazione perché le sue storie e il suo cinema sono nati e si sono sviluppati sotto il segno del più rivoluzionario espressionismo formale, perché si tratta di storie di “strani” che hanno bisogno di essere mostrate in modo speciale e di cui lo spettatore si deve impossessare col più ampio coinvolgimento possibile. Partendo dallo sguardo e coinvolgendo tutto se stessi nel mondo che Cassavetes ci vuole non solo descrivere, ma farci vivere.
Cassavetes nella critica: un esempio.
Che “Una moglie” debba essere considerato il film-simbolo della poetica di Cassavetes e il suo indiscusso capolavoro è un giudizio che ha trovato concorde la critica più avveduta, anche quella americana, allorchè, sempre in ritardo su quella europea, ha cominciato a rendersi conto della bellezza innovativa del nuovo cinema indipendente. E tra i critici americani uno dei più consapevoli e riflessivi è senza dubbio Roger Ebert (purtroppo scomparso pochi anni fa). Sempre ostile alle graduatorie dei film migliori, ai “top ten”, alle liste di ogni genere, l’unica concessione che fece fu “Great Movies”, e cioè una raccolta di circa 300 sue recensioni di film che egli riteneva al di sopra di tutti gli altri, spiegando che “Uno dei regali che un amante del cinema può dare ad un altro è il titolo di un film meraviglioso da questi non ancora scoperto. Qui ci sono più di 300 riconsiderazioni critiche, dal lontano passato a quello più recente: tutti film che, secondo la mia considerazione, vale la pena che siano chiamati Grandi”.
Ebbene, a proposito di Cassavetes non ha dubbi: “A woman under the influence” (“Una moglie”) è il più grande film del regista newyorkese ed è il simbolo di una filmografia comunque piena di grandi titoli, ove, è il caso di dire, tu veramente stenti, tra tanti capolavori, a deciderti per un secondo posto! Titoli che non a caso sono quasi tutti citati nella recensione di “Una moglie”, come se questo film fosse appunto la summa del cinema del regista di New York. Cassavetes, secondo Ebert è uno di quegli autori, come Hitchcock, del quale vedi pochi secondi di un suo film e subito riconosci l’autore.
Non a caso, egli dice, è sicuramente il più importante rappresentante del cinema indipendente.
Eppure, per una ironia della sorte, il regista indipendente e antihollywoodiano per eccellenza poté essere tale grazie ai fondi che riusciva a mettere insieme col suo lavoro di attore nel cinema convenzionale degli studi, anche con la direzione di registi importanti e non proprio convenzionali al 100%. Ricordiamo ad esempio la sua collaborazione con Polanski come protagonista in “Rosemary’s baby” e con De Palma in “Fury”.
Sarebbe un capitolo di estremo interesse quello che riuscisse a fare luce completa sull’influenza di Cassavetes sul cinema e sui registi successivi. È un capitolo che non è stato mai compiutamente scritto da nessuno, ma solo, di volta in volta accennato. Limitiamoci solo ad una bella intervista di Guido Fink ad Al Ruban, uno dei più stretti collaboratori di Cassavetes, preziosa soprattutto per i ricordi sulla genesi e le difficoltà incontrate girando “Shadows”. Alla domanda di Fink “È giusto dire che alcuni dei nuovi registi di Hollywood – i Fratelli Coen, Ferrara e Tarantino – possono essere considerati come suoi continuatori?”, Al Ruban risponde senza esitazione: “Prima di quelli che ha citato, aggiungerei John Sayles, Woody Allen e Martin Scorsese”.
E se pensiamo ad esempio a quest’ultimo, allorché, giovanissimo, camera in spalla, gira avventurosamente per le strade caotiche di New York, a volta senza neanche il permesso delle Autorità, per realizzare “Taxi Driver”, allora non possiamo che dare ragione ad Al Ruban, perché ci sembra di vedere improvvisamente ritornare, nella realizzazione di quel film, le “ombre” (shadows) di Cassavetes e della sua troupe di amici, parenti e persone della strada.
(1) In effetti “The truth about Charlie” (2002), infelice remake di “Charade” di Peter Stone, fu un film molto mediocre e un flop produttivo notevole. Girato a Parigi, i richiami alla Nouvelle Vague sono insistenti ma poco ispirati. Demme cita soprattutto “Tirate sul pianista” di Truffaut e infatti Aznavour compare in i due scene e canta due canzoni. Cameo per altri personaggi della Nouvelle Vague, come Anna Karina, Agnes Varda, ecc. Ma questo non basta!
(2) Marino Demata: “LA NOUVELLE VAGUE: CONVINTI ACCORDI E VIOLENTI DISACCORDI” in “Carte di Cinema” n° 11 – gennaio 2017.
(3) L’intervista è di Rudolf Mestdagh nel corso di uno special televisivo dedicato a Cassavets nel 1993. Dell’intervista riferisce Guido Fink in ”John Cassavetes: più vero del vero”, Firenze: Festival dei Popoli.
(4) Sergio Arecco: “John Cassavetes” – ed Il Castoro 2009
(5) Peter Bogdanovic: “One of the first” (intervista del 16/11/1993)
(6) Michelangelo Antonioni: “La realtà e il cinema diretto” in Cinema Nuovo n° 167 del febbraio 1964. Ristampato nella preziosissima collezione di saggi “Fare un film è per me vivere” – Marsilio, Venezia 1994, pagg. 53-55.
L’Enfant cinéma
di Barbara Grassi
“Noi mostriamo un’Africa senza eroi,
nella sua quotidianità,
con le sue speranze e le sue sconfitte.”
Sarah Maldoror
Molti cineasti africani hanno trattato il tema della condizione femminile nel Continente. C’è differenza, però, tra rappresentazione e protagonismo. Come mostra l’impegno di pioniere quali Sarah Maldoror o Safi Faye. In Africa, le donne si sono trovate in una posizione ambivalente: lodate come simbolo e soggetto, nelle opere di Ousmane Sembene, Djibril Diop Mambéty e Souleymane Cissé, e come registe, denigrate in termini di produzione. A questo proposito Sarah Maldoror ha dichiarato: “Le donne africane devono essere ovunque. Devono essere nelle immagini, dietro la macchina da presa, in sala di montaggio e coinvolte in ogni fase della realizzazione di un film. Devono essere loro a parlare dei loro problemi”. La presenza femminile, dietro la macchina da presa, aumentò decisamente a partire dagli anni Novanta, insieme agli studi che la riguardano. Soprattutto in Europa e in Nord America. Presso l’Howard University, nella seconda metà degli anni Novanta, Beti Ellerson diede vita ad un importante progetto di censimento e studio sulle donne africane che lavorano in ambito cinematografico. Da una ricerca condotta tra il 2004 e 2011, è emerso che le donne impegnate erano 218 (stima approssimativa). La maggior parte, registe: 178, anche se non mancavano produttrici, attrici, fotografe, truccatrici, montatrici, critici, giornaliste, organizzatrici di festival ed eventi cinematografici. Svariate le occasioni in cui le addette ai lavori ricoprono molteplici ruoli. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la camerunense Thérèse Sita-Bella, (1933-2006) che realizzò il cortometraggio documentario “Tam-Tam à Paris” (1963), incentrato su balli tradizionali eseguiti dal National Dance Company del Camerun, durante il tour parigino svoltosi tra il 1963 e il 1966. La pellicola fu presentata in occasione della Semaine du Cinéma Africain, nel 1969, durante la prima edizione del Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pioniera in molti campi, fu la prima giornalista (carta stampata, radio, televisione) e pilota d’aereo in Camerun. Chitarrista e modella professionista, iniziò a lavorare al Ministero dell’Informazione del Camerun nel 1967. Nel 1989, durante un’intervista, dichiarò di avere molti script e idee per film, che sperava di realizzare in futuro. Purtroppo si è spenta nel 2006, mentre preparava l’uscita di un suo libro, senza aver mai realizzato altri progetti cinematografici.
O Efua Theodora Sutherland, (1924 – 1996), nata in costa d’oro, ora Ghana, figura fondamentale per la cultura Africana. Scrittrice, poetessa, autrice per bambini, drammaturga, regista teatrale, cinematografica, televisiva, editore, sostenitrice della cultura Pan Africana. Dagli anni Cinquanta sino alla sua morte, rivestì un ruolo importante nello sviluppo di programmi educativi, letterari, teatrali, cinematografici e televisivi per e sui bambini ghanesi. Il docu-dramma “Araba: The Village Story ”, (ritenuto perduto) girato nel 1967, con l’aiuto dalla rete televisiva americana ABC, racconta la vita nel villaggio di Atwia dal punto di vista di una ragazzina di nome Araba. Il villaggio, che si trova nella Regione Centrale del Ghana, era uno dei luoghi di ricerca sulle tradizioni orali della Sutherland.
La produzione cinematografica di Sarah Maldoror, regista franco-antille, è decisamente più corposa: trentasette pellicole e varie esperienze come aiuto regista. Sarah Ducati nasce in Francia, nel 1939, madre francese e padre della Guadalupa. Negli anni Parigini si forma, frequenta una scuola di recitazione e ispirandosi al cupo antieroe de “I canti di Maldoror” sceglie il suo cognome d’arte. Nel 1956 insieme agli amici, Toto Bissainthe, noto cantante haitiano, Timite Bassori, e Ababacar Samb, fonda la prima compagnia teatrale nera in Francia, Compagnia d’Arte Drammatica “Les griots”. Spiega la Maldoror: “I nostri obiettivi erano quelli di presentare autori, letteratura nera e creare una scuola d’arte per attori africani.” Fra le varie esperienze di quegli anni, ricordiamo l’incontro col regista cinematografico senegalese Alioune Diop e la scoperta dell’impegno militante grazie a Mário Pinto de Andrade, poeta angolano, leader del Movimento Popolare di Liberazione dell’Angola (MPLA), fondatore del Partito Comunista Angolano. Che diverrà suo marito. Nel 1960, Sarah, abbandonò il palcoscenico per dedicarsi attivamente alla lotta di liberazione dell’Africa, unendosi al MPLA. La cineasta ricorda: “Mi sono resa conto che in Africa, il cinema era il mezzo più appropriato per aumentare la consapevolezza politica delle masse, visto che molti erano e sono tuttora analfabete. A quel punto ho deciso di diventare una regista.” Nel ’61, vinse una borsa di studio in Unione Sovietica, per studiare cinema e produzione cinematografica, presso il Moscow Film Academy e lo Studio Gorki a Mosca. Dove Sergei Gerassimov e Mark Donskoy, le fecero conoscere le tecniche e l’ideologia del cinema sovietico. Dopo l’esperienza come aiuto regista di Donskoy, nel film “Hello Children” (1962), si trasferì prima in Marocco e nel 1963, in Algeria dove lavorò come assistente di Pontecorvo. Come ricorda lei stessa: “…Più tardi, in Algeria, sono diventata assistente di Gillo Pontecorvo durante le riprese de “La Battaglia di Algeri” (1966)… Sempre in Algeria ho girato il mio primo film, “Monangambeee”, nel 1969.” Recentemente digitalizzato, è stato presentato fuori concorso, nella sezione Berlinale Shorts, alla 67ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino. Monangambeee! ovvero morte bianca, era il grido d’allarme che passava di villaggio in villaggio, per avvertire dell’arrivo dei commercianti di schiavi portoghesi. Negli anni Sessanta, venne utilizzato come segnale in codice per convocare le riunioni del Fronte di Liberazione Angolano. Il film racconta la lotta quotidiana di un popolo, attraverso la storia di Kurz, una donna che fa visita al marito in carcere a Luanda. Nelle sequenze iniziali vediamo molti uomini trasportati in un carcere, poi l’incontro tra i due coniugi. La donna, prima di andarsene, abbraccia il marito e gli promette un “completo”. La guardia fraintende il significato della parola e informa il direttore dei suoi sospetti. A causa di un malinteso linguistico, l’uomo verrà interrogato e torturato a morte. La sceneggiatura della Maldoror, Mario de Andrade e Serge Michel è tratta da “O fato completo de Lucas Matesso” (1962), racconto dello scrittore e attivista politico angolano José Luandino Vieira, condannato dal governo portoghese a quattordici anni di lavori forzati. Podotto dal Département Orientation et information du Front National de libération, Algeria – Francia, col sostegno ufficiale della Conferenza delle organizzazioni nazionaliste delle colonie portoghesi, con l’assistenza tecnica dell’esercito nazionale algerino, è interpretato da attori non professionisti eccetto Mohamed Zinet (la guardia). Quando uscì vinse la Palma d’Oro del Festival di Cartagine e nel 1971, fu selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes. L’intento della Maldoror:“A quel tempo, era molto importante che le persone in tutto il mondo sapessero che c’era una resistenza e una repressione in Angola.” La regista non denuncia l’oppressione descrivendola in modo realistico, sceglie invece una rappresentazione metaforica, paradossale, pirandelliana al fine di liberare la propria cultura dallo sguardo dei governi coloniali. Smascherando l’ignoranza e lo scarso interesse dei portoghesi nei riguardi della cultura angolana attraverso un qui pro quo. Il “completo” è un piatto di fagioli e pesce in angolano, che diventa per i portoghesi un vestito. Parola interpretata dalla guardia come un messaggio in codice per avvertire il marito dell’imminente tentativo di appello in tribunale. La descrizione del trattamento crudele riservato a chi attivamente contrasta il colonialismo o semplicemente è ritenuto tale, dal governo, è tutta nelle sequenze del carcere e nell’isolamento di Matesso, quando conversa con una lucertola, che si trova fuori dalla cella, al sole. Metafora della solitudine estrema di un popolo che non viene compreso e non riceve risposta dai colonialisti. La scelta sonora del jazz d’avanguardia dell’Art Ensembe Chicago, interrotta saltuariamente da dialoghi in francese, amplifica le sensazioni di claustrofobia e disperazione delle scene. Una testimonianza di quel cinema militante, che caratterizzerà molte opere della Maldoror. Votate a far nascere una consapevolezza politica nel popolo africano e una legittimazione della lotta di liberazione presso l’opinione pubblica e i governi d’Europa e America.
Nel 1970, in Guinea-Bissau, iniziò le riprese di “Des Fusils pour Banta”, lungometraggio rimasto incompiuto. Il Consiglio Nazionale del Commercio e l’Industria cinematografica algerina le commissionarono un film che documentasse la lotta del Partito africano per l’indipendenza della Guinea e Capo Verde. Il cast era formato da attori non professionisti e da guerriglieri. L’Esercito algerino sperava di usare il film come strumento di propaganda, ma la Maldoror esigeva il pieno controllo sul film. In fase di montaggio, la regista si scontrò con le autorità algerine e fu rimandata in Algeria, decise di lasciarla, per tornarvi solo vent’anni dopo. Le bobine vennero confiscate dall’esercito, a tutt’oggi i sei rulli non sono stati restituiti o identificati. Lo script è incentrato su una giovane donna di nome Awa, che si unisce alla resistenza, dopo che un membro del partito rivoluzionario è arrivato nel suo villaggio rivendicando la lotta in termini di terra e pane. La ragazza si addestra, combatte e partecipa ad importanti operazioni, come l’agguato a quattrocento soldati portoghesi. Infine, perde la vita durante la sanguinosa rappresaglia ad opera delle forze coloniali. Sono stati trovati tre diversi script, ognuno con un finale diverso. La Maldoror, partendo da questo racconto semi immaginario, voleva offrire immagini viste raramente al cinema, il coinvolgimento di donne e bambini nella lotta di liberazione. I fotogrammi di donne armate di fucili e bombe si alternano a scene di vita domestica. Altro elemento inviso all’esercito algerino, che accusò la regista di dare troppa importanza alle donne nella guerriglia. Lei, che aveva vissuto la rivoluzione in prima persona, e le aveva viste trasportare bombe sulle spalle, riteneva di aver il diritto di raccontare la loro storia:“Le guerre funzionano solo quando le donne vi prendono parte”. Ciò che resta del film è una raccolta di fotografie scattate da Suzanne Lipinska durante la lavorazione e i ricordi frammentari dei testimoni ancora vivi, tutto ciò raccolto dall’artista Mathieu Kleyebe Abonnenc nel suo breve diaporama “Préface à des fusils versano Banta” (2011).
L’insurrezione anti-colonialista in Angola viene ripresa in “Sambizanga” (1972), primo lungometraggio della Maldoror. Tratto nuovamente da un’opera di Vieira: “A vida verdadeira de Domingos Xavier”. Sambizanga è il nome di un quartiere operaio di Luanda, dove si trovava una prigione portoghese, tristemente nota per il numero ingente di militanti angolani torturati e uccisi. Attaccata dalle forze del MPLA il 4 febbraio 1961, come per la presa della Bastiglia, simboleggia l’inizio della guerra. La pellicola, ambientata undici anni prima della sua realizzazione, è la storia di una giovane coppia, Domingos Xavier, operaio edile che vive in un villaggio costiero insieme alla moglie Maria e al loro bambino Bastido. Mentre dormono, la polizia segreta entra in casa, lega Domingos e lo carica in auto. Sospettato di essere un’attivista politico, trovato in possesso di un volantino contro il colonialismo, viene portato in città e incarcerato. Sottoposto a brutalità di vario genere, si rifiuta di dare i nomi dei suoi compagni dissidenti e perde la vita. Una sceneggiatura potente, nata dalla collaborazione della Maldoror, Mario de Andrade, Maurice Pons e Claude Agostini, che si prefigge di realizzare un film dal contenuto politico sotteso, in grado di catturare un particolare movimento nella storia della lotta di liberazione angolana, informare gli occidentali della situazione e raccontare la storia di una rivoluzione dalla prospettiva di una donna. Soprattutto far capire le ragioni di tale impegno politico. Gli intenti della regista e del MPLA erano quelli di ottenere la condanna internazionale dell’ingiustizia portoghese e fornire credibilità al movimento, presso la comunità internazionale. Intrecciando tre storie: Il martirio di Domingos, il viaggio di Maria per trovarlo e gli sforzi dei rivoluzionari per accertare l’identità del prigioniero. La macchina da presa segue Maria nel suo viaggio eroico alla ricerca del marito, a piedi, col figlio sulle spalle, la narrazione è scandita dalle sue grida strazianti: Domingos!, e dagli incontri coi funzionari di turno, in uffici e prigioni, che la Maldoror usa come stacchi, sulle scene di tortura subita dal marito. Creando, nello spettatore, un senso di angoscia e il desiderio di salvarlo attraverso Maria. Desiderio reso ancora più urgente e frustrato dall’inconcludente ricerca compiuta dalla donna. Le scene di tortura, senza retorica e la scena poetica e struggente in cui gli altri carcerati lavano, il corpo inerte di Domingos, dal sangue e cantano sommessamente, risultarono estremamente efficaci. In quel momento storico, un decesso, era ancora un atto d’indicibile violenza per l’opinione pubblica. La Maldoror cattura una società sull’orlo del cambiamento. Negli anni successivi, la morte e le lesioni saranno fatti comuni nella lotta per la libertà, come per la repressione. Il film mostra la drammaticità e la necessità di continuare a vivere, in tempi politicamente instabili, attraverso la pena, il canto, le grida strazianti di Maria, che si fanno protesta, denuncia e consapevolezza politica. La comunità, in particolare quella femminile, le viene in aiuto in vari momenti del film e alla fine, le ricorda le sue responsabilità verso suo figlio, verso il futuro dell’Angola. In “Sambizanga” conta la collettività, non il singolo, come dimostrano le scene corali in carcere o di serenità familiare, e solidarietà, che stridono ancor di più con la brutalità dei colonialisti portoghesi. O nella scena finale, dove vediamo gli attivisti ballare, e festeggiare, mentre arriva la notizia della morte di Domingos. Un momento sia di lutto che di gioia, riassunto nella frase che pronuncia Mussunda, uno dei leader del movimento: “Domingos ha iniziato la sua vita nel cuore del popolo angolano”. Questo pensiero cattura lo spirito di “Sambizanga”, la volontà di mostrare lo sviluppo di una forte coscienza politica collettiva che porterà al cambiamento in Angola. Nel 1972, film vinse la prestigiosa Tanit d’Or al Festival di Cartagine. Prodotto in larga parte dalla Guinea-Bissau e Algeria, la regista ha dichiarato: “I francesi ci hanno dato i soldi per fare ‘Sambizanga’, perché l’Angola non era una colonia francese”. Girato in Congo, con un cast formato per la maggior parte da attori non professionisti, congolesi e angolani, coinvolti in movimenti anti-coloniali africani, vede il personaggio di Domingos Xavier, interpretato da un esiliato angolano che viveva in Congo. Maria era impersonata dall’economista Elisa Andrade da Capo Verde. Tra i professionisti: Domingos de Oliveira, attore, drammaturgo, regista e sceneggiatore brasiliano che interpreta il poliziotto che tortura il protagonista. In Portogallo fu proiettato, nel 1974, solo dopo la rivoluzione dei garofani che rovesciò il regime del Estado Novo.
Safi Faye, classe 1943, ha girato sedici film ed stata la prima regista africana ad ottenere un riconoscimento internazionale. A tal proposito, con amara ironia, ha dichiarato: “Visto che ero la prima negra a fare un film, mi hanno notata”. Figlia del capo villaggio di Fad’jal, lavorò come insegnante a Dakar per sei anni, finchè nel 1966, grazie all’incontro con l’etnologo e regista francese Jean Rouch, che l’incoraggiò a studiare etnografia, e interessarsi al cinema come strumento etnologico, trovò la sua vera vocazione. Nel 1969, si trasferì a Parigi per studiare antropologia e etnografia all’ Ecole Pratique des Hautes Etudes, nel ’72 s’iscrisse alla Louis Lumière Film School e nel ’79-’80, studiò produzione video a Berlino. Per mantenersi agli studi lavorò come modella, attrice e doppiatrice cinematografica. Esordì come attrice ne “Petit à petit: lettres persanes” (1971), di Jean Rouch e come regista coi cortometraggi “La passante”, (1972) e “Revanche”, (1973), realizzato con l’aiuto di altri studenti dell’Ecole è la storia di un squilibrato che vuole scalare il ponte Neuf, il più antico di Parigi. Ma come in Amleto, c’è del metodo nella sua follia. “La passante”, invece, è un lavoro intimista, ispirato alla poesia “A une Passante” di Baudelaire. Girato in bianco e nero, con una colonna sonora fatta di musica e poesia, ma nessun dialogo, narra la storia di una bella donna africana (interpretata dalla stessa Faye) che arriva a Parigi e passeggia per le strade. Come in un sogno, nota che tutti la guardano, affascinati e incuriositi. Tra i suoi ammiratori la macchina da presa sceglie un bianco e gli permette di sognare. Egli fantastica di portare la ragazza a cena in un ristorante. Poi sceglie un uomo di colore, che immagina la giovane mentre gli prepara un pasto in casa. I loro pensieri rispecchiano la concezione dei rispettivi ambiti culturali, il rapporto col cibo, il modo di cucinare, di consumare i pasti, e altre concezioni che influenzano le interazioni con l’altro sesso. Il cibo indagato come mediatore e rivelatore culturale, tornerà in “Ambassades nourriciers”, documentario del 1984. La regista, ci parla della solitudine, dell’immigrazione e integrazione, della condizione di colei o colui che passa, e non mette radici, di chi è diviso tra due culture, col corpo si trova in Francia, ma col pensiero in Africa. Frutto dalla sua esperienza di straniera a Parigi. Il tema dell’esilio e dei suoi effetti psicologici ricorre lungo tutta la sua produzione, così come la piccola storia che da il quadro d’insieme, il profilo autobiografico, e la cura nella costruzione della colonna sonora, dove l’elemento extradiegetico diviene intradiegetico veicolando significati, sentimenti, emozioni. “Kaddu Beykat” (1975), primo lungometraggio scritto e diretto dalla Faye, ambientato nel suo villaggio, Fad’jal, nel sud del Senegal, non è il classico documentario etnografico. Circa la sua gestazione la Faye ha spiegato :“Un giorno ho capito che potevo usare le informazioni di sociologia ed economia per fare un film. Così ho creato una piccola storia d’amore tra un uomo e una donna che non potevano sposarsi a causa della difficile situazione economica del loro paese. Così fu l’inizio di “Kaddu Beykat” che non significa Lettere contadine, come traducono alcuni, ma Parola, Parole dei contadini. O ai contadini. Ho incluso, tuttavia, una lettera in questo film per mostrare al mondo e sottolineare, il modo in cui vivevano”… “Non vedo la differenza tra documentario e fiction: sono capace di parlare solo della società da cui provengo”. Finanziato dal Ministero della Cooperazione francese è stato girato in tre settimane, con una troupe composta oltre che dalla Faye, da suo zio, come tecnico del suono e da un cameraman francese, ed è dedicato al nonno della regista, presente come attore e deceduto undici giorni dopo la fine delle riprese. Selezionato a Cannes nel ’75, ottenne il riconoscimento internazionale, vincendo premi prestigiosi come il Georges Sadoul e il premio della Critica Internazionale del Cinema al Festival di Berlino nel 1976. Inizialmente vietato in Senegal, fu proiettato nei cinema tedeschi e francesi nel 1976. Nella prima parte, il ritratto del villaggio ad opera della voce fuori campo della regista, che legge una lettera indirizzata ad un amico, sottolineata da immagini taglienti, in bianco e nero, di ambienti rurali, impoveriti dai prezzi fluttuanti delle poche colture, retaggio coloniale che ancora li limita. La cinepresa è fissa, sugli agricoltori nei campi aridi, i canti di lavoro, gli attrezzi irregolari e improvvisati, i bambini sulle spalle delle madri mentre lavorano. Per passare poi alle testimonianze dirette degli abitanti del villaggio, accettando anche i loro consigli su cosa filmare. La Faye è attenta a mostrare la cultura africana dall’interno, piuttosto che come osservatore obiettivo. Si parla di siccità, della necessità di variare le colture, oltre quella delle arachidi, promossa dal governo senegalese su richiesta delle multinazionali americane. La seconda parte narra la storia di Ngor e Coumba. Da due anni, Ngor desidera sposare la ragazza, ma anche quest’anno la siccità ha influenzato negativamente il raccolto, commerciabile solo una volta all’anno e il ragazzo e la sua famiglia, non possono permettersi la dote di Coumba. Così Ngor si reca a Dakar, per cercare un lavoro, ma invece di arricchirsi, viene sfruttato. Ritorna la dura vita rurale e i suoi problemi, la denuncia della corruzione nella nuova classe media nera e a ciò, si aggiunge il tema dell’esodo verso le città o l’estero. In città, non esistono relazioni di reciproco sostegno come avviene nel villaggio, ma solo sfruttamento, disoccupazione, imbrogli, come accade al protagonista: “Hai lavorato certo, ma non abbastanza bene. Vattene, e non vedrai la paga promessa”. Non mancano le scene ricche di tagliente ironia verso la Francia, come quella in cui il maestro del villaggio legge ad alta voce, le dichiarazioni dei rappresentanti del governo francese, sul giornale . Parole che hanno poca rilevanza per la loro sopravvivenza quotidiana, come rivela uno dei presenti: “Per me, la politica significa solo, mangiare un pasto al giorno, per sei mesi l’anno”.
Il progetto di “Mossane”, suo secondo lungometraggio, iniziò nel 1990, ma a causa di problemi con i produttori francesi, ottenne i fondi per realizzarlo solo nel 1996. Co-prodotto dalla televisione francese, tedesca e inglese è un melodramma che racconta la storia di una ragazza senegalese, di nome Mossane, che vive nel villaggio rurale di Mbissel. Dove le tradizioni sono molto radicate e si tramanda una leggenda che racconta della nascita, ogni secolo, di una bambina che morirà a causa della sua bellezza. I cattivi presagi avvolgono Mossane, che a quattordici anni è già considerata di straordinaria bellezza. Nessuno può resistere alla perla di Mbissel, persino suo fratello, Ngor, ne è affascinato. La ragazza, secondo l’usanza, alla sua nascita è stata promessa in sposa, la scelta è caduta su Diogoye, uomo piuttosto ricco e molto più grande di lei, emigrato in Francia. Diogoye, nel corso degli anni, ha fornito alla famiglia della ragazza molti regali, inclusa la dote, ed ora ha chiesto di sposarla per procura, per poi farsi raggiungere in Francia. Mossane, però, s’innamora di Fara, studente universitario povero, che la ricambia. La ragazza, divisa tra i propri sogni, i desideri dei genitori e le tradizioni, decide di ribellarsi e il giorno del matrimonio si rifiuta di sposare Diogaye. Dopo aver sfidato tutte le convenzioni fugge e s’ imbarca in una canoa sul fiume, ma la sua bellezza è tale da far innamorare anche gli spiriti, che pretendono la sua vita. La libertà coincide con la morte, il suo destino si compie come da profezia. Attraverso le canzoni della colonna sonora, la regista crea un’atmosfera che ricorda le tragedie greche, dove il coro commenta l’azione e gli esseri soprannaturali intervengono sul destino degli esseri umani. Ben rappresentate le figure di una società sospesa tra tradizioni ed esigenze di modernità, come il viandante saggio, il griot o lo studente universitario e l’immigrato, che ha fatto fortuna, ma rimane ancorato a usanze del luogo d’origine. Un ritratto della società in forma di favola senza lieto fine, debitore della tradizione orale, archetipi simili alla tragedia greca: la profezia, la bellezza fonte di sventura, l’attrazione incestuosa da parte di un consanguineo, l’amore impossibile, il sacrificio, la ribellione vana contro il destino e le tradizioni, infine la morte, che s’innestano con una spietata realtà sociale, che riguarda spesso anche le donne dell’area mediorientale: solitudine, matrimonio combinato, poligamia, tradizione e credenze, la modernità, il desiderio di poter decidere della propria vita. L’elemento di novità è rappresentato dall’ampio spazio riservato alla storia d’amore, che nel contratto matrimoniale non è necessario, e dove al primo posto c’è il fattore economico. A differenza dei precedenti lavori, dove la Faye, utilizzava uno stile più legato al documentario, in “Mossane” prevale la finzione, nonostante il villaggio e i problemi della vita rurale facciano da sfondo alla vicenda. Le donne nei film della Faye, sono sempre sospese tra desideri, esigenze di vita quotidiana, tra l’oggi e i miti, riti di una tradizione millenaria. Mossane, considerata un’eroina moderna, è diventata il vessillo dei movimenti femministi africani. Ma, come ha spesso ribadito la regista: “’Mossane’ non è un film femminista, è un film sulla libertà, l’indipendenza in rapporto a un contesto sociale particolare, quello del Senegal”. Il film, dedicato al coraggio e alla resistenza delle giovani generazioni, si sviluppa attraverso un linguaggio poetico, fatto di sguardi, movimenti dei corpi, uso della musica e del rito, che si fanno segni della lotta della protagonista. Poetica esaltata dal montaggio della Davanture, che sottolinea il cambiamento di ritmo, sino a farsi schizofrenico nelle scene finali. Grazie all’uso del colore della fotografia di Jürgen Jürges, e ai temi musicali della cantante e attrice senegalese Yande Codou Sene. Non manca un ringraziamento rivolto a Jean Rouch. Proiettato nella sezione Un Certain Regard al Festival del Cinema di Cannes del 1996 e al Toronto International Film Festival nel 1997, uscì nelle sale di Francia e Germania solo nel ’98, ritardo dovuto ad un conflitto con la produzione.
SAGGI
LA SAGA DI “ALIEN” – FENOMENOLOGIA DELLO XENOMORFO
di Riccardo Poma
La saga di “Alien” – che per ora conta sei film, esclusi gli spin-off – è certamente una delle più popolari ed apprezzate di sempre. Le (dis)avventure spaziali degli ignari astronauti alle prese con i mostri alieni chiamati “xenomorfi” coinvolgono gli spettatori perché, sostanzialmente, si ispirano all’atavica paura umana dell’ignoto. Ma la fortuna della saga è dovuta anche ad una formula azzeccata che fa incontrare le ambientazioni tipiche della space-opera con le atmosfere e gli stilemi tipici dell’horror di mostri. Altra scelta rischiosa ma vincente, portata avanti anche coi nuovi “Prometheus” e “Covenant”, è quella di catapultare dentro questo pastiche di generi cinematografici tipicamente maschili – fantascienza, horror, ma anche azione – una protagonista femminile. Una scelta che assume un valore aggiunto se si pensa che uno dei temi cardine della saga è proprio quello della maternità. Negli anni la saga è stata oggetto di molte interpretazioni, da quella sessuale/sessuofoba della scrittrice femminista Ximena Gallardo (la bocca dello xenomorfo sembra sia una vagina dentata che un pene eretto) a quella “sociale” del filosofo Kevin Decker (il sangue acido dell’alieno come metafora delle malattie veneree). L’unica cosa certa è che, come ogni grande saga che consideriamo cult (da “Star Wars” a “Harry Potter”, da “Il signore degli anelli” agli zombi di Romero), quella di “Alien” può prestarsi a infinite chiavi di lettura che la rendono continuo oggetto di studio. I sei film hanno visto susseguirsi quattro registi che, senza mai snaturarne gli elementi di fondo, hanno saputo portare al franchise lo stile e le riflessioni tipiche del loro cinema. Complimenti dunque a Fox, che ha lasciato spazio ad artisti anche molto diversi tra loro riuscendo comunque a garantire un file rouge che si è sviluppato coerentemente di capitolo in capitolo.
“Alien” di Ridley Scott
Nel 1979 esce “Alien” di Ridley Scott, prodotto da Century Fox e basato su uno script di Dan O’Bannon (già sceneggiatore del pregevole “Dark Star” di John Carpenter) e Ronald Shusett. Nel 2122 l’equipaggio della nave da carico Nostromo, nello spazio per cercare e portare sulla terra combustibili minerari utili al fabbisogno energetico, intercetta una richiesta d’aiuto proveniente da un pianeta sconosciuto; giunti alla fonte del segnale, gli uomini e le donne dell’equipaggio non si accorgono di essersi portati a bordo un temibile alieno che sembra avere come unico obiettivo il loro sterminio. Alla fine l’unica sopravvissuta risulterà essere il tenente Ellen Ripley (Sigourney Weaver), secondo ufficiale della Nostromo. L’incredibile design dell’alieno fu sviluppato dall’artista svizzero Hans Ruedi Giger e realizzato dal grandissimo Carlo Rambaldi. Sull’aspetto scelto per il mostro, il sociologo italiano Carlo Bordoni sostiene che “lo xenomorfo fa paura proprio in virtù di ciò che siamo disposti a riconoscere di umano in lui, come di fronte a una velata minaccia di ciò che potrebbe diventare l’uomo in un luogo e in un futuro remoti, senza più alcun legame culturale o comportamentale con l’oggi”. In pratica, l’alieno non è altro che un’aberrazione di ciò che spesso già siamo: esseri che per sopravvivere diventano meschini, violenti e disposti a tutto.
A livello di trama le ispirazioni di O’Bannon e Shusett erano abbastanza esplicite: i più attenti notarono molte somiglianze di trama col cult nostrano “Terrore nello spazio” (1965) di Mario Bava, ma l’idea di base doveva molto anche ad un vecchio racconto di A. E. Van Vogt dal titolo “Discord in Scarlet” (lo scrittore minacciò querele, ma Fox lo quietò con un lauto accordo economico). La regia di Scott ricorda quella di Stanley Kubrick tanto è controllata, sinuosa, simmetrica: un rigore formale che accentua la suspense e, senza alcuna fretta (il mostro appare dopo un’ora di film), traghetta lo spettatore verso la sanguinolenta caccia all’uomo della seconda parte. La macchina da presa, perennemente ad altezza nuca, fiata sul collo dei terrorizzati protagonisti e contribuisce a creare un clima di claustrofobica angoscia. Non solo. Celando il mostro e mostrandolo raramente per intero, Scott fa di necessità virtù: da un lato sopperisce alla palese artificiosità dei trucchi (si trattava di pupazzi animati, mica di computer grafica), dall’altro stuzzica lo spettatore creando una paura basata sul non visto, sull’indefinito e sull’indefinibile. Altri contributi tecnici notevoli del film sono il sound design, un inquietante tessuto sonoro di rumori e musica che inquieta e disturba, e il sapiente uso della luce che crea un clima onirico e allucinato.
Insomma, non è un’esagerazione sostenere che “Alien” sia, a livello stilistico, un film da scuola del cinema. E che, a partire da una trovata narrativa decisamente “a la Hitchcock” (il protagonista – Dallas/Tom Skerrit – muore dopo un’ora di film e lascia il posto ad un altro personaggio – Ripley/Sigourney Weaver – come accadeva in “Psyco”), si rivela tutt’altro che un horror convenzionale. Così come poco convenzionali sono i temi affrontati. Innanzitutto, i protagonisti del film non sono scienziati interessati alla conoscenza e all’esplorazione come accade in ogni space-opera che si rispetti: si tratta piuttosto di semplici operai che, stipendiati da corporation (la Weyland, in questo caso), vagano per l’universo cercando di sopperire al fatto che la Terra sia oramai inabitabile e priva di risorse energetiche. Questa totale assenza di poesia rivela un notevole pessimismo di fondo, sottolineato anche dal ruolo negativo della tecnologia: non solo astronavi e strumenti sono già in disfacimento (la sala macchine della Nostromo pare quella del Titanic), bensì addirittura i frutti più innovativi del progresso umano – come gli androidi – si rivelano infine controproducenti (sono disposti a sacrificare gli umani pur di portare lo xenomorfo sulla Terra per essere studiato). L’androide Ash (Ian Holm), tornando all’eterno dibattito sul rapporto tra scienza e suoi limiti imposti dalla morale e dall’etica, considera l’alieno un essere perfetto perché non è offuscato dalla coscienza e dunque non possiede debolezze. Tuttavia, alla fine, Ripley vince su di esso utilizzando la propria astuzia e la propria intelligenza per sopperire alla propria debolezza fisica, cioè alla propria imperfezione. Come dire: rispetto allo xenomorfo gli umani saranno pure esseri geneticamente imperfetti, ma è proprio questo a renderli degli esseri umani.
“Aliens” – Scontro finale di James Cameron
Il grande successo del film di Scott spinge la Fox a mettere in cantiere un seguito, uscito nel 1986. A dirigerlo viene chiamato James Cameron, reduce dal successo di “Terminator” e “Rambo II”. Dopo 57 anni di ipersonno nella navetta di salvataggio della Nostromo, Ripley è intercettata e risvegliata. Una volta scoperto che il pianeta del primo film è stato colonizzato ma che ora non arriva più alcuna trasmissione da esso, Ripley accetta suo malgrado di accompagnarvi scienziati e marines. Qui, dopo aver trovato una bambina, unica superstite, scoprirà un vero e proprio alveare comandato da una regina aliena. Meno concettuale e decisamente più “bad-ass” del primo (personaggi duri e puri, battutone da caserma), questo sequel si stacca dalla suggestioni kubrickiane del primo e punta molto sull’azione, senza tuttavia mai rinunciare alla suspense (la prima parte coi marines che arrivano sul pianeta è da brividi) o alle riflessioni “alte”. La macchina da presa si muove velocissima, il montaggio si fa frenetico e le scene riflessive non sono altro che preludi all’azione. Anche a livello tematico il film è un Cameron a 18 carati: c’è la passione per mezzi di trasporto e armi, la fascinazione per l’ambiente militare e gli scontri a fuoco, c’è l’idea di una tecnologia buona e davvero amica dell’uomo (questa volta il cyborg Bishop – Lance Henriksen – è un personaggio positivo, e alla fine Ripley ha la meglio sul mostro sfruttando il suo aiuto e quello di un esoscheletro meccanico da carico). Più consapevole e decisa (anche perché ormai conosce il nemico), Ripley se ne sta a guardare per un’ora e poi si lancia attivamente nella battaglia.
Forti diventano in questo sequel i temi della femminilità e della maternità: l’alieno che depone le uova è una vera e propria regina, dunque una femmina ed una madre; non è difficile considerarla la controparte mostruosa della stessa Ripley, che qui si scopre anche madre nell’interfacciarsi con la piccola Newt, unica superstite della colonia. Lo scontro tra Ripley e la regina è lo scontro tra due femmine dominanti che lottano per salvaguardare la propria specie, ma anche quello tra due madri che lottano per tenere in vita le rispettive progenie. Alla fine del film si salvano soltanto il caporale Hicks (Michael Biehn), Newt (Carrie Henn) e la stessa Ripley, andando così a formare una sorta di famiglia improvvisata in cui tuttavia sono molto chiari (e non convenzionali) i ruoli: la donna, Ripley, è colei che prende le decisioni e salvaguarda l’integrità della famiglia mettendo sé stessa davanti a tutto; la figlia, Newt, è il bene supremo da proteggere e salvaguardare; l’uomo, Hicks, è un vero duro ma non ha voce in capitolo sulle scelte legate alla famiglia, sempre e comunque governata da Ripley (usando un’espressione poco accademica ma significativa, è lei che porta i pantaloni). Ecco che, ancor più che nel film di Scott, è la donna con le sue scelte il fulcro attorno a cui ruotano le vicende della saga. Continua anche il discorso sui limiti della scienza: di nuovo, le corporation e i governi sono disposti a tutto pur di portare sulle Terra lo xenomorfo, ufficialmente per studiarlo, ufficiosamente (come pensa anche la stessa Ripley) per trasformarlo in un’arma potentissima. Questa riuscita commistione di azione e riflessioni profonde fa di “Aliens – Scontro finale” uno dei capitoli della saga più apprezzati di sempre sia dal pubblico che dalla critica.
“Alien³” di David Fincher
Pubblico e critica sono concordi nel considerare il terzo capitolo il meno riuscito della saga: noioso, troppo parlato, poco coerente a livello narrativo. Certo non hanno giovato al risultato finale le vicissitudini produttive che hanno portato ad un continuo cambio di sceneggiatori (nei credits è citato solo Vincent Ward, ma pare che gli autori che misero mano al progetto furono una decina, tra i quali anche il grande scrittore di fantascienza William Gibson). La storia ricomincia esattamente dove finiva nel film di Cameron. Mentre viaggia verso la Terra, la navetta con a bordo Bishop, Ripley, Newt e Hicks (gli ultimi tre ancora in ipersonno) si schianta sul pianeta/carcere Fury 161. La donna è l’unica sopravvissuta allo schianto, ma la perdita dei propri cari è solo l’inizio della fine: quando scopre di avere in grembo uno xenomorfo pronto a nascere, Ripley è costretta al suicidio per evitare che la Weyland lo porti sulla terra. L’ambientazione del film è decisamente azzeccata: un pianeta semi abbandonato utilizzato come carcere di massima sicurezza in cui rinchiudere gli indesiderati, non controllati da secondini ma col compito di far andare avanti una miniera che lavora per la Terra (impoverita delle risorse, come già si diceva nel primo capitolo). La trovata geniale è che tutti i prigionieri sono uomini – l’arrivo di Ripley porta infatti scompiglio – e, per giunta, fervidi credenti che utilizzano la religione per lenire la propria prigionia e, soprattutto, per autoregolarsi. I fan hanno storto il naso per la discutibile trovata di partenza (perché far morire due personaggi come Newt e Hicks?), ma è pur vero che, affinché la narrazione arrivasse coerente al capolinea (il suicidio di Ripley), occorreva che la protagonista non avesse più nulla da perdere.
Cameron aveva inebriato l’horror fantascientifico con una ventata di cinema d’azione, Fincher fa la stessa cosa aprendo al dramma carcerario. Una scelta che si rivela comunque coerente con lo spirito della saga. Ma il futuro regista di “Seven” si fa notare anche per lo stile raffinato: introduce le soggettive dell’alieno per aumentare la suspense, filma i personaggi dal basso per aumentare il clima di oppressione che si respira nel carcere, concepisce scene di forte impatto simbolico (notevole il montaggio alternato tra il funerale di Newt e Hicks e la nascita dello xenomorfo dal ventre del cane, sottolineato ironicamente dalle parole del Pastore). Per quanto riguarda invece il rapporto con la tecnologia, Fincher si tiene in bilico tra suggestioni scottiane (tutto è in disfacimento, nulla funziona mai come dovrebbe) e riflessioni notevoli che anticipano i capitoli a venire. Come quella sulla coscienza degli esseri robotici: i resti di Bishop chiedono a Ripley di essere terminati, proprio come un essere umano malato chiede che si metta fine alla sua sofferenza. La domanda sorge spontanea: Bishop è programmato per sentire dolore o davvero è arrivato a provarlo come un qualsiasi essere umano vero? Qualunque sia la risposta, fa davvero differenza? Interessante anche il lavoro che viene fatto sul personaggio di Ripley: donna, arriva in un mondo di soli uomini; facendo sesso col dottor Clarence (Charles Dance) esplicita una femminilità che aveva sempre dovuto accantonare per lasciare il posto alla sua parte combattiva, ma è subito costretta a nasconderla (tagliandosi i capelli a zero) per difendersi in qualche modo dagli altri maschi (cosa che comunque non la protegge dal rischio di essere violentata). Infine, scopre che dentro di lei non c’è uno xenomorfo qualunque, bensì una regina. La regina umana ospita la regina aliena, e dunque la battaglia non può avere un finale lieto perchè l’unico modo per fermare la seconda è uccidere la prima. La morte di Newt, Bishop, Hicks e Ripley segna la morte del bene e ci fa guardare al futuro con occhio decisamente sconsolato.
“Alien – La clonazione” di Jean-Pierre Jeunet
Dopo aver chiamato in causa un britannico, un canadese e un americano Fox stupisce tutti ingaggiando per il quarto film della saga il francese Jean-Pierre Jeunet, fattosi notare in patria per due anomali film di stampo fantascientifico/grottesco, “Delicatessen” (1991) e “La città perduta” (1995). Duecento anni dopo il suo sacrificio – siamo dunque nel 2379 – Ellen Ripley viene clonata sull’astronave laboratorio Auriga per poter estrarre dal suo corpo un esemplare vivo di xenomorfo regina. Il governo vorrebbe utilizzarlo per scopi militari, ma il mostro fugge al controllo e inizia a deporre uova e quindi a partorire nuovi alieni. Con l’aiuto di un gruppo di ignari pirati spaziali bloccati sulla nave il clone Ripley cerca di fuggire, ma il suo legame con la regina è così forte da arrivare a dubitare di volerla eliminare.
“La mia mamma diceva sempre che i mostri non esistono. Non quelli veri. Invece esistono”. A cominciare da queste parole, pronunciate dalla voce fuori campo di Ripley ad inizio fim, questo quarto capitolo si preannuncia diverso dai tre che lo hanno preceduto. Jeunet prende da Scott le suggestioni kubrickiane e da Cameron i personaggi bad-ass, ma il suo film sembra muovere verso altre vie. Il cambiamento più grande rispetto al passato, da cui derivano tutti gli altri, si ha proprio nel personaggio di Ripley. Innanzitutto non si tratta davvero del tenente della Weyland conosciuto negli altri film, bensì di un clone creato col solo scopo di gestare la regina aliena. La nuova Ripley si muove spaesata come appena nata, e infatti è inizialmente inquadrata in una sorta di sacco di plastica che ricorda una placenta. Il clone è un involucro che conserva alcuni tratti caratteriali della vera Ripley – come la solidarietà e il coraggio – ma che racchiude anche molte caratteristiche della razza aliena (freddezza, forza sovrumana, aggressività). Soltanto nell’incontro con il droide Cole (Wynona Ryder), un essere artificiale creato dall’uomo che come lei non riesce a comprendere (o forse solo ad accettare) il proprio scopo, il clone di Ripley mette da parte i propri tratti alieni e lascia affiorare quelli umani. Ecco perché alla fine, nonostante l’evidente sofferenza, sceglie di stare dalla parte degli umani e di uccidere l’essere che, tecnicamente, è per lei un vero e proprio figlio. Da un lato c’è la Ripley umana che sa che è giusto ucciderlo, dall’altro la Ripley madre dell’alieno che, come qualunque essere vivente (compreso lo xenomorfo) patisce la morte di ciò che arriva dal suo grembo (i maligni hanno ironizzato sulla cosa scrivendo che “ogni scarrafone, è bello a mamma sua”, ma al di là dell’espressione non proprio accademica il senso è proprio questo). Per molte ragioni, dunque, è il film più al femminile di una saga che è già di per sé tutta al femminile. Due protagoniste donne, uno xenomorfo regina come villain. La battaglia rimane tra esemplari femmina, con i maschi o malvagi o, se buoni, semplici gregari, ed è emblematica a questo proposito la scena in cui Ripley strappa la lingua dentata di uno xenomorfo morente come se lo evirasse. Alla fine si scopre pure che Ripley, unico ospite mai rimasto vivo dopo il “parto”, ha in qualche modo dato alla regina un sistema riproduttivo umano che non necessita di uova. È il lascito di una madre ad un figlio, ma anche la rappresentazione perfetta di un vero e proprio salto evolutivo. Anche la regia di Jeunet sembra sottolineare queste riflessioni sulla maternità: si pensi ai tanti passi che ricordano la fiaba (le parole iniziali di Ripley, ma anche la discesa della protagonista tra i tentacoli alieni), il tipo di racconto che da sempre racconta le basi del rapporto genitori-figli.
Il film è anche uno dei più politici della serie (negli altri era una corporation ad avere la presunzione di addomesticare il male per scopi militari, qui è direttamente il governo), e apre una serie di interrogativi legati alla robotica che in qualche modo anticipano le riflessioni di “Prometheus”: c’è davvero differenza tra coscienza umana e coscienza artificiale? In fin dei conti i personaggi capaci di maggiore umanità ed empatia sono due esseri artificiali, un clone e un droide sintetico. Dunque le loro emozioni valgono meno di quelle degli uomini? A vedere come si comportano loro e come si comportano questi ultimi, verrebbe da dire che valgono di più. Tuttavia, non sempre l’arrivo di tratti umani in un essere non umano ne fa un essere migliore: lo xenomorfo, ad esempio, apprende sentimenti umani negativi come la vendetta e il risentimento (emblematica la scena in cui uccide gli scienziati utilizzando gli strumenti che questi ultimi usavano per tenerlo a bada). La nuova specie, dunque, è più cattiva perché più umana e meno bestiale. Sono passati duecento anni ma la scienza – delle multinazionali prima, governativa ora – continua a non capire che giocare a fare Dio si rivela sempre quacosa di controproducente: emblematica, a tal proposito, la sequenza in cui Ripley disintegra col fuoco i sette cloni “sbagliati” creati prima di lei, come a dire che a cancellare i limiti della scienza si finisce immancabilmente col generare mostri. Un pessimismo riscattato dal finale più straniante della saga, in cui finalmente si arriva sulla Terra (il nostro pianeta non era mai apparso) e accade qualcosa che ricorda da vicino la creazione della “famiglia ideale” vista alla fine di “Aliens” di Cameron. A salvarsi soltanto il clone Ripley, l’androide Cole, il badass Johner (Ron Perlman) e il disabile fisico Vriess (Dominique Pinon). Emblematico che, tolto Johner, gli altri tre appartengano a minoranze bistrattate, ed emblematico che tutti e quattro siano reietti rifiutati per ciò che sono. Le coppie che potrebbero formarsi sono Ripley/Johner (in virtù dell’essere due bad-ass) e Cole/Vriess (in virtù del legame che li lega), ma – perché no? – anche Ripley/Cole (esseri artificiali) e Johner/Vriess (esseri umani, che per giunta nell’ultima scena si baciano sulla bocca per la gioia di essersi salvati). Qualunque sia il loro futuro, l’unica cosa certa è che la navetta porta su una Terra in crisi energetica, climatica, demografica, un anomalo meltingpot di “ultimi” che ha tutto il diritto di ripopolarla a propria immagine e somiglianza. Questo perché, indipendentemente da ciò che sono e dal cupo mondo in cui vivono, questi personaggi hanno saputo mantenere la loro umanità. Come? Portando in salvo non solo se stessi, bensì anche gli altri. Ecco un barlume di ottimismo in una saga che ha fatto di un pessimismo quasi assoluto un marchio di fabbrica.
“Prometheus” di Ridley Scott
Nel 2004 e nel 2007 escono due mediocri spin-off di “Alien”. Si tratta di “Alien vs. Predator” di Paul W. S. Anderson e “Alien vs. Predator 2” dei fratelli Greg e Colin Srause. Per il quinto capitolo della saga si dovrà attendere il 2012, quando per la regia di Ridley Scott (regista del primo) esce “Prometheus”, un prequel in cui si racconta come – e perché – nacque il primo xenomorfo. “Alien – La clonazione”, capitolo conclusivo delle avventure di Ripley, terminava con l’arrivo dei superstiti sulla Terra; “Prometheus” vi inizia, ribadendo una certa circolarità del racconto ma anche che molto duro è stato il pellegrinaggio dell’uomo dalla partenza (“Prometheus”) al ritorno (“La clonazione”). In Scozia, nel 2089 una coppia di archeologi trova una mappa stellare in cui i precursori dell’umanità – alieni scienziati detti “ingegneri” – sembrano invitare gli esseri umani ad incontrarli. Quattro anni dopo, grazie ai fondi di una multinazionale chiamata Weyland Enterprise, i due arrivano al pianeta dei nostri creatori. Qui scoprono che gli alieni ci hanno effettivamente creato, ma che ora il loro obbiettivo è diventato distruggerci attraverso un virus biologico potentissimo. Tuttavia l’arma selezionata per lo scopo sfugge al loro controllo e, rivoltataglisi contro, dà vita ad un nuovo essere pericolosamente simile allo xenomorfo.
Qualcuno ha rimproverato a Scott di aver concepito la tecnologia del 2093 come più avanzata rispetto a quella in disfacimento del 2122, anno in cui è ambientato il primo “Alien”, ma si tratta di una critica decisamente fuori luogo. È molto chiaro, infatti, che la tecnologia del 2122 si trovi in stato di disfacimento DOPO aver raggiunto l’apice, e dunque ha perfettamente senso che quell’apice sia stato raggiunto una trentina di anni prima (nel 2093, appunto). A livello tematico il film rielabora alcuni elementi tipici del cinema di Scott, ma si deve tener conto che tra il 1979 di “Alien” e il 2012 di “Prometheus” il regista ha girato nientemeno che “Blade Runner”, ed è subito chiaro quanto il concetto di fantascienza del regista sia mutato proprio in seguito a quel film. Proprio come i replicanti del film del 1982, il vecchio Peter Weyland (Guy Pearce) sogna di incontrare il proprio creatore per chiedergli “più vita”. L’obiettivo della scienziata protagonista, la dottoressa Elizabeth Shaw (Noomi Rapace), è quello di scoprire chi ci ha creati, quello di Weyland è scoprire perché ci hanno creati imperfetti, ovvero mortali. Tuttavia, nel momento in cui scopre che gli “ingegneri” vogliono distruggerci, anche la Shaw comincia a cercare risposte. Si tratta di un’emblematica rappresentazione del bisogno umano di conoscere le risposte per capire ciò che non si è in grado di capire e, dunque, accettare. Non a caso la missione si chiama Prometeo, come l’uomo che nel mito greco voleva sottrarre il fuoco agli dei per elevare gli esseri umani: l’unica differenza è che qui il fuoco da sottrarre è il sapere. Il discorso di Scott non si ferma qui. La religione, ci dice, opta per il dogma e cessa di porsi domande; nella scienza, invece, il dogma non esiste: se c’è qualcosa che non riusciamo a capire è più che legittimo continuare a porsi le domande e cercare combattivamente una risposta ad esse. Troppo facile fermarsi perché qualcuno ci ha detto che il fuoco è in mano a Dio e, dunque, irraggiungibile. Si deve piuttosto lottare per provare ad ottenerlo. Un umanesimo profondo in cui la cieca fiducia nella scienza non esclude per forza di cose la spiritualità. A sostegno di questa tesi c’è un emblematico dialogo tra la Shaw e il suo compagno Holloway:
Holloway: “Quindi Dio non esiste. Loro ci hanno creato”
Shaw: “Già, ma chi ha creato loro?”
Un colpo al cerchio e una alla botte? Può darsi, ma il discorso non fa una grinza. Oltre al tema della maternità (la Shaw non può avere figli ma, come Ripley, porta in grembo un alieno) torna, più forte che mai, quello dell’intelligenza artificiale. Il cyborg David (Michael Fassbender), pupillo di Peter Weyland, è un essere perfetto costruito per assecondare i bisogni degli esseri umani. Weyland crea David per ovviare a quello che secondo lui è il difetto principale della razza umana, ovvero la mortalità. Non a caso, è proprio questa la domanda che Weyland pone all’ingegnere sopravvissuto: perché mi hai fatto mortale, quando avresti potuto crearmi eterno come l’essere (David) che ho creato io?
Tuttavia, non è difficile constatare che la perfezione di David è relativa. Le sue azioni sono davvero sempre mosse da scopi scientifici? Quando contagia volutamente Holloway per scoprire le reazioni del virus alieno, il suo scopo è davvero solo accademico? Oppure c’è della cattiveria nelle sue azioni? In pratica, David è l’ennesimo essere non umano che eredita i tratti negativi degli esseri umani, proprio come l’alieno rancoroso visto ne “La clonazione”. Quanto nelle azioni di David è frutto della sua programmazione – “la scienza prima di tutto” – e quanto invece, nonostante la materia sintetica di cui è fatto, prova sensazioni terribilmente umane come l’invidia, il rancore, la rabbia? Domande che, almeno parzialmente, troveranno risposta nel secondo prequel, “Covenant”.
“Covenant” di Ridley Scott
Nel 2017 esce “Alien: Covenant”, ancora una volta diretto da Scott. Il film è stato criticato duramente a livello narrativo (trama inverosimile, personaggi stupidi, colpi di scena telefonati), ma va riconosciuto a Scott di aver portato avanti in maniera coerente il discorso iniziato cinque anni prima con “Prometheus”. La trama è pericolosamente simile a quella del primo capitolo: nel 2104, circa dieci anni dopo gli eventi del film precedente, un astronave con a bordo 2000 coloni – la Covenant, appunto – subisce un’avaria ed è costretta a rispondere ad un SOS lanciato da un misterioso pianeta che potrebbe essere abitabile. Arrivati sul posto, gli astronauti scoprono che quello è il pianeta natale degli “ingegneri”, ma che questi ultimi sono stati distrutti dal cyborg David che li ha iniettati col virus nero per trasformarli in esseri secondo lui perfetti, ovvero gli xenomorfi.
L’introduzione del film, in cui scopriamo che David ha preso il nome da un oggetto che, meglio di qualunque altro, simboleggia la perfezione tanto cercata da Weyland (il David di Michelangelo) riprende ancora una volta le suggestioni kubrickiane di “2001: odissea nello spazio”. Questa volta il modello è decisamente attinente, anche perché il fulcro del film è la riflessione su una macchina (David) che, sfuggita al controllo dell’uomo, diventa pericolosa per l’uomo stesso (quello che accadeva con il computer HAL 9000 nel capolavoro di Kubrick).
I dubbi di “Prometheus” diventano certezze: David è diventato tristemente simile al proprio creatore Peter Weyland nel fare propria la superbia umana di volersi sostituire a Dio. Ciò che vuole è il potere di distruggere e di creare, e infatti non a caso si ritrova a citare la poesia Ozymandias di Percy Bysshe Shelly, il cui tema centrale è l’inevitabile declino di tutti gli imperi costruiti dall’uomo. Ciò che rimane da capire – come già accadeva nella quadrilogia originale – è quanto di quelle azioni siano parte della sua programmazione (scopo primario: trionfo della scienza) e quanto, invece, siano frutto di una vera e propria coscienza, seppur negativa. L’unica cosa certa è che il cerchio narrativo si chiude nel modo più cupo: gli “ingegneri” hanno creato gli uomini, gli uomini hanno creato David, David ha creato lo xenomorfo e lo xenomorfo, Ripley permettendo, diverrà il responsabile della distruzione umana. David ha eliminato i creatori (gli “ingegneri”) dei propri creatori (gli uomini) perché li ritiene indegni di sé e di ciò che LUI è stato in grado di creare. Ecco di nuovo il tema della ricerca della perfezione, un concetto tuttavia relativo perché, per ognuna delle parti chiamate in causa da Scott (Weyland, David, gli “ingegneri”) ha un’accezione differente. Per Weyland perfezione è immortalità, per David è assenza di coscienza.
Il finale di “Covenant” è un finale aperto, anche perché Scott ha affermato che girerà un terzo prequel. Quali che saranno gli sviluppi, è innegabile che la saga di “Alien” abbia saputo in questi cinquant’anni mettere in campo riflessioni tutt’altro che banali, soprattutto se si pensa che il genere di riferimento della saga è un genere spesso giudicato frivolo come l’horror. Il potere immaginifico dello xenomorfo rimane qualcosa di unico ed emblematico, capace di interpretare le nostre paure e le nostre ansie rispetto all’ignoto ma anche di farci ragionare sulle direzioni che sta prendendo il nostro futuro. Per evitare di trovarci un giorno a bordo di una Nostromo, in cerca di risorse o di un pianeta che ci ospiti perché abbiamo distrutto il nostro.
IN RICORDO DI …
MARCO FERRERI
ESSERE COERENTI NON SIGNIFICA ESSERE RIVOLUZIONARI.
L’UTOPIA NEGATIVA DI MARCO FERRERI
di Roberto Lasagna
“L’opera di un signore può essere coerente, ma essere coerente non vuol dire essere rivoluzionario; io posso dire di essere coerente, non ci sono gli studenti che mi spernacchiano, ma comunque non posso dire di essere rivoluzionario. (…). Queste sono contraddizioni fondamentali in un individuo… Certo, l’ho fatto, ma riconosco i miei limiti… Comunque anche prima lo pensavo, già da ‘L’uomo dei cinque palloni’. Non nei film spagnoli, non nella ‘Donna scimmia’, perché erano film diciamo più neorealistici. Quando entri nell’isolamento lo fai per protesta, perché ti dici: ‘io non voglio essere assorbito, io non voglio entrare nel sistema’, ma non è che isolandoti non entri; vivi, vivi in isolamento ma vivi nel sistema, dai una ragione anche al sistema per dire ‘ma nel sistema si può criticare, si può parlare’… In fondo un film, che può essere non rivoluzionario ma che attaccava una parte del sistema, per noi attaccava la censura, era ‘L’ape regina’, perché dopo ‘L’ape regina’, che è stata ferma sei mesi, che ha costituito un precedente, qualcosa è cambiato. La mia opera la individuo anche in questa distruzione, in questo cercare di ottenere la libertà massima. Adesso è diverso. ‘Dillinger’ è sì un film a basso costo, è un film abbastanza felice, è un film libero, ma poi deve rientrare nei canali, c’è una distribuzione, ci sono le vendite, cioè entra nei canali normali; è sempre una protesta borghese; ripeto, può darsi che noi possiamo fare solo questo, ma io non sono contento; sento gente che dice ‘ma io non sono integrato, io sono contento di quello che faccio, io faccio tutti gli sforzi per essere al di fuori’, ma non è vero, con le opere non intacchiamo. (…). Ci sono due strade. Bisogna decidere: o fare delle opere quantitativamente numerose, tirare fuori le opere, cercare di distruggere il metodo attuale del cinema, fare cinquanta film in un anno se si possono fare, fare i film come li fa il signor Godard, in una certa direzione, con un certo capitale; oppure smettere per un momento di fare il cinema e cercare di fare la rivoluzione; questi sono i due sistemi. E la rivoluzione si fa facendo la rivoluzione, non facendo i film”.
Così parlò Marco Ferreri, intervistato da Adriano Aprà per il numero doppio di “Cinema & Film” della primavera del 1969. Sono parole di una radicalità inequivocabile, che mostrano il tono di autentica solitudine a cui non vuole comunque cedere il regista indomito Ferreri. Quello che il regista ci porta a vedere con “Dillinger” e “Il seme dell’uomo”, entrambi film usciti nel 1969, è che la fuga non è possibile perché oltre la dimensione chiusa di questa società non c’è l’inesistente, il nulla, ma qualcosa di molto peggio, ancora questa società e ancora questo mondo. Non è dunque possibile fare la rivoluzione attraverso il cinema perché il cinema riporterebbe allo stato esistente. In queste frasi di Ferreri è dato di cogliere una disillusione, forse, ma anche una radicalità di sguardo che ci è parsa sovente perduta in anni a noi più vicini. Quello che capita dopo il Sessantotto, per lui, è che l’utopia inseguita non è la concreta realtà trasformata, in grado di portare, nel presente, al cambiamento; ciò che vagheggiano i personaggi di Ferreri è un’isola al sole, come quella di Tahiti, o come quella della coppia di giovani del “fantascientifico” “Il seme dell’uomo”: un luogo in cui si rinnova il cannibalismo dell’uomo sull’uomo, anche attraverso il rifondarsi irrazionale di istinti che nella famiglia vedono la prigione ontologica. E’ propriamente, quella di Ferreri, un’utopia negativa, che nel 1968 avrebbe fatto scuola con un film di produzione anglo-americana come “2001: Odissea nello spazio”, non a caso citato dal regista italiano in una sequenza de Il seme dell’uomo, quella in cui il giovane sopravvissuto ai fantomatici disastri collettivi mai spiegati nel film mostra al responsabile di stato la sua casa museo, tra cui le immagini dell’uomo quando volteggiava sulle astronavi (è evidente che l’Utopia del progresso spaziale non ha portato molto lontano l’uomo).
Ma la rivoluzione è allora estetica, ad un livello di comunicazione che contempli e affini il gusto degli spettatori. Ma ciò evidentemente non basta a Ferreri, perché la realtà non sembra ancora preparata e comunque è da leggere sempre con attenzione evitando di sottrarsi all’esperienza quotidiana con gli altri, con chi sperimenta le difficoltà spicciole e quotidiane del vivere. Il regista ha in mente il sistema cinema, in particolar modo quello italiano, conforme e corrotto con evidenti riflessi e parallelismi possibili tra l’Italia del compromesso storico e quello della Spagna franchista da cui presero le mosse i suoi film d’esordio. Gli appaiono fin troppo chiari gli atteggiamenti delle persone per strada, per le quali il cinema è un solletico, un’aspettativa evasiva, non lo strumento rivoluzionario che può smascherare, per dirla con Adorno, la duplicazione del reale, e rendere libero lo sguardo e i condizionamenti che lo tengono in una prigione. Il cinema del regista italiano indica nella sua strada una traiettoria di uomini che sono vittime insofferenti, più che di una rivoluzione impossibile, di una rivoluzione fraintesa. A loro, nel migliore dei casi, è lasciato di riuscire in un gesto anarchico di ribellione, a cui segue presto la sconfitta, mostrata dal film o rinviata al di là delle immagini, in un racconto possibile. Nelle azioni prive di vera forza di un Dillinger, si rivela la sua impotenza, e la sua non-consapevolezza. Individui destinati a ridursi come animali sacrificali perché privi di potere, propriamente im-potenti. E’ questo il momento in cui l’autore accusa direttamente e senza ambiguità una classe sociale e lascia pensare a quanto siano realistiche le sue osservazioni nei confronti di una rivoluzione che il cinema non può fare. La classe sociale a cui appartengono i vinti del suo cinema non riconosce a loro alcun diritto: li depriva di opportunità umane davvero rivoluzionarie. Per Ferreri, se non si riconosce questo assunto, un film può solo sperare che si apra una breccia, uno spiraglio nello sguardo imbavagliato. I piccoli uomini del suo cinema, tra la metà degli anni Sessanta e il ’68, sono piccoli imprenditori, professori, ingegneri, fotografi, disegnatori di fumetti, avvocati, magistrati, registi televisivi, cuochi, piloti d’aerei, giovanotti smaniosi di una promozione sociale oppure in cerca di una felicità sbandierata come possibile attraverso le opportunità della scena consumistica: stati e atteggiamenti che rappresentano agli occhi di Ferreri una moltitudine di pose con cui l’uomo del cosiddetto boom economico vive la fuga dal reale. Come scrivevano Fulvio Accialini e Lucia Coluccelli: “una schiera di nevrotici frustrati, che un ordine repressivo ha mutilato, riducendone nel tempo e nello spazio la libido, una moltitudine ordinata di piccoli-medi borghesi schiacciati tra chi ha il potere politico e chi il potere lo avrà domani” (in “Marco Ferreri”, Edizioni Il Formichiere, Milano, 1979, pag. 184.). In Ferreri urta la critica alla coscienza politica del buon senso comune, quella frase generica pronunciata con rabbia che palesa l’insoddisfazione di chi, sentendo di essersi costruito con le proprie mani e credendo di essersi garantito un privilegio, scopre ora che il proprio ruolo è nullificato, al lavoro e a casa. La rivoluzione che può fare il cinema è allora da intendersi, in Ferreri, di mostrare come l’uomo che vive solo entro schemi determinati, quelli dell’alienazione, possa rendersi conto della sua prigione. Nei suoi film, quando il tempo del lavoro e del divertimento regolato escono dai binari prestabiliti e sfuggono al controllo, il ritmo degli ingranaggi sociali si spezza e l’uomo si scopre solo, avverte l’insoddisfazione insopportabile, inscena un macabro rituale che richiede la sua o le sue vittime, come Dillinger che, la prima notte di ferie, uccide la moglie addormentata. La fuga impossibile è simboleggiata da immagini pubblicitarie e slogan che non possono avere nulla di rivoluzionario, come nel “dirigibile” della pepsi-cola che simboleggia l’orizzonte esistenziale mercificato, a una dimensione, dei protagonisti de “Il seme dell’uomo”. Questi uomini senza qualità, o “a una dimensione”, hanno chiuso ogni spiraglio alla loro immaginazione, sono giovani mai stati giovani e individui precocemente invecchiati, che hanno destituito la loro capacità di eversione, e persino quanto di più libero, il sesso, è stato “soggiogato dall’ordine della procreazione”, mentre la perversione si indirizza a canoni consueti, perché, in un cinema che via via racconterà “storie di ordinaria follia” o “diari di un vizio”, anche la dimensione sessuale apparirà priva di ribellione ma avvitata sulle incostanze della pulsione, nelle linee di una costrizione imposta anch’essa da modelli riconosciuti. Dentro queste costrizioni, il cinema di Ferreri si intratterrà a lungo, e nel suo percorso anche la critica dovrà riconoscere che, per quanto il sogno dei movimenti giovanili del ’68 non si è realizzato, la rivoluzione è rimasta come una prova, una prospettiva politica da anticipare nella vita quotidiana, di cui il cinema del regista ha osservato la distanza siderale tra lo slancio al cambiamento e la minuta osservazione di un’impossibilità. E da quegli anni il regista trarrà nondimeno lo spirito per una nuova “fuga in avanti”, a livello espressivo, quasi come gli era successo durante gli anni spagnoli.
CHIEDO ASILO: LA RIVOLUZIONE PEDAGOGICA
di Francesco Saverio Marzaduri
“L’ultima luna
la vide solo un bimbo appena nato,
aveva occhi tondi e neri e fondi
e non piangeva
con grandi ali prese la luna tra le mani, tra le mani
e volò via e volò via
era l’uomo di domani
e volò via e volò via
era l’uomo di domani…”
LUCIO DALLA, L’ultima luna
Il recente, fin troppo tardivo restauro di “Break Up – L’uomo dei palloni”, ad opera della Cineteca di Bologna, è l’ennesimo segnale di riscoperta, destinato probabilmente anch’esso a sbiadire, verso un cineasta la cui lucida visione d’insieme – la più cosmica e radicale nella produzione italiana – non è stata ripagata con meritata mercede. Un pubblico sempre più borghese e apatico si è mostrato insofferente alla necessaria attenzione con cui Ferreri, servendosi di beffarda giocosità e dissacrazione, andava destrutturando i fattori universali senza cadere nello stereotipo fattosi regola d’arte, nei generi divenuti abitudinario vezzo, nei codici tesi alla facile partecipazione dello spettatore a rischio di conformismo. Al pari di pressoché tutta l’opera del regista-sceneggiatore milanese, “Break Up” giunge semmai come l’aneddotica scheggia di un passato lontano anni luce, filtrata in un presente che pare aver ormai dimenticato, se non disconosciuto, la firma di Ferreri: un presente molto più vicino di quanto non si è disposti a credere al disegno di un autore, mai analizzato a modo e perlopiù sottostimato, la cui scomparsa è avvenuta in punta di piedi un po’ come succedeva al Benito di “Diario di un vizio”, suo penultimo lavoro. E quasi col medesimo stile veemente, sulfureo, mai eccessivo né esagitato (inclassificabile, in una parola), con cui era solito dissertare di tutto, dalla vita alla morte, dalla politica al cinema.
È il 1967 quando “Break Up” conosce una durata filologica, a seguito di un funesto tourbillon produttivo che lo riduce a striminzito segmento per l’episodico “Oggi, domani e dopodomani”, prima che Ferreri decida di tornarvi sopra, girando nuove sequenze e accludendole allo short, utilizzando nuove musiche, ciak diversi, un’intera sequenza a colori, viraggio in rosa, diversa successione delle scene, diverso doppiaggio, dialoghi aggiunti e un nuovo formato di stampa, meno panoramico. E prima che il progetto di nuovo gli sia tolto di mano, e di nuovo rimaneggiato, convincendo l’autore a rinunciarvi definitivamente. Ugualmente però, anche nella versione di ottantasei minuti presentata lo scorso anno a Venezia, Ferreri offre un riconoscibile saggio della propria politique: l’onirismo felliniano, facile ad attendersi dalla presenza-feticcio dell’industriale Mastroianni qui alle prese con un interrogativo da leggersi come latente impotenza, sposa la figura dell’iperbole acquisendo proporzioni tragiche che si traducono nel vuoto dell’assurdo. In piena era del boom, l’ossessione di un infelice, che impazzisce non riuscendo a stabilire sino a che punto si possa gonfiare un palloncino senza farlo scoppiare, si fa sconfitta cosmica in cui il maschio, presunto dominatore, ancora e sempre è vittima di sé stesso. E a propria volta, a partire da “Una storia moderna: l’ape regina”, il topos riacquista ineludibile peso, che la successiva produzione dell’autore arricchirà di accenti.
Così pure in “Chiedo asilo”, datato 1979, lo spettatore assiste a un apologo incentrato su di un fragile ed una difficoltà. E arrivando un anno dopo “Ciao maschio”, che termina con la sconfitta nichilista della figura virile indotta a cedere il passo alla femmina creatrice di Vita, rovescia il citato epilogo in chiave inusualmente ottimista. Anche qui, la frapposizione dei sessi e il loro plausibile ribaltamento. Anche qui, come nell’opera precedente, si contempla la prospettiva di diventare padre (di un bambino vero, non più di uno scimpanzé), senza che lo scoglio non rechi difficoltà, tant’è che il personaggio principale è un altro bizzarro, utopico e utopista. Trattasi però di un dichiarato fool, calato in un’era e in un progresso inesorabilmente mutati dal conformismo dilagante, e da quel consumismo che Ferreri condannava ne “La grande abbuffata”: là era una figura femminile, e anche lei una maestra materna, l’unica superstite di un suicidio di massa, che, come abitudine dell’autore, si salvava perché depositaria di un’estrema ancora di rinascita. In “Chiedo asilo” l’equazione non può essere più lancinante: a cominciare dalla professione che esercita, il fool in questione si appropria, in modo asessuato, di ciò che di solito è riconducibile all’emisfero femminile (“Sono la nuova maestra. Sono un uomo. Spero”, si presenta ai bambini), contravvenendo al luogo comune secondo il quale solo le donne possiedono l’attitudine ad occuparsi dell’infanzia. Più volte indossa indumenti o grembiuli da dada, e il secondo giorno che lavora si presenta con un finto pancione, inscenando un’imminente maternità ai bimbi che, più adulti del balocco infantile posto di fronte a loro, sorridendo rifiutano.
Rivedendo la pellicola a distanza di anni, stupisce che la narrazione volutamente disordinata (opera di Ferreri e dell’abituale sceneggiatore di Polański, Gérard Brach), senza alcun rispetto per il canone drammaturgico, serbi oggi più che alla sua uscita un’inalterata freschezza nella tessitura filmica. Chi scrive non fa mistero d’insegnare, per professione, nelle scuole d’infanzia, e dunque di conoscere la struttura a spirale dell’apprendimento infantile: è agli alunni che spetta il compito di far strame della sceneggiatura riempiendo le pareti degli interni con le proprie voci informi e sessualmente indistinguibili, di cui la presa diretta documenta il peso. E nell’emisfero pedagogico documentato da Ferreri, non si fatica ad individuare un caos interno ch’è necessario riverbero, paradossalmente ordinato, della condizione esterna di un Paese all’apparenza tranquillo, e in verità attraversato dalle turbolenze di quegli anni di piombo. Simpatizzante rivoluzionario è il protagonista, il cui passato in più di un’occasione riemerge a mo’ di etichetta: prima ancora che la visita alla fabbrica dove l’educatore accompagna la propria sezione in gita didattico-educativa, si prenda l’irruzione della polizia nell’appartamento della compagna, ove il senso di palpabile tensione è il corrispettivo italiano delle pellicole tedesche del medesimo periodo. Ancora, di lì a poco, l’interrogatorio in questura sulla cui parete troneggia la foto di Che Guevara, che, fattore surreale e suggestivo, si contrappone alla dichiarazione dell’uomo quando afferma di non occuparsi di una politica che non gli interessa più. Il fatto d’insegnare ai bambini, la generazione dei prossimi cittadini (il “nostro futuro”, secondo l’aforisma pedagogico) si pone quale scelta dolorosamente rimasta tra le poche possibili: non è casuale che in tempi di cupezza e morti nelle strade Ferreri risponda utilizzando un corpo comico, quello di Benigni, per antonomasia complemento di un finto ordine, che solo in un ambiente infantile – adibito a reinterpretare in altra modalità un universo difficilmente traducibile – può recuperare l’originaria dimensione della “lotta”. Né è casuale che il suo personaggio rechi lo stesso nome anagrafico, come il personaggio-Benigni – indipendentemente da qualsiasi connotazione (non) attoriale, e a partire dalla collaborazione in sceneggiatura – è chiamato a portare lo scompiglio buffonesco a lui congenito, mai aggressivo e sempre candido, allo scopo di guidare il mondo, nella propria innocente dimensione, accostandosi a una realtà altra. Realtà che, se non autentica, dovrebbe detenere una concezione di verità lontana dall’inquinamento delle contraddizioni, degli egoismi, delle falsità dell’universo adulto.
Parente non troppo lontano dell’autarchismo à la Moretti, Roberto anticipa di un anno lo Svitol di “Maledetti vi amerò”, e tuttavia, pur avendo anch’egli qualche noia con la legge che individua in lui un potenziale sovversivo, se ne distacca perché inquietudini e disillusioni non scalfiscono il suo riservato anticonformismo. Pure, nel corpo e nel volto di Roberto, Ferreri ribadisce la propria visione iconoclasta, deluso dai risultati conseguiti dalla sua generazione, per adattarla a quella più giovane, scegliendo l’insolito itinerario della favola pseudo-documentaristica à la Zavattini (nell’incipit una maestra chiede a una bimbetta perché sia allergica all’asilo) e venandola di sfumature che quasi accantonano la carica apocalittico-pessimista del citato “Ciao maschio” per una possibile conciliazione. Tale ottimismo si può riesumare lasciando la realtà e i suoi squallori (suggellati dalla minacciosa coltre di fumo all’esterno) sulla soglia dell’ingresso scolastico, attraversato il quale ogni finestra sul mondo – come il suo presentarsi ai bimbi da una sagoma di carta sul muro – è da interpretare come magica, addirittura fumettistica (il pupazzo a forma di robot giapponese che si libra nel cielo e riecheggia King Kong). La dimensione favolistica è accentuata dalle vetrate dipinte, ricche di illustrazioni naïf che mostrano un paesaggio marino (e preannunciano l’epilogo), dagli angoli-tana e dagli spazi del plesso, dall’arrivo dei bambini in cassettiera guidati dal tamburello della maestra, dalla fisarmonica che Roberto si porta perennemente appresso con cui intrattiene grandi e piccini. La stessa Bologna, dove il film è per buona parte girato, offre ancora un’aura topografica ludica, lunare e ben lontana da quella cui sarà condannata negli anni a venire.
Il modello pedagogico di Roberto, beninteso, non va confuso con quello ormai abusato de “L’attimo fuggente”, di dieci anni successivo: accesa e innata, la sua vocazione all’insegnamento è da intendersi quale giocosa provocazione, senza rischio di espulsioni, di provvedimenti disciplinari o, nella peggiore delle ipotesi, di accuse pedofile. Sempre attraverso l’ossimoro, lente d’ingrandimento tramite cui Ferreri filtra la realtà, il protagonista reinterpreta i campi d’esperienza, i traguardi di sviluppo per la competenza del fanciullo. Il sovvertimento delle regole entro il contesto ludico-infantile, alla ricerca della loro primigenia essenza, prosegue con l’introduzione di un giovane deficitario in veste di animatore e, in quell’ambito di vita genuinamente animale prima dello svezzamento, dall’ingresso di un asinello nel cortile (“Gli psicologi dicono che il rapporto con l’animale stimola la vita, la vispezza e la scioltezza del bambino”), offerto ai bimbi in alternativa a quella artefatta della televisione. Quel piccolo schermo che diffonde immagini relative agli esperimenti comportamentali, di carattere gestaltico, condotti su una scimmia: ancora una volta, il pattern della scimmia così ricorrente in Ferreri torna per restituire la concezione di modello pedagogico a una forma di concretezza distante da velleitarismi. Non esiste più la finestra cui affacciarsi per osservare gli eventi della natura, in quanto la televisione sostituisce il mondo (l’originale) con una serie infinita di copie standardizzate e destinate a una partecipazione virtuale, e non più tattile, dello spettatore. Così pure la visita didattica alla fabbrica si traduce in una scoperta della realtà che non detiene alcun intento eversivo, contrariamente a quanto pensano il commissario o i genitori dei bambini: trattasi di una scoperta del mondo innocente, non ancora impuro, verso il proprio corrispettivo speculare. E se da una parte ci si ricorda di Monica Vitti e del suo figlioletto, impalati e impotenti di fronte alla fabbrica di fumi gialli, nell’antonioniano “Il deserto rosso”, dall’altra è Ferreri medesimo ad accompagnare il piccolo Pierrot de “L’ultima donna” nell’industria in cui lavora il padre Depardieu.
Ancora, in un lavoro focalizzato prevalentemente sul dualismo linguaggio-immagine, con netta predilezione per il primo aspetto, l’intento pedagogico scelto da Roberto – come acutamente osserva Alberto Scandola – è basato più sullo sguardo che sulla parola, tanto che a inizio film il protagonista s’imbatte in un volume intitolato “Esperimenti sulla percezione visiva”. Nondimeno, la percezione visiva che il piccolo schermo restituisce è priva di suoni, contraddicendo quanto insegna Roberto, e si risolve in un fotogramma muto che gli alunni rifiutano preferendo la realtà di un animale in carne ed ossa di fronte a loro. Come il suono della fisarmonica. Come quel tripudio di aria, neve, luna: luci e colori che l’uomo contempla e rimira come un paese delle meraviglie dove condurre i bambini, contrapposti alla voce simulata (cioè finta) del pupazzo-robot nel mezzo di una periferia simboleggiante il silenzio. La solitudine. Perché Roberto, creatura maschile ferreriana, per sua condizione sociale è condannato a essere solo, e il verbo poetico è un quid che figure bizzarre come lui possiedono accentuando tale condizione. N’è riprova il personaggio del poeta underground Carlo Monni che, seminudo alla maniera di un freak che anticipa Ciprì e Maresco, declama versi della “Beat Generation” solo nella sua stanza (il che, a sua volta, prelude al Bukowski del successivo “Storie di ordinaria follia”).
La finzione in quanto solitudine, la solitudine quale sinonimo di morte. In più passaggi, Roberto è immortalato da solo: nell’esterno del cortile dell’asilo, colmo di neve, il giovane pensa alla fame nel Terzo Mondo nel pieno di un’atmosfera magica, e la sovrimpressione del volto di un bimbo africano si confonde col dipinto sulle pareti della scuola. Ancora, nello stesso ambiente inquadrato di notte, il solitario Roberto fa fronte a quel deserto ascoltando le parole degli alunni incise su un registratore (di nuovo il suono artefatto), mentre rimira le loro fotografie su di un muro e la propria vecchia foto d’infanzia. Come, sempre in solitudine, è ripreso in tutti gli angusti spazi che lo colgono insieme ai pochi amici e alla compagna Isabella, i cui corpi – non esattamente comunicativi – non bastano a riempire la vastità di ambienti che ogni volta paiono sopraffarli, addirittura fagocitarli. E se nel finale, attorniato dalla propria sezione, l’insegnante sceglie di portare la donna a partorire in una sala cinematografica abbandonata (già Ferreri la sapeva lunga, prima del conclusivo “Nitrato d’argento”), ricordare che “Chiedo asilo” non scompone l’aura magica. Come se tutto, partendo dal monito allo spettatore di aver assistito a qualcosa di non completamente reale, dovesse aver luogo alla maniera di un’operazione disney-felliniana. Sovente inquadrato in compagnia di Gianluigi, un bimbetto muto e anoressico che a causa di ciò è chiuso in un istituto, Roberto è insieme a lui in riva al mare, al tramonto. All’improvviso Gianluigi comincia a parlare, mostrando al pedagogo un barattolo di vetro con dentro due rane. Finché Roberto non si avvia con lui in direzione dell’acqua: questo miracolo suggerisce una morte che, immortalata dall’interno del barattolo, somiglia a un’incantata sparizione. Il bimbo simbolizza il candido trapasso: il dolce rumore della vita cui il protagonista si abbandona lasciandoci cullare dal respiro del mare, quasi che la madre e il figlio di “Ciao maschio” scegliessero ora di sacrificarvisi. L’ultimo suono vero impresso dall’immagine ferreriana, cui il vagito fuoricampo del neonato di Isabella funge da contrappunto. La lezione di Roberto è compiuta, la morte si riconcilia inestricabile con la vita. Ecco il senso dell’opera di Ferreri, regista che venne dal futuro.
MICHELANGELO ANTONIONI
RESIDUI FILMICI NELLA TRILOGIA DI MICHELANGELO ANTONIONI
di Stefano Usardi
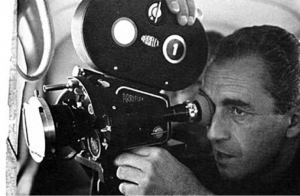 Antonioni ha fatto cinema, ma con il suo cinema ha fatto nuovi spettatori. I film della cosiddetta trilogia Antonioniana rendono esplicita la permanenza di una loro residualità all’interno del fruitore. Ma cosa si intende esattamente per residualità filmica, e come si può valutarne una permanenza? Un appello alla loro indagine era già venuta dal noto fenomenologo francese Mikel Dufrenne che senza possibilità di fraintendimento disse: “se vi interrogate sul cinema, non considerate lo spettatore all’ingresso della sala, consideratelo all’uscita.”[1]
Antonioni ha fatto cinema, ma con il suo cinema ha fatto nuovi spettatori. I film della cosiddetta trilogia Antonioniana rendono esplicita la permanenza di una loro residualità all’interno del fruitore. Ma cosa si intende esattamente per residualità filmica, e come si può valutarne una permanenza? Un appello alla loro indagine era già venuta dal noto fenomenologo francese Mikel Dufrenne che senza possibilità di fraintendimento disse: “se vi interrogate sul cinema, non considerate lo spettatore all’ingresso della sala, consideratelo all’uscita.”[1]
La presenza dello spettatore all’interno dell’atmosfera cinematografica, nella quale l’evento filmico si esplica nella sua massima potenzialità condizionante, ha delle naturali conseguenze anche nella successiva fase di abbandono della sala. Il “passaggio” del film, nella mente-corpo del fruitore lascia delle tracce che si riflettono indelebilmente nel suo approccio al circostante. Nel circolo creativo la realtà davanti a sé, da un lato ha condizionato l’esperienza del fruitore, dall’altro è a sua volta condizionata dal passaggio del film nell’intimità dello stesso. Il film può essere immaginato come una sostanza gassosa che si diffonde nello spazio, l’atmosfera cinematografica, e si insedia all’interno di tutto ciò che trova attorno. Lo spettatore, se si trova ad una giusta distanza, ed è disposto ad accoglierlo, viene avvolto da questo gas che si insedia in lui. Non a caso lo stesso Antonioni parlò di atmosfera dei suoi film.
E’ necessario, però, in questa dinamica creativa, che anche il film faccia la sua parte. Deve evidentemente permettere allo spettatore di poter condividere il momento del film, di partecipare alla sua creazione. Questa funzione è agevolata dalla presenza di un film “aperto”, che accolga le aspettative e proiezioni del fruitore per condividerne la significazione. Nel cinema di Antonioni, come sostiene Aldo Tassone, uno dei suoi massimi studiosi, “lo spettatore verrà messo in una situazione di grande libertà, potrà scegliere lui stesso l’inquadratura, il proprio angolo visuale.”[2] E di conseguenza partecipare al film come meglio crede, o meglio, come la sua esperienza personale e culturale suggerisce. La compartecipazione all’interno dell’atmosfera cinematografica lascia evidentemente dei residui che possono riflettersi sulla percezione del circostante. Lo spettatore deve quindi mettersi a disposizione dell’atmosfera filmica e costruire, in simbiosi con il film stesso, il proprio evento costruttivo, se desidera una residualità che gli permetta una nuova visione del mondo. Non sempre il pubblico è disposto ad accogliere il film, anche nel caso di Antonioni la sua ricezione ha avuto esiti contrastanti, basti pensare all’accoglienza de L’Avventura (1960), come ci ricorda Christian Metz. “Il pubblico di «droghieri» di Cannes che ha fischiato l’Avventura aveva compreso il film, ma non aveva compreso ciò di cui parlava, oppure non gliene importava niente. […] E’ normale che i problemi della coppia, quali li pone Antonioni, lascino gran parte del pubblico indifferente, sconcertato o beffardo.”[3] Metz sostiene che non è obbligatorio che il pubblico capisca il film da un punto di vista contenutistico, che ne condivida l’atmosfera, i droghieri, infatti, avevano capito il linguaggio del film, avevano compreso le immagini, ma non erano riusciti ad entrare nella sua atmosfera perché avevano ancora una cultura e un’esperienza diversa, non pronta. Metz individua tre macro insiemi di significanti del film: 1) il linguaggio cinematografico; 2) L’Avventura (1960) come opera, sia dal punto di vista dell’espressività del contenuto che della tecnica utilizzata; 3) una certa ideologia, che avviene in una determinata situazione storica e socio-culturale e che si riflette nel film, quella che noi identifichiamo con il circolo creativo, in cui ogni momento storico fornisce una diversa “lettura” dell’opera. I droghieri ebbero alcuni problemi con il secondo e terzo insieme.
Rispetto alla novità culturale della trilogia di Antonioni si era espresso anche Umberto Eco, chiedendosi se il pubblico fosse pronto per questi film dai lunghi silenzi e dal “racconto in cui non succede nulla, o succedono cose che non hanno più l’apparenza di un fatto narrato, ma di un fatto accaduto per caso. Pensiamo ai due esempi più illustri di questa nuova maniera, L’Avventura e La Notte di Antonioni (il primo in modo più radicale, il secondo in misura più mediata e con maggiori addentellati con una visione tradizionale).”[4] Il cinema di Antonioni è un cinema del reale, da non confondere con realista, come evidenzia perfettamente Robbe-Grillet “in un film di Hitchcock il significato di quello che vediamo sullo schermo è continuamente rimandato, ma alla fine del film capiamo tutto. In Antonioni succede esattamente il contrario. Vale a dire: l’immagine non ci nasconde mai nulla”, è perfettamente visibile, accoglie lo spettatore e ne permette un’interazione, ma il significato assoluto, la veridicità dei suoi film, è sempre compromesso tra lo spettatore e il film stesso. E’ appunto in questa ulteriore significazione dell’immagine oltre l’immagine che Antonioni, particolarmente con la trilogia, ha dato una nuova possibilità al cinema. E’ evidente, altresì, che allo spettatore, nell’atto di partecipare al film, con tutte le implicazione psico-fisiche che questo implica, rimangono dei residui, consci o meno, che ne condizioneranno la visione sulla realtà circostante.
Il residuo non è il semplice ricordo che può presentarsi nella quotidianità quando si vive un fatto “simile” a quello visto in un film, il residuo filmico è una sorta di interferenza costruttiva che cambia, più o meno radicalmente, la modalità di sguardo sul circostante. Questa azione non è identificabile temporalmente perché è entrata a far parte dello spettatore senza che quest’ultimo avesse la possibilità di scinderla da altre influenze determinanti per la sua esperienza. Anche perché, partecipare ad un film, è innanzitutto fare un’esperienza. “E quando lo spettatore esce, il film è rimasto aperto.”[5]
E’ rimasto aperto in quanto è entrato a far parte dell’immaginario dello spettatore, vive con lui e ne ha cambiato la direzione percettiva. “Pertanto la percezione, nel suo senso più ampio, deve includere la capacità mentale di produrre immagini, ed il suo rapporto con l’osservazione sensoriale diretta.”[6] In questo modo, lo spettatore riproduce dentro di sé le immagini che ha visto scorrere sullo schermo, le rivive una seconda volta e le fa sue. Questa operazione avviene nella tranquillità dell’immersione cinematografica, in cui lo spettatore è disponibile a mettere in discussione le proprie convinzioni, la propria cultura, atto che gli spettatori di Cannes non erano evidentemente pronti a fare.
Come abbiamo suggerito, l’intero circolo creativo, che ha nell’atmosfera cinematografica il principale centro espressivo, in cui l’opera e lo spettatore si con-fondono per una nuova costruttività, oltre alla temporalità del film non permette una delimitazione netta degli elementi che concorrono alla permanenza di una sua residualità. Anche perché “l’immagine del film diviene immagine mentale senza dover passare attraverso il meccanismo razionale e senza che la critica logica, che si dispiega in quel meccanismo, abbia tempo e spazio a sufficienza per esercitare la sua scelta in anticipo, per emettere i suoi divieti ed effettuare i suoi ridimensionamenti.”[7] E’ quello che si rende necessario se lo spettatore desidera compartecipare all’opera e non lasciare che l’evento rimanga sterile e insignificante. L’immediatezza di quest’atto si esplica con una compartecipazione di stimoli, da una parte l’opera, con la sua realtà filmica composta dalla realtà circostante (la parte di mondo fotografato) e simbolizzazione della stessa (l’immagine dietro l’immagine) e dall’altra lo spettatore, con la sua realtà circostante (la sala cinematografica) e il suo potere percettivo esperienziale (attese e proiezioni). Al termine dell’abbandono, soltanto fisico, dell’atmosfera cinematografica, di cui il film rappresenta lo slancio iniziale, lo spettatore rimane con delle tracce, dei residui appunto, di questo incontro.
Il cinema di Antonioni non ha bisogno di battere sul tempo la ragione, la sua narrazione si basa sulla lentezza che non influisce negativamente sulla partecipazione dello spettatore, anzi, è proprio la compromissione intellettiva ad essere il principale stimolo che permette una condivisione del film. Anche Metz ne esalta l’efficacia. “Filmata da un antonioniano, l’attesa di un quarto d’ora non sarà più un tempo morto, perché essa sarà diventata momentaneamente l’argomento stesso del film – che è sempre costruito – , e perché, in quel momento, sarà tutta la vita del film a passare per quel «tempo morto».”[8] E’ interessante notare come questo coinvolgimento, lento e basato sulla ragione, permetta a sua volta di rompere i divieti e le rigidità della mente dello spettatore che proprio passando per la ragione ha la possibilità di emozionarsi e crearsi immagini mentali altamente fantastiche. La forza del cinema di Antonioni si sviluppa senza impedimenti di alcun tipo, da un lato emoziona, basti pensare alle vicende che accadono, dall’altro stimola la ragione con i suoi spazi e le sue aperture narrative. Evidentemente i due ambiti non possono essere tenuti separati, ma si confondono a loro volta con la personalità creativa dello spettatore e ne lasciano una residualità condizionante.
Il cinema di Antonioni è un cinema della profondità, i suoi film sono un “grido” che proviene dal profondo, dal non apparente, dall’immagine nascosta, solo evocata da quella visibile, concreta. I suoi film sono un continuo richiamo per la mente dello spettatore che ha l’opportunità di evocare a sé il proprio immaginario celato dalla superficialità della realtà circostante. Lo spazio visivo/narrativo aperto dei suoi film accoglie e traccia la mente del fruitore, che può condividere con l’opera la propria esperienza e fantasia. “Del resto lo sviluppo derivato dallo stimolo cinematografico avviene anche in profondità, nella mente stessa, che scopre o riscopre territori dimenticati o ignorati, facoltà relegate o lasciate nella semi-incoscienza, destinate ad agire di nascosto.”[9] Non c’è niente di più concreto dell’immagine assente. Quella che lo spettatore mette a disposizione della con-partecipazione filmica, in cui la provenienza, la prevalenza, l’importanza di un’immagine, filmica rispetto ad una immaginaria, perde completamente di rilevanza. E’ la prolifica modalità di sguardo sui film della trilogia di Antonioni. “Si può allora supporre che questa lettura abbia a che fare con due diversi tipi di immagini, quelle che appaiono sullo schermo e quelle che si producono nella mente dello spettatore.”[10]
E’ il procedimento che Jhon Dewey intende per una vera e profonda partecipazione con l’opera. “Per percepire, chi osserva deve infatti creare la sua propria esperienza. E la sua creazione deve includere relazioni comparabili a quelle che provò il produttore originario”.[11] Tralasciando l’aspetto puramente strutturale dell’opera, ben esplicitato da Dewey, che ricorda l’esigenza da parte del fruitore di ripercorrere le tappe creative dell’artista, ci preme compiere una leggera forzatura inerente un altro aspetto fondamentale in quest’atto di percezione estetica. Dal momento che avviene una ri-creazione dell’opera deve rimanere di conseguenza un residuo di quest’operazione tutt’altro che superficiale nel fruitore. Non solo rimarrà ancorata nella sua esperienza, che poi si rifletterà in altre fruizioni all’interno del circolo creativo, ma si insinuerà nella sua rinnovata, appunto attraverso lo slancio creativo, percezione della realtà circostante. Dewey è ancora più esplicito nel prosieguo del suo stimolante testo quando esprime il concetto fondamentale che memorie anche non coscienti, ma che sono ben incorporate organicamente nella struttura stessa del sé, alimentano e modificano l’osservazione del presente. “Sono il nutrimento che dà corpo a ciò che si vede”[12] e che di conseguenza non potrà mai essere univoco e definito, ma continuamente e vorticosamente modificato in una spirale di ri-creazione soggettiva che rompe con la tradizione millenaria che ha sempre cercato una dicotomia chiara (soggetto-oggetto) che permettesse di giungere ad un significato assiomatico e veritativo.
Dewey torna svariate volte a definire precisamente l’apporto significativo delle esperienze precedenti del fruitore, anzi, ne sottolinea l’imprescindibilità per una comprensione dell’opera che sia svincolata dalla sua mera tecnicità. L’espressività è una sorta di equilibrio tra l’aspetto tecnico e la proiezione simbolica e valoriale del fruitore, questo rapporto non può naturalmente scivolare da un lato o dall’altro, perché da una parte vi sarebbe la mera percezione solipsistica di una persona con il proprio chiuso, e impermeabile, giudizio dello sguardo, dall’altra l’opera autoreferenziale intesa come agglomerato tecnico chiuso in sé. Questa espressività ci obbliga ad uscire dalla nostra abitudine per metterci nuovamente di-fronte al mondo, svincolato dalla sua riduzione legata alla routine, obbliga il fruitore, se interessato alla vita e al cambiamento, a rimettere in gioco la propria comprensione del circostante, sospeso tra il nuovo e il passato, in un continuo rinnovamento senza appiglio strutturale ma in un continuo riscoprire sé e il circostante. E’ conseguenza diretta il fatto che in quest’ottica l’esperienza estetica dona un mondo fatto di opere d’arte vive e continuamente mutevoli, non potendo legarle ad una fissità univoca rimangono indici di nuove visioni e scoperte. Quest’incontro estetico tra sé e l’opera rompe, come abbiamo sottolineato più volte, la dicotomia soggetto-oggetto perché è estetica nella misura in cui organismo e ambiente riescono a cooperare per far emergere un’esperienza estetica “ove entrambi sono così pienamente integrati che ciascuno di loro scompare”.[13] Questo avviene nel nostro caso all’interno dell’atmosfera cinematografica in cui il fruitore e l’opera si incontrano senza limiti e barriere razionali.
L’incontro annullante è di estrema importanza per la comprensione e ricostruzione della realtà soggettiva; in un primo momento il fruitore deve compiere la massima catarsi possibile che lo liberi da interferenze esistenziali legate all’abitudine, alla morale e quant’altro, solo dopo questa fase verrà agevolato all’incontro, a questo punto altamente creativo, con l’opera. In una seconda fase, nel momento dell’addio, perché non ritroverà mai più la stessa opera, si ricompongono quelle strutture simboliche e valoriali che sono “necessarie” per la ri-immersione nella realtà circostante. Ogni piccola esperienza estetica andrà a modificare incisivamente queste strutture. Ed è in questa semplice distorsione delle linee guida sulla visione del mondo, che il fruitore aveva prima di confondersi con l’opera, che si installa l’immaginazione, ovvero la capacità di confrontarsi con l’ambiente famigliare in modo nuovo.
Il cinema della trilogia di Antonioni propone costantemente immagini originali, non tanto per le loro caratteristiche oggettive, sono evidentemente delle immagini prese dalla realtà circostante[14] (realtà filmica), ma quanto per la tipologia di sguardo su di essa, ossia il punto di ripresa. La sua distanza dal neorealismo si può misurare anche in questa sua ricerca di una nuova modalità di sguardo, in cui non si esalti la verosimiglianza dell’immagine, ma se ne esalti il punto di vista. Anche perché “è il carattere artificiale, unico, impressogli dallo stile del pittore e il contesto dell’opera a costruire la sua novità, e questa distanza dalla natura è necessaria perché l’opera venga registrata nella memoria a lungo termine.”[15] Questa originalità, nel suo caso non è di conseguenza ascrivibile agli oggetti in sé, ma soprattutto al nuovo e diverso modo di guardarli, ed è appunto in questa novità di sguardo che lo spettatore ha la possibilità di partecipare, e ricordare, questa con-fusione con l’opera.
Anzi, anche una fruizione cinematografica apparentemente senza coinvolgimento emotivo può lasciare dei residui filmici, particolarmente se riesce a rendere congrua la sua visione sul mondo con quella dello spettatore che si avvicina all’opera. La residualità agisce, ed è efficacie, in svariati ambiti, ha la persuasività di appoggiarsi a forti emozioni, shock, e di lasciare l’impronta, ma al tempo stesso può tranquillamente agire invisibile nella partecipazione agevolata, perché risponde alle attese dello spettatore, e lasciare una residualità meno apparente, ma comunque efficacie.
Si prendano ad esempio le parole di Raymond Bellour. Il critico cinematografico francese ripercorrendo la propria biografia ammette, probabilmente involontariamente, l’esistenza dei residui filmici. Nei ringraziamenti alla sua opera dice: “la prima è stata Alexandre Astruc. Aver visto e amato nella stessa settimana Une vie (Una vita. Il dramma di una sposa, Jean-Luc Godard, 1958) e Vertigo (La donna che visse due volte, Alfred Hitchcock, 1958), dopo aver vissuto, un primo momento con Hiroshima mon amour e i film di Chris Marker, aver avuto la possibilità, subito, di parlarne con lui, a lungo e spesso, è stato davvero determinante per un certo accesso alla fascinazione cinematografica.”[16] Riferendosi al rapporto con Astruc è fondamentale notare che dia anche una definizione temporale nella quale hanno visto il film insieme, dice -nella stessa settimana-, proprio ad indicare che una visione cambia nel tempo, anche dello stesso film, perché lo spettatore non è mai il medesimo durante due proiezione diverse. E rafforza il concetto parlando del suo rapporto filmico con Marker, quando dice -subito-, e di conseguenza ha avuto la possibilità di confrontare la propria residualità nell’istante dell’abbandono dell’atmosfera cinematografica. Può apparire una questione di poca rilevanza, ma è invece una testimonianza autorevole che la residualità filmica esiste, anche se di difficile individuazione, e la sua influenza è tenace e persiste nel tempo.
I residui filmici non sono solamente di difficile individuazione nella loro fase formativa, ma lo sono ancor di più nella loro applicazione pratica, e permanenza, nella mente umana. Se il residuo è formato da una complessità di eventi che interagiscono in modo a-temporale tra di loro, è altrettanto vero che la sua esistenza è testimonianza ancor più complicata da discernere perché si esprime in sintonia con altri elementi utili alla percezione del circostante.
E’ appunto il circolo creativo, in cui le immagini filmiche assumono il valore fondamentale di indici e impulso di realtà. Ed il primo stimolo è venuto, nel caso di un film d’autore, al regista, nel nostro caso ad Antonioni. E’ il suo immaginario che per primo si è espresso attraverso l’esigenza di comunicare un mondo possibile, una simbolizzazione del circostante legittima. “In fondo ogni immagine filmica ha un’origine mentale e questa permane e si prolunga attraverso il dispositivo per riprodursi nella mente dello spettatore, nel tempo della sua fruizione fino a oltrepassarla nella memoria (tornando a vivere nella mente di chi l’ha esperita e magari producendo altre immagini e così via).”[17] L’immagine è a sua volta elemento residuale che si insedia nella mente del fruitore. Il residuo filmico, oltre alla difficoltà di una sua identificazione, si concretizza attraverso svariati fattori. L’immagine, che seppur trasformata, e adattata, nella mente dello spettatore, è facilmente memorizzabile, ripresentandosi continuamente nella decodifica del circostante. Oppure ad esempio un dialogo tra due personaggi che parlano della morte diventa residuo filmico nel momento in cui, a distanza di tempo, uno spettatore, consciamente o meno, utilizzerà nella sua vita quotidiana parti di quel dialogo, solo apparentemente distante durante la fruizione cinematografica. Anche la struttura causale di un film può trasformarsi in residuo, è sufficiente che uno spettatore ammetta la possibilità di eventi semplicemente sceneggiati nell’opera filmica per farsi testimone attivo nella vita quotidiana degli stessi eventi.
Gallese e Guerra, nel loro attualissimo testo, individuano nell’empatia il principale approccio con l’opera che permette una permanenza strutturale e condizionante nello spettatore. Utilizzano il termine di “simulazione incarnata” per definire la trasposizione, soprattutto fisica, che avviene tra il personaggio sullo schermo ed il fruitore nella sala. Sostanzialmente lo spettatore ri-vive, intimamente, con tutte le implicazioni che comporta, le azioni che vede sullo schermo, e di conseguenza ne viene influenzato. Evidentemente l’agire del personaggio è fondamentale per una simulazione incarnata, quindi l’azione, sottolineano, ha una “presa” maggiore sul guardante. Ed è in questo contesto che ammettono l’esistenza di una residualità, e seppur non la citino in questo modo, la definiscono perfettamente. Riferendosi al film “Au hasard Balthazar” (1966) di Robert Bresson, interamente incentrato sulle burrascose vicende di un asino, ammettono che “dopo aver visto il film di Bresson, il modo a cui pensiamo a un animale, le riflessioni e i sentimenti che vi associamo, il nostro modo di rapportarci con un asino in carne e ossa nella vita reale, insomma tutte le nostre possibili relazioni con quel mondo, saranno verosimilmente molto diverse rispetto a prima.”[18]
Il residuo filmico è la permanenza nel tempo di tutte le influenze che la partecipazione al film ha lasciato nello spettatore. Le quali possono essere consce o inconsce e manifestarsi nel tempo involontariamente. Lo spettatore, abbandonato alla fruizione cinematografica, in cui vede il film e contemporaneamente vede se stesso, mette in discussione tutto il proprio patrimonio identitario. In questo dinamismo creativo, a cui la significazione è legata, permangono all’interno del fruitore delle strutture percettive che ne influenzeranno l’esistenza e l’approccio alla realtà circostante. Come abbiamo visto, il circolo creativo cinematografico, richiede la “presenza” dello spettatore, senza la quale l’evento rimarrebbe sterile e insignificante. Al tempo stesso, per una maggiore residualità, il fruitore necessita di un’opera aperta capace di metterne in gioco la personalità e di esaltarne l’esperienza. L’aspetto fondamentale è la permanenza condizionante di questa residualità, che non solo ha cambiato le credenze e l’esperienza del fruitore, ma ne ha cambiato la modalità di partecipare al “reale”. E per agevolare questa residualità Antonioni non poteva certo sapere a-priori quali parti di mondo fotografare, ma doveva a sua volta affidarsi al proprio immaginario e scoprire la più efficace inquadratura di quello spazio in quel preciso momento, perché la realtà non passa ugualmente due volte.
“Ripeto perciò che difficilmente penso prima alle inquadrature me le penso nel momento in cui metto l’occhio alla macchina da presa, nell’ambiente nel quale devo girare la scena.”[19]
[1] . Dufrenne, M [1991], Le spect-acteur du cinéma, in Esthétique et philosophie, 3 voll., Paris, Klincksieck; trad. it in Accornero M., Mazzocut-Mis M. [2008], a cura di, L’esperienza estetica: percorso antologico e critico, Milano, Mimesis, p. 127.
[2] . Tassone, A.[1994], Io e il cinema, io e le donne, in Corriere della Sera, 12 febbraio 1978, in Antonioni, M., Fare un film è per me vivere, (a cura di) Di Carlo C. e Tinazzi G., Venezia, Marsilio, p. 183.
[3] . Metz, C. [1968], Essais sur la signification au cinéma, Paris, Klincksieck; trad. it. Semiologia del cinema, Milano, Garzanti, 1989, p. 109.
[4] . Eco, U. [1962], Opera Aperta, Milano, Bompiani, 2006, p. 200.
[5] . Robbe-Grillet, A. [2002], Antonioni o il cinema del reale, in Di Carlo, C. (a cura di), Il cinema di Michelangelo Antonioni, Milano, Il Castoro, p. 91.
[6] . Arnheim, R [1969], Visual Thinking, Los Angeles, Berkeley; trad. it. Il pensiero visivo, Torino, Einaudi, 1974, p.96.
[7] . Epstein, J. [1974], Alcool e cinéma, in Ecrits sur le cinéma, Paris, Seghers, trad. it. Alcool e cinema, Udine, Il principe costante, 2002, p. 42.
[8] . Metz, C. [1968], Essais sur la signification au cinéma, Paris, Klincksieck; trad. it. Semiologia del cinema, Milano, Garzanti, 1989, p. 254.
[9] . Epstein, J. [1974], Alcool e cinéma, in Ecrits sur le cinéma, Paris, Seghers, trad. it. Alcool e cinema, Udine, Il principe costante, 2002, p. 79.
[10] . Bauer, M. [2015], La “poetica dello spazio” di Michelangelo Antonioni, in Boschi, A. e Di Chiara, F. (a cura di), Michelangelo Antonioni. Prospettive, culture, politiche, spazi, Milano, Il Castoro, p. 229.
[11] . Dewey J. [1989], Art as Experience, pubblicata in, The Later Works, 1925-1953, Carbondale, Southern Illinois University Press; trad. it. Arte come esperienza, Palermo, Aesthetica, 2007, p. 77.
[12] . Ibid. p. 107.
[13] . Ibid. p. 246.
[14] . Antonioni non ha utilizzato per le riprese dei tre film della trilogia nessuna immagine generata con l’utilizzo di computer (CGI). Utilizzando solamente pellicola le immagini che vediamo sono state direttamente impresse dalla luce sulla pellicola, naturale o artificiale che fosse.
[15] . Changeux, J. [1994], Raison et plaisir, Paris, Odile Jacob; trad. it. Ragione e piacere, Milano, Raffaello Cortina, 2005, p. 34.
[16] . Bellour, R. [1995], L’analyse du film, Paris, Calmann-Lévy; trad. it. L’analisi del film, Torino, Kaplan, 2005, p. 36.
[17] . Dalpozzo, C. [2012], Fuori campo, Padova, libreriauniversitaria.it, p. 119.
[18] . Gallese V., Guerra M. [2015], Lo schermo empatico, Milano, Raffaello Cortina, p. 24.
[19] . Bianco e Nero, La malattia dei sentimenti, nn. 2-3, febbraio-marzo, 1961, in Antonioni, M. [1994], Fare un film è per me vivere, (a cura di) Di Carlo C. e Tinazzi G., Venezia, Marsilio, p. 29.
TONINO VALERII
UN ABILE ARTIGIANO DEL CINEMA, SOTTOVALUTATO
di Mario Giunco
Fra gli oltre centottanta protagonisti del western all’italiana, intervistati da Marco Giusti per il suo Dizionario (Milano, Mondadori , 2007) invano si cerca il nome di Tonino Valerii, che pure un posto non marginale ha nella storia del genere. E’ stato tardivamente riscoperto dai giovani, da Quentin Tarantino in particolare e attraverso retrospettive e rassegne in Italia e all’estero. La sua scomparsa, avvenuta il 13 ottobre 2016, non ha avuto il risalto che avrebbe meritato nel mondo dello spettacolo e sui mass media. Proprio in quei giorni era stato pubblicato dall’editore statunitense Mc Farland il volume Tonino Valerii. The Films di Roberto Curti, autore, in precedenza, dell’altra fondamentale monografia Il mio nome è nessuno. Lo spaghetti western secondo Tonino Valerii (Roma, Un mondo a parte, 2008). Secondo Curti, siamo in presenza di “ un corpus di opere, qualitativamente consistente, ma numericamente sparuto: nove film in undici anni, dal 1966 al 1977, quasi tutti di notevole successo popolare. Poi una réntrée dignitosa , ma giocoforza non all’altezza dei lavori passati, a partire dalla metà degli anni ’80, e l’inevitabile approdo televisivo, comune a tanti cineasti della sua generazione: un buen retiro vissuto con stoico professionismo e malcelata irritazione nei confronti del continuo calo di professionalità, della sciatteria elevata a sistema, di un patrimonio di conoscenze sacrificato all’audience”. Proviamo a ripercorrere le principali tappe della sua vita artistica.
Antonio (Tonino) Valerii nasce a Montorio al Vomano (TE) il 20 maggio 1934. Frequenta le scuole superiori a Teramo, appassionandosi al cinema. Conseguita la maturità, si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove si diploma in sceneggiatura e regia con Alessandro Blasetti. Il saggio finale di regia è un adattamento del Diario di Anna Frank, lodato da Blasetti. Nel 1959 entra nella Jolly Film come capo ufficio edizioni. Blasetti lo chiama, nel 1961, a fargli da assistente (non accreditato) in “Io amo, tu ami…” e in “I due nemici” . Nel 1962 è assistente di Camillo Mastrocinque in “I motorizzati” (con Franchi e Ingrassia, Ugo Tognazzi, Walter Chiari) e, nel 1963, aiuto regista (ma regista a pieno titolo) di “Tutto è musica” di e con Domenico Modugno. Insieme a Ernesto Gastaldi, compagno di studi in Accademia, nel 1964 scrive le sceneggiature di due “horror”, “La cripta e l’incubo” e “I lunghi capelli della morta”, portati sullo schermo, rispettivamente, da Camillo Mastrocinque e da Antonio Margheriti. Il suo incontro con Sergio Leone data al 1963, quando riscrive, in base alla sceneggiatura originale smarrita, i dialoghi di “Per un pugno di dollari”, il western che segna un’epoca, non solo nel cinema italiano. Due anni dopo Valerii è aiuto regista di Leone in “Per qualche dollaro in più”.
Ormai l’apprendistato volge al termine. Il debutto nella regia avviene nel 1966 con “Per il gusto di uccidere”. Il protagonista (Craig Hill) è un cinico cacciatore di taglie, che sa leggere solo i numeri stampati sui soldi, un parente prossimo di Clint Eastwood, lo straniero senza nome dei film di Leone. Ma, a differenza di quest’ultimo, non raccoglie le simpatie dello spettatore. E’ un personaggio ambiguo, un eroe – nota Curti –“privo di etica, il quale, nella scena iniziale, lascia che i banditi massacrino un convoglio di soldati, per poter recuperare il maltolto e guadagnarsi la ricompensa. Non si sporca le mani più del necessario”. Già nel suo primo film, Valerii cerca una strada autonoma, rispetto a Leone. “Mi attenevo scrupolosamente – ha detto il regista – all’ABC: master, divisione del master, movimenti di macchina, a che battuta si doveva arrivare per poi tagliare. Non c’erano invenzioni come nei film di Monte Hellman, che sono in apparenza molto disordinati, ma anche molto liberi, sperimentali nell’uso della grammatica cinematografica. ‘Per il gusto di uccidere’ era un film onesto, fatto conoscendo le regole”.
Il soggetto de “I giorni dell’ira” (1967), uno dei film prediletti dall’autore, si ispira alla tradizione del western psicologico. Come Edipo, per diventare uomo il protagonista (Giuliano Gemma) deve uccidere il padre (Lee Van Cleef), o l’individuo che incarna per lui la figura paterna. Il senso di colpa gli farà poi gettar via (non sappiamo se per sempre) la pistola che è servita all’uccisione rituale. “’I giorni dell’ira’ – ha scritto Tullio Kezich – potrebbe anche essere la storia di una corruzione: come un ragazzo povero, che è figlio di una prostituta e pulisce i gabinetti del paese, accetta la lezione di un pistolero alienato per uscire dalla propria condizione. La piccola comunità, che ha confinato il bastardo ai lavori più umili, è composta di gente falsamente rispettabile, un groviglio di vipere. Il pistolero, che per alcuni atteggiamenti simpatici nei confronti del ragazzo, fa prevalere addirittura un rovesciamento finale dei suoi sentimenti, in realtà ha maturato un egoismo assoluto. Il bene è rappresentato da un vecchio ex sceriffo, che riflette la figura paterna ed è a sua volta riflesso in un mendicante cieco: un resto, nella ricostruzione del mito, del personaggio di Tiresia”. Il film, a fine stagione, è secondo nella classifica dei migliori incassi italiani.
Nel 1969 esce “Il prezzo del potere” con Giuliano Gemma, Van Johnson, Fernando Rey e Warren Wenders. Ispirato all’assassinio di Kennedy è un western politico, che ha il merito di affacciare, tra duelli e sangue, qualche ipotesi sulla manipolazione dell’opinione pubblica e sulla violenza dei gruppi di potere, industriali e razzisti, con diversi riferimenti ai giorni nostri. Ucciso il presidente degli Stati Uniti, il vicepresidente esita ad assumerne la carica, perché sa che vi sono documenti compromettenti sul suo conto. Un pistolero vuole smascherare e punire gli assassini del presidente e del proprio padre, mentre un messo del vicepresidente cerca di eliminare i pericolosi documenti. Si confrontano il Sud schiavista e il Nord capitalista, ma la pace nel paese potrà essere assicurata solo da ipocriti compromessi.
 “La ragazza di nome Giulio” (1970), tratto dal romanzo di Milena Milani, rappresenta una “incursione” nel genere erotico, di moda in quegli anni. Silvia Dionisio, Anna Moffo, Gianni Macchia – per il regista “una specie di icona dell’ambiguità” – danno vita a una vicenda dai risvolti freudiani. E’ il ritratto di una giovane ricca, che ha il nome del padre morto e, affidata a una viziosa governante, non riesce ad appagare la propria femminilità. Secondo una critica, apparsa sul “Corriere della Sera”, Valerii conserva la “buccia sensazionale del romanzo della Milani: le mani e l’occhio avido della governante che fruga la bambina, gli scontrosi tentativi di essere donna, i suoi amarissimi incontri con uomini di ogni risma e finalmente, buttato all’aria il matrimonio con un vecchio compagno di scuola troppo dabbene, quel furibondo mutilare un ganimede sconosciuto, che simbolizza l’estrema vendetta contro i maschi”. Il film ebbe noie censorie, ma fu selezionato – insieme a “Il conformista” di Bernardo Bertolucci e “L’urlo” di Tinto Brass – per rappresentare l’Italia al Festival di Berlino del 1970.
“La ragazza di nome Giulio” (1970), tratto dal romanzo di Milena Milani, rappresenta una “incursione” nel genere erotico, di moda in quegli anni. Silvia Dionisio, Anna Moffo, Gianni Macchia – per il regista “una specie di icona dell’ambiguità” – danno vita a una vicenda dai risvolti freudiani. E’ il ritratto di una giovane ricca, che ha il nome del padre morto e, affidata a una viziosa governante, non riesce ad appagare la propria femminilità. Secondo una critica, apparsa sul “Corriere della Sera”, Valerii conserva la “buccia sensazionale del romanzo della Milani: le mani e l’occhio avido della governante che fruga la bambina, gli scontrosi tentativi di essere donna, i suoi amarissimi incontri con uomini di ogni risma e finalmente, buttato all’aria il matrimonio con un vecchio compagno di scuola troppo dabbene, quel furibondo mutilare un ganimede sconosciuto, che simbolizza l’estrema vendetta contro i maschi”. Il film ebbe noie censorie, ma fu selezionato – insieme a “Il conformista” di Bernardo Bertolucci e “L’urlo” di Tinto Brass – per rappresentare l’Italia al Festival di Berlino del 1970.
“Mio caro assassino” (1972), con George Hilton, Salvo Randone, Marilù Tolo, si basa su un meccanismo classico: il rapimento e l’uccisione di una bambina, preludio a una serie di delitti. “Tra i gialli italiani degli anni ’70 – scrive Roberto Curti – è quello più profondamente e implacabilmente morale (non moralistico), proprio come ‘I giorni dell’ira’ e ‘Il prezzo del potere’ erano rari esempi di western etici. L’indagine poliziesca procede di pari passo, grazie alla costruzione a flashback, con la discesa in un habitat familiare pervaso da odi, rancori mai sopiti, tradimenti e serpi in seno. Ma quando i nodi vengono al pettine e l’assassino è smascherato, non v’è catarsi né redenzione, e ciò che rimane è una sensazione di spreco e sconfitta: chi ha ucciso l’ha fatto inutilmente, perché il suo destino era già segnato fin dall’inizio; chi sopravvive non sarà più lo stesso, dopo aver guardato la propria immagine riflessa nello specchio che fornisce la soluzione del mistero, svelata solo nell’ultima inquadratura. Uno specchio a due facce: da un lato la maschera ormai insulsa della normalità, dall’altro l’insostenibile consapevolezza di quanto v’è celato dietro”.
Sempre nel 1972 Valerii ritorna al western con “Una ragione per vivere e una per morire”, con James Coburn, Bud Spencer, Telly Savalas. Nel Nuovo Messico, durante la guerra di secessione, un colonnello nordista, che aveva abbandonato un munitissimo forte nelle mani di uno sparuto gruppo di assedianti (nell’illusorio tentativo di salvare la vita al proprio figlio, tenuto in ostaggio dai sudisti), ha la possibilità di riabilitarsi rioccupando il caposaldo. L’ex ufficiale può contare soltanto sul proprio coraggio e sulla malfida collaborazione di otto pendagli di forca, soprattutto sull’astuzia di uno di questi (Bud Spencer), che prepara la carneficina finale. Il western italiano, dopo aver demolito l’epos, cerca di ricostruirlo, con un prodotto per molti versi originale, che lascia qualche spazio all’ironia e alla malinconia. Fra i riferimenti, un classico: “L’assedio dell’Alcazar” (1940) di Augusto Genina.
Su “Il mio nome è Nessuno” (1973) – il western europeo che ha più incassato – esiste un’ampia aneddotica, soprattutto in merito alla paternità, che Sergio Leone cercava di attribuirsi, anche a scapito dell’evidenza e di molteplici testimonianze. Interpretato da Henry Fonda e Terence Hill, con musiche di Ennio Morricone, il film fu girato integralmente da Valerii, tranne un paio di sequenze, ritenute tra le più deboli, attribuibili al regista romano, che era il produttore. Per dare un’idea delle polemiche, riportiamo alcuni stralci della recensione apparsa su “L’Unità” del 22 dicembre 1973: “C’è da chiedersi perché mai il nome di Sergio Leone appaia in prima linea, a chiare lettere, sulla pubblicità, mentre quello di Tonino Valerii, il regista, lo si legge appena, incastrato sotto il titolo. Evidentemente, per non pensar d’altro, si tratta di un attacco di divismo d’autore, dopo tutto abbastanza ingiustificato, perché, a conti fatti, il film di Valerii si rivela di notevole interesse, comunque nettamente superiore a tutti i film girati da Sergio Leone e dai registi italiani specializzati nel ‘western spaghetti’. Il film di Valerii è forse il primo western ‘all’italiana’ che contesta se stesso e tutta la tradizione del genere, è c’è da rilevare che tutta l’operazione dissacrante è condotta con raro rigore stilistico e soprattutto con i mezzi dell’ironia e della satira”. E ancora: “I protagonisti della storia sono un pistolero imbattibile della vecchia generazione, Jack Beauregard, l’ultima speranza di giustizia nel paese, tallonato dal ‘mucchio selvaggio’ di Sam Peckimpah (che giace in un piccolo cimitero) e Nessuno, l’uomo nuovo, astuto e scanzonato, capace di far entrare e uscire dalla storia l’eroe. Nessuno sarebbe con quelli che ‘leggono’ la storia, mentre Jack con quelli che ‘muoiono’ nella storia. Ma, alla fine, le cose andranno ben diversamente, e possiamo anche cogliere una sottile allusione: gli eroi – secondo la lezione brechtiana del Galilei – sono ormai tramontati non solo nei film, ma anche nella storia, nella vita”. Invece “Il mio nome è Nessuno” per Roberto Curti “non è il migliore western di Valerii. Gli fanno difetto la densità emotiva de ‘I giorni dell’ira’ e il respiro storico di ‘Il prezzo del potere’, ed è penalizzato da una sottotrama pretestuosa. Inoltre, soffre lo stridente contrasto tra il tono elegiaco e le zeppe comiche, in misura ancora maggiore di quanto le sporadiche impennate buffonesche del personaggio di Bud Spencer stonassero all’interno del cupo universo barbarico di ‘Una ragione per vivere e una per morire’”.
“Vai gorilla” (1975), con Fabio Testi, Renzo Palmer, Claudia Marsani, Saverio Marconi, è un poliziesco, ambientato nella periferia romana. Dopo un incidente imprecisato, il protagonista cessa di fare la controfigura per scene acrobatiche ed entra a far parte dei cittadini dell’ordine, facendosi assumere come “gorilla” da un costruttore, che si sente minacciato da una banda di ricattatori. L’unico modo per fronteggiarli è quello di uscire dalla legalità, sotto l’occhio benevolo della polizia. Alla fine il “gorilla” scopre il doppio gioco dei suoi colleghi, il costruttore ritrova la pace del lavoro e la città torna ad essere “civile”.
Segue, nel 1977, “Sahara cross” (1977), con Franco Nero, Michel Constantin, Pamela Villoresi. E’ un film d’azione di ambientazione esotica, con spunti picareschi, alla maniera de “La stangata”. “Fanno parte del gioco anche lo smaccato accumulo di colpi di fortuna – tra gli interpreti, il prestigiatore Tony Binarelli -, i rovesciamenti di fronte e gli azzardi che conducono il protagonista e i soci a dividersi i dollari, sganciati da una multinazionale del petrolio. Il carattere di divertissement è svelato fin dall’inizio, mentre il finale è parodistico, con lo spogliarello accelerato di Franco Nero, che brinda alla fortuna milionaria in mutande e calzini” (Curti). La Steadicam permette a Valerii una evoluzione del piano sequenza dalla sua forma base, sostanzialmente lineare. Viene infatti usato in esterni per costruire uno spazio tridimensionale, da esplorare circolarmente.
Passano otto anni, prima che Valerii torni alla macchina da presa. I progetti non lo soddisfano. Nel 1985 dirige tre episodi di 60’ ciascuno della serie televisiva “Caccia al ladro d’autore”: “Addio Raffaello”,” La foresta che vola”,” Cartografia sacra”, con Giuliano Gemma. “La cosa più tremenda del lavorare in televisione – racconta il regista – è il tempo che ti mettono a disposizione. In questi casi occorre sopperire alla mancanza di tempo con la furbizia, con le invenzioni, dato che bisogna strutturare la storia in modo diverso. Ci vuole un grande mestiere, che non sempre dà i risultati sperati”. Nel 1984 aveva diretto due episodi , di 60’ ciascuno, della serie tv in tredici episodi “Due assi per un turbo”, di produzione italo ungherese, andata in onda nel 1987: “Chi primo arriva” e “L’uomo dal turbante rosso”. Fra gli interpreti: Philippe Leroy, Adolfo Celi, Isabel Russinova, Giulio Scarpati.
Nel 1986 Valerii dirige “Senza scrupoli” con Sandra Wey, Marzio Honorato, Cinzia de Ponti. “E’ una metafora sulla violenza e l’erotismo – dichiara il regista a Ciak – in un contesto sociale aberrante, in cui i rapporti umani sono labili e difficili. Per far capire tutto questo era necessario, da parte mia, raccontare in maniera realistica”. Il film incassa bene e ha un seguito apocrifo, “Senza scrupoli 2” (1991) di Carlo Ausino. Nonostante la presenza della francese Sandra Wey, protagonista di “Histoire d’O- Ritorno a Roissy”, le scene erotiche, grazie a “calligrafiche ellissi” o al ricorso al grottesco, non sono mai eccessive.
Nello stesso 1986 e nel 1987 il regista dirige due film, visibili solo in home video o in tv, perché senza visto di censura: “La sporca insegna del coraggio / Fratelli di sangue” (nato come filiazione di un film di guerra di Ted Kotcheff, “Fratelli nella notte” e interpretato da Bo Svenson e Peter Hooten, già in “Quel maledetto treno blindato” di Enzo G. Castellari) e “Sicilian Connection (Shatterer)”, con la partecipazione di Toshiro Mifune. Entrambi i film – girati negli anni della crisi profonda del cinema italiano, quando i registi trovavano lavoro soprattutto in funzione dei passaggi televisivi – sono coraggiosi e hanno una loro dignità artistica.
Nel 1988 dirige tre puntate e parte della quarta del film per la televisione(trasmesso da Canale 5) “Il ricatto”, con soggetto di Ennio De Concini e Massimo Ranieri, con Massimo Ranieri, Barbara Nascimbene, Fernando Rey, Jacques Perrin, Kim Rossi Stuart, Luca De Filippo, Leo Gullotta, Roberto Herlitzka. L’anno seguente dirige il film per la tv “Due madri”, con soggetto di Ugo Pirro, Massimo Russo, Marta Prandi e dello stesso Valerii, interpretato da Barbara De Rossi (premiata come migliore attrice televisiva dell’anno), Sonia Petrovna, Gianni Garko. Andato in onda su Raiuno, il film ottiene un notevole successo di pubblico ed è considerato il più riuscito fra quelli realizzati per la televisione. Merito del regista, che affronta con misura e pudore, temi fra loro diversi, come l’accoglienza di un minore in una famiglia non sua e il dramma dei “desaparecidos” argentini. Ancora per la tv Valerii dirige “Una prova d’innocenza” con Enrico Montesano, in un inedito ruolo drammatico, Corinne Dacla, Luigi Pistilli. Il film è trasmesso in due puntate su Raidue nel 1991 e registra ascolti notevoli.
“Un bel dì vedremo” (da un idea di Kon Ichikawa, l’indimenticato autore de “L’arpa birmana”), girato in alta definizione nel 1996, è un film rivolto al pubblico giapponese. E’ la storia di un gruppo di anziani ospiti in una casa di riposo, che rappresentano per l’ultima volta Madama Butterfly. Fra gli interpreti la soprano bulgara Raina Kabaivanska, Massimo Girotti, Giuliano Gemma. L’ultimo film diretto da Valerii è “Una vacanza all’inferno” (1997) tratto dal libro inchiesta del giornalista Fabrizio Paladini sulla vicenda di un giovane imprigionato per traffico di droga in un carcere thailandese. Interpretato da Marco Leonardi, F. Murray Abraham, Mirca Viola, Giancarlo Giannini, è stato girato a Manila e nel dismesso penitenziario di massima sicurezza di Frosinone. E’ film di interesse culturale nazionale.
Nel 2007, in veste di attore, Valerii è fra gli interpreti di “All’amore assente” di Andrea Adriatico, con Milena Vukotic, Corso Salani, Eva Robin’s. A Roseto degli Abruzzi ha ideato e diretto, dal 1996 al 2013, la rassegna “Roseto Opera Prima”, dedicata ai migliori esordi nella regia di giovani talenti. Fra i premiati Carmine Amoroso, Ferzan Ozpetek, Danis Tanovic, Francesco Patierno, Vittorio Moroni, Kim Rossi Stuart, Giorgio Diritti, Alessandro Angelini.
Valerii era consapevole che con “Il mio nome è Nessuno” – e con le polemiche susseguenti, che lo avevano provato fisicamente e psicologicamente – era finita un’epoca, “che non è stata solo quella del western all’italiana, ma di tutto il cinema italiano, perché per molto tempo il western è stato il cinema italiano. Non dobbiamo vergognarcene. Per oltre un decennio il western ha assorbito e plasmato energie e idee, forze creative e muscolari: registi, sceneggiatori, operatori, ma anche tecnici, macchinisti, cascatori”. Il regista non era venuto a patti con le esigenze del mercato, della televisione in particolare, che gli dettava i tempi delle riprese. Alla fine aveva dovuto cedere, con dignità – come tanti colleghi, più o meno famosi, in attesa di postuma rivalutazione – al cinema che si consumava in un attimo. Era un cineasta colto, di molte e raffinate lettura. Prediligeva il cinema orientale, specie quello giapponese, di cui era esperto. E’ autore del Manuale dell’aiuto regista (Ed. Gremese, Roma 2008). Tonino Valerii lascia l’immagine di un abile artigiano, scrupoloso nel suo lavoro, aperto al nuovo, estraneo a ogni forma di improvvisazione e superficialità.
INCONTRI
Intervista a Sunny Yu
di Francesco Saverio Marzaduri
In occasione del “Taiwan Week – Asian Film Festival”, tenutosi a Bologna i primi di giugno, abbiamo incontrato e intervistato Sunny Yu, 32 anni, regista-sceneggiatrice di Taiwan, autrice di “Xiao Hai” (“The Kids”), con cui nel 2015 ha esordito nel lungometraggio, e in qualità di attrice per la serie televisiva “Newsroom Tokyo”, dello stesso anno, in cui interpretava se stessa. Dopo essersi laureata in comunicazione di massa, ha lavorato per circa otto anni in diverse produzioni cinematografiche: tra le sue esperienze, di fondamentale importanza è quella di assistente al fianco di Chang Tso-chi.
Basato sulla storia vera di un ragazzo da lei incontrato, la cui moglie non aveva lavoro e lui era costretto a rubare per mantenere la famiglia, “Xiao Hai” è uno spaccato drammatico e fresco, coinvolgente e convincente, sulle opportunità dei giovani e sulle loro sfide, emotive e finanziarie, nell’odierna Taiwan. Al centro è una coppia di adolescenti che diventano genitori mentre sono ancora studenti, precipitati in un mondo di responsabilità più grandi di loro. Wu Chien-Ho interpreta Bao-li, un sedicenne che soccorre Jia-jia, impersonata da Chen-Ling Wen, di cui è innamorato benché piu grande di lui. Presto diventano una coppia e hanno una figlia. Ben presto, stanca della vita complicata di ogni giorno, lei inizia una relazione con un uomo sposato, e quando la madre di Bao-li esaurisce i risparmi della famiglia col gioco d’azzardo, decide di lasciare il compagno. Pur di riaverla, Bao-li compie una rapina a mano armata che fallisce miseramente e si conclude col suo arresto. Se la produzione asiatica è solita adottare un approccio uniforme e sensazionalistico per questo genere di temi, di fatto l’autrice compie un diverso percorso, cercando di capire come un giovane padre possa essere indotto al crimine pur di sostentare la famiglia.
Ogni interprete di “Xiao Hai” è alla sua prima esperienza, e un prezioso contributo creativo è offerto dal compositore Wen Hsu, il cui delicato fraseggio suscita empatia senza essere sentimentale, in particolare grazie alla chitarra acustica di Huang Qin Sheng. Professionali tutti gli altri contributi tecnici, nonostante il modesto budget. La prima mostra internazionale dove il film è stato presentato è il Tokyo International Film Festival, nella sezione “Asian Future Competition”, prima di essere proiettato a Taipei, Stoccolma, Singapore, e in seguito vincere il premio NETPAC all’Hawaii International Film Festival.
Una domanda d’impostazione generale. Come sei arrivata al cinema? Hai compiuto studi particolari, frequentato scuole di regia o si è trattato di una scelta indipendente da questo?
A 16 o 17 anni non avevo ancora un’idea precisa di cinema. Solo iniziando gli studi universitari ho cominciato a leggerne, tra saggi, articoli, monografie, e a scriverne. La mia è stata una passione, più che un’intenzione di lavorare in quel mondo, e tale passione risiedeva principalmente nel comunicare qualcosa, raccontare una storia. Pensavo che il cinema fosse il modo migliore per farlo.
Il tuo modo di filmare il reale è influenzato dalla tradizione tematica neorealista, o a Taiwan questo genere di rappresentazione è una costante?
Ci sono modi differenti nel raccontare le storie, e non necessariamente vere. Secondo me, è importante osservare attentamente le esistenze quotidiane per poi narrarle in un film o attraverso le sceneggiature. Che poi si tratti di una storia vera o meno, non è così importante.
Qual è l’odierna situazione del mercato asiatico, e come si pone nei riguardi dei giovani autori?
In questo momento ci sono esempi di cinema basati sul sociale, benché il mercato cinese tenda a fagocitare quello degli altri paesi asiatici. Film makers cinesi, che detestano girare opere incentrate su problemi sociali o pellicole d’autore, optano per confezioni mainstream, più commerciali e redditizie, o spudoratamente festivaliere. Tuttavia, la televisione pubblica mette a disposizione fondi e risorse per giovani inediti cineasti che intendano uscire da tale logica di mercato: io mi considero di questa categoria. Non c’è solo l’intrattenimento o il cinema per attrarre il pubblico estero, sento di non appartenere all’uno né all’altro. Non m’interessa il cinema di genere, né ho predilezioni per qualche genere in particolare. In questo momento predomina l’intrattenimento, più che l’impegno sociale. Il cinema taiwanese da tempo sta vivendo una forte crisi creativa. Non avevamo prodotti da esportazione, a differenza di Hong Kong, ma adesso anche da noi c’è questa tendenza all’intrattenimento, ed è un aspetto più legato alla sopravvivenza che non alla scelta stilistica. Eppure, non mancano giovani nomi che guardano alla realtà nazionale attraverso opere prive di intellettualismi.
I festival sono importanti per la scoperta e la diffusione del cinema. In Asia quali sono i più importanti? E quant’è mondano il clima che vi si respira?
Direi che il più importante è il Golden Horse, non solo per il cinema taiwanese, ma per tutta la produzione asiatica. Riguardo l’atmosfera, è una cosa di mezzo.
Hai qualche modello di riferimento nel cinema asiatico?
A Taiwan è molto difficile fare un solo nome, ma se proprio ne dovessi dire uno, credo Hou Hsiao-hsien, perché in un certo senso nel mio lavoro ci sono omaggi al suo cinema, quello è il mio punto di riferimento. Dopodiché ho avuto esperienze di regia e in qualità di assistente al fianco di Chang Tso-chi, che mi ha insegnato ad indagare i vari aspetti del reale. Fonti emotive e spunti di partenza me li hanno trasmessi anche prodotti pensati per un pubblico di teenager.
Volevamo sapere se e quali difficoltà hai incontrato durante la lavorazione; in particolare, potresti raccontare del tuo rapporto con maestranze e interpreti?
Trattandosi di un’opera prima, la cosa più importante è la fiducia. Avere rapporti di fiducia con interpreti e maestranze ha consentito i migliori risultati. Nel film il gestore del ristorante, ad esempio, è un mio amico e molti altri della troupe li conosco da tempo, sicché il rapporto di amicizia con loro è stato proficuo per il mio lavoro. Ripeto, essendo il primo lungometraggio, non so ancora bene come potrà essere in avvenire il rapporto con gli interpreti, o l’aspetto inerente il budget. Esiste un sistema tale per cui a Taipei è tutto molto organizzato, si evitano difficoltà con la popolazione e il traffico. Potevo sempre contare sull’esperienza dei miei collaboratori. Si lavorava tra le 14 e le 16 ore al giorno, ero incerta se girare un’altra scena o farla il giorno seguente per non abusare della loro amicizia e guastare i rapporti lavorativi. L’importante per me è non esagerare, non eccedere. Sono state necessarie due settimane di lavorazione, due mesi di post-produzione e un mese e mezzo di pre-produzione. È davvero un film a low budget. È stata più difficile l’esperienza sul set che quella di scrittrice, da sempre il mio sogno.
La struttura a flashback era volutamente presente in sceneggiatura o si è sviluppata in fase di ripresa?
La struttura a flashback collima col presente e col futuro dei personaggi: per me non sono flashback, ma due storie parallele. Erano concepite così già in fase di sceneggiatura. Qualche spettatore ha ammesso di essere rimasto confuso, a causa dell’effetto straniante dovuto al montaggio.
In Italia, una donna alla regia non è caso frequente. A Taiwan, le cineaste hanno le medesime opportunità dei colleghi?
A Taiwan non è molto difficile essere una regista donna, nella società c’è una certa equivalenza tra uomo e donna. Vi sono alcune eccezioni, certo, ma Taiwan è un luogo molto aperto e non ho incontrato grandi difficoltà ad iniziare questo mestiere. Attualmente sto scrivendo una sceneggiatura sul sistema educativo taiwanese: allo studio si riservano molte ore della giornata, senza che vi sia spazio né tempo per rapporti o altre attività personali fuori dalla scuola.
Com’è stata l’accoglienza del pubblico asiatico e internazionale?
Il film è stato presentato in diversi festival del Giappone, di Singapore e degli Stati Uniti. Le storie narrate sono universali, sia nei paesi asiatici sia altrove. In Taipei molti hanno rivisto la loro città. Ho notato, però, che ciò che ha toccato maggiormente il pubblico, in particolare le donne di mezza età, è stata la vicenda e i sentimenti provati dai protagonisti. Invece a Singapore, paese storicamente conservatore, un prete mi ha rimproverata di aver girato alcune situazioni che possono risultare spiazzanti. Da parte mia non c’è alcun intento morale, né sorta di giudizio sulla storia d’amore, sui personaggi e le loro azioni, scaturite da sentimenti veri e da drammi quotidiani.
Quali erano le tue intenzioni?
Speravo di fare un film come questo, era una storia che sentivo profondamente. Per me era molto importante infondere una speranza, una seconda possibilità per chi si trova in una situazione analoga, suscitare nel pubblico una sorta di simpatia-empatia verso i due personaggi. Da una parte le difficoltà sono rappresentate da figure come la madre del protagonista, o altre più ambigue che ruotano intorno a loro, ma dall’altra resta sempre la fiducia in sé stessi, posta come una speranza per il futuro in tanti piccoli gesti. Circa la seconda possibilità, la redenzione, non esiste la seconda chance nella nostra cultura, si vive la quotidianità senza tornare indietro sui propri errori.
Pertanto, se non c’è redenzione la speranza diventa fondamentale nel film, come quell’ultima scena che apre alla speranza in un futuro possibile?
Esatto, è ciò che volevo trasmettere.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
FILMMAKER ALLA RIBALTA:
LAURA BIGGI E LORENZO CARAVELLO
di Paolo Micalizzi
I coniugi Laura Biggi e Lorenzo Caravello sono soci fondatori del Cineclub FEDIC Gruppo Cineamatori delle Apuane da loro costituito nel 1999. La loro passione per il cinema è nata dalla fotografia con la quale si sono cimentati già dagli anni 80. A tal proposito dichiarano: «Fermare nella memoria un istante, un’emozione, un fatto che poi diventerà un ricordo da condividere con le persone più care, con un click appariva come una necessità irrinunciabile. Negli anni successivi gli eventi personali, familiari e culturali, grazie anche all’evoluzione tecnologica cominciano ad essere documentati anche con filmati realizzati con videocamere dotate di videocassette S-VHS-VHS ed infine VHS-C dapprima prese a noleggio e successivamente acquistate». E continuano dicendo: « Amici, parenti o compagni di viaggio erano ormai abituati a finire nel mirino delle apparecchiature foto-video che portavamo sempre con noi nell’immancabile ed ingombrante zaino corredato di tasche per obbiettivi, batterie, pellicole e videocassette. Ironicamente la videocamera e la macchina fotografica (una reflex Olimpus) venivano considerate dagli amici come un prolungamento della persona o un membro della famiglia». Arriva dunque il momento dopo tutte queste esperienze di far nascere il Cineclub. La scuola, essendo Laura Biggi insegnante, è la culla della loro ispirazione per le future attività. «Io, dice Laura, ho usato la videocamera con la stessa naturalezza con cui molte colleghe usano matita e penna per delineare percorsi educativi e didattici. Ed avere dei figli in età scolare ha favorito l’avvicinamento anche di Lorenzo al rapporto tra la scuola e il video». Cosa filmare? L’attenzione si rivolge subito all’ambiente, alle tradizioni locali, alla loro scoperta, difesa e divulgazione. Nasce cosi nel 2005, dopo alcune esperienze nel mondo della scuola, “La Lizzatura”, documentario sull’antichissimo rapporto tra le cave di marmo bianco e l’uomo.
Da queste prime esperienze scaturiscono altre opere, la maggior parte delle quali sono state realizzate nell’ambito del Concorso Una storia per un Film rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Massa Carrara. Bambini e ragazzi propongono un soggetto, spesso a livello embrionale, che viene sviluppato insieme in classe per poi passare alla stesura della sceneggiatura, all’individuazione delle location e all’assegnazione di ruoli da interpretare. Si sceglie di realizzare il film sulla base dell’idea più originale e significativa. «Spesso, afferma Laura (a Lorenzo soprattutto il compito della realizzazione tecnica), le tematiche hanno riguardato temi sociali e problematiche giovanili di grande impatto emotivo. Ed è attraverso la realizzazione del film che la problematica viene vissuta, drammatizzata, e talvolta assume valore catartico e terapeutico». E, insieme a Lorenzo, dichiara, con soddisfazione, che spesso i ragazzi a distanza di anni dall’esperienza vissuta, in occasione di una premiazione o di una rassegna, li vanno a trovare, con un po’ di nostalgia, dichiarando che fare il film è stato di grande aiuto per la loro crescita culturale. Una sessantina i film realizzati insieme ai giovanissimi studenti (ragazzi in particolare della scuola primaria e secondaria di primo grado, ma il raggio d’azione si è esteso tra i 4 e 17/18 anni). Particolarmente significativi sono per i due autori alcune opere. Del 2007 è “La leggenda del marmo bianco”, una fiaba che narra la nascita del prezioso marmo bianco come frutto di un incantesimo di alcune fate buone per contrastare la malvagità , ed affidato in custodia all’antico popolo apuano. Seguono quattro opere del 2009: “Un albero… un quadro” è incentrato su un’insegnante che durante la lezione d’Arte e Immagine mostra una tela dipinta ed invita gli alunni a riprodurla reinterpretando il soggetto in base alle proprie capacità espressive e alle proprie emozioni dando libero sfogo a creatività ed immaginazione. Una bambina si lascia trasportare dalla fantasia ed approda ad una dimensione onirica in cui fantasia e realtà si incontrano e sovrappongono fino a fondersi l’una nell’altra. La natura si anima, i personaggi, gli alberi, vengono quasi umanizzati, provano emozioni, sentimenti e sono in grado di comunicare tra loro e con il pubblico invitando a riflettere sul senso della vita di ciascuno, sulla libertà d’espressione di cui dovrebbe godere ogni individuo, pur nel rispetto della diversità. Nella stessa location, il bosco del Vignale di Bedizzano, viene girato “La banda del bosco” in cui è narrata una vicenda quasi anacronistica, che attinge ai classici della letteratura per l’infanzia, in cui assistiamo ad una guerra tra bande rivali per il controllo del territorio.
Durante la battaglia, uno dei bambini, Diego, la piccola vedetta, cade dall’albero ferendosi, tutti accorrono in suo soccorso e l’incidente diventa un’occasione di riflessione: non è necessario combattere, il bosco può essere condiviso. Viene cosi stabilito di formare un unico gruppo che tuteli e protegga il luogo tanto amato e conteso. Il film si conclude con una poesia composta dai bambini dedicata al loro prezioso bosco. Sul tema dell’autolesionismo si sviluppa “Ho solo voglia di piangere”. Un problema che si rivela quando dagli zaini di due compagne che si scontrano accidentalmente sulle scale di scuola esce una lametta, che prontamente viene nascosta. Dall’incrocio dei loro sguardi la situazione è chiara: vogliono procurarsi del dolore fisico. Le due ragazze, diventano amiche, si confidano, si sostengono. E superano le proprie problematiche ascoltando i problemi e le confidenze di un amico, conosciuto casualmente, che come loro è alla ricerca dell’amore e delle attenzioni dei genitori. I tre amici, in un finale commovente, si ritroveranno nel giorno dell’amore, S. Valentino, in spiaggia davanti ad un falò a guardare le stelle: i problemi sembrano ormai un lontano ricordo. Un film in cui, da un punto di vista realizzativo, particolare importanza hanno le scene di dialogo-conflitto tra le ragazze e le rispettive madri.
Le problematiche giovanili sono trattate anche nel corto “Black bull” che affronta il difficile percorso di crescita degli adolescenti, che per autoaffermarsi, talvolta fanno branco ed arrivano a gesti di violenza gratuita. Partendo dal ricordo di Caterina, una ragazza ormai adulta che al tavolo di un bar osserva due adolescenti che parlano di dieta e calorie, si snoda il flashback del film “Alla ricerca della perfezione”.
La ragazza confida al suo diario il disagio di vivere in armonia con il suo corpo, vorrebbe essere sempre più magra come pensa sia richiesto dalla società per essere accettata ed apprezzata. Si crea cosi un problema che la porta a rifiutare il cibo trovando sia in famiglia che con gli amici sempre nuove scuse. Diventa allora assente, distante e nervosa e l’ossessione per la perfezione estetica rischia di rovinarle per sempre la vita, e addirittura di perderla. Sarà grazie all’affetto e alla determinazione della madre, oltre alle cure specialistiche dei medici, che ritroverà la gioia di vivere. Nel 2011 nasce “Il segreto del libro” che è incentrato su una bambina che durante una passeggiata ai margini di un bosco trova un vecchio libro. Sfogliandolo trova indicazioni misteriose per entrare in un mondo fantastico. Nell’impresa coinvolge i fratelli minori ed ha inizio cosi una vicenda dai toni suggestivi intrisa di fantasia, desiderio di ricerca di sé e di esplorazione del mondo circostante. Entra quindi in scena la madre che attraverso l’affannosa ricerca dei figli scomparsi ritroverà una parte forse dimenticata di sé: riscoprirà insieme alle persone care, ed in particolare del fratello, la fantasia, la volontà, la determinazione che spesso aiutano a superare difficoltà che possono apparire insormontabili. Una favola moderna che invita ad inneggiare alla rivalutazione dei valori e al continuo viaggio introspettivo indipendentemente dall’età. Prolifica è anche l’attività nel 2012: 3 film e 3 spot. In “Una biblioteca da salvare” troviamo dei bambini e dei genitori impegnati, su diversi fronti, a difendere il proprio diritto di avere uno spazio culturale adeguato. In “Alice e gli altri” sono al centro della storia le difficoltà di relazione degli adolescenti, spesso proiettati verso l’affermazione ed il successo personale, in bilico tra le aspettative familiari e scolastiche. Sarà soprattutto attraverso la musica che, Alice, la protagonista troverà se stessa ed un sereno rapporto con gli altri.
Il tesoro nascosto, musicato dal giovane compositore Marco Segnan, vede come protagonista un gruppo di ragazzini impegnato nella ricerca di un tesoro segreto.
Gli spot riguardano “La partita difficile” sul tema della dislessia visto dagli occhi di un bambino e “Telefono azzurro” in cui bambini e bambine prestano la voce, il volto e le mani per esprimere la gioia di chi ha una famiglia serena e la tristezza di chi non ce l’ha. Un altro spot( è del 2014) riguarda la sensibilizzazione alla donazione del sangue: è stato realizzato in collaborazione con l’AVIS. Un altro aspetto dell’attività di Laura Biggi e Lorenzo Caravello è la realizzazione di Videopoesie. Autrici sono alcune alunne. “Separazione” (2008) è una lirica semplice ma intensa scritta da una bambina di 9 anni, che anche l’interpreta, che vive un forzato distacco dalla madre. «Pioggia d’inverno» (2013) l’ha scritta invece una bambina di circa 12 anni in cui la sofferenza e le lacrime dovute ad un trauma indefinito sono paragonate alla pioggia. Una ragazzina di 12 anni è poi l’autrice di “Pelle tossica” (2016) che riflettendo sul tema delle dipendenze si cala nei panni di chi vive questo dramma a livello personale e sociale. Un altro film da sottolineare è “Il sentiero della bolla d’ombra” realizzato nel 2015. Protagonisti due cugini in vacanza a casa del nonno che abita in un piccolo paese. Da un incontro- scontro con lui, personaggio singolare, scaturisce un percorso di ricerca che li porterà a confrontarsi con gli altri e con se stessi, affrontare prove di abilità e coraggio tipiche di un’età in cui coesistono magie e timori infantili e progetti per il futuro. All’attivo di Laura Biggi è da sottolineare poi il ruolo di Responsabile nazionale FEDIC Scuola per la quale coordina e divulga progetti di cinema e scuola. Con questo ruolo ha ideato ed organizzato convegni, eventi culturali, proiezioni, tenuto interventi nell’ambito di Festival del cinema nazionali ed internazionali (tra essi, Forum FEDIC alla Mostra di Venezia e Festival UNICA a S. Pietroburgo dove è stato presentato il loro videoclip sull’Inno FEDIC intitolato Il Cine). Collabora poi, in particolare, con il MISFF (Montecatini International Short Film Festival) nel settore MISFF-Edu, occupandosi soprattutto della formazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, attuando (con la preziosa e costante collaborazione di Lorenzo Caravello) laboratori di linguaggio cinematografico. Importanti poi, da questo punto di vista sono i Campus estivi di cinema Naturalmente-Cinema (a carattere nazionale) che si svolge dal 2014 a Fivizzano MS e Eurolandia, la settimana del cinema iniziativa internazionale che ha luogo dal 2015 alla Commissione Europea di Ispra (Varese).
Biofilmografia
Laura Biggi è nata a Carrara nel 1968. Docente di scuola primaria presso la scuola Gentili di Carrara. Socio fondatore del cineclub Gruppo Cineamatori delle Apuane. È docente formatore di didattica del linguaggio cinematografico ed audiovisivo.
Dal 2013 è consigliere FEDIC (Federazione Nazionale Cineclub) con il ruolo di responsabile nazionale FEDIC Scuola per il coordinamento e la divulgazione dei progetti di cinema a scuola . Collabora da anni con il festival internazionale FEDIC MISFF (Montecatini International Short Film Festival) nel settore MISFF-Edu, occupandosi soprattutto della formazione degli studenti,(scuola primaria e secondaria di primo grado) attuando laboratori di linguaggio cinematografico. Ha ideato ed organizzato convegni, eventi culturali, proiezioni, tenuto interventi nell’ambito di Festival del cinema nazionali ed internazionali (Forum FEDIC a Venezia, presenza festival UNICA S.Pietroburgo). Collabora con associazioni culturali ed onlus del territorio (Telefono Azzurro, Cesvot, Anffas, Acca, Dal libro alla solidarietà…). Ha scritto e diretto spot sociali e cortometraggi soprattutto in ambito scolastico. Per FEDIC Scuola organizza i campus estivi di cinema: NaturalmenteCinema (a carattere nazionale a Fivizzano MS) dal 2014 Eurolandia la settimana del cinema (Internazionale–Commissione Europea Ispra-Varese) dal 2015.
Lorenzo Caravello è nato a Palermo nel 1962. È socio fondatore del Cineclub Gruppo Cineamatori delle Apuane che dal 1999 organizza festival, convegni, corsi di formazione, attività di cineforum per adulti e studenti, ma soprattutto laboratori di cinema per bambini e ragazzi. In ambito professionale, sottufficiale della Guardia di Finanza, è responsabile della documentazione video (riprese e montaggio) di eventi ed operazioni di servizio significative per la provincia di Massa Carrara. Ha partecipato al 1° Stage FEDIC di sceneggiatura con docente Franco Ferrini. Ha documentato eventi culturali in collaborazione con enti ed associazioni su tutto il territorio nazionale. Autore di numerosi cortometraggi (circa 50), spot, videoclip e documentari, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti nei maggiori Festival nazionali ed internazionali. Collabora con FEDIC Scuola per i campus estivi di cinema a carattere nazionale ed internazionale: NaturalmenteCinema ( Fivizzano MS) ed Eurolandia ( Commissione Europea sezione italiana di Ispra ).
FILMOGRAFIA BIGGI-CARAVELLO
2017
- VITA DA PINO 9 min.
- CHE NE SANNO I 2000 6 min.
- UNA SCUOLA ENIGMATICA 12 min.
- PUNTIAMO ALLE STELLE 4 min. (videoclip)
- MONTECATINI COLPISCE ANCORA 9 min.
- UTÒPIA 70 23 min. (documentario)
2016
- IL NUOVO ARRIVATO 12 min.
- DAI RAPPA PROF 12 min.
- PELLE TOSSICA (videopoesia) 6 min.
- SOGNI INFRANTI 6 min.
- GAME OVER 5 min.
CAMPUS:
- SELFIE 21 min.
- UN’AVVENTURA MOSTRUOSA sceneggiatura e regia Laura Biggi 11 min.
2015
- UN FUTURO DA GUSTARE 12 min.
- SIAMO DI NUOVO AMICI 9 min.
- IL DONO PIU’ GRANDE 15 min.
- IL SENTIERO DELLA BOLLA D’OMBRA (CAMPUS) 20 min.
- ULISSE Il viaggio 30 min.
2014
- DONNE 13 min.
- UNA STORIA INCREDIBILE (CAMPUS) 20 min.
- MANCAVISOLO TU 9 min.
- ALEX COMPAGNO CAMPIONE 12 min.
- ATTENTI AL LUPO 12 min.
- L’AEREOPLANINO DEI SOGNI 9 min.
- IL CINE (videoclip per Inno FEDIC) 4 min.
2013
- IL MISTERO DELLA 3B, sceneggiatura e regia Laura Biggi 15 min
- LA SCUOLA DEI MOSTRI 15 min.
- DOVE TI PORTA LA VITA 9 min.
- PIOGGIA D’INVERNO (videopoesia) 6 min.
- NON STIAMO ZITTI (videoclip flash-mob) 6 min.
2012
- ALICE E GLI ALTRI 13 min.
- LA PARTITA PIU’ DIFFICILE (spot ) regia Laura Biggi 3 min.
- TELEFONO AZZURRO (spot) regia Laura Biggi 3 min.
- UNA BIBLIOTECA DA SALVARE 15 min.
- IL TESORO NASCOSTO 15 min.
- COSE VERE ( videoclip RAP) 4 min.
2011
- IL SEGRETO DEL LIBRO 18 min.
- L’INIZIO DELLA FINE 13 min.
- SIBILLA 18 min.
- UN PROBLEMA DA RISOLVERE PRESTO 13 min.
2010
- LACRIME IN TASCA 9 min.
- INCONTRO MORTALE 13 min.
- LA MIA LUNA (videoclip) 4 min.
2009
- LA BANDA DEL BOSCO 16 min.
- ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE 12 min.
- UN ALBERO UN QUADRO 9 min.
- HO SOLO VOGLIA DI PIANGERE 13 min.
2008
- BLACK BULL 15 min.
- CHIARE, FRESCHE, MIRACOLOSE ACQUE 10 min.
- SILENZIO 12 min.
- SEPARAZIONE (videopoesia) regia Laura Biggi 6 min.
2007
- INVISIBILE
- LA LEGGENDA DEL MARMO BIANCO 10 min.
- E’ ORA DI CAMBIARE 9 min.
- PICCOLI INVESTIGATORI 15 min.
2006
- IL CAVALIERE SENZA CAVALLO 16 min.
- LA VOCE DEL MARE 13 min.
- SAMPLED 16 min.
2005
- MARCELLO, IL FRATELLO DI DRACULA 12 min.
- LA LIZZATURA (documentario) 20 min.
- IL BUCATO (documentario) 20 min.
2004
- QUANDO NON BASTANO AMULETI E SCONGIURI 15 min.
2000
- QUELLI DELLA 3E ( videoclip) 6 min.
Lavorando in maniera congiunta non è sempre facile attribuire la regia ad un’unica persona, il film è il frutto di uno scambio di energie e suggerimenti operativi e stilistici tra membri dello staff. In genere Laura Biggi ha curato maggiormente le sceneggiature e Lorenzo Caravello ha diretto i lavori.
Nella suddivisione di genere viene indicato VIDEOPOESIA, questa dicitura anomala merita una delucidazione.
In qualità di insegnante. dichiara Laura Biggi, mi capita di raccogliere le necessità comunicative di bambini e ragazzi, ognuno sceglie ed utilizza la modalità che gli è più congeniale, talvolta la lettera (o pagina di diario), più raramente la poesia.
Se il messaggio poetico ha un contenuto significativo e soprattutto di forte impatto emotivo, ha tutto il diritto di essere scelto,ma per ovvie ragioni non può diventare un film. Ecco allora la necessità di cercare, o forse inventare un nuovo genere, un ibrido che vada ad accostare parole recitate ad immagini evocate, ritmi e sonorità. Non è impresa facile bilanciare le varie componenti in un opera armonica ed efficace, spesso il tema musicale è determinante.
- “Separazione” è una lirica semplice ma intensa scritta da una bambina di circa 9 anni che vive un forzato distacco dalla madre. Lei stessa interpreta i propri versi e sceglie immagini simboliche con l’autore Laura Biggi con cui ha un profondo rapporto di affetto e fiducia essendo sua insegnante da anni.
- “Pioggia d’inverno” scritta da un’alunna di circa 12 anni, la sofferenza e le lacrime dovute ad un trauma indefinito sono paragonate alla pioggia. Alcune immagini sono volutamente sfuocate per dare maggior risalto ai versi.
- “Pelle tossica” l’autrice ancora una volta è una ragazzina di circa 12 anni che riflettendo sul tema delle dipendenze si cala nei panni di chi vive questo dramma a livello personale e sociale.
Alcuni dei cortometraggi pluripremiati per il valore sociale del tema trattato come “Black bull” per il tema del bullismo, “Alla ricerca delle perfezione” (disturbi del comportamento alimentare) “Alex compagno campione” (disabilità) sono stati utilizzati nell’ambito di numerosi convegni.
IL GIRO DEI CINECLUB IN 80… CLICK, VIA INTERNET
di Ettore Di Gennaro
Che la FEDIC sia diffusa sul territorio italiano in quasi tutte le regioni, è un dato di fatto. Che nel 2017 sia anche presente sul web, non era altresì scontato.
Ed ecco che sono partito per un viaggio attraverso la penisola e attraverso i Cineclub FEDIC visitando i loro siti web e la loro presenza sui social, alla scoperta della faccia “social” della Federazione.
I siti da me visitati sono 24, tutti censiti nello spazio dedicato ad ogni Cineclub sul sito www.fedic.it.
Il dato che accomuna tutti è la presenza di un 95% di Cineclub con un proprio sito web. Alcuni hanno anche un profilo social su facebook. Il restante 5% ha optato esclusivamente per la sola presenza su facebook sfruttando gli strumenti che questo portale social mette a disposizione.
Il sito web classico, in media, ha un aspetto professionale e curato, sintomo che con questo mezzo intendono informare soci e simpatizzanti con e rendendosi facilmente reperibili e indicizzati su google.
L’ elemento in comune fra tutti i siti web è la presenza, ovviamente, delle informazioni e aggiornamenti sul Cineclub FEDIC stesso.
Molti Cineclub inoltre presentano corsi di formazione o approfondimento, concorsi rivolti al pubblico e una sezione di rassegna stampa locale o nazionale in cui vengono citate le proprie attività.
In alcuni casi addirittura questa rassegna stampa ripercorre storie ventennali con dei picchi in qualche caso giunto ben oltre il cinquantesimo anniversario. Alcuni Cineclub che si occupano ed offrono proiezioni pubbliche le pubblicizzano con dovizia di informazioni e programmi.
Altri si cimentano nel campo delle recensioni su film attualmente al cinema o novità dal mondo vasto della settima arte contemporaneamente a Cineclub di recente fondazione che contemplano nei loro articoli, anche la sempre più emergente realtà della serialità televisiva.
Vi sono infine gallerie di foto, piccoli manuali scaricabili su tecniche cinematografiche o monografie e almeno un caso in cui si offre addirittura una APP per poter ricevere le news del Cineclub.
Il quadro che emerge alla fine di questo viaggio è un panorama in cui i Cineclub FEDIC sono molto attivi e impegnati a promuovere se stessi e le proprie attività di produzione (video, corsi o concorsi), la loro conoscenza e preparazione sul cinema e serialità (recensioni e proiezioni) con strumenti mediamente professionali e aggiornati per raggiungere il maggior numero di visitatori.
Questa pattuglia di siti è il perfetto compagno di viaggio della RETE dei FESTIVAL FEDIC anch’essi presenti sul web, insieme offrono e mostrano il meglio che la FEDIC esprime sui territori e nelle realtà locali.
Se volete visitare i siti che ho esplorato, ecco i link, a voi il piacere della scoperta.
http://www.facebook.com/groups/111549002215429/
http://www.Cineclubpiacenza.it/
http://www.videoclub-brescello.org/
http://www.reggiofilmfestival.com/
http://www.Cineclubromafedic.it/
http://www.Cineclubgenova.net/
http://www.cineamatoriapuani.com/
http://daedalum1.wix.com/daedalum1
http://www.facebook.com/groups/508994599199838/?fref=ts
http://www.videofilmmaker.org/
http://www.club-ilcampanile.it/
http://www.fanofilmfestival.it/
http://www.videoclubpesaro.it/
http://www.prolocosettimomilanese.it/
http://www.cinevideoclubbg.altervista.org/
UN’INIZIATIVA DEL GRUPPO CINEAMATORI DELLE APUANE
UTÒPIA 70: IL PROGETTO
di Lorenza Corsetti e Rosaria Bonotti
Gli anni ‘70 sono stati anni impegnativi per l’Italia e per il mondo intero, in quanto caratterizzati da molti cambiamenti a livello politico e sociale che hanno coinvolto in particolare i giovani, veri protagonisti di questa epoca accesa dalle grandi ideologie del Novecento. Al tempo stesso la storia di quegli anni è stata nel corso del tempo dimenticata, maltrattata, non conosciuta soprattutto dalle nuove generazioni sempre più distanti dalla cosa pubblica. Da queste considerazioni nasce il Progetto “ Utòpia 70: violenza, diritti e partecipazione. Storia e memoria di un decennio mancato”, del Liceo Classico pellegrino Rossi di Massa, partito da un’idea della prof.ssa Rosaria Bonotti , in collaborazione con il Liceo scientifico E. Fermi e l’I.C. Malaspina Staffetti.
Così le scuole massesi si sono ricoperte di immagini, colori, suoni per un viaggio nel passato, nei trascurati anni di piombo, che ha utilizzato tutti i linguaggi, dalla musica, all’arte, dalla letteratura al costume. Un aspetto fondamentale è stato quello del cinema, che , come sua prerogativa, nel tortuoso percorso tra rivolte e lotte per i diritti, affermazione di ideali e violento ideologismo, si è fatto strada offrendo al pubblico una cinepresa sul mondo, talmente veritiera da non tralasciare neanche il più crudo dettaglio ed ha arricchito di emozioni l’intero percorso educativo.
Insieme alle lezioni propedeutiche ed agli incontri seminariali, che hanno visto relatori eccellenti, una tra tutte, l’On. Livia Turco con un intervento sul ruolo delle donne nella conquista dei diritti. Il Cinema è stato una tappa fondamentale del percorso formativo per due aspetti: uno didattico laboratoriale che ha coinvolto la scuola media Malaspina nella realizzazione di due cortometraggi sul tema e un Cineforum. In particolare Lorenzo Caravello e Laura Biggi, che da alcuni anni collaborano con il laboratorio di cinema dell’ I.C. Malaspina, hanno guidato gli alunni nella realizzazione del cortometraggio “Che ne sanno i 2000” dove viene trattato in modo ironico e divertente il tema del confronto generazionale e del documentario “Utòpia 70. Massa e dintorni” nel quale alcuni personaggi di rilievo del panorama cittadino hanno regalato una loro testimonianza degli anni 70 per raccontare tra luci ed ombre vari aspetti del costume, oltre che politici, sociali e culturali di quell’epoca, anche in relazione alle vicende della città.
I due filmati sono stati proiettati nelle manifestazioni conclusive del 27 Aprile a Palazzo Ducale e nel successivo convegno del 28 Aprile a Teatro Guglielmi, con apprezzamento del pubblico presente. Più in generale l’associazione Gruppo Cinematori delle Apuane ha partecipato a tutti i momenti del progetto con un Cineforum che ha visto la proiezione di sette pellicole significative selezionate nella ricca produzione cinematografica di quegli anni: “Ecce Bombo” di Nanni Moretti, “Apocalypse Now” di Francis Ford Coppola, “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Miloš Forman, “Il cacciatore” di Michael Cimino, “Arancia Meccanica” di Stanley Kubrick, “La rabbia giovane” di Terrence Malick e “I cento passi” di Marco Tullio Giordana . Tutte le pellicole sono state presentate e commentate dal professore universitario Carmine Mezzacappa e seguite da un partecipato dibattito dei numerosi studenti in sala. Il progetto ha quindi offerto al pubblico di ogni età una lente di ingrandimento su un decennio variegato ma spesso dimenticato. Non esiste mezzo migliore per mostrare una realtà, passata e presente, al mondo intero potente più di quanto lo sia il cinema. “Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima”, ha affermato il regista Ingmar Bergman.
UTÒPIA 70: IL CINEFORUM
di Carmine Mezzacappa
Per gli insegnanti è sempre motivo di grande soddisfazione quando i loro studenti propongono di redigere il programma di un Cineforum che offra stimolanti riflessioni riguardo a temi di attualità o politica o cultura generale che li appassionano. È quanto ho potuto verificare io con immenso piacere quando ho avuto l’onore di introdurre i film scelti dagli studenti del liceo classico Pellegrino Rossi di Massa dedicati agli anni Settanta.
Due cose, in particolare, mi hanno impressionato molto favorevolmente.
La prima è che gli studenti del Pellegrino Rossi mi hanno dato la conferma di quanto sia ancora importante la visione di un film come azione culturale collettiva condivisa invece della visione individuale davanti al piccolo schermo del televisore o del personal computer. In effetti, qualsiasi forma di narrazione – cinematografica, letteraria, artistica, musicale – ha un senso compiuto se la percezione della realtà da parte di un regista/scrittore/musicista/artista, e la conseguente rappresentazione in forma creativa, diventa un veicolo di identificazione, prima, e riflessione, dopo, da parte del pubblico. In altre parole, un grande plauso agli studenti che credono ancora alla cultura come momento di condivisione e crescita intellettuale, morale e sociale.
La seconda è che il dibattito dopo ogni proiezione non ha mai seguito un percorso prestabilito e quindi si è evitato il rischio di ingabbiare la spontaneità dei commenti in argomentazioni che avessero una pretesa troppo intellettuale. Ogni film, pur dibattendo argomenti di dimensione universale (vedi la inquietante rappresentazione delle mistificazioni del potere in “Arancia meccanica”, gli orrori dell’imperialismo in “Apocalypse Now”, il disagio giovanile in “La rabbia giovane”, la sofferenza del disadattamento sociale di soggetti psicologicamente fragili in “Qualcuno volò sul nido del cuculo”), ha suscitato negli studenti sensazioni diversissime permettendo a noi insegnanti di cogliere non solo le diverse abilità e attitudini critiche degli studenti (alcuni privilegiavano l’analisi puramente cinematografica, altri si soffermavano sulla tecnica narrativa, altri ancora sul linguaggio, altri ancora su riferimenti a letteratura, filosofia, storia) ma anche la sensibilità individuale di chi, con ammirevole onestà, parlava delle proprie emozioni provate durante la proiezione.
Sta di fatto, in sintesi, che la rassegna “Utòpia 70”, oltre ad evidenziare l’interesse dei giovani per un periodo per loro sia anagraficamente sia culturalmente lontano, ci ha fatto capire che i nostri ragazzi vedono nel cinema – giustamente! – una inesauribile e insostituibile fonte di documentazione per comprendere le dinamiche della società.
Ci sono, infatti, approcci diversi al cinema. Qualcuno lo esamina dal punto di vista dell’industria dell’intrattenimento. Altri lo vedono come fonte di intrattenimento. Altri ancora lo vedono come una preziosa forma di documentazione storica – anche se in forma creativa – di come evolvono i comportamenti e i gusti sia dei registi sia del pubblico.
Complimenti sinceri, dunque, sia agli studenti sia agli insegnanti che hanno organizzato “Utòpia 70”. L’augurio più sincero è che si continui su questo percorso e concludo, se mi è consentito, con un modesto suggerimento di dedicare, in futuro, maggiore spazio anche al cinema italiano che, spesso, critichiamo senza essere del tutto consapevoli dei tesori che ci ha lasciato in eredità dai suoi primi passi fino ad oggi.
Arrivederci a tutti.
FESTIVAL ED EVENTI
 REPORTAGE SU TEMI D’ATTUALITÀ
REPORTAGE SU TEMI D’ATTUALITÀ
A “LE VOCI DELL’INCHIESTA”
DI PORDENONE DEDICATO
AL CINEMA DEL REALE
di Paolo Micalizzi
Ancora un bilancio decisamente positivo per “Le Voci dell’Inchiesta” di Pordenone che nell’edizione 2017, svoltasi dal 5 al 9 aprile, ha registrato, in cinque giorni di proiezioni, oltre seimila spettatori. Un Festival, come afferma Riccardo Costantini che ne è il Direttore artistico, che è capace di dare voce alle diversità, aumentare l’attenzione per l’ambiente e i diritti umani e favorire la comprensione di fenomeni sociali complessi. Un Festival di alta ricaduta sociale, quindi, come testimoniato nei 30 lungometraggi, di cui ben 22 in anteprima nazionale, proposti al pubblico che ha affollato la sala di Cinemazero e agli addetti ai lavori italiani e stranieri, sempre più numerosi, significando così con la loro presenza un interesse in crescendo di un Festival che sempre più s’impone nel panorama italiano ed internazionale dando vitalità al cinema documentario ed in particolare a quello d’inchiesta. Un cinema del reale che ha affrontato diverse tematiche di attualità.
Da “Miranda: The making of a Politician” di Mats Agren su una quattordicenne, Miranda, che s’impegna politicamente nel partito dei democratici svedesi fino ad uscirne per contrasti con la direzione a “The confession” di Ashish Ghadiato(UK) che attraverso un’intervista a Moazzan Beggi, presunto estremista deportato a Guantanamo, ne racconta la sua storia.
La parabola delle lotte politiche extraparlamentari tra il ’67 e il ’77 dei giovani che inseguirono l’idea della rivoluzione tra slanci e sogni ma anche violenza e delitti è raccontata, con materiale documentario di archivio in “Assalto al cielo” di Francesco Munzi. Il tema del lavoro è affrontato in “Merci Patron” di François Ruffin, considerato il Michael Moore francese. Si tratta di un film- manifesto contro la Loi Travail(in corsivo) voluta dal ministro del lavoro Myriam El Khomri. Sul lavoro anche “Mouth of hell” del regista bosniaco Samir Mehanovic incentrato sullo sfruttamento del lavoro minorile attraverso la storia di un bambino di 8 anni costretto a vivere in una miniera di carbone a cielo aperto dell’India.
Tematiche di pressante attualità , come quelle relative alla relazioni israeliano-palestinesi, in “Waiting for Giraffes” di Marco De Stefanis( italiano che produce da tempo in Olanda), un affresco semplice e comunicativo sui rapporti tra i due paesi attraverso la storia del veterinario dell’unico zoo palestinese. Ma anche “Forever Pure” di Maya Zinsthein , film che con la scusa dello sport parla di razzismo, integrazione religiosa e politica internazionale ed anche “Shalom Italia” di Tamar Tal sulla toccante vicenda,raccontata con grazia ed ironia, di tre fratelli ebrei fiorentini, che ritornano cinquant’anni dopo da Israele in Toscana alla ricerca della grotta dove hanno trascorso un lungo periodo di nascondiglio per sfuggire alle persecuzioni razziali. Attenzione del Festival anche alle tematiche ambientali. La tutela della biodiversità, proteggendo la cultura dei semi , è raccontata in “Seed: the untold story” , ma anche in “Food ReLovution” di Thomas Torelli che esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente. Molti altri, ovviamente, i temi trattati in questo Festival ricco di opere.
E’ un genere molto vivo, quello dell’inchiesta filmata, la cui storia è stata tracciata anche da grandi protagonisti del giornalismo italiano televisivo. “Le voci dell’inchiesta” di Pordenone nelle edizioni precedenti l’ha ricordato attraverso le retrospettive dedicate a Sergio Zavoli, Ugo Gregoretti, Gianni Minà, Liliana Cavani. Nella decima edizione ha omaggiato Giuseppe Marrazzo, ovvero Joe Marrazzo come era affettuosamente chiamato nell’ambiente televisivo, un altro grande protagonista di quella mitica Rubrica che era TG2 Dossier L’”uomo col microfono” della nostra memoria televisiva è divenuto soprattutto noto per le numerose inchieste su temi sociali: in particolare, sulla mafia e sulla camorra. Ma viene ricordato anche per altre inchieste e servizi come la documentazione sul terremoto in Friuli nel 1976 a poche ore dalle scosse: fu tra i primi inviati Rai-TV. Partendo dalle sue inchieste, Joe Marrazzo ha scritto diversi libri tra cui il più famoso è “Il camorrista”( pubblicato nel 1984) in cui racconta la vita di Raffaele Cutolo, uno dei boss campani più influenti durante gli anni ’80, da cui fu tratto l’omonimo film dell’esordio cinematografico di Giuseppe Tornatore e del quale Roberto Saviano si ritiene debitore, avendo utilizzato parecchi spunti nella scrittura del suo Gomorra ( Giorgio, mettere in corsivo). Lo hanno ricordato a “Le voci dell’inchiesta”( corsivo) i figli Gianpiero e Piero( oggi Corrispondente Rai da Gerusalemme) e il giornalista Sandro Ruotolo che l’ha sempre avuto come riferimento professionale dichiarando anche che “non era il classico giornalista mediatore ma che con lui la realtà entrava dentro”. Nel corso della serata-omaggio, coordinata dalla giornalista della sede Rai FVG Marinella Chirico vi è stato anche un intervento- video del regista Tornatore e sono stati proiettati alcuni reportage coraggiosi: “Camorra” su Raffaele Cutolo; “Eroina Spa”, indagine sul traffico di droga in Sicilia;
”Sciuscià 80”, interviste in presa diretta a bambini napoletani dai 5 ai 10 anni che girano per la città in motorino vivendo in mezzo alla strada, senza andare a scuola, di piccoli espedienti. Il programma ha anche annoverato “Nero napoletano”(1979), dove Joe Marrazzo intervista Pino Daniele, in un viaggio fra musica e appartenenza alla città natale, riflettendo su temi impegnati come il razzismo. In tema con le inchieste di Joe Marrazzo, la proiezione di “Robinù”, documentario di Michele Santoro con la collaborazione di Maddalena Oliva e Micaela Farrocco sui baby-killer napoletani e sulla guerra che combattono quotidianamente tra i vicoli.
Ad inaugurare “Le Voci dell’inchiesta” è stato il documentario di Antonio Bellia “La corsa de L’Ora” che racconta l’avventura del quotidiano siciliano , con la direzione di Vittorio Nisticò, tra il 1954 e il 1975, una “fabbrica delle notizie” , come testimoniato anche dal giornalista Marcello Sorgi, oggi noto editorialista de “La Stampa”, che in quel giornale iniziò a 18 anni la sua carriera.
Alla decima edizione del Festival si deve anche la pubblicazione del volume “Breve ma veridica storia del documentario: dal cinema del reale alla nonfiction”, pubblicato insieme alle edizioni Falsopiano, di Adriano Aprà che raccoglie una serie di saggi da lui scritti in varie occasioni e consente di riflettere sulla situazione attuale del “cinema del reale”.
 ”CINEMAMBIENTE” DI TORINO:
”CINEMAMBIENTE” DI TORINO:
TEMI D’IMPORTANZA SOCIALE
E CIVILE NEL MONDO CONTEMPORANEO
di Paolo Micalizzi
Nei sei giorni di “Cinemambiente” 2017, svoltasi a Torino dal 31 maggio al 5 giugno, oltre un centinaio i film proiettati. Non solo film nella nuova formula “Cinemambiente”, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Capizzi che da vent’anni lo dirige con passione e competenza, ma anche approfondimenti e dibattiti su temi ambientali di cruciale importanza per l’intera società civile. Temi emersi anche dalla proiezione delle opere che hanno registrato una grande affluenza di pubblico, in significativo aumento secondo le informazioni dell’organizzazione.Miglior documentario internazionale è risultato un film cinese, “Plastic China” di Jiu-liang Wang con protagonista una bambina di undici anni che lavora a fianco del padre in un laboratorio di riciclaggio della plastica. Mentre il suo sogno sarebbe quello di frequentare la scuola. Attraverso lo sguardo e i gesti ripetitivi di coloro che maneggiano quotidianamente i rifiuti plastici provenienti da tutto il mondo, si delinea nel documentario un’analisi sui consumi e la cultura nati dalla globalizzazione. Nel contempo viene data voce a una comunità di lavoratori pressoché invisibile ,immersa nella spazzatura e lontana dai riflettori televisivi. Fatica e povertà ma anche sogni d’istruzione sono gli elementi caratterizzanti del documentario che per la giuria rappresenta “La geografia della plastica, una geografia corporea di diseguaglianze, di paesaggi periferici marginali e di persone marginali”. Concludendo che “raccontare queste storie invisibili è un atto di resistenza fisico e politico”. Il film ha avuto anche la menzione Ambiente e Società della Cooperativa Arcobaleno perché, sottolinea tra l’altro la motivazione, ” Rappresenta una verità cruda di profonda miseria legata ad uno dei temi più urgenti per il pianeta e da noi ben conosciuto, il recupero ed il riciclo dei rifiuti” .
Il tema dei rifiuti plastici è trattato anche in “Ocèan, le Mystère plastique” del francese Vincent Perazio che sottolinea che solo l’1% della plastica che fluttua negli oceani raggiunge le coste o rimane intrappolata nei ghiacciai artici, mentre del restante 99%,stimato intorno a centinaia di migliaia di tonnellate, si sa ancora poco: una sorta di buco nero che lascia intravedere un dramma ecologico perché non essendo la plastica biodegradabile si trasforma in microparticelle tossiche, in gran parte invisibili all’occhio umano dando vita a un nuovo ecosistema: la plastifera. Da qui la necessità di indagare il fenomeno e le sue conseguenze, soprattutto sulla catena alimentare. Come miglior documentario italiano è stato designato ”Dusk Chorus – Based on Fragments of Extinction” di Nika Saravanja e Alessandro D’Emilia perché “L’importanza di un tema vitale raccontato in modo originale permette allo spettatore un’esperienza nuova anche dal punto di vista cinematografico.
Il film dimostra quanto il cinema vissuto in sala può ancora avere una forza nella trasmissione di contenuti ed emozioni”. Il tema è quello dei cambiamenti climatici, della sopraggiunta siccità, della presenza massiccia delle compagnie petrolifere che viene alla luce attraverso un viaggio sonoro nella foresta amazzonica dell’Ecuador. Un’esperienza sensoriale, scientifica e nel contempo poetica che per la prima volta registra il ricchissimo patrimonio sonoro di un ecosistema antico, vero e proprio archivio di milioni di anni di evoluzione sulla Terra. Italiano è anche “Con i piedi per terra” di Andrea Pierdicca, che ha ricevuto una Menzione speciale Legambiente. Il film costituisce un viaggio nelle campagne italiane per scoprire persone che hanno scelto di radicarsi sul territorio per coltivarlo in maniera autonoma, efficace e sostenibile, riportando alla ribalta una cultura di saperi millenari, sbarazzandosi dei metodi agroindustriali di oggi. Raccontato come se fosse una favola, una favola moderna. Secondo la Giuria “Un bell’affresco del nuovo-antico mondo contadino italiano, che spesso è fatto di bizzarri visionari che stanno riscoprendo e valorizzando il suolo come bene comune. Un patrimonio per troppo tempo violentato dalla cementificazione e da un’agricoltura senza scrupoli”. Il pubblico ha premiato “Fragil Equilibrio” dello spagnolo Guillermo Garcia Lopez in cui vi è, attraverso tre storie di vita ambientata in altrettanti continenti, uno sguardo su un’umanità lacerata da contraddizioni profonde e un invito a riflettere sul senso del cammino intrapreso, ripensando alle necessità di relazioni sostenibili tra gli individui stessi e il loro quotidiano.
Coinvolti nei premi anche gli studenti del Corso di Economia dell’ambiente, della Cultura e del Territorio dell’Università di Torino(EACT), che hanno assegnato un riconoscimento a “Source international” realizzato da Advocate Creative, un’opera di 6 minuti incentrata sulla figura del fondatore di Source International, Flaviano, che a Cerro de Pasco (Perù) combatte accanto ai cittadini contro la compagnia mineraria che sta “avvelenando” la città. La Giuria, nella sua motivazione, ha sottolineato che il documentario “ si pone come un messaggio di speranza nei confronti di tutte quelle realtà che stanno ancora lottando per vedere riconosciuti i propri diritti, persone e società diverse, che soffrono spesso lo stesso problema: la preminenza dell’interesse economico sulla salute dell’uomo”. Il Festival, oltre alle Sezioni competitive ne ha presentate altre. In “Panorama Cortometraggi” sono state presentate opere che riguardano, tra l’altro, il mondo animale, la natura, il contrasto industriale, le situazioni d’emergenza ambientale, il mondo del lavoro. Opere di pochi minuti che hanno dato la possibilità di volgere uno sguardo ad altri aspetti relativi all’ambiente che portano a riflettere sulla situazione contemporanea.
Inaugurato con “The age of Consequences” di Jared P.Scott, opera che ci conduce nei retroscena della guerra in Siria, dei disordini sociali scaturiti dalle Primavere arabe, dell’ascesa e del consolidarsi dell’ISIS, si è concluso con “La Vallée des Loups” di Jean-Michel Bertrand a cui è stato conferito dal Festival il Premio “Movies Save the Planet”. Si tratta di un film che costituisce una ricerca personale del regista che ha raggiunto l’obiettivo d’incontrare , dopo tre anni di ricerche, dei lupi selvatici nel loro ambiente naturale. Cogliendo dei momenti privati, ma sollevando anche la questione dei limiti da non valicare.
Tra le iniziative culturali di “Cinemambiente”, da sottolineare la presentazione del progetto artistico “Atlas Bormida”, un’installazione che rappresenta un Archivio dove visioni e documenti, esperienze sonore e racconti s’innescano a vicenda.
La proiezione sulla cupola della Mole Antonelliana, vicina al cinema “Massimo”, di una galleria d’immagini di animali a rischio estinzione , realizzata da grandi fotografi internazionali, ha attirato ogni sera l’attenzione del pubblico consentendo un ulteriore momento di riflessione e monito sulla biodiversità perduta, o che stiamo per perdere.
BILL VIOLA:
RINASCIMENTO ELETTRONICO
di Maurizio Villani
Tra le arti visive, la videoarte è quella che più si avvicina al cinema. Queste due forme espressive hanno in comune il linguaggio di immagini in movimento; si differenziano, invece, per le finalità estetiche che si prefiggono e per la strumentazione video che si avvale oggi di nuove tecnologie (dagli schermi al plasma e LCD alla definizione in 4K). Per queste ragioni il rapporto tra creazione artistica e sviluppo tecnologico è centrale nel processo di sviluppo della videoarte e ripropone in termini rinnovati i contenuti della riflessione che nel 1936 aveva sviluppato Walter Benjamin nel saggio su L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica.
Il termine videoarte pare sia nato tra i produttori di opere pensate per la fruizione televisiva negli anni Sessanta a New York (Nam June Paik, uno dei pionieri del movimento, intitolò una sua personale del 1968 a New York Electronic Art).
Tra i maggiori esponenti della videoarte contemporanea lo statunitense Bill Viola, nato a New York nel 1951, si è da tempo segnalato per un suo particolare approccio a originali stilemi creativi che istituiscono un dialogo tra l’arte antica – in particolare la pittura rinascimentale italiana – e le forme più moderne del linguaggio iconico.
A tal proposito Maria Rosa Sossai scrive nel Catalogo della mostra Bill Viola Reflection (2012) che «l’approfondita conoscenza della tecnologia video unita a una concezione intimamente spirituale dell’arte gli permetterà di sviluppare una ricerca espressiva che ha tracciato i principi di un nuovo umanesimo fondato su un uso etico oltre che estetico dell’immagine elettronica, in cui la tecnica è uno strumento di trasformazione della coscienza individuale».
A questo artista Firenze ha dedicato l’importante mostra intitolata Rinascimento elettronico (Palazzo Strozzi, dal 10 marzo al 23 luglio 2017), documentando la produzione di Viola dalle prime sperimentazioni degli anni settanta fino alle grandi installazioni che arrivano al 2014.
Per la prima volta nella sede fiorentina è stato possibile proporre ai visitatori un confronto diretto delle opere di Viola con quei capolavori di grandi maestri del passato – quali Pontormo, Paolo Uccello, Masolino, Cranach – che sono stati per lui fonte di ispirazione e hanno segnato l’evoluzione del suo linguaggio.
«Esplorando spiritualità, esperienza e percezione – si legge nella Presentazione della mostra – Viola indaga l’umanità: persone, corpi, volti sono i protagonisti delle sue opere, caratterizzate da uno stile poetico e fortemente simbolico in cui l’uomo è chiamato a interagire con forze ed energie della natura come l’acqua e il fuoco, la luce e il buio, il ciclo della vita e quello della rinascita».
Tra le molte opere presenti nella mostra fiorentina ne esaminiamo sommariamente alcune, emblematiche della poetica di Bill Viola e del suo rapporto con l’arte rinascimentale.
In “The Greeting” (“Il saluto”, 1995,10’22”) due donne conversano davanti a edifici industriali. Sono interrotte da una terza che le due salutano, ma che una sola conosce. Vengono fatte le presentazioni. Tutta l’azione è rallentata all’estremo in modo da accentuare la gestualità dei personaggi e da cogliere i particolari più nascosti dei loro atti e dello spazio in cui si trovano, in un’atmosfera fortemente enigmatica. Evidente è l’ispirazione alla Visitazione del Pontormo, a cui il video si rifà con l’utilizzo di attori e di scenografie di tipo cinematografico. La mostra fiorentina consente per la prima volta di fare in confronto diretto tra il video di Viola e la tavola del Pontormo, in cui vediamo l’incontro di Maria ed Elisabetta, entrambe incinte (l’una di Gesù, l’altra del Battista), e di altre due donne. Sono stati soprattutto i colori intensi e quasi dissonanti a impressionare Viola: «Il mio incontro con il quadro è avvenuto in California. Ero andato in una libreria …vedo con la coda dell’occhio un … nuovo testo sul Pontormo. Sulla copertina era riprodotta la Visitazione, mi colpirono i colori. Di quel quadro non sapevo niente, ma non potevo smettere di guardarlo. Ho comprato il libro e l’ho portato a casa. Ma aspettai mesi prima di prenderlo in mano. Alla fine, apro il libro, lo leggo, resto affascinato dalle idee, dai colori di quel pittore. Nasce così l’idea di The Greeting».

Bill Viola, “The Greeting” – Pontormo, Visitazione (1528-1529 circa, Carmignano, Pieve di San Michele Arcangelo)
Altra installazione-video in cui l’immaginario contemporaneo si collega all’ispirazione prodotta da un’opera del passato è “The Path” (“Il sentiero”, 2002, 34’30”, Pannello 2 dei 5 di Going Forth By Day). Assistiamo ad un flusso ininterrotto di persone, tutte diverse e appartenenti alle più svariate età ed estrazioni sociali, che senza una logica apparente attraversano una pineta in una calda giornata d’estate. La processione lungo questo “sentiero della vita” finisce per coinvolgere nel profondo lo spettatore che resta avvinto da un andare e un venire ambigui e misteriosi in uno spazio che congiunge due mondi. Secondo di cinque video di un “ciclo di affreschi digitale” realizzato per il Deutsche Guggenheim Berlin, “The Path” si riferisce alle Storie di Nastagio degli Onesti, di Botticelli, ispirato da una novella di Giovanni Boccaccio.
Una istallazione video di grande impatto emotivo è “Emergence” (“Emersione”, 2002,11’40”). Le immagini iniziali ci presentano un sepolcro in marmo bianco, ricolmo d’acqua, e due donne che assistono ai lati del sacello; spunta dall’acqua la testa poi il corpo, pallidissimo, di un giovane che si solleva a fatica e che cadrebbe se le due donne non lo sostenessero, deponendolo a terra e coprendolo con un telo. È stato osservato che «Viola unisce qui pensiero cristiano e spiritualità orientale in un originale sincretismo». La narrazione congiunge, attraverso simboli iconici, i temi della nascita (l’acqua che rimanda al liquido amniotico) e della morte (il sepolcro).
Questi sono due dei temi più ricorrenti nella produzione di Viola: il fluire dell’acqua rimanda allo scorrere del tempo e ai riti di purificazione di molte religioni; ma, a sua volta, lo scorrere del tempo racchiude in sé la dialettica irrisolta tra passato, presente e futuro, tra le dimensioni della temporalità e dell’eternità, di fronte alle quali si staglia il mistero della morte.
I riferimenti ispiratori del video sono svariati: il più evidente è il rapporto con l’affresco del Cristo in pietà di Masolino da Panicale, ma altre influenze derivano da sarcofagi romani, dalla Pala Baglioni di Raffaello, dalla Pietà Rondanini di Michelangelo, dalla Morte di Marat di David.
Installazione video-audio lunga 34’30”, “The Deluge” (“Il diluvio”, 2002) presenta il progressivo passaggio da una tranquilla giornata d’autunno, in cui molte persone passeggiano o lavorano in uno spazio urbano davanti ad una casa, ad una situazione catastrofica in cui un torrente d’acqua irrompe dalle scale, dalle porte e dalle finestra dell’abitazione travolgendo tutto. Alla fine il diluvio si placa, l’acqua si ritira e il sole torna a risplendere sulle case e sulla strada.
Bill Viola ricorda che a Firenze: «ebbi le mie prime esperienze inconsce di un’arte collegata al corpo, poiché molte delle opere di quel periodo, dalle grandi sculture pubbliche ai dipinti incorporati nelle architetture delle chiese, non sono che una forma di installazione: un’esperienza fisica, spaziale, da consumare interamente».
Nel caso del “Diluvio” la mostra ci propone il collegamento con Diluvio universale e recessione delle acque di Paolo Uccello (1439-1440 circa, Museo di Santa Maria Novella, Chiostro Verde): una delle testimonianze pittoriche più impressionanti del primo Rinascimento per la straordinaria forza espressiva che ancora conserva.
Sono presenti in mostra, tra le altre, due installazioni video recenti, una del 2013 e una del 2014.
La prima è “Uomo alla ricerca dell’immortalità/Donna alla ricerca dell’eternità”: un uomo e una donna anziani, nudi, camminano verso lo spettatore fissandolo negli occhi, poi iniziano a esaminano con lentezza il proprio corpo per trovare segni anticipatori di una morte ineluttabile. Sono dipinti in movimento che rimandano alla tradizione iconografica nordica, rappresentata nella sala espositiva da Adamo / Eva di Cranach.
Del 2014 sono i quattro video della Serie dei “Martiri” (“Martire della Terra, Martire dell’Aria, Martire del Fuoco e Martire dell’Acqua”), figura di uomini pronti a sopportare il dolore e a sacrificare la vita in nome di un ideale superiore.
A conclusione di questa rassegna di opere poniamo una riflessione di Bill Viola, che bene riassume il suo pensiero intorno al tema della centralità dell’immagine nella storia della civiltà umana, pur nel mutare dei linguaggi visivi e delle tecniche comunicative. «Questo è un monitor LCD o uno schermo al plasma. Un secolo fa sarebbe stato un dipinto, in epoca preistorica una scultura fatta di pietra, di fango o di sangue. Anche se è importante tenere conto dei diversi media utilizzati nel corso della storia, secondo me non è questo l’aspetto fondamentale. La cosa fondamentale è l’immagine. E l’immagine è eterna. L’umanità ha sempre creato immagini di se stessa, ma l’importante è l’essenza di quanto viene detto o fatto. Perciò sì, questa è tecnologia avanzata, nuova, ma io sento veramente di essere un pittore. In futuro avremo immagini olografiche tridimensionali e qualche giovane artista – io non potrò vederlo – farà qualcosa di nuovo con quella tecnologia. Per me sarà una prosecuzione di tutto questo – di Van Gogh, di Rembrandt, di Leonardo, della storia insomma. L’immagine è l’eterno DNA, il gene culturale dell’umanità che continua il suo movimento nel tempo».
OCCHIO CRITICO a cura di Marco Incerti Zambelli
FAMIGLIE
di Marco Incerti Zambelli
Quest’ultimo scorcio di stagione ci regala due belle opere che, pur mettendo in scena con stili diversi mondi lontanissimi tra di loro, sono accomunate dalla capacità di meditare con acuta sensibilità sulle dinamiche della famiglia.
Dopo l’intensa opera prima “Salvo”, Fabio Grassadonia ed Antonio Piazza, proseguono con “Sicilian ghost story” nel loro viaggio nelle efferatezze della mafia siciliana, prendendo spunto dall’atroce vicenda dell’adolescente Giuseppe di Matteo, sequestrato per più di due anni, poi ucciso e sciolto nell’acido per vendetta nei confronti del padre, diventato collaboratore di giustizia.
Ispirandosi al racconto “Un cavaliere Bianco” di Marco Mancassola, ne adottano la dimensione sospesa tra realtà e favola, realizzando un’opera di forte impatto emotivo. Protagonista è Luna (interpretata da Julia Jedlikowska, la cui figura è persuasiva nel rappresentare la determinazione assoluta di un’innamorata adolescente), ragazzina con un innato talento per il disegno, che vive con disagio l’atmosfera omertosa e retriva della Sicilia di provincia. Le difficili relazioni famigliari con una madre svizzera, fredda ed anaffettiva ed un padre diabetico e rassegnato, sono compensate dal rapporto con la solare ed esuberante amica del cuore, con la quale scambia notturni dialoghi utilizzando alfabeto Morse e torce elettriche in una sorta di chat line ante litteram.
Ma è soprattutto l’amore adolescenziale per un compagno di classe, provetto fantino, il cui padre è invischiato in trame mafiose, ad illuminare la vita di Luna. La scomparsa del ragazzo, la progressiva consapevolezza del rapimento e della tremenda fine che si prospetta, la immergono in una sorta di favola nera (i racconti dei fratelli Grimm sono fonti di ispirazione per esplicita dichiarazione degli autori), nella quale i piani si confondono. Le inquadrature si riempiono di cavalli e gufi, boschi imponenti e laghi misteriosi si intrecciano con il racconto del dipanarsi della vicenda reale, fantasmatiche presenze fanno da contrappunto alla caparbia determinazione della ragazza fino allo scioglimento finale, di commovente ambiguità.
Gli autori padroneggiano con sicurezza la complessità dei livelli narrativi, scegliendo una unità stilistica sorretta dalla fotografia di Luca Bigazzi, al solito affascinante e raffinata, che illumina armoniosamente i diversi piani, dai tratti quasi documentaristici della prigionia ai poetici, anche se a volte un poco insistiti, paesaggi dei boschi siciliani, in una felice continuità narrativa, sottolineata dal musicale montaggio di Cristiano Travaglioli.
Hirokazu Kore-Eda si conferma uno dei più interessanti autori contemporanei. Le sue esplorazione dei rapporti familiari, ambientate in un realistico Giappone moderno che pure assume una dimensione universale, hanno spesso fatto citare Ozu come nume tutelare, anche se certe asprezze, certi rancori si discostano dalla poetica del grande maestro. “Ritratto di famiglia con tempesta”, ultima opera di Kore-Eda, in cui ritroviamo Hiroshi Abe e Kirin Kiki , magnifici attori già protagonisti del purtroppo inedito in Italia “Still Walking”, racconta di Ryota, uno scrittore che dopo il successo del primo libro è precipitato nella sindrome della pagina bianca. Incapace di progettare il futuro, galleggia in un presente precario, tra le povere (in tutti sensi) collaborazioni con una agenzia investigativa e l’irrefrenabile (e perdente) tentazione al gioco d’azzardo, passione ereditata dall’inaffidabile padre, morto da poco e poco rimpianto. Il suo arrancare ha sbriciolato il matrimonio con la bella moglie, ha incrinato il rapporto con il figlio preadolescente, alienato la relazione con la sorella; solo la madre gli manifesta un ironico affetto, sottolineato dalla preparazione di raffinati manicaretti.
In occasione della visita mensile al figlio, complice un imminente tifone, sarà proprio la madre ad imbastire un improbabile tentativo di riconciliare la famiglia. L’autore coreografa un racconto intimo, giocando su tonalità agrodolci, tristi ma non disperate, una sorta di malinconica e partecipata ballata che racconta di sentimenti trattenuti, scontri rimandati, sguardi sfuggenti, impossibilità non dichiarate. Ed è nel prefinale, in un vero e proprio balletto sotto la pioggia, nella notte di tempesta nel parco, alla ricerca di utopici biglietti della lotteria, che per un attimo la felicità pare essere a portata di mano, per poi svanire nel luminoso sole della mattina seguente.
CANZONI STONATE: “SONG TO SONG”
di Francesco Saverio Marzaduri
Una ragione dovrà esserci se “Song to Song”, nono lungometraggio di Terrence Malick, non ha riscosso larghi consensi al botteghino, benché la presenza di nomi importanti – Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman, Cate Blanchett – potesse far presumere il contrario. Si aggiunga che, come altre volte è capitato (l’ultima proprio di recente con “Knight of Cups”), quest’ultimo lavoro ha ancor più ristretto la cerchia di un cineasta noto per la sua enigmatica invisibilità, la cui dichiarata scelta di relegarsi ai margini del system fa il paio con una cifra stilistica spiazzante – fotogrammi flou ai limiti del patinato, impiego reiterante ed ossessivo di voci off, uso della cinepresa asimmetrico e destabilizzante. Stilemi di un autore ormai focalizzato su un’insistita ricerca del mistico, che non teme più di azzardare con altezze vertiginose o accesi contrasti cromatici, fattori iconografici tesi a disorientare lo spettatore in un intricato dedalo narrativo, scandito da improvvisi passaggi di discorso, diretto e indiretto. Ma ciò che in “The Tree of Life” fungeva da ingresso per un oggetto analiticamente insolito dal punto di vista cinematografico, e nell’ancor meno compreso “To the Wonder” era ribadito quale spiazzante concezione, in “Song to Song” si pone come una meta da raggiungere. Chiusura di un cerchio (e punto di non ritorno) lungo un percorso a tappe biennali che, per un autore così poco prolifico, suggerisce l’idea di una peculiarità calcolata. Se in “To the Wonder” il dilemma della Fede, incarnato in un sacerdote in crisi, si specchiava nella dissoluzione sentimentale di una giovane coppia, laddove in “Knight of Cups” il campo esistenziale si restringeva nei tormenti personali e professionali di uno sceneggiatore, in “Song to Song” l’inquietudine interiore trova nuove manifestazioni nella sfera musicale. Ma nulla cambia, per Malick. L’utopia di un “altro mondo al di fuori di questo” teorizzata dal soldato Witt, si scontra con la desolazione morale di chi, come il produttore discografico Fassbender, immortalato in immagini volutamente pantografate – a mo’ di appropriata copertina per chi non sa rinunciarvi – si serve di sogni e illusioni per sentirsi vivo. Perché tutto risplenda, e un’allegorica palma fiorisca in un’isola contaminata, ci si può solo adeguare, come il paroliere Gosling, a una modesta esistenza da operaio che odora di New Hollywood anni Settanta (la medesima da cui anche il regista de “La rabbia giovane” discende). La frenesia del “nuovo mondo” continentale, che già civilizzava e trasformava i nativi, è un quid troppo prevaricante e divorante per poter godere dei suoi frutti. E le apparizioni di qualche sex symbol dei precedenti decenni, come un declinante Val Kilmer, sono la bolsa effigie di ciò che furono, parodie à la Ozzy Osbourne. Della lezione nordamericana, nazionale e culturale, si può solo preservarne la saggia, livida memoria: chi, espropriato da radici inquinate da showbiz e mercimonio, comprende che lo spettacolo impone costi esorbitanti in termini di esistenza e sentimenti, ricerca nel Verbo degli sciamani del rock il senso di un’inestimabile preziosità (ovvero la normalità). Così, le parole di una segnata Patti Smith delineano una purezza orizzontale che contrasta coi flussi di coscienza di figure sospese in un vuoto verticale vertiginoso, ove la caduta libera è in costante agguato e a farne le spese sono le figure più ingenue, dalla cameriera Portman alla madre di lei, una rediviva Holly Hunter. In “Song to Song” la sottile linea rossa contrassegna l’implosione di un ambiente squallido, per poter risalire a quella superficie di estasi che l’immagine finale, coi due protagonisti fotografati al tramonto in amorosa sublimazione, eleva a un ritrovato Paradiso. Per conseguire il quale, come in una cantica dantesca, lo spettatore attraversa un girone costituito da bolge suadenti e catramate, con tutte le implicazioni tragiche che di quest’ultimo capitolo fanno l’anello mancante per definire l’albero della vita. Ramificazioni che, dell’opera di Malick, costituiscono una dissertazione filosofica, seminale, di non facile comprensione e di ancor meno cristallina empatia. Eppure unica. Eppure controversa.
“LA TENEREZZA” DI GIANNI AMELIO
a cura di Tullio Masoni
Un padre e i figli che non ama. I figli che lo cercano, forse, ma fra equivoci, motivi di interesse, e rancori. Una giovane coppia, una famiglia, con la quale questo padre – l’anziano avvocato convalescente da un attacco cardiaco – sembra trovare intesa per poi ritrovarsi nella tragedia. Napoli: non la solita o solo in parte. Una città nel senso proprio e ampio del termine vissuta attraverso i personaggi, il loro mondo e gli immediati dintorni. Tratto liberamente da un romanzo di Lorenzo Marone: La tentazione di essere felici, e interpretato dai bravi Renato Carpentieri, Greta Scacchi (un suo monologo è da antologia), Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti e Elio Germano, il film intende la tenerezza come sentimento agognato, nascosto e sfuggente; come bisogno, per meglio dire, così vitale e delicato da confondersi, depistare, rispondere nel momento giusto alle persone sbagliate: «C’è la volontà – dice Amelio – di fare i conti con le ansie o con le speranze dei giorni nostri, di respirare l’aria del tempo con tutte le sue contraddizioni e guardare le cose da più punti di vista. C’è una tensione costante, nella vicenda che raccontiamo, dove tutto nasce dal disagio e talvolta dal buio dei sentimenti, la cosa più fragile che abbiamo e che ogni giorno facciamo fatica a esprimere. Se dovessi definirlo in poche parole, direi che è un film dove i sentimenti si perdono e si ritrovano, dove il dolore ci lega più della felicità.»
Una rivisitazione distanziata di Antonioni, dunque? Forse, ma per eredità storica d’artista, non per accademia. E Fellini? C’è un momento, sì, nel quale chi ama “La dolce vita” (e Amelio è fra questi) può avvertirne – con la pioggia e non in pieno sole, in un quartiere della Napoli storica invece che nelle zone residenziali di Cinecittà a Roma – la memoria.
Legato ai personaggi fino a concepire la regia – e il senso di realtà – in loro funzione, Amelio si attiene ne “La tenerezza”, come ha sempre cercato di fare, all’insegnamento dei maestri americani: « La macchina da presa è meglio che non si senta. Più la macchina da presa è discreta e più importanza dà a quello che inquadra.» Così una regia “invisibile” diventa personale, cioè ricca “per necessità”. Nel suo ultimo film Amelio passa dal “realismo” all’astrazione onirica (ricordo l’ospedale, la scenografia di Basili), dall’indiretta ma veritiera percezione di Napoli alla metafora sui confini labili e “fantastici” fra la vita e la morte.
Amelio ha popolato il suo cinema di padri: veri, putativi, sostituiti da fratelli maggiori (come nel “Ladro di bambini”) inventati a loro volta; insomma ha perseguito una continuità, anche autobiografica, nella quale il padre era perso e ritrovato, presente e perfino nemico o figura del vuoto. Da qualche tempo – in particolare dalla “Stella che non c’è” – egli cerca la propria parte femminile e vi si abbandona. Come dimenticare l’anziana madre del “Primo uomo”, il suo naturale, domestico stoicismo? Nella “Tenerezza”, quindi, fa un passo ulteriore: «…mi sdoppio fra Lorenzo ed Elena, sua figlia (Giovanna Mezzogiorno). E’ quella forza in più che le donne posseggono, la capacità di non arrendersi e, se si tratta d’amore, di scalare le montagne.»
Qualcuno ha espresso qualche riserva per l’apparizione in sogno (o no?) di Micaela morta – ma non è il mio caso – altri hanno avvertito come troppo forte il pre-finale, dove Elena abbandona il processo per seguire il padre che poi, con fatica, le prenderà la mano…Dubbi legittimi, credo, che però non tolgono nulla a un film di eccezionale forza e sensibilità. Amelio definisce se stesso, ironicamente, come “il regista che visse due volte”:« Non sai quanti critici me l’anno detto. Hanno avuto bisogno di rivedere un mio film per rivalutarlo. Ci sono stati casi plateali. Canova una volta l’ha anche scritto parlando di “Così ridevano”: Ma cosa ho visto io la prima volta, come ho fatto a non capire!» Già. Il film era stato fischiato a Venezia da un pubblico – quello festivaliero è sovente il più antipatico – che avrebbe voluto incoronare una delle meno interessanti e ripetitive opere di Kusturica: “Gatto nero, gatto bianco”. Anche Mauro Gervasini, come Canova, ha fatto, a proposito di “Così ridevano”, una franca autocritica: onore, dunque, a chi sa ripensare e qualche volta, come ingiungeva Bergman rivolto ai critici, chiedere perdono.
“ASSALTO AL CIELO” di Francesco Munzi
Un film di montaggio, suddiviso in tre movimenti, col quale Munzi – usando materiale di archivio – vuole raccontare i giovani e le lotte politiche della sinistra extraparlamentare fra il 1967 e il 1977. Il “mitico” ’68 (pre e post) con la sua carica di rivolta e di ambizione rivoluzionaria.
E’ vero, come ha sostenuto Silvana Silvestri, che rendere conto nella sintesi di un’ora di dieci anni complessi e animati quanti mai è impossibile, ma credo sia vero altrettanto che l’interpretazione a distanza – pur se animata dalle migliori intenzioni – rischia la superficialità e, quel che è peggio, le facili analogie: erano, i sessantottini, black-block ante litteram? Dalla visione bruta di “Assalto al cielo” si potrebbe sospettarlo.
Con “Saimir”, “Il resto della notte” e “Anime nere”, Munzi ci ha dato opere notevoli, ancorché disperse nella memoria di un pubblico e di una critica poco propensi a rinnovare e ravvivare il senso comune; ma stavolta, credo, il bisogno di oggettività (niente voce di commento) e l’affidarsi esclusivamente a materiali originali (dagli archivi del Movimento operaio e democratico, del Luce, della Cineteca di Bologna o della Fondazione Alberto Grifi) hanno fatto un cattivo servizio – o quantomeno insufficiente – a una rievocazione troppo complicata per fondarsi sul flash e sul frammento “sporco”.
Munzi aveva solo un’ora a disposizione, si dirà, ma io osserverei che oltre a trascurare troppo, al film mancano i necessari punti di forza o gli slanci provocatori. Un’ora non basta, certo, ma forse il regista e i suoi collaboratori avrebbero potuto pensare a più puntate. Qualcosa di simile a ciò che ha fatto, sull’Argentina, la menzionata Silvana Silvestri: un documentario per temi che in Italia, purtroppo, non ha ancora trovato distribuzione.
Il finale è affidato all’intervento di un animatore della famosa festa di Parco Lambro: « Il comunismo – dice questi più o meno – va bene ma è un obiettivo transitorio, temporaneo… occorre andare più in là, molto più in là!…»
A sentirle adesso, quelle parole velleitarie e un po’ pedanti, si è costretti a considerare cosa poi è davvero accaduto: il comunismo liquidato in nome del credo liberista, e diversi di coloro che danzavano al Lambro – neppure pochi – regalati al terrorismo, all’autodistruzione, o a “viaggi politico-ideologici” senza ritorno.
A CASA NOSTRA (E ALTROVE):
“SOLE CUORE AMORE” DI DANIELE VICARI
“A CASA NOSTRA” DI LUCAS BELVAUX
a cura di Paolo Vecchi
Eli tutte le mattine si alza quando è ancora buio, prende l’autobus e la metropolitana per andare da Ostia al bar di Roma, zona Tuscolana, dove lavora per ottocento euro al mese, in nero. Ha quattro figli e un marito che la ama ma è disoccupato. Quando le vengono diagnosticati problemi cardiaci, il medico le prescrive un riposo che non si può permettere perché significherebbe lasciare senza sostentamento la famiglia.
Coerente con la sua idea di un cinema nobilmente attento al sociale, con “Sole cuore amore” Daniele Vicari offre un’immagine precisa e attendibile dell’Italia delle nuove povertà, del lavoro precario o della mancanza del lavoro stesso. E, insieme, dell’abnegazione di chi come la sua protagonista riesce a farvi fronte, senza mai lamentarsi ma con una dignità e una fierezza che la portano, ad esempio, a rischiare il posto per difendere i diritti della giovane collega araba.
Oltre che su questa bella figura di donna, ruolo nel quale Isabella Ragonese ci consegna forse la sua interpretazione più intensa, il regista e sceneggiatore lavora con duttilità sui personaggi di contorno – dal marito che si occupa con affettuosa rassegnazione dei lavori domestici al rapace padrone del bar – cosciente del celebre assunto renoiriano che il tragico nella vita è che tutti hanno le loro ragioni. Funziona meno, nel film, il controcanto di Vale, l’amica d’infanzia di estrazione piccoloborghese, un’artista del gesto soffocata dai sensi di colpa e da una madre invadente, quindi incerta nelle scelte di vita a partire dalla stessa identità sessuale, e non solo perchè le sue performances vengono messe in scena con una stilizzazione non priva di goffaggini.
Anche Pauline si alza presto al mattino. Il suo lavoro di infermiera a domicilio la chiama quotidianamente a confrontarsi con tante persone e situazioni, senza pregiudizi di tipo religioso o razziale. In questa direzione l’ha educata il padre, un operaio comunista e sindacalizzato, ora male in arnese a causa della tossicità dell’ambiente della fabbrica. La donna ha una certa propensione a scegliersi gli uomini sbagliati, dal padre dei suoi due figli, un poco di buono che non le offre nessun appoggio anche nelle emergenze, all’attuale compagno, di giorno simpatico allenatore di calcio giovanile, di notte naziskin xenofobo e violento. Quando il dottor Bertier, medico di famiglia con il quale occasionalmente collabora, le offre di candidarsi a sindaco della cittadina del nord della Francia in cui vive, Pauline dapprima esita, poi accetta. Entra così in contatto con un partito nel quale è abbastanza facile riconoscere il Front National, così come nella sua bionda leader Marine Le Pen, la quale pare non l’abbia presa bene.
“A casa nostra” di Lucas Belvaux affronta in maniera efficace uno dei temi più attuali del panorama politico – sociale europeo e nordamericano: l’attrattiva esercitata su una classe operaia sempre più proletarizzata, o comunque sulle fasce a minor reddito, da parte di forze populiste, sovraniste, in ultima analisi di destra comunque le si voglia definire. E, insieme, la necessità di un’apparente legittimazione democratica per questi stessi movimenti (“sono cambiati i metodi, non gli obiettivi”, sibila in una sequenza del film uno degli adepti), con la presa di distanza dalle loro frange più violente, per tranquillizzare l’elettorato cosiddetto benpensante. Con forme nuove, adattate alle circostanze del momento, ma comunque sempre legate alla medesima matrice storica carsicamente sopravvissuta, come suggerisce la metafora che apre e chiude il film, quelle bombe fatte emergere dal trattore che erpica un campo e che alla fine vengono ammucchiate al suo limitare. Naturalmente il regista belga osserva senza offrire spiegazioni e tantomeno soluzioni, in una dimensione di asciutta commedia drammatica tra i cui protagonisti spiccano il solito, impeccabile André Dussolier, ed Emilie Dequenne, la non più adolescente Rosetta dei Dardenne.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
Sopravvivere ai tempi del colera (finanziario)
“PIIGS – Ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l’Austerity”
di Adriano Cutraro, Federico Greco, Mirko Melchiorre
di Marcello Cella
 In una stanza ci sono cento cani, ma solo novantacinque ossi. Si dirà che i cinque cani che restano senza mangiare dovranno essere più veloci, più scaltri, più competitivi. Ma se ripetiamo l’esperimento, resteranno senza mangiare altri cinque cani. Chi ha deciso quali cani mangiano e quali no? Questo l’interrogativo posto dall’insider finanziario americano Warren Mosler, che aleggia senza risposta apparente per tutto il film dei tre giovani registi italiani. Chi ha deciso che cinque cani resteranno comunque senza mangiare? E cosa c’entra tutto questo con l’economia e la crisi e l’austerity e la disoccupazione e la precarietà lavorativa e il taglio dei servizi sociali? Può sembrare una domanda lunare, ma c’entra moltissimo. Infatti il bel documentario dei tre cineasti cerca di mettere in relazione le problematiche della macroeconomia e le difficoltà crescenti della microeconomia. Ciò che in genere evita di fare l’informazione economica dei quotidiani specializzati, chiaramente indirizzata ad una platea di esperti e di fedeli al dogma economico dominante, e cioè quella particolare forma di capitalismo che si è affermato da pochi decenni, il capitalismo finanziario. Perchè di dogma si tratta, quasi di una religione e i suoi epigoni assumono spesso la veste di sacerdoti fondamentalisti, soprattutto quando affermano decisamente che “non c’è alternativa a questo sistema economico”. Ma, come sappiamo, la mancanza di alternative è sempre un regalo avvelenato di ideologie totalitarie perchè anche l’economia è una creazione umana e, come tutte le creazioni umane, imperfetta e subordinata alla finitezza della sua condizione. Parafrasando Giovanni Falcone, quando affermava che “la mafia è una creazione umana e come tutte le creazioni umane ha avuto un inizio, uno sviluppo e avrà anche una sua fine”, allo stesso modo l’economia vive all’interno di questi limiti oggettivi e di queste contraddizioni, messe bene in luce dal documentario che, lungi dall’essere un noioso pamphlet ideologico, si sviluppa come un’inchiesta tesa, giornalisticamente inattaccabile, ma dotata di un ritmo cinematografico mozzafiato. Si respira fin dall’inizio un’atmosfera inquietante da thriller e non può essere un caso che, proprio all’inizio, dopo le parole di Bush senior che incensano il maggiore ideologo del neoliberismo, Milton Friedman, sulle parole della voce narrante (l’attore Claudio Santamaria), la macchina da presa riprenda dall’alto il sinuoso percorso seguito da un’automobile (quella del protagonista occulto del film?) in corsa su una strada di montagna, proprio come all’inizio di “Shining” di Stanley Kubrick, come a suggerire l’affascinante paragone fra la corsa verso la follia e gli incubi notturni del suo protagonista (Jack Nicholson) con quella attraverso la follia criminale del sistema economico raccontato da “PIIGS”. PIIGS, un acronimo che indica quei Paesi europei appesantiti da un grave debito pubblico, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, e che i tre giovani registi hanno ripreso nel titolo della loro opera, frutto di cinque anni di studi e due di riprese e montaggio. Un documentario che racconta l’economia e i condizionamenti che essa riversa sulla vita quotidiana delle singole persone mettendo in relazione gli autorevoli interventi di economisti, intellettuali e attivisti con le vicende molto più prosaiche della Cooperativa “Il Pungiglione” di Monterotondo, alle porte di Roma, nata nello stesso anno, il 1992, del famigerato Trattato di Maastricht che determinò i criteri di ingresso nell’Unione Europea, a rischio fallimento a causa della mancata riscossione di crediti per centinaia di migliaia di euro da parte degli enti locali, bloccati dal patto di stabilità che ne impedisce il versamento in rispetto di astratti parametri economici che il film si occupa di destrutturare e qualificare per quello che sono, e cioè menzogne ad alto tasso di ideologia senza nemmeno una vaga apparenza di scientificità, prodotte però con un fine ben preciso: smantellare lo stato sociale per come lo abbiamo conosciuto in Occidente nel secondo dopoguerra e tornare ad una sorta di “Ancien Régime” (come lo definisce senza mezzi termini un economista americano nel corso di una conferenza) precapitalista e profondamente classista. Per chiarire questi concetti “PIIGS” non è avaro di esempi e testimonianze. Come quella dello studente americano Thomas Herndon, autore di una clamorosa scoperta, e cioè che nei documenti di Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, con cui l’Unione Europea giustificò le misure di austerity, ci sono dei banalissimi errori di allineamento di fogli e colonnine Excel. O come la vicenda di Guy Abeille che spiega meglio di qualsiasi altra cosa l’origine dell’assurdo parametro del 3%, il famigerato rapporto tra deficit e PIL ripetuto come un mantra da politici ed economisti per giustificare le loro devastanti scelte economiche e sociali, una letterale invenzione a casaccio. Guy Abeille, ex funzionario del ministero delle finanze francese quando all’Eliseo era presidente Mitterand la racconta così: “Il presidente voleva fissare un tetto alla spesa pubblica, cercava uno strumento semplice e per uso interno, nessuna teoria economica. In nemmeno un’oretta mettemmo il deficit in rapporto al PIL e con un’operazione alquanto casuale e legata ai parametri dell’epoca ci risultò il 3%. Fu poi Trichet nel 1992 durante la preparazione del Trattato di Maastricht a tirare fuori quel parametro. “Noi in Francia abbiamo un numero che funziona bene, possiamo utilizzarlo”. E così nacque quella cifra totalmente priva di senso”. Priva di senso si, ma con un unico obiettivo: “smantellare lo stato sociale”, come ricorda il linguista Noam Chomsky, “il più grande contributo delle socialdemocrazie europee del dopoguerra dato alla civiltà moderna”. Un enorme traguardo di civiltà, ma con un unico difetto: essere in totale disaccordo con il pensiero del massimo teorico del neoliberismo attuale, e cioè l’economista Milton Friedman e la sua cosiddetta Scuola di Chicago, che, negli anni Settanta del secolo scorso, fu consulente economico anche del feroce dittatore cileno Augusto Pinochet: “Tagliare ogni spesa pubblica a parte quelle per la difesa. (…) Il mondo va avanti grazie alle persone che perseguono i propri interessi, perché le grandi conquiste della civiltà non arrivano da uffici governativi e l’unico modo per le grandi masse di poveri di uscire dalla miseria è nelle società capitaliste dove il commercio è libero”. L’egoismo, l’avidità e l’individualismo sfrenato come strumento e fine del vivere sociale con gli effetti che oggi ben conosciamo in termini economici, sociali, politici, culturali e ambientali. E se così funziona il sistema anche i diritti individuali e sociali e la democrazia diventano potenziali ostacoli da abbattere. “I diritti ottenuti nel dopoguerra sono diventati servizi, mentre il cittadino europeo oggi è un cliente. E ci sono servizi che non tutti i clienti possono permettersi”, spiega bene lo scrittore Erri De Luca. Insomma, la società che umilia i più deboli affidandosi alla cieca obbedienza dei dogmi economici del sistema dominante è una sceneggiatura già scritta: “Quando partecipai al primo meeting dei paesi dell’Eurozona proposi alla Troika un compromesso tra le nostre istanze, derivanti da un referendum popolare, e le loro”, commenta l’ex ministro dell’economia greco, Yannis Varoufakis. “Ma Schauble, il ministro delle finanze tedesco dell’epoca, mi disse che ‘le elezioni non possono essere permesse se cambiano il progetto economico della Germania’”.
In una stanza ci sono cento cani, ma solo novantacinque ossi. Si dirà che i cinque cani che restano senza mangiare dovranno essere più veloci, più scaltri, più competitivi. Ma se ripetiamo l’esperimento, resteranno senza mangiare altri cinque cani. Chi ha deciso quali cani mangiano e quali no? Questo l’interrogativo posto dall’insider finanziario americano Warren Mosler, che aleggia senza risposta apparente per tutto il film dei tre giovani registi italiani. Chi ha deciso che cinque cani resteranno comunque senza mangiare? E cosa c’entra tutto questo con l’economia e la crisi e l’austerity e la disoccupazione e la precarietà lavorativa e il taglio dei servizi sociali? Può sembrare una domanda lunare, ma c’entra moltissimo. Infatti il bel documentario dei tre cineasti cerca di mettere in relazione le problematiche della macroeconomia e le difficoltà crescenti della microeconomia. Ciò che in genere evita di fare l’informazione economica dei quotidiani specializzati, chiaramente indirizzata ad una platea di esperti e di fedeli al dogma economico dominante, e cioè quella particolare forma di capitalismo che si è affermato da pochi decenni, il capitalismo finanziario. Perchè di dogma si tratta, quasi di una religione e i suoi epigoni assumono spesso la veste di sacerdoti fondamentalisti, soprattutto quando affermano decisamente che “non c’è alternativa a questo sistema economico”. Ma, come sappiamo, la mancanza di alternative è sempre un regalo avvelenato di ideologie totalitarie perchè anche l’economia è una creazione umana e, come tutte le creazioni umane, imperfetta e subordinata alla finitezza della sua condizione. Parafrasando Giovanni Falcone, quando affermava che “la mafia è una creazione umana e come tutte le creazioni umane ha avuto un inizio, uno sviluppo e avrà anche una sua fine”, allo stesso modo l’economia vive all’interno di questi limiti oggettivi e di queste contraddizioni, messe bene in luce dal documentario che, lungi dall’essere un noioso pamphlet ideologico, si sviluppa come un’inchiesta tesa, giornalisticamente inattaccabile, ma dotata di un ritmo cinematografico mozzafiato. Si respira fin dall’inizio un’atmosfera inquietante da thriller e non può essere un caso che, proprio all’inizio, dopo le parole di Bush senior che incensano il maggiore ideologo del neoliberismo, Milton Friedman, sulle parole della voce narrante (l’attore Claudio Santamaria), la macchina da presa riprenda dall’alto il sinuoso percorso seguito da un’automobile (quella del protagonista occulto del film?) in corsa su una strada di montagna, proprio come all’inizio di “Shining” di Stanley Kubrick, come a suggerire l’affascinante paragone fra la corsa verso la follia e gli incubi notturni del suo protagonista (Jack Nicholson) con quella attraverso la follia criminale del sistema economico raccontato da “PIIGS”. PIIGS, un acronimo che indica quei Paesi europei appesantiti da un grave debito pubblico, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, e che i tre giovani registi hanno ripreso nel titolo della loro opera, frutto di cinque anni di studi e due di riprese e montaggio. Un documentario che racconta l’economia e i condizionamenti che essa riversa sulla vita quotidiana delle singole persone mettendo in relazione gli autorevoli interventi di economisti, intellettuali e attivisti con le vicende molto più prosaiche della Cooperativa “Il Pungiglione” di Monterotondo, alle porte di Roma, nata nello stesso anno, il 1992, del famigerato Trattato di Maastricht che determinò i criteri di ingresso nell’Unione Europea, a rischio fallimento a causa della mancata riscossione di crediti per centinaia di migliaia di euro da parte degli enti locali, bloccati dal patto di stabilità che ne impedisce il versamento in rispetto di astratti parametri economici che il film si occupa di destrutturare e qualificare per quello che sono, e cioè menzogne ad alto tasso di ideologia senza nemmeno una vaga apparenza di scientificità, prodotte però con un fine ben preciso: smantellare lo stato sociale per come lo abbiamo conosciuto in Occidente nel secondo dopoguerra e tornare ad una sorta di “Ancien Régime” (come lo definisce senza mezzi termini un economista americano nel corso di una conferenza) precapitalista e profondamente classista. Per chiarire questi concetti “PIIGS” non è avaro di esempi e testimonianze. Come quella dello studente americano Thomas Herndon, autore di una clamorosa scoperta, e cioè che nei documenti di Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, con cui l’Unione Europea giustificò le misure di austerity, ci sono dei banalissimi errori di allineamento di fogli e colonnine Excel. O come la vicenda di Guy Abeille che spiega meglio di qualsiasi altra cosa l’origine dell’assurdo parametro del 3%, il famigerato rapporto tra deficit e PIL ripetuto come un mantra da politici ed economisti per giustificare le loro devastanti scelte economiche e sociali, una letterale invenzione a casaccio. Guy Abeille, ex funzionario del ministero delle finanze francese quando all’Eliseo era presidente Mitterand la racconta così: “Il presidente voleva fissare un tetto alla spesa pubblica, cercava uno strumento semplice e per uso interno, nessuna teoria economica. In nemmeno un’oretta mettemmo il deficit in rapporto al PIL e con un’operazione alquanto casuale e legata ai parametri dell’epoca ci risultò il 3%. Fu poi Trichet nel 1992 durante la preparazione del Trattato di Maastricht a tirare fuori quel parametro. “Noi in Francia abbiamo un numero che funziona bene, possiamo utilizzarlo”. E così nacque quella cifra totalmente priva di senso”. Priva di senso si, ma con un unico obiettivo: “smantellare lo stato sociale”, come ricorda il linguista Noam Chomsky, “il più grande contributo delle socialdemocrazie europee del dopoguerra dato alla civiltà moderna”. Un enorme traguardo di civiltà, ma con un unico difetto: essere in totale disaccordo con il pensiero del massimo teorico del neoliberismo attuale, e cioè l’economista Milton Friedman e la sua cosiddetta Scuola di Chicago, che, negli anni Settanta del secolo scorso, fu consulente economico anche del feroce dittatore cileno Augusto Pinochet: “Tagliare ogni spesa pubblica a parte quelle per la difesa. (…) Il mondo va avanti grazie alle persone che perseguono i propri interessi, perché le grandi conquiste della civiltà non arrivano da uffici governativi e l’unico modo per le grandi masse di poveri di uscire dalla miseria è nelle società capitaliste dove il commercio è libero”. L’egoismo, l’avidità e l’individualismo sfrenato come strumento e fine del vivere sociale con gli effetti che oggi ben conosciamo in termini economici, sociali, politici, culturali e ambientali. E se così funziona il sistema anche i diritti individuali e sociali e la democrazia diventano potenziali ostacoli da abbattere. “I diritti ottenuti nel dopoguerra sono diventati servizi, mentre il cittadino europeo oggi è un cliente. E ci sono servizi che non tutti i clienti possono permettersi”, spiega bene lo scrittore Erri De Luca. Insomma, la società che umilia i più deboli affidandosi alla cieca obbedienza dei dogmi economici del sistema dominante è una sceneggiatura già scritta: “Quando partecipai al primo meeting dei paesi dell’Eurozona proposi alla Troika un compromesso tra le nostre istanze, derivanti da un referendum popolare, e le loro”, commenta l’ex ministro dell’economia greco, Yannis Varoufakis. “Ma Schauble, il ministro delle finanze tedesco dell’epoca, mi disse che ‘le elezioni non possono essere permesse se cambiano il progetto economico della Germania’”.
E così, in questo cortocircuito continuo fra macroeconomia e microeconomia, “PIIGS” pone molte domande e cerca di fornire alcuni elementi di riflessione allo spettatore anche attraverso molti dati concreti, come il fatto che in Europa i lavoratori del sociale sono 15 milioni e forniscono aiuto e servizi fondamentali a 50 milioni di persone disabili e svantaggiate. E’ giusto che questo lavoro rischi di scomparire perchè fuori dalle logiche selvagge e disumane del profitto ad ogni costo? E’ giusto abbandonare i disabili e le persone svantaggiate, gli “scarti”, per usare un termine di Papa Francesco, al loro destino? E’ giusto che una cooperativa di eccellenza come “Il Pungiglione” che dà lavoro a 100 persone e ne aiuta in media altre 500 fra disabili e persone svantaggiate rischi di chiudere perchè lo Stato non paga i suoi debiti per rispettare criteri economici palesemente falsi? E, per tornare al quesito iniziale, è giusto che in una stanza con cento cani affamati, il ricco padrone di casa lasci soltanto 95 ossi, insufficienti per sfamarli, ma utilissimi per farli sbranare fra loro?
Regia: Adriano Cutraro, Federico Greco, Mirko Melchiorre
Sceneggiatura: Adriano Cutraro, Federico Greco, Mirko Melchiorre
Montaggio: Federico Greco
Musica: Paolo Baglio, Daniele Bertinelli, Antonio Genovino
Cast: Noam Chomsky, Erri De Luca, Warren Mosler, Claudio Santamaria, Yanis Varoufakis
Produzione: Studio Zabalik
Distribuzione: Fil Rouge Media
Italia, 2017, 76′
QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
“TABOO”
di Luisa Ceretto
Prima stagione: 8 episodi diretti da Kristoffer Nyholm (1-4) Anders Engström (5-8)
Ideata da: Tom Hardy
Scritta da: Stephen Night, Tom Hardy, Chips Hardy
Prodotta da: FX e BBC ONE
Produttore esecutivo: Ridley Scott
Presentata su: SKY ATLANTIC
Interpreti: Tom Hardy (James Keziah Delaney). Leo Bill (Benjamin Wilton), Oona Chaplin (Zilpha Geary), Richard Dixon (Edmund Pettifer), Edward Fox (Horace Deaney), Jefferson Hall (Thorne Geary),Edward Hogg (Michael Godfrey), Franka Potente (Helga von Hinten), Jonathan Pryce (Stuart Strange), Nicholas Woodeson (Robert Thoyt)
Siamo a Londra nel 1814, periodo di forte tensione politica tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti: protagonista delle vicende narrate è il misterioso James Keziah Delaney, un avventuriero creduto morto dai parenti, che dopo molti anni passati in Africa, fa ritorno in Inghilterra a causa della scomparsa del padre, morto in circostanze poco chiare. L’uomo si porta dietro una fama di girovago dannato e tenebroso, che nel corso dei suoi soggiorni in terre lontane, ha appreso le arti magiche. Dovrà affrontare nemici, cospirazioni, tradimenti, segreti di famiglia ma, soprattutto, dovrà far fronte alle insidie della Compagnia delle Indie Orientali, la quale era ormai fiduciosa di poter mettere le mani su un terreno nella British Columbia, all’indomani della guerra d’Indipendenza, con cui gli Stati Uniti avevano preso le distanze dalla madrepatria. Un pezzo di terra ritenuto strategico per il commercio, appartenuto al padre di Delaney e ora di proprietà del figlio…
 Il termine “Tabù” nelle religioni primitive significa interdizione, divieto sacrale per il quale certe persone o certi oggetti vengono considerati intoccabili, certe azioni non eseguibili e determinate parole non pronunciabili.
Il termine “Tabù” nelle religioni primitive significa interdizione, divieto sacrale per il quale certe persone o certi oggetti vengono considerati intoccabili, certe azioni non eseguibili e determinate parole non pronunciabili.
“Taboo” dà il nome alla nuova serie britannica presentata su Sky Atlantic che ha per protagonista un uomo che vive fuori dalle regole, noncurante di seguire i codici dettati dalla società del tempo. Una sigla avvincente per la nuova serie prodotta da BBC, dà l’avvio ad un period drama dalla fattura elegante e accurata, in cui i protagonisti si muovono nelle viscere di una Londra notturna e pericolosa, praticando attività illegali.
Sempre più spesso attori e registi della settima arte muovono verso l’universo televisivo, per misurarsi col linguaggio seriale delle tv. Recentemente Jean-Marc Vallée ha diretto una serie di sette episodi, Big little lies – Piccole grandi bugie, con un cast stellare tra cui Nicole Kidman e Reese Witherspoon.
In questo caso, ideatore della serie è l’attore inglese Tom Hardy, insieme al padre, Chips e a Stephen Knight. Attore talentuoso, in “Taboo” dà vita a Delaney, un avventuriero tormentato che nel corso dei suoi viaggi è scampato alla morte grazie a rituali antichi di magia e stregoneria.
A proposito del personaggio, Hardy ha dichiarato: “Lo cercavo, un personaggio del genere – violento, crudele – da quando interpretai Bill Sikes in ‘Oliver Twist’, fu un’esperienza stupenda. Così mi era venuta l’idea di adottare la stessa silhouette di quel personaggio per sovrapporvi però alcuni elementi ispirati anche al Marlow di ‘Cuore di tenebra’, e anche un pizzico di Heathcliffe di ‘Cime tempestose…’ Volevo insomma un mix dei miei eroi preferiti della letteratura inglese”.
Il debutto di Hardy, come attore, avviene in una serie tv prodotta da Steven Spielberg “Band of Brothers” (2001), mentre sul grande schermo fa la sua prima apparizione in “Black Hawk Down” di Ridley Scott. Successivamente lavora con Sophia Coppola in “Marie Antoinette”. Nel 2010 è co-protagonista del film di Nolan, “Inception”, al fianco di Di Caprio e Watanabe. Con Nolan collabora nuovamente con “Il cavaliere oscuro-Il ritorno” (che lo ha reclutato anche nel film di prossima uscita, “Dunkirk”.). Accanto a ruoli perlopiù psicotici, minacciosi e violenti (“Mad Max: Fury Road”, “The Revenant”), Tom Hardy si mette in gioco dando corpo al personaggio di Ivan Locke, che nella sua ordinarietà è esemplare e per il rigore delle sue scelte è assimilabile ad un eroe classico. Diretto da Stephen Night, “Locke” è girato in tempo reale all’interno dell’abitacolo di un’automobile in corsa in cui Hardy è l’unico protagonista e il tessuto narrativo si alimenta delle telefonate che via via fa e riceve.
Attore versatile, bravo nell’interpretare ruoli compositi, Tom Hardy non poteva sfuggire al fascino di una nuova sfida, cimentandosi in una serie dalla forte dimensione esoterica, vincendo egregiamente la scommessa.
L’ottava puntata si conclude con un finale aperto, perfetto per il prosieguo di una seconda serie, che nel frattempo è stata confermata.
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
 ETTORE SCOLA- UN TRIBUTO
ETTORE SCOLA- UN TRIBUTO
a cura di Felice Laudadio
SIAE – BIF@ST
Marzo 2016 –s.i.p.
E’ un tributo del Bif@St, di cui era Presidente, attraverso una serie di testimonianze apparse sulla stampa italiana e internazionale all’indomani della morte del regista. “Una quantità talmente sterminata, sottolinea il curatore Felice Laudadio, da aver sorpreso perfino la sua famiglia e gli amici più cari. Un segnale forte, molto forte, della traccia profonda lasciata nella cultura, nel cinema, nella società di questo grande signore che molto, moltissimo ci mancherà”. E non è retorica quella di Felice Laudadio perché il Maestro Ettore Scola ha lasciato veramente un segno importante nella Storia del Cinema italiano e mondiale. Uno, come evidenzia nell’intervento iniziale Gaetano Blandini, Direttore Generale SIAE, che dagli anni Cinquanta come sceneggiatore, regista e grande osservatore “ è stato capace di descrivere il meglio e il peggio del nostro Paese, con una penna sopraffina e pungente, e uno sguardo penetrante, a volte cinico”. Film senza età, aggiunge, che il tempo non invecchia, semmai li migliora. E sono tanti, come testimoniato negli interventi critici contenuti nel volume. Ettore Scola, poi, come sottolinea ancora Blandini, va ricordato anche per la sua signorilità “ che ormai, purtroppo, è andata perduta. E che plasticamente era rappresentata dalla cravatta che indossava tutti i giorni sul set”. Tanto che per i lavoratori di Cinecittà, lui era a tutti gli effetti, “Il regista con la cravatta”. Un segno di rispetto per chi lavorava con lui. Signorilità e prestigio di Maestro che anche chi scrive, ha potuto constatare di persona in tante occasioni.
 LO SPECCHIO DIPINTO – ETTORE SCOLA E DINTORNI
LO SPECCHIO DIPINTO – ETTORE SCOLA E DINTORNI
a cura di Paola Dei
Edizioni Falsopiano 2016
Pagg. 195, euro 18.00
Altre testimonianze sul valore del cinema di Ettore Scola in questo libro curato da Paola Dei per il Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive. A partire da Nicola Borrelli, Direttore Generale per il Cinema- MiBACT, che nella prefazione sottolinea che Ettore Scola ha raccontato l’Italia e che “Gran Maestro della commedia italiana –dalla quale, ritenendo che le storie non dovessero obbligatoriamente far ridere, seppe anche allontanarsi ( ad esempio con “Passione d’amore”) – nei suoi film non amò filmare i propri sogni, la propria immaginazione, ma fu sempre interessato al racconto della realtà, dando voce a tutti i tipi di italiani, consegnando allo spettatore un bestiario umano di personaggi tesi al raggiungimento di un’inarrivabile felicità, eroici perdenti puntualmente sconfitti dalla vita”. Aggiungendo anche che “I suoi film, capolavori senza tempo, sono terapeutici e beffardi, ironici e teneri, stravaganti eppure realistici, tanto da essere ancora attuali in ognuno dei temi affrontati”. Il libro raccoglie poi tanti documenti che illuminano la personalità di questo regista che per Paola Dei è” uno dei Maestri della commedia all’italiana, un cineasta che ha saputo trasformare con ironia la visione in una delle più alte realizzazioni del processo creativo”. Ecco, quindi, che “Dall’Album della memoria” spuntano, tra gli altri, le testimonianze di Giuliano Montando e Pupi Avati, una preziosa intervista realizzata con il marito da Gigliola Fantoni Scola, gli “Incontri magici” di alcuni critici e l’analisi di alcuni suoi film significativi e tanti altri interventi che, per la curatrice del volume Paola Dei, rappresentano “il punto di vista di chi è cresciuto con i suoi film presentando cosi la possibilità di ampliare l’universo aggiungendo e scoprendo nuove dimensioni che permettono a chi osserva di sperimentare internamente le mille sfumature dell’essere al mondo, non solo in ciò che è visibile ma spesso anche in ciò che è invisibile”.
 L’UMBRIA SULLO SCHERMO- DAL CINEMA MUTO A DON MATTEO
L’UMBRIA SULLO SCHERMO- DAL CINEMA MUTO A DON MATTEO
di Fabio Melelli
Edizioni Aguaplano.2016
Euro 13.00
Un rapido excursus sulla presenza dell’Umbria nel cinema e nella fiction, segnalando le opere portate sullo schermo e sulla televisione. Non solo quelle sul frate di Assisi, San Francesco ma tante altre che sono sfuggite all’osservazione dello spettatore sia cinematografico che televisivo. Per il cinema si parte dal documentario “Corpus Christi Procession” realizzato nel 1898, a pochi anni i vita dell’invenzione dei fratelli Lumière proseguendo con uno poco noto su San Francesco dal titolo “Il poverello di Assisi”(1911) di Enrico Guazzoni ed anche gli altri due film sul Santo di Assisi realizzati nel periodo muto: “Frate Sole”(1918) di Ugo Falena e Mario Corsi , “Frate Francesco”( 1927) di Giulio Cesare Antamoro. Senza trascurare, ovviamente, le opere che su San Francesco ha realizzato Liliana Cavani. Da ricordare, poi, nel periodo del cinema muto, un classico come “Acciaio”(1933) di Walter Ruttman che porta alla ribalta Terni e le sue acciaierie, una città che alla fine degli anni Novanta diventa un centro importante della cinematografia nazionale grazie al successo del film “La vita è bella” 1997 di Roberto Benigni che poi nel piccolo centro ternano di Papigno impianta una propria realtà produttiva girando anche “Pinocchio”(2002) e “La tigre e la neve”(2005). Un assiduo frequentatore dell’Umbria è poi il bolognese Pupi Avati che nel territorio di Todi ha girato “L’arcano incantatore”(1996), “La via degli Angeli(1999) e “I cavalieri che fecero l’impresa”(2001) ed a Perugia “Ma quando arrivano le ragazze”(2005). Tanti altri i registi che hanno usufruito del territorio umbro per la scenografia dei loro film: tra essi, Richard Fleischer per “Barabba”con scene al Lago di Corbara, Louis Malle per “La vita privata” ambientato a Spoleto, Vittorio De Sica per “I sequestrati di Altona” e “Lo chiameremo Andrea” girati a Terni, Mario Monicelli che ad Arrone ha girato la scena della giostra cavalleresca che appare all’inizio del film “L’armata Brancaleone”(1966), ma vi hanno girato anche Luigi Comencini, Nino Manfredi, Franco Zeffirelli, i fratelli Taviani, Carlo Verdone e Armando Crispino che a Spoleto ha girato il thriller “L’etrusco uccide ancora”(1972), un film cult. Tante anche le opere televisive, le più note delle queli sono la serie “Carabinieri”(2001-2008) e “Don Matteo” che iniziata nel 2000 è ancora in programmazione. A rendere piacevole la lettura alcune “Curiosità”. Non mancano poi brevi biografie di “Umbri nel cinema e nella fiction” ed un corredo fotografico che riporta alla memoria alcune opere significative.
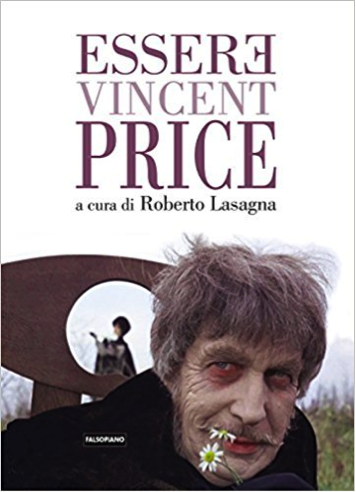 ESSERE VINCENT PRICE
ESSERE VINCENT PRICE
a cura di Roberto Lasagna
Edizioni Falsopiano, 2016
Pagg. 233, euro 20.00
Tante le maschere di Vincent Price nella sua lunga carriera di attore. Un’attività camaleontica la sua i cui personaggi legati ,soprattutto, al genere horror sono rimasti nell’immaginario dello spettatore cinematografico. A partire dai film “La maschera di cera”(1953) di André De Toth e “L’esperimento del dottor K”(1958) di Kurt Neumann per proseguire con i Cult movie realizzati da Roger Corman “I vivi e i morti”(1960), “Il pozzo e il pendolo”(1961), “La maschera della morte rossa”( 1964) e “La tomba di Ligeria”( 1965). Ma nell’immaginario cinematografico da annoverare sono anche i personaggi da lui interpretati in “Bernadette”(1943) di Henry king e in “Vertigo”(19449 di Otto Preminger , “Femmina folle”(1945) di John M. Stahl, “ I tre moschettieri”( 1948) di George Sidney, “L’avventuriero di New Orleans” (1951) di William Marshall, “Il mostro delle nebbie”(1954) di John Brahm, “L’abominevole Dr. Phibes” (1971) di Robert Fuest, “Oscar insanguinato”( 1973) di Douglas Hickox e tanti altri fino alla sua ultima interpretazione in “Edward mani di forbice”(1990) di Tim Burton. Tutta una carriera che è ricordata nelle sue fasi più importanti nella prefazione di Roberto Lasagna e nei contributi critici di studiosi come, ed è il caso di citarli tutti, Anna Antonini, Danilo Arona, Riccardo Bellini, Francesca Brignoli, Lorenzo Donghi, Leonardo Gandini, Mario Gerosa, Alessandro Leone, Federico Magni, Anton Giulio Mancino, Giovanni Memola, Alberto Morsiani, Meris Nicoletto, Michele Raga, Barbara Rossi, Fabio Zanello. Citando Roberto Lasagna, Vincent Price è stato un interprete raffinato e camaleontico che ha osato sperimentare infinite maschere e travestimenti, regalando film e collaborazioni irripetibili come quelle con Roger Corman e Robert Fuest, portando sullo schermo le ombre del reale, i trasalimenti dell’anima, gli sgomenti esistenziali e i fantasmi di un mondo inquietante che il cinema e l’arte hanno contribuito a smascherare.
Pregevole la filmografia che annovera anche le interpretazioni televisive, le apparizioni nei cortometraggi e il suo ruolo di doppiatore. E utili i riferimenti bibliografici.
IL LIBRO
SUSPENSE! IL CINEMA DELLA POSSIBILITÀ
Recensione di Vittorio Giacci
La suspense, principio compositivo che mediante la sospensione narrativa rende possibile l’identificazione nella rappresentazione, è una straordinaria modalità diegetica che permette, al lettore come allo spettatore, di identificarsi totalmente nella vicenda e di vivere, nella forma del piacere ansioso ma anche fortemente eccitante, le vicende del protagonista. Di questa tecnica di racconto ne è ampiamente permeata la letteratura anglosassone, molto meno quella italiana, il che spiega la scarsità, per non dire l’assenza, nel nostro Paese, di studi al proposito.
Si tratta di una mancanza che per anni ha fatto ritenere alla nostra critica letteraria che il racconto “nero”, “giallo” o di detection, fosse un genere di serie B ed a quella cinematografica di non capire, un cineasta come Alfred Hitchcock che della suspense ne aveva fatto la chiave espressiva per eccellenza, la bussola che permetteva di navigare nel suo arcipelago di situazioni e di personaggi, di complotti e di intrighi, di tensioni e di ansiti, di azioni e di attese; di perdersi e di compiacersene nell’infinito di una dinamica che, di volta in volta, ci fa assumere i panni del colpevole e dell’innocente, di chi fugge e di chi insegue, di chi pecca e di chi espia.
Viene fortunatamente e finalmente a colmare questa grave lacuna epistemologica l’approfondito studio di Damiano Cantone e Piero Tomaselli Suspense! Il cinema della possibilità, edito da Orthotes (Napoli-Salerno, 2016) con prefazione di Federico Di Chio.
 Suddiviso in tre parti ed in undici capitoli (Suspense sive Hitchcock; La suspension of disbelief: L’in-cludere e l’iper-mediatizzazione del mondo; Il paradosso della suspense e i principali approcci teorici; L’uomo che sa(peva) troppo. La psicoanalisi e la suspense; Suspense e analisi narratologica. Le tipologie, gli strumenti e le fasi della suspense; La suspense e l’iper-codificazione narrativa; La detection e il Ricercatore Mago; Suspense sive epoché; La inner-suspense: cristalli di tempo e détournement; Per una teoria eXistenZialista della suspense; Dalla serialità televisiva al videogame. Le nuove forme della suspense contemporanea), il libro, attraverso lo studio di un corpus di oltre 1000 titoli, analizza la suspense, oltre a soffermarsi doverosamente su quella specificamente hitchcockiana, in ogni suo aspetto ed in ogni sua tipologia, dalla codificazione narrativa all’interpretazione dei suoi eroi archetipali; dalla lettura psicanalitica fino alla sua utilizzazione nei nuovi mezzi di comunicazione oltre il cinema, dalla serialità televisiva ai videogiochi.
Suddiviso in tre parti ed in undici capitoli (Suspense sive Hitchcock; La suspension of disbelief: L’in-cludere e l’iper-mediatizzazione del mondo; Il paradosso della suspense e i principali approcci teorici; L’uomo che sa(peva) troppo. La psicoanalisi e la suspense; Suspense e analisi narratologica. Le tipologie, gli strumenti e le fasi della suspense; La suspense e l’iper-codificazione narrativa; La detection e il Ricercatore Mago; Suspense sive epoché; La inner-suspense: cristalli di tempo e détournement; Per una teoria eXistenZialista della suspense; Dalla serialità televisiva al videogame. Le nuove forme della suspense contemporanea), il libro, attraverso lo studio di un corpus di oltre 1000 titoli, analizza la suspense, oltre a soffermarsi doverosamente su quella specificamente hitchcockiana, in ogni suo aspetto ed in ogni sua tipologia, dalla codificazione narrativa all’interpretazione dei suoi eroi archetipali; dalla lettura psicanalitica fino alla sua utilizzazione nei nuovi mezzi di comunicazione oltre il cinema, dalla serialità televisiva ai videogiochi.
Il volume è arricchito da 30 schede relative ad altrettante opere filmiche emblematiche sul tema (integrate da una postilla horror), che gli autori chiamano Stimmung narrative, “situazioni esistenziali archetipe in cui può venire a trovarsi l’eroe/ricercatore e che sostanziano e determinano il mondo narrativo del cinema (che gravita attorno alla detection) e il profilo psicologico/esistenziale del protagonista, (…) catalizzatrici e acceleratrici di suspense nel senso che, quando sono presenti, innescano spesso un feedback/transfert essenziale con lo spettatore, aumentando considerevolmente il livello di empatia/identificazione. Sono altresì situazioni narrative che appaiono costitutivamente caratterizzate da un senso di angoscia, incertezza e provvisorietà e che postulano quindi uno sviluppo e/0 un ribaltamento prossimi a venire”.
Gli autori si pongono fin dal principio il problema di come definire l’ambito di questa complessa tipologia narrativa quando scrivono: “Non è facile delimitare lo spettro d’azione della suspense, così come non è facile fornirne una fenomenologia completa. Essa funziona nella letteratura prima che al cinema. Proprio per questo suo carattere così apertamente connaturato alle forme della narrazione, si è sempre dato per scontato che fosse riducibile a una tecnica diegetica tra le altre, un artificio capace di attirare l’attenzione dello spettatore per spingerlo a inoltrarsi più proficuamente nei meandri di un mondo narrativo. In quanto tale trova la sua giusta collocazione nei manuali di retorica, pur non occupando in essi uno spazio particolarmente significativo. Essa viene considerata ora come uno strumento di costruzione, magari propedeutico al colpo di scena o comunque a uno snodo significativo della narrazione, ora come genere letterario tout court, con le sue regole e i suoi codici specifici”.
Da un punto di vista più propriamente narrativo -continuano Cantone e Tomaselli- , “la suspense si presenta essenzialmente come un dispositivo di accumulazione di tensione, come una strategia diegetica che rallenta il normale corso dell’intreccio e, attraverso un elevato grado di sospensione informativa e cognitiva, getta il lettore/spettatore in uno stato di agitazione e di ansietà per l’impossibilità di prevedere come andrà a concludersi la storia. Essa è provocata dalla creazione nel destinatario di una necessità di sapere di più circa una narrazione di cui già sa o indovina qualcosa. I processi di sospensione sono generati dal ritardo di un fatto atteso o desiderato che, fino a quando non si verifica, garantisce l’attesa dello spettatore. In questo senso la suspense, come ha dimostrato Hitchcock, ha anche un’altra fondamentale funzione: quella di aumentare esponenzialmente l’identificazione e il livello di empatia del pubblico, creando con esso un legame sempre più forte via via che il plot si sviluppa, in direzioni che non risultano (quasi) mai totalmente prevedibili, ma che innescano da subito un circolo ermeneutico/emozionale con l’orizzonte di aspettative dello spettatore”.
E’ stato proprio Hitchcock, infatti, a definirla nella maniera più appropriata distinguendo l’”effetto-suspense” dall’”effetto-sorpresa! E che così magistralmente descrive: “Noi stiamo parlando, c’è forse una bomba sotto questo tavolo e la nostra conversazione è molto normale, non accade niente di speciale e tutt’a un tratto: boom. L’esplosione. Il pubblico è sorpreso, ma prima che lo diventi gli è stata mostrata una scena assolutamente normale, priva di interesse. Ora veniamo al suspense. La bomba è sotto il tavolo e il pubblico lo sa, probabilmente perché ha visto chi la metteva. Il pubblico sa che la bomba esploderà all’una e sa che è l’una meno un quarto –c’è un orologio nella stanza- ; la stessa conversazione insignificante diventa tutt’a un tratto molto interessante perché il pubblico partecipa alla scena. Gli verrebbe da dire ai personaggi sullo schermo: “non dovreste parlare di cose così banali, c’è una bomba sotto il tavolo che sta per esplodere da un momento all’altro”. Nel primo caso abbiamo offerto al pubblico quindici secondi di sorpresa al momento dell’esplosione. Nel secondo caso gli offriamo quindici minuti di suspense. La conclusione di tutto questo è che bisogna informare il pubblico ogni volta che è possibile. Si tratta di dare al pubblico informazioni che i personaggi non conoscono”.
Partendo dall’individuazione del codici ermeneutici suggerita da Roland Barthes Cantone e Tomaselli distinguono quattro tipologie di suspense riconducibili ad altrettante domande, di cui le prime due fattispecie fanno parte di una suspense d’essere mentre le ultime due sono ascrivibili a una suspense di fare: 1. “Chi?” (Chi ha compiuto il crimine? Chi è stato ucciso? Chi è in realtà quel personaggio?); 2. “Che cosa?” (Che cosa diverrà? Che cos’è? A che gruppo appartiene?); 3. “Sì o no?” (Ce la farà l’eroe/eroina? Andrà a finire bene o male? Chi vincerà?); 4. “Come ha fatto?” (Come è riuscito a uscire dalla prigione? Come ha compiuto il delitto? Come è stato possibile arrivare a questo punto?).
Non sfugge poi agli autori che la suspense cinematografica, a differenza di quella letteraria, viene essenzialmente creata grazie agli accorgimenti tecnici del linguaggio filmico, in particolare del cosiddetto “punto di vista” che, al cinema, appartiene in via esclusiva all’occhio della cinepresa, e per esternare il concetto ai propri lettori ricorrono alle parole di Dario Argento, uno dei rari registi italiani ad esserne costantemente sistematicamente attratto in ogni sua opera: “se un personaggio che cammina al centro dello schermo io lo sposto di lato, durante tutta questa carrellata, tu spettatore proverai un senso di angoscia, perché é irregolare. Quindi ti provocherà una piccola, pungente sensazione di ansietà. Perché é così? Perché non puoi pensare che è uno sbaglio, ci deve essere sotto qualcosa! (…) Si crea una piccola ansietà, dato che non riesci a capire. Vedi che è irregolare, perché alle sue spalle c’è troppo vuoto, e lui è piazzato verso il bordo. E allora pensi che qualcosa arriverà di qua, da un momento all’altro. E se io non faccio succedere nulla, la cosa può andare avanti anche molto, un carrello luuuungo……”.
Nel leggere questo bel saggio di Cantone e Tomaselli che mi auguro venga studiato anche dal maggior numero possibile di cineasti del nostro Paese così da colmare questo “gap” anche nella nostra filmografia nazionale, sono rimasto particolarmente colpito dalla riflessione sulla “inner-suspense”.
Riallacciandosi alla distinzione di Gilles Deleuze a partire dal pensiero di Henri Bergson all’interno di Materia e Memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, tra immagine attuale e immagine virtuale Cantone e Tomaselli svolgono una riflessione sulla possibilità che il procedimento della suspense possa essere applicato non solo al cinema classico ma anche al cinema della modernità, articolato sull’idea di de-costruzione della narrazione tradizionale, e sulle esperienze del “Nouveau Roman” e dell’”Ecole du Regard”, quello che non distingue tra tempo dell’azione e tempo del ricordo, come, ad es. L’anno scorso a Marienbad di Alain Resnais e Alain Robbe-Grillet, un film che -come scrivono gli autori del libro- “non racconta una storia vera e propria, ma che sembra piuttosto presentare una situazione calata in un eterno presente. In un hotel di lusso (o forse in una clinica) un uomo corteggia una donna sostenendo di averla già conosciuta l’anno prima nello stesso luogo, ma lei nega. Il rendez-vous può essere avvenuto, oppure stiamo forse assistendo al primo incontro fra i due o alla proiezione nel futuro di un incontro che deve ancora avvenire. I tre registri della temporalità si confondono senza che nessun artificio tecnico (flashback, flashforward, immagine-sogno) intervenga a spiegare cosa stia succedendo. La situazione è inesplicabile, “complicata” in senso deleuziano: l’uomo vive l’istante presente in nome del passato, la donna in virtù di un futuro semplicemente possibile, e il marito di lei in funzione del presente attuale. Resnais non cerca una soluzione all’enigma (è l’uomo che mente per far vacillare le sicurezze della donna? E’ la donna che lo inganna per non insospettire il marito? E quest’ultimo, fino a che punto è al corrente di quanto sta accadendo?), ma fa anzi in modo che esso pervada l’intero film, sovrapponendo le tre istanze -temporali e soggettive- in un unico e paradossale flusso immobile”, quello che si affida, come “opera aperta” -nel significato indicato da Umberto Eco- all’interpretazione personale e soggettiva dello spettatore che ne diventa così una sorta di co-autore.
“In tal modo la inner-suspense -scrivono ancora gli autori- finisce per problematizzare e sospendere i vincoli della narrazione e della “normale” codificazione diegetica. Ma attenzione. Non si tratta di una suspense che appartiene al cinema come a uno dei suoi tanti strumenti di lavoro, come a una tecnica di narrazione/rappresentazione tra le altre, ma di una sospensione del cinema stesso, perlomeno se intendiamo quest’ultimo nel suo aspetto di strumento e linguaggio codificato. Al posto di un meccanismo teso all’intrattenimento fondato sull’illusion of reality e sull’identificazione, la inner-suspense procura una vertigine improvvisa che spossessa lo spettatore della sua posizione abituale, costringendolo a interrogarsi sulla sua funzione e a rompere con quel pensiero automatico che caratterizza i regimi della narrazione”.
Non è più il cinema dell’azione, dunque, a farsi strada nelle volute della suspense ma quello della contemplazione, della coscienza, dell’introspezione, della ipoteticità e della problematicità, quello di grandi autori contemporanei come Antonioni, Welles, Tarkovskij, Resnais, “immagini-cristallo” -per utilizzare l’espressione di Gilles Deleuze- che rispecchiano sequenze dove si con-fondono passato, presente e futuro, esistenza e memoria, l’agire e il ricordare, in una caleidoscopica realtà-altra priva di logica apparente ma ricca di intensa fascinazione.
E’ evidente che, così facendo, si fa uscire la suspense dalla considerazione restrittiva che essa possa essere una formalità narrativa valida in via esclusiva per un solo genere, il “nero”, per estenderla invece al cinema nel suo insieme.
Pierre Boileau e Thomas Narcejac, scrittori a cui si devono opere fondamentali del genere come I diabolici (per il film omonimo di H. G. Clouzot) e il racconto D’entre les morts da cui Alfred Hitchcock ha tratto il suo capolavoro assoluto “La donna che visse due volte”, hanno scritto nel loro saggio Le roman policier (Quadriges Presses Universitaires de France, Paris, 1975) che esiste tra il tempo e l’eccitazione un rapporto matematico prodotto dal racconto e questo rapporto è precisamente la suspense.
Mi sembra che Cantone e Tomaselli, nella loro competente, esaustiva ed originale ricerca, si siano fatti guidare proprio da questa idea “matematica” che dona al libro un valore aggiunto tale da farlo spiccare nel panorama della pubblicistica cinematografica contemporanea, e non solo italiana.
Damiano Cantone-Piero Tomaselli, Suspense! Il cinema della possibilità, prefazione di Federico Di Chio, Orthotes, Napoli-Salerno, 2016.
AUTORI (New entry)
Nella sezione dedicata agli autori troverete la biografia di ognuno.
CREDITS
Carte di Cinema 13
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com )
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 13 della rivista online: Rosaria Bonotti, Marcello Cella, Luisa Ceretto, Lorenza Corsetti, Marino Demata, Ettore Di Gennaro, Mario Giunco, Barbara Grassi, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Carmine Mezzacappa, Paolo Micalizzi, Riccardo Poma, Stefano Usardi, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Marco I. Zambelli, Giancarlo Zappoli.