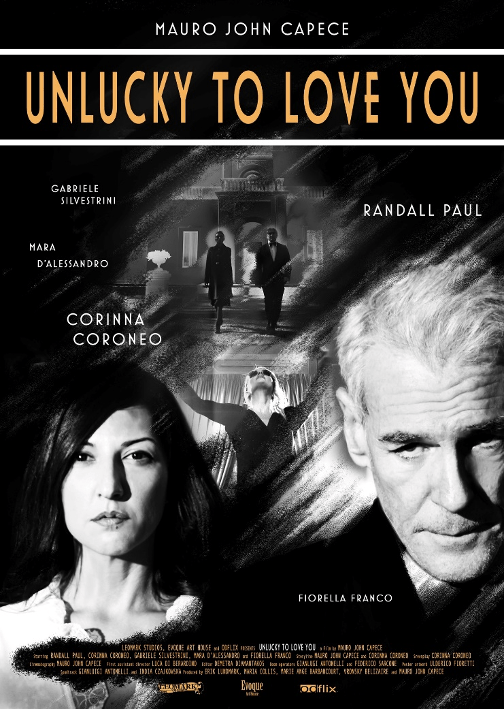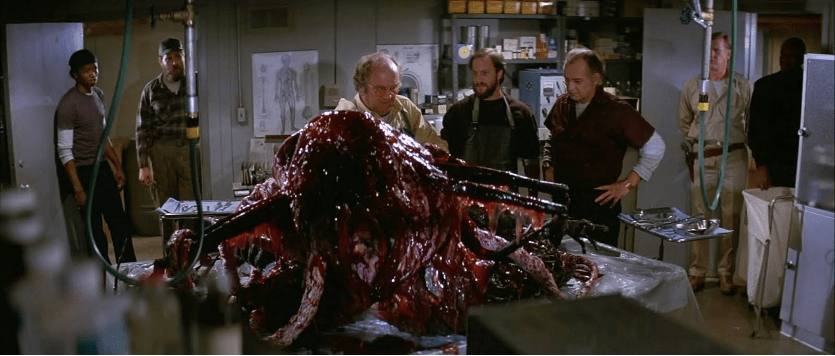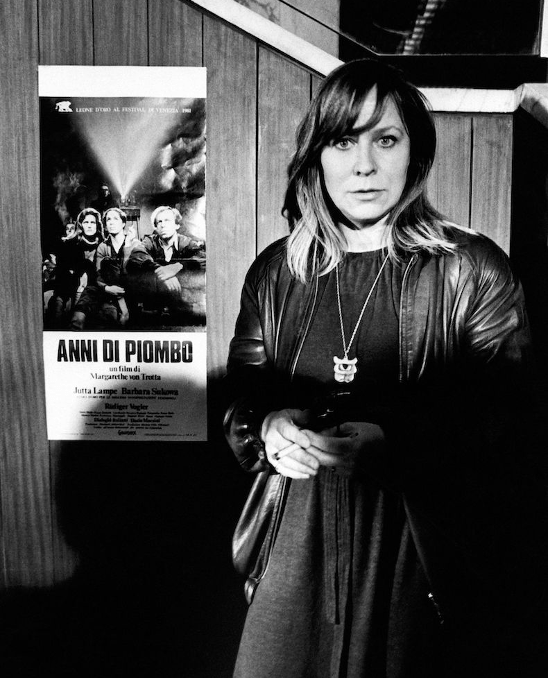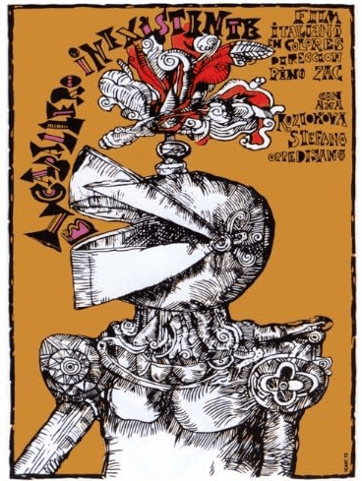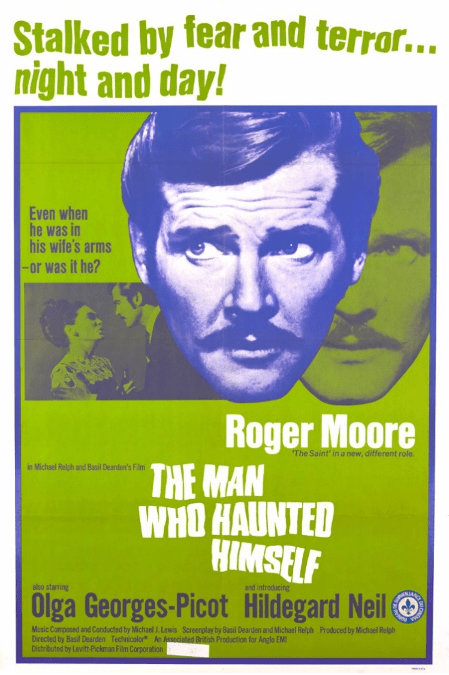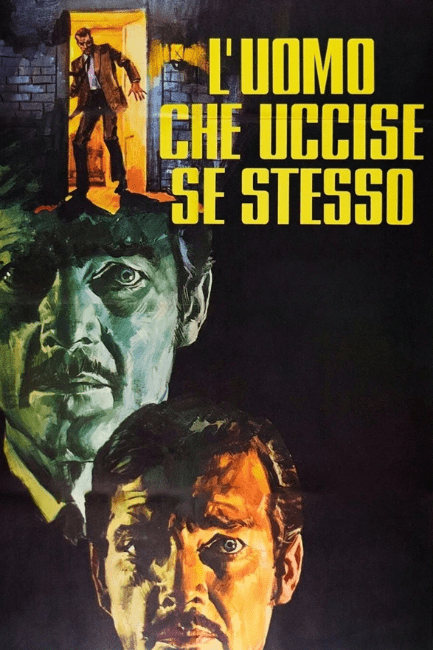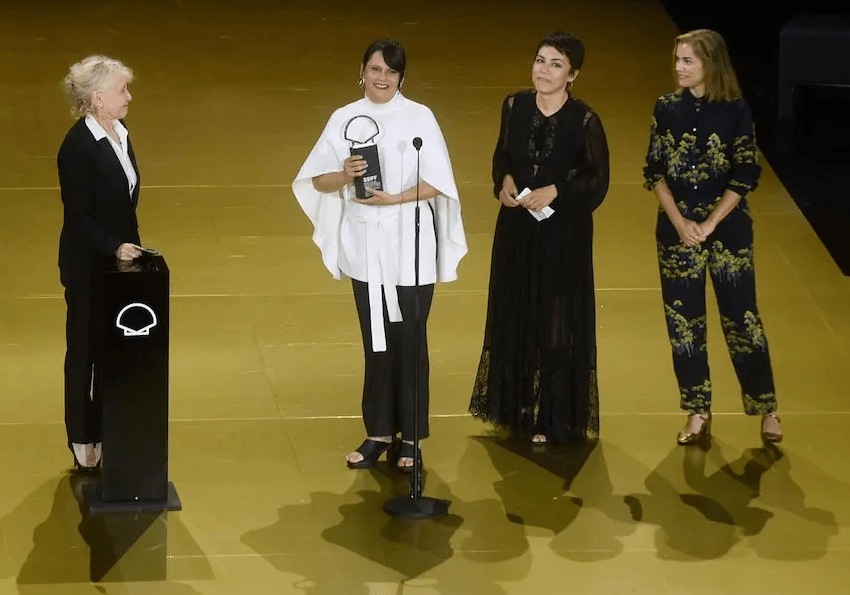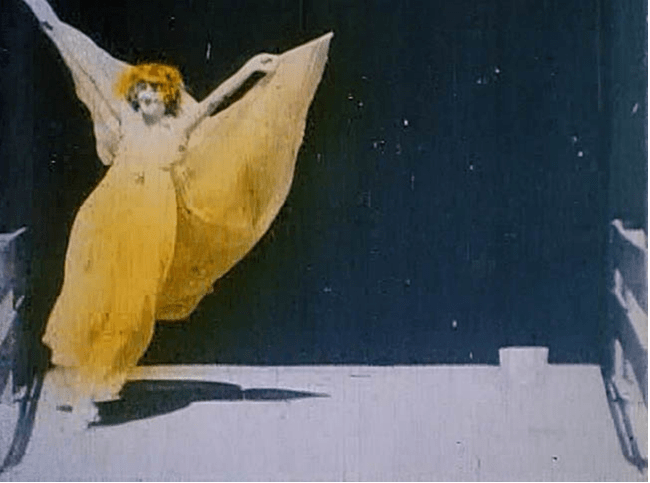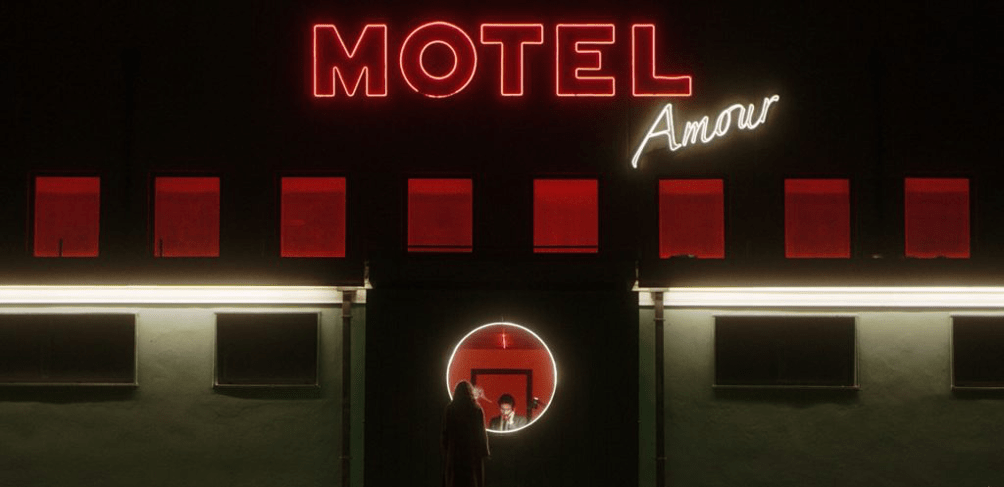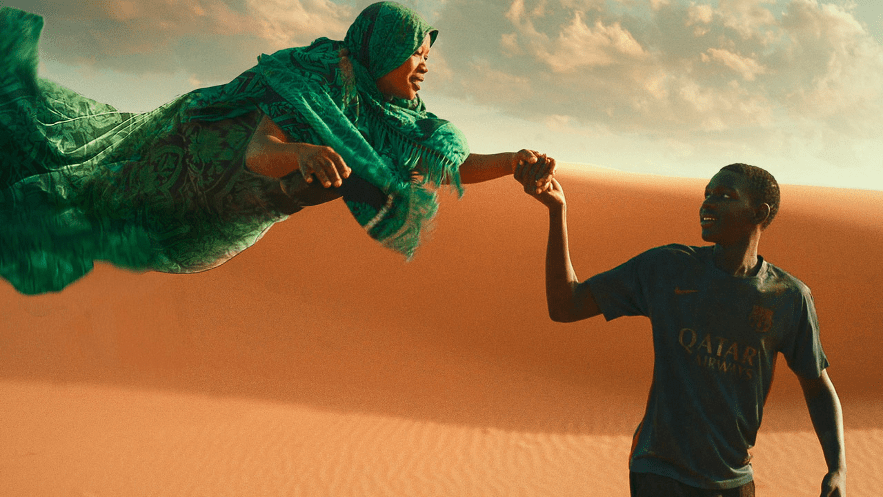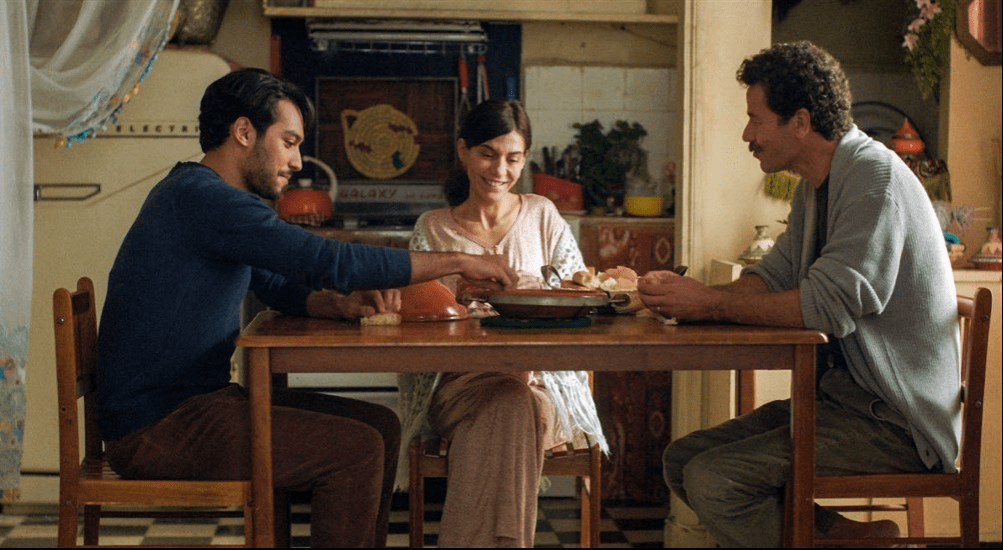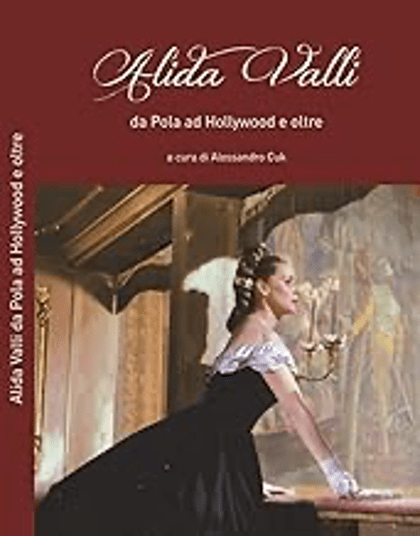Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 2.1 L’AMORE AI TEMPI DEL NOIR “Unlucky to love you”, il nuovo film di Mauro John Capece di Marcello Cella
- 2.2 INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPACE a cura di Marcello Cella
- 2.3 ZURLINI ULTIMO IN DVD “IL DESERTO DEI TARTARI” di Tullio Masoni
- 2.4 SUSPENSE ED ESTETICA: IL “NEW HORROR” DI JOHN CARPENTER di Roberto Lasagna
- 3 SAGGI
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 6 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO
- 7 OCCHIO CRITICO
- 7.1 “AMUSIA”: PRIMO LUNGOMETRAGGIO DI MARESCOTTI RUSPOLI di Paola Brunetta
- 7.2 LA TONALITA’ DI “IO CAPITANO” di Tullio Masoni
- 7.3 “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI di Tullio Masoni
- 7.4 TRANSILVANIA “ANIMALI SELVATICI” DI CRISTIAN MUNGÌU; “EL CONDE” DI PABLO LARRAÌN di Paolo Vecchi
- 7.5 IL BLU DEL CAFTANO di Marco Incerti Zambelli
- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 9 PANORAMA LIBRI
- 10 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
L’AMORE AI TEMPI DEL NOIR – “UNLUCKY TO LOVE YOU”, IL NUOVO FILM DI MAURO JOHN CAPECE di Marcello Cella
Un uomo solitario, dj per passione e per necessità, ricorda la propria storia tormentata con la bella ballerina Chantal e la misteriosa dark lady Lucrezia sfociata in un delitto e in una fuga nell’anonimato, mentre la polizia indaga. Noir condito con whisky e blues come nella più classica tradizione del genere, ma girato in una Puglia dai colori pop, a metà strada fra la pittura di Edward Hopper e la California più psichedelica.
INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPECE a cura di Marcello Cella
Nuova intervista a tutto campo con il regista di “Unlucky to love”, sulle suggestioni musicali e pittoriche del suo film noir, sulle enigmatiche figure femminili che lo popolano, sul suo modo di essere regista indipendente, sull’ironia sottile delle sue storie, sulla feroce lotta di classe che affiora in molti suoi personaggi, sul suo lavoro con gli attori, sul condizionamento delle piattaforme, e sulla sua grande attrice-musa e fondamentale collaboratrice Corinna Coroneo.
ZURLINI ULTIMO IN DVD – “Il DESERTO DEI TARTARI” di Tullio Masoni
Dal romanzo di Dino Buzzati, 1940. Un film sulla finitezza umana e il Destino. Ultima opera di Valerio Zurlini, 1976, la cui dimensione spettacolare sembra poco compromessa dal piccolo schermo.
SUSPENSE ED ESTETICA: IL “NEW HORROR” DI JOHN CARPENTER di Roberto Lasagna
John Carpenter è un cineasta portatore di una visione che, in non pochi episodi della sua filmografia, aspira a ribadire la torbida e stoica sopravvivenza di individui tenuti al margine del sistema, ma inevitabilmente carichi di un disincanto che ne lascia intendere la singolare politicità. Una condizione costretta a confrontarsi con scenari di collasso dei diritti, con le magagne e le grandi contraddizioni di un’America dal volto ingannatore.
SAGGI
ITALO CALVINO E IL CINEMA di Maurizio Villani
L’articolo, prendendo spunto dalla Mostra alle Scuderie del Quirinale a Roma, ricostruisce il complesso rapporto di Italo Calvino con il cinema a partire dalla passione dello scrittore per la settima arte fino alle collaborazioni giornalistiche e ai contributi teorici sul nesso tra cinema e letteratura.
ROGER MOORE 007 E LO STRANO CASO DEL SIGNOR PELHAM di Mario Galeotti
Attore brillante capace di dare un tocco speciale e ironico ai suoi personaggi, Roger Moore è noto per essere stato il terzo volto ufficiale dell’agente segreto 007, alias James Bond, in ben sette film girati tra il 1973 e il 1985. Confinato nel cliché dell’uomo d’azione ed elegante seduttore, nel corso della sua carriera Roger Moore ha avuto anche qualche rara occasione di proiettarsi verso nuovi orizzonti artistici, come nel 1970 quando, a ridosso dell’enorme successo della serie televisiva “The Saint”, fu protagonista del thriller diretto da Basil Dearden “L’uomo che uccise se stesso” (“The Man Who Haunted Himself”), un film che gli permise di affrancarsi temporaneamente dalla prevedibilità del typecasting.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
VENTESIMA EDIZIONE DI SEDICICORTO FORLI’ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL di Paolo Micalizzi
Resoconto su un festival giunto alla ventesima edizione che fa di Forlì la capitale del cortometraggio Internazionale. Dichiarazioni del direttore artistico Gianluca Castellini ed elenco dei Premi principali.
FESTIVAL ED EVENTI
VENEZIA. UNA MOSTRA DEL CINEMA CHE RISCUOTE SEMPRE PIU’ SUCCESSO. I PREMI PRINCIPALI di Paolo Micalizzi
Commenti sui principali Premi assegnati dalla Giuria ufficiale ma anche dai Premi collaterali. Ed evidenziazione dei numeri della Mostra che testimoniano un interesse sempre maggiore di pubblico , giornalisti ed operatori culturali.
LA XXIV EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE di Paolo Micalizzi
Resoconto su di un Festival che quest’anno ha reso omaggio ad autori un po’ dimenticati ma meritevoli di essere ricordati come Nico Cirasola e Gianni Minà, ha proiettato in anteprima, alla presenza di registi ed attori, sei film di interesse per le sale cinematografiche. Menzione dei Premi assegnati. Eventi collaterali.
“O CORNO” CONCHIGLIA D’ORO DEL 71° FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN di Alessandra Pighi, Xoxan Villanueva
Trionfo storico per la regista nata a San Sebastiàn, Jaione Camborda, che con “O Corno” è diventata la prima regista spagnola a vincere la Conchiglia d’Oro per il Miglior Film. I due Premi Donostia sono stati assegnati al regista giapponese Hayao Miyazaki, uno dei grandi del cinema d’animazione mondiale, e al regista spagnolo, Victor Erice.
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre
“FILM WITH THREE DANCERS” di Roberto Baldassarre
Come in “Bleu Shut”, opera analizzata nel numero 29, anche “Film with Three Dancers” è un cortometraggio che fa largo uso della sperimentazione. Il movimento del cinema cristallizza il movimento della danza.
OCCHIO CRITICO
“AMUSIA” di Paola Brunetta
“Amusia”, primo lungometraggio di Marescotti Ruspoli, è un’opera singolare: fredda, geometrica, lineare ma anche calda e irregolare e spiazzante. Al centro del racconto c’è la patologia del titolo, che rende biologicamente incapaci di decodificare la musica; ma ci sono anche due ragazzi e la loro voglia di conoscersi che diventa qualcosa di diverso, e di più importante; e l’originalità di un’opera prima decisamente matura, che lavora sul visivo (gli spazi, i paesaggi…) per parlare dell’uditivo e per compensarlo.
LA TONALITA’ DI “IO CAPITANO” di Tullio Masoni
Il tono, il colore, e la sensibilità antropologica che rinviano a “Lettere dal Sahara” di Vittorio De Seta. Realtà in forma fiabesca nel solco di una tradizione letteraria antica.
“IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI di Tullio Masoni
La memoria del ’56 ungherese e il sogno che scelte diverse nel PCI avrebbero liberato energie migliori per il cambiamento. Un film che ha suscitato prevedibili polemiche, dividendo fra loro anche gli ammiratori di Moretti.
TRANSILVANIA: “ANIMALI SELVATICI” DI CRISTIAN MUNGÌU di Paolo Vecchi
In Transilvania convivono rumeni, ungheresi e tedeschi. A questo coacervo di etnìe e lingue si aggiungono gli immigrati di pelle nera, verso i quali il protagonista finisce per dimostrarsi intollerante, lui che in Germania era stato a sua volta discriminato. Mettendo in scena il magma che si nasconde nelle intercapedini delle tradizioni di ciascun popolo, “Animali selvatici” affronta dietro il paravento della metafora il tema attualissimo della difficile integrazione europea degli stati un tempo nell’orbita dell’ex impero sovietico.
“EL CONDE” DI PABLO LARRAÌN di Paolo Vecchi
“El Conde” parte da un’idea molto originale, che offre una lettura in chiave horror della politica, capovolgendo cioè la vettorialità di quella teorizzata da Kracauer nel classico “Da Caligari a Hitler”. Attua inoltre una contaminazione tra mitologia, letteratura e cinema di matrice europea – Vlad Dracul, Stoker e il romanzo gotico, Murnau e le produzioni Hammer – con la figura dell’autocrate mediocre e triste che appartiene a tanti scrittori di lingua ispanica, da Ramòn del Valle Inclàn a Gabriel Garcia Marquez.
IL BLU DEL CAFTANO di Marco Incerti Zambelli
Maryam Touzani conferma con il suo secondo film, premiato a Cannes e candidato all’Oscar, “Il caftano blu” il talento nel narrare le contraddizioni del Marocco, imbastendo una vicenda straordinariamente tenera e dignitosa.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
VIVERE DENTRO UN PARADOSSO di Marcello Cella
Il documentario “Kosovo vs Kosovo” di Valeria Bassan e Andrea Legni racconta cosa vuol dire vivere dentro un’enclave, costruzione artificiale e tragicomica nata all’interno di uno dei tanti paradossi nazionalisti che si vanno espandendo in Europa. All’origine del nuovo romanzo della scrittrice di origine bosniaca Elvira Mujčić, La buona condotta.
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
Storie scellerate, Cinema di Sergio Citti di Roberto Baldassarre; Nino Martoglio. Il moschettiere del cinema di Franco La Magna; Giovanni Verga e il “Castigo di Dio” di Franco La Magna; Alida Valli, da Pola a Hollywood e oltre a cura di Alessandro Cuk.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
L’AMORE AI TEMPI DEL NOIR “Unlucky to love you”,
il nuovo film di Mauro John Capece
di Marcello Cella
Un uomo solitario ricorda la sua vita stropicciata, il suo amore sfortunato per la bella ballerina Chantal, il suo errore fatale nell’essere caduto nella tela di ragno di una affascinante dark lady, Lucrezia, il rimorso che lo insegue per un crimine mai commesso, sulle arie di un nostalgico blues dall’evocativo titolo di “Maybe”, “forse”, in compagnia di una bottiglia di whisky, delle sue cuffie da dj, di un soprammobile a forma di scheletro umano e di un ramarro, mentre fuori dalla finestra infuria un temporale notturno che non preannuncia niente di buono. Questi sono gli ingredienti così materici, evocativi e spirituali al tempo stesso del nuovo film di Mauro John Capece, “Unlucky to love you”, un noir che ripercorre consapevolmente gli schemi narrativi e lo stile dei grandi film noir americani degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo corso, quelli, per intenderci, come i film di un regista marginale e da culto come Edgar G. Ulmer, a cui il film è dedicato, B Movie girati con pochi mezzi, ma così densi di significati esistenziali e spesso anche sociali, seppur in modo non direttamente percepibile dagli spettatori dell’epoca. Un cinema fatto di ombre, di personaggi ambigui, di luoghi mai perfettamente illuminati dove bene e male, vita e morte si incrociano senza che l’uno prevalga mai totalmente sull’altro, persi in un dilemma morale perturbante per gli spettatori. Un cinema fatto nei bassifondi di Hollywood che evita gli happy end tipici di quel cinema industriale per lasciare gli spettatori in balia di dubbi e domande senza risposta, di riflessioni sul senso del vivere che gli umani forse si portano dietro da sempre. I registi dei classici film noir non rassicurano mai gli spettatori (e spesso nemmeno i produttori), si immergono nei luoghi meno frequentati dalla narrazione mainstream per sporcarsi le mani con la sofferenza, il dolore, le delusioni, le illusioni perdute, il crimine, il male di cui è fatta l’altra faccia dell’essere umano senza diventare mai un cinema pedissequamente realistico o di denuncia tout court. Forse anche per questo posizionarsi fra gli interstizi meno conosciuti della vita, il noir è stato schematicamente collocato alternativamente dal punto di vista ideologico a destra o a sinistra. Troppo sfuggente, il cinema noir racconta le sue storie senza farne l’emblema di una visione chiara e strutturata della vita. Le storie del cinema noir possono essere interpretate in molti modi diversi, si prestano a letture ondivaghe e mai definitive. La vita dei suoi personaggi è come ci suggerisce la superficie delle storie che racconta oppure no? Potrebbe essere diversa? Maybe. Forse.
Anche Mauro John Capece, con “Unlucky to love you”, si inserisce consapevolmente in questo genere, interpretandolo però secondo il suo stile, senza perdere nulla della sua creatività di regista più propenso ad un “cinema della riflessione” che ad un “cinema della sensazione”. E sicuramente “Unlucky to love you” continua il percorso della sua ricerca narrativa e stilistica, assistito da un nutrito “clan” di collaboratori in perfetta sintonia con la ricerca filmica del regista abruzzese. A cominciare dalla bellezza ambigua e dalle molte sfumature di una attrice come Corinna Coroneo, autrice anche del soggetto e della sceneggiatura, da sempre musa ispiratrice e presenza insostituibile nell’universo poetico di Capece, così ricco di ambiguità e deragliamenti narrativi a cui Corinna sa dare corpo e anima come pochi. Inoltre Capece non è nuovo a questo lavoro di ricerca sui generi, perché nella sua filmografia sono ben presenti riferimenti a generi come l’horror, il thriller o i film di denuncia sociale, ma sempre reinterpretati secondo la personalissima visione del regista che mai si limita ad imitare gli stili e le strutture narrative dei generi a cui di volta in volta fa riferimento. Spesso anche all’interno dello stesso film. E “Unlucky to love you” non fa eccezione. Soprattutto quando sceglie di spostarsi a lato della narrazione principale, con due intermezzi, un epilogo ed un prologo, che raccontano la vita tormentata di alcuni personaggi non proprio centrali nell’economia narrativa del film, come la ballerina Chantal, il maggiordomo e la governante della villa dove vivono la misteriosa dark lady Lucrezia ed il suo consorte, lo stimatissimo e ordinatissimo dr. Ricciardi. Inutile dire che, come da copione, l’arruffato dj Russell, persa la sua musa Chantal, partita alla rincorsa di impossibili sogni di successo a Londra, finirà nella perfida tela di ragno ordita dalla affascinante Lucrezia, anche lui all’affannoso inseguimento di una seconda chance, morale, sentimentale e materiale dall’esito infausto. A differenza però dello stile del noir classico a cui fa riferimento il regista abruzzese, l’ambiguità morale del suo film non si esplica in un gioco di luci e ombre espressioniste in cui la visione delle cose che sembrava chiara all’inizio del film si complica sempre più con l’andare del tempo, ma nell’esatto contrario, in un eccesso di luci, in una simmetria innaturale delle immagini, in superfici che appaiono indecifrabili proprio a causa in un eccesso di luminosità che cancella le ombre e ne rende indistinguibili i contorni. Come nei film precedenti di Capece, gli spazi vuoti in cui si muovono i personaggi, la loro simmetria inquietante, accentuano il senso della loro solitudine e della sconfitta delle loro aspettative esistenziali. E’ come se continuamente i personaggi di Capece ripercorressero le loro vite e si chiedessero: come avrebbe potuto essere la mia vita se gli eventi che mi hanno coinvolto avessero assunto un significato diverso? Sarebbe stata diversa? Maybe. Forse.
INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPACE a cura
di Marcello Cella
Come è nato il progetto di “Unlucky to love you”?
E’ nato da un’analisi che abbiamo fatto in America dove i nostri film sono sempre molto visti. Abbiamo pensato quindi di girare un film in inglese prendendo il noir come genere, l’indie noir nello specifico che è un genere che si è sviluppato in America negli anni Quaranta-Cinquanta ed era prevalentemente fatto da registi disperati che in buona sostanza per sbarcare il lunario facevano cinque o sei film all’anno. Quindi mi piaceva molto questo parallelismo con i disperati americani degli anni Quaranta-Cinquanta con un analogo personaggio italio-americano. Ho voluto fare un film stile Edgar G. Ulmer e ho chiesto una sceneggiatura di questo tipo. Il film è partito così. Abbiamo trovato una produzione americana che ci appoggiava ed è partito il progetto.
Quindi nella storia del dj Russell è possibile vedere in filigrana anche la vicenda umana di questi registi che spesso hanno vissuto e sono morti in povertà?
Assolutamente si. Lui è solo e intrappolato così come questi tecnici, attrezzisti come Ulmer o scenografi o altro, che si sono trovati intrappolati in America, stranieri che vivevano lì. Allo stesso modo Russell è intrappolato nella sua vita in Italia e non può tornare in America perché non ha i soldi.
Uno degli elementi che rendono molto suggestivo questo film è la musica, con questo blues, questo jazz che accompagna la triste storia del dj…
Nel mio cinema la musica è importantissima. Spesso molti pezzi vengono realizzati prima delle riprese perché danno il mood. Per esempio, in questo caso avevamo dei pezzi che stavano sul balletto ed erano stati realizzati prima. Poi una parte delle musiche sono originali americani degli anni Trenta e un’altra parte è stata composta appositamente per il film. Quindi Gianluigi Antonelli ha composto delle musiche con delle tonalità relativamente più contemporanee. Mentre India Czajkowska ha fatto delle parti orchestrali e questa fusione è stata bellissima perché da una parte ci sono le musiche originali di quegli anni, dall’altra una composizione più orchestrale, e poi una composizione un po’ più contemporanea.
Le musiche spesso sembrano caratterizzare anche i personaggi. Nel senso che quando c’è in scena il dj lo accompagna sempre questa musica blues un po’ nostalgica, mentre ricordo che la prima volta in cui Lucrezia va al locale da sola, in auto ascolta una specie di pop dance elettronico.
Esatto. Questo sottolinea il contrasto che c’è all’interno del mondo del locale “I love you”, dove si fanno le stesse cose che si facevano in quel tipo di locali negli anni Quaranta, quindi jazz, ballerina introdotta da un presentatore e socialità. L’intento era quello di creare un luogo magico, un po’ fuori dal tempo. Poi quando Chantal va via sfiorisce. Mentre Lucrezia ascolta della musica normalissima, radiofonica, contemporanea.
Un altro elemento che rende suggestivo il tuo film è il riferimento visivo ai generi pittorici di quegli anni, mi viene sempre in mente l’opera di Edward Hopper…
Volevo creare sicuramente una fotografia molto pulita, da un lato espressionista, con ombre pesanti, ecc., dall’altro molto simmetrica. Io non amo essere trascurato dal punto di vista fotografico e in questo caso ho utilizzato delle ottiche vintage lentis che potrebbero risalire orientativamente a quel periodo per avere un’immagine un po’ vintage e non volevo il “vissuto” in questo film. Volevo creare un’immagine come i film dell’epoca, in cui gli ambienti sembravano un po’ finti, dei set. Perciò ho trovato a Nardò una location che aveva quel tipo di caratteristiche, una villa che non era molto sfarzosa ma molto bella a livello estetico…
…in effetti ricorda molto certe case vittoriane dei quadri di Edward Hopper…Un’altra cosa che risalta sempre in questo come negli altri tuoi film è il ruolo del denaro…
Il denaro nella società contemporanea…c’è sicuramente una critica velata al “compra tutto”, ma nello stesso tempo il “compra tutto” non può comprare l’arte che non si prostituisce. Perché se l’arte è pura non può essere acquistata dal denaro. Nei miei film ci sono spesso dei soggetti che si prostituiscono a livello artistico o decidono di non farlo. Il denaro è un anello di congiunzione. Quindi ho mandato Chantal, come da sceneggiatura di Corinna Coroneo, a prostituirsi all’estero, con la promessa di un lavoro, alla Royal Albert Hall di Londra, e, allo stesso modo, Russell sta lavorando in un piccolo club ma stenta. Poi Russell decide di essere complice in un crimine appunto per denaro. E quindi il denaro è un elemento importante…che rende le nostre vite più infelici fondamentalmente. Vivremmo tutti meglio senza denaro, questo è poco ma sicuro…
Un’altra cosa di cui vorrei che mi parlassi sono le figure femminili. In questo film ce ne sono tre con caratteristiche completamente diverse. Ma anche negli altri tuoi film esse sono presenze forti, ma ambigue nello stesso tempo. Cosa ci puoi dire in proposito?
Si, nel film ci sono tre figure femminili. C’è Lucrezia, interpretata da Corinna Coroneo, che è una donna che si presenta come fragile e abusata e in realtà è una persona machiavellica e malvagia. E chiaramente mi piace molto vedere Corinna in questi ruoli un po’ complessi, in cui c’è uno switch perché lei è anche brava nel rappresentarli, nel renderli palesi al pubblico. Poi c’è Chantal che è un bellissimo personaggio, costretta ad andarsene all’estero e si ritrova dopo molti anni prostituta e ancora innamorata di Russell. E questa è la fine che fanno gli artisti oggi, che partono con i migliori principi e poi finiscono per andare a fare un lavoro qualsiasi. Quando l’arte dovrebbe essere il lavoro più bello del mondo. E poi c’è un personaggio che mi piace molto, che è quello della governante, una finta sordomuta, una homeless che per opportunismo decide di rimanere lì. Anche Mara D’Alessandro ha fatto una bellissima performance secondo me.
Parlando dei tuoi personaggi mi viene in mente il tema del doppio. Addirittura qui c’è un personaggio che ha due ruoli all’interno del film…
Sicuramente Randall è un attore che mi piace molto e io non riesco a lavorare con attori che non mi piacciono, sotto ogni punto di vista. Nel senso che un attore mi deve piacere come persona, per come recita, fisicamente. E la bellezza non è necessariamente perfezione perché tutto può essere bello e cinematografico in un film. Lui era molto giusto come personaggio e gli ho dato la possibilità di fare quello che gli sarebbe piaciuto fare, e cioè interpretare due ruoli. La sceneggiatura lo prevedeva e quindi è stato molto interessante e sfidante lavorare con lo stesso attore nella stessa stanza. E’ regia pura quando succedono queste cose, quindi è bello. Per un attore è una cosa sempre molto sfidante fare due ruoli in un film, e quindi ci ho voluto provare. Penso che sia abbastanza riuscito. E’ stato bravo Randall Paul a fare tutte e due le cose. Però era bello vedere queste due figure completamente diverse, uno ricco e l’altro povero, uno artista e l’altro dottore.
Fra parentesi mi incuriosisce anche come scegli i tuoi attori, nel senso che, a parte Corinna Coroneo, spesso nella vita quotidiana fanno tutt’altro, come Fiorella Franco, o non hanno fatto solo gli attori, come Randal Paul…
E’ vero, non sono sempre attori di professione anche se una base di attori di professione ce la metto sempre perché è fondamentale. E mi piace lavorare sempre con le stesse persone per creare un piccolo universo, per prima cosa perché sai cosa aspettarti ed essendo il lavoro di produzione spesso difficile, in questo modo diventa più fluido. E poi mi piace lavorare sempre con le stesse persone perché, piccola nota polemica, me lo posso permettere, almeno finché il mio cinema rimane puro, perché faccio le cose che voglio fare. Nel momento in cui dipendi da un broadcaster o dal mercato non puoi scegliere nessun attore. Quindi è bello poter lavorare con le stesse persone. E’ un regalo che faccio a loro e che loro fanno a me dandomi tanta fiducia.
A proposito di indipendenza, tu puoi essere considerato un regista indipendente. Ma cosa significa, oggi, per te, essere un restare indipendente?
Teoricamente indipendenza in questo settore vuol dire non dipendere da un broadcaster. Quindi in Italia questo significa non dipendere dalla RAI o da Netflix, non avere i loro contributi in produzione. Quindi tutte le produzioni che non hanno un contributo da loro sono considerate indipendenti. Ma nel mio caso io sto cercando di fare un cinema libero, libero anche nei contenuti. Sto cercando di portare avanti un discorso che mi ha portato, dopo la trilogia della riflessione alla trilogia della sensazione, ma voglio essere libero nel fare questa trilogia. In mezzo non ci voglio mettere un film che non c’entra niente con questa cosa e questa è una scelta che non sempre ti puoi permettere. Di sicuro non potrò farlo in eterno, ma io spero di poterlo fare anche in seguito… Per come si delinea il cinema nel mondo, c’è sempre meno libertà. E’ chiaro che stiamo vedendo tutti i film uguali, tutti politicamente corretti, che vanno tutti in una stessa direzione. Tutto funziona per mode. Tutto questo non rende gli artisti più liberi. E’ improbabile oggi che nasca un Tarkovskj o un Truffaut. E’ difficile essere un autore oggi.
Ho notato che spesso nei tuoi film giochi spesso con i generi. C’è l’horror, il thriller, il noir in questo caso, ma spesso anche all’interno dello stesso film tu cambi registro e genere di riferimento. Per esempio, rimanendo ad “Unlucky to love you”, ci sono delle situazioni che possono essere ricondotte all’horror o al gotico, all’interno di un film che è dichiaratamente noir…
Mi piace molto giocare con i generi, perché è vero che mi piacciono i film d’autore, i film liberi, ma amo molto anche i generi. In questo caso ho voluto cimentarmi con il noir e quindi dovevo essere un po’ specifico. Per cui abbiamo lavorato utilizzando l’attrezzatura dell’epoca, carrelli, movimenti di macchina, tagli di inquadratura perché c’era questa ostruzione che mi ero imposto affrontando il genere noir. E chiaramente questo condizionamento c’era soprattutto con quei personaggi un po’ gotici che richiedevano una fotografia un po’ espressionista, anche con uno stile di recitazione che, essendo un omaggio, può apparire anche un po’ ingenua, non sbagliata. Era così in quell’epoca ed io ho cercato quindi di far recitare gli attori secondo quello stile. Non serviva una recitazione troppo sofisticata per questo tipo di film. E’ interessante anche per il pubblico che non sa mai cosa aspettarsi. Anch’io quando vedo un film mi piace sperimentare questa condizione. Magari prima mi annoio, poi il film accelera, riparte. Il film non deve essere statico, deve essere materia dinamica.

Una cosa meno evidente nel tuo cinema è l’ironia. Spesso i tuoi personaggi fanno emergere questo elemento psicologico anche all’interno delle situazioni più drammatiche…
Si, in certi casi mi piace caricare molto i personaggi. Di solito cerco di rendere più fluidi i protagonisti e poi cerco di dare colore al film con l’antagonista e con i personaggi dei ruoli secondari. E’ una cosa che mi piace molto fare e che ritrovo spesso anche nelle graphic novel, nei fumetti di una certa epoca storica. In questo caso mi sono divertito molto con i personaggi nel prologo e nell’epilogo, che non erano i personaggi principali del film e li ho coloriti un bel po’. Anche la fine che fa Chantal che si ritrova sola a bere, senza parrucca, a pensare al suo amore che se n’è andato via è drammatico, ma, se vogliamo, allo stesso tempo ironico…
…anche l’immagine di lei con il cliente, dopo la consumazione del sesso, con quell’immagine fissa che li ritrae silenti mi ha ricordato certe inquadrature di Kaurismaki in cui i personaggi pur nella loro immobilità risultano un po’ ridicoli…
…oppure i fagioli e il peto del maggiordomo…Erano due storie completamente svincolate anche dalla narrazione tradizionale del film…
C’è sempre una specie di lotta di classe nei tuoi film…
Assolutamente si. Anche prima quando hai accennato all’elemento dei soldi, quando faccio vedere il passato dei personaggi e il futuro di Chantal sono molto diretto. In questo film non potevo essere politicamente molto scorretto perché i film noir degli anni Trenta-Quaranta erano ingenui quindi dovevo rispettarne un po’ lo stile per cui solo traslatamene potevo mandare dei messaggi d’autore. Mentre negli intermezzi ho spinto di più in questo senso. Quindi negli intermezzi in cui c’è il passato del maggiordomo e della governante, in cui loro vengono presi a lavorare per soldi quando erano degli homeless e quello in cui c’è il futuro di Chantal che non è riuscita a fare successo a Londra ed è diventata una prostituta da strada. E lì c’è una citazione molto chiara a “La scultura”, perché ho girato nelle stesse location. Era una cosa voluta anche se non si nota a un primo sguardo.
A proposito di personaggi che usano la propria creatività per rapportarsi al mondo, qui c’è un dj che ha questo rapporto dialettico fra creatività e realtà che si trova spesso nei tuoi personaggi.
Anche qui c’è un personaggio che vive di creatività e pertanto non ha accumulato la giusta somma di denaro per poter decidere il proprio futuro. Mi piace molto questo tema molto politico, dell’arte manipolata, dell’arte comprata, dell’arte usata. Si, è un tema che mi piace.
Un altro tema importante è quello della seduzione che compare spesso anche negli altri tuoi film ed emerge anche in modo drammatico…
Si, è vero. Ci sono spesso delle donne, delle femmes fatale, delle situazioni in cui c’è una sensualità, ci tengo molto…in questo caso ero molto censurato dal tema. Perché se andiamo a vedere i noir la donna è sempre variamente idealizzata. Il protagonista è sempre un uomo. Non ci sono noir in cui la donna è protagonista, parlo degli indie noir. Non potevo scendere su un piano troppo erotico. Però si tratta di donne appassionanti, particolari.
In questo film c’è, come spesso nel tuo cinema, una dialettica fra verità e menzogna che è un tema molto attuale, ma rimanda anche ad un tema classico dei noir che giocavano molto su questa ambiguità diventando indirettamente anche politici in quanto critici di un certo stile di vita e di un certo modo di vedere le cose…
Sicuramente anche qui i temi di fondo sono sempre quelli. I soldi, come hai detto tu, sono centrali e a volte indirizzano i personaggi verso scelte di vita sbagliate, il fatto che gli amori vengono distrutti dai soldi o che la creatività viene distrutta da questo meccanismo è emblematico. Quindi da un lato i soldi sono necessari e dall’altro sono il motivo per cui compiamo scelte sbagliate. Questo film è meno politico degli altri perché avevo un condizionamento importante, quello di dover fare un film noir, classico, il secondo della mia trilogia della sensazione, e poi anche la piattaforma a cui era destinato, Amazon Prime, comportava una sorta di censura artistica, che poi tutti gli artisti stanno subendo.
Quanto pesa il condizionamento delle piattaforme?
Sicuramente oggi ci sono tanti problemi nel produrre perché i film devono essere tutti politicamente corretti secondo determinate situazioni. Ci sono le pari opportunità, le categorie protette, ecc…. dobbiamo essere attenti a molte cose per cui la libertà degli artisti subisce una limitazione. Ma non ce ne sarebbe nemmeno al cinema per come è strutturato il cinema oggi. Tu pensa che oggi i film di Bergman sicuramente non uscirebbero nelle sale.
Dal punto di vista distributivo che percorso seguirà questo film?
Questo film uscirà sicuramente nelle sale e nelle piattaforme tv canadesi. Poi, per quando riguarda il resto del mondo, a parte i festival in cui è già stato in parte presentato, in Italia e negli USA uscirà su Amazon Prime Video.
Come mai i canadesi?
In Canada il film ha potuto fare un accordo molto favorevole per cui potrà uscire anche nelle sale. Poi, essendo un film girato in lingua inglese, sicuramente potrà essere facilmente visto nei paesi anglofoni.
Come tutti i noir, anche il tuo film finisce un po’ tragicamente, gli amori in qualche modo falliscono. Qual è la tua concezione dell’amore che esce da questo come dagli altri tuoi film?
Nei miei film tende ad essere un elemento positivo, ma non troppo, sinceramente. L’amore è il motore del mondo. Anch’io ho fatto delle scelte per amore e queste scelte spesso non sono andate per il verso giusto come sempre capita. Sul finale c’è questa sensazione…sto un po’ soffrendo in questa trilogia della sensazione, per la verità, perché io amo un cinema libero, come avrai certamente capito. Però nel finale di questo film ho messo una riflessione che fa il protagonista, Russell, che secondo me è molto interessante, quando lui dice alla fine che non gliene frega niente di niente, quando lo arrestano. E’ una cosa un po’ anti-sistema…
Un magnifico perdente…
…esatto, un perdente consapevole…
Che tipo di lavoro hai fatto con gli attori, in particolare con Randall Paul, perché lui fa due ruoli completamente diversi…
Si, inizialmente c’era questa cosa del parrucchino. Anche questo deriva un po’ dai film noir che erano un po’ ingenui e non c’era una verosimiglianza pazzesca. Quindi la mia scelta è stata quella di fare un parrucchino un po’ alla cantante rock. Anche sul look abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto molti acquisti, molte prove sul look di questi due personaggi che dovevano essere molto diversi, anche se uno, quello del dottore, lo conosciamo pochissimo perché in realtà sappiamo di lui delle cose false, che era un marito cattivo. Sicuramente era una persona superprecisa però diciamo che per il dottore Ricciardi abbiamo lasciato il look normale di Randall Paul, mentre sull’altro abbiamo giocato.
Quanto si rispecchiano i due personaggi del dj e di Lucrezia secondo te?
In parte i due sono simili perché tutti e due in fondo vogliono la stessa cosa, però il livello di perversione è diverso. Chiaramente Lucrezia è più doppia di Russell. Russell è più ingenuo. Quindi fondamentalmente ci casca. Come in tutti i noir, quelli con Humphrey Bogart per esempio, tutti i personaggi fanno un errore. L’errore è una cosa tipica dei noir…
la dark lady…
…si, esattamente…
Il noir lavora molto sul contrasto fra luci e ombre, che poi è la l’immagine di un contrasto morale, mentre tu lavori invece molto sulle superfici, sull’eccesso di luce, quindi fai un’operazione un po’ diversa…
Nel noir l’ombra si vede, è in campo. La fotografia è un po’ espressionista e mi piace molto e la sceglierei indipendentemente dal genere. Per me l’espressionismo come idea di fotografia è molto interessante, uno stile che è nato con l’uso delle luci artificiali sul set. Così è nata l’ombra. E l’ombra può essere molto narrativa. Però la mia fotografia è qualcos’altro. Nel senso che mi piace molto anche padroneggiare l’uso delle superfici, del colore, degli ambienti. Per cui è sicuramente molto diversa. Volevo anche rimanere fedele al mio stile utilizzando le immagini che ho sempre fatto.
Dal punto di vista della scrittura, la sceneggiatura è molto dettagliata o è qualcosa che si modifica come work in progress?
Era molto dettagliata. avevo chiesto a Corinna Coroneo di scrivere un noir tipico con la dark lady, il crimine, l’uomo deluso da una donna che l’ha tradito. E così è nato “Unlucky to love you”. Poi però cosa succedeva? Che il noir durava 64 minuti e con quella durata non poteva essere distribuito come film. A questo punto c’è stata un’idea che ha cambiato molto il film, in meglio secondo me, che è stata quella di aggiungere un prologo e un epilogo focalizzati su due personaggi che non sono centrali nella storia. Sono due cortometraggi di riflessione all’interno di un film che ha una narrazione moto lineare e ben precisa.
Tu usi spesso questi intermezzi nei tuoi film. Che significato hanno all’interno del tuo modo di raccontare?
L’intermezzo mi piace molto perché prima di tutto rilassa lo spettatore. Noi sappiamo che tutti i film soffrono in genere nel periodo compreso fra l’ora e l’ora e mezzo. E non a caso spesso nei cinema ci mettono l’intervallo così ti vendono anche i pop corn. La mia idea è nata proprio quando i miei film dovevano uscire al cinema e nel momento dell’intervallo c’era l’intermezzo. Mi piace molto questa idea perché in questo modo lo spettatore può respirare e ripartire con il film dopo un attimo di riflessione. Quindi mi piace staccare un po’ dalla narrazione, anche per far sedimentare la storia e anche per far tenere alta l’attenzione, perché sono conscio del fatto che i miei film non sono film ultraavvincenti, che comunque non sono quello che voglio fare. Appunto perché sono film di riflessione hanno bisogno di uscire un po’ per poi rientrare. E’ una mia idea…
-…in fondo danno la possibilità di un’ulteriore momento di riflessione all’interno della storia…Un altro elemento importante che ho notato nei tuoi film è il tema della sofferenza, una sorta di piacere della malinconia, della nostalgia…
…un’opera di riflessione non può che essere malinconica. Del resto il publico che mi sono scelto è quello che adora un certo tipo di cinema…e poi nella vita si può ridere, essere gioviali, ecc. ecc. però l’unica certezza che abbiamo nella vita è che dobbiamo morire. Quindi anche io come persona sono cosciente che la vita non è gioia, assolutamente, anzi. E’ una condizione di grandissimo dubbio…questa cosa merita una riflessione abbastanza accorata. C’è chi lo fa con le religioni, c’è chi lo sublima con la filosofia e chi usa l’arte per esorcizzare questo dramma che abbiamo…
Quanto hanno in fluito le location nell’economia della narrazione, elemento anche questo molto importante nei tuoi film? Anche perché “Unlucky to love you” sembra un film girato in America, mentre invece è girato tutto in Italia…
Questo film è ambientato tutto nel basso Abruzzo e in Salento ed è molto importante. La scelta che faccio delle location è sempre molto accurata, faccio sempre molta pre-produzione. In questo caso ho trovato questa villa che è Villa Nucci a Nardò che mi piaceva molto perché non volevo una cosa troppo antica che poi non sarebbe stata coerente con il noir, perché gli indie noir non si potevano permettere le location di “Barry Lyndon”. Per questo giravano molto in luoghi “bassi” come bar, motel, ecc. Quindi ho voluto cercare una villa bella ma senza esagerare troppo. Invece per quanto riguarda il locale ho cercato un locale stile anni Quaranta-Cinquanta dove c’erano esibizioni dal vivo, di jazz soprattutto, e lo abbiamo trovato a Chieti. Le location sono sempre importantissime e spesso sono troppo trascurate in Italia…Odio quando gli scenografi mi dicono “facciamo una scenografia vissuta” e cominciano a buttare cose in giro…No, non è così che mi piace. L’ordine è fondamentale.
Ci puoi raccontare cosa stai facendo per quanto riguarda i tuoi progetti futuri?
Si, in questo periodo sono al montaggio di un film molto bello che sarà un ponte fra la sensazione e la riflessione. Un film di sensazione in cui però si torna a riflettere su cose serie. Ci lavoreranno degli attori che sono anche in “Unlucky to love you”. Un film impegnativo perché ci abbiamo lavorato 45 giorni, un film denso. L’abbiamo girato in Italia con un titolo provvisorio che non ti dico perché non è definitivo. L’abbiamo iniziato durante il covid e l’abbiamo finito qualche mese fa e ora è in montaggio. Un film molto bello perché con questa cosa che dopo il covid c’era la ripartenza, questa energia, tutti allora hanno dato il massimo, dai tecnici agli attori…
-…C’è ancora Corinna Coroneo, presenza immancabile, inquietante…
…Si, certo…Anche Truffaut lavorava spesso con gli stessi attori, Anche per me è così. Spero che in futuro si capirà che anch’io cerco di creare un mio piccolo universo dove tutti fanno cose diverse…
ZURLINI ULTIMO IN DVD “IL DESERTO DEI TARTARI”
di Tullio Masoni

Ricordando Bruno Fantuzzi,
che mi raccomandò la memorabile
interpretazione di Vittorio Gassman.
Rivisto nel piccolo schermo “Il deserto dei tartar”i di Valerio Zurlini (1976) mi pare soffra meno di altri. Film di spazi panoramici per eccellenza, mantiene infatti un fascino antico grazie alla fotografia di Luciano Tovoli, alle scelte di paesaggio compiute dal regista e da Jacques Perrin, e ai tempi narrativi di sapiente e alterna scansione: «…Movimento morbido – ha scritto Paolo Vecchi – spesso circolare o ellittico, a cui talvolta si coniugano lo stacco improvviso, la successione frastagliata di inquadrature perfette nella loro fissità, l’elasticità dei controcampi, l’azione concepita secondo un personale rispetto delle regole stabilite dai maestri del cinema classico americano…».
Il caso, le improvvise emergenze e gli “errori” hanno talvolta, in arte, un esito miracoloso. Per il finale del Deserto Zurlini avrebbe voluto rispettare alla lettera il testo del romanzo di Buzzati: «La mia intenzione era di realizzare un finale estremamente fedele al libro (…) Non è stato possibile perché per finire il film abbiamo dovuto pagarci da soli le spese di viaggio (…) E’ davvero per mancanza di mezzi che non abbiamo potuto girare un finale conforme al libro e seguire quello previsto da Brunelin (co-sceneggiatore con Jean-Louis Bertuccelli, ndr)…».
Ebbene, il finale “costretto” mi sembra abbia la sintesi sospesa che forse la fedeltà al testo non avrebbe consentito: arrivano i tartari scollinando e, nello stesso momento il sottotenente Drogo è portato via in carrozza.
Non vale perdersi nei confronti tra film e romanzo ma, riguardo a Buzzati e Zurlini, vorrei riprendere un giudizio di Paolo Mereghetti: «…Lunga e scolastica versione del romanzo omonimo di Dino Buzzati, appesantita da episodi e personaggi assenti nel libro. Più televisivo che kafkiano.» Episodi e personaggi assenti nel libro? E allora? Più televisivo che kafkiano? Sul televisivo non mi soffermo, quanto al kafkiano – termine accostato allo scrittore dalla critica e da certo senso comune fino all’esasperazione – mi sembra che Zurlini avesse in mente altro, e altro abbia fatto.
“Il deserto dei tartari” credo definisca un meccanismo assurdo sulla base di due elementi: la disciplina militare e gli attori. La disciplina serve al regista per scolpire l’azione e, nel contempo, rivelare il vuoto, gli attori – titolati e al loro meglio – per trarre dal vuoto stesso una resistenza di umanità.
La critica, è naturale, vive per fasi e talvolta, anche la più intelligente e attendibile, ubbidisce a proprie convenzioni. Per un ampio periodo Zurlini è stato vissuto come autore forse abile ma secondario, cioè subalterno alla letteratura (come Bolognini?) e al limite della calligrafia. Basti ricordare che Goffredo Fofi, un critico-maestro imprescindibile per molti di noi, in un suo pamphlet dei primi anni settanta lo aveva collocato fra gli autori italiani cattolici. Cristiano-laico, se vale l’ossimoro, e sicuro ammiratore di Giovanni XXIII, ma cattolico…
Tornando al Deserto piuttosto che a un Kafka di (presunta) seconda mano credo che Zurlini abbia tratto dalla lettura di Buzzati l’intento di guardare al Destino. Che è assurdo in quanto tale e tuttavia accompagnato dall’originale finitezza degli uomini. Nel film di Zurlini gli attori, con le loro pose, stabiliscono una presenza umana accomunata dalla disciplina e al medesimo tempo variegata dalla fenomenologia dei singoli. Più che l’assurdo di Kafka, mi sembra, Zurlini propone un vuoto di perdente consapevolezza e attesa; quello degli eredi esistenzialisti, di Camus, in particolare. Ogni attore, quindi, è inseparabile dalla compagnia ma, offrendo il meglio di sé, accede agli obblighi del Destino attraverso la personale e professionale libertà del personaggio. Non rinuncia, infine, a una propria limitata, romantico-crepuscolare cognizione del limite; quella che di fronte a una inevitabile sconfitta promuove l’uomo, fin quando è vivo nel mondo, e la sua disperata dignità.

SUSPENSE ED ESTETICA: IL “NEW HORROR” DI JOHN CARPENTER
di Roberto Lasagna

John Carpenter è un cineasta portatore di una visione che, in non pochi episodi della sua filmografia, aspira a ribadire la torbida e stoica sopravvivenza di individui tenuti al margine del sistema, ma inevitabilmente carichi di un disincanto che ne lascia intendere la singolare politicità. Una condizione costretta a confrontarsi con scenari di collasso dei diritti, con le magagne e le grandi contraddizioni di un’America dal volto ingannatore. Gli anti-eroi di Carpenter devono sopravvivere, fuggono ai fantasmi che ritornano pretendendo vendetta, e in una simile contesa si aprono nuovi immaginari, considerando che, in primo luogo, non esistono più quegli spazi cinematografici che i grandi western amatissimi dal regista sin dalla giovinezza disegnavano (all’insegna di un eroismo oggi inattuale), illustrando molto bene le fondamenta della storia e della mitologia americana. I personaggi dei suoi film sono quindi portati o costretti a calcare altri spazi, sovente quelli impietosamente reali o mentali della fuga, e lo stesso Carpenter è un regista appartato che ritorna sui suoi passi, sui suoi ambienti, dando intensità a scenari ammantati di sinistre avvisaglie, tramite un’inesausta variazione di motivi in grado di dare corpo a una filmografia che, mentre omaggia i cineasti prediletti (Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Raoul Walsh e Orson Welles), formula, con racconti ispirati alla narrativa popolare, una meditazione amara ma non rassegnata sull’identità. Un territorio affrontato mettendo al primo posto il tema della visione, che in Carpenter diventa esperienza esplorativa, luogo del conflitto sempre più magmatico e confuso tra bene e male, che sfumano l’uno nell’altro riflettendosi in un’ambiguità che l’immagine riesce a restituire innescando una lucida riflessione, propria di un cineasta singolare non di rado sperimentatore, al quale non interessa realizzare i film che non sente l’urgenza, ovverosia estranei alla sua visione. Con il suo lavoro egli ha dato una nuova luce ai generi, che ha vivificato curando la regia, scrivendo le sceneggiature, componendo le colonne sonore.
John Howard Carpenter nasce Carthage, nello stato di New York, il 16 gennaio 1948, ma la sua infanzia egli la vive nel Kuntucky, a Bowling Green. Il padre è un professore di musica il cui talento è confortato dalle session con i celebri cantanti e musicisti a cui prende parte: Roy Orbison, Johnny Cash, Frank Sinatra. In un primo tempo il giovane John Carpenter studia alla Western Kentucky University e dà vita a vari cortometraggi, quasi tutti animati dalla presenza di figure di un immaginario fantascientifico popolato di creature mostruose di altri mondi (“Gorgon, the Space Monster”, 1969; “Gorgo versus Godzilla”, 1969; “Warrior and the Demon”, 1969; “Sorceror from Outer Space”, 1969). In un secondo tempo egli si trasferisce alla University of Southern California (USC), dove, tra i corsi di cinema e di regia, scopre l’arte di Orson Welles, Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Howard Hawks. Qui studia il cinema non soltanto come fucina di trucchi e tecniche come era stato nel Kentucky, dove aveva potuto accrescere la confidenza già spiccata con gli effetti speciali come la stop-motion di cui fu maestro Ray Harryhausen: adesso i corsi di cinema e regia fanno crescere la sua consapevolezza estetica, e soprattutto in Howard Hawks egli trova il suo punto di riferimento e la fonte di ispirazione. Perché in Hawks Carpenter coglie il regista in grado di affrontare i generi facendone ambito di linguaggio ed espressione di una poetica che non rinnega gli stilemi ma li utilizza al meglio della loro forma e potenzialità. Vedendo e studiando questi registi, Carpenter ne saggia lo stile, a cui farà riferimento e ricapitolandone diversi aspetti nel suo cinema disposto a personalizzare gli esiti di spettacolarità dei suoi maestri, assieme alla predilezione hawksiana per gli spazi circoscritti, per l’amicizia virile e il singolare utilizzo dei personaggi femminili che lo studente Carpenter ha potuto apprezzare in titoli tra cui il prediletto “Un dollaro d’onore” (“Rio Bravo”, 1959). Tra i cortometraggi scolastici di John, si segnala l’ironico “Captain Voyer” (id., 1969), anticipatore di future atmosfere di cui avremo ampio perfezionamento in “Halloween – La notte delle streghe” (“Halloween”, 1978), dove la quotidianità di un uomo tediato dal suo lavoro ripetitivo è spunto per l’apparizione di un individuo che si traveste con mantella e cappuccio nero (pur rimanendo bizzarramente in shorts) dando il via a un’ossessione voyeuristica che troverà nel futuro killer seriale Michael Meyers l’incarnazione della persecuzione e della spietatezza inesorabile.
Già alcuni aspetti dell’opera del futuro cineasta si possono cogliere negli spazi delimitati di questo corto studentesco, dove le divagazioni del bizzarro personaggio, il cui volto si nasconde dietro una maschera, esplorano abitazioni e corridoi, giardini e spazi che troveranno trasparenza ed espressione nel cinema horror del futuro cineasta. L’adesione a un gruppo di studenti che usufruisce dei fondi della USC per produrre un cortometraggio, “The Resurrection of Bronco Billy” (id., 1970), pensato come un’esercitazione accademica e poi invece vincitore di un premio Oscar nel 1970 quale miglior cortometraggio, rappresenta per Carpenter il momento dell’ingresso vero e proprio nel mondo del cinema. John, che gira personalmente alcune sequenze del corto senza essere accreditato (la regia è firmata da James Rokos), contribuisce alla scrittura del soggetto e della sceneggiatura, cura il montaggio e compone la colonna sonora. Si ritrovano temi carpenteriani in questo piccolo e gradevole film che dona popolarità ed entusiasmo a tutti i collaboratori: è il viaggio di un giovane alla ricerca del West cinematografico e immaginario nella Los Angeles degli anni Settanta, dove si alternano sequenze e fotogrammi di film muti, disegnando una realtà come via di fuga e omaggio a una dimensione eroica perduta. Questa visione meta-cinematografica è il punto d’avvio significativo di un’adesione a una poetica dei generi che in Carpenter diviene autorialità. Egli continuerà a frequentare il modello western rivisitandolo con gli altri generi – il thiller, l’horror, la fantascienza – e proprio un film con cui avrà la possibilità di formulare per la prima volta e pienamente la sua idea di cinema, “Distretto 13 le brigate della morte” (“Assault on Precint” 13, 1976), riuscirà e riprodurre una situazione di assedio prendendo spunto dall’adorato western hawksiano “Un dollaro d’onore” per calarla in una temperatura cinematografica tesa e affascinante.
Il modello (e i modelli) western come avvio di una dimensione in cui l’assedio e la fuga si ritrovano in atmosfere e situazioni proprie dell’avventuroso, del poliziesco, del carcerario, lasciando aperti i contatti con il fantastico e con l’inesauribile vitalità che i generi, riproposti magari sotto singolari travestimenti, possono restituire. Tra citazioni infinite e mimetizzazioni (in Distretto 13… il regista firma il montaggio con lo pseudonimo di John T. Chance (esattamente il nome del personaggio interpretato da John Wayne nel film di Howard Hawks), Carpenter è interessato ai codici dei generi che possono essere assimilati dalla propria visione permettendo al cineasta di dominare un linguaggio visivo di grande efficacia, forte dell’apertura di sguardo e della visione intensa che utilizza il Cinemascope e ottiene di sintetizzare l’incandescenza di un nuovo cinema, quel “western metropolitano” o “western urbano” che influenzerà numerosissimi autori.
In conclusione degli studi universitari, il diploma di laurea è un mediometraggio girato in 16’mm, da cui Carpenter trarrà il primo lungometraggio con il titolo “Dark Star” (id., 1974): progetto ideato tra il 1970 e il 1972 durante gli studi alla University of Southern California, poi realizzato dal venticinquenne Carpenter che lo scrive assieme al compagno di studi Dan O’Bannon il quale si occupa del montaggio e della produzione ma interpreta anche il sergente Pinback. Recupero in versione beckettiana e satirica di 2001: “Odissea nello spazio” (2001: “A Space Odissey”, 1968) Carpenter lo ha definito una sorta di “Aspettando Godot nello spazio”, e del film di Kubrick rappresenta un omaggio-parodia a basso costo. Con i suoi dialoghi paradossali, la sua ambientazione spaziale e gli interni curati da Ron Cobb, “Dark Star” è il sorprendente lavoro di tre anni impegnati per “gonfiare” il mediometraggio di partenza; possibilità che viene premiata dal contributo di John Landis, il quale viene a conoscenza del lavoro di Carpenter grazie all’amico Dan O’Bannon e recupera i sessantamila dollari necessari per farne un lungometraggio di 83’.
A cavallo tra il lavoro scolastico (soprattutto per i mezzi messi a disposizione) e il precoce lavoro autoriale, “Dark Star” fa da ponte tra il cinema dell’esplorazione spaziale e quello degli alieni che arriverà, con il soggettista e sceneggiatore del film che in futuro scriverà anche “Alien” di Ridley Scott. Per Carpenter, la possibilità di mettersi alla prova con la durata lunga, scoprendo l’angoscia nello spazio e offrendo una meditazione sul cinismo della colonizzazione spaziale. La missione dell’equipaggio dell’astronave “Dark Star” è di colpire i pianeti che escono fuori orbita, e ciascuno dei bizzarri componenti si è ritagliato distrazioni per sopravvivere al vuoto del viaggio interminabile. Mentre il regista omaggia “2001: Odissea nello spazio”, è anche “Il dottor Stranamore…” (“Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worryng and Love the Bomb”, 1964) dello stesso Kubrick ad essere citato in una singolare sintesi con il film precedente, basti pensare alla rappresentazione della bomba che in “Dark Star”, a seguito di un guasto, è un oggetto che si pone interrogativi filosofici sulla sua missione opponendosi agli ordini dell’equipaggio. La satira piace inevitabilmente a John Landis, che rimane colpito dal film e lo sottopone al produttore-distributore Jack H. Harris, il quale lancerà nelle sale il battesimo nel lungometraggio del regista. E in questo sguardo sugli aspetti hippy di un’umanità lanciata nel cosmo si intravvedono motivi carpenteriani che diverranno familiari, a cominciare dalla condizione del manipolo di individui costretto in uno spazio circoscritto, dove il confronto dell’uno con l’altro si riflette nella contrapposizione tra loro stessi e il mondo esterno, in “Dark Star” più che mai portatore di angosce in parte esorcizzabili con l’ironia che il cineasta non risparmia mettendo a punto la sua visione attenta al recupero (adesso in chiave satirica) degli elementi caratteristici dei generi chiamati alla memoria dello spettatore. Il viaggio è sempre portatore di angoscia, e Carpenter lo attraversa sempre con una dose di humour, come sarebbe potuto piacere a Hitchcock, a cui il regista deve la capacità di sostenere la suspense. Questi aspetti diventeranno cardini del suo cinema ed affinati nella trilogia dell’orrore a basso budget composta dal già citato “Distretto 13 – Le brigate della morte”, da “Halloween, la notte delle streghe” (“Halloween”, 1978), titolo destinato a diventare il caposaldo del genere slasher intitolato, e dall’affascinante “Fog” (“The Fog”, 1980). Tre capitoli che fanno crescere Carpenter elevandolo tra i più rappresentativi horror. Con lui il genere è davvero New Horror, perché gli orrori trovano una nuova forma radicata nella consapevolezza del linguaggio e nei tempi della suspense, serbatoio di mitologia e di situazioni in grado di riflettere la realtà in modo realistico e al contempo sconcertante. A questa trilogia Carpenter perviene dopo aver perfezionato la scrittura (sarà sceneggiatore di molti dei suoi film, e in questo periodo firma anche lo script del tesissimo “Occhi di Laura Mars” di Irvin Kershner, 1978, e mentre lavora a due film per la televisione con cui affina il senso del ritmo e l’economia rappresentativa dando prova di grande talento nel creare tensione e atmosfera (“Pericolo in agguato”, 1978, “Elvis, il re del rock”, 1979), nel 1981 Carpenter estende la riflessione agitata dal suo western metropolitano creando un affresco visionario e politico con il film cult “1997, Fuga da New York” (“Escape from New York”), titolo che, portando in scena con il personaggio di Jena Plissken interpretato da Kurt Russel uno degli anti-eroi più iconici del cinema statunitense, rinnova il cinema di genere americano offrendo la staffetta d’avvio per un immaginario ossessionato dalla guerriglia e dall’assedio. Senso del ritmo, stilizzazione, tempi della visione dominati con certosina perizia, fanno del suo cinema un esempio che vanta diversi imitatori, ma intanto Carpenter riflette sugli orrori cercando di esplorare le onde del contagio attraverso terrificanti storie di mutazione, come per il titolo del 1982, “La cosa” (“The Thing”), tratto da un romanzo di J. W. Campbell. Che sia l’Antartide o un’auto infernale (come nel successivo “Christine, la macchina infernale”, del 1983), Carpenter studia le atmosfere da cui sa ricavare il terrore, plasma cadenzate situazioni tensione nel confronto con quanto rimane minaccioso e costringe gli spettatori – e i personaggi – a rimanere desti, nonostante l’assassino o l’entità maligna compaiano senza un vero volto (come in Halloween), o, come ne “La cosa”, con le sembianze di una forma non umana. Il regista evita di affidarsi alle soluzioni dell’horror granguigolesco, perché per lui l’horror, come il western e il thriller, è linguaggio, forma della rappresentazione, stile dell’essenzialità e del ritmo.
Carpenter non a caso musica i suoi film (e anche quando Ennio Morricone si sostituisce a lui per “La cosa”, il maestro italiano riesce ad assimilare la lezione musicale del regista americano inventando timbri sonori che riflettono l’impronta chiara, ovverosia tenebrosa e intensamente coinvolgente, del cinema del regista), e le sua colonne sonore accompagnano lo spettatore, diventando espressione di un ritmo che sorregge la suspense e dipinge un’atmosfera singolarissima, avvolgente, magnetica, rendendo più diretto e coinvolgente il viaggio immersivo in geografie della visione. Un’intensità della visione che nei migliori film di Carpenter si traduce in stile, dandosi come manifestazione artistica che completa e arricchisce la rappresentazione sullo schermo.
Orgoglioso e coerente, sul piano esistenziale Carpenter è un autore sempre dalla parte dei perdenti, degli antieroi disillusi che tuttavia scelgono di combattere ancora nonostante il crollo degli ideali, e l’autore è in grado di affinare una visione politica che negli anni risulta sempre più ineludibile. Autroproclamandosi “l’anti-Spielberg” (nello stesso anno de “La cosa” con i suoi inquietanti aspetti di contagio e disillusione, “E.T.” è invece l’alieno portatore di un messaggio di solidarietà collettiva dai toni straordinariamente sognanti), Carpenter rappresenta la punta più visionaria e radicale di un cinema che non dimentica di guardare ai modelli cinematografici del passato per farne territorio di esplorazione. Con “Starman” (id., 1984) si può dire che egli realizzerà il “suo” “E. T”., riconsiderando la presenza di un alieno sulla terra, dando voce a sfumature ironiche suscettibili di rammentare in chi guarda gli esordi di “Dark Star”.
Anche il fantasy, e la commistione tra i generi, caratterizzano il cinema del regista americano, che viene riconosciuto, specialmente dal pubblico e dalla critica europea, come un autore legato a una visione particolarissima del cinema, come testimonia anche quello che diviene un altro cult, “Grosso guaio a Chinatown” (“Big Trouble in Little China”, 1986), titolo che spiazza tutti per la novità di un cinema fatto di omaggi e citazioni dal gusto amabilmente fumettistico, capitanato da un attore, Kurt Russel, novello Flash Gordon con il carisma del carpenteriano Jena Plissken. In grado di restituire una lezione di finezza cinematografica nell’omaggiare il cinema orientale e la lettura di genere con largo anticipo rispetto a Quentin Tarantino, quello di Carpenter è un cinema che sconta battute d’arresto al botteghino ma vitale sul fronte artistico. La visione politica si dunque fa esplicita nel fanta-horror-metropolitano “Essi vivono” (“They Live”, 1988), uno dei titoli più visionari del cineasta americano, dove il mondo ufficiale nasconde una proliferazione di figure aliene che dominano gli umani attraverso i mezzi di comunicazione: come in “Distretto 13” e in “1997: Fuga da New York”, e come sarà in “Fantasmi da Marte”, il personaggio solitario, anarchico e disilluso, dovrà vedersela con un’odissea di sopravvivenza in cui gli ultimi possono fare la differenza. I rapporti virili (anche tra uomo e donna), segnalano la persistenza di una temperatura western che rimarrà sempre stile, marchio di fabbrica, fascinazione profonda. Non sarà un caso se la visione di questo cineasta visionario e irriducibile, nell’ultima parte della sua filmografia, si concentrerà sull’horror, avviato splendidamente da “Halloween nel 1978”. “Il seme della follia” (In The Nouth Of Madness, 1994) propriamente è il ritorno all’horror, e con questo film – un trattato sulla dispercezione della realtà e sulla frammentazione dell’identità – il regista riepiloga i temi che più gli stanno a cuore per ridare il via a una serie di viaggi nell’immaginario del brivido.
Ad esso fanno infatti seguito sia il sottovalutato remake “Il villaggio dei dannati” (“Village of The Damned”, 1995), sia il ritorno all’horror-western rappresentato dal gustoso “Vampires” (id. 1998), incentrato sulle vicende di un cacciatore di vampiri che ai più nostalgici potrà far venire in mente John Wayne, sia il fanta-horror “Fantasmi da Marte” in cui si ritrovano, attraverso un singolare e significativo flashback, alcuni ricorrenti temi carpenteriani che incendiano i fans: l’ambientazione western (con il treno come una diligenza lanciato nell’universo dei “popoli rossi”), gli alieni mutanti in grado di invadere gli umani come virus, la donna protagonista, un’eroina intelligente, forte e pronta a muoversi verso il riscatto dando smalto e bellezza a un cinema che sotto nuove forme rinnova il genere e lo rende un ambito insostituibile per riportare in primo piano l’avventura di personaggi che, nonostante la ruvida scorza, continuano a difendere la loro integrità. Ma al terrore puro è dedicata anche l’ultima regia di Carpenter, “The Ward – Il reparto” (“The Ward”, 2010) ultimo non ultimo viaggio nella follia.
SAGGI
ITALO CALVINO E IL CINEMA
di Maurizio Villani
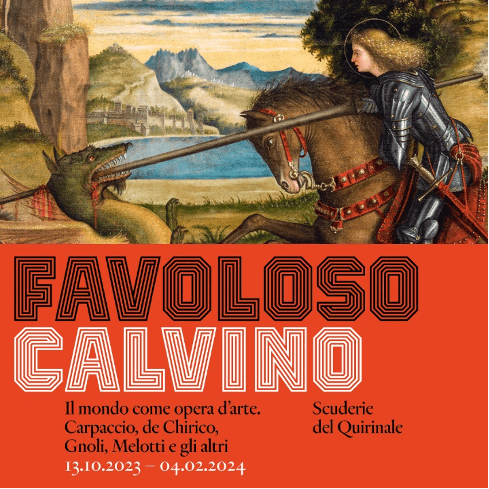
- «Andavo al cinema quasi tutti i giorni»
A 100 anni dalla nascita di Italo Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985) una grande Mostra alle Scuderie del Quirinale a Roma ricostruisce la biografia intellettuale di uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento. La terza sala dell’esposizione romana è in gran parte dedicata al rapporto di Calvino con il cinema e documenta, seppur parzialmente, la passione dello scrittore per la settima arte.
Calvino era un appassionato di cinema fin da ragazzo, e frequentava assiduamente le sale cinematografiche. L’interesse per il cinema si riflette in tutta la sua opera, sia letteraria che saggistica.
Due grandi pannelli riportano una citazione – tratta dalla sua Autobiografia di uno spettatore. Prefazione al volume Fellini: quattro film (1974) – in cui Calvino espone una serie di ricordi sul suo amore giovanile per il cinema: quali opere e quali attrici e attori lo colpirono maggiormente e il valore formativo che la visione dell’immaginario dei film ebbe sul suo rapporto con la realtà.
«Ci sono stati anni in cui andavo al cinema quasi tutti i giorni e magari due volte al giorno ed erano gli anni tra il ‘36 e la guerra, l’epoca insomma della mia adolescenza. Anni in cui il cinema è stato per me il mondo. Un altro mondo da quello che mi circondava, ma per me solo ciò che vedevo sullo schermo possedeva le proprietà d’un mondo, la pienezza, la necessità, la coerenza, mentre fuori dallo schermo s’ammucchiavano elementi eterogenei che sembravano messi insieme per caso, materiali della mia vita che mi parevano privi di qualsiasi forma. La “mia” epoca va pressappoco da “I Lancieri del bengala” (1935) con Gary Cooper e “L’ammutinamento del Bounty” (1935) con Charles Laughton e Clark Gable, fino alla morte di Jane Harlow (che vissi tanti anni dopo come morte di Marilyn Monroe in un’epoca più cosciente della carica nevrotica d’ogni simbolo).
Con in mezzo molte commedie giallo rosa con Myrna Loy e William Powell e il cane Asta, i musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, i gialli di Charlie Chan detective cinese e i film del terrore di Boris Karloff. (…) Dopo aver visto Casbah di Algeri in “Pépé le Moko” (1937) guardavo con altri occhi le vie a scale della nostra città vecchia».
L’andare al cinema dischiude al giovane Calvino lo spazio immaginario dei film che incanta il giovane spettatore con l’annuncio o la promessa che il mondo è molto più grande e ricco, più vario e avventuroso della realtà di cui può avere esperienza diretta.
- Le prime collaborazioni giornalistiche di critica cinematografica
Nel quadro del suo interesse per il cinema, Calvino scrisse recensioni di film a partire dall’estate del 1941 quando “Il giornale di Genova” gliene pubblicò due fra cui quella di “San Giovanni decollato” con Totò protagonista.
Nel 1949 Calvino fu inviato, come giovane cronista de “l’Unità”, sul set di “Riso amaro” di Giuseppe De Santis. Scisse un articolo in cui definì la Mangano “una diciottenne dalla bellezza sconvolgente” e «una delle più belle ragazze che io abbia mai visto». Calvino fu colpito dalla bellezza naturale e dalla forza espressiva della Mangano, che riusciva a trasmettere allegria, dolore e passione con la stessa intensità. La Mangano era «una presenza fisicamente così forte da sopraffare la finzione del film, (…) il suo volto e il suo corpo sembrano incarnare il destino di una generazione».
Nel 1954 Calvino iniziò una collaborazione giornalistica con la rivista “Cinema nuovo” che si protrarrà per alcuni anni. In questa veste di critico scrisse una corrispondenza dalla XV Mostra di Venezia. Su quell’articolo così si esprime Gian Pero Brunetta nella sua storia della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: «Si è assunto il compito di ricreare l’atmosfera della serata inaugurale (poi scriverà anche un articolo quasi tutto dedicato alla “Romana”) e regala un testo per molti aspetti eccezionale: in poche righe coglie e racchiude lo spirito che tocca i presenti, il senso d’attesa comune e l’illuminazione collettiva grazie all’epifania del mito incarnato da Gloria Swanson, quasi direttamente traghettata al Lido dal finale di “Viale del tramonto” di Billy Wilder del 1950». (Brunetta, 2022, pp. 319-320).

A proposito de “La Romana” Calvino dapprima dichiara che dall’incontro Zampa-Moravia ci si poteva aspettare certamente di più; passa poi a parlare della Lollobrigida, che lo «abbaglia per il biancore appena rosato della pelle». La Lollo è «cuore del film, sua ragione prima, lustro e vanto dei produttori e del pubblico fanatico che quasi la linciò dall’entusiasmo davanti al palazzo del cinema. (…) Ne penso tutto il bene che merita pur senza levarla alle stelle, (…) pensiamo che l’interpretazione della “Romana” le abbia servito molto a precisare il tipo di popolana italiana che le più riesce a comprendere e a definire». (Brunetta, 2022, p. 327).
- La relazione sentimentale con Elsa De Giorgi e la presenza alle Mostre internazionali d’arte cinematografica di Venezia
Nel 1955 Calvino iniziò una relazione sentimentale con l’attrice e scrittrice Elsa De Giorgi (Pesaro 1914 – Roma 1997), sposata con il nobile Sandrino Contini Bonacossi. Fu Natalia Ginzburg a presentare alla De Giorgi Calvino, allora occupato nella redazione della Casa editrice Einaudi, affinché le facesse da editor per la pubblicazione del suo primo romanzo, I coetanei. La liaison durerà fino al 1959 e fu raccontata da Elsa nel suo libro autobiografico Ho visto partire il tuo treno (1992). Fu un amore difficile e tormentato, fatto di incontri proibiti, corrispondenze, viaggi, di cui ci resta un corpus epistolare che la filologa Maria Corti, una delle poche ad averlo letto nella sua interezza, ha dichiarato essere «il più bello del Novecento italiano».
La De Giorgi negli anni ‘60 incontrò Pier Paolo Pasolini, che la chiamò sul set de “La ricotta” (1963); ebbe inizio una lunga e profonda amicizia, che portò Elsa a difendere Pier Paolo in diverse occasioni, e a partecipare al suo ultimo film, “Salò o le 120 giornate di Sodoma” (1975).
Il 12 agosto 1955 morì a Zurigo Thomas Mann, tredici giorni dopo si aprì la XVI Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Calvino collegò i due eventi in un articolo per “Cinema Nuovo” (n. 65), dal titolo La noia a Venezia, in cui scrisse: «Aschenbach è preso da un senso d’inferiorità, lui con le sue pagine così avare ed esangui, e gli viene un terribile desiderio di tutte le cose che il cinema è e dà, la realtà più immediata e l’idealizzazione più smaccata, una libertà d’espressione grande quanto il mondo visibile e una convenzione codificata all’estremo, la fama più altisonante e impudica, l’atmosfera di ricchezza onnipotente, e insieme il senso di lavorare per un mondo di povera gente, per le folle anonime che si stiperanno nelle sale buie. Per tutto quel che il cinema è: tecnica e baraccone, volgarità e sapienza raffinata, avventura per chi lo fa e per chi lo vede».
Alla Mostra di quell’anno la Giuria assegnò il Leone d’Argento per la regia a Michelangelo Antonioni per “Le amiche”, film tratto dal romanzo di Cesare Pavese Tra donne sole. La trasposizione del romanzo non convinse Calvino, che criticò la rappresentazione dell’universo femminile, rappresentato in particolare da una Clelia (Eleonora Rossi Drago) «più sfumata e meno problematica», e da Momina (Yvonne Furneaux), che Calvino si aspettava «più acre e aggressiva, con un cinismo più scoperto».
Nel 1974 Calvino pubblicò il saggio Autobiografia di uno spettatore, prefazione di un volume edito da Einaudi in cui erano raccolte le sceneggiature di quattro film di Fellini: “I vitelloni”, “La Dolce Vita”, “Giulietta degli spiriti” e “8½”. Il testo si compone di due parti: la prima, autobiografica, è la rievocazione che Calvino fa della propria giovanile scoperta del cinema come altra dimensione del mondo; la seconda parte ha un carattere più teorico, volto a esplorare nuove forme di narrazione e di rappresentazione e nuovi linguaggi cinematografici.
Nel 1981 Calvino è nominato alla Presidenza della Giuria della Mostra di Venezia. Alludendo a una polemica avviata da un giornalista americano, critico verso le scelte dei film in concorso, dichiarò, nel corso della cerimonia finale, che «i film americani non hanno bisogno di essere lanciati da Venezia, per cui non hanno ottenuto alcun premio» (Brunetta, 2022, p. 628).
In quell’edizione vinse il film “Anni di piombo” (“Die bleierne Zeit”) diretto da Margarethe von Trotta: fu la prima volta nella storia della Mostra che il Leone d’oro venne assegnato ad una regista donna. Il Leone d’argento, ex aequo, andò a “Sogni d’oro” di Nanni Moretti.
- Pensieri sul cinema
L’itinerario della riflessione critica sul cinema condotta da Calvino si dipana per un tempo di oltre trent’anni. Non possiamo in questa sede, evidentemente, delinearlo se non per grandissime generalizzazioni. Esso passa attraverso alcune tappe più significative, quali gli articoli e le recensioni di film per diverse riviste e giornali, tra cui “l’Unità”, “Cinema Nuovo” e “Paese Sera”. Le sue recensioni sono caratterizzate da un’analisi originale, che spesso va oltre la semplice valutazione del film per cogliere ed esplorare il rapporto dei film con la realtà e la loro influenza sulla società. Calvino ha anche scritto diversi saggi sul cinema, in cui riflette sul ruolo del cinema nella società e sulla sua importanza come forma d’arte. Tra questi Il cinema è un mondo (1954), Il cinema e la letteratura (1956), Il cinema è una forma di scrittura (1959) e Il cinema è un gioco (1962).
Nel saggio su Il cinema e la letteratura Calvino esprime la sua convinzione che cinema e letteratura siano due differenti mezzi di comunicazione che si servono di linguaggi diversi. Il cinema ha una propria specificità che lo rende un’arte a sé stante: «il cinema non è un’illustrazione della letteratura, non è un’interpretazione della letteratura, non è un’imitazione della letteratura. Il cinema è un’arte che si vale di immagini e di suoni per raccontare una storia, e che ha le sue proprie regole e le sue proprie possibilità».
In un articolo del 1963, intitolato Il cinema nuovo, Calvino scrive: «Il cinema nuovo è un cinema che ha rifiutato le convenzioni del cinema classico, e che ha cercato di sperimentare nuove forme di narrazione e di linguaggio». Questa ammirazione per la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi lo porta ad appezzare registi come Fellini, Antonioni, Godard, Bergman e Kurosawa.
Opera importante dell’attività critica è L’autobiografia di uno spettatore, testo del 1974 a cui abbiamo già fatto riferimento. In questo saggio il discorso di Calvino si sofferma su vari aspetti del linguaggio cinematografico, tra i quali ci piace ricordare l’interesse dell’autore per la funzione attoriale nei film.
Riflettendo su un tema che era già stato oggetto di analisi da parte di Walter Benjamin ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Calvino si sofferma sul rapporto tra mitologia e ruolo degli attori e delle attrici. Predilige i grandi interpreti hollywoodiani, di cui prende in esame l’espressività dei volti e i tipi di caratteri che rivelano.
«Gli attori rappresentavano modelli di caratteri e di comportamenti; c’era un eroe possibile per ogni temperamento; per chi si proponeva d’affrontare la vita nell’azione, Clark Gable rappresentava una certa brutalità rallegrata dalla spacconeria, Gary Cooper un sangue freddo filtrato dall’ironia; per chi contava di superare gli ostacoli mediante lo humour e il savoir-faire, c’era l’aplomb di William Powell e la discrezione di Franchot Tone; per l’introverso che vince la sua timidezza c’era James Stewart, mentre Spencer Tracy era il modello dell’uomo aperto e giusto che sa fare le cose con le sue mani; e veniva proposto perfino un raro esempio d’eroe intellettuale, in Leslie Howard».
Con lo stesso criterio è presentato il catalogo delle attrici, distinte nelle «due categorie fondamentali delle bionde e delle brune. (…) S’andava dall’estrosa Carole Lombard alla pratica Jean Arthur, dalla bocca ampia e languida di Joan Crawford a quella sottile e pensosa di Barbara Stanwyck (…). Dalla spregiudicatezza monellesca di Claudette Colbert all’energia puntuta di Katharine Hepburn, il modello più importante che i caratteri femminili del cinema americano proponevano era quello della donna rivale dell’uomo in risolutezza e ostinazione e spirito e ingegno; in questa lucida padronanza di sé di fronte all’uomo, Myrna Loy era quella che metteva più intelligenza e ironia» (L’autobiografia di uno spettatore, pp. XII-XIII).
L’ultima tappa del percorso critico di Calvino coincide con l’opera che stava scrivendo quando lo colse la morte. Sono le cinque Lezioni americane che, come scrive nella quarta di copertina Gian Carlo Roscioni, sono «riflessioni di Calvino sull’arte come conoscenza [che] vertono in ultima analisi su un unico tema, quello delle “connessioni invisibili”: che una volta scoperte dal suo sguardo attento e affilato rendono trasparente l’opacità del mondo».
Nella quarta Lezione – che ha per argomento la Visibilità – dopo aver messo a tema le “visioni” poetiche, Calvino passa a esaminare i processi immaginativi propri del cinema, teorizzando la presenza di un “cinema mentale” che presiede alle creazioni fantastiche della mente umana.
La lettura del passo in questione richiama alla memoria le tesi di Bergson sulla “visione cinematografica della realtà”, quando il filosofo francese evidenzia come “il meccanismo cinematografico del pensiero” non solo sia costitutivo del linguaggio cinematografico, ma riguardi la più generale dinamica di un nostro modo di percepire e di pensare il mondo. (L’evoluzione creatrice, pp. 249-250).
«Nel cinema – scrive Calvino – l’immagine che vediamo sullo schermo era passata anch’essa attraverso un testo scritto, poi era stata “vista” mentalmente dal regista, poi ricostruita nella sua fisicità sul set, per essere definitivamente fissata nei fotogrammi del film. Un film è dunque il risultato d’una successione di fasi, immateriali e materiali, in cui le immagini prendono forma; in questo processo il “cinema mentale” dell’immaginazione ha una funzione non meno importante di quella delle fasi di realizzazione effettiva delle sequenze come verranno registrate dalla camera e poi montate in moviola. Questo “cinema mentale” è sempre in funzione in tutti noi, – e lo è sempre stato, anche prima dell’invenzione del cinema – e non cessa mai di proiettare immagini alla nostra vista interiore» (Lezioni americane, p. 83).
- Filmografia
Le informazioni sulla filmografia relativa a Italo Calvino sono relativamente scarse. Se nel secondo dopoguerra molti film sono stati tratti da romanzi di scrittori italiani contemporanei – basta fare i nomi di Moravia, Bassani, Pasolini, Tomasi di Lampedusa, Gadda – non così è stato per Calvino, a proposito del quale Lietta Tornabuoni ha fatto queste osservazioni: «è uno degli scrittori che direttamente meno hanno contribuito al cinema italiano: qualche collaborazione a sceneggiature (…). Ma è forse lo scrittore italiano che più ha anticipato nella propria opera l’immaginario, le fascinazioni, le tendenze del cinema internazionale contemporaneo: il mondo medievale rivissuto con ironia, l’universo magico ripetitivo e fatale della fiaba, le cosmogonie fantastico-scientifiche, le città del sogno tra Oriente visionario e megalopoli moderna, la narrativa come processo combinatorio di elementi preesistenti, la narrazione come forma compiuta che è possibile scomporre giocando col racconto come con gli scacchi» (Lietta Tornabuoni, nell’intervista Calvino: il cinema inesistente, pubblicata sulla «Stampa» il 23 agosto 1981).
1958 – “I soliti ignoti” di Mario Monicelli. L’idea di partenza è tratta dal racconto Furto in una pasticceria (1947), contenuto nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo (1949).
1962 – “L’avventura di un soldato” di Nino Manfredi, uno dei quattro episodi del film “L’amore difficile”, tratto dal racconto “L’avventura di un soldato”, pubblicato da Calvino nel 1949.
1962 – “Renzo e Luciana” di Mario Monicelli, uno dei quattro episodi del film “Boccaccio ’70”. Il film è tratto dal racconto L’avventura di due sposi (1958) e Calvino collabora alla sceneggiatura.
1967 – “America paese di Dio” è un documentario diretto da Luigi Vanzi (aiuto regista di Michelangelo Antonioni). Il testo originale del film fu redatto da Italo Calvino, pubblicato nel volume postumo Un ottimista in America.
1962 – “Ti-Koyo e il suo pescecane” diretto da Folco Quilici. Calvino elaborò la sceneggiatura con un adattamento fiabesco della storia tra il bambino e il pescecane.
1970 – “Marcovaldo” di Giuseppe Bennati. Serie televisiva RAI in sei puntate che compie una riduzione dell’omonima raccolta di racconti di Italo Calvino.
1970 – “Il cavaliere inesistente” di Pino Zac. Ispirato dall’omonimo romanzo di Italo Calvino del 1959, è un film, prodotto dall’Istituto Luce, girato a tecnica mista, che unisce attori in carne ed ossa e personaggi di animazione.
1972 – “L’inseguimento” di Carlo Di Carlo, tratto dal racconto omonimo, pubblicato sul giornale “Il Giorno” il 28 maggio 1967. Fu realizzato, come “L’avventura di un lettore”, per la Seconda rete televisiva tedesca.
1973 – “L’avventura di un lettore” di Carlo Di Carlo, tratto dall’omonimo racconto del 1958, contenuto negli Amori difficili.
1983 – “Avventura di un fotografo”, un film per la televisione italiana diretto e sceneggiato da Francesco Maselli e tratto da un soggetto di Italo Calvino.
1991 – “Fantaghirò” di Lamberto Bava. Serie televisiva di genere fantastico trasmessa da Canale 5, si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella contenuta nelle Fiabe italiane raccolte da Italo Calvino.
2002 – Calvino compare nel film documentario “Federico Fellini: Sono un gran bugiardo”, del regista Damian Pettigrew.
2023 – È stato presentato alla Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia il documentario “Italo Calvino – Lo scrittore sugli alberi”, diretto da Duccio Chiarini. Il film ripercorre la carriera di Calvino attraverso la storia de Il barone rampante.
Il produttore Lorenzo Mieli ha dichiarato nel 2023 di aver acquisito i diritti per realizzare un adattamento tv del Barone Rampante e de Il visconte dimezzato.
- Indicazioni sitografiche e bibliografiche
- Bergson H. L’evoluzione creatrice (1907), a cura di Fabio Polidori, Cortina Editore, Milano 2002, la Parte IV Il meccanismo cinematografico del pensiero e l’illusione meccanicistica, pp. 223-300.
- Calvino I. Autobiografia di uno spettatore, in Federico Fellini, Fare film, Torino, Einaudi, 2010.
- Calvino I. Romanzi e racconti, I Meridiani, Mondadori, Milano 2022. Edizione diretta da Claudio Milanini, a cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto. Prefazione di Jean Starobinski. In tre Meridiani è raccolta in ordine cronologico l’intera produzione narrativa di Calvino.
- Calvino I. Saggi 1045-1985, a cura di Mario Barenghi, I Meridiani, Mondadori, Milano 2022, due voll. Indivisibili.
- Gian Piero Brunetta, La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 1932-2022, Marsilio, Venezia 2022.
- Mario Barenghi, Favoloso Calvino. Il mondo come opera d’arte. Editore Electa. Il catalogo ufficiale della mostra.
- Palumbo M. «Quell’altro mondo che era il mondo». Calvino e il cinema https://journals.openedition.org/italies/4554
- Santoro V. (a cura di) Calvino e il cinema, https://www.cineforum.it/
- Santoro V. (a cura di) Italo Calvino e il cinema (sito web dedicato al rapporto tra Calvino e il cinema) https://www.rapportoconfidenziale.org/?p=29873
- Santoro V. (a cura di), Calvino e il cinema: l’avventura di uno spettatore. Le recensioni (1945-1962), Quodlibet, Macerata 2019.
- Santoro V. (a cura di), L’avventura di uno spettatore. Italo Calvino e il cinema, nuova edizione ampliata, Quodlibet, Macerata 2016.
- Santoro V. “Il cinema come una specie di allucinazione”. Italo Calvino e il cinema, in “Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti”, s. IX, vol. XXIV, fasc. 1-2, 2004, pp. 233-250.
- Santoro V. “Il cinema è un mezzo sconvolgente”. Italo Calvino e il cinema, in “Il cinema italiano. Rivista di storia, critica e analisi”, n. 12, 2004, pp. 13-30.
ROGER MOORE 007 E LO STRANO CASO DEL SIGNOR PELHAM
di Mario Galeotti
Attore brillante capace di dare un tocco speciale ai suoi personaggi, l’inglese Roger Moore (1927 – 2017) è noto per essere stato il terzo volto ufficiale, dopo Sean Connery e George Lazenby, dell’agente segreto 007, alias James Bond. Lo ha impersonato, con disinvoltura e ironia, per ben sette volte tra il 1973 e il 1985: “Agente 007 – Vivi e lascia morire” (“Live and Let Die”, di Guy Hamilton, 1973), “Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro” (“The Man With the Golden Gun”, di Guy Hamilton, 1974), “La spia che mi amava” (“The Spy Who Loved Me”, di Lewis Gilbert, 1977), “Moonraker – Operazione spazio” (“Moonraker”, di Lewis Gilbert, 1979), “Solo per i tuoi occhi” (“For Your Eyes Only”, di John Glen, 1981), “Octopussy – Operazione piovra” (“Octopussy”, di John Glen, 1983), “007 – Bersaglio mobile” (“A View To a Kill”, di John Glen, 1985). Ma se il ruolo di Bond è servito a consacrare definitivamente la sua carriera a livello planetario, va detto che Roger Moore aveva già raggiunto la fama con i personaggi portati sul piccolo schermo tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Settanta: il coraggioso cavaliere medievale Sir Wilfred nella serie televisiva Ivanhoe, l’avventuriero gentiluomo Simon Templar nella famosa serie “Il Santo” (“The Saint”) ispirata ai racconti polizieschi di Leslie Charteris, lord Brett Sinclair nel telefilm “Attenti a quei due” (“The Persuaders”) in coppia con l’americano Tony Curtis.
Confinato nel cliché dell’uomo d’azione, impavido giustiziere e elegante seduttore, nel corso della sua carriera Roger Moore ha avuto anche qualche rara occasione di proiettarsi verso nuovi orizzonti artistici, come nel 1970 quando, a ridosso dell’enorme successo della serie televisiva “The Saint” conclusasi l’anno prima, fu protagonista del thriller diretto da Basil Dearden “L’uomo che uccise se stesso” (“The Man Who Haunted Himself”), un film che gli permise di affrancarsi temporaneamente dalla prevedibilità del typecasting.
Fu senz’altro un’esperienza stimolante, un ruolo intenso e drammatico che si discostava molto dalle parti sostenute fino a quel momento: “una delle poche volte che mi fu concesso di recitare davvero”, ha ricordato Roger Moore nell’autobiografia (R. Moore, Il mio nome è Bond, Gremese, Roma 2009, p. 145). Purtroppo, però, il film non ebbe l’esito commerciale sperato, nonostante la buona accoglienza della critica, a dimostrazione del fatto che anche il pubblico a volte è capace di incorrere nello stesso imperdonabile snobismo degli intellettuali. Va considerato, però, che la popolarità del Simon Templar televisivo aveva finito inevitabilmente per connotare in maniera univoca l’attore, che nell’immaginario collettivo veniva ormai identificato con l’indole avventurosa e filantropica del personaggio nato dalla penna di Charteris: a ridosso della chiusura della seguitissima serie, dunque, con molta probabilità il pubblico non era pronto per apprezzare inedite doti drammatiche di Roger Moore in un film così distante dalle appassionanti ma prevedibili imprese a lieto fine del Santo.
Prima collaborazione di Roger Moore con Bryan Forbes, qui in veste di produttore e di sceneggiatore (non accreditato) – i due avrebbero lavorato insieme anche in altre occasioni – il film “L’uomo che uccise se stesso”, girato negli Elstree Studios, era liberamente tratto dal racconto di Anthony Armstrong The Strange Case of Mr. Pelham, pubblicato nel 1957 e uscito in Italia con il titolo La tragedia del doppione.
Strutturato a flashback, il racconto di Armstrong esordisce nella cornice mondana del casinò di Montecarlo, ai cui tavoli da gioco siede il misterioso James Pellham, un ricco uomo d’affari titolare di una ditta di import – export a Londra. Il suo aspetto non sembra molto distinto e ha l’aria di un innocuo uomo di provincia, un semplice impiegato o un assicuratore, ma circolano strane dicerie sul suo conto: da posato conservatore, scapolo e amante della quiete, tutt’altro che ardito, sembra che nel giro di poco tempo Pelham abbia dato una svolta decisiva alla propria vita, lanciandosi con successo in arrischiate imprese che gli hanno fruttato molti soldi e ora, dopo una noiosa esistenza fatta di routine, ha iniziato a godersi la vita viaggiando su un lussuoso yacht a bordo del quale è solito dare feste trasgressive. Chi è il signor Pelham? Ne viene ripercorsa la storia, prima dell’inaspettata metamorfosi che lo ha portato a cambiare abitudini e stile di vita.
Abitudinario e puntiglioso fino all’inverosimile, Pelham divideva casa con il fido cameriere Rogerson, vestiva sempre un abito a doppiopetto scuro, con cappello e ombrello, portava due baffi ben curati ripresi da Roger Moore nel film e si spostava sempre in taxi (rare volte in metropolitana) perché non era assolutamente il tipo da guidare un’auto sua nel traffico londinese. Viveva, dunque, le sue giornate in maniera “semplice, monotona e felice” (A. Armstrong, La tragedia del doppione, Edizioni del Corriere della Sera, Milano 1957, p. 16), quando ad un certo punto un susseguirsi di strani eventi iniziò a turbarne il quotidiano equilibrio, sprofondandolo in un “dramma tipo Jekyll e Hyde” (Ivi, p. 29). Amici e conoscenti cominciarono a dirgli di averlo visto in determinati luoghi e orari, quando lui invece si trovava da tutt’altra parte: partite a biliardo al club, bevute, conversazioni e altre circostanze di cui lui non solo non aveva memoria, ma alle quali non avrebbe fisicamente potuto presenziare perché impegnato in altre faccende. Un sosia? Una doppia vita?
La situazione andava complicandosi sempre più, fino ad assumere contorni decisamente surreali. Un giorno Pelham telefonò a casa per avvisare Rogerson che non sarebbe rientrato per pranzo la sera e il cameriere, lamentando un malfunzionamento nella linea, rispose come se all’apparecchio stesse parlando un estraneo e il vero signor Pelham si trovasse invece nella sua abitazione in quel momento. Rincasato, con stupore l’uomo trovò nella propria stanza le recentissime tracce lasciate dall’ipotetico sosia, mentre Rogerson “era convinto ch’era stato il suo padrone ad entrare, uscendo poi per una breve passeggiata e rientrando di nuovo” (Ivi, p. 67).
Persuaso di avere a che fare con un abile criminale o con un folle, che oltre ad assomigliargli alla perfezione nell’aspetto fisico riusciva ad “assomigliargli anche nel carattere, nell’abito e nelle abitudini” (Ivi, p. 65), Pelham aveva deciso di rivolgersi alla polizia, ma non si rivelò un’idea felice, perché si trattava di una storia talmente fantasiosa che difficilmente lo avrebbero preso sul serio. Così si era convinto a seguire, almeno in parte, il consiglio di un amico: cambiare abitudini e orari, indossare abiti di diversa fattura e modificare leggermente la propria firma sui documenti ufficiali, in modo da disorientare il persecutore e coglierlo sul fatto.
Sul lavoro, intanto, il sosia aveva addirittura portato a termine due importanti affari che andavano a tutto vantaggio della società di Pelham. Ma l’aspetto davvero curioso consisteva nel fatto che i termini con i quali erano stati conclusi i due contratti commerciali presupponevano un’intraprendenza e un senso del rischio di cui il vero Pelham era assolutamente sprovvisto: non avrebbe mai avuto l’audacia di prendere simili decisioni. Inoltre, il fantomatico gemello aveva addirittura siglato un assegno con la nuova firma che, con una piccola modifica alla lettera “P”, Pelham aveva già provveduto a depositare in banca.
Cominciando seriamente a dubitare di se stesso e a convincersi di essere impazzito o in preda a un brutto esaurimento nervoso, Pelham aveva deciso di consultare uno specialista. Il medico, assecondando la teoria del sosia, gli aveva raccomandato assoluto riposo e gli aveva prescritto alcune pillole per calmare i nervi, suggerendogli anch’egli (come l’amico) di cambiare consuetudini giornaliere quel tanto che bastava a confondere l’astuto doppione. Ma tutta la faccenda sembrava ormai fuori controllo, il sosia “si comportava sempre più come una specie di maligno tarlo, intento a scavar la sua tana nel legno, e a mangiarsi inesorabilmente tutti quei puntelli e quei sostegni sui quali poggiava la sua vita semplice e ordinata” (Ivi, p. 116).
L’autentico Pelham aveva scoperto perfino, con agghiacciante stupore, che il sosia si era incontrato in via confidenziale, al di fuori dell’ufficio, con la sua segretaria Lily e il futuro sposo di lei e che di nascosto si intratteneva intimamente con la ragazza, la quale sempre più affascinata ne ricambiava le attenzioni. Arrivato a tali livelli di sfrontatezza, nella mente di Pelham si insinuò il dubbio che potesse trattarsi non di una persona in carne e ossa, ma di una creatura soprannaturale, un’entità che non era di questo mondo ma che era comunque in grado di “infiltrarsi inesorabilmente nella sua esistenza” (Ivi, p. 132). Attribuendo agli incredibili eventi una matrice trascendentale, Pelham aveva infine pensato di rivolgersi a un pastore, suo ex insegnante di religione a scuola divenuto vicario di una parrocchia del Devonshire. “Va in un certo senso impadronendosi della mia vita, e non per viverla come io la vivo, ma come la vorrebbe vivere lui” (Ivi, p. 140), spiegò al sacerdote. Orientato ormai verso l’ipotesi dello spirito maligno, parlando con il religioso aveva preso forma, però, anche l’idea che potesse trattarsi di un lato malvagio del proprio carattere, emerso in un inquietante “sdoppiamento di personalità divenuto materiale” (Ivi, p. 143).
Non addivenendo a nessuna utile soluzione, Pelham scelse di intraprendere un viaggio all’estero. Telefonando a casa per avvertire Rogerson e per dirgli di preparare le valige, con tono garbato e bonario gli rispose l’altro Pelham. Era il primo confronto diretto con il sosia. Lasciato l’ufficio, raggiunse in fretta la propria abitazione. Quel giorno, per la prima volta, aveva indossato una cravatta rossa e verde, lontanissima dai suoi gusti in fatto di abbigliamento, acquistata dieci giorni prima per assecondare i ripetuti suggerimenti circa la necessità di cambiare almeno in parte stile di vita. Si ritrovarono uno di fronte all’altro, sotto lo sguardo attonito del domestico che dovette assistere a un duello verbale e psicologico in cui ognuno dei due doveva convincere Rogerson di essere il vero Pelham. Ma proprio l’inconsueta cravatta rossa e verde rischiava di essere un dettaglio controproducente, perché se non fosse stato per i consigli dell’amico e del medico, il Pelham che tutti conoscevano non avrebbe mai acquistato, né tanto meno indossato, un accessorio simile.
Nell’ultimo capitolo del libro ritorniamo alla cornice monegasca della sala da gioco. Rimescolando le carte, il lungo racconto dello strano caso del signor Pelham si conclude informando il lettore che il sosia mistificatore, colto da un eccesso d’ira e di violenza che lo fece addirittura schiumare dalla bocca, era stato infine rinchiuso in un manicomio e che l’originale James Pelham stava viaggiando in compagnia della bella segretaria. Con i suoi occhi che “a tratti hanno qualcosa… qualcosa di fuor dal comune, qualcosa che non si riesce a spiegare […] una strana espressione” (Ivi, p. 168), col suo fare ambiguo, capace di suscitare sensazioni contrastanti, affascinante e repellente allo stesso tempo, capiamo invece che verosimilmente ad essere stato rinchiuso è il Pelham autentico: il Pelham che siede al casinò, probabile alter ego riemerso con prepotenza dal subconscio nel quale era stato a lungo confinato, è un uomo completamente diverso, “dinamico, sempre il primo in ogni affare, arrischiato, se vogliamo, ma di vedute sicure: un vero fulmine di guerra” (Ivi, p. 167).
Nella versione cinematografica, il protagonista si chiama Harold Pelham (interpretato da Roger Moore) ed è un ingegnere navale, socio fondatore e dirigente della Freeman, Pelham & Dawson Ltd., sposato e con due figli. L’ambientazione vacanziera di Montecarlo, che nel libro racchiude il lungo flashback, è del tutto omessa e nel film il racconto si svolge al presente. La sceneggiatura introduce anche un importante elemento di novità rispetto al soggetto originale: un grave incidente automobilistico, che coincide con l’inizio di quella serie di strani eventi che stravolgono la vita di Pelham. Fedelmente alla novella di Armstrong, invece, il film si concentra ampiamente sulla personalità e sulle abitudini del protagonista, soffermandosi su tutti i dettagli utili a fornire una descrizione del suo carattere che sarà fondamentale nello svolgimento della storia e nel confronto con l’intrepido alter ego.
Harold Pelham è un uomo serio, abitudinario, puntiglioso, vestito sempre in modo impeccabile e in perfetto stile inglese (Moore non abbandona il suo inconfondibile tocco british). Fin dall’inizio, quando lo vediamo uscire dall’ufficio e salire sulla sua Rover di grossa cilindrata, notiamo la precisione con cui ripone bombetta e ombrello sui sedili posteriori della vettura, liscia la propria capigliatura con la mano, allaccia la cintura di sicurezza. Nel viaggio verso casa ha anche cura di rispettare rigorosamente i limiti imposti dalla segnaletica. Ma improvvisamente qualcosa in lui prende il sopravvento: slaccia la cintura e con un’espressione di inconsueta baldanza sul volto si lancia in una folle corsa in mezzo al traffico, su una strada a tre corsie, sorpassando le altre auto. Sul totale della Rover che viaggia a tutta velocità, vediamo apparire in sovrimpressione una bella macchina sportiva argentata, che altro non è che la tangibile espressione di uno sdoppiamento di personalità che ha rivoluzionato il modus vivendi di Pelham: un’immagine simbolica che ritornerà più volte nel corso del film e verso cui la moglie Eve (Hildegarde Neil), insofferente alla vita monotona che conduce, si sentirà terribilmente attratta.
L’incauto gesto gli costa caro e, urtando contro un ostacolo, Pelham perde il controllo del mezzo e finisce in ospedale in gravissime condizioni. Sul tavolo operatorio, il battito cardiaco di Pelham si azzera brevemente. Poi, per alcuni istanti, riprende con doppia frequenza, come se ci fossero due cuori, con stupore dei medici che pensano a un malfunzionamento della macchina. Infine, la pulsazione si normalizza e l’uomo risulta fuori pericolo. A distanza di tempo, ristabilitosi alla perfezione, lo vediamo riprendere la vita e i gesti di tutti i giorni. Ha acquistato lo stesso identico modello di automobile, perché come dice sua moglie per lui “non c’è mai ragione di cambiare niente”, e si prepara ad andare in ufficio, salutando affettuosamente la famiglia, non prima di aver provveduto ad allacciare prudentemente la cintura di sicurezza: “io non dimentico mai nulla, soprattutto le cose così importanti”, dice Harold alla moglie.
Gli incredibili eventi descritti nella novella non tardano a verificarsi. Amici e conoscenti gli parlano di conversazioni, appuntamenti e serate mondane di cui Pelham non conserva alcuna memoria. Un giovedì sera avrebbe addirittura giocato una partita a biliardo, di fronte a testimoni, quando però lui si trovava all’estero per affari. Scopre anche che il presunto sosia frequenta clandestinamente una giovane fotografa, che una volta Pelham aveva incrociato per caso in piscina dopo il lavoro. “Che strano, non sembri mai la stessa persona”, gli dirà la bella amante, mentre lui, non ricordando assolutamente nulla dei loro incontri, invocherà aiuto dicendo: “Sto annegando!”.
Tutte queste situazioni, segni di un’ipotetica doppia vita oppure di un macabro scherzo, finiscono per intaccare l’aura di perbenismo e compostezza che ha sempre contraddistinto il rispettabile Pelham, compromettendo non solo il rapporto con la moglie ma anche l’ambiente lavorativo, dove si è verificato uno strano esodo di informazioni riservatissime volto a favorire in segreto una fusione aziendale. Le due personalità si affiancano, a distanza sempre più ravvicinata, al punto che Pelham può rinvenire le tracce concrete della presenza dell’altro suo ‘io’, ovvero della sua parte indomita, al circolo e a casa: un bicchiere mezzo vuoto, il fiammifero spezzato a metà come d’abitudine dopo aver acceso la sigaretta, un cappello e un ombrello identici, il colletto rigido da mandare in tintoria. Il crescendo di allucinazioni trova adeguata figurazione nelle angolature sempre più oblique della macchina da presa.
Consultatosi col proprio medico, Pelham viene indirizzato da uno psichiatra, il dottor Harris (interpretato da un notevole Freddie Jones), personaggio alternativo che indossa sempre occhiali scuri, che esaminando attentamente il caso rimane sconcertato dalla singolarità della vicenda. Nei fenomeni conosciuti come “allucinazioni da sosia”, il soggetto è convinto di avere a che fare con un proprio doppio immaginario, non con persone reali. Ma nel suo caso, sono gli altri che sostengono con convinzione la presenza di un possibile sosia. Cercando di fornire una spiegazione logica al fenomeno, lo specialista parla di contrastanti aspetti della nostra personalità che si scontrano e si combattono, in ognuno di noi, per il predominio. “Lei è un uomo di rigide abitudini, quasi puritano nella severità dei suoi principi, tanto negli affari che nella sua vita privata”, dice il dottor Harris, sostenendo anche che quest’indole irremovibile si manifesta in forma estrema nel suo rifiuto della sessualità (al contrario del suo alter ego) perfino con la moglie. La vita che conduce, il suo abbigliamento, l’auto che guida, rispecchiano chiaramente una repressione di costumi. Lo psichiatra esorta Pelham a liberare la parte latente della propria personalità, a vestirsi più vivacemente, a godersi i piccoli piaceri della vita, a non essere schiavo delle convenzioni. Del resto, come aveva sottolineato il regista americano Stuart Gordon ricordando a distanza di anni il film, “dal punto di vista di uno psichiatra, [la storia] sembra una crisi di mezza età. Un uomo infelice nel matrimonio e nella vita. Talmente rigido e contratto da andare letteralmente in pezzi” (video intervista a Stuart Gordon inclusa nel contenuto extra del DVD “L’uomo che uccise se stesso”, Edizioni Master S.p.A. 2009: “The Man Who Haunted Himself”, “Viewed by Masters of Horror”).
Nel singolare duetto tra Moore/Pelham e Jones/dottor Harris c’è una bellissima scena in stile Hitchcock che purtroppo è stata tagliata nell’edizione italiana del film. Con un’inquadratura angolata dal basso, Pelham è seduto al centro della stanza, sotto a una lampada, su una poltroncina girevole e lo psichiatra gli parla camminandogli attorno e facendolo ruotare su se stesso: Pelham gira in tondo sulla sedia, il dottore gli gira intorno e con esso anche la macchina da presa. Si tratta di una scena di particolare effetto, che produce una sorta di smarrimento, dando ulteriore forma cinematografica alla confusione mentale del protagonista.
Durante il breve ricovero in clinica, il suo gemello – quello disinibito, audace, fedifrago, amante delle auto sportive – ha ormai preso il sopravvento e si è impadronito della sua vita, della sua casa, della sua famiglia. Intanto, seguendo i consigli circa l’opportunità di cambiare stile di vita, una volta dimesso Pelham ha deciso come prima cosa di indossare un abito e una cravatta molto inusuali per il suo gusto: similmente al racconto originale, questo dettaglio gli si ritorcerà contro nel momento del confronto decisivo.
Dapprima di fronte allo sguardo stranito di moglie, figli e domestico, e poi faccia a faccia da soli, i due Pelham si scrutano a vicenda e uno dei due si muove lentamente intorno all’altro, con effetti visivi notevoli per l’epoca: sono le due antitetiche espressioni di una psiche che ha fatto emergere un lato recondito. “Io sono te, tu sei morto quel giorno sul tavolo operatorio. Per alcuni attimi sei morto sul serio e questo mi ha permesso di uscire, solo che purtroppo tu hai ricominciato a vivere… e quindi, adesso siamo in due. Ma non può andare avanti così, lo sai bene. Uno di noi dovrà andarsene”, spiega il nuovo Pelham. In un inseguimento notturno, sotto la pioggia, il vecchio Pelham (quello puritano, austero e pedantesco) precipita nel Tamigi a bordo della sua Rover e scompare per sempre. Il suo doppio, in piedi sul ponte, guarda l’altro inabissarsi nel fiume; per un attimo sembra colto da simbiotico malore, porta la mano al cuore con aria sofferente, ma dopo pochi istanti si riprende: ora è lui l’unico Harold Pelham.
Una nota dolente del film riguarda Basil Dearden, qui alla sua ultima regia cinematografica prima di morire in circostanze tragiche. Nel maggio del 1971, infatti, il regista rimase coinvolto in un tragico incidente d’auto mentre rientrava dai Pinewood Studios, perse il controllo della vettura a velocità sostenuta e finì decapitato, per ironia del destino proprio nel tratto di strada dove pochi mesi prima era stata girata la scena dell’incidente di Harold Pelham all’inizio del film.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
VENTESIMA EDIZIONE DI SEDICICORTO FORLI’ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
di Paolo Micalizzi
Si è svolta a Forlì la 20esima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, ideato e portato avanti come Direttore Artistico con passione e grande capacità da Gianluca Castellini. Un Festival che fa ritornare Forlì ad essere la capitale del cortometraggio internazionale. Cosa rappresentano 20 anni, è stato chiesto a Castellini nel corso della Conferenza Stampa di presentazione: la voglia delle scelte responsabili o la ricerca di una nuova pazzia? “C’è un po’ di tutto questo, è stata la risposta. Ma, come un ventenne, si naviga in un mare di variabili che nel bene e nel male, determinano l’esito di un percorso. Ogni volta è una conquista, con il sapore che consumi giorno dopo giorno, lasciando la parte migliore in fondo, per farla durare il più a lungo possibile. Lo spettacolo del cinema si rinnova con le sue luci spente, la voglia di stupire e l’opportunità di ascoltare storie di paesi sconosciuti. Un’occasione per avvicinarsi al mondo, seduto semplicemente su una poltrona qualunque vicino al tuo compagno di viaggio”. E quest’anno, il viaggio ha portato il pubblico in 44 paesi offrendogli 158 cortometraggi divisi tra le 7 sezioni della competizione ufficiale e le 3 fuori concorso che sono inseriti all’interno di alcuni progetti speciali del Festival. Sono tornati a Sedicicorto alcuni appuntamenti: Il centenario, pillole di storia del cinema a cura di Enrico Gaudenzi che ha ci portato in un viaggio nel cinema del 1923 facendoci vedere “Il grido dell’Aquila” di Mario Volpe, “La sorridente signora Beudet” di Germaine Dulac, “Ombre ammonitrici” di Arthur Robison e “Preferisco l’ascensore” di Fred C. Newmeyer e Sam Taylor con l’irresistibile comico Harold Lloyd; Cinebox, realizzato da Gabriella Maldini, che ha presentato, cogliendo l’occasione della celebrazione dei 70 anni dell’iconico “Vacanze romane” con Audrey Hepburn , una serie di titoli che indagano sul rapporto tra cinema, costume e moda. In programma poi una speciale Mostra fotografica sull’attrice visitabile presso Fedifo Shop&Lab.
PREMI
Hanno arricchito il programma due prestigiosi eventi: JazzinShort, concerto inaugurale a cura del noto trombettista Tiziano Bianchi, già collaboratore di Vasco Rossi e Vinicio Capossela, e “Fango”, uno studio per uno spettatore teatrale che è stato portato sul palco della Sala San Luigi, dove si sono svolte le proiezioni, realizzato da Marco Cortesi e Mara Moschini: racconta storie della città e dei suoi abitanti colpiti dalla tragedia dell’alluvione. Un racconto per fare memoria, generare consapevolezza e ricordare. Un’inchiesta teatrale sulle cause che hanno portato ad un n evento tanto violento, sull’urgente lezione che il presente vuole lasciarci e sulla sfida che il futuro ci pone. L’evento si inseriva nel contesto delle iniziative del progetto 16ECO, grazie al quale Sedicicorto fa proprio il decalogo delle azioni green proposte a livello nazionale da AFIC -Associazioni Festival Italia di Cinema di cui fa parte e realizza momenti e contest per la tutela dell’ambiente, per una compiuta transizione green nella gestione della propria manifestazione Il Festival si è concluso con la Cerimonia di premiazione delle opere in Concorso.
I 4 Luminòr – ovvero i premi principali – sono stati assegnati come segue: il vincitore della sezione Movie è risultato il film “I promise you Paradise” del regista egiziano Morad Mostafa, già vincitore nel 2021 con l’opera “What we don’t know about Mariam”. Il cineasta è riuscito ancora una volta a colpire la sensibilità della giuria e del pubblico, grazie ad una storia raccontata con intensità e sentimenti reali.
Anche per il film vincitore della sezione Animalab, “The Black Promegranate”, ci troviamo di fronte ad un dramma esistenziale, grazie alla scrupolosa ricostruzione sperimentale del regista iraniano Ali Zare Ghanatnowi. Un film che la giuria ha dichiarato come opera indispensabile per non perdere il contatto con il dramma legato alla negazione dei diritti di una giornalista.
Per la sezione Cortitalia, riservata alle opere Nazionali, si è aggiudicato il primo premio il film “In tutte le ore e nessuna” di Davide Minotti e Valeria Miracapillo. Anche qui ci troviamo di fronte alla privazione di libertà della scrittrice e attivista turca, Asli Erdogan. Un racconto toccante su alcune delle tappe più importanti della sua travagliata vita.
Il premio per la migliore opera della sezione Cortinloco, riservata alla cinematografia della Regione Emilia Romagna, è stato assegnato a Claudio Casazza, per il film “Cicciolina Pocket”, racconto nostalgico e divertente di quattro adolescenti che vivono in un piccolo paese di periferia. In tutto sono stati assegnati 20 premi e riconoscimenti per un valore di oltre 4.000 €.
Sedicicorto ha assegnato un Premio alla carriera Cinemaitaliano.info al noto attore Silvio Orlando ed il Premio Generazione G, per l’attrice del futuro, a Mila Damato, convincente protagonista del film” Estasi” di Domenico Laddaga.
Il Premio Fedic va, invece, a “La Musica nel sangue” di Alessandro Zaffanella.
Le motivazioni dei premi sopra indicati:
“I promise you paradise” – Perché, attraverso immagini come quadri, il regista descrive, con rara sensibilità e precisione, una periferia del mondo e dell’anima, che prende lavia migrante del mare come l’ultimo dei paradisi sperati e continuamente perduti.
“The Black Promegranade” – “L’animazione è sempre più il linguaggio privilegiato dai cineasti per raccontare la realtà. Lungi dal limitarsi a ‘decorare’ le immagini dal vero, essa le esalta, le trasfigura, conferisce loro una potenza e una universalità che superano le barriere emotive e ideologiche dello spettatore, giungendo, per sua stessa natura, a ridare corpo – e vita – a quanti ne sono stati privati ingiustamente. La voce – e gli occhi – della protagonista di questo film riemergono per lanciare un grido insopprimibile contro la tirannide che nemmeno la morte può zittire, e rappresentano un monito necessario per questi tempi smemorati e indifferenti. Il premio Animalab 2023 viene assegnato dalla giuria a “La grenade noire” (“The Black Pomegranate”) di Ali Zare Ghanatnowi.
In tutte le ore e nessuna – Il premio come miglior cortometraggio va a “In tutte le ore e nessuna” per la vivacità e la cura con cui sviluppa l’idea del collage visivo, capace di valorizzare al massimo le immagini d’archivio confermando l’opportunità di un’attualizzazione sempre possibile. Un lavoro pieno di invenzioni, visive e sonore, mai fini a loro stesse ma anzi funzionali a rendere il messaggio più efficace, il coinvolgimento più completo. Interessante in particolare la trovata della voce, quale “eco che parla in te”.
Cicciolina Pocket – Per la spontanea autenticità, portando in vita un momento delicato e privato della giovinezza, come l’acquisto di una rivista hard. Un’opera che cattura la vita dei giovani di una volta con cura e leggerezza, regalandoci un’emozione sincera che ci ricorda la bellezza della vita.
Premio alla Carriera Cinemaitaliano.info a Silvio Orlando: Per la spontanea ed empatica presenza dell’uomo della porta accanto, capace d’interpretare personaggi contrastanti. Un uomo che con naturalezza trascina sul set una carica di emotiva affabilità. Un uomo che vorremmo vedere, come protagonista, nel nostro prossimo film del cuore.
Premio Generazione G a Mila Damato: Una giovane attrice, capace di esprimere i sentimenti più nascosti, con una enorme forza espressiva e padronanza del set. Riteniamo Mina una delle più autorevoli interpreti di cui la scena del cinema Italiano avrà in futuro bisogno.
Premio Fedic: Per avere creato una parodia divertente ed efficace, a partire da una frase estremamente popolare che rende l’idea di come un individuo non possa fare a meno della musicalità, anche a costo di perdere la propria vitalità. La musica accompagna la nostra vita ed il protagonista ne è un parodistico testimone.
FESTIVAL ED EVENTI
VENEZIA. UNA MOSTRA DEL CINEMA CHE RISCUOTE SEMPRE PIU’ SUCCESSO. I PREMI PRINCIPALI
di Paolo Micalizzi
Una Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia che si è conclusa con un verdetto che la critica ha condiviso per gran parte. E con un successo di presenze superiore del 17 per cento sull’edizione del 2022. Duecentotrentamila poi gli ingressi complessivi nelle sale, 85 mila i biglietti venduti al pubblico e oltre 13.000 gli accrediti ritirati. Numeri che testimoniano un interesse sempre maggiore di pubblico ed accreditati(giornalisti, operatori culturali e di categorie dell’industria cinematografica) verso il più importante Festival italiano e fra i primi a livello mondiale. In quanto ai film possiamo dire che essi erano di buon livello. Vittoria con il ”Leone d’Oro”, come da previsione, del film “Poor Things”(Povere creature) del regista greco Yorgos Lanthimos, un film con protagonista Bella Baxter, una giovane donna, frutto delle macabre manipolazioni d uno scienziato senza scrupoli(Willem Dafoe) che la rende un mostro, una donna che dopo aver scoperto i piaceri della carne e della mente si batte per l’eguaglianza e l’emancipazione.
Un vero trionfo per il film “Io capitano” di Matteo Garrone che ha ricevuto il “Leone d’Argento” per la migliore regia ed alcuni premi collaterali tra cui quello della Fedic(Federazione Italiana dei Cineclub) che gliel’ho ha attribuito perché trattasi di “un film innovativo e coinvolgente che per la prima volta dà la voce ai migranti seguendo, con realismo, l’odissea di due giovani da Dakar e la Libia verso l’Italia, fra la terribile ostilità del deserto, la malvagità umana, con furti, umiliazioni, sfruttamento, atroci torture e infine la temuta incognita del mare”. Una storia che Matteo Garrone racconta evidenziando l’ingiustizia, la violazione dei diritti umani ed il rischio della vita da parte di persone che affrontano la pericolosa avventura per seguire le proprie aspirazioni. Il film è basato sulla vera storia di Mamadou Kouassi, un senegalese che ora vive a Caserta. Nel film è interpretato da Seydou Sarr che è stato premiato con la Coppa Volpi per il migliore attore. Non è stata premiata invece come miglior attrice Emma Stone, la protagonista di “Povere creature” poiché la giuria ha attribuito la Coppa Volpi a Cailee Spaeny, protagonista del film “Priscilla” di Sofia Coppola che racconta la storia della donna vissuta all’ombra del mito Elvis Presley. Una storia fatta di amore, sogni e fama. Una bella interpretazione certo che però non meritava di sacrificare quella veramente eccezionale di Emma Stone. “Leone d’Argento” al film giapponese “Evil Does Not existe” di Ryusuche Amaguchi, incentrata sul tentativo di un’azienda di costruire un camping di lusso in un villaggio di montagna, scontrandosi con l’opposizione della popolazione locale. Per la migliore sceneggiatura sono stati premiati Guillermo Calderon e Pablo Larrain per il film “El Conde” diretto dallo stesso regista cileno Pablo Larrain. Un film su Pinochet rappresentato,in chiave horror, come un vampiro che dopo 250 anni di vita terrena, fa i conti con le atrocità del suo passato, il disonore, i conflitti familiari e decide di morire una volta per tutte. Una cupa satira in un sontuoso bianco e nero. Un premio importante è poi quello dello spettatore Armani-Beauty della Sezione “Orizzonti” extra: quest’anno è stato attribuito all’esordio nella regia di Micaela Ramazzotti “Felicità” che racconta la storia di una famiglia disfunzionale. Altri i premi attribuiti alla 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Tra essi, quelli collaterali che hanno visto trionfare il film di Matteo Garrone “Io capitano” che oltre al Premio Fedic se ne è aggiudicati altri nove , tra cui quello dell’UNESCO, Signis, Soundtrack e Leoncino d’oro dell’Agiscuola.
Premi per quanto riguarda il cinema italiano anche a Mario Martone che ha ricevuto all’Ente dello Spettacolo il prestigioso Premio Bresson, mentre Sergio Castellitto con “Enea” ha vinto il Premio Bianchi del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani , Simone Massi con “Invelle” ha preso il Premio Lizzani dell’ANAC- Associazione Nazionale Autori Cinematografici e “Anna “ di Marco Amenta ha fatto sua la Menzione speciale del Premio Fedic. Il cinema italiano era presente alla Mostra di Venezia con un numero considerevole di opere, di cui sei in concorso, ed altre sparse nelle varie Sezioni. Un premio l’ha ricevuto anche Micaela Ramazzotti con il suo film d’esordio nella regia “Felicità” che nella Sezione “Orizzonti” ha conquistato il premio degli spettatori Armani Beauty. Un film il suo che parla di disagio mentale, abusi, conflitti culturali. Storia di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli. A combattere questa situazione Desirè (da lei interpretata), la sola che può salvare suo fratello Claudio e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell’unico amore che conosce, per inseguire un po’ di felicità. Nella stessa Sezione anche “El Paraiso” di Enrico Maria Artale, che ha conquistato il premio per la migliore sceneggiatura, film che racconta un rapporto malato fra madre e figlio (Edoardo Pesce) che lavorano per uno spacciatore di droga della zona. Un’esistenza ai margini vissuta con amore, al tempo stesso simbiotica e opprimente, che viene stravolta dall’arrivo di una giovane colombiana reduce dal suo primo viaggio come “mula” della cocaina. Premio , quello della Giuria, anche a “Una sterminata domenica” di Alain Parroni su tre giovani di cui è raccontato il romanzo di formazione tra la campagna del litorale laziale. Poco successo per gli altri film italiani in concorso: “Lubo” di Giorgio Diritti, “Enea” di Pietro Castellitto e “Comandante” di Edoardo de Angelis che grazie al protagonista Pierfrancesco Favino sicuramente sperava in una maggiore fortuna, “Adagio” di Stefano Sollima. Una grande soddisfazione, comunque l’Italia l’ha avuta con il “Leone d’Oro” alla carriera all’immensa Liliana Cavani.
LA XXIV EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE
di Paolo Micalizzi
Si è svolta a Lecce la XXIV edizione del Festival del Cinema Europeo diretto con capacità e passione da Alberto La Monica che si avvale di uno staff che rende molto accogliente la partecipazione sia degli ospiti che del pubblico: fra i collaboratori il fratello Luigi che lo affianca nella selezione delle opere e l’ufficio stampa di Giovanna Mazzarella e Cristina Scognamillo. Il Festival si è articolato in alcune Sezioni: 10 film Europei del concorso Ulivo – d’Oro Premio Cristina Soldano, Cinema &Realtà – rassegna di documentari italiani, Premio Mario Verdone, Premio Emidio Greco, Puglia Show-Concorso di cortometraggi per giovani registi pugliesi, Vetrina dedicata alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Finalisti del Premio Lux del Pubblico del Parlamento Europeo. Fra gli ospiti Michael Winterbottom che ha accompagnato il suo nuovo film “Shorshana”: Un thriller politico ambientato negli anni Trenta che affronta il modo in cui l’estremismo politico e la violenza creino una separazione tra le persone costringendole a scegliere da che parte stare. Accanto a questo film ve ne sono stati altri 6, scelti tra quelli di prossima uscita nelle Sale italiane. Vi sono stati “Giorni felici” di Simone Petralia con la presenza di Anna Galiena e Franco Nero, “8 giorni in agosto” di Samuel Perriard, “Improvvisamente a Natale mi sposo” di Francesco Patierno che è stato presentato dal regista insieme a Diego Abatantuono, “I limoni d’inverno” di Caterina Carone con la presenza della regista e di Teresa Saponangelo, “Ricomincio da me” di Nathan Ambrosini.
La protagonista del cinema italiano è stata Micaela Ramazzotti alla quale è stata dedicata una Retrospettiva con cinque film da lei interpretati e con “Felicità” che ha segnato il suo esordio nella regia e che è stato da lei presentato. Sono stati anche omaggiati Gianni Minà con la presentazione del docufilm “Gianni Minà – Una vita da giornalista” di Loredana Macchietti Minà che ha presentato anche il libro di Gianni Minà “Fame di storie”. Ma anche Nico Cirasola, un amico del Festival del Cinema Europeo, con una Retrospettiva dei suoi sei lungometraggi ed un incontro – ricordo con parenti ed amici del regista pugliese recentemente scomparso. Quella del regista pugliese Nico Cirasola è stata una riscoperta meritevole che rende Omaggio ad un autore, ma anche ad un personaggio, che si era distinto, oltre che per innata simpatia, per un cinema singolare che si nutriva della sua terra, la terra pugliese che lui trasferisce in film dai titoli bizzarri come “Albania Blues” o come “Focaccia Blues” ma anche nel ricordare il mito Valentino nel film “Rudy Valentino”.
Io l’ho conosciuto nel 1990 quando ad un Convegno del Sindacato Nazionale critici Cinematografici Italiani, svoltosi a Bari, lui presentò “Odore di pioggia”, film che vedeva il suo debutto di regista dopo un’intensa attività in un Cinecircolo da lui fondato a S. Teresa dei Maschi che il “Corriere della Sera” considerava “il cuore propulsore della Cultura in Puglia”, alcuni documentari ed un Festival di cinema e video. Un film, “Odore di pioggia”, incentrato su Totò, un personaggio sognatore che passa le notti a scrivere poesie e che in un giorno in cui nell’aria c’è odore di pioggia un Angelo Azzurro, impegnato nelle riprese di uno spot, s’insinua nella sua vita. Un film che ci colpì per l’intensa narrazione venata di uno spirito naif. Un altro autore omaggiato al Festival è stato il giornalista Gianni Minà, la cui vita è raccontata da Loredana Macchietta aiutando lo spettatore a capire l’evoluzione o l’involuzione dell’informazione in Italia. Ospiti illustri del Festival, tra gli altri, il regista inglese Michael Winterbottom, Franco Nero, Anna Galiena, Micaela Ramazzotti, Diego Abatantuono e Teresa Saponangelo. Ma anche Silvia e Luca Verdone che con il fratello Carlo, collegato online, hanno riferito sul Premio intitolato al padre Mario assegnato quest’anno( il Premio è alla sua XIV edizione) al film “Discoboy” di Giacomo Abbruzzese scelto tra le sei opere prime in Concorso. Un film che racconta la ricerca di una propria identità di un uomo che passa attraverso esperienze estreme. In tema di Premi riferiamo ancora che miglior film è stato giudicato il francese Midwives” di Léa Fehner che racconta di due ragazze diventate ostetriche che si troveranno ad affrontare responsabilità piene di difficoltà. Il premio speciale della giuria è andato invece a “Légua” di Filipa Reis e Joao Miller Guerra, per la miglior sceneggiatura a “Remember to Blink” di Austéja Urbaitè, premio del pubblico a “Vasil” di Avelina Prat , premio della Fipresci al film “Copenhagen does not exist” di Kobenhavn Finders Ikke, la cui attrice Angela Bundanovic ha ricevuto il premio del Sindacato dei Giornalisti italiani . Premio Emidio Greco, in ricordo di un regista pugliese al cortometraggio “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella imperniato sul tema dell’omosessualità. Anche la Puglia ha assegnato dei Premi. Il riferimento è in particolare al Concorso per cortometraggi di giovani registi pugliesi “Puglia Show” che ha visto la vittoria di “Paramore” di Andrea La Medica e Francesco Mastroleo. Per il protagonista del cinema europeo la scelta quest’anno è caduta, giustamente, su un regista di grande rilievo come Roman Polanski di cui è stata presentata un’ampia Retrospettiva, a cura di Massimo Causo.
Il Festival si è chiuso con la proiezione del film “Chimera” di Alice Rohrwacher alla presenza degli attori Vincenzo Nemolato e Yile Vianello.
“O CORNO” CONCHIGLIA D’ORO DEL 71° FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN
di Alessandra Pighi, Xoxan Villanueva
Per la quarta edizione consecutiva, una pellicola diretta da una donna, Jaione Camborda, “O Corno” ha vinto la Conchiglia d’Oro per il Miglior Film del Festival del Cinema di San Sebastiàn. Un trionfo storico per la regista nata a San Sebastiàn, che è diventata la prima regista spagnola a vincere il premio principale, in questa 71esima edizione, tenutasi dal 22 al 30 settembre. Il film ci porta in una città della Galizia, in Spagna, negli anni ’70, dove un’enigmatica ostetrica, che si occupa sia di nascite che di aborti, deve fuggire in Portogallo dopo la morte di un’adolescente che aveva aiutato ad abortire. Una fuga drammatica per la sopravvivenza, sullo sfondo l’aiuto della solidarietà femminile. Un sottile appello a favore del diritto della donna a decidere del proprio corpo. Possiamo dire che è stato un premio meritato quello assegnato dalla giuria del festival presieduta da Claire Denis, una delle voci più chiare e riconoscibili del cinema europeo contemporaneo.
La Conchiglia d’Argento per la Migliore Regia è stata assegnata ai cineasti taiwanesi Peng Tzu-Hui e Wang Ping-Wen per “A Journey in Spring”, una storia bella e dolorosa di riconciliazione e lutto di un uomo che si rende conto, nella sua solitudine da vedovo, degli errori nei confronti della moglie e del figlio. Una consapevolezza che comporta sia l’accettazione degli insuccessi della vita, sia la riparazione, anche simbolica, degli errori del passato. Una delicata passeggiata attraverso la primavera, l’amore e la morte. La Conchiglia d’Argento per la Migliore Interpretazione Protagonista è andata, ex aequo, al veterano attore giapponese Tatsuya Fuji, che interpreta un professore universitario, che sprofonda nella sua follia senile in “Great Absence”. Un film che ci ricorda la sofferenza causata dal declino mentale. Opera discontinua, ripetitiva, con sequenze che si trascinano inutilmente, che trasuda comunque un certo lirismo nelle battute finali, alle quali si arriva piuttosto esausti. Il premio è stato condiviso dall’attore argentino Marcelo Subiotto, anche lui docente universitario di filosofia nel lungometraggio “Puan”. Film argentino, che ha vinto anche il premio per la migliore sceneggiatura, scritto dai suoi registi, María Alché e Benjamín Naishtat. Due professori universitari, estremamente opposti per stile e pedagogia, si contendono la proprietà di una cattedra vacante. Una commedia leggera e divertente che ci mostra il competitivo mondo universitario, con i suoi conflitti, le miserie da un lato e la solidarietà e il cameratismo dall’altro.
Da segnalare anche i due premi vinti da “Kalak” della regista svedese Isabella Eklöf. Il Premio Speciale della Giuria e il Premio per la Miglior Fotografia sono andati a Nadin Carlsen. Basata sulla vera storia dello sceneggiatore. Una radiografia scomoda, acida e nuda dell’abuso paterno sui minori che ha molto a che fare con l’arroganza maschile, con il sesso inteso come punizione ed esercizio di dominio. Un opera scioccante per gli effetti devastanti di un trauma che dura per sempre. La Conchiglia d’Argento per la Migliore Interpretazione Non Protagonista è stata assegnata all’attore libanese residente in Spagna, Hovik Keuchkerian, per il film “Un amor”, della regista spagnola Isabel Coixet. La storia di un uomo duro che vive isolato in una città della profonda Spagna rurale, coltivando verdure e facendo lavori vari. Lì incontrerà Nat che è scappata dalla città per rifugiarsi e potersi isolare in solitudine vicino alla natura. Inizieranno una relazione sessuale complicata e complessa che attraverserà diverse fasi fino al brusco epilogo finale.
Oltre al concorso ufficiale, nelle altre sezioni abbiamo potuto vedere film molto interessanti e curiosi. Nella sezione Nuovi Registi, il premio è andato al film indiano “Bahadur the Brave” della giovane regista Diwa Shah. Una riflessione sul confinamento, durante la pandemia di coronavirus in India. Quando i lavoratori migranti nepalesi sono costretti a tornare nel loro paese, Hansi vede un’opportunità per guadagnare più soldi per il figlio malato nel momento in cui suo cognato, Dil Bahadur, gli offre un lavoro illegale. “El Castillo” dell’argentino Martin Benchimol ha vinto il premio nella sezione Horizontes Latinos. Justina, domestica per tutta la vita, eredita dal suo ex datore di lavoro un’enorme villa nel mezzo della pampa argentina, a condizione di non venderla mai. Un documentario sulle sfide di Justina nel mantenere vivo l’impegno. Il premio del pubblico è andato a “La sociedad de la nieve”, di J. A. Bayona, il film candidato spagnolo all’Oscar come miglior film internazionale. Basato sull’incidente aereo avvenuto nel 1972, su un ghiacciaio delle Ande, con 45 passeggeri intrappolati in uno degli ambienti più ostili del pianeta, costretti a misure estreme per sopravvivere. Segnaliamo infine il premio, anche del pubblico, per il miglior film europeo, al regista italiano Matteo Garrone, “Io Capitano”. L’odissea moderna di due emigranti senegalesi nel loro drammatico percorso per raggiungere l’Europa.
Premi Donostia a Hayao Miyazaki e Victor Erice
Il regista giapponese Hayao Miyazaki, uno dei grandi del cinema d’animazione mondiale, ha aperto la Sezione Ufficiale con il suo ultimo lavoro “Kimitachi wa do ikiru ka”, anteprima europea con cui conclude la sua lunga carriera cinematografica. Il Premio Donostia si aggiunge ai numerosi premi al suo attivo, tra cui l’Oscar nel 2002, per il miglior film d’animazione, “Il viaggio di Chichiro”, che vinse il Orso d’Oro a Berlino quello stesso anno. Premiato anche a Venezia, nel 2005, con il Leone d’Oro in riconoscimento alla sua carriera professionale. Nel 2014 gli è stato assegnato l’Oscar onorario per la sua carriera professionale. L’altro premio Donostia è andato a Víctor Erice, regista spagnolo nato nei Paesi Baschi, che ha ricevuto il premio in occasione della première del suo ultimo film, “Cerrar los ojos”, 50 anni dopo la Conchiglia d’Oro per il suo primo lungometraggio da solista, “El espíritu de la colmena”, un film emblematico nella storia del cinema spagnolo. Era previsto un altro premio per l’attore Javier Bardem, posticipato a prossima edizione, a causa dello sciopero degli attori di Hollywood.
In conclusione, un’edizione complessa per diversi fattori. Locale, come la polemica sulla presenza di un documentario sull’ETA, o internazionale, come lo sciopero di attori, attrici e sceneggiatori di Hollywood. I film potranno essere migliori o peggiori, ma a San Sebastián chi non delude mai sono gli spettatori. Sono state proiettate 57 anteprime mondiali. Un dato importante considerando che è l’ultimo festival dell’anno, tra i grandi festival, e quindi molto difficile attrarre grandi titoli di grandi registi e poter competere con i più grandi festival. Tuttavia, questo handicap aiuta l’organizzazione a correre dei rischi nelle sue proposte. Non tutti i film sono stati perfetti, anzi, ma una buona parte ha fornito visioni interessanti e alcune non prive di qualità.
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO
STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO “FILM WITH THREE DANCERS”
di Roberto Baldassarre
Il cinema è movimento (cinema, dal greco antico: κίνημα, -τος “movimento”), e la danza, nelle sue differenti tipologie, è anch’essa movimento (del corpo). La danza è una delle più antiche arti e/o espressioni linguistiche, prima come rituale religioso e poi come spettacolo. Nell’antica Grecia la rappresentava un momento fondamentale nelle rappresentazioni teatrali, con il “coro” che si muoveva sulla scena, e da qui il termine coreografia (χόρος, coro, e quindi in italiano coreutica). In un certo qual modo si può affermare che anche la danza – e la relativa coreografia – sia stata un antenato del cinema. Il coro, ossia gli attori, recitavano muovendosi a seconda se la tematica era una tragedia o una commedia, dando così agli spettatori un accorato senso della narrazione.
Nel cinema la danza è apparsa sin dal principio, proprio perché qualora si voleva avvalorare la magia del cinematografo, ossia il decantato movimento, non c’era più fulgido esempio di una ballerina che ballava davanti all’obiettivo, come attesta il cortometraggio “Annabelle Serpentine Dance” (1895) di William K.L. Dickson e William Heise. Da allora, fino ad oggi, al cinema sono stati prodotti molti film contenenti balli e/o danze, che hanno creato il genere musical: musica + ballo. Coreografie divenute col tempo sempre più articolate, come ad esempio i grandiosi spettacoli ideati da Busby Berkeley (1895-1976), tra gli anni ’30 e i ’40. Maggior numero di ballerini, scenografie sempre più ricercate, oppure ambientazione in un contesto urbano, “terreno”. Quest’ultimo aspetto è quello di innestare nel reale una situazione (il ballo e il canto) che usualmente rimangono nell’immaginario. In tal senso “West Side Story” (1961) di Robert Wise e Jerome Robbins è il musical che ha meglio rappresentato quel recondito desiderio degli spettatori di poter agire nella realtà ballando e cantando. A conferma di ciò l’omonimo rispettoso remake fatto da Steven Spielberg nel 2021, che attesta come quel grandioso spettacolo danzante (in riferimento alle coreografie e ai movimenti di macchina) abbia affascinato le platee di quel tempo.
Ugualmente “Tutti dicono I Love You” (“Everyone Says I Love You”, 1997) di Woody Allen, che oltre ad essere un affettuoso omaggio al musical, è una riflessione di come sarebbe più facile, bello e dolce avere relazioni interpersonali attraverso la danza e il canto; e non importa se non si è perfettamente intonati: questo elemento canoro è un’azione liberatoria, rispetto a tutti i musical in cui gli attori erano sempre perfettamente intonati e… deliziosi ballerini. Ma va citato anche “La La Land” (2016) di Damien Chazelle, straordinario successo che quasi aveva rivitalizzato il musical. Il film, praticamente, si riallaccia al discorso cinefilo e “filosofico” di Woody Allen, ma riportando tutto alla “perfezione” tecnica hollywoodiana.
La lista di musical è lunghissima, ma tra le molte opere di vario formato filmico dedicate alla danza, è interessante recuperare “Film with Three Dancers” di Ed Emshwiller. È un cortometraggio sperimentale che fu anche proiettato agli Incontri del cinema di Sorrento nell’edizione del 1970, festival che quell’anno dedicò la rassegna alla New Hollywood e al cinema Underground. Martin Scorsese, che era uno dei giurati, trovò questo lavoro interessante e… molto sexy. Il titolo di questa breve opera è già indicativo, perché mette in evidenza che sarà incentrato su tre danzatori. I protagonisti, o per meglio dire i soggetti in questione, sono Carolyn Carlson, Emery Hermans, Bob Beswick. Del trio, il più noto è la Carlson, una delle personalità più rinomate del balletto americano, nonché innovativa e ardita coreografa. Vincitrice nel 1968 del Premio come miglior danzatrice al Festival Internazionale di Danza di Parigi, dalla metà degli anni Settanta divenne anche insegnante, impartendo una metodologia che si basava sull’improvvisazione e la composizione coreografica.
“Film with Three Dancers”, a livello di cortometraggio, conferma come il breve metraggio sia perfetto per poter sperimentare nuovi linguaggi visivi, e come sia ideale per realizzare un “diario intimo”. Nello specifico della tematica, invece è un tentativo di fissare in immagini la fisicità della danza. Il trio, ripreso in differenti situazioni, attua delle coreografie sperimentali e minimaliste: in una scenografia teatrale completamente spoglia, oppure esternamente, in ambienti urbani. I danzatori di volta in volta attuano in un body “futuristico”, in maglietta e jeans (vestiario casual molto in voga in quegli anni di contestazione) e infine nudi. Questo per evidenziare come anche gli indumenti comportino una precisa modifica al significato che si vuole dare alla rappresentazione.
“Film with Three Dancers” si ricollega perfettamente al cortometraggio “Annabelle Serpentine Dance”, poiché il lavoro svolto da Ed Emshwiller è principalmente visivo. Con il corto l’autore vuole trasmettere agli spettatori, attraverso uno stile fortemente sperimentale, il movimento. I balletti in body oppure quelli in cui i tre ballerini sono completamente nudi, sono ripresi utilizzando l’effetto stroboscopico, sulla falsariga di Norman McLaren, proprio per rendere visibile il movimento dei corpi. E il balletto finale, con le riprese che divengono sempre più veloci, trasformano i corpi in puro astratto movimento. Un’opera visiva, ma anche un “diario intimo”. Brevemente, nel corpo centrale del cortometraggio, mentre il trio pratica coreografie avanguardistiche in contesti urbani o in teatro, appaiono le loro voci fuoricampo. Sono “flussi” riflessivi riguardo la danza o confessioni personali. Un inserimento sonoro che da “anima” a questi tre corpi, altrimenti anonimi e, come nelle altre parti dell’opera, commentate da musica elettronica, estraniante.
Ed Emshwiller (1926-1990), attivo dalla fine degli anni Cinquanta fino alla fine degli anni Ottanta, è stato principalmente un illustratore di copertine di riviste e romanzi di fantascienza, e registicamente le sue opere si concentravano sull’elaborazione dell’immagine. Un artista che ha molto sperimentato, anche con il digitale, quando ancora era in forma primitiva. Tra le sue realizzazioni più note, le riprese di Bob Dylan mentre canta “Only a Pawn in Their Game” il 6 luglio 1963, ad un Voters’ Registration Rally di Greenwood, Mississippi. Riprese che furono poi usate per i documentari “The Streets of Greenwood” (1963) di Jack Willis e “Don’t Look Back” (1967) di D. A. Pennebaker.
“Film with three dancers” – Regia: Ed Emshwiller; Con: Carolyn Carlson, Emery Hermans, Bob Beswick; Durata: 19:00 (24 fotogrammi al secondo)
OCCHIO CRITICO
“AMUSIA”: PRIMO LUNGOMETRAGGIO DI MARESCOTTI RUSPOLI
di Paola Brunetta
Amusia, primo lungometraggio di Marescotti Ruspoli, è un’opera singolare. Fredda, geometrica, lineare; ma anche calda e irregolare e spiazzante. Più spiazzante ancora è il problema che mette al centro del racconto, lo stesso del titolo, una patologia (scoperta a fine ‘800 ma riconosciuta solo nel 2005) che rende biologicamente incapaci di decodificare la musica, che risulta per le persone che ne soffrono un rumore indistinto o disturbante.
Nel film ne è affetta Livia, figlia di un autore di colonne sonore che non riesce a spiegarsi il disturbo della figlia e che passa degli anni a cercare la canzone che possa risolvere il problema, arrivando, alla fine, arreso, a regalarle dei tappi per le orecchie. Dall’altro lato c’è Lucio, cresciuto nella musica perché i genitori, ora defunti, erano dei cultori di quell’arte e gli hanno instillato non solo l’amore per i grandi del jazz e del rock (John Coltrane, Nina Simone, i Joy Division sono nomi che ricorrono) ma anche quello per i luoghi in cui la musica si ascolta, comprese balere e discoteche. Lui fa ballare gli anziani del suo paese nel vecchio night club e quando va a trovare i genitori in cimitero, porta con sé un mangianastri. Quando i due ragazzi si incontrano, e lo fanno in un modo particolare, nel motel (un love motel, come quelli che ci sono in Giappone) in cui Lucio lavora e a cui approda Livia, in fuga dai genitori e da se stessa, chiedendo incredibilmente una stanza per tutta la notte e magari anche con la colazione, l’attrazione si mescola alla paura e porta più volte la ragazza a fuggire e a ritornare, scoprendo, alla fine, che di Lucio si può fidare e che la conseguente apertura, con il racconto del disturbo che la affligge, è anche un modo per riconciliarsi con se stessa e con la propria famiglia. Lucio, dal canto suo, si mette in gioco; abbandona il proprio quotidiano piacevole ma monotono, fatto di libri, dischi e partite a biliardo con il migliore amico di suo padre, quindi di passato e nostalgia, per provare a vivere davvero, a vivere la propria, di vita, anche se questo comporta, per stare con Livia, rinunciare alla musica: si può ballare anche senza, le dice alla fine.
Tante cose e belle dense: amore, sentimenti, drammi ma anche leggerezza, sorriso, gioco. Un richiamo ai film francesi con “i ragazzi che si amano” di Prévert, il piacere di stare insieme, la lentezza della conoscenza che si fa qualcosa di diverso, qualcosa di più importante. E l’originalità di un’opera prima decisamente matura, che lavora sul visivo, con attori ottimamente in parte (i protagonisti sono Carlotta Gamba e Giampiero De Concilio, i genitori di lei Maurizio Lombardi e Fanny Ardant), per parlare dell’uditivo e per compensarlo.
Il film presenta infatti una confezione molto particolare, a partire dai luoghi in cui è stato girato. Siamo nell’Emilia degli anni Ottanta (i telefoni fissi, i vinili e le musicassette, le balere e i vecchi bar con il biliardo…) ma l’idea è quella di un film che non abbia né uno spazio né un tempo specifici, che sia qualcosa di metafisico, di universale. Poi però i luoghi e le architetture in particolare gli danno un tocco originalissimo, in sintonia con i personaggi e con quello che provano, a partire da Tresigallo con i suoi edifici unici (uno di questi nel film è la casa di Lucio ed è sovrastato dalla scritta “Sogni”) per arrivare al cimitero di San Cataldo (Modena), quello moderno di Aldo Rossi e Gianni Braghieri, in stile razionalista-metafisico. E interessanti sono anche i paesaggi naturali, l’Emilia di Ghirri e dei CCCP tra Modena, Ferrara e Reggio, mare, campagna, cielo e strade lunghe che chissà dove porteranno, in un minimalismo astratto, metafisico appunto. Per un film che da un altro punto di vista è molto pieno (di immagini, di note, di bellezza e di sostanza), e che a un’ottima sceneggiatura, sempre di Ruspoli, accompagna la fotografia di Luca Bigazzi, interessante anche sul piano cromatico.
LA TONALITA’ DI “IO CAPITANO”
di Tullio Masoni
Quando vi sono urgenza di sostegno alle cause e denuncia, il rischio di “buonismo” (brutta parola) c’è sempre. Nell’allestire il racconto e stabilire il gioco delle parti, Garrone affronta il rischio e credo lo corra. Ma ha la franchezza, e in certo senso l’umiltà, di usare la fiaba; che assorbe il reale, lo adegua ai propri modi e lo rilancia – lo arricchisce – fra repliche e variazioni.
Incontriamo allora, molti lo hanno rilevato, la crescita avventurosa di Harvey in “Capitani coraggiosi”, poi Hansel, Gretel e Pollicino, Pinocchio (già riproposto dallo stesso Garrone in forme altamente spettacolari), gli eroi deamicisiani, Enea col vecchio padre sulle spalle…E soprattutto, a mio avviso, il Bori ka di “Andrej Rublëv”, che costruisce una campana senza averlo mai fatto come, a rischio della vita, faranno Seydou e il suo maestro con la fontana del mafioso libico. Bambini, adolescenti e giovani che scoprono il coraggio, l’astuzia e la responsabilità per salvarsi e salvare, cioè rispondere alla cattiveria o alla stanchezza degli adulti.
La fiaba viaggiante di Garrone si affida – per sublimazioni visive, paesaggi fra orrore e incanto, e il mistero del mare – a una eccezionale equipe di collaboratori tecnici poi, dall’incipit ai titoli di coda (dove il dettaglio coloristico-fotografico elabora la suggestione della pittura esotica ottocentesca), a una tonalità costante.
Ricordando uno dei suoi viaggi, Moravia scriveva: «… un villaggio (…) uno squallore fantastico, quasi incredibile, come sono spesso le cose dell’Africa…». Lo scrittore non riferiva del Senegal, ma ho sempre avuto l’impressione che, nei drammatici reportage proposti dalla TV in occasione di crisi violente e migrazioni, qualcosa accomunasse le immagini che venivano da zone lontane fra loro. Questo qualcosa era, e credo sia, la tonalità.
Comincia dal nero/bruno della pelle; un nero/bruno dorato che sfuma atmosfericamente i colori squillanti di stoffe e oggetti, le luci notturne e l’abbaglio dei gialli. Sfuma senza però diminuire, dei colori stessi, la forza e gli stacchi. Il nero/bruno, quindi, e il ramato delle mucose: labbra che rammentano quelle di certe statue greche in bronzo. Una simile morbidezza aveva dato carattere e classicità a “Lettere dal Sahara” di Vittorio De Seta: il giovane senegalese fuggiasco, all’inizio di quel film, attraversa la Valle dei templi di Agrigento e confronta il colore della pelle con quello dominante del tufo. Viene dall’antico, il giovane, vi tornerà e dopo, lasciata la testimonianza, potrebbe ancora attraversare il Mediterraneo. Non sappiamo se la dignità cui il suo maestro di vita richiama tutti, sarà sufficiente a vincere la corruzione che ovunque assedia l’immigrato in Europa, ma a furia di perderla e ritrovarla forse il giovane le darà un luogo.
Una dignità che Garrone, in “Io Capitano”, attribuisce soprattutto alla madre e a come il legame con lei vive nei sentimenti pur disperati di Seydou. L’angelo che porta il ragazzo a vederla – senza che lei possa vedere lui, però, e gli parli – assolve un compito omerico: accompagna nel regno dei morti. La donna che morirà nel deserto, infatti, rappresenta per Seydou la propria madre; cioè il sogno di un ragazzo, che poi rovescia la felicità degli amanti di Chagall e fa correre le tragiche spoglie della donna come un aquilone.
Colori sgargianti nel cielo infuocato del deserto; e ancora, forse, un dolce tono che, sia pure per poco, frenerà il male.
“IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI
di Tullio Masoni

Com’era prevedibile il film di Moretti ha sollevato contrasti e polemiche nella critica e negli spettatori.
E’ accaduto spesso. Per il passato più recente e meno, ad esempio, ricordo i giudizi (sempre disinvolti) di Tatti Sanguineti che aveva promosso, per così dire, una gara sul peggio fra “La stanza del figlio” e “Mia madre”. Sanguineti è un eclettico talvolta brillante che con sincera modestia tengo in conto; e siccome avevo apprezzato i due film fui indotto a riconsiderarli. Non cambiai idea, ma la verifica mi aveva convinto una volta di più che Moretti divide anche per una presunzione “di appartenenza” (un po’ come accade col tifo sportivo) e visceralità. Qualche amatore diventato ex si è gettato contro “Il sol dell’avvenire” in una sorta di furore iconoclasta: se la passione – sportiva o culturale – viene meno, i difetti di replica (frequenti nel cinema dell’autore romano) pesano di più; ma la passione è volubile e spesso, con dismisura, rovescia pareri e preferenze. Lontano da porre paragoni impropri: quanto ci ha messo Bellocchio a riconquistare consenso dopo il pregiudizio creato dal capolavoro di esordio? Credo avesse ragione il fratello Piergiorgio a dire che l’entusiasmo suscitato da “I pugni in tasca”: «…preannunciava un futuro tutto in salita…come uno che fa il record alla prima corsa».
Quanto a me, ho seguito negli anni il lavoro di Moretti con attenzione talvolta ammirata, talaltra prudente; “II sol dell’avvenire” in quest’ultima occasione, mi ha indotto a sorvolare sui “vizi” per apprezzare le “virtù” che nell’opera credo abbiano rilievo.
In primo luogo la messa in scena di un sogno politico, o meglio di un “se” storicamente non ammesso, che per via di sogno guarda all’ideologia e soprattutto alla sua applicazione nel partito di massa, cioè nel PCI. Un modo di preservare alcuni fondamentali valori tenendo al centro, in forma di commedia, le più gravi denunce.
Va ricordato che nel cinema italiano la crisi ungherese del 1956 è stata quasi rimossa. Fu l’argomento di un film di Indro Montanelli: “I sogni muoiono all’alba”, del 1961, poi solo sfiorato nell’incipit della “Rabbia” di Pasolini, del 1963, e in un equivoco commento pur nell’ottimo “All’armi siam fascisti”, del 1962. Più nulla, almeno di rilievo. Il film di Moretti riesce, in certa maniera, a proporre quel conflitto cruciale e andare in profondità riprendendo la buona e la mala fede dei capi e dei militanti di base. Non bisogna dimenticare, a proposito della base di partito, che l’interesse del cineasta ha offerto non trascurabili precedenti come, per citare il più prezioso, “La cosa”, del 1990: una telecamera che entra nelle sezioni del PCI per documentare il dibattito sulla svolta avviata da Achille Occhetto alla Bolognina.
Altre “virtù”. Gli omaggi felliniani che non si limitano a coniugare la lirica nostalgia dei quadri della “Dolce vita” con Lontano lontano, una delle ultime canzoni di Luigi Tenco, o l’allusione lievissima, quasi “distratta”, al guardare da auto ad auto, da abitacolo ad abitacolo, com’era stato in “Otto e mezzo e Roma”, o ancora la memoria del circo, convenzionale fin che si vuole, ma fantasticamente curata e felice. Poi l’autoironia della danza, un montaggio coreografico in cui Moretti celebra l’affetto privato e la pubblica allusione. Infine, ma altro ci sarebbe e non voglio farla lunga, il corteo conclusivo con l’innalzamento del ritratto di Trotskij. Perché Trotskij! Si è lamentato qualcuno. Forse perché, e non mi pare sia una scoperta, è stato il più famoso nemico dello stalinismo – così determinante nella tragica vicenda ungherese – senza rinnegare gli ideali della Rivoluzione o, se vogliamo, della socialdemocrazia radicale che occorrerebbe oggi.
Il corteo, a ogni modo, richiama il girotondo finale di “Otto e mezzo” (narcisisticamente, sì, che novità!) e, al tempo stesso, “Sovversivi” dei Taviani. Autori questi ultimi che Moretti mi pare abbia sempre stimato e che, fra tante incertezze, hanno dato forza, carattere e utile ambiguità al passaggio d’epoca segnato su vari schermi dai funerali di Togliatti. Ben oltre il famoso quadro di Guttuso, e non lontanissimo dall’inquietante, poetica suggestione di “Uccellaci e uccellini”. Un capolavoro, “Il sol dell’avvenire”? Non direi e non occorre, ma per molti che avvertono le affinità nel profondo e nel tempo, una “compagnia”.
TRANSILVANIA “ANIMALI SELVATICI” DI CRISTIAN MUNGÌU; “EL CONDE” DI PABLO LARRAÌN
di Paolo Vecchi
Mathias torna in patria dalla Germania dove lavorava in un macello dal quale é fuggito dopo aver picchiato un collega che lo ha chiamato zingaro. Al villaggio ritrova la moglie Ana, il figlio sordomuto, il vecchio padre malato e l’amante di un tempo, Csilla, impiegata in un panificio industriale. La titolare, non trovando manodopera disposta ad accettare uno stipendio da fame, la fa venire dallo Sri Lanka, suscitando la reazione degli abitanti della comunità.
Fin dai tempi dell’Impero Austroungarico, in Transilvania convivono rumeni, ungheresi e tedeschi. A questo coacervo di etnie e lingue, in “Animali selvatici” si aggiungono gli immigrati di pelle nera, verso i quali il protagonista, paradossalmente ma non tanto, finisce per dimostrarsi intollerante, lui che in Germania era stato a sua volta oggetto di discriminazione. In un formidabile piano sequenza a macchina fissa, il regista di “Un padre, una figlia” (2016) mette in scena in maniera straordinariamente incisiva il punto di vista di ciascun gruppo, dei suoi interessi e soprattutto delle sue paure. Questa volontà di analisi viene dichiarata quasi in via preliminare dal titolo originale, “R.M.N.”, acronimo che in rumeno indica la risonanza magnetica ma che, aggiungendo le vocali alle consonanti, va a comporre il nome del paese danubiano.
Ma c’è di più, nell’ambizione di Mungìu. Un giovane ricercatore francese, che si aggira tra il villaggio e le foreste per studiare gli orsi, si sforza ingenuamente di capire anche le ragioni della variegata umanità che li abita, ma è l’unico a non arrivare a nulla. Se il regista lascia senza risposta le paure di un bambino che si imbatte in un impiccato nel bosco o, più in generale, il magma che si nasconde nelle intercapedini delle tradizioni dei popoli, affronta dietro il paravento della metafora il tema di coinvolgente attualità della difficile integrazione europea degli stati un tempo nell’orbita dell’ex impero sovietico. “Anche durante il periodo comunista, ha dichiarato, noi ricevevamo un’educazione, in particolare a scuola, molto diretta verso la cultura occidentale…E siamo stati delusi nel constatare che, a trent’anni dalla caduta del Muro, ciò che gli Occidentali conoscono dell’Europa dell’Est si riduce a degli stereotipi…In un mondo globalizzato, come avanzare insieme in un’Europa democratica senza avere un minimo di scambi un po’ più equilibrati? Mi sembra che la pretesa democrazia sia diventata faticosa per certe persone, che richieda uno sforzo della volontà e non ci si arrivi in modo naturale. E’ stata imposta a una categoria di persone poco educate, cosa che ha funzionato per un certo periodo, ma alla fine possono trovare impegnativo dover decidere tutto. Si chiedono se non sia più semplice avere qualcuno che decida per loro e non ne chieda continuamente l’opinione su tutto”. Ovvero la tentazione della cosiddetta democratura, che appartiene anche agli altri europei, che la democrazia la praticavano da decenni e che sembrano oggi sottoposti a suicide tentazioni autoritarie.
La Transilvania è la patria di Vlad l’Impalatore, il modello degli innumerevoli Dracula che si sono succeduti nella letteratura e nel cinema. Dunque, secondo “El Conde” di Pablo Larraìn, da qui viene, sia pure indirettamente, anche Augusto José Ramòn Pinochet Ugarte. Il generale che perpetrò il golpe del 1973, l’assassino di Salvador Allende, il massacratore di decine di migliaia di cileni, è infatti un vampiro venuto al mondo circa 250 anni fa e tuttora in qualche modo attivo. Concepito nella Francia prerivoluzionaria da una contadina e da un militare che durante l’amplesso le ha affondato i canini nella giugulare, come sanculotto ha assistito alla decapitazione di Maria Antonietta, riuscendo a impadronirsi della testa della regina, primo fra i cimeli che avrebbero poi fatto parte dell’arredamento del suo studio, insieme a busti di Napoleone e soldatini delle più celebri battaglie della storia. Sopravvissuto bevendo un frullato del sangue delle vittime eviscerate nel corso delle sue scorribande notturne, oggi abita in un’isola nel sud del Cile, insieme alla moglie Lucia e al maggiordomo Fedor, un ex controrivoluzionario russo di lei amante nonché partecipe delle vampiresche imprese del padrone. Stanco della sua non vita e avvilito per la scarsa considerazione in cui i compatrioti lo tengono, sceglie di morire davvero. In conseguenza di questa sua decisione, viene raggiunto dai cinque figli, ansiosi di spartirsi la ricca eredità, frutto delle sue ruberie, occultata nei paradisi fiscali di mezzo mondo. A loro si unisce Carmencita, una giovane suora che alla funzione di esorcista associa quella di contabile.
Larraìn ha già fatto riferimento due volte in maniera più o meno diretta a Pinochet. In “Post Mortem” (2010) un impiegato dell’obitorio, addetto a trascrivere i referti delle autopsie, si trova di fronte al cadavere di Allende. In “No – I giorni dell’arcobaleno” (2012), sul referendum indetto nel 1988 dal dittatore, convinto di vincere grazie ai buoni risultati ottenuti sul piano dell’economia, un pubblicitario giovane e spregiudicato supera la resistenza dei dirigenti della sinistra a improntare la campagna a criteri aggiornati alle nuove tecniche di comunicazione, portando alla vittoria il fronte del no. Ma anche “Tony Manero” (2008), “Il Club” (2015) e “Neruda” (2016), girati in patria prima del trasloco hollywoodiano del regista, risentono in maniera evidente dell’atmosfera plumbea del regime.
“El Conde” parte come si vede da un’idea molto originale, che offre una lettura in chiave horror della politica, capovolgendo cioè la vettorialità di quella teorizzata da Kracauer nel classico “Da Caligari a Hitler”. Attua inoltre una contaminazione tra mitologia, letteratura e cinema di matrice europea – in soldoni, il già citato Vlad Dracul, Stoker e il romanzo gotico, Murnau e le produzioni Hammer – con la figura dell’autocrate mediocre e triste che appartiene a tanti scrittori di lingua ispanica, da Ramòn del Valle Inclàn a Gabriel Garcia Marquez. In coerenza con questi presupposti, che ribadiscono in parte alcune costanti del suo cinema, risulta quindi la scelta del grottesco come registro narrativo (quasi per giustificarsi, visto che tratta di quella che è stata una delle pagine più drammatiche del proprio Paese, Larraìn cita un capolavoro come “Il dottor Stranamore” realizzato nel 1964 da Stanley Kubrick, il suo ghigno rabelaisiano sulla catastrofe nucleare). Un po’ perché naviga comunque nelle acque dell’horror, un po’ per sottolinearne la dimensione tragica, “El Conde”, se si esclude la breve sequenza conclusiva, è girato nel magnifico bianco e nero di Edward Lachman, per intenderci, direttore della fotografia, tra gli altri, di “Lontano dal Paradiso” (2002) di Todd Haynes, in cui ricrea magicamente il fulgore del Technicolor d’antan del grandissimo Russel Metty, collaboratore di fiducia di Douglas Sirk. A ricordarne la suggestione basterebbe la sequenza del volo del vampiro, manto e cappello da generale, sulle luci di una Santiago notturna.
“El Conde”, Leone d’argento per la sceneggiatura a Venezia, é uscito esclusivamente su Netflix. Consigliamo di vederlo nella versione originale in castellano, per non perdere in tutta la sua pregnanza il colpo di scena, che ci guardiamo bene dal rivelare, subdolamente anticipato da una voce fuori campo in inglese.
IL BLU DEL CAFTANO
di Marco Incerti Zambelli
Ad un certo punto de “Il caftano blu” Halim, un maalem (maestro sarto che confeziona caftani) istruisce Youssef, il suo giovane apprendista, a tagliare un tessuto: i corpi premuti insieme, le mani intrecciate che stringono un paio di grandi cesoie. La scena è soffusa di erotismo e mentre il sarto parla diventa chiaro il significato simbolico di ciò che stanno per fare. Dice al giovane di essere sicuro prima di fare il taglio perché indietro non si può tornare e aggiunge ‘lascia sempre un centimetro di margine. È il tuo margine: il centimetro del maalem’. È in quel piccolissimo spazio che pare svolgersi la vita di Halim, il suo nascondere la propria omosessualità, della quale si vergogna e che lo tormenta, che vuole celare alla moglie, alla quale tuttavia lo lega un affetto sincero e profondo. Il sentimento di Mina, la moglie, nei confronti del marito è segnato da un intenso amore e da spirito di protezione, è lei che gestisce la parte commerciale, occupandosi di clienti esigenti e commercianti di tessuti, cercando di preservare il marito da un mondo impaziente, permettendogli di continuare stoicamente a cucire e ricamare i suoi splendidi caftani fatti a mano secondo un’antica tradizione ereditata dal padre. E’ l’arrivo di Youssef ad accendere in lei la gelosia che la spinge a tramare fino ad allontanare il giovane con una falsa accusa. Mina è molto malata, decide di non lottare più contro il cancro che l’affligge e necessita di sempre più attenzione dal marito; questa situazione porta al ritorno dell’apprendista e permette il crearsi progressivamente una sorta di miracoloso triangolo, nel quale i rapporti di accettazione fra i tre sono dettati essenzialmente dall’amore e dal rispetto reciproco, fino al commovente finale.
Il secondo lungometraggio di Maryam Touzani, che ha vinto il premio Fipresci a Cannes lo scorso anno ed è candidato all’Oscar per il Marocco, è un dramma straordinariamente tenero e dignitoso.
La sceneggiatura di millimetrica precisione, capace di svelare poco alla volta caratteri e personalità dei protagonisti, è stata scritta dall’Autrice con il marito, il pregevole regista franco marocchino Nabil Ayouch, che già aveva collaborato al precedente, primo lungometraggio di Touzani, il notevole “Adam”. “Caftano blu” rivela infatti analogie e sintonie con il film precedente: in quel caso storia tutta al femminile, ma le vicende narrate sono ai confini della morale corrente in Marocco (una giovane incinta senza matrimonio accolta dapprima con titubanza e poi con sempre maggior affetto da una fornaia della medina), girate quasi esclusivamente in interni, con dialoghi scarni e sguardi rivelatori, la costante attenzione alla fisicità del lavoro, alla bellezza di gesti antichi nel maneggiare i materiali che trasformano le materie prime in manufatti di grande bellezza, il graduale instaurarsi di sentimenti di condivisione e affetto.
Per il secondo film la Regista si avvale di magnifici attori a partire da Lubna Azabal, protagonista di tutte due le pellicole, capace di rendere le sfaccettature della moglie, di mettere in scena con rara efficacia le indicazioni dell’Autrice: ‘con il progredire della malattia, Mina sfiderà le proprie apprensioni, sfiderà i limiti dell’amore, trascenderà le proprie paure e ridefinirà la fede religiosa che la caratterizza. Lo farà perché sente l’urgenza, prima di morire, di assicurarsi che Halim, l’uomo che ama, non abbia più paura e non si vergogni più di essere chi è veramente’. Saleh Bakri disegna un delicato ritratto di Halim, intrappolato tra la tradizione e un orientamento sessuale ancora tabù, e che permette alle emozioni di emergere solo nei momenti più critici. Ayoub Missioui, qui al suo debutto, interpreta la timidezza del giovane Youssef con efficacia, sa tratteggiarne la sincera devozione nei confronti del maestro ed anche la generosità come nell’episodio del falso furto. La fotografia di Virginie Surdej è superba ed estremamente sensuale. Già al fianco di Touzani in “Adam”, in cui le citazioni vermeeriane impreziosivano i ritratti femminili, governa con maestria la macchina da presa, impegnata in primi piani e dettagli che narrano la progressiva realizzazione del caftano: “io e lei abbiamo lavorato sulla sensualità, volevo che il film avesse quell’aspetto sensoriale. Quando Halim tocca il tessuto, volevo che gli spettatori sentissero il tocco di questo tessuto, per essere pienamente nei dettagli della sartoria. Volevo che il pubblico fosse immerso in questo mondo, conducendoci all’anima di Halim. Attraverso il suo lavoro capiamo chi è Halim, la sua passione prende forma concreta” dichiara la regista. Nelle inquadrature, spesso con camera a mano, le luci filtrano a ritagliare volti, sguardi, frammenti che rivelano gli animi, i sentimenti dei protagonisti e il film diventa sempre più luminoso man mano che le relazioni e le tensioni si allentano. Fino alla sequenza finale, una sorta di epifania, nella quale si sciolgono e convivono tradizione, trasgressione, devozione, amore.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
VIVERE DENTRO UN PARADOSSO
di Marcello Cella

“Nel cortile dinanzi alla casa senza intonaco due bambine si tiravano i capelli con una violenza tale da far piegare le loro testoline pressoché a terra.
“Molla”, sibilavano all’unisono.
“Cosa succede qua? Chi ha iniziato?”, gridò una donna dalla porta di casa.
“Lei”, esclamarono entrambe.
La donna si avvicinò, rifilò una sberla a ciascuna e spedì una in un angolo e l’altra in quello opposto. Strisciando con fermezza un piede sull’erba secca disegnò un confine appena visibile.
“Ora giocherete da sole”, disse, piazzò a terra la pentola che teneva tra le mani, agguantò una sedia e si sedette esattamente sulla linea tracciata a fare da vedetta.
“Tanto io con lei non ci voglio giocare mai più”.
“Mamma, mamma, dille di andare a casa sua”.
La donna si portò in grembo la pentola e, senza badare a loro, si mise a pelare. Le due attaccabrighe si girarono di spalle, con broncio risentito iniziarono a fare torte di fango senza guardarsi.
Non resistettero a lungo.
“Io ho fatto la torta a forma di fiore e tu no”.
“Non è vero, non ci credo!”.
“Tu come l’hai fatta?”.
“Non te lo dico”.
“Mamma, mamma, la mandi via?”.
La donna continuò a pelare le patate con una dedizione che raramente si riserva a quest’attività.
“Ti faccio vedere la mia torta, se tu prima mi fai vedere la tua”.
La bambina dai capelli corti prese il suo miscuglio molle a forma di stella e si incamminò verso l’amica.
“Ehi! Ehi! Cosa ho detto? Torna indietro”, si levò la voce della donna, mentre la bambina varcava il confine del territorio assegnatole.
“Voglio solo mostrarle la mia torta”, sussurrò sgranando gli occhi e fingendo innocenza.
“Ho detto di no”.
“Mamma, dai, ti prego, voglio solo vedere come l’ha fatta”, implorò l’altra bambina.
“Finite sempre per picchiarvi”.
“No, non lo faremo, giuro, giuro”, gridarono all’unisono.
La donna sospirò, annuì e si diresse verso casa, lasciandosi dietro la sedia vuota a fare da guardia alla frontiera.
Le bambine corsero l’una verso l’altra, pronte a confabulare come pasticcere esperte al cospetto delle loro torte di terriccio. Ripresero ad inseguirsi per il giardino e c’era da scommetterci che nel giro di poco sarebbero finite a tirarsi i capelli di nuovo.
Miroslav scosse la testa e si spostò dalla finestra: la fotografia perfetta di questo paese. E se i confini li tracciassimo unicamente per poter desiderare l’altro?”.
Con questo inizio incredibilmente significativo Elvira Mujčić, scrittrice di origine bosniaca, apre il suo ultimo romanzo, “La buona condotta”, che racconta la storia di Miroslav, un sindaco di un piccolo paese del Kosovo, eletto con i voti dalla maggioranza sia dei cittadini di origine serba, che da quelli di origine albanese che si vede affiancare da Belgrado, che non riconosce le istituzioni kosovare, un altro sindaco serbo, ma che non ha mai vissuto in quella piccola enclave. L’origine della storia paradossale raccontata nel romanzo risiede però in un documentario che due registi italiani, Valerio Bassan e Andrea Legni, hanno girato nel 2012 in Kosovo, intitolato per l’appunto “Kosovo vs Kosovo”. All’interno del documentario, indipendente e autoprodotto, girato in alcune enclaves serbe all’interno del Kosovo a maggioranza albanese, fra le altre si racconta anche la vicenda tragicomica dei due sindaci di Krokot, un paese non lontano dal confine con la Macedonia, uno eletto secondo le regole del Kosovo, e un altro eletto secondo le regole di Belgrado. Ma cosa vuol dire vivere dentro un’enclave? Se andiamo a cercare il termine sul dizionario troviamo al seguente definizione: “Territorio completamente chiuso entro i confini di uno stato diverso da quello cui politicamente o linguisticamente appartiene”. Ed è esattamente quello che accade ai territori abitati dalle minoranze serbe all’interno del Kosovo albanese, resosi unilateralmente indipendente nel 2008, ma riconosciuto ancora da pochi altri paesi al mondo, dopo un conflitto nato all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso con le autorità jugoslave e sviluppatosi in varie fasi, fra le quali la più cruenta nel 1999, quando, in seguito alle repressioni attuate da esercito e paramilitari serbi contro gli albanesi, ci fu l’intervento militare della NATO che portò ad una separazione di fatto fra le due componenti etniche del Kosovo, quella albanese e quella serba. Oggi in Kosovo, oltre alla zona a nord, a maggioranza serba e di fatto unita alla madre patria, esistono circa 240 enclave serbe all’interno del territorio kosovaro, con effetti istituzionali ed esistenziali paradossali. “Le zone abitate dai serbi all’interno del Kosovo formano un vero e proprio Stato dentro lo Stato” – affermano gli autori del documentario – “Piccole enclave monoetniche sulle quali il governo di Pristina non ha alcuna autorità. Gli abitanti di queste aree votano sindaci riconosciuti solo da loro stessi, utilizzano una propria moneta, hanno infrastrutture, scuole, ospedali gestiti direttamente da Belgrado. Ma vivono senza libertà di movimento e senza lavoro, evitando di addentrarsi nelle città albanesi per paura di subire aggressioni, Una situazione che ha spinto oltre duecentomila serbi a lasciare il Kosovo, una realtà dimenticata dai media occidentali”. Il documentario di Bassan e Legni attraversa queste enclaves, questi piccoli paesi rurali, queste realtà periferiche aggrappate alla propria storia, al proprio sentimento nazionale, mentre i paesaggi che scorrono davanti alle telecamere dei due cineasti raccontano una realtà fatta di povertà, di case distrutte e abbandonate, di vite vissute nella paura di ciò che si ha intorno, di giovani senza prospettiva e senza lavoro che sognano solo di fuggire da questi luoghi contrassegnati da bandiere serbe, targhe serbe, negozi e insegne in cirillico e che senza il sostegno del governo di Belgrado rischierebbero di scomparire per sempre.
Emblematico poi il racconto quando si concentra sulla città di Mitrovica, nel Kosovo del nord, una città divisa in due dal fiume Ibar e da un ponte presidiato dalle forze dell’ONU e che divide la comunità albanese a sud da quella serba a nord. Una specie di Berlino dei Balcani, con un senso tristissimo di deja vu che rimanda ad un’epoca, quella della Guerra Fredda, che si pensava di aver archiviato per sempre, almeno in Europa, ma che così non è. “Kosovo vs Kosovo” non fa sconti nemmeno alla cooperazione internazionale, corresponsabile del disastro economico e sociale del Kosovo. “La cooperazione ha speso tanti miliardi per assistenza, cibo, case, ma non per ricostruire le strutture. A Pec c’era una fabbrica che riforniva di birra tutta la Jugoslavia. Ora ha cambiato nome, si chiama Peja, in albanese, ci lavorano solo 50 operai dove prima ce n’erano 600. E così la fabbrica di biciclette e quella delle componenti della Zastava, l’auto jugoslava, non esistono più. La disoccupazione è al 70% e fra i serbi è ancora più alta”. Un disastro in cui si sono inserite le mafie che qui prosperano con i loro traffici illeciti che attraversano tutta l’Europa. Quello che si intuisce da questo documentario così poco conosciuto su una realtà per lo più ignorata dal resto d’Europa è che questa situazione non riguarda solo il Kosovo e sintomi micro-nazionalistici sono ben presenti in tutto il nostro continente rappresentando un rischio per la convivenza civile dei popoli e per la democrazia. Si tratta di un’esistenza paradossale, come racconta un cittadino serbo nel finale del documentario, una vita divisa in due, due identità, due carte di identità, due comuni, due sindaci, due di tutto e nessuna prospettiva realistica di un futuro condiviso mentre tutto intorno sembra degradarsi irreversibilmente. Una realtà immobile che nell’esaltazione della propria appartenenza nazionale nasconde una inconfessata paura dell’altro.
“Chiusi a chiave in pochi chilometri quadrati si perde la capacità di porsi domande, di riflettere su sé stessi e la propria condizione. Sei chiuso lì, non vai da nessuna parte e ti sembra normale che sia così, ti dimentichi di domandarti se esiste un’altra maniera di vivere, non sai nulla del mondo e non sapendo nulla, non ti chiedi nulla. E avanti così, non se ne esce” (da “La buona condotta” di Elvira Mujčić, Crocetti Editore, 2023).
Kosovo versus Kosovo
di Valerio Bassan e Andrea Legni
Italia, 2012
Durata. 52’
Web: https://openddb.it/film/kosovo-versus-kosovo/
https://www.facebook.com/KosovoVersusKosovo/?locale=it_IT
La buona condotta di Elvira Mujčić
PANORAMA LIBRI
Roberto Baldassarre
Storie scellerate. Il cinema di Sergio Citti
Edizioni Falsopiano – Alessandria, 2024
Pagg. 335, Euro 22
E’ l’anno in cui si rivaluta la figura di Sergio Citti, l’imbianchino che permise a Pier Paolo Pasolini di conoscere quel mondo ed il gergo romanesco che gli sono serviti per scrivere prima il romanzo “Ragazzi di vita”(1955) e poi dirigere film come “Accattone”(1961) e “Mamma Roma” (1962) con i quali si fece conoscere nel mondo letterario ed in quello cinematografico, film in cui Sergio Citti collaborò come sceneggiatore. Roberto Baldassarre si concentra su uno dei film che Sergio Citti ha diretto, mentre collaborava alla sceneggiatura di alcuni film di Pier Paolo Pasolini. Il riferimento è a “Storie scellerate” (1973), un film, come scrivo nella prefazione al libro, inconsueto, come gli altri da lui diretti, nel panorama del cinema italiano, un film originale e coraggioso che Roberto Baldassarre ci restituisce in uno studio approfondito facendo leva sulla sceneggiatura che viene pubblicata per la prima volta. Un film incentrato su personaggi inconsueti del mondo popolano, con protagonisti due condannati a morte nella Roma ottocentesca che si raccontano, prima di venire condannati a morte per furto e omicidio, storie che ruotano attorno al sesso, all’astuzia ed all’inganno, secondo la migliore tradizione della novella italiana, da Boccaccio in poi. “Un film, scrivo ancora, in cui su tutto aleggia la morte come condizione universale che accomuna gentiluomini e lestofanti, giovani e vecchi, ricchi e poveri, ingenui e corrotti. Un film che consente di vedere le vicende della vita sotto una luce diversa, di introdurre nel quotidiano la dimensione dell’eterno. Film poco commerciali che non hanno avuto grandi incassi ma che arricchiscono il piacere di amare film di qualità”. Roberto Baldassarre nei capitoli successivi approfondisce il rapporto tra Sergio Citti e il cinema evidenziando nella sceneggiatura le differenze tra script e film, pubblicando anche una scena inedita del film( quella che riguarda la preparazione della scena) e un ‘intervista a Sergio Citti contenuta in un filmato muto realizzato da Gideon Bachman sul set di “Storie scellerate”. Nel libro, Roberto Baldassarre dà conto dell’intervento censorio e delle revisioni cinematografiche su di esso. Ed offre poi un panorama di recensioni che danno un’idea dell’accoglienza critica avuta in Italia. Molte le Note che accompagnano il testo di Roberto Baldassarre, una valida testimonianza della cura con cui ha compiuto la sua ricerca. Approfondita è poi la filmografia e ricchissimi , tendente ad essere esaustivi, i riferimenti bibliografici relativi a monografie, soggetti e sceneggiature, Interviste, dichiarazioni, lettere, stralci d’interviste, fotografie, saggi e recensioni su ogni film diretto da Sergio Citti. Un libro fondamentale per conoscere “Storie scellerate” ma anche l’avventura cinematografica di Sergio Citti. Un libro che dimostra, attraverso lo scrupoloso esame di ogni documento, la grande capacità di ricercatore di Roberto Baldassarre.
Il libro è stato presentato, per la prima volta, al Torino Film Festival 2023.
Franco La Magna
Nino Martoglio. Il moschettiere del cinema
Editore Algra – Viagrande(Catania), 2023
Pagg, 96 + Appendice fotografica, Euro 12
“Il moschettiere del cinema”, il catanese Nino Martoglio che nel 1889 fondò il settimanale politico – satirico – letterario “D’Artagnan” occupandosi in particolare di cinema. A partire da un articolo del dicembre 1896 in cui, come scrive Franco La Magna, annuncia, con toni entusiastici l’arrivo del cinema nella città etnea, cioè Catania. In attesa di leggere la sua annunciata “Storia del cinema in Sicilia” arricchiamo la conoscenza del cinema in quella Regione con questo libro su Nino Martoglio, autore che Franco La Magna approfondisce con molta cura, come è testimoniato anche dalle numerose note che accompagnano il percorso artistico di questo autore che con “Sperduti nel buio” , tratto da un dramma di Roberto Bracco, come evidenzia Gian Piero Brunetta, dà inizio alla corrente realistica del cinema italiano ed è uno dei film più significativi di tutta la produzione del cinema muto. Nella sua Storia del cinema italiano poi, Carlo Lizzani sottolinea che il film si avvale di una tecnica di racconto a contrasti piuttosto interessante: passano , scrive, sullo schermo infatti alternativamente due ambienti differenti che costituiscono , volta a volta, il teatro di due diverse vicende4, legate poi tra di loro. L’ ambiente misero del vicolo è dato con maggiore forza e crudezza che non l’ambiente aristocratico, e il film si fa ricordare per l’irruenza documentaria con la quale, a tratti, sfrutta il materiale visivo”. Un film dall’insolito livello e dal linguaggio relativamente sincero il cui merito è di Nino Martoglio, più che di Bracco, conclude Lizzani storico del cinema.
Sei i capitoli del libro in cui l’autore ci informa, tra l’altro, del rapporto di Martoglio con la Casa di produzione romana Cines, della sua fondazione della “Morgana Films” di Roma, del suo “mitico e mitizzato” capolavoro ”Sperduti nel buio” a proposito del quale dice che esso è stato realizzato in co-regia con Roberto Danesi. Ma anche sulle baruffe giudiziarie dei film “Teresa Raquin” del 1914 e di “San Giovanni decollato”(film controverso) che segna nel 1916 il definitivo allontanamento di Nino Martoglio dal cinema. Un film in cui protagonista è Angelo Musco ma che ricordo offrì un’intensa interpretazione di Totò , sia a teatro che al cinema.
Ed infine “ I film ‘martogliani’ sonori, cioè quelli tratti dall’opera letteraria dell’autore siciliano: tra essi, oltre a “San Giovanni decollato”, “L’aria del continente”(1935) di Gennaro Righelli, uno dei film più esilaranti del grande comico siciliano Angelo Musco qui in coppia con la sua compagna Rosina Anselmi, altra interprete cinematografica eccellente, “Il marchese di Ruvolito”(1938), “Troppo tardi ti ho conosciuta”(1940) di Emanuele Caracciolo, tratto da “Il divo” di Martoglio.
La Bibliografia essenziale e la filmografia aiutano il lettore a meglio inquadrare la figura di questo autore siciliano, mentre un’appendice fotografica offre immagini significative del suo percorso artistico, ma non solo.
Franco La Magna
Giovanni Verga e il “Castigo di Dio”. Per una storia dei rapporti tra cinema e narrativa
Editore Algra – Viagrande(Catania), 2022
Pagg. 106, Euro 10
Prima del libro su Martoglio Franco La Magna ne aveva scritto un altro , pubblicato anch’esso da Algra editore, su Giovanni Verga e il “Castigo di Dio” . Un’opera “Per una storia dei rapporti tra cinema e narrativa” pubblicato, anch’esso da Algra editore, in occasione del centenario verghiano. Che riporta la frase “castigo di Dio” con cui Giovanni Verga valutava in modo spietato il cinema, una frase che suggeriva la sequela di autocensure, volgarizzazioni, tradimenti cui l’opera letteraria deve soggiacere per passare alla consacrazione dello schermo. Valutazione che Verga dissemina nei carteggi dell’ultimo decennio a Dina Di Sordevolo, a Marco Praga. Tenendo conto dei giudizi verghiani ma senza cedere in toto alla loro suggestione, continua la prefazione di Antonio Di Silvestri, il libro di Franco La Magna, attraverso un intelligente utilizzo delle recensioni contemporanee, offre una panoramica storico – culturale che agevola la comprensione dell’operazione filmica verghiana, misurandone incertezze e conquiste, damnationes ed entusiastici accoglimenti. Il percorso, che valorizza quale spartiacque il passaggio dal film muto a quello sonoro, si distingue anche per il recupero di episodi di trasposizione poco conosciuti, quali quelli dei romanzo erotico – mondani considerati come una fase ‘parallela’ a quella veristica e quindi e quindi estesi fino al post – malavogliesco “Marito di Elena”. Il prefatore ricorda anche le realizzazioni documentaristiche sulle altre opere di Verga che “completano il quadro di un cinema attento a dialogare con le variabili e le oscillazioni della lingua verghiana, dall’aspetto cangiante e sfaccettato , scoprendone inedite potenzialità. Nove i capitoli con cui Franco La Magna inquadra il rapporto tra Giovanni Verga e il cinema. Nel primo, “Dall’iniziale ripudio al consenso ‘risentito’” Franco La Magna data l’inizio del disprezzo verso il cinema di Giovanni Verga alla seconda metà degli anni ’10 che continua, soprattutto, dopo che aveva ceduto per soldi i diritti della sua opera teatrale “Cavalleria rusticana, da cui scaturirà un film francese che lui, ma anche la critica italiana, non apprezza. Il secondo capitolo è invece dedicato a “Le due ‘Cavalleria rusticana’ del 1916, dallo schermo al Tribunale” in riferimento al fatto che Pietro Mascagni trasformò il testo teatrale in opera lirica senza nessun accordo con lui escludendolo quindi dai lauti guadagni ricavati grazie allo straordinario successo ottenuto. Una controversi che si concluse, ricorda Franco La Magna, con una “pacifica” transazione tra le parti, in base alla quale Verga veniva definitivamente liquidato con la congrua somma di ben 153 mila lire a fronte di una prima liquidazione di 143 mila lire . Ricorda anche che la questione non finì lì perché vi fu un’altra vertenza giudiziaria di cui racconta la complessa vicenda. Nel terzo capitolo, il libro si sofferma sul film “Tigre reale”(1916) interpretato da Pina Menichelli e sui successivi altri film tratti da opere di Verga come “L’amante di Gramigna”, ”La lupa” , “La terra trema”, ed anche” il “Bronte” di Florestano Vancini.
Un excursus affrontato dall’autore del libro con tanti documenti, a testimonianza della qualità d ricercatore e di storico di Franco La Magna.
A cura di Alessandro Cuk
Alida Valli, da Pola ad Hollywood e oltre
Alcione editore, 2021
Pagg. 173, Euro 12
Il libro racconta il percorso artistico di Alida Valli, nata a Pola, allora italiana, come Alida Maria Laura von Altenburger, il 31 maggio 1921. Una donna, scrive Alessandro Cuk in questo libro, che fin da bambina respira cultura e ambizioni artistiche. Seguendo i trasferimenti del padre, uomo di origini nobili insegnante di filosofia che scriveva di teatro per il “Corriere istriano”, quando lui è chiamato ad insegnare a Chieti Alida si trasferisce a Roma ospite di parenti e si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia esordendo nel cinema appena quindicenne nel film “I due sergenti”(1936) di Enrico Guazzoni. Era quasi una comparsata, l’esordio vero e proprio avvenne, grazie a Francesco Pasinetti che la presentò al regista, con “Il feroce Saladino”(1937) di Mario Bonnard recitando con Angelo Musco e Rosina Anselmi nel ruolo della bella Sulamita. Da quel momento su suggerimento di Mario Bonnard diventa Alida Valli, nome d’arte con il quale diventa famosa in tutto il mondo. Alessandro Cuk ne ripercorre la prestigiosa carriera che la porta nell’arco di sessant’anni a partecipare a ben 109 film, una quindicina di sceneggiati e serie Tv e un numero notevole di spettacoli teatrali. Chi scrive la intervistò in uno di questi, il famoso “Uno sguardo dal ponte” con la regia di Raf Vallone. Ma è il cinema a darle più soddisfazioni, a partire, soprattutto, da “Piccolo mondo antico”(1941) di Mario Soldati in cui interpreta il ruolo di Luisa che diventa sposa in segreto di Franco(Massimo Serato), un nobile, contro il volere della nonna di lui, la marchesa Orsola((Ada Dondini); Con questo film, il quindicesimo della sua carriera, Alida Valli compie un salto di qualità segnando il suo decollo nel mondo del cinema. Altri film significativi interpretati in quel periodo sono “Ore 9: lezione di chimica”(1941) di Mario Mattòli, regista con il quale in quel periodo interpreta altri film, ma soprattutto “Noi vivi/Addio, Kira!” diretto nel 1942 da Goffredo Alessandrini ed “Eugenia Grandet”(1946) con il quale ritorna a recitare per M;ario Soldati. Inizia quindi il periodo hollywoodiano, grazie ad un vantaggioso contratto con il potente produttore David O. Selznick debuttando con Alfred Hitchcock nel film “Il caso Paradine” (1947) a fianco di Gregory Peck. Parte così la sua avventura internazionale che la porta a recitare con registi come Carol Reed(“Il terzo uomo”, 1949) e Yves Allegret(“I miracoli non si ripetono”, 1951). Ma la nostalgia per l’Italia e la consapevolezza di essere condizionata nelle scelte la spingono a ritornare in Italia dove ritorna a recitare con Mario Soldati(“La mano dello straniero”, 1954) e viene molto valorizzata da registi come Luchino Visconti(“Senso”, 1954 dove recita a fianco di Farley Granger), Michelangelo Antonioni(“Il grido”, 1957), Pier Paolo Pasolini(“Edipo Re”, 1967), Bernardo Bertolucci(“ Strategia del ragno”, 1970 ; “Novecento – atto I e II, 1975; “La luna”, 1979) , Valerio Zurlini(“La prima notte di quiete”, 1972), Dario Argento(“Suspiria”, 1977; “Inferno”, 1980), Marco Tullio Giordana(“La caduta degli angeli ribelli”, 1981), Giuseppe Bertolucci(“Berlinguer ti voglio bene”, 1977; “Sehreti segreti”1984; “Il dolce rumore della vita”, 1999; “L’amore probabilmente”, 2001). Ma anche registi come Henri Colpi (“L’inverno ti farà tornare”, 1961), Claude Chabrol(“Ophélia”,1962) e George Franju (“Occhi senza volto”, 1964) , Margarethe Von Trotta(“Il lungo silenzio”, 1993). Film che Alessandro Cuk approfondisce con molte informazioni, così come do conto dei rapporti familiari e privati di quest’attrice che è un’icona di grande rilievo del cinema che la Mostra di Venezia ha omaggiato nel 1977 con il “Leone d’Oro” alla carriera. Una luminosa carriera lunga settant’anni.
CREDITS
Carte di Cinema 30
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E. Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 30 della rivista online, Roberto Baldassarre, Paola Brunetta, Marcello Cella, Mario Galeotti, Roberto Lasagna, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Alessandra Pighi, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Xoxan Villanueva, Marco Incerti Zambelli.