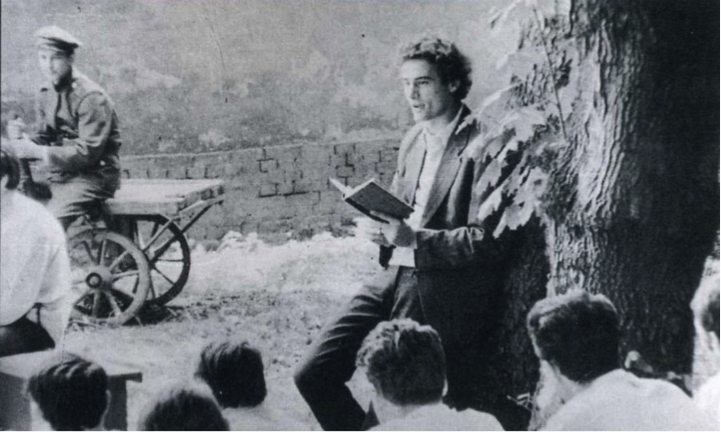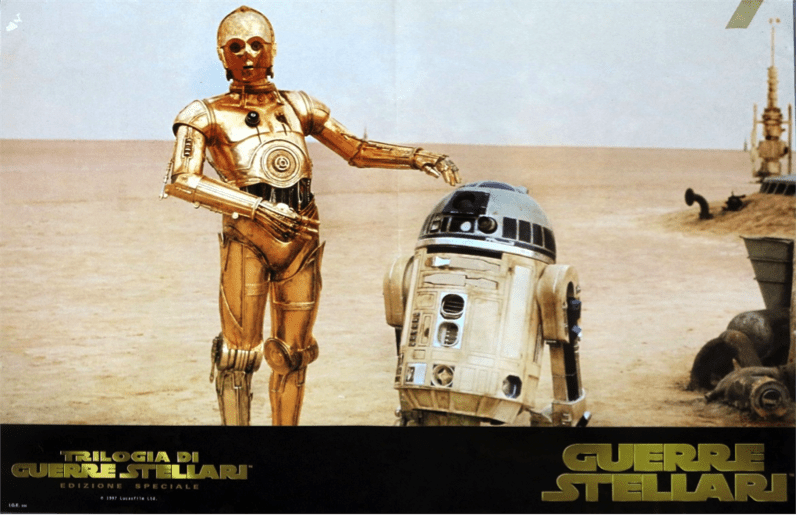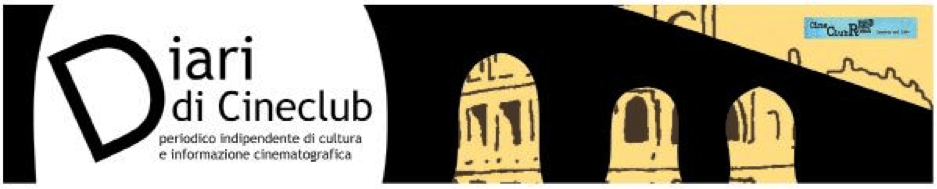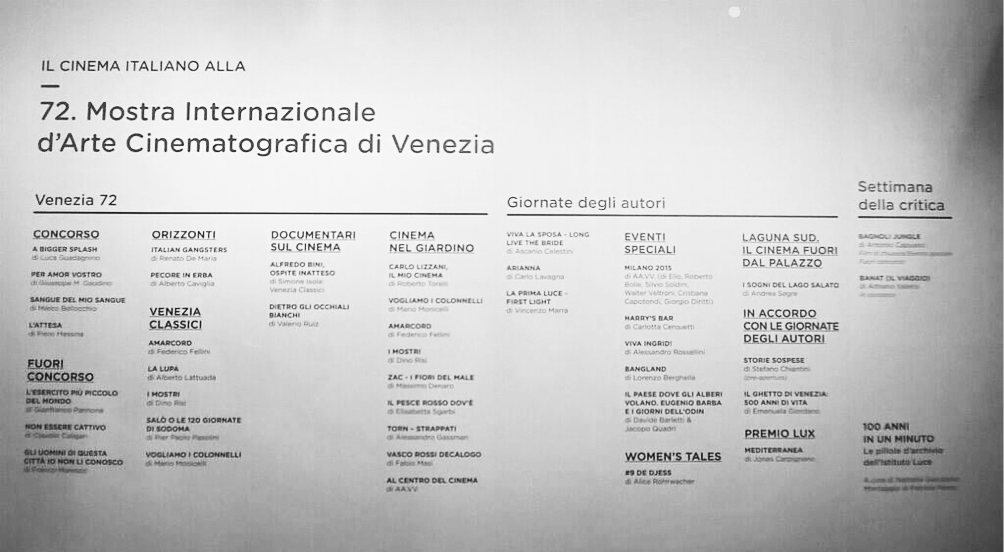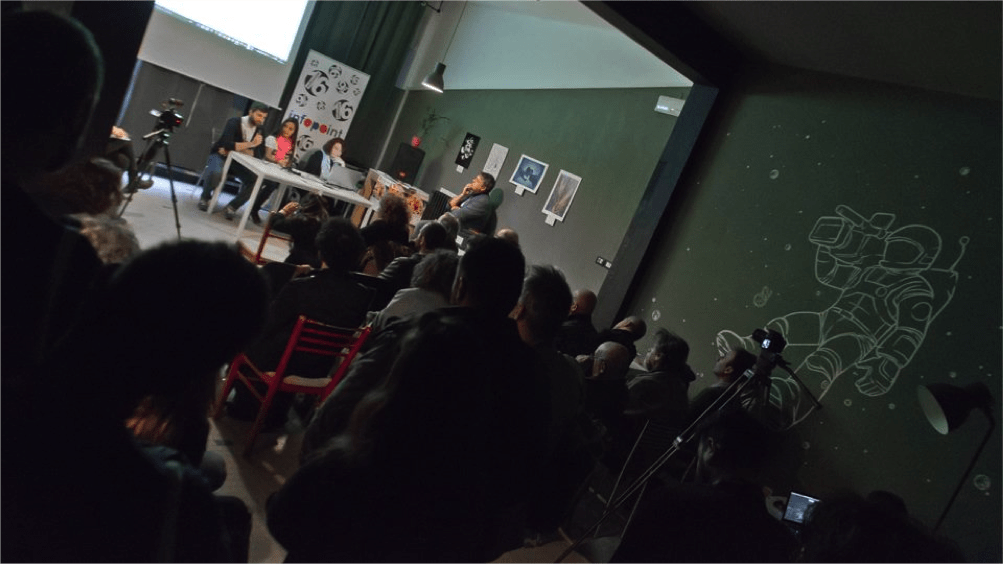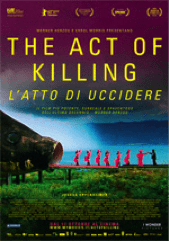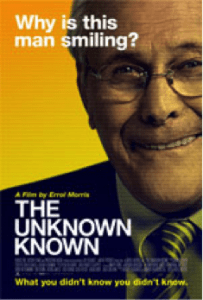Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 4 FEDIC. LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 5.1 72 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
- 5.2 SE DICI CORTO? “SEDICICORTO” di Francesco Saverio Marzaduri
- 5.3 SEDICICORTO 2015: RECENSIONI CORTITALIA
- 5.4 LOCARNO: RIFLESSIONE SUL PALMARES E IL CONCORSO di Ugo Brusaporco
- 5.5 SAN GIO’ VERONA VIDEO FESTIVAL / XXI di Paolo Micalizzi
- 5.6 CASTELLINARIA di Andreina Sirena
- 5.7 IL NETWORK EUROSHORT di Gianluca Castellini
- 6 ITALIA IN CORTO di Elio Girlanda
- 7 CLASSICI
- 8 QUALITÀ IN SERIE
- 9 HOME VIDEO
- 10 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 11 AUTORI
- 12 Credits n.7
ABSTRACT
FILM REPRESSIVAMENTE TOLLERATI. APPUNTI SUL CINEMA UNGHERESI DEGLI ANNI SESSANTA di Judit Pintér e Paolo Vecchi
Dopo la rivoluzione del ’56, Kádár introduce una certa tolleranza in campo culturale. In quello cinematografico un ruolo fondamentale lo svolge l’autonomia produttiva degli Studi. Non si assiste però a teorizzazioni e pratiche ”di scuola”, ma a soluzioni formali che rivelano una visione individuale, essendo nello stesso tempo aperte le une verso le altre.
LA RAGIONE DI UN SOGNO : SERGIO CITTI E IL CINEMA di Francesco Saverio Marzaduri
Il nome di Sergio Citti è legato a Pasolini, della cui politique sembra il motore. In realtà, il suo è uno sguardo apolide ed eretico, beffardo e controcorrente, nella cui poetica c’è un mondo reietto, desideroso, nonostante le indigenze, di sogni, bisogni, sorrisi per interpretare la vita e il proprio rovescio.
ALLE ORIGINI DELL’IMMAGINARIO DI GEORGE LUCAS di Roberto Lasagna
Mentre ‘Il risveglio della forza’ conquista le classifiche mondiali ma segue troppo pedissequamente il Lucas prima maniera, Carte di cinema torna alle origini e riflette sui bagliori di un cineasta unico, il Re Mida di Hollywood per il quale il cinema è una sfida davvero imprevedibile e, probabilmente, un conto ancora aperto sul piano dell’immaginario
DARIO ARGENTO. LE COREOGRAFIE DELLA PAURA di Vittorio Giacci
Il saggio ripercorre tutta la filmografia di Dario Argento partendo dalla premessa che tra lui ed Alfred Hitchcock esistono più differenze che analogie. Vere e proprie “coreografie le sue opere sorprendono ed atterriscono come altrettante cerimonie funebri, anatomie del terrore dove la violenza si fa gesto drastico e la sofferenza immagine allo stato puro. Cinema dell’eccesso, quello di Dario Argento si è costruito in una stringente progettualità in cui l’artista, vittima e carnefice ad un tempo di un’arte così trasgressiva e “diversa” come è, ontologicamente, il cinema ha voluto sacrificare la sua sfrenata visionarietà per una coerenza d’autore sempre più rigorosa e cosciente.
FILMMAKER ALLA RIBALTA: FRANCESCO GIUSIANI di Paolo Micalizzi
Profilo di un filmmaker FEDIC che a trent’anni ha già al suo attivo alcuni cortometraggi inviati a Festival nazionali ma anche internazionali ricevendo importanti riconoscimenti. Filmmaker dalla solida preparazione che tende al grande salto nel cinema professionale.
CINEMA: UN LINGUAGGIO UNIVERSALE di Laura Biggi
ll cinema come strumento di comunicazione interculturale. Sperimentare la magia delle immagini in movimento unisce e favorisce la socializzazione a qualsiasi età. Un esempio? Il Campus Estivo Eurolandia di FEDIC Scuola.
DIARI DI CINECLUB. LA CULTURA CINEMATOGRAFICA AL TEMPO DEL WEB di Stefano Macera
L’esperienza di Diari di Cineclub, diretto da Angelo Tantaro, periodico nato nel dicembre 2012, per coinvolgere il vasto e variegato panorama dell’associazionismo cinematografico italiano e sviluppare sino in fondo la prospettiva secondo la quale il cinema non è un fatto a sé stante, evidenziandone il carattere di mezzo di comunicazione profondamente inserito nel dibattito del proprio tempo e delle consequenziali lotte. Motivo di vanto della rivista anche l’intervento pubblicato dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che riconosceva, con lettera al direttore, il positivo ruolo dei Circoli del cinema.
YOUNGERCARD. UN PROGETTO PER AVVICINARE I GIOVANI AL CINECLUB di Eleonora Carrara
Esperienza cinematografica di una giovane universitaria che grazie ad un Progetto della Regione Emilia-Romagna sostenuto dal Cineclub Claudio Zambelli di Boretto(RE) è diventata un’appassionata cinefila e organizzatrice di attività nel cortometraggio.
PREMI, TRA CONSENSI E DISSENSI, E RICCHE PROPOSTE di Paolo Micalizzi
Resoconto della Mostra di Venezia 2015, con giudizi sui Premi principali nelle varie sezioni comprese la “Settimana della critica” e “Le Giornate degli Autori” . Sottolineate anche le iniziative FEDIC.
I FILM IN CONCORSO GIORNO PER GIORNO di Ugo Brusaporco
Analisi dei 20 film in Concorso redatte quotidianamente da un critico che da molti anni segue la Mostra del Cinema di Venezia.
GLI ITALIANI A VENEZIA. FILS ROUGE di Carlotta Bruschi
A seguito dell’esperienza alla 72° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’autrice propone il suo punto di vista in merito alle analogie, di tecnica di realizzazione e di contenuti, riscontrate tra le opere dei cineasti italiani.
A VENEZIA RIAFFIORA IL CINEMA INVISIBILE di Vittorio Boarini
La sezione Venezia Classici 2015 ha aggiunto la Carte blanche al Leone d’oro alla carriera, Tavernier, che ha inserito 4 film nei 16 scelti dalla Mostra con 8 documentari sul cinema. L’Italia era presente con 5 pellicole, fra cui “Salò” di Pasolini, che ha vinto il Leone d’oro per il miglior restauro.
SE DICI CORTO? “SEDICICORTO” di Francesco Saverio Marzaduri
Panoramica sulla XII edizione del Sedicicorto International Film Festival, tra appuntamenti e molteplici attività.
SEDICICORTO 2015. RECENSIONI “CORTITALIA” a cura di “Carte di Cinema”
Recensioni critiche da parte di Marzaduri, Micalizzi e Villani di “Carte di Cinema” on line dei cortometraggi in Concorso a “Sedicicorto” di Forlì nella Sezione “Cortitalia”.
FESTIVAL DEL FILM LOCARNO: RIFLESSIONE SUL PALMARES E IL CONCORSO di Ugo Brusaporco
Riflessioni su Premi e film, ma anche sulle caratteristiche dell’importante Festival Svizzero, di prestigio internazionale.
SAN GIÒ VERONA VIDEOFESTIVAL / XXI di Paolo Micalizzi
Premi e giudizi sui cortometraggi in Concorso, ma anche sui lungometraggi a questo VideoFestival che, malgrado difficoltà economiche, viene portato avanti con passione e coraggio.
CASTELLINARIA di Andreina Sirena
All’indomani del tragico venerdì 13 parigino,il festival di Castellinaria cambia fisionomia dedicando un’attenzione crescente alla cultura nella formazione giovanile, per allontanare il divario che separa le nuove generazioni dal privilegio dell’immenso bagaglio artistico del mondo occidentale. Partendo dal fantasy garroniano de “Il racconto dei racconti”, passando per “Human” di Yann- Arthus Bertrand fino al film postumo di Caligari, il festival esplora in tutta la sua ampiezza contraddizioni e criticità del presente, senza abbandonarsi a facili nichilismi ma anzi, considerando le possibili prospettive per edificare un futuro diverso
IL NETWORK EUROSHORT di Gianluca Castellini
Informazioni utili sul Network Euroshort nato nel 2013 su proposta del “Sedicicorto” di Forlì che a tutt’oggi è composto da 9 Festival europei.
ITALIA IN CORTO di Elio Girlanda
Per la prima volta cifre e statistiche su un ambito, tutt’altro che marginale, che coinvolge circa 200 festival e più di 1.000 film, sono disponibili nel Report 2014 dell’industria del cortometraggio italiano con analisi, riflessioni e proposte per lacune e problemi ancora irrisolti.
ELEONORA DUSE: LA GRANDE LEI di Ivana Baldassarri
Un ampio Ritratto di una grande attrice teatrale che ha offerto anche un’indimenticabile interpretazione nel film “Cenere”(1916) di Febo Mari.
MOZART IN THE JUNGLE di Luisa Ceretto
Una serie per chi ama la musica classica, il dietro le quinte di un’orchestra sinfonica e…il buon cinema! Un cast d’eccezione per una commedia scritta, tra gli altri, dallo sceneggiatore di “Moonrise Kingdom”.
GRANDI STORIE PER LEGGERE IL PRESENTE di Giancarlo Zappoli
THE EPIC OF EVEREST. IL MISTERO DI MALLORY E IRVINE di Giancarlo Zappoli
Il documentario ha riacquisito dopo un lungo periodo di latenza l’attenzione che merita da parte sia del pubblico che della critica. Il cofanetto di opere presentate al Biografilm e le rare immagini che testimoniano del primo tentativo di ascesa all’Everest meritano l’attenzione dei cinefili.
BEATLES 1 + A MAGICAL TOUR di Marco I. Zambelli
Il cofanetto 1+ permette di ripercorrere la straordinaria cavalcata dell’avventura Beatles. Lo strepitoso lavoro di restauro sia delle musiche che delle immagini diventa l’occasione per sorprendersi ancora e di deliziarsi della creatività e della magia di uno dei fondamentali fenomeni della cultura del 900 .
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
Segnalazione-recensioni di 5 libri di cinema che riguardano Pier Paolo Pasolini, Claudio Gora, Italo Calvino, Enrico Medioli e Alessandro D’Alatri.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
FILM REPRESSIVAMENTE TOLLERATI
APPUNTI SUL CINEMA UNGHERESE DEGLI ANNI SESSANTA
di Judit Pintér e Paolo Vecchi
Come d’altronde per le altre vagues coeve dell’Europa dell’Est, qualsiasi discorso, anche sintetico, sul nuovo cinema ungherese degli anni sessanta non può prescindere da un accenno alla situazione storica, economica e politica della quale è figlio. Il punto di partenza – o di svolta, se si preferisce – è ovviamente rappresentato dai gloriosi e tragici avvenimenti del’56, oggi letti da quasi tutti gli analisti del Paese danubiano come l’unica rivoluzione democratica del secolo scorso (1). Dopo i carri armati, a incaricarsi della difficile opera di restaurazione di un regime già squalificato dagli orrendi anni di Rákosi viene chiamato János Kádár. Vissuto dapprima come una sorta di Quisling danubiano, questo piccolo uomo di umili origini dimostra una certa abilità nel gestire i rapporti con l’URSS che, al di là della retorica ufficiale sui traditori del comunismo e una volta fatta piazza pulita con processi sommari, ha convenienza a risarcire il popolo ungherese dei disastrosi trascorsi, al fine di avviare una normalizzazione il meno possibile traumatica. Con il beneplacito dell’ingombrante alleato sovietico, Kádár inizia una campagna di liberalizzazioni in campo economico, dando spazio all’inziativa privata e incentivando i consumi. Così, già dai primissimi anni sessanta, l’Ungheria in ambito COMECON viene sarcasticamente battezzata “la baracca più allegra del lager” e a proposito della sua peculiare struttura economico-politica si parla di “comunismo al goulash” (2).
In parallelo, si allentano i legami censorii, pur rimanendo in vigore alcuni punti fermi, secondo i dettami di quella che viene chiamata “tolleranza repressiva”. Vale per gli scrittori, ma in seguito anche per i registi, la classificazione formulata da György Aczél, potentissimo Primo Sottosegretario alla Cultura dal 1957 al 1967, tra letteratura proibita, tollerata e appoggiata, aprendo così tra i reprobi e i trombettieri del regime una sorta di ambigua zona grigia nella quale ciascuno può avventurarsi a cercare un proprio risicato spazio. Aczél, con funzioni diverse ma sempre di alto livello, rimane uno tra i piú potenti personaggi della politica ungherese fino al 1985, anche se con minore influenza sulla cultura. Muore nel 1991, amareggiato dal disprezzo spesso palese di molti intellettuali. La sua ”riabilitazione parziale” si sta svolgendo proprio oggi, come conseguenza della politica autoritaria di Orbán, gestita da funzionari che – al contrario di Aczél – non conoscono e soprattutto non sono interessati alla cultura ma soltanto al proprio tornaconto. Perfino molti dei cineasti un tempo appena tollerati da Aczél ne riconoscono l’intelligenza e la sincera volontà di appoggiare le arti ungheresi.
In campo cinematografico, un ruolo fondamentale nel senso del rinnovamento lo svolgono gli Studi, il Béla Balázs su tutti, strutture produttive autonome in cui si incontrano l’esperienza degli anziani e la voglia di sperimentare dei giovani e dove il documentario come registrazione della realtà spesso precede il passaggio alla finzione: Gaál e Sára, ad esempio, girano ”Tisza – “Őszi vazlatok”” (t.l: Tibisco – ”Variazioni d’autunno”) e ”Cigányok” (t.l.: Zigani) come preparazione rispettivamente a ”Sodrásban” (t.l.: Corrente) e ”Feldobott kő” (t.l: La pietra lanciata).
Le influenze delle altre cinematografie, dell’Est come dell’Ovest, che indubbiamente ci sono e risultano avvertibili, vengono riassorbite e indirizzate verso un’ottica peculiarmente nazionale. Come ha scritto Gábor Gelencsér, non si assiste però a teorizzazioni e pratiche ”di scuola” ma a “un sistema di valori piuttosto generico” nell’ambito del quale poterono nascere “soluzioni formali che rivelavano una visione individuale ma erano allo stesso tempo aperte le une verso le altre”, per cui si può dire che se “la poetica dell’arte cinematografica ungherese degli anni sessanta non può essere definita unica e omogenea, nello stesso tempo però le diverse poetiche non possono essere interpretate separatamente” (3).
Schematizzando, si potrebbe indicare un percorso attraverso tre gruppi di film.
a) Le opere dei registi giá attivi in precedenza, per la maggior parte legate alla letteratura, nelle quali il ruolo di quest’ultima – limitato, schematico e sopprattutto propagandistico, o nel migliore dei casi puramente ”culturale” – quale era nel cinema dagli anni cinquanta all’inizio degli anni sessanta, viene ad assumere finalità molto piú astratte, diventando un tramite per esprimere opinioni personali e dubbi sulle certezze fino ad allora proclamate, ma soprattutto per rappresentare in modo piú fedele la realtá , sia del passato che del presente.
Tra questi, Károly Makk ha il compito di iniziare il decennio con ”Megszállottak” (t.l.: I fanatici, 1961), sullo scontro tra vecchio e nuovo nelle campagne, importante “non tanto per la novità della forma, quanto per quella del tono” (4), ma soprattutto di chiuderlo con un capolavoro, ”Szerelem” (t.l.: Amore, 1970). Scritto da Tibor Déry, il film riesce a concentrare tra le pareti di una stanza e a stilizzare nel gioco di menzogne, reciprocamente accettate da parte della madre e della moglie di un uomo in carcere per motivi politici, l’atmosfera di oppressione del regime di Rákosi. Zoltán Fábri è conosciuto soprattutto per ”Húsz óra” (t.l.: Venti ore, 1965), tratto da un celebre romanzo di Ferenc Sánta, durissima inchiesta di taglio giornalistico su una comune agricola, ma sarebbero da menzionare anche ”Nappali sötétség” (t.l.:Buio di giorno, 1963) e ”Utószezon” (t.l.:Fine stagione, 1966), per il tema dell’olocausto, pochissimo trattato dal cinema ungherese. Di András Kovács va citato ovviamente ”Hideg napok”(t.l.: Giorni freddi,1966), sulla strage compiuta dall’esercito magiaro in Serbia nel 1942, un tema molto ”delicato” e da molti osteggiato a partire dall’uscita del romanzo di Tibor Cseres, ostilità che naturalmente è tornata attuale oggi, in un clima di nazionalismo montante. Sono però da ricordare anche due pellicole che risultano testimonianze emblematiche dell’epoca: ”Falak” (t.l.: I muri, 1968), il cui titolo simboleggia la situazione degli intellettuali di sinistra ”riformisti”, e il lungometraggio documentario ”Nehéz emberek” (t.l.: Gente difficile, 1964), in cui cinque inventori raccontano le proprie vicissitudini per la realizzazione di brevetti di importanza nazionale, ostacolati dalla burocrazia e/o dall’invidia dei colleghi.
A questa generazione appartiene Miklós Jancsó, monumento e vate del cinema ungherese, al quale ha saputo imporre una svolta decisiva, anche sul piano strettamente linguistico. I suoi film rappresentano in maniera esemplare i movimenti, le correnti e gli sviluppi di tutta la settima arte magiara. ”Oldás és kötés” (t.l.:Sciogliere e legare, conosciuto anche come Cantata, 1963), da un testo letterario di József Lengyel, è già profondamente segnato dalle stigmate di un autore appartenente sia alla corrente ”popolare” – il protagonista è un intellettuale di origine contadina – che a quella ”urbana”, con il Bartók etnomusicologico di “Cantata profana” a fare da connettivo tra passato e presente, mondo rurale e società industriale, valore delle tradizioni e necessità del rinnovamento.”Így jöttem” (t.l.: Sono venuto così, o Il mio cammino, 1964) è un’ interessante opera di transizione, o forse di compromesso, in quanto mette in scena l’amicizia tra un giovane soldato ungherese e un coetaneo russo verso la fine della guerra. Da questo momento Jancsó si occuperà dei problemi eterni del rapporto tra individuo e potere nel corso della storia, sia ungherese che europea, in simbiosi con l’ amico e co-sceneggiatore, lo scrittore Gyula Hernádi, almeno fino alla morte di quest’ultimo. ”I disperati di Sandor” (Szegénylegények,t.l.: Poveri giovani, o I senza speranza, 1965), uno dei capolavori assoluti del regista e del cinema danubiano, è troppo noto e analizzato perchè ci si debba tornare sopra. Basterà fare cenno all’utilizzo del piano sequenza come forma dell’oppressione psicologica, al rapporto magistrale che viene a instaurarsi tra figura umana e paesaggio, all’ambiguità della metafora anche come strumento per aggirare le trappole della censura. Temi e stilemi che ritroviamo nei successivi ”L’armata a cavallo” (Csillagosok, katonák, t.l.: Soldati stellati, 1967),”Silenzio e grido” (Csend és kiáltás, 1968), ”Sirokkó” (t.l.: Scirocco, 1969) , ”Agnus Dei” (Égi bárány, 1970) e ”Még kér a nép” (t.l.: Il popolo chiede ancora, 1971).
Un discorso a parte merita ”Venti lucenti” (Fényes szelek, 1968), importante per il dibattito che innesca a suo tempo. Per capirlo bisogna riassumere alcune circostanze della sua genesi. La storia é ambientata nel 1948, quando i comunisti hanno preso il potere in Ungheria. I protagonisti sono i membri di NÉKOSZ – Associazione dei Collegi Popolari, provenienti dalle classi oppresse nel regime precedente, pieni dunque – oltre che della speranza di ”cambiare il mondo” – anche della rabbia contro i rappresentanti del passato. Il film é girato nel periodo della contestazione in Occidente, sperimentata di persona da Jancsó a Roma, che é anche quello del tentativo di riforma del socialismo a Prága e dell’invasione della Cecoslovacchia da parte dei ”paesi fratelli”. Attuando una fusione tra le proprie esperienze del passato e quelle del presente, il regista mostra la natura violenta e prima o poi fine a se stessa delle rivoluzioni. I politici hanno considerato ”Venti lucenti” antidemocratico per la dissacrazione delle idee comuniste, mentre Jancsó, come nel caso della ”Pacifista” (1971), voleva riflettere sulle conseguenze caotiche di ogni processo rivoluzionario e, soprattutto, sulla sua manipolazione da parte del potere.
b) I cortometraggi della generazione formatasi prevalentemente nell’atmosfera del tutto particolare dello Studio Béla Balázs.
Qui, almeno nei primi anni, non esiste una vera e propria linea ”di tendenza”, dunque vengono realizzati cortometraggi di finzione, documentari e anche film sperimentali, prima praticamente inesistenti, con l’unica eccezione del magnifico ”Pályamunkások” (t.l.:Operai della ferrovia, 1957) di Gaál. In questo ambito, István Szabó, che sará poi il rappresentante principale del cinema ”urbano”, realizza alcuni corti tra i quali va segnalato soprattutto ”Te” (t.l.:Tu, 1963), toccante elegia dell’amore nella quale è possibile riscontrare i germi della trilogia della quale parleremo più avanti. Di Sándor Sára, grande direttore della fotografia oltre che regista, vanno ricordati i cortometraggi ”Vízkereszt” (t.l.: Epifania,1965) e ”Pro patria” (1971), oltre naturalmente a ”Cigányok”. Inoltre, i film da lui realizzati insieme a Ferenc Kósa e al poeta-sceneggiatore Sándor Csoóri, che diventano gli esempi più importanti dello stile ”popolare”, basato sulle tradizioni contadine, sulla ”fonte pura” della musica di Bartók e sul cinema di István Szőts, la cui pellicola d’esordio, ”Emberek a havason” (t.l.: Gli uomini della montagna), presentata alla Mostra di Venezia del 1942, è la prima e per molti anni unica con caratteristiche analoghe a quelle del neorealismo girata in Ungheria. Questi due gruppi lavorano insieme nello Studio Béla Balázs, ma la politica culturale ”divide et impera” di Aczél ben presto li allontanerà.
Un caso a parte è rappresentato da Zoltán Huszárik, pittore e attore oltre che regista, figura tragica di irregolare lontano dalla politica e dal mondo, che in ”Elégia” (t.l.: id., 1965) intona un inno al cavallo, figura mitica nella cultura ungherese, ribadendo in seguito la propria vocazione in qualche modo decadente con il suo primo, folgorante lungometraggio, ”Szindbád” (t.l.: id, 1971), dai racconti di Gyula Krúdy e con la fotografia di Sára, ritratto di un gaudente d’epoca di straordinaria raffinatezza linguistica.
c) I lungometraggi dei registi provenienti dallo Studio Béla Balázs.
Le caratteristiche generali sono riassumibili nella speranza di poter raccontare in modo piú sincero sia la storia dei loro autori che quella dei loro genitori e dei loro ambienti, l’ambizione di cambiare in meglio la societá e la volontà di contaminare le acquisizioni linguistiche del nuovo cinema internazionale con le tradizioni della cultura ungherese . Personalità di spicco in questo ambito è István Gaál, un solitario come Huszárik e, grazie ai suoi studi in Italia, tra quelli maggiormente influenzati dalle arti figurative occidentali, sia classiche che moderne. I suoi film si concentrano soprattutto sulla psicologia dell’individuo nei diversi periodi della storia dell’Ungheria del dopoguerra. ”Sodrásban”, esordio di sbalorditiva maturità linguistica, pur mutuando da Antonioni lo schema delle crisi individuali in seguito a un evento drammatico, racconta secondo i dettami di una poetica del tutto personale sia la ieraticità dell’antico mondo contadino che i dubbi e le insicurezze degli adolescenti urbanizzati. ”Zöldár” (t.l.: Anni verdi, 1965) è ancora una struggente opera generazionale sull’apprendistato alla vita di uno studente venuto a Budapest dalla campagna negli anni di Rákosi. ”Keresztelő” (t.l.: Battesimo,1967), illuminato dalla tragica figura del ”divo” Zoltán Latinovits, morto suicida, ruota attorno all’antinomia successo/fedeltà ai propri principi. ”I falchi” (Magasiskola, letteralmente Alta scuola, 1970), è una potente e audace metafora sul potere.
L’altro regista a imporsi in questo periodo è István Szabó, l’unico destinato al successo internazionale dopo l’Oscar di ”Mephisto”. La trilogia composta da ”Álmodozások kora” (t.l.:L’età delle illusioni,1964), ”Il padre” (Apa ,1966) e ”Szerelmesfilm” (t.l.: Film d’amore, 1970) racconta con garbo e sensibilità i trasporti e i drammi piccoli e grandi dell’adolescenza, guardando certamente a Truffaut, al quale ruba il personaggio guida, una sorta di Doinel-Léaud interpretato da András Bálint.
Emblematiche sono poi le vicende della nascita e della sorte di ”Tízezer nap” (t.l.: Diecimila soli) di Ferenc Kósa, iniziato nello Studio Béla Balázs, realizzato nel 1965 ma uscito soltanto nel 1967, in quanto rispecchiano in modo evidente la strategia della politica culturale del regime di Kádár nei confronti degli artisti legati alle tradizioni popolari. E’ Aczél in persona a proporre di fare una ricerca sulla storia dei contadini del Novecento ai giovani cineasti dello Studio, che accetta il progetto della triade Kósa-Sára-Csoóri. Nel film però il punto di vista degli autori risulta completamente diverso da quello che si aspettava il potere. La sorte dei contadini, infatti, continua a essere travagliata anche nel socialismo: gli ex braccianti, dopo una breve euforia per avere finalmente ricevuto un pezzo di terra, vengono costretti a rinunciarvi e a entrare nelle cooperative. ”Tízezer nap” mette in scena con chiarezza e sincerità le tragedie umane provocate dalla dittatura di Rákosi e, fatto unico in quel periodo, i suoi protagonisti chiamano ”rivoluzione” quella del 1956. Oltre alle motivazioni ideologiche, nemmeno la rappresentazione visuale della cultura contadina piace alla politica. Aczél e compagni sono praticamente costretti dai critici stranieri a consentire la partecipazione del film al festival di Cannes, dove vince il premio per la regia.
Altre opere importanti, ”Feldobott kő” di Sándor Sára, in cui il sommo cinematographer riprende il discorso sugli zingari introdotto dal cortometraggio preparatorio, attirandosi a sua volta gli strali della censura, che lo costringe a cambiare il finale, e ”Ítélet” (t.l.: Giudizio, 1970) di Ferenc Kósa, sul sollevamento dei contadini nel 1514 capeggiato da György Dózsa, che fu bruciato vivo su un trono di ferro. Quest’ultimo é uno dei tre film, insieme a ”Venti lucenti” e ”Agitátorok” (t.l.: Agitatori, 1969) di Dezső Magyar, che per la loro inusuale lettura delle rivoluzioni provocano molti dibattiti immediatamente dopo il ’68. ”Ítélet” si muove sulla falsariga degli affreschi storici di Wajda, è cioè pensato anche per un grande pubblico, ma la caratterizzazione molto complessa e sfumata sia del protagonista che della sua violentissima rivolta si ritiene vada contro i criteri dell’ideologia marxista, o meglio delle sue semplificazioni volute dal potere.
Ancora più complicato il caso di ”Agitátorok” in quanto opera collettiva di giovani, di una ”nuova sinistra” le cui idee nei paesi socialisti sono considerate piú pericolose di quelle dei cosiddetti ”popolari”. Anche questa pellicola, ambientata nel 1919 durante la Repubblica dei Consigli di Béla Kun, che pure faceva parte della mitologia del regime di Kádár, mette in scena le diverse tipologie di rivoluzionari, dagli estremisti violenti agli intellettuali ”umanisti”. Mentre la generazione dei vari Szabó, Gaál, Sára e Kósa era disposta a qualche compromesso, l’anticonformismo e il rigore di quella del ’68 provoca un intervento censorio piú severo da parte del potere. E infatti, dei tre film sulla natura e sulla pratica delle rivoluzioni in diverse epoche storiche, ”Agitátorok” é l’unico a venire assolutamente proibito.
A partire da questo momento si affaccia sugli schermi una nuova generazione, quella di György Szomjas, Gyula Gazdag, Gábor Bódy e István Dárday, autori capaci di rinunciare con più decisione di quanti li avevano preceduti ai compromessi con la politica, affrontando in maniera diretta i problemi sociali del presente, dunque destinati spesso a scontrarsi con la censura del regime. Ma questa è appunto un’altra storia.
NOTE
1) Se Imre Nagy, leader del nuovo corso, veniva dai quadri del Partito, il suo ideologo, Istvan Bibo, era un appartato liberale. Ci sarebbe poi molto da dire su quello che il ’56 ha rappresentato come punto di svolta per tanti intellettuali italiani come Italo Calvino, mentre la vulgata ufficiale del PCI parlava di rigurgito fascista o giù di lì.
2) Cfr. Tibor Sandor, Storia di una baracca, in Paolo Vecchi (a cura di), “Sciogliere e legare – Il cinema ungherese degli anni ’60”, Lindau – 14° Festival Internazionale Cinema Giovani, Torino, 1996.
3) Gabor Gelencsér, Sciogliersi e legarsi – Poetiche creative nel cinema ungherese degli anni sessanta, ibid.
4) ibid.
5) Per chi voglia approfondire su questa figura la cui importanza, anche sul piano simbolico, travalica l’ambito del cinema, oltre al “Castoro” del compianto Giovanni Buttafava, segnaliamo il libro molto bello e “definitivo” di Giacomo Gambetti, “Miklos Jancsó – Il cinema tra storia e vita”, Marsilio, Venezia, 2008.
.
LA RAGIONE DI UN SOGNO: SERGIO CITTI E IL CINEMA
di Francesco Saverio Marzaduri
“Er cinema è quer posto dove vai, compri un bijetto e poi trovi uno che ‘tte lo strappa… Quell’è er cinema, no? O me sbajo?”
SERGIO CITTI
L’estate scorsa ho avuto modo di rivedere “Brutti, sporchi e cattivi,” durante un’ennesima sua messa in onda televisiva. La cui trama, come si sa, ruota su uno stuolo di baraccati alla periferia romana che la cinepresa di Scola, con piglio semi-documentaristico, scruta e trasla con l’occhio impietoso della commedia italiana. E non può non trasparire (e come d’altronde non potrebbe?) un’impronta pasoliniana nella piccola grande sfera su cui si pone lo sguardo. Anche in una bottega di orrori casalinghi, dove l’ignobile cinismo del patriarca Manfredi è proporzionale alla delinquenza cui è spinto il parentado per sopravvivere – in sé e per sé costante di una commedia, la nostra, ai limiti del ne(r)orealismo, frattanto divenuta irrimediabilmente corrosiva – lo spettatore più accorto riconosce e ritrova Pasolini. Salvo che le note circostanze, un anno prima dell’uscita del film, impedirono a questi di prestare la propria collaborazione per un prologo filmato, e ciò spiega la ragione per cui alla voce “consulenza artistica” sui titoli di coda fa capolino il nome Sergio Citti.
Senza voler imporre al critico di fungere anche da storico pedestre, e indurlo a una testimonianza esaustiva sul ruolo da Citti assunto nella menzionata pellicola, quanto sinora esposto dovrebbe bastare alla formulazione di un’idea, se non a mettere a fuoco meglio l’immagine di un cineasta che sfortunatamente non è mai riuscito a godere di una cifra personale. Inutile, oltreché sterile, negare l’evidenza: indissolubilmente, il nome di Sergio Citti è legato alla filmografia pasoliniana. Pure, il fatto che tale nome appaia in uno degli epitaffi della commedia italiana non può non far pensare che la lezione “di vita,” con tutta la propria realista connotazione, inoculi una sorta di tara ereditaria a un genere la cui risonanza derivava da un’allegorica traslazione. E nelle cui pieghe grottesche l’osservatore più disposto poteva scorgere qualsivoglia riferimento alla realtà.
Come si sa, il piglio vernacolare, romanamente sanguigno, con cui si ritrae una Capitale infida, in tutti i sensi ai margini e resa ancor meno innocente da derelitti che il titolo vuole lontanissimi da aure di virtù e nobiltà d’animi, agevola nella comprensione di un occhio, quello di Citti, da sempre sensibile alla rappresentazione di una realtà sordida. E tuttavia desiderosa di pieghe oniriche, dove la ragione del sogno, per mostrare che tale sogno non si scosta completamente dalla reale condizione, è stemperata – sublimata, anzi – da un’ironia ora mordace e cattivista, ora graffiante e irriverente.
Nella non vasta filmografia registica di Citti, che egualmente conta titoli di un certo pregio, lo sguardo è quello di un cineasta che assorbe la lezione controcorrente di Pasolini, infondendo non poco il pepe necessario all’eversiva asciuttezza nella politique del secondo. Sovente ne è il cervello e il motore, fin dai titoli d’esordio “Accattone” e “Mamma Roma,” per i quali rispettivamente è sceneggiatore e co-interprete insieme al fratello Franco, e curatore dei dialoghi. Senza trascurare la collaborazione per il Bolognini de “La notte brava” e per il giovane Bertolucci de “La commare secca,” anch’essi realizzati sotto lo sguardo di Pasolini. Ma il sodalizio umano e artistico tra Citti e Pasolini – destinato a durare quindici anni circa, sino alla morte, comprendendo la lavorazione di “Salò” – non si esaurisce nella collaborazione di nomi fissi della sua produzione (Baragli, Davoli, Delli Colli, Donati, Ferretti, Garofalo, Grimaldi, Morricone), e a seguire s’impreziosisce da firme non meno rinomate (Cerami, Piovani, Grieco, Jemma, e ancora Mario Ambrosino, Francesco de Masi, Andrea Crisanti).
Al pari di Fellini, del quale condivide un ironico apprezzamento (“Er momento più bbello der cinema è quanno te danno ‘n acconto”), Citti inscena un immaginario dove il reale non può apparire più vero di quel ch’è, e lungo un itinerario che solca una condizione d’indigenza e squallore: benché non sia facile tener testa alla fame, sopravvivere alla disperazione o alle meschinità del mondo, arrabattarsi anche a costo della più esasperata avidità o dell’azione più turpe, le creature del regista-sceneggiatore romano si rilasciano al racconto, quando non al sogno, quale unico surrogato a un’esistenza grigia, monotona, fatta di piccoli crimini o di truci delitti, e talora estrema ratio per attendere la morte. Inusuale, ma non troppo, che in Citti il quid onirico di matrice felliniana abbracci la poetica pasoliniana, irriverente e all’uopo sporca: una bilanciata alchimia che non dimentica lo sguardo fiabesco e surreale di apologhi politico-allegorici come “Uccellacci e uccellini,” “La Terra vista dalla Luna,” “Che cosa sono le nuvole?” e “La sequenza del fiore di carta.”
Chi conosce Citti nella dimensione del fantasy può individuarne la mano in quello che, a detta di molti, è il suo capolavoro, “I magi randagi,” all’uscita incompreso e ignorato come pure i titoli che ne conclusero la produzione (“Vipera,” “Fratella e sorello”). Un’opera il cui soggetto all’origine è un ipotetico film da girare inerente la Natività di Cristo (quel medesimo “Porno-Teo-Kolossal” di cui Abel Ferrara, nel recente “Pasolini,” avrebbe ricostruito alcune sequenze): traendo spunto dal prototipo, Citti immagina che a rappresentare la Natività sia una combriccola di teatranti filosofi, i quali, non capiti, sono costretti ad allontanarsi e compiere lunghi itinerari da viandanti. Sino a che, inevitabile, la realtà non sostituisce la fantasia…
Personalità nomade, girovaga come i magi randagi, è lo stesso Citti. Un cinema apolide, il suo, inesorabilmente relegato ai margini di una produzione, e ancor prima di una cultura, incapaci nel tempo di conferire a cineasti del medesimo calibro un più equo riconoscimento, e che dunque condanna l’opera cittiana a non trovare quanto le spetterebbe. La cosa, all’autore romano, non sembrava importare più di tanto, come documenta una video-intervista, rilasciata poco prima della scomparsa: Citti confessa in prima persona il suo rapporto col cinema e con la vita a quei Ciprì e Maresco che, a partire da “Cinico Tv,” molto devono a lui quanto al suo maestro. A loro, il regista di “Ostia” testimonia il ricordo di un Pasolini dedito a catturare un episodio d’insostituibile realtà sul set de “Il Decameron,” nonostante la pellicola fosse terminata da diversi minuti. Ancora, Citti rivela lo spirito giocoso, vitale, sempre scherzoso e sorridente, di una figura altresì tormentata, sulla quale si è detto e scritto di tutto, e il contrario di tutto, salvo forse comprenderla nella sua interezza.
Il sogno e l’antitesi sono i pattern predominanti del cinema di Citti, dove il primo aiuta a esorcizzare la seconda. Perfino i riferimenti a un’attualità del tempo peggiore della stessa peggiore fantasia fanno, di questo cinema, un’isola a parte ben poco commerciabile: ne è un esempio Piripicchio, figlio dei suonatori ambulanti di “Duepezzidipane” (il titolo, rammentava il compianto Grazzini, è “proprio così: tutt’una parola”), che, da rampollino riconoscente, via via diventa un piccolo mostro, cinico e crudele. L’ingrediente per dimenticare la mestizia, anche solo per un istante, è la risata, da intendersi quale strafottente scherno e liberatorio sfotto’ – la stessa che sorprende i due assassini, una volta giustiziati, negli ultimi fotogrammi di “Storie scellerate”. A star bene accorti, il cinema di Citti è puntellato di presenze comiche, figurine ilari che recano facce e corpi buffoneschi illustri (Benigni, Montesano, Nichetti, Nuti, Pozzetto, Villaggio, Verdone e persino Fiorello), accostati a interpreti di rango (Gaber, Gassman, Giuffré, Noiret, Placido, Proietti, Stoppa, Tognazzi, le sorelle Melato e via sciorinando), e tutti a un tempo immortalati in paradossali situazioni al fianco di comprimari (da Mario Brega ad Angelo Infanti, da Franco Javarone a Carlo Monni, a Giacomo Rizzo), anche appartenenti all’avanspettacolo meno raffinato (Frassica, Luotto, Vitali), che detengono e mantengono inalterata la forza, e prima ancora la poetica, del più genuino intrattenimento popolare, quello che già le riviste più militanti e politicamente impegnate riconoscevano a Franchi e Ingrassia a inizio anni Settanta.
Non meno ardito è l’accostamento di questo cinema, e questa poetica, con l’operazione delle stripes, dove un contorno scenico funge da pretesto od anello di congiunzione per una sequela di segmenti, talvolta ad incastro, e personaggi che la circostanza obbliga a intersecare un unico discorso. Al cinema l’operazione si rivela indovinata con il citato “Storie scellerate,” che rinvia alla struttura semplice del racconto nel racconto ereditato dalla “Trilogia della vita,” mentre la papalina corte dei miracoli messa in scena appartiene al contesto più schiettamente romanesco. E, rivalutato nel tempo, è il corale “Casotto,” titolo ben distante da qualsiasi connotazione di commedia balneare scollacciata. Ma è nel piccolo schermo che Citti consegue risultati anche meglio definiti: esercizi di stile – parafrasando una tardiva operina girata a più mani e a cui l’autore romano ha collaborato – dove la poetica sospesa tra il grottesco e il favolistico porta a eccellenti risultati, da “Il minestrone,” ancora di matrice pasoliniana e, seppur uscito in sala, da recuperare nell’extended version del formato televisivo, fino al monumentale “Sogni e bisogni”.
In quest’ultimo caso, il frame di base non può nascondere la derivazione felliniana, fotografando il Destino (che non per niente ha il volto della Masina) incarcerato per un equivoco insieme al Bene e al Male, alla disperata ricerca, una volta evaso con loro, di un libriccino sul quale è scritta la vita di ciascun essere umano. Al contrario, il libriccino è nelle mani di un bimbo povero le cui manine sono riprese di volta in volta nell’atto di scrivere ciascun titolo degli undici segmenti, presentati a due a due per ogni puntata televisiva: apologhi concisi di un riadattato “Ai confini della realtà,” che il ritrovatore del quaderno inventa e scrive di sana pianta sul prezioso strumento del Fato, rendendole reali e veritiere.
.
.
.
.
Questi, si diceva, gli echi che meglio identificano (e permettono d’identificare) la produzione cittiana. Ma il regista-sceneggiatore romano ha sempre fatto di tutto per dissociarsi dagli inevitabili paralleli ipertestuali coi maestri da cui discende la sua opera, e austera è la sua presa di posizione verso i critici, ignoranti sulla materia trattata. Nondimeno, sarebbe un errore gravissimo dissertare di Sergio Citti senza spendere qualche parola per “Mortacci”: autentica summa di pensiero arbitrario e saggezza, di un modo al contempo anarchico e cialtrone d’interpretare la vita e il suo rovescio; e anch’esso strutturato per episodi ad anello con relativi personaggi, sullo sfondo di un camposanto che, reinterpretando Edgar Lee Masters, in certo senso è stretto parente del Buffalora di Tiziano Sclavi (e del gotico adattamento di Michele Soavi). In un passerella di situazioni bislacche, dove lo sguardo irriverente, ancora una volta controcorrente, non s’inchina nemmeno alla morte e alla voglia di scherzarci su (“Ce diventerei amico,” per usare le sue parole, “so’ sicuro che la incastrerei… Je farei ‘na sola!”), Citti compie un balletto dissacratorio lontano da mestizia o da patetismo, dove la beffa felicemente spodesta il macabro e la polka che lo conclude è degna della danza funerea de “Il settimo sigillo”. “Mortacci” riesce dove non riusciva lo spunto di partenza di “Viale del tramonto,” coi deceduti che dialogavano tra loro sulle proprie spoglie; ma i tempi sono quelli che sono. E se il tempo ancora non ha reso giustizia al nome di Citti, né concesso un’attenta riscoperta al suo occhio (dis)incantato e difficilmente collocabile, piace pensare che tra i defunti “non morti” del film figuri anche lo spiritaccio di un artista senza padroni. O così, almeno, chi scrive vuol ricordare la morte – avvenuta l’11 ottobre di dieci anni fa, e a quarant’anni dalla dipartita di Pasolini – di qualcuno che nel panorama del nostro cinema ha portato avanti il messaggio del collega-maestro: che in quella favola dolce-amara ch’è la vita, “essere morti o essere vivi è la stessa cosa.”
.
SAGGI
ALLE ORIGINI DELL’IMMAGINARIO DI GEORGE LUCAS
di Roberto Lasagna
George Lucas, ovverosia il cineasta che visse nel futuro. La saga di “Guerre stellari” non ha soltanto conquistato i botteghini di tutto il mondo, ma ha prodotto interpretazioni e ripensamenti del genere fantastico, soprattutto, di un modo di intendere lo spettacolo cinematografico negli anni Settanta della New Hollywood. La saga di “Guerre stellari” non è soltanto una fuga dal reale, una vertigine in nuovi spazi del possibile e del visibile. La prova è forse da ricercare negli altri lavori cinematografici di Lucas, nelle sue poche ed emblematiche regie (considerando la successiva trilogia-prequel di “Guerre stellari”, quella realizzata a cavallo tra il 1999 e il 2005, tutt’uno con un unico progetto di cinema che riemerge negli anni Novanta e si proietta nel nuovo millennio) e nelle produzioni, cioè in quei tasselli cinematografici che da soli appaiono esclamativi di un’idea di cinema come campo di sperimentazione per nuovi scenari della visione. Peraltro, quando esce nelle sale il primo film del giovane regista, non tutti lo ritengono soltanto un divertissement per la “generazione pop-corn” come sarebbe successo invece per i successivi film del regista; nello stesso tempo, la figura del cineasta Lucas appare legata, almeno agli inizi, al destino di Francis Ford Coppola e di una concezione egemonica del rapporto con il pubblico (nonché con la produzione). In seguito Lucas erediterà i toni sontuosi e spettacolari di Coppola privilegiando tuttavia la ricetta estetica del padre spirituale dei nuovi cineasti americani, Roger Corman. Quindi, la strada percorsa da Lucas prenderà una direzione che lo porterà presto alla definizione di un modo decisamente personale di intendere lo spettacolo cinematografico. Nel tentativo di rivendicare l’importanza dell’immaginazione, non per questo diffidando completamente del realismo, Lucas intende proclamarsi fin dal primo lungometraggio, “THX 1138”, realizzato nel 1970, quale novello Georges Méliès del cinema statunitense. Un Méliès per le masse americane avvinto da una serie di presupposti ben definiti. Astrattismo, simbolismo, amore per i generi e tensione formale all’ennesima potenza fanno di questo esordio un atto di coerenza per la nascente casa di produzione Zoetrope. Quasi un manifesto di modernismo che favorisce la molteplicità di letture. L’autarchia produttiva di Coppola e di Lucas, uniti nel tentativo di smarcarsi dallo strapotere delle Major, nasce comunque nel segno della mediazione con le grandi case di produzione. Infatti, come il primo film di Lucas si rivelerà un flop al botteghino, Coppola sarà costretto a correre ai ripari lavorando con la Paramount per il blockbuster “Il Padrino”. Grazie agli enormi proventi di quel film potrà finanziare ancora l’amico Lucas “imponendo” alla Universal la distribuzione di “American Graffiti” (1973). E questa volta si tratterà di un grande successo di pubblico.
Graffiti
“American Graffiti” è uno dei film più emblematici nella ridefinizione del pubblico che corre nelle sale per gustarsi i prodotti della rinascente industria cinematografica: grande attenzione ai giovani, al loro micro-mondo che diviene simbolo di molte universalità, alle mode e ai gusti correnti; ma anche, “American Graffiti”, film del ripensamento generazionale, della riflessione sui piccoli-grandi temi della quotidianità, sull’importanza dell’adolescenza e sul riaffiorare dei sogni rimasti irrealizzati durante quell’importante fase dell’esistenza. La fuga da una vita sentita come frustrante è pertanto una radice comune ed autori come Lucas, Scorsese e Spielberg. Se Il grande amico degli esordi cinematografici di Lucas è Francis Ford Coppola, più avanti, dopo l’enorme popolarità di “Guerre stellari”, egli individua in Steven Spielberg il nume tutelare delle sue nuove operazioni produttive. La saga dell’esploratore Indiana Jones, di cui Lucas produce il primo e il terzo episodio scrivendo però il soggetto dell’intera trilogia e lasciando a Spielberg il compito di regista, mentre appartiene allo spirito di entrambi i cineasti, può essere considerato a pieno titolo come un progetto lucasiano: ne fanno fede la vocazione antropologica dei migliori momenti della saga, e, inoltre, la concezione stessa di serialità che si impone come una delle caratteristiche fondanti il cinema di Lucas. Più in generale, Lucas e Spielberg rilanciano il cinema d’avventura per adulti, ben oltre la vocazione “infantilista” da più parti additata in merito alla loro vocazione espressiva. In questo senso, le influenze tra produttore e regista sono senza dubbio reciproche, così come, all’inizio di carriera, Coppola avrebbe influenzato Lucas nella scelta di esprimere una tensione estetica maggiormente rigorosa e intellettualistica, mentre Lucas, a sua volta, avrebbe incoraggiato Coppola nella prosecuzione di un proprio disegno produttivo. Ad ogni modo, a dispetto della grande popolarità dei suoi più grandi successi produttivi, il “lato oscuro” di Lucas si sarebbe fatto sentire anche dopo i due film d’inizio carriera, cioè sia in Guerre stellari, terza regia del nostro nonché l’ultima prima di un silenzio registico durato vent’anni, sia nella saga “prestata” alla regia di Steven Spielberg. Per quanto pertiene quest’ultima, le avventure dell’archeologo Jones condensano in una traiettoria di ripetizioni il modello di un cinema entusiasmante che sembra volere restituire ai quarantenni la foga di quando erano scolaretti. Dal canto suo Spielberg, nei tre film interpretati da Harrison Ford (una delle “scoperte” di Lucas), si impegna al fine di rendere lo spettacolo sempre più acrobatico, pirotecnico, come sarà anche nei momenti migliori di “Jurassic Park”. Sua, ad esempio, è l’attenzione per i meccanismi della suspense, suo è anche il sensazionalismo effettistico di buona parte della saga. La tensione conoscitiva verso nuovi mondi, che si modula in una vera e propria poetica dell’altrove in “Incontri ravvicinati del terzo tipo” e in “E.T.”, fa capolino nella saga di Indiana Jones attraverso la raffigurazione di un personaggio, l’esploratore-archeologo, cui è nondimeno agevole riconoscere la più genuina ispirazione lucasiana. L’incontro con l’avventura simbolizzato attraverso la baldanza fumettistica della saga di Indiana Jones, acquisisce tuttavia un senso più sfaccettato se ricondotto alle origini cinematografiche di Lucas; quelle, propriamente, di “THX 1138”. A questo proposito, volendo gettare uno sguardo sul film più “sperimentale” del cineasta, conosciuto e apprezzato soprattutto dagli appassionati di cinema, ci sembra opportuno soffermarci un poco sul titolo italiano, mai come in questo caso così “profetico”: “L’uomo che fuggì dal futuro”. Il film di Lucas è infatti la raffigurazione di un XXV secolo buio, sotterraneo, decisamente poco a misura d’uomo. Il destino degli individui appare programmato a tavolino da un sistema sociale impietoso e cibernetico, così come la riproducibilità della specie è affidata al freddo determinismo delle provette di laboratorio.
Il senso dell’avventura
“THX 1138” è un film insolito, non soltanto per l’epoca in cui esce. In esso l’avventura è una delle componenti del film, ma non la principale. Il fascino che Lucas avverte per altri mondi, sicuro riflesso della sua formazione di studioso d’antropologia, si traduce nella ricognizione di un universo futuro che sembra imparentato con il passato di totalitarismo di alcune reali situazioni storiche. Il lavoro di Lucas deve molta della sua particolarità ai referenti cinematografici cui fa riferimento, primo fra tutti il mondo sotterraneo di “Metropolis”. Ma la divisione in classi è qui allegorizzata attraverso una più invadente divisione tra buoni e cattivi. L’opposizione bene contro male che sarà centrale in “Guerre stellari”, è esplicitata in “THX 1138” nell’esperienza formale di un racconto post-espressionista, che attualizza in parte le istanze politiche presenti nella narrativa di Orwell e Huxley. Ci troviamo in fondo nei pressi di in un cinema altamente simbolico nel quale si riattiva il terrore per la figura del “grande fratello”, simbolizzata questa volta dall’invisibile “Controllore supremo”. L’universo concentrazionario di “THX 1138” sembra essere il mondo ideale per gli adepti di Darth Vader, il cavaliere Jedi al servizio del lato oscuro della “Forza” in “Guerre stellari”. È un sotto-mondo totalitario in cui il “Controllore supremo” resta sconosciuto ai più, mentre al suo servizio è predisposta una rete di controllori e osservatori, secondo una rigida scala gerarchica difesa alla base da una potente squadra di robopoliziotti, completamente meccanici, agghindati con divise nere ed elmetti bianchi, i quali, coadiuvati da temibili sbarre elettriche, assicurano il mantenimento dell’ordine attraverso punizioni corporali e soluzioni definitive. Il futuro secondo Lucas è già pienamente raffigurato in “THX 1138”. Il titolo americano del film sta a significare il codice con cui è denominato il personaggio del film (Robert Duvall, in uno dei primi ruoli da protagonista); si tratta di un numero di serie tra i tanti che compongono quel che resta dell’umanità. Un’umanità sotterranea, igienizzata, stordita da onnipresenti altoparlanti che emettono di continuo slogan rassicuranti, secondo un training di controllo e stordimento della psiche. La vita è all’insegna dell’artificialità. Il cibo è sintetico. Il lavoro avviene in centri supermeccanizzati ed è finalizzato allo scopo di produrre nuovi soggetti meccanici. Il sesso è bandito dal sistema, mentre qualche volta si scopre tra gli individui, tutti rasati e vestiti di camici bianchi, la sopravvivenza di qualcuno nato non in provetta, ma attraverso un rapporto sessuale considerato “animalesco” e geneticamente riprovevole. Proprio costoro il sistema perseguita più di altri, come anche chi sembri “cedere” alle tentazioni della carne. I “nati-naturalmente” vengono controllati con assiduità, per evitare il rischio che contagino gli altri. Ed è quanto succede a Luh 3417 (Maggie McOmie), che si mostra irrispettosa delle leggi poiché butta nel water i sedativi e cerca di sedurre THX, un “operatore” addetto al montaggio dei robot. Nel futuro di Lucas il crimine più sconcertante riguarda dunque la carica libertaria che l’eros porta inevitabilmente con sé. Si tratta di una tematica fondamentale in un film come “THX 1138”. La macrostruttura concentrazionaria può mantenere la sua coesione laddove eserciti il suo controllo sul lato meno addomesticabile della natura umana: gli istinti e la carica trasgressiva di Eros. In questo senso il film di Lucas anticipa, con la sua fredda ambientazione, la resa espressiva di alcune tematiche che ritorneranno in altri film sul futuro realizzati durante gli anni Settanta, da 2022: “i sopravvissuti” a “Arancia meccanica”: la censura degli istinti, conseguenza di una struttura sociale autodistruttiva e cannibalica, rappresenta la chiave d’interpretazione di un avvenire letto nella prospettiva di un’Utopia negativa e cibernetica. Ma Lucas conduce la sua dialettica facendo emergere, in extremis, la speranza. Come sarà nella trilogia di “Guerre stellari”, il bene combatterà contro il male in una danza che sarà annunciata sin dal titolo dei singoli film: l’equilibrio tra bene e male (Guerre stellari), il prevalere del male (L’impero colpisce ancora), il riscatto del bene, quindi, l’affermazione della verità (Il ritorno dello Jedi). In effetti, già in “THX 1138” lo scontro tra bene e male supera lo schematismo attraverso una prospettiva di chiarificazione delle “potenzialità” dell’individuo: affrontare la lotta contro il sistema ipermeccanizzato significa anche percepire la gravità della propria condizione di individuo tenuto in una condizione di totale “snaturamento”, e recuperare l’autodeterminazione (la “Forza”) per fuggire ai controlli del sistema significa percepire l’urgenza di una ribellione imperiosa e fatale ai meccanismi dell’automa sociale. L’estrema conseguenza di questo tragitto di ribellione è la scoperta della verità, che determina a sua volta una nuova concezione dell’esistenza, simbolizzata nel finale di “THX 1138” attraverso la scoperta da parte del protagonista di una realtà altra, di cui si negava l’esistenza negli ambienti sotterranei del pianeta. L’immagine di Duvall stremato che, raggiunta la superficie terrestre, apre la botola e sbuca fuori, non trova il paesaggio azzerato dalle radiazioni propagandato minacciosamente dal sistema, ma un immenso sole che accoglie la sua rinascita, si iscrive senza equivoci nel clima simbolico di una fiaba sociologica, secondo quell’affabulazione romanzesca che sarà comune a tutti i film di Lucas fino a “I predatori dell’arca perduta”.
Postmodernismo luminoso
L’esordio di Lucas è all’insegna del recupero di quegli elementi dell’immaginario fantascientifico classico di cui il regista verifica l’inossidabilità attraverso un racconto destinato a nascondere la sua vocazione classica nella brillantezza di uno stile in cui trova ampio spazio il gioco delle contaminazioni. “THX 1138” è, in questo senso, un film ostentatamente “postmoderno” eppure vivificato dal sapore di verosimiglianza della ricostruzione scenica e sorretto dalla sobrietà della narrazione. Inoltre, la modernità di Lucas è da cogliersi nel clima altamente simbolico in cui egli cala il suo immaginario, bagnando la vicenda di toni ora messianici e speranzosi, ora impauriti e oscuri. Lo stile del racconto, sospeso tra simbolismo e iperrealismo, favorisce presto un’interpretazione critica meno scontata del suo lavoro. Sergio Arecco, ad esempio, si domanda se “Thx, nel suo camice bianco, col capo raso, fra le pareti nude della sua stanza-utero, spesso rannicchiato in posizione fetale, circondato da altre larve come lui, non allegorizza forse la condizione del neonato che apre gli occhi per la prima volta, senza ancora distinguere nulla? E tutta la fabula del film non veicola forse la metafora della nascita, o rinascita, dal grembo altrui, con le proprie sole forze? E non è questa una simbologia anche autobiografica?” (Sergio Arecco, George Lucas, Il castoro, La Nuova Italia, 1995, p. 31). Non è pertanto un caso che tutti i film di Lucas ottengano nel corso del tempo una sorta di supervalutazione critica. Il destino interpretativo del regista di “Guerre stellari” prende le mosse senza dubbio dall’aura “sperimentale” di “THX 1138”, film che pone le premesse per uno stile caratterizzato dalla fascinazione per le nuove acquisizioni della tecnologia e il riproporsi di costanti, narrative e tematiche, di sapore antico. La moderna epica di “Guerre stellari” sembrerebbe dunque anticipata da questo racconto allusivo, conoscitivo, ritualistico, sorta di allegoria “rinascimentale” del nuovo cinema statunitense che cerca di opporsi all’omologazione dell’immaginario nutrendosi delle molteplici possibilità offerte da una scrittura costantemente simbolica, affascinata da un mondo ideale che come un dedalo mostra anfratti di morte e crudeltà, ma anche momenti di rivalsa possibilista. Il cinema di Lucas muove quindi i suoi passi nel terreno dell’arcano esibendo una predilezione per il “germe” della ribellione in contesti sociali diversificati. In questo senso la trilogia composta da “THX 1138”, “American Graffiti” e “Guerre stellari” appare decisamente compatta. Il tema del riscatto da un universo concentrazionario (sorta di mondo demoniaco o di Leviatano, come avrebbe notato anche Arecco), che si modula attraverso il canone della fuga e dell’inseguimento, è comune alla vicenda di Thx e della sua compagna Srt, a Luke Skywalker e Han Solo di “Guerre stellari”, mentre non è improprio riconoscerlo indirettamente anche nella ipnotica deambulazione dei personaggi di “American Graffiti”, per i quali la notte diviene l’inesauribile “territorio di fuga” dalle regole di un mondo adulto percepito come imperscrutabile. La ribellione inscenata in “THX 1138” anticipa dunque il bisogno di sperimentare una concezione più autentica del vivere, attitudine che sarà propria del personaggio più enigmatico di “American Graffiti”, il giovane Curt Henderson al quale il Circolo dei Commercianti devolve un assegno di duemila dollari come borsa di studio in suo favore affinché lui, ragazzo intellettualmente dotato, possa frequentare un collegio dell’est. E la reazione di Curt, la sua esitazione dinanzi a quell’allettante offerta degli adulti, esprime una ribellione al pensiero comune che si manifesta attraverso la condizione di una protratta e irriducibile afasia, sintomo di disadattamento ma anche, nel film di Lucas, di una personalità gratificata dall’emergere del proprio spirito anticonformista. L’incertezza esistenziale del ragazzo californiano del 1962 è all’origine della sua coscienza di scrittore, tale sarà infatti, un giorno, il destino di Curt; se non sapremo mai di cosa si occuperà il giovane, di quali argomenti nutrirà i suoi libri, grazie al respiro di grande nostalgia evocato da American Graffiti è legittimo immaginare che egli non riuscirà a liberare facilmente i suoi pensieri dalle origini di “navigante” nella fitta rete di luci notturne del paese natìo. Luci, bagliori, immagini. Come il viaggio nell’iperspazio dell’astronave Millennium Falcon in “Guerre stellari”, il cinema di Lucas esplora l’impatto dell’individuo con le molte realtà di un universo abitato da luci, ologrammi, riproduzioni digitali, lanciandosi a tutta velocità in una sinfonia visiva che esprime tensione nei confronti della famigerata “riproducibilità tecnica”, così come nei riguardi di un’esistenza minacciata da quel “grande fratello” della nostra epoca chiamato serialità. Il rischio nel quale incorre l’uomo del futuro (e questo discorso vale, a ben vedere, sia per il protagonista di THX 1138 che per i futuri adulti di “American Graffiti”) è di perdere coscienza, cadere stordito nel marasma sonnambolico di un mondo percepito come pura superficie visiva; a questo proposito “THX 1138” trasmette l’inquietudine per un universo futuro dominato da immagini stranianti, e proprio grazie ad una simile prospettiva hanno avuto buona ragione coloro che hanno saputo leggere nel film l’attualizzazione di una tematica kafkiana. Tuttavia, il percorso di Lucas deve il suo smalto iperrealista soprattutto all’ispirazione cinefila, la stessa che sarà percepibile nei migliori episodi filmici dell’amico Steven Spielberg (pensiamo in particolar modo a Incontri ravvicinati del terzo tipo, forse il più affine alla tensione estetica di Lucas). Dunque la suggestione kafkiana, come il riflesso di film quali “Aurora” (Murnau) e “Il processo” (Welles), sono da leggere nell’ottica citazionistica propria di un cinema che si nutre di immagini altrui mimetizzandosi in una forma cinematografica abbagliante, luminosa, ipotizzando una dimensione sociale (gli ambienti asettici e supersorvegliati di “THX 1138”, lo sfavillio delle strade notturne di “American Graffiti”) nella quale è in atto la battaglia inquietante tra reale e virtuale. T”HX 1138,” come abbiamo detto, sarà un flop ai botteghini. Esso verrà riscoperto solo in seguito all’enorme successo di “American Graffiti”, diventando un vero e proprio cult-movie per le nuove generazioni. In Italia uscirà soltanto nel 1976. Curiosamente, nell’arco di 4 anni, il nostro paese verrà “invaso” dai tre film di Lucas.
Sfide e successo
“American Graffiti” è notoriamente uno dei più grandi successi cinematografici degli anni Settanta. L’ enorme popolarità del film è dovuta principalmente all’inventiva del suo autore, il quale sembra sapere più di chiunque altro cosa possa affascinare i giovani cinespettatori americani. Innanzitutto, a fare breccia nel cuore delle nuove generazioni, è il clamoroso effetto “revival” evocato dalle immagini, che invita lo spettatore a tuffarsi in una dimensione di sogno nella quale ciò che conta è liberarsi dai pensieri angosciosi della vita “diurna” per dedicarsi unicamente alla gratificazione dei propri desideri. In questo senso “American Graffiti” incarna l’idea stessa di cinema quale esperienza onirica, un’idea che d’ora innanzi Lucas non abbandonerà più. Cosa di meglio, allora, che avere tutto il tempo per rimorchiare le ragazze, lanciarsi in sfide temerarie con le automobili, provare l’ebbrezza della “bumba” (ovverosia gli alcolici), non dovere ascoltare i ricatti della fedeltà di coppia e tutte le regole “da grandi” che affliggono la vita dei ragazzi di provincia? Lucas, con il suo secondo lungometraggio, realizza il prototipo del “film-desiderio”, costruendo un giocattolo vivificato da una colonna sonora che diverrà presto un glorioso hit internazionale. Come un caleidoscopico e modernissimo “video-clip”, “American Graffiti” è scandito ininterrottamente dalle note di Bill Haley (Rock around the clock è la canzone-simbolo con cui si apre il film), Crests (Sixteen Clandles), Del Shannon (Runeway), Beach Boys (Surfin’ Safari, All Summer Long), Platters (Smoke Gets in Your Eyes, Only You, Pretender), Joey Dee & The Starlighters (Peppermint Twist), Regents (Barbara Anne), Monotones (Book Of Love), Chuck Berry (Jonny B. Goode), Johnny Burnette (You’re Sixteen – You’re Beautiful – And You’re Mine), Sonny Till & The Orioles (Crying In The Chapel), Spaniels (Goodnight, Well It’s Time To Go). Ogni canzone, interrompendosi, lascia il posto alla successiva secondo un’alternanza mai casuale. Ciascun brano diviene infatti necessario per la comprensione del particolare episodio rappresentato, secondo una concezione di cinema sinfonico e corale che trae energia dalla cura meticolosa con cui il materiale sonoro interagisce con le cadenze ipnotiche del racconto cinematografico. Dunque un film composto di microeventi disposti in una successione magmatica resa armoniosa da una regia che scandisce le sequenze al ritmo dei Platters, di Chuck Berry e di un repertorio di minuziosa archeologia musicale. E il rischio di frammentarietà è superato grazie all’equilibrio dell’insieme. Lucas è consapevole di stare realizzando un film di pure emozioni, e un giorno considererà T”HX 1138″ la sua “testa”, e “American Graffiti” il suo “cuore”. Coerentemente, il regista si concentra sul cuore emotivo del film rappresentato dai giovani americani dei primi anni Sessanta. Precisamente, ci troviamo nella California del 1962, con buona probabilità a Modesto, città natale di Lucas e di Steve, uno dei protagonisti. Il film ripropone la serata d’addio alle vacanze estive. Tra le molte microstorie Lucas predilige quattro personaggi e le loro disavventure. Insieme formano un clan che onora quotidianamente il rito del raduno al Mel’s Drive-in. Qui convengono, uno alla volta, il goffo e proletario Terry Fields (Charlie Martin Smith), sempre in vespa e alla ricerca di una bellona che gli rivolga un’occhiata, Steve Balander (Ronnie Howard, presto star del serial televisivo “Happy Days” e poi regista di successo per pellicole di smagliante fede hollywoodiana), il rampollo di famiglia benpensante con tanto di auto nuova e girlfriend, Laurie Henderson, smorfiosa quanto lui, Curt Henderson (Richard Dreyfuss), la “coscienza” del gruppo, intelligente al punto da ricevere un assegno come borsa di studio da parte dei commercianti del paese, ma anche il più straniato assertore dei valori della vita, scettico nei confronti dei clan e delle certezze comuni, sfuggente e infantile così come straordinariamente affascinato dalla “magia notturna” (sogna di incontrare sulla prossima auto la sua “dea”, e di poter conoscere un giorno “Lupo solitario”, la voce della radio che, come un “grande fratello” bonario, infonde calore e nostalgia ai ragazzi in cerca di emozioni). Infine, sopraggiunge l’ultimo protagonista del film, il meccanico John Milner (Paul Le Matt), sorta di James Dean diseroicizzato, grande talento del voltante, mitizzato dall’occhialuto Terry Fields come l’imbattibile pilota della vallata di San Joaquin. Lucas descrive con evidente partecipazione un universo giovanile sul quale pesano grandi responsabilità. Ognuno infatti deve fare una scelta, prendere una decisione che condizionerà il proprio futuro. Chi deve, come Steve, decidere se ritenere la sua storia sentimentale con Laurie un fatto realmente importante, chi invece, come Curt, riflettere se valga la pena raggiungere il college oppure se sia meglio buttare via ogni cosa e restare nella soffocante provincia di Modesto. In questo clima d’incertezza, trasfigurato nella sarabanda movimentata di suoni e luci del film, incutono particolare simpatia coloro che non sembrano avere molte possibilità di scelta nel proprio immediato futuro: Terry Fields, buffo giullare squattrinato, paladino d’inadeguatezza ma sempre sul punto d’inventare qualche nuova soluzione per mettersi al pari con i più collaudati rivali, John Milner, nostalgico senza méta (spegne bruscamente la radio sulle note di Surfin’ Safari dei Beach Boys e dichiara con tristezza che il vero rock’ n’ roll’ è finito con la morte di Buddy Holly), proletario e viscerale proprio come il deificato Holly, immagine del “duro ribelle” la cui progressiva inattualità comunica sgomento più che nostalgia. La didascalia finale del film (spesso censurata nelle riedizioni italiane passate in TV, secondo un malcostume che produce un vero e proprio snaturamento con relativo “alleggerimento” del senso di “American Graffiti”), rappresenta una sorta di lapide che sancisce il limite definitivo della grande notte di divertimenti: Steve sarà un giorno un agente delle assicurazioni a Modesto, Curt diverrà scrittore e vivrà in Canada, John perderà la vita nel 1964, investito da un ubriaco, Terry morirà in Vietnam nel 1965. La finitezza dell’esistenza assume un significato impietoso per questi giovani. Il film favorisce dunque il recupero di un passato che non può risolversi in puro revival. Se Lucas si impegna, come sarà nel successivo “Guerre stellari”, in una riproduzione dei segni esteriori dell’epoca che sembra fuoriuscita da un’enciclopedia (drive-in, blue-jeans, t-shirts, flipper, giubbotti di pelle, gonne larghe con la vita stretta, ecc.), la sua opera va al di là dell’immagine del film-cartolina producendosi in una rivisitazione nostalgica di quell’età, i sedici anni, in cui ogni fatto dell’esistenza acquisisce un significato rituale, consonante con i cambiamenti che ciascun individuo deve affrontare. In questo senso, “American Graffiti” diviene davvero un film simbolo, poiché, più dello scrupolo filologico, conta in esso la celebrazione appassionata, divertente ma anche amara di una condizione nella quale i miti verranno presto vanificati o smascherati (come succede a Curt il quale, alla fine del film, scopre che “Lupo solitario” non trasmette da un satellite in orbita come favoleggiato dai giovani, ma dalla periferia di Modesto, e altri non è che un simpatico grassone con la barba). Film nostalgico, dunque, ma anche film sospeso sulla condizione di passaggio dal sogno al reale, vivificato dall’idea che i miti sono comunque indispensabili per ciascuno. “THX 1138”, in questa prospettiva, sembra il negativo di “American Graffiti”. Nel primo film di Lucas il personaggio doveva liberarsi da un mondo di incubo per scoprire che la vita sulla terra non era affatto invivibile come pretendeva il Controllore Supremo. Alla fine, un immenso sole nascente avrebbe infatti riscaldato la nuova nascita dell’uomo. In “American Graffiti” il sogno sembra confinato nella notte, e la scoperta della realtà, mentre smaschera il mito, ne rivendica l’importanza per l’individuo. L’alternativa è di rimanere degli eterni borghesi benpensanti come Steve, oppure morire senza avere sognato l’esistenza della propria “dea ispiratrice”. Lucas, con “American Graffiti”, mentre è coinvolto fino in fondo dall’aspetto emotivo dei suoi sognatori, lascia tuttavia tra parentesi la riflessione sull’infantilismo giovanilista degli americani, mostrando una disposizione d’animo estremamente conciliante con quell’eden di eterni ragazzini. La tappa successiva della sua carriera sarà propriamente la saga di “Guerre stellari” cui il regista dedicherà le sue forze (e il termine non è casuale), di lì in avanti, nel segno di un cinema-ossessione da rivedere-riformulare-rivisitare, come una favola metacinematografica sempre pronta a ridisegarsi sulle attitudini dei nuovi spettatori.. Senza dubbio “American Graffiti” pone le basi per la strategia di serializzazione dell’immaginario di cui si sarebbe d’ora innanzi nutrito il lavoro di Lucas. In questo, ancora una volta, il regista è influenzato da Coppola il quale, nel 1974, cioè l’anno successivo a “American Graffiti”, realizza con enorme successo di critica e di pubblico il primo seguito di “Il Padrino”. Ma sarà soprattutto Lucas a fare della serialità una colonna portante del nuovo cinema e insieme una “dichiarazione d’intenti”; ciò, beninteso, non soltanto attraverso la trilogia di Guerre stellari, ma anche con l’ideazione della saga dell’archeologo Indiana Jones e la creazione dell’Industrial Light Magic, vero e proprio laboratorio di sperimentazione nel campo degli effetti speciali. Inoltre, e non proprio per caso, nelle reti del cineasta capiterà talvolta la produzione di qualche film “teorico” come Mishima di Schrader o “Tucker” di Coppola.
Arca(dia) avventurosa
Varrà quindi la pena, a questo punto, di soffermarsi sul più clamoroso tra i progetti realizzati da Lucas e Spielberg. Per puro caso i due vecchi amici si erano ritrovati assieme in vacanza alle Hawaii nel maggio del 1977. “Guerre stellari” era uscito da poco e stava sbancando il box-office. Lucas confidò all’amico fraterno di avere in mente un progetto altrettanto clamoroso, un film incentrato su di un archeologo insolito, Indiana Jones, un po’ atleta, un po’ scienziato, un eroe e un mercenario, sorta di James Bond degli anni Trenta animato da una passione profonda e “disinteressata” per i fatti e gli oggetti storici.
Il film, che sarebbe stato diretto da Philip Kaufman, avrebbe seguito le avventure di Indiana Jones alla ricerca della leggendaria Arca dell’Alleanza. Spielberg confessò di essersi innamorato del progetto dopo pochi istanti: “George me ne parlava da cinque minuti ed ero già in piedi, incapace di trattenere l’eccitazione” (The Making of “Raiders of The Lost Ark”, Ballantine Books, New York, 1981, p. 25). Quando, qualche mese più tardi, Lucas gli disse che Kaufman aveva rinunciato alla regia, Spielberg confidò all’amico il desiderio di dirigere il film personalmente. Contattò allora il giovane sceneggiatore e futuro regista Lawrence Kasdan, che approntò una sceneggiatura adattata fedelmente al dinamismo grafico dei numerosi bozzetti preparati da Spielberg durante l’ideazione del lavoro. Dopo cinque mesi di intensa scrittura, Kasdan si presentò infine con una sceneggiatura ricca e fantasiosa. A quel punto, nel dicembre del 1979, Lucas volle definire assieme a Spielberg e Kasdan un dettagliato piano di produzione, pretendendo anche l’alleggerimento di alcune parti della sceneggiatura. Alla vigilia del nuovo decennio, Lucas e Spielberg si stavano dunque preparando ad allestire un film che sarebbe apparso grandioso nella messa in scena, ma che sarebbe risultato relativamente economico nella realizzazione. Sarebbe stata questa, d’altronde, la regola dei due cineasti per tutti gli anni Ottanta. Le parole di Spielberg sono rivelatrici del lavoro con Lucas: “Cominciammo a girare nel giugno dell’80 e finimmo nel settembre dello stesso anno. Fu il periodo complessivo di riprese più breve che mi trovai a fare dai tempi di “Sugarland Express”. Per Sugarland ci vollero cinquantacinque giorni. “I predatori”, con tutta la sua spettacolarità e la sua esuberanza, lo girammo in settantatrè giorni, cosa di cui sono orgogliosissimo. Volevo davvero girarlo in modo economico, facendolo apparire come un film di quaranta milioni di dollari, spendendo invece solo venti milioni, che era il budget originariamente previsto. I venti milioni però, avrebbero coperto ottantasei giorni di riprese, ma io avevo organizzato un secondo piano generale di settantatrè giorni, di cui pochissimi sapevano e la Paramount per prima. Quello fu il piano di lavoro che seguimmo e scoprii che non facendo i circa cinquantatré ciack previsti per ogni inquadratura, ma facendone soltanto, diciamo, da tre a cinque, riuscivo a mettere molta più spontaneità nel film e, insieme, meno pretenziosità e meno indulgenza nei confronti di me stesso”. La prontezza di Spielberg nell’adattarsi alle esigenze organizzative del progetto rappresenta già un primo elemento per individuare la sensibile affinità con Lucas; quest’ultimo, d’ora in avanti, sempre più produttore e ideatore di nuove formule cinematografiche anziché esecutore in prima persona. Ma le affinità tra i due cineasti toccano più punti. La loro collaborazione imprime infatti una svolta alla carriera di entrambi. Mentre registi come Coppola, Scorsese e Schrader saranno riconosciuti come i “film-makers” del nuovo cinema statunitense, ovverosia autori di pellicole di impatto popolare ma ricche di spunti critici e influenze artistiche, Lucas e Spielberg saranno invece per lungo tempo soltanto dei “movie-makers”, cioè i fortunati ideatori di pellicole di facile presa sul grande pubblico (in particolar modo su quello giovanile), il cui obiettivo principale è di sbalordire con un accumulo di trovate ad effetto. Sarebbe apparsa come sempre più inequivocabile, in seguito, la seguente dichiarazione di Spielberg l’indomani dell’incredibile boom de “Lo squalo” al botteghino; un’affermazione che il regista si lascia sfuggire pensando proprio all’entourage dei suoi amici-collaboratori, tra i quali, appunto, Lucas, Zemeckis, Milius e De Palma: “Ci scambiamo spesso aiuto e copioni: siamo interessati a fare film intelligenti e ben fatti che possano rivolgersi a milioni di spettatori ed assolutamente disinteressati a film di successo critico che nessuno andrà a vedere”. Una dichiarazione che lo stesso Spielberg avrebbe cercato di far dimenticare in futuro realizzando film “seri” come “L’impero del sole” e “Schindler’s list”. Ma si tratta, ad ogni modo, di una dichiarazione d’intenti estremamente attendibile, se pensiamo all’evoluzione della carriera della coppia Lucas-Spielberg negli anni a venire.
Il primo film realizzato assieme si intitola “I predatori dell’arca perduta”, e fu uno dei successi più travolgenti del 1981. Sin dalla prima sequenza, attraverso la celebre sovrimpressione della montagna che prende il posto del marchio Paramount, possiamo percepire lo smalto di un film determinato a riaprire il conto in sospeso con lo stile e l’entusiasmo del cinema avventuroso americano d’un tempo; un progetto di regia che propone in una formula inedita e scoppiettante il temperamento di un antieroe, l’archeologo Indiana Jones interpretato da Harrison Ford, icona attualizzata di un immaginario cinematografico di antica memoria. Se “I predatori dell’arca perduta” è innegabilmente frutto del piglio spielberghiano, risulta nondimeno indubbio che affiori in esso una perfetta intesa tra i due uomini di spettacolo. Assieme, Lucas e Spielberg recuperano la figura del paladino di grandi avventure, senza parodizzarla secondo il gusto corrente, ma calcando certamente i toni ironici e da “burlesque”; la loro operazione si ispira evidentemente al cinema americano degli anni Trenta e Quaranta, ma soprattutto al carisma divistico di Humphrey Bogart, mentre, a livello narrativo, il loro lavoro si concentra in principal modo sull’intento di riprodurre il dinamismo grafico dei fumetti americani d’epoca, tanto più che lo storyboard del film è concepito sin da subito come un’enorme tavolozza a fumetti. E se gli aspetti visivi e scenografici riprendono gli stilemi e il fascino delle tavole di Flash Gordon, sul piano del ritmo narrativo ci troviamo piuttosto dalle parti dei film con l’agente segreto James Bond, sorretto per di più da un inedito gusto disneyano (mentre in futuro si parlerà di alcuni film disneyani, tra cui “Aladdin”, somiglianti ai film di Spielberg). Occorre precisare che il progetto di Lucas e Spielberg si fonda su una proposta solo presuntamente inattuale. Infatti, l’enorme successo del film e del personaggio non è dovuto soltanto alla promessa fatta al pubblico di due ore di straordinario divertimento, ma anche all’aspetto di archeologia dell’immaginario che “I predatori dell’arca perduta” sviscera e ripropone nei primi anni Ottanta. “I predatori dell’arca perduta” è infatti un grosso catalogo di riferimenti, come “American Graffiti” lo era di una differente epoca storica: l’eroe-mito degli anni Trenta, il mercenario alla Bogart in epoca di Guerre Mondiali, le terre misteriose del Nepal, le tombe dei faraoni egizi la cui profanazione grida vendetta, l’elemento magico celato nell’Arca dell’Alleanza, il magazzino finale nel quale viene depositata l’Arca, a sua volta immagine di un ipotetico “archivio dell’immaginario”. Tra i molti elementi implicati nella catalogazione, a uscire da un processo di museificazione è soprattutto il versante spiritualista della vocazione cinematografica, che ne “I predatori dell’arca perduta” risuona come una sorta di ideale rivendicazione ebraica contro la ferocia dei nazisti profanatori (emblematica a questo proposito la clamorosa sequenza finale con Indiana Jones e la sua compagna che si salvano chiudendo gli occhi dinanzi alla “tentazione demoniaca” di vedere le ricchezze nascoste dentro l’Arca, mentre la furia divina si scaglia contro il manipolo di nazisti capitanati dal perfido e fumettistico Belloq). Il versante spiritualista, in particolar modo, deve essere molto importante per i due cineasti, se pensiamo che Spielberg aveva realizzato quattro anni prima un film come “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo” la cui vocazione messianica era ben raffigurata dall’arrivo degli angeli-alieni sulla Terra, mentre i personaggi predestinati al “contatto” come Richard Dreyfuss (interprete-feticcio di Spielberg non a caso proveniente dalla fucina lucasiana di American Graffiti) rivolgevano spesso gli occhi al cielo in attesa di una visione rassicurante. Lucas e Spielberg propongono dunque un cinema nel quale gli effetti speciali raggiungono livelli ragguardevoli. Il loro lavoro diviene, in qualche modo, raffigurazione di quelle “visioni supreme” agognate da Dreyfuss in Incontri Ravvicinati. In questo senso il loro sforzo appare nutrito soprattutto di cinema e di sperimentazione visiva. Tuttavia è dato cogliere nel loro comune exploit anche un meno consolante “lato oscuro”. I successivi episodi della saga di Indiana Jones sono il sicuro riflesso di questa circostanza. Occorre ricordare, a questo proposito, che il progetto di Lucas prevedeva una trilogia sin da subito, ma a patto che il primo film riscuotesse un buon successo di pubblico. Tuttavia, diversamente da “Guerre stellari”, la trilogia dell’archeologo non era stata del tutto progettata anticipatamente nelle sue trame. Decisivo, su questo punto, è stato l’intervento di Spielberg. Del trittico interpretato da Harrison Ford, il secondo episodio, “Indiana Jones e il Tempio Maledetto”, è quello che ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei fan. Film eccessivamente claustrofobico e sepolcrale, è stato detto. In effetti, il film presenta una sceneggiatura più scarna rispetto al capostipite, una scrittura che si adagia in modo piuttosto meccanico su una sinfonia di sacrifici umani e riti vudù, con Indiana alle prese questa volta con i seguaci di una dea assassina e i rischiosissimi sforzi per cercare di salvare centinaia di bambini tenuti come schiavi in una miniera. Il ritmo, incalzante nella prima parte, non salva però le debolezze della seconda. “Indiana Jones e il Tempio Maledetto”, comunque, rende conto ancora una volta della vocazione cinefila di Lucas e Spielberg, che si rifanno sfacciatamente alle vecchie scenografie dei film con Tarzan e Bela Lugosi, tanto più che il racconto insiste sui riferimenti al culto della dea Kalì e sulle imprese sanguinarie dei Thugs. Inoltre, in modo ancora più esplicito rispetto a “I predatori dell’arca perduta”, l’intrepido e ironico Indiana viene affiancato da una ragazza continuamente in disaccordo con lui ma fatalmente innamorata (qui la biondina Kate Capeshaw, futura signora Spielberg). La donna, come altre interpreti spielperghiane, sembra provenire direttamente dalle deliziose commedie anni Trenta di Howard Hawks. Il clima di morte e truculenza, smussato a tratti dall’ironia e dalla goliardia carnascialesca del racconto, sembra comunque appartenere pienamente all’ideatore di “Guerre stellari”. Anzi, possiamo dire che “Indiana Jones e il Tempio Maledetto” appare più cupo e sinistro de “I predatori dell’Arca Perduta” quasi come “L’impero colpisce ancora” si mostrava meno enfatico e possibilista di “Guerre stellari”. In ultima analisi, “Indiana Jones e l’ultima crociata” è spielberghiano soprattutto nel recupero della figura del padre del personaggio, ruolo che viene assegnato al carismatico Sean Connery. Questi, attore-feticcio del cinema spionistico, è l’emblema di un ideale confronto tra il modello avventuroso-rocambolesco degli anni Sessanta (i film di James Bond, appunto) e gli eredi spirituali degli anni Ottanta-Novanta come Lucas e Spielberg, imbevuti di cinefilia e spregiudicato sensazionalismo.
Ma, a bene vedere, Indiana Jones e l’ultima crociata è anche un film lucasiano, nella misura di un rinnovato scontro tra bene e male che tanto caratterizza il cinema di Lucas. Infine, esso è il simbolo luminoso della collaborazione tra due cineasti affini, entrambi orfani di autentici padri spirituali e agitati dal costante desiderio di trasfigurare attraverso racconti iperbolici il proprio “lato oscuro”. Un simbolo che cerca nuova luce nel film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, dove Harrison Ford ritorna, nel 2008, a rivestire i panni del celebre archeologo, e dove l’attore, assieme a Spielberg e a Lucas, inaugura un inevitabile effetto nostalgia che si rifletterà nelle loro realizzazioni future (fino al ritorno celebratissimo e atteso di Ian Solo ne “Il risveglio della forza”, settimo episodio di “Guerre Stellari” diretto da JJ Abrams, dove ogni aspetto confluisce nel solco di una “rifondazione di immaginario” nutrito di nostalgia primigenia, quando Lucas avrà ormai ceduto la Lucas film e il suo progetto di cinema alla Disney). Per concludere questa riflessione sul cinema di Lucas prima di “Guerre stellari”, può essere interessante sottolineare come la carriera di questo fortunato cineasta (ma lo stesso si potrebbe dire di Spielberg) si sia occasionalmente fronteggiata, in anni di grande sfarzo per la “Lucasfilm”, con l’ispirazione maggiormente idealista e critica di alcuni “film-makers” suoi contemporanei. Pensiamo alla produzione di film quali “Mishima” (Paul Schrader), oppure “Tucker” (Francis Ford Coppola), quest’ultimo raffigurazione di una parabola di industriale-inventore particolarmente consonante con la figura del cineasta “artigiano” George Lucas. E pensiamo al progetto a lungo caldeggiato da Spielberg, poi abbandonato, per un lungometraggio dal romanzo-scandalo “Cruising”, che sarebbe successivamente passato nelle mani dell’inquieto William Friedkin, o, infine, all’idea di Lucas per un rifacimento di Arancia meccanica, manifesto del cinema moderno e perturbante. Sono le tracce di quel “lato oscuro” dietro la favola bella di questi celeberrimi bambini-prodigio, avvinti e, in un modo tutto particolare, dominati dal loro progetto industriale di cinema-spettacolo.
.
DARIO ARGENTO LE COREOGRAFIE DELLA PAURA
di Vittorio Giacci
Ho sempre personalmente ritenuto che la pubblicità dei film di Dario Argento basata, soprattutto agli inizi della sua carriera, sull’ analogia con il cinema di Alfred Hitchcock, pur comprensibile in termine di promozione commerciale, non rendesse giustizia della complessa articolazione della sua opera.
Come spesso accade anche in ambito critico, tale analogia verteva infatti più sui “contenuti” che sulla “forma”, ingenerando l’ equivoco di considerare Argento un regista “noir”, un maestro del “brivido” e della “suspense” solo perché i suoi film appartenevano con ogni evidenza al genere, mentre in realtà poco si attenevano alle regole inventate dal quel geniale “creatore di forme” che è stato il cineasta inglese, scivolando progressivamente dal cosiddetto “spaghetti thriller” degli esordi (la “trilogia degli animali”: “L’uccello dalle piume di cristallo”, 1970; “Il gatto a nove code”, 1971; “Quattro mosche di velluto grigio”, 1971), abbandonato e poi ritrovato nel “giallo” americanizzato “Trauma” (1993) e ne “Il cartaio” (2004), verso un “horror” simbolicamente esoterico (“Profondo rosso”, 1975), occulto, paranormale (“Phenomena”, 1985) e poi sempre più efferato, allucinato, truculento (la “trilogia delle tre madri”: “Suspiria”, 1977; “Inferno”,1980; “La terza madre”, 2007), fino allo “splatter” (“Tenebre”, 1982; “Opera”, 1987; “Il fantasma dell’opera”, 1998, “remake” di un classico dell’horror gotico; “Non ho sonno”, 2001; “Giallo”, 2009), mai frequentato dalla filmografia hitchcockiana.
Valga per tutti la distinzione fra “suspense” e “sorpresa” su cui Hitchcock ha tanto insistito nella sua elaborazione teorica. Non vi è dubbio che, ad una più attenta lettura in termini di costruzione diegetica, Dario Argento, a differenza di Alfred Hitchcock che opta decisamente per la “suspense”, privilegi l’effetto “sorpresa”, utilizzando tutte le tecniche visive ed auditive a sua disposizione ed inventandone di nuove per dar vita ad un linguaggio personalissimo sicuramente non accostabile a quello del maestro anglosassone.
I “gialli all’italiana” di cui Argento è stato capostipite erano infatti diversi, sotto il profilo strutturale, da quelli del regista d’oltre Manica, così come era differente il loro impatto visivo, né avrebbe potuto essere altrimenti. In un caso la nebbiosa, compassata freddezza di un’isola, nell’altro la sanguigna, mediterranea vitalità del sud di un continente, pur se abilmente celata dietro i clichés di un gotico neo-espressionista.
In termini di linguaggio, quindi di stile, Argento è visionario, barocco, espressionista, surreale ed onirico quanto Hitchcock è classico, cartesiano, concreto e realista. E se in Argento il “plot” è funzionale, in via esclusiva, ad una inquietudine perturbante da riversare con forza sullo spettatore, in Hitchcock la trama non rinuncia mai alla plausibilità, alla logica, al senso compiuto.
Alfred Hitchcock mette in scena personaggi ordinari catapultati in situazioni straordinarie, Dario Argento figure agghiaccianti inseriti in situazioni aberranti all’interno di opere che non hanno, né vogliono avere, soluzione razionale, abitate da assassini senza movente se non una pazzia da scatenare con omicidi rituali e da serial killers resi folli da gravi psicopatologie spesso derivanti da oscuri traumi infantili.
Certo, lo stesso Argento ha giocato con questa “parentela” artistica, omaggiandola con diverse citazioni, chiamando l’attore hitchcockiano Reggie Nalder (è il sicario alla London Albert Hall ne” L’uomo che sapeva troppo”, 1956) nel cast di “L’uccello dalle piume di cristallo”; girando un film televisivo, “Ti piace Hitchcock?” (2005) a lui dedicato e lavorando anch’egli su alcune “regole del gioco” linguistiche e narrative di “Hitch” come Il “punto di vista”, l’impiego della “soggettiva” o lo schema strutturale del “presunto colpevole” e del “falso innocente”, ma a me sembra che egli si possa definire, più che un discepolo di Hitchcock, l’erede diretto e legittimo di Mario Bava, il re del “fantastico” italiano con il quale condivide l’idea di un cinema puramente immaginifico, emblematicamente espressa in uno dei suoi film più importanti, I” tre volti della paura” (1963), opera di riflessione sul genere che coniuga in modo sublime tradizione ed innovazione, identificazione e de-codificazione, ansia e piacere, arte e morte.
Ne “L’uccello dalle piume di cristallo” (1970) Dario Argento, coadiuvato da una sorprendente cinematografia di Vittorio Storaro attuata con colori accesi e innaturali, crea un luogo non-luogo, una città virtuale, frammentata, de-localizzata, sintesi di tante città, dunque di nessuna in particolare, frutto di diversi ambienti non identificabili territorialmente per ingenerare nel pubblico una irreale, impalpabile, misteriosa indeterminatezza geografica che fa da perfetto contesto a protagonisti avulsi da una dimensione reale. Quanto di più lontano dalla determinazione hitchcockiana che, nei suoi film, elenca invece, con precisione kantiana, non solo i nomi delle città dove sono ambientate le storie ma addirittura quelli dei ristoranti, dei bar, dei locali di ritrovo frequentati dai protagonisti. Così, mentre il cinefilo che voglia andare alla ricerca delle sue locations le può agevolmente ritrovare nella loro realtà fisica, da quelle del cinema di Argento non potrà che ricavare un ulteriore spaesamento in aggiunta a quello sperimentato con la visione del film.
A San Francisco, città che fa da straordinario sfondo (quasi un personaggio tra i personaggi) al film più bello e sincero di Hitchcock, “La donna che visse due volte” (1958) e che è fedelmente ritratta nella effettiva misteriosità dei suoi paesaggi e delle sue atmosfere, si potevano acquistare audiocassette illustranti i percorsi, le vie, gli ambienti, i palazzi, i negozi intravisti nel film. Tutto corrispondeva e tutto combaciava. I soli che non si potevano visitare erano quelli che, nel frattempo, o erano stati abbattuti, come il McKittrick Hotel, oppure chiusi come il ristorante Ernie’s, il magico locale dove James Stewart intravede per la prima volta Kim Novak.
E’ noto che Alfred Hitchcock si compiaceva poi del fatto che nella scena più efferata del suo film più crudo, “Psyco” (1960), l’uccisione della donna sotto la doccia, non si vedesse neppure una goccia di sangue. Nel cinema di Dario Argento il sangue non si può certo dire che lo si risparmia.
Infine, se Hitchcock è scrupolosamente attento all’”impressione di realtà”, Argento se ne disinteressa con una plateale volontà di inverosimiglianza. Per lui, come per l’artista seicentesco, “è del poeta il fin la meraviglia”.
Così, i film di Dario Argento, sono iperbolici e “meravigliosi”, quelli di Hitchcock saggi ed incantati.
Analogo discorso si può sviluppare sul forzoso accoppiamento con Cesar Romero, in “Due occhi diabolici” (1990). Fortunatamente la suddivisione in due episodi (quello di Argento si intitolava Il gatto nero) ha permesso ai registi di rimanere autonomi evitando confusioni tra mondi espressivi solo in apparenza contigui.
La personalità artistica di Dario Argento è infatti inimitabile. Viene indubbiamente dal cinema da lui amato, fra cui beninteso quello hitchcockiano, ma poi subisce una radicale metamorfosi, come avviene per i suoi personaggi, e diventa un unicum che non può più esservi accostato, come una farfalla cancella in sé le tracce della crisalide che è stata.
Liberati da questo ingombrante cordone ombelicale, si potranno più facilmente intravvedere, allora, alcune caratteristiche tipiche del suo cinema, ben più articolato di quanto appaia ad un primo approccio.
Il centro del suo mondo poetico è prioritariamente occupato dalla relazione arte/morte, tema che Argento eredita -come si è visto- da Mario Bava e che si dipana lungo tutta la sua opera come un filo rosso e profondo.
La sua filmografia non può prescindere infatti da un tessuto referenziale che va dall’arte pittorica (i graffiti preistorici, Caravaggio, Goya, Bruegel, Munch, Hooper, Pollock, il Liberty, l’Art Nouveau, il Surrealismo) alla scultura, dal teatro alla musica, dalla letteratura all’architettura, dalla fotografia al cinema. I protagonisti dei suoi film sono esperti o figli d’arte oppure giornalisti, scrittori, fotografi, pittori, musicisti, pianisti, cantanti liriche, poetesse, ballerine; i luoghi dove si svolgono le vicende teatri, musei, gallerie d’arte, negozi d’antiquariato.
Conseguentemente a tale relazione gli ambienti naturali sono scenari desolati, alienati, fantasmatici, inospitali, frequentati da assassini e stupratori; le città spazi cupi e malsani che contengono, come temibili matriosche (la più grande si chiama, significativamente, “madre”), dimore occultatrici, forze malvagie votate all’esclusione dell’intruso, prigioni familiari, strutture claustrofobiche, aure spettrali e camere oscure in cui si sviluppano le storie e si decifrano gli enigmi.
Fulcro filmico della relazione arte/morte, incardinato al centro della sua filmografia, 26 anni dopo il suo primo titolo e 16 anni prima del suo ultimo, è “La sindrome di Stendhal” (1996), opera squisitamente “programmatica”, dunque apparentemente la meno riuscita anche se la più pertinente e significante, che affronta il tema del malessere dell’uomo di fonte all’opera d’arte.
Altrettanto si può dire per un film di ambientazione storica definito sbrigativamente una “parentesi” -e per questo meno considerato- come “Le cinque giornate” (1973) che appare invece anch’esso come una testimonianza ulteriore della messa in opera di un organico ed unitario progetto in quanto vi si possono già rintracciare, con più di vent’anni d’anticipo, i medesimi temi della violenza e dell’arte.
Con il termine “sindrome di Stendhal”, che prende il nome dallo scrittore francese che ne fu colpito durante il suo “Grand Tour” in Italia (e che così la descrisse: “Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti ed i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce, ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere”) (1) si definisce l’affezione psicosomatica, analizzata dalla psichiatra fiorentina Graziella Magherini (2), al cui studio il regista si è esplicitamente ispirato, che provoca in soggetti messi al cospetto di opere d’arte tachicardie, capogiri, vertigini ed allucinazioni.
L’interpretazione della studiosa si basa su diverse teorie psicoanalitiche in cui convergono l’esperienza estetica primaria madre-bambino, il primo contatto con la bellezza, l’empatia, la proiezione, la simulazione incarnata ed il Perturbante, studiato da Freud come una esperienza conflittuale passata e rimossa che si riattiva al contatto con l’opera artistica. Essa descrive l’insorgenza improvvisa di uno scompenso psichico che avviene nel corso di un viaggio solitamente intrapreso “in solitudine”.
Nell’opera di Dario Argento, similmente a quanto descritto da Graziella Mogherini, l’arte, anziché svolgere una funzione catartica, porta in sé inquietudini e perturbanze molteplici, prima fra tutte l’idea di “inganno”, in quanto travisamento consapevole della presunzione di verità insita nella rappresentazione artistica e ciò, a maggior ragione, se si tratta di immagine che è apparenza, e che, in tal modo, si fa impotenza.
Ingannevole, tradita, travisata, l’immagine si traduce in pulsione che si duplica e si riflette (il vedere è anche l’essere visto), si deforma e si altera, si corrompe e si svia.
La pupilla si dilata, lo sguardo diventa uno sguardo che spia e l’occhio -e con esso la mente- devia in una visione compromessa, forzata o negata.
Come nel romanzo di Edgar Allan Poe, scrittore amato da Argento, “La lettera rubata”, citata da Marcel Proust: “…quegli oggetti che sfuggono alle perquisizioni più minuziose, e che semplicemente sono esposti agli occhi di tutti, passando inosservati” (3), la verità, nei suoi film, è davanti agli occhi e basterebbe saper vedere ma lo sviamento dello sguardo lo impedisce. Ciò ostacola anche la scoperta di un assassino ed è quanto avviene già nel suo primo lavoro, “L’uccello dalle piume di cristallo”, in cui la soluzione era lì, nelle prime inquadrature, che ritornano alla fine secondo una differente “focalizzazione” (François Jost la chiama “ocularizzazione” per meglio sottolineare il rapporto visuale e non verbale che si instaura tra l’occhio della cinepresa e quello dello spettatore) (4) e che fa scoprire il latente dietro l’apparente in una sorta di rompicapo interattivo da ri-comporre con la memoria nei suoi “particolari mancanti” (o meglio, presenti ma non percepiti perché, appunto, non focalizzati, non ocularizzati) grazie a testimoni “oculari” che svolgono indagini parallele per decifrarli e farli così diventare “particolari rivelatori”.
La dinamica investigativa, nel cinema di Dario Argento, è qui, nel passaggio dal particolare mancante al particolare rivelatore.
In “Quattro mosche di velluto grigio”, l’immagine rivelatrice che può portare alla scoperta del colpevole è già indelebilmente impressa nella retina della vittima, solo che, ad una prima occhiata, risulta ingannevole, parziale, distorta, incapace di fornire la certezza di una verità.
 Lo sguardo, in un cinema non a caso pieno di pupille sbarrate, di occhi costretti a vedere, di orbite ferite, violate, dilaniate, accecate, da strumento di godimento artistico diventa, inesorabilmente, osservazione della violenza e della morte, e da “miraggio del vedere”, come lo definisce Pierre Sorlin (5) si trasforma in un incubo, assumendo, a sua volta, il senso di occhio diabolico, di “occhio che uccide” (come nel film-culto di Michael Powell “Peeping Tom”, 1960).
Lo sguardo, in un cinema non a caso pieno di pupille sbarrate, di occhi costretti a vedere, di orbite ferite, violate, dilaniate, accecate, da strumento di godimento artistico diventa, inesorabilmente, osservazione della violenza e della morte, e da “miraggio del vedere”, come lo definisce Pierre Sorlin (5) si trasforma in un incubo, assumendo, a sua volta, il senso di occhio diabolico, di “occhio che uccide” (come nel film-culto di Michael Powell “Peeping Tom”, 1960).
Ecco adombrarsi allora il mito della Medusa, l’orrenda creatura che aveva il potere di pietrificare chi avesse incrociato il suo sguardo e che viene decapitata da Perseo, descritta da Ovidio nelle sue Metamorfosi e tante volte raccontata dalle arti, da Caravaggio a Rubens, da Cellini a Bernini.
Una rappresentazione mitologica dell’archetipo della “paura dello sguardo”, tragico per i pericoli mortali che esso comporta, che entra di prepotenza nel cinema di Dario Argento nel florilegio reiterato di macabre scene di teste mozzate e di corpi decollati.
Da tutto ciò nasce una “estetica del delitto” per cui l’artista si trasforma in omicida, o meglio, l’omicida diviene una sorta di folle, perverso e perturbante artista che plasma le sue vittime come se fossero opere d’arte.
L’artista e l’omicida -così come il regista e la sua opera – si legano in maniera indissolubile, prigionieri entrambi – proprio come nella sindrome stendhaliana – di una grave nevrosi e di una disperata solitudine.
E’ una riflessione meta-linguistica che coinvolge il cinema non più e non solo come macchina desiderante ma come strumento di devianza.
Per esprimere tale concezione Argento si serve di una tecnica innovativa ed altamente sperimentale che ricorre, secondo una ferrea applicazione del principio enunciato da Erwin Panofwsky (“dinamizzazione dello spazio e spazializzazione del tempo”) (6) ad una dilatazione esasperante del tempo, dello spazio e dell’azione, ai primi ed ai primissimi piani; ai dettagli di oggetti, mani ed occhi; ad un insistito utilizzo della “soggettiva” ed alla evidenziazione dei “punti di vista”; alla scarsità di dialoghi e ad un montaggio frenetico ed alternato; all’enfatizzazione uditiva con l’amplificazione dei rumori e degli effetti sonori e con le musiche progressive e reiterative di Ennio Morricone, Giorgio Gaslini, Pino Donaggio e dei Goblin di Claudio Simonetti, simili a filastrocche per bambini; ad un uso metaforico ed antinaturalistico del colore, soprattutto dei rossi e dei blu che simboleggiano gli elementi primordiali ricorrenti nei suoi film, l’acqua e il fuoco, con ciò dando vita ad un ampio innovamento di un genere, (analogamente allo “spaghetti-western” di Sergio Leone), spesso vittima di ripetitivi e manierati stereotipi.
Questo sistema narrativo così fortemente connotato verso sensi altri e nascosti ma che, al tempo stesso, è costruito secondo modalità di scrittura appartenenti alla “grafia d’invenzione” del cinema mélièsiano delle origini dove dominava, come osserva André Gaudreauly, l’estetica della mostrazione e non della narrazione (7), risulta egregiamente funzionale alla messa in scena di “favole nere”, di racconti inquietanti che, come nelle fiabe oscure e tenebrose dei fratelli Grimm, sanno mescolare sapientemente atmosfere infantili e violenze adulte, psicopatie sessuali ed ossessioni ancestrali, narrando di uomini traumatizzati, di donne dominatrici e di madri autoritarie (in opere che hanno tutto l’aspetto di “horror al femminile” di sapore matriarcale); di forze sataniche malvagie quanto imprevedibili (ed è proprio questa imprevedibilità del male che allontana il cinema di Dario Argento dalla razionalità); di zone d’ombra dove gli animali sono portatori di sventura e l’arte possiede un’aura alchemica, stregata, demoniaca, che turba le menti e sconvolge le coscienze.
Vere e proprie “coreografie della paura” in cui, come chiarisce George Bluestone, non conta il telling ma lo showing, non il concept ma il percepts (8), danzate e ritmate al suono di martellanti monodie e di minacciosi carillon, le sue opere sorprendono ed atterriscono come altrettante cerimonie funebri, anatomie del terrore dove la violenza si fa gesto drastico e la sofferenza immagine allo stato puro.
Cinema dell’eccesso, quello di Dario Argento si è venuto nel tempo costruendo nel quadro di una stringente progettualità, un rito estremo in cui l’artista, vittima e carnefice ad un tempo di un’arte così trasgressiva e “diversa” come è, ontologicamente, il cinema (“la morte al lavoro” l’ha chiamato Jean Cocteau) ha voluto (e saputo) sacrificare la sua sfrenata visionarietà per una coerenza d’autore sempre più rigorosa e cosciente.
NOTE
(1) M. Henri Beyle, Roma, Napoli e Firenze, Laterza, Roma-Bari, 1990.
(2) G. Magherini, La sindrome di Stendhal. Il malessere del viaggiatore di fronte alla grandezza dell’arte, Ponte alle Grazie, Firenze, 1996.
(3) M. Proust, Sodoma e Gomorra, Einaudi, Torino, 1964.
(4) F. Jost, “Narration(s): en deça et au delà”, Communications 38 (1983).
(5) P. Sorlin, Ombre passeggere. Cinema e storia. Marsilio, Venezia, 2012.
(6) E. Panofvsky, Style and Medium in the Motion Pictures, in: D. Talbot, ed., Film: An Anthology, University of California Press, Berkeley, 1966; trad. Italiana, “Stile e mezzo nel cinema”, Cinema & Film 5-6 (1968).
(7) A. Gaudreault, Du littéraire au filmique. Système du récit. Méridiens Klincksieck, Presses de l’Université Laval, Paris/Quebec, 1988; trad. italiana, Dal letterario al filmico. Sistema del racconto, Lindau, Torino, 2000.
(8) G. Bluestone, Novels into Film, University of California Press, Berkeley, 1968.
FEDIC. LE PERSONE E I FATTI
 FILMMAKER ALLA RIBALTA:
FILMMAKER ALLA RIBALTA:
FRANCESCO GIUSIANI
di Paolo Micalizzi
Leggendo il curriculum del trentenne Francesco Giusiani si rileva subito dalle qualifiche e titoli di studio che la sua è una formazione mirata sicuramente ad un impegno professionale nel cinema, dopo essersi avvicinato alla settima arte frequentando lo storico cineclub pisano Corte Tripoli Cinematografica sotto la direzione di Roberto Merlino. E certi incontri ai quali ha partecipato sicuramente lo hanno arricchito per poter diventare un nuovo autore del cinema italiano. Corsi di Regia e di sceneggiatura, soprattutto, dopo la Laurea in Lettere Moderne per conseguire la quale ha studiato Cinema, Musica e Teatro approfondendoli poi per una Laurea specialistica per cui ha studiato anche la Produzione multimediale. Possiamo citare il Diploma in Regia e Sceneggiatura presso l’Accademia del Cinema e della Televisione di Cinecittà, il Master in Drammaturgia e Sceneggiatura presso l’Accademia D’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma ma anche Stage di formazione e perfezionamento FEDIC con docenti molto qualificati come Franco Ferrini (che è stato, tra gli altri, sceneggiatore di Alberto Lattuada, Dario Argento, Sergio Leone) e Lamberto Caimi (direttore della fotografia di Ermanno Olmi), Carlo Lizzani oltre che di Lattuada e Renato Pozzetto, ed Incontri alla Fondazione Teatro Verdi di Pisa con Alessandro Baricco, Arnoldo Foà, Moni Ovadia, Paolo Poli, Isa Danieli e con registi d’avanguardia come Jean Maria Straub o di formazione rigorosa come Nanni Moretti e Roberto Faenza al Cineclub Arsenale, sempre di Pisa. L’elenco di personaggi in grado di arricchire sicuramente la formazione di Francesco Giusiani stimolandolo anche ad approfondimenti non usuali sarebbe ancora lunghissimo ma non si possono non citare gli Incontri con Roberto Saviano e Furio Colombo, e le Master Class con Luis Bakalov, Vittorio Storaro, Dario Argento, Vittorio De Seta, Abel Ferrara, Ferzan Ozptek, Carlo Verdone, Pupi Avati, Alessandro D’Alatri, Carlo Lizzani, Luciano Tovoli, Carlo Lizzani e Francesco Frigeri che gli hanno consentito di riflettere su argomenti che riguardano la regia, la fotografia, la direzione degli attori ed altri aspetti della realizzazione di un film. Incontri che lo hanno anche portato ad essere Docente di sceneggiatura e regia presso alcune iniziative Fedic. Una formazione propedeutica alla realizzazione di opere che si distinguono per le qualità che hanno nel panorama nazionale del cortometraggio, ricevendo premi prestigiosi. Ci riferiamo in particolare agli ultimi cortometraggi che sono una testimonianza rilevante di un cinema inteso non come espressione fine a se stessa per raggiungere risultati gratificanti come persona che si occupa di cinema, ma come uno che vuole dare ad essi un’impronta di autore che ama dedicarsi alla settima arte come professione. Ho conosciuto Francesco Giusiani grazie alla visione del cortometraggio “Innocenze perdute”, un’opera , con protagonisti ragazzi di una borgata romana , dove una partita di calcio sfocia in un dramma inatteso. Un’opera che rivelava un grande talento cinematografico che mi indusse a presentarlo alla Mostra di Venezia 2012 nell’ambito del Forum FEDIC. Fu anche l’occasione per segnalarlo ai selezionatori di Premi prestigiosi come Il David di Donatello ed i “Nastri d’Argento meritando di essere inserito tra i finalisti Un cortometraggio che ha avuto molto successo.
Ed un grande successo ha ottenuto anche il cortometraggio successivo di Giusiani, “Culurzones”( 2013) nel quale dirige un attore di notevole spessore artistico come Carlo Delle Piane. Si tratta della storia, scritta da Federico Lubino ambientata nella campagna sassarese. Racconta di Latifa, giovane ragazza marocchina, che in una calda mattina d’estate arriva nella casa di Michelina e Tonino. Assunta per aiutare i due anziani coniugi, Latifa deve fare i conti con problemi imprevisti, che solo la presenza del piccolo Tommaso –il nipote dei suoi nuovi “datori di lavoro” – e la tenerezza di Tonino riusciranno a mitigare, stemperando le tensioni tra le due donne e aiutandole a mettere da parte la paura della diversità e del cambiamento per incontrarsi e darsi una mano. Un corto realizzato con passione e amore che al Festival di Brescello 2015 ha avuto il Premio Fedic.
Attualmente Francesco Giusiani ha appena terminato il cortometraggio “Lara” che costituisce la storia di una perdita. Racconta di una giovane donna che realizza di aver abortito durante una notte di pioggia. La notte e il sogno/incubo fanno da file-rouge e da spirale strutturale a questa storia che narra una presa di coscienza dolorosissima. Lara è la protagonista del corto ma è in primis un nome d donna, come di molte donne: le donne che come lei, devono affrontare il vuoto della perdita e l’implacabile accettazione della verità. Per realizzarlo l’ha dovuto finanziare insieme al soggettista e cosceneggiatore Simone De Michele: un segnale forte della sua volontà di fare cinema.
.
.
.
L’avventura cinematografica di Francesco Giusiani ebbe inizio a 12 anni quando frequentando lo storico Cineclub pisano Corte Tripoli Cinematografica realizzò il suo primo cortometraggio, “Terroris Clamor” che ha per protagonisti un ex commissario in pensione e un non vedente con la passione per i gialli che si mettono sulle tracce di un serial Killer che sta terrorizzando la città. L’attività realizzativa nel cinema, mentre seguiva Corsi e Stage formativi, è proseguita con altri lavori , tra cui” Retone a Bocca d’Arno” che racconta le storie pittoresche e piene d’umanità di un pescatore pisano e “Dolce fuggevole giovinezza”(2001), opera di 2 minuti incentrata sul ricordo del primo amore e del suo primo bacio di un anziano signore mentre compie, nel clima autunnale, una passeggiata. Dello stesso anno è “Il pazzo di Dio”, un documentario sulla “figura rivoluzionaria e anarcoide” di Francesco d’Assisi. All’attivo di Francesco Giusiani anche “L’urne dei Forti”, documentario sui tesori artistici contenuti presso il camposanto monumentale di Pisa, un video-ritratto dell’artista pisano Cesare Borsacchi ed uno dell’incisore Paolo Ciampini, ma anche “L’eroe mai cantato”, spot di lancio dell’omonima manifestazione internazionale che ha lo scopo di far scoprire ai giovani “I nuovi eroi” che vivono nel nostro quotidiano e che non sono ancora conosciuti dalla comunità . Opere, per la maggior parte, alla ricerca della realtà che lo circonda. Di maggior impegno narrativo “Enigma Club” con protagonista Roberto le cui sofferenze lo fanno precipitare nel tunnel della depressione dalla quale ne uscirà grazie ad un raggio di sole, e “L’ultimo nastro di Krapp”(2008) che rielabora in video il celebre atto unico di Samuel Beckett incentrato su un uomo che utilizza come diario un vecchio registratore in cui descrive le sue giornate, i pensieri e i desideri. Ispirato ad un altro scrittore, Charles Bukowsky, è poi “La Notte dei due innamorati”. Un racconto dai toni di un noir sui cortocircuiti sentimentali di una coppia di amanti. Ma la sua preparazione cinematografica lo ha portato anche a collaborazioni come direttore della fotografia ed aiuto regista di alcuni lungometraggi, come si può rilevare dalla sua filmografia . Negli obiettivi di Francesco Giusiani un posto di rilievo riveste l’esordio nel lungometraggio. Situazione produttiva permettendo( e sicuramente è pronto a lottare per consentirla), lui è pronto al grande salto.
Filmografia
“LARA” – 12’ – colore – 2015
“CULURZONES” – 17’- colore – 2013
“INNOCENZE PERDUTE” – 13’ – colore – 2011
“LA NOTTE DEI DUE INNAMORATI” – 45’ – Colore 2010
“L’UOMO DEI SUONI” – 17’ – colore – 2009
“SENZA FINE: diario di Paolo Ciampini incisore” – 18’ – colore – 2008
“SICKNESS OF THE SEA” – 9’ – colore – 2003
“CESARE BORSACCHI: Viaggio dentro un artista” – 17’ – colore – 2003
“L’URNE DEI FORTI” – 17’ – colore 2004
“L’EROE MAI CANTATO” – 7 – b/n – 2004
“BON APPETIT” – 1’ – colore – 2001
“IL PAZZO DI DIO” – 22 – colore – 2001
“DOLCE GIOVINEZZA” – 2’ – colore – 2001
“RETONE A BOCCA D’ARNO” – 12’ – colore – 2001
“SPIRALI DI FUMO” – 11’ – colore – 2000
“TERRORIS CLAMOR” – 15’ – colore – 1998
Collaborazioni a film in qualità di direttore di fotografia e aiuto-regista
Direttore della fotografia – “DENTRO LO SPECCHIO” di Luca Caserta.
Aiuto Regista – “UN GIOCO DI CUI TUTTI CONOSCONO LA FINE” di Kami Fares con Remo Remotti
Direttore della fotografia – “I SAPORI DELLA TERRA” di Cristiano Bortone. Presentato alla 54’ mostra esposizione Internazionale d’ Arte- Biennale di Venezia.
.
CINEMA: UN LINGUAGGIO UNIVERSALE
di Laura Biggi
Il linguaggio iconico è la prima forma di comunicazione per l’essere umano, basta pensare ai graffiti dell’uomo primitivo dell’epoca preistorica.
Anche oggi, nell’era digitale, lo sviluppo cognitivo ed espressivo del bambino, passa necessariamente attraverso la rappresentazione grafica della realtà. Il piccolo osserva e cerca di riprodurre attraverso il disegno il mondo che lo circonda, gli elementi naturali, le persone, le loro azioni. Ogni espressione grafica, quindi, dallo stadio embrionale a quello piu’ evoluto e complesso, racconta una storia, che si presta ad interpretazioni diverse, talvolta anche diagnostiche. La conoscenza della pedagogia e della psicologia dell’età evolutiva sono alla base dell’avvio al linguaggio cinematografico che Fedic Scuola propone ai bambini attraverso diverse attività didattiche e formative.
Talvolta gli adulti si chiedono quale sia l’età più adatta per avvicinare i bambini alle molteplici progettualità che la società odierna e la scuola sono in grado di offrire. (Lingue straniere, arte, musica, sport).
Le varie teorie suggeriscono un avvicinamento graduale ad ogni ambito disciplinare privilegiando modalità ludiche ed esperienziali fin dalla più tenera età (scuola dell’Infanzia 3-6 anni). Il cinema può rappresentare per il bambino una scatola magica da aprire e smontare per capirne il funzionamento.
Fare per imparare.
La scorsa estate si è tenuto ad Ispra Varese il primo Campus Estivo di FEDIC Scuola in collaborazione con la Commissione Europea (Ufficio Infrastrutture e Logistica). I bambini di Eurolandia (Campo Estivo) sono esclusivamente figli dei dipendenti del CCR (Centro Comune di Ricerca) il più grande sito europeo per la ricerca scientifico-ambientale.
 Frequentano la scuola europea con sezioni di lingua inglese, tedesca, francese e olandese, durante il periodo estivo sperimentano ogni settimana tematiche e linguaggi diversi che concorrono all’acquisizione di abilità e competenze per una completa formazione. L’ultima settimana di agosto è stato richiesto ed effettuato un laboratorio di cinema.
Frequentano la scuola europea con sezioni di lingua inglese, tedesca, francese e olandese, durante il periodo estivo sperimentano ogni settimana tematiche e linguaggi diversi che concorrono all’acquisizione di abilità e competenze per una completa formazione. L’ultima settimana di agosto è stato richiesto ed effettuato un laboratorio di cinema.
Gli iscritti erano 32 bambini (età 4/10 anni) provenienti da diversi paesi europei e nonostante l’età erano in grado di parlare almeno 2 lingue, talvolta con qualche difficoltà di comunicazione e comprensione dell’italiano. I piccoli, pur essendo un gruppo eterogeneo, hanno dimostrato subito grande curiosità, entusiasmo e capacità comunicativa.
Lo staff tecnico composto da 6 persone ha permesso di suddividere i bambini in gruppi per proporre loro attività diverse nello stesso momento. Il primo approccio al linguaggio cinematografico è avvenuto con la presentazione della strumentazione necessaria per effettuare le riprese: la videocamera posta su un cavalletto. In questo modo, e grazie alla modalità a circuito chiuso, tutti i bambini hanno potuto sperimentare inquadrature, regolare manualmente il fuoco, fare carrellate scegliendo cosa e come riprendere. Lo schermo che ripropone immagini in tempo reale è sempre attraente per i piccoli, poiché è come se si trovassero contemporaneamente in due luoghi diversi, di cui uno reale e l’altro virtuale. L’animazione cinematografica, come prevedibile, è molto gradita dai bambini, da qui l’idea di proporre un workshop-base di animazione: “Animani” a cura di Nadia Abate e Paola Paradisi.
 Si è partiti proprio dalla realizzazione individuale dei flip book, che con i disegni realizzati dai bambini, riescono a raccontare brevi e semplici storie per poi passare all’animazione di materiali diversi carta e plastilina con la tecnica STOP MOTION /PIXILLATION.
Si è partiti proprio dalla realizzazione individuale dei flip book, che con i disegni realizzati dai bambini, riescono a raccontare brevi e semplici storie per poi passare all’animazione di materiali diversi carta e plastilina con la tecnica STOP MOTION /PIXILLATION.
Il magico mondo del cinema può rendere possibile anche l’impossibile, modificare la realtà rendendola spettacolare grazie agli effetti speciali resi possibili da appositi software di elaborazione video, ma soprattutto con la tecnica del chromakey. (Green screen).
Grande fascino e divertimento anche per l’esperienza di doppiaggio, con cui i piccoli attori interpretano personaggi noti del grande schermo, spesso protagonisti di film d’animazione. Si immedesimano nel ruolo e si impegnano a rendere credibile il proprio personaggio, magari modificando la voce a seconda di situazioni e stati d’animo. Divertentissimo rivedere scene di film, ascoltando e riconoscendo le proprie voci.
Sia per quanto riguarda l’animazione che per il doppiaggio i bambini si rendono conto che occorrono tempo e concentrazione per realizzare brevi clip video e questo impreziosisce e dà valore al percorso effettuato.
Ogni attività è stata calibrata in base alle attitudini ed alle capacità dei partecipanti.
Con quelli più grandicelli si è abbozzato un percorso di scrittura creativa partendo dall’idea della storia, scegliendo i luoghi, e individuando personaggi e caratteristiche. L’idea embrionale era quella di una “SPY STORY” ambientata a Manhattan.
In occasione di una gita sul lago Maggiore i bambini hanno effettuato una specie di reportage giornalistico con interviste a compagni, educatori, membri dello staff e perfino passanti. Durante le attività all’aria aperta e il bagno nel lago, sono state effettuate riprese dinamiche con la ACTION CAM.
 La settimana del cinema è trascorsa velocemente ed è giunto il momento tanto atteso della presentazione dei prodotti realizzati. Tanto lavoro, anche notturno di montaggio per gli adulti dello staff, la stessa trepida attesa per tutti grandi e piccoli.
La settimana del cinema è trascorsa velocemente ed è giunto il momento tanto atteso della presentazione dei prodotti realizzati. Tanto lavoro, anche notturno di montaggio per gli adulti dello staff, la stessa trepida attesa per tutti grandi e piccoli.
Per accedere all’Auditorium del Centro Congressi JRC (Joint Research Centre ) sito di Ispra è stato necessario depositare i nostri documenti d’identità un paio di giorni prima per essere identificati e ricevere pass nominativi, anche l’auto, carica di strumentazione è stata controllata e munita di pass.
 Gli addetti alla sicurezza ci hanno ribadito il divieto di effettuare fotografie e riprese video all’interno del sito, infatti alla nostra fedele videocamera è stato precluso l’accesso. Sembrava quasi l’ambientazione adatta alla “spy story” ideata dai bambini.
Gli addetti alla sicurezza ci hanno ribadito il divieto di effettuare fotografie e riprese video all’interno del sito, infatti alla nostra fedele videocamera è stato precluso l’accesso. Sembrava quasi l’ambientazione adatta alla “spy story” ideata dai bambini.
All’interno dell’auditorium bambini, genitori ed educatori hanno assistito alla proiezione dei video prodotti durante il campus.
Grande emozione, entusiasmo, partecipazione per tutti i presenti.
Gli adulti non si aspettavano un lavoro così articolato e strutturato realizzato in pochi giorni e con molti bambini piccoli.
I protagonisti dell’evento, hanno manifestato con applausi e risate, sorpresa e divertimento, ed orgogliosi hanno ritirato l’attestato di frequenza ed un piccolo Ciak a ricordo dell’esperienza. Inoltre ad ogni partecipante è stato consegnato un DVD con i video realizzati e circa 2000 foto di backstage. Birgitte Nickel responsabile e coordinatrice di Eurolandia, visibilmente commossa, si è dichiarata pienamente soddisfatta dell’ottimo lavoro svolto dallo staff del campus organizzato da Fedic Scuola e propone di pianificare già un nuovo progetto.
STAFF :
Laura Biggi Responsabile Nazionale FEDIC Scuola
Lorenzo Caravello (riprese e montaggio)
Daniele Corsi ( docente di scrittura creativa e sceneggiatore)
Margherita Caravello ( attrice)
Nadia Abate (Visual Designer “Animani”)
Paola Paradisi ( Visual Designer “Animani)
Alberto Cavanna ( Esperto effetti speciali, collaborazione on line )
.
.
L’evento mensile di Diari di Cineclub. Periodico di cultura e informazione cinematografica
DIARI DI CINECLUB. La cultura cinematografica al tempo del web
di Stefano Macera
L’esperienza di un periodico nato con l’intento di coinvolgere il vasto e variegato panorama dell’associazionismo cinematografico italiano e di sviluppare sino in fondo la prospettiva secondo la quale il cinema non è un fatto a sé stante, ma un mezzo di comunicazione profondamente inserito nel dibattito del proprio tempo. Tra i motivi di vanto della rivista, vi è una lettera inviata, nel novembre 2013, al Direttore Angelo Tantaro: firmata dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, vi si riconosceva il positivo ruolo dei Circoli del cinema. Nel 2015 la XXIV edizione di “Domenico Meccoli ScriverediCinema”, ha deliberato di assegnare a Diari di Cineclub, il premio “Magazine on-line di cinema” dell’anno.
In molti dei recenti dibattiti sulle trasformazioni della cultura cinematografica, si è sottolineato come uno dei fenomeni più rilevanti della fase attuale sia il sempre maggior numero di riviste che nascono direttamente online. Si tratta di una tendenza dalle molteplici cause, tra le quali la necessità di abbattere i cospicui costi del cartaceo, che di fatto sta contribuendo a modificare tanto le forme della scrittura quanto il rapporto con i lettori della pubblicistica legata alla “settima arte”. In tal senso, rivelatrice ci pare l’esperienza di Diari di Cineclub, una pubblicazione mensile – giunta nel dicembre 2015 al suo 34° numero – che ha come direttore responsabile Angelo Tantaro, coadiuvato da Patrizia Masala, vicepresidente della FICC (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema), che ne cura anche la pagina facebook e da Maria Caprasecca che collabora in redazione. Interessante è il processo che ne ha determinato la nascita, dovuto alla convergenza di diverse spinte, una delle quali prodottasi all’interno del Cineclub Roma FEDIC, i cui associati, ansiosi di far circolare quanto emergeva nelle articolate discussioni successive ad ogni proiezione, hanno in primo luogo dato vita ad un ciclostile. A breve giro, si è poi verificato quello che, concettualmente, è un salto di decenni: abbandonando una modalità di pubblicazione che l’immaginario collettivo associa a tempi lontani, si è realizzato il sito internet del cineclub. Col tempo, però, si è fatta strada la convinzione che fosse giunto il momento di creare una rivista di più ampio respiro e, soprattutto, capace di coinvolgere il vasto e variegato panorama dell’associazionismo cinematografico italiano. Un’idea rafforzatasi nel dialogo con Marino Borgogni, Vice Presidente della FEDIC, Presidente di Valdarno Cinema FEDIC e fondatore del notiziario “FEDIC Notizie”: a lui, scomparso prima che il progetto andasse in porto, è stato infatti interamente dedicato il 1° numero (dicembre 2012).

Da sx Angelo Tantaro direttore di Diari di Cineclub e Marino Borgogni in un sorridente pomeriggio estivo del 11 luglio 2008 a Montecatini durante la 59. edizione di filmVideo (foto di Vincenzo Rosace)
Ma non bisogna dimenticare gli stimoli che, in questa direzione, sono venuti anche da un importante momento di confronto collettivo con quelle che sono le molteplici facce attuali dell’audiovisione: quel Sardinia Film Festival (di cui lo stesso Tantaro è presidente) che, assieme ad altre manifestazioni, testimonia la sorprendente vivacità culturale di un’isola che, oggi, viene citata dai media soprattutto in relazione a devastanti processi di desertificazione industriale. Da queste spinte è nata un’esperienza singolare, evidentemente indicativa delle possibilità insite in un uso accorto della rete: una testata indipendente che sembra appartenere a chi, volta per volta, ci scrive. E che fa della mescolanza tra i contributi di personalità illustri (artisti, intellettuali, critici cinematografici) e gli scritti firmati da “semplici” appassionati di cinema, una vera e propria filosofia. In effetti, in ogni numero si registra la presenza di qualche nuovo autore, segnalata da una breve scheda che ne restituisce sinteticamente i percorsi culturali, professionali ecc. Tra i collaboratori che non necessiterebbero di particolari presentazioni, vi è Pierfrancesco Uva, pittore e illustratore che ha ottenuto numerosi riconoscimenti di settore, sempre lieto di fornire vignette su temi di attualità. A lui, negli ultimi mesi, si è affiancato un altro disegnatore talentuoso, particolarmente dotato sul versante della caricatura di personalità politiche e del mondo dello spettacolo: Luigi Zara. Se invece parliamo di saggistica cinematografica, non possiamo non citare Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi-Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna e studioso dai vasti interessi, confermati dalla varietà di temi qui approcciati. Per non dire degli articoli di Simone Emiliani – Direttore Editoriale di Sentieri Selvaggi, rivista online ormai di lungo corso – che, ad esempio, in un bilancio controcorrente dell’ultimo festival di Cannes pubblicato nel numero di luglio-agosto 2015, ha sottolineato quanto la spinta a premiare, oltre i suoi reali meriti, i registi francesi abbia penalizzato più le cinematografie di altre paesi che non quella italiana. Ma è necessario sottolineare che Diari di Cineclub riceve contributi qualificati anche da parte di intellettuali che si occupano prioritariamente di altre forme espressive. Si pensi allo spazio fisso curato dallo storico dell’arte Giovanni Papi, che si occupa tanto degli eventi che si svolgono nella capitale, quanto della tutela dei valori monumentali, spaziando dalla contemporaneità all’antichità classica; ad esempio, nel numero di novembre 2015, vi è la prima parte di un intervento concernente tre importanti creazioni dell’età imperiale: l’Anfiteatro Flavio, la Meta Sudans e il Colosso del Sole. Una presenza non casuale, bensì legata ad una precisa consapevolezza, riguardante lo statuto stesso del cinema, concepito come luogo dell’incrocio e della sintesi fra le diverse arti, da quelle visive alla letteratura e alla musica. Di più, la convinzione da cui si muove è che uno sguardo non estemporaneo alla riflessione che si svolge attorno agli altri mezzi espressivi dovrebbe essere un elemento centrale di ogni seria rivista di cultura cinematografica. Ovviamente, sviluppando sino in fondo l’ottica secondo la quale il cinema non è un fatto a sé stante, si può andare anche oltre, evidenziandone il carattere di mezzo di comunicazione profondamente inserito nel dibattito del proprio tempo. In questo senso, non deve sorprendere l’attenzione riservata a due figure straordinarie – e per molti versi scomode – del cattolicesimo italiano: Don Lorenzo Milani (ricordato in particolare nel marzo 2014) e Don Andrea Gallo (luglio 2014), entrambi punti di riferimento per chiunque abbia fatto propria l’idea di una chiesa veramente vicina agli ultimi. Il confronto con simili personaggi non può esser considerato come qualcosa di eccentrico, rinviando invece all’idea che il cinema stesso sia storia. Non a caso, il dibattito pubblico sul nostro passato recente, tende sempre più spesso a svilupparsi attorno a prodotti audiovisivi. E la stessa triplice richiesta (libro, luogo, film) che un noto conduttore di Rai Storia, Massimo Bernardini, rivolge agli illustri studiosi che ospita, venuti a parlare di questa o quella fase della vicenda umana, traduce in forma semplice la consapevolezza che, ormai, non è più possibile negare lo strettissimo rapporto tra cinema e storia, tra cinema e società. In effetti, questa convinzione è già presente nella riflessione di molti critici e saggisti, però ancora affiora, qua e là, la tendenza a concepire la passione cinefila, in sé sana, come una variante del vecchio adagio sull'”arte per l’arte”. E peculiare rimane, a ben vedere, la costanza con cui Diari di Cineclub porta avanti questo assunto, ribadendolo di numero in numero. Se poi si cerca l’originalità assoluta, allora non si può non confrontarsi con le specifiche modalità di distribuzione della rivista. La quale, oltre che al pubblico “indistinto” e imprevisto che si può raggiungere online, arriva a tutti i 1400 circoli del cinema sparsi nel territorio della penisola e appartenenti alle 9 Associazioni di Cultura Cinematografica con riconoscimento ministeriale (Ficc, Uicc, Fic, FEDIC, Cinit, Cgs, Ancci, Ucca, Csc). In più, vi è la singolare esperienza delle edicole virtuali, cioè dei siti internet che hanno il link alla pagina e/o pubblicano il sommario di ogni numero di Diari di Cineclub. Le edicole, in costante aumento, hanno già superato la sessantina, rinviando alla capacità di mettere comunicazione realtà socio-culturali tra loro assai differenti. Per esempio, quella connessa al Sardinia Queer Short Film Festival – il primo festival sardo interamente dedicato al cinema a tematica gay, lesbica, bisessuale, transgender, queer e intersessuale – coesiste con diversi siti legati al mondo cattolico. Dunque, il concetto di pluralismo, sulle colonne di Diari di Cineclub è inteso nel senso più sostanziale e meno formale possibile. Del resto, l’idea di uno scambio permanente fra diverse visioni del mondo si riflette efficacemente nel Comitato di Consulenza e Rappresentanza della rivista, composto da tre donne e tre uomini. Tra le prime troviamo una figura eminente della sinistra italiana (Luciana Castellina), una delle più importanti documentariste nostrane (Cecilia Mangini) e una precaria della cultura, i cui vasti interessi partono dal teatro e dal cinema (Giulia Zoppi). Nel secondo gruppo incontriamo un decano della critica cinematografica, firma storica di Famiglia Cristiana (Enzo Natta), il Presidente della Ficc, l’Associazione Cinematografica più diffusa (Marco Asunis) e un regista che ha sempre saputo coniugare impegno civile e qualità formale (Citto Maselli). Ora, proprio questo dialogo fra le differenze rende più incisive, in quanto fondate su un terreno davvero solido, le battaglie che la rivista conduce. Ad esempio, a molti esponenti politici è stato chiesto di esprimersi chiaramente sullo scottante tema dell’impegno delle istituzioni verso la cultura. Dal numero di ottobre 2015 è partito un interessante dibattito su Quale riforma per il cinema italiano, con l’intervento diretto della senatrice del Pd Rosa Maria Di Giorgi, che ha esposto il Disegno di Legge sul Cinema e sull’Audiovisivo di cui è prima firmataria. A questo contributo si affiancava una nota di Ugo Baistrocchi, in cui si delineavano Considerazioni e 10 consigli per una nuova legge quadro per il Cinema e l’Audiovisivo. Ma forse va citato anche un intervento non concordato: il messaggio, datato 15 novembre 2013 e pubblicato nel numero 12, con il quale l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, oltre a compiacersi per l’omaggio tributato, dieci anni dopo la morte, a suo fratello Riccardo, documentarista e Presidente della FICC, riconosceva il positivo ruolo dei Circoli del cinema. Certo, i rapporti con le istituzioni rimandano anche a un necessario approccio critico: le scelte del Mibact e della sua Direzione Generale Cinema vengono sempre analizzate puntualmente e, quando è necessario, messe in discussione. Si pensi al caso – esaminato a partire dal numero di settembre 2015 – della Fondazione Barbaro, che si è vista eliminare qualsiasi finanziamento per l’anno 2015. A essa si legano almeno tre attività: la pubblicazione della storica rivista Cinemasessanta, l’annuale consegna del Premio Chaplin e la gestione della Biblioteca Umberto Barbaro, un ingente e qualitativamente straordinario patrimonio di libri e riviste sul cinema e non solo. In verità sul perché siano venuti meno i finanziamenti, peraltro non cospicui, ancora non vi sono stati chiarimenti, ma si è ottenuto il risultato di creare, attorno alla vicenda, una forte attenzione. Messaggi di solidarietà sono venuti tanto da intellettuali rinomati quanto da persone sconosciute e, in particolare, in molti hanno a preso a cuore le sorti della Biblioteca, rispetto alla quale le scelte della DGC hanno aggravato difficoltà preesistenti, in parte legate a responsabilità dell’Amministrazione Capitolina. Da tempo le sue collezioni sono ubicate in due sedi provvisorie distanti tra loro, ma dopo gli interventi di Diari di Cineclub non sono mancate proposte interessanti per evitare ogni dispersione, alcune delle quali sono attualmente oggetto di studio. Per quanto concerne poi Cinemasessanta, la FICC si è ufficialmente impegnata a sottoscrivere un certo numero di abbonamenti, così da mantenere in vita una pubblicazione che, a dispetto di una diffusione assai ridotta rispetto al passato, ha mantenuto un’ottima qualità. Ovviamente, questo forte “interventismo” nel settore della politica culturale si coniuga con la spinta a misurarsi con il cinema in tutti i suoi aspetti. Oltre a informare sulle principali attività delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica, partendo da quelle editoriali, viene assegnato il giusto – e, quindi, non esclusivo – spazio ai film che escono in sala. Inoltre, a conferma del fatto che il mondo del web non è necessariamente nemico delle forme tradizionali di fruizione della scrittura, un ampio risalto è dato ai libri che hanno per oggetto il cinema: tra gli ultimi analizzati, nel mese di ottobre, in un articolo a firma di Stefano Beccastrini, L’avventuriera di Montecarlo (Adelphi 2015), raccolta di interventi sul cinema del grande scrittore Joseph Roth. Ma la “settima arte” viene anche esaminata in relazione alla sua capacità di evitare luoghi comuni e stereotipi nell’affacciarsi su una realtà in continua trasformazione, che ad esempio spinge al superamento dei modi tradizionali di concepire la sessualità, spesso ancorati a un’ideologia patriarcale. Perciò, una particolare attenzione è riservata a quei film che si confrontano con il mondo Lgbtqi riuscendo anzitutto a suggerire l’idea che la diversità sia un valore. Ora, si può ben dire che il culmine di questo sguardo complessivo verso un’arte sempre più articolata nelle proposte estetiche e culturali è rappresentato dalla partecipazione a ogni aspetto dell’organizzazione di due festival. Il primo è il Sardinia Film Festival, che si svolge all’Università di Sassari e che si giova dello sforzo di docenti e studenti (sia dell’Ateneo sia del locale Istituto di Belle Arti), che fanno parte di quella pre-giura di selezione che deve visionare gli oltre mille film l’anno che arrivano da non meno di 58 paesi. L’altro festival alla cui realizzazione contribuisce Diari di Cineclub è il Valdarno Cinema Fedic, che si svolge a San Giovanni Valdarno, nella provincia di Arezzo svolgendo da più di 30 anni un ruolo di primo piano nella diffusione del cinema indipendente in Italia. D’altronde, sebbene giornali e televisioni se ne occupino deliberatamente poco, queste manifestazioni sono tra i principali luoghi di diffusione della cultura cinematografica in Italia, muovendo spesso da una logica più libera di quella che informa i festival maggiori. E’ vero che, come s’è visto, Diari di Cineclub non rinuncia a dire la sua su questi ultimi, cercando – in linea con altre testate specializzate – di sottrarli al superficiale chiacchiericcio che viene loro riservato dai maggiori organi d’informazione. Non si può negare, però, che attualmente realtà come la Mostra veneziana risentano troppo fortemente di fattori come le mode del momento: lo ha tristemente evidenziato la scelta – ai tempi della gestione di Marco Müller – di far sbarcare al Lido il cinema trash, per giunta all’insegna di un’operazione puramente goliardica, che nulla aveva a che fare con quell’approccio analitico che può e deve essere applicato a qualunque prodotto audiovisivo, anche appartenente ai cosiddetti “generi di profondità”. Forse proprio il fatto di non avere puntati addosso i riflettori del sistema dell’informazione, favorisce la caratterizzazione di molti festival sparsi nella penisola come luoghi di confronto autentico su un’arte che, se affrontata a partire dalle sue espressioni meno appariscenti, si rivela ancora dinamica e vitale. Contribuire a costruirne qualcuno, adottando una logica orizzontale, tale da non coinvolgere solo gli addetti ai lavori, non poteva non essere un imperativo per una rivista che sta attraversando tutte le nuove frontiere della cultura cinematografica. Esprimendo uno slancio propositivo di cui ha evidentemente tenuto conto la giuria, composta dal gotha della comunicazione cinematografica italiana, che – nell’ambito della XXIV edizione di “Domenico Meccoli ScriverediCinema” – ha deliberato di assegnare al periodico Diari di Cineclub il premio “Magazine on-line di cinema” 2015.
Diari di Cineclub è scaricabile su www.cineclubromafedic.it/diari-di-cineclub.html e su oltre 60 siti. Per ricevere l’abbonamento gratuito on line scrivere a diaridicineclu@gmail.com
.
.
YoungERcard un progetto per avvicinare i giovani al Cineclub
di Eleonora Carrara
 È passato quasi un anno da quando ho sentito parlare per la prima volta di YoungERcard e di un progetto che mi avrebbe avvicinata al Cineclub Claudio Zambelli, una famiglia di cui ad oggi mi vanto di far parte.
A febbraio 2015 mi fu proposto di partecipare ad una riunione dell’associazione sopracitata per poter realizzare, insieme ad altri giovani del mio paese, qualcosa che non era mai stato fatto prima né a Boretto né nelle cittadine limitrofe. Attraverso il patrocinio del Comune di Boretto e del progetto della Regione Emilia Romagna “YoungERcard”, ci veniva proposto una sorta di tirocinio al termine del quale avremmo imparato cosa significasse gestire un cinema: utilizzare le attrezzature, scegliere i titoli per la programmazione, dialogare con le principali case distributrici e organizzare la pubblicità intorno agli eventi su tutti i canali. E così, grazie al tutoraggio di Donatella e Lorenzo, membri storici del Cineclub, ci siamo buttati a capofitto in questa avventura. Non avrei mai pensato quanto lavoro stesse dietro ad un “cinemino di paese” e soprattutto quanto impegno dei volontari potessero dedicare a un’attività lontana dalle loro occupazioni quotidiane. E così, come loro avevano fatto anni prima, abbiamo imparato tutto da zero, affrontando le difficoltà legate ad una strumentazione all’avanguardia e pensando a strategie per invogliare il pubblico locale ad approcciarsi alla nostra sala.
Una volta apprese le basi e consolidato il rapporto con i volontari dell’associazione, abbiamo sentito il desiderio di realizzare qualcosa di nostro anche per dare un senso al percorso avviato grazie al sostegno di YoungERcard. Era marzo quando il Cineclub Claudio Zambelli iniziò a progettare la prima rassegna cinematografica pensata da giovani del territorio. Quattro film sarebbero stati proiettati alla domenica pomeriggio (ore 18.00), preceduti da un piccolo buffet per assecondare la moda degli aperitivi, tanto cari ai ragazzi di oggi. Era nato l’”apericinema” che, ancora adesso, costituisce un modo divertente di avvicinare le generazioni e di parlare insieme di cinema.
È passato quasi un anno da quando ho sentito parlare per la prima volta di YoungERcard e di un progetto che mi avrebbe avvicinata al Cineclub Claudio Zambelli, una famiglia di cui ad oggi mi vanto di far parte.
A febbraio 2015 mi fu proposto di partecipare ad una riunione dell’associazione sopracitata per poter realizzare, insieme ad altri giovani del mio paese, qualcosa che non era mai stato fatto prima né a Boretto né nelle cittadine limitrofe. Attraverso il patrocinio del Comune di Boretto e del progetto della Regione Emilia Romagna “YoungERcard”, ci veniva proposto una sorta di tirocinio al termine del quale avremmo imparato cosa significasse gestire un cinema: utilizzare le attrezzature, scegliere i titoli per la programmazione, dialogare con le principali case distributrici e organizzare la pubblicità intorno agli eventi su tutti i canali. E così, grazie al tutoraggio di Donatella e Lorenzo, membri storici del Cineclub, ci siamo buttati a capofitto in questa avventura. Non avrei mai pensato quanto lavoro stesse dietro ad un “cinemino di paese” e soprattutto quanto impegno dei volontari potessero dedicare a un’attività lontana dalle loro occupazioni quotidiane. E così, come loro avevano fatto anni prima, abbiamo imparato tutto da zero, affrontando le difficoltà legate ad una strumentazione all’avanguardia e pensando a strategie per invogliare il pubblico locale ad approcciarsi alla nostra sala.
Una volta apprese le basi e consolidato il rapporto con i volontari dell’associazione, abbiamo sentito il desiderio di realizzare qualcosa di nostro anche per dare un senso al percorso avviato grazie al sostegno di YoungERcard. Era marzo quando il Cineclub Claudio Zambelli iniziò a progettare la prima rassegna cinematografica pensata da giovani del territorio. Quattro film sarebbero stati proiettati alla domenica pomeriggio (ore 18.00), preceduti da un piccolo buffet per assecondare la moda degli aperitivi, tanto cari ai ragazzi di oggi. Era nato l’”apericinema” che, ancora adesso, costituisce un modo divertente di avvicinare le generazioni e di parlare insieme di cinema.
A tutti coloro che hanno avuto modo di partecipare è stato chiaro che quelle del cinema di Boretto non erano semplici proiezioni in quanto lo scopo principale era quello di costruire un legame con il pubblico in modo che le persone si legassero alla sala e ai suoi volontari piuttosto che ai singoli film. Questa è forse la differenza principale tra il Cineclub Zambelli e un asettico multisala in cui viene a mancare il contatto umano. Nel Cinema-Teatro del Fiume si va anche per scambiare quattro chiacchiere con i volontari, per dare consigli sui film da selezionare per le future proiezioni e per fare qualche pettegolezzo sui compaesani. Nonostante le attrezzature del nostro cinema non fossero aggiornate (il sistema utilizzato era ancora legato al lettore dvd e blu ray), gli spettatori non sono mancati e le persone hanno premiato l’iniziativa. In estate, i giovani “tirocinanti” del Cineclub sono stati sottoposti ad altre due prove importanti: il Festival del Cinema di Brescello e la rassegna estiva. Nel primo caso, ci è stata data la possibilità di conoscere personalità di rilievo del mondo del cinema, come Valentina Cervi e Steve Della Casa, e di intervistare alcuni importanti critici e scrittori. Se il mese di giugno, dunque, ci ha trasformati in giornalisti d’assalto, all’inseguimento delle “stelline” del Festival, luglio ci ha visti assorti nella programmazione del cinema sotto le stelle.
.
Due giorni a settimana, in due paesi della Bassa reggiana (Boretto e Brescello), il Cineclub si è impegnato a portare sullo schermo storie emozionanti e profonde per allietare le torride serate emiliane, registrando grandi successi. Il coronamento di questa esperienza è stato il #getcomfy, tradizione americana mai importata in Italia prima d’ora. Il giardino delle scuole elementari è stato riadattato in vista delle proiezioni solo che, oltre alle normali sedie di plastica, c’erano cuscini, sdraio, poltrone gonfiabili e un piccolo bar per ristorare gli accaldati spettatori e ricreare un’atmosfera intima e conviviale.
Indubbiamente il 2015 è stato un anno focale per il Cineclub Claudio Zambelli che, dopo l’estate, ha fatto un passo fondamentale nella sua storia: acquistare il sistema DCP (Digital Cinema Package) indispensabile per poter proiettare le prime visioni. Quest’investimento, portato avanti grazie al sostegno economico del Comune di Boretto, ha portato a riflessioni e decisioni importanti: aumentare il numero di proiezioni e dunque lo sforzo dei volontari per poter far conoscere al grande pubblico le potenzialità della sala del Cinema-Teatro del Fiume.
Tornando ai giovani, a settembre ci è stata consegnata la chiavetta USB di YoungERcard a testimonianza del lavoro svolto all’interno dell’Associazione. Quel semplice oggetto, oltre ad essermi utile nelle emergenze universitarie, è diventato un simbolo importante del mio 2015, una chiave d’accesso a ricordi preziosi che si proiettano in futuro dove vedo, oggi più che mai, il Cineclub Claudio Zambelli.
.
.
FESTIVAL ED EVENTI
 72 MOSTRA INTERNAZIONALE
72 MOSTRA INTERNAZIONALE
D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
PREMI, TRA CONSENSI E DISSENSI, E RICCHE PROPOSTE
di Paolo Micalizzi
Pro e Contro alla Mostra di Venezia. È il solito discorso dei dissensi soprattutto per il “Leone d’Oro” e per il “Leone d’argento”. A noi i due film “Desde allà” dell’esordiente venezuelano Lorenzo Vicas e “EL Clan” dell’argentino Pablo Trapero, che hanno conquistato rispettivamente i due premi più prestigiosi, non sono dispiaciuti ma i nostri “Leone d’Oro” e “Leone d’Argento” erano da scegliere tra “Francofonia” del maestro russo Alexandr Sokurov ( a cui va la nostra preferenza per il massimo riconoscimento) e “Remember” del canadese Atom Egoyan.
La nostra impressione è che siano stati preferiti temi, che ormai sono quasi diventati di moda nel cinema come l’omosessualità (il film di Vicas) e la violenza, inscenata nel regime dittatoriale del film di Trapero, piuttosto che guardare alla qualità dell’opera da un punto di vista cinematografico, visto, tra l’altro, che ci troviamo in una Mostra d’Arte Cinematografica. Che nel film di Sokurov è di alto livello. Si tratta di un’opera che, come altri suoi film precedenti, unisce l’arte alla storia, raccontando del Louvre parigino sotto la dittatura nazista. E lo fa con un linguaggio cinematografico che fonde i due soggetti in una simbiosi sempre più stretta. E di qualità cinematografica è ben nutrito anche il film di Egoyan , che affronta in maniera nuova e imprevedibile, dandogli anche un’impronta da thriller, il tema della caccia ai nazisti, rivelando un aspetto finora inusuale. E cioè, che dietro i “cacciatori” possono nascondersi dei criminali. E non è un espediente romanzesco ma una possibile verità. D’accordo con la Giuria, presieduta dal regista Alfonso Cuaròn, per il Gran Premio attribuito a “Anomalisa” degli statunitensi Charlie Kaufman e Duke Johnson, film d’animazione dove la voce di una ragazza ridà vitaòità ad un uomo che con la sua oratoria faceva felice gli altri rendendo nel contempo monotona la sua esistenza. D’accordo, ma non solo noi, sulla Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Valeria Golino, che offre un intenso ritratto di donna nel film di Giuseppe M. Gaudino “Per amor vostro” ambientato in una Napoli degradata che è uno specchio della vita della protagonista.
Ma anche sulla Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Fabrice Luchini nel più che convincente ruolo di un Giudice, antipatico e temuto, innamorato di una giurata popolare nel film “L’Hermine” di Christian Vincent. Per il Premio Marcello Mastroianni, riservato a un attore o attrice emergente, la scelta è caduta su Abraham Attah, il giovane africano costretto a diventare un bimbo soldato, del film statunitense “ Beasts of no Nation” di Cary Joji Fukunaga. Premiato , giustamente, per la sceneggiatura Christian Vincent per “L’Hermine”, da lui anche diretto: una storia d’amore ben strutturata raccontata con garbo. E quello speciale della Giuria (che era anche composta da Lynne Ramsay, Diane Kruger, Elizabeth Banks, Emmanule Carrère, Nuri Bilge, Pawel Pawlikoswski, Francesco Munzi, Hou Hsiao-hsienm) a “Frenzy” di Emin Alper, ambientato in una Istanbul degradata e violenta. Trascurate nel verdetto opere come “11 minutes” del polacco Jerzy Skolimowski, autore lontano dallo schermo sin dal 1985 (“Lightship-La nave faro”) il cui atteso ritorno è stato salutato da tanti apprezzamenti. Un film, dove gli undici minuti del titolo sono quelli sufficienti a decidere il destino di quattro persone, che il regista racconta con un linguaggio cinematografico poliedrico che ha nel finale un segno innovativo di grande spessore. Trascurato anche “Marguerite” di Xavier Giannoli che s’ispira alla storia vera di Florence Foster Jenkins stonato soprano il cui successo era dovuto alla sua ricchezza: una storia ben ricostruita. Nel ruolo di Marguerite , Catherine Prot che fino all’ultimo ,nelle aspettative della critica, contrastava il successo della Golino. Ma buone chances aveva, per noi, anche “L’attesa” di Piero Messina che si è dovuto accontentare invece di alcuni Premi collaterali quali Signis, Leoncino d’Oro Agiscuola, Fedic. Apprezzato dalla critica anche “Behemoth” del regista Zhao Liang che in questo suo documentario, incentrato sulla difficile vita quotidiana di juna comunità mongola, offre contemporaneamente uno spaccato della Cina d’oggi. Significativi riconoscimenti nelle altre Sezioni. L’”Orizzonti” ha premiato (Giuria presieduta da Jonathan Demme) come miglior film “Free in deed” di Jake Mahaffy, opera che ha per protagonisti due attori professionisti intenti a salvare un bambino con le sole armi della fede e come miglior regia “The childhood of a leader” di Brady Corbert con protagonista il bambino di un diplomatico amerixano la cui crescita è caratterizzata dall’attrazione per la violenza. Altri ki premi attribuiti in questa sezione, ma nessuno riconoscimento per gli italiani “Pecore in erba” di Alberto Caviglia e per “Italian gangsters” di Renato De Maria. Il primo, che ha ricevuto il Premio Civitas Vitae prossima e quello di Arca Cinema Giovani, è un finto documentario sui luoghi comuni dell’antisemitismo in Italia raccontato attraverso un personaggio inventato che non si riesce a rintracciare, mentre l’altro ricostruisce, alla maniera dei documentari Luce, l’epopea dei più celebri banditi italiani degli anni 50. Un Premio alla carriera per il francese Bertrand Tavernier, attento narratore della vita di provincia e del confronto generazionale in cui emergono richiami autobiografici.
La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia non è soltanto rappresentata dalle sezioni organizzate dalla Biennale. Come avviene da alcuni anni a darle anche vitalità, completando cosi il Panorama del Cinema contemporaneo, vi sono la “Settimana della Critica”, giunta alla 30^ edizione e le “Giornate degli Autori” di cui quest’anno è ricorso il 12° anno. La “Settimana”, organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, ha contribuito anche quest’anno a segnalare, direi a scoprire, nuovi autori e nuove cinematografie. La famiglia, con i suoi conflitti e disagi adolescenziali, è il filo rosso che lega le opere in Concorso provenienti da alcuni paesi come il Portogallo, l’Inghilterra e la Turchia. Ma si sono visti anche conflitti politici in opere come “Kalo Pothi” di Min Bahadur Bham, il film risultato vincitore. In esso il regista nepalese, paese che per la prima volta ha partecipato alla Mostra di Venezia, racconta la vicenda di due giovani che crescono in una società divisa durante la rivolta maoista. Una storia d’amicizia che ruota attorno al ritrovamento di una gallina, che con le sue uova dava loro da vivere, alla cui ricerca si muovono malgrado il conflitto in atto fra governo e guerriglieri maoisti. In Concorso anche l’italiano “Banat” (Il viaggio) di Adriano Valerio, con protagonisti due giovani, un agronomo pugliese ed una restauratrice costretti dalla crisi ad emigrare in Romania. Troveranno la felicità? “Fuori Concorso” l’ultimo film di Antonio Capuano, “Bagnoli Jungle” che intreccia la storia di tre personaggi in una periferia dominata dai ruderi dell’Italsider. Venti opere nelle “Giornate degli Autori” tra cui tre italiani. Il più interessante è stato “Arianna” di Carlo Lavagna, che ha rivelato in Ondina Quadri un nuovo talento d’attrice, incentrato su una persona alla ricerca della propria identità. In programma anche “La prima luce” di Vincenzo Marra, storia di un padre( un eccessivo Riccardo Scamarcio) che va alla ricerca del figlio portato via dall’Italia dalla madre. Un film attuale sui bimbi contesi. Ma anche “Viva la sposa” di Ascanio Celestini con tante storie ,all’insegna della bizzarria del personaggio, indicative di un’Italia che l’autore vede senza speranza. Sui film presenti alla mostra si sofferma in questo numero in modo approfondito l’articolo di Carlotta Bruschi. Vincitore delle “Giornate degli Autori” il film “Underground fragrance” di Pengfei che racconta storie di migranti nelle megalopoli cinesi con una società non solo in piena trasformazione ma in cerca della sua identità. Tra gli Eventi speciali da ammirare “Zonda, folclore argentino”, affascinante viaggio di Carlos Saura nella magia della musica popolare. Da guardare con interesse la nuova sezione della Biennale “Il cinema nel Giardino”, svoltosi all’aperto al Movie Village, con omaggi, tra l’altro, al Cinema di Carlo Lizzani, del disegnatore satirico Zac ed alla storia del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Era anche presente Elisabetta Sgarbi con “Il pesce rosso dov’è”, storie di pescatori nell’affascinante territorio del Delta del Po. Tante sarebbero ancora le cose interessanti della Mostra da ricordare. Ma non si può trascurare un Evento come il Tributo a Orson Welles in preapertura del Festival. Un Omaggio, in occasione del centenario della sua nascita, con due suoi capolavori ”veneziani” di ispirazione shakesperiana, eccezionalmente recuperati e restaurati, “Il mercante di Venezia” del 1969, film di 35 minuti considerato perduto, e “Otello”( 1952).
Due opere che hanno riproposto la grandezza di un genio immortale del Cinema. Altro Evento, la presenza al Lido di Venezia di Vasco Rossi occasionato dalla presentazione del documentario di Fabio Masi “Il decalogo di Vasco”. Una presenza che ha catalizzato l’attenzione di fans, ma non solo, e che sul piano artistico contribuisce sempre più a quell’integrazione tra linguaggi e forme espressive che la Mostra tende a perseguire per aprirsi a pubblici diversi.
La FEDIC ha continuato per la ventiduesima volta ad essere presente alla Mostra. Con il “Premio FEDIC” ha premiato due film che si sono distinti nel panorama dei film italiani presenti nelle varie sezioni della prestigiosa manifestazione. Il ”Premio FEDIC”, destinato “All’opera che meglio rifletta l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore” è stato attribuito al film “Non essere cattivo” di Claudio Caligari “perché descrive con crudo realismo ma con affettuosa e partecipe umanità un microcosmo di emarginati di cui rappresenta, con una forza creativa ormai rara per il cinema italiano, desideri di una vita e di un futuro diversi”. La “Menzione FEDIC – Il Giornale del Cibo” destinata “all’opera che propone la scena più significativa legata al cibo e all’alimentazione” è stata invece assegnata al film “L’attesa” di Piero Messina “perché le sequenze in cui il cibo diventa protagonista hanno un forte valore simbolico che rimanda al tema della nascita dell’identità e della rigenerazione”.
.
.
.
Il “ Forum FEDIC”, che si è svolto nello spazio Incontri Venice Film Market all’Hotel Excelsior, ha quest’anno affrontato un tema particolarmente interessante, il rapporto tra i Media e il cortometraggio. Ad aprire il Forum, il saluto di Luigi Cuciniello, direttore organizzativo della Mostra e Presidente Anec, che ha sottolineato come l’iniziativa della FEDIC costituisca, a suo parere, una peculiarità originale della Mostra di Venezia che da sempre dedica spazio molto importante a tutte le attività associative aprendosi così ad un dialogo con il mondo del cinema al di là dei dieci giorni della Mostra. Ospite del Forum anche Stefania Ippoliti, Presidente dell’Italian Film Commission, che ha ribadito l’interesse per il lavoro della Fedic auspicando una sempre più concreta collaborazione con le varie rappresentanze associative. Nel suo intervento il Presidente FEDIC Roberto Merlino ha tracciato un excursus delle iniziative FEDIC concludendo che la Federazione ha fatto parecchie cose buone e concrete con l’obiettivo di fare ancora di più, dichiarandosi convinto che la Fedic riuscirà a farlo. Con l’intervento di Paolo Micalizzi, che da vent’anni cura il Forum FEDIC, si è poi entrati nel vivo del tema di quest’anno. Da un interesse dei Media per il cortometraggio come si registrava dagli anni 50 ai 70, ha rilevato, si è passati, soprattutto negli ultimi tempi, ad un grande disinteresse. Lo ha rilevato anche Jacopo Chessa, Direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio, che ritiene che ciò sia dovuto ad una situazione del Cortometraggio stesso che oggi è molto diversa da allora, precisando anche che i Media non sono solo informazione ma anche un’opportunità di comunicazione molto più ampia. In quanto ai Media, ha poi aggiunto, a parlare del Corto sono più le testate web ed in qualche modo quelle specialistiche che la stampa generalista. A quest’ultimo proposito ha illuminato la situazione Franco Montini (Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e giornalista del Quotidiano “La Repubblica”) affermando che ai giornali poco importa del cortometraggio poiché tendono ad occuparsi soltanto di ciò che è noto e celebrato. Concludendo poi che la causa principale sta proprio nella scarsa attenzione che oggi il mondo dei Media ha verso ciò che è nuovo, più originale, più interessante: un atteggiamento duro da sconfiggere. Al cortometraggio pone invece particolare attenzione il prestigioso Dizionario Morandini, come sottolineato dalla co-autrice Luisa Morandini che al suo interno ha creato un’apposita sezione dove figurano i corti segnalati dai festival, come quello da lei organizzato per gli studenti delle scuole superiori. E interesse per il cortometraggio è stato testimoniato anche da Fabrizio Cavaniglia, redattore della Rivista “Tutto Digitale” che si occupa dei filmmakers indipendenti, non solo mettendo in luce il loro lavoro, ma anche confrontandoli con i professionisti del settore. Sull’opportunità, e importanza, che la stampa parli del cortometraggio si è dichiarato d’accordo anche Marcello Zeppi, Presidente di “FilmVideo” di Montecatini. Ha concluso il Forum la proiezione di tre cortometraggi di soci FEDIC, vincitori di tre Concorsi indetti dalla Federazione Italiana dei Cineclub: “Inno FEDIC” di Laura Biggi e Lorenzo Caravello che ha vinto il 1° premio al Concorso “Inno Fedic” 2015; “Vuoto a perdere” di Stefano Vannelli che ha vinto il 1° premio al Concorso da “1 minuto”( 2014); “Il ponte dei sospiri” , video di 6’ di Roberto Merlino, 1° premio al Concorso “Acqua”( 2015).

Forum FEDIC. Il tavolo dei relatori- da sin. Montini, Chessa, Morandini, Merlino, Micalizzi, Cavaniglia. (Foto di Marco Asunis)
.
.
I FILM IN CONCORSO GIORNO PER GIORNO
di Ugo Brusaporco
“Beasts of No Nation” e “Looking for Grace”
Il concorso di questa 72° Mostra del Cinema di Venezia si era aperto con due film dedicati al tragico passaggio tra l’infanzia, intesa non solo come età, alla maturità, con al centro una sedicenne in “Looking for Grace” dell’australiana Sue Brooks e un bambino in “Beasts of No Nation” di Cary Joji Fukunaga, primo film prodotto dal colosso audiovisivo Netflix, che lo porrà sulla sua rete in ottobre, dopo alcune proiezioni in sala che serviranno ad assicurare la corsa agli Oscar al film. Tratto dall’acclamatissimo romanzo dell’autore nigeriano Uzodinma Iweala, il film di Joji Fukunaga, produzione USA, si basa sulla drammatica storia di Agu, un bambino soldato strappato alla sua famiglia per combattere nella guerra civile di un paese africano non meglio identificato. Il film non riesce mai a essere comprensibile, soprattutto per il fatto di decidere l’anonimato del paese, denunciare all’accusa presente nel libro, è scelta economica per non ininamicarsi paesi produttori di petroli e altri beni, perché è qui che si compie l’apprendistato guerriero di un bambino felice e amato dalla famiglia che si trova in un momento a assistere alla fuga della madre e all’assassinio del padre e del fratello più vecchio. Il film racconta i mirabili paesaggi africani, ma fatica a essere credibile e emozionante proprio perché si allontana dal dettato del romanzo da cui parte, dove ogni descrizione è più reale e violenta. Il regista si preoccupa troppo di “nascondere” invece che dire e nel film pesa il suo essere menzognero e pronto al compromesso con un pubblico che mal accetterebbe la sodomia sui bambini e il fatto di scoprire che non esiste una innocenza infantile, ma esiste una vile prevaricazione dei diritti dei bambini. Il nostro infantile protagonista diverrà amante del capo e assassino, unica possibilità che gli viene concessa per sopravvivere. Il film manca di un discorso politico capace di identificare pienamente la complicata situazione che si vive nei territori sub sahariano in cui i protagonisti agiscono, resta in una blanda narrazione televisiva, senza dare emozioni. Su ben altri livelli lavora l’australiana Sue Brooks nel suo “Looking for Grace”. La Grace del titolo è un’adolescente in viaggio verso il concerto del suo gruppo heavy rock preferito. Lei, una brava Odessa Young, sta viaggiando tra i suggestivi paesaggi australiani per raggiungere insieme a un’amica il concerto più amato e atteso, per arrivarci occorrono giorni di viaggio nell’immenso territorio australiano, per farlo servono i soldi che ruba a suo padre, pronto a tradire una moglie che gli nasconde il fatto di avere un altro figlio. A un certo punto del viaggio Grace accettando l’improvviso innamoramento con uno giovane sconosciuto, si vede abbandonata dalla sua miglior amica, ma proprio il giovane dopo una notte d’amore la deruba lasciandola sola. Un vecchio investigatore è chiamato a cercarla, mentre un camionista trasporta il grano di qua e di là di un paese sconfinato e colmo di solitudini. La regista spiega e noi condividiamo: “Volevo girare un film che fosse come io vivo la vita. Senza nessun percorso eroico. Senza nemmeno un eroe. Se credete che siamo fautori del nostro destino, questo film non fa per voi. Se credete che abbiamo tutti un destino che sfugge al nostro controllo e che passiamo la vita a cercare di plasmarlo nella forma che pensiamo dovrebbe avere, allora forse questo film fa per voi” Un film che delicatamente racconta il dolore del vivere, del sentirsi vivi, nonostante tutto. Il pubblico resta sorpreso, questo non è Hollywood e neppure Netflix, è cinema vero.
“Francofonia” e “Marguerite”
“Francofonia” di Alexander Sokurov e “Marguerite” di Xavier Giannoli, due film che cantano l’Arte come unica strada di vita, di sopravvivenza, per ognuno e per l’umanità tutta. Sokurov regala 87 minuti di riflessione sul destino dell’opera d’arte come memoria dell’umanità in balia di un tragico destino durante le guerre. Nei giorni in cui vediamo distruggere ogni testimonianza artistica da parte di fanatici ignobilmente ignoranti, nei giorni in cui in Italia, senza guerra, si consumano Pompei e troppi altri siti, un film come questo pone un confine netto alle coscienze, diventando esso stesso mezzo di necessaria memoria. Se non è possibile raccontare in breve un film dove seguiamo una nave carica di opere d’arte in balia di un oceano tempestoso che vuole seppellirle nel suo fondo e i nazisti che invadono Parigi e ne rispettano architetture e opere d’arte contemplate con gioia da Hitler, che non esita a comandare alle sue truppe la distruzione vigliacca dei musei e delle opere d’arte a Leningrado e in tutta la Russia, la Polonia e i paesi dell’est, come se queste non rappresentassero un valore esemplare come il Louvre. Già, il Louvre, è questo museo straordinario, il protagonista del film, con le sue opere, con il suo essere edificio-opera d’arte, con il suo essere stato protagonista durante il secondo conflitto mondiale della più strana alleanza franco-tedesca per difenderlo. Protagonisti di quell’alleanza il direttore del Museo Jacques Jaujard (1895-1967, ben reso da Louis-Do de Lencquesaing) e il nobile ufficiale tedesco Conte Franziskus Wolff Metternich (1893-1978, interpretato da Benjamin Utzerath), che insieme tra il 1940 e il 1942 compiono l’impresa straordinaria di salvare Parigi e le sue opere dal saccheggio tedesco, per questo l’ufficiale si farà un nemico potente come Goering. Il loro rapporto è reso come fiction da Sokurov, che sceglie di mostrare la Parigi del tempo con documentari d’epoca, e che, ancora come finzione fa abitare da due fantasmi il Museo, uno è lo spirito di Napoleone (Vincent Nemeth) che si sente a casa tra le opere esposte, l’altro è Marianne (Johanna Korthals Altes),personificazione della Francia che invita sempre a volgere il pensiero su tre parole: Libertà, Uguaglianza e Fraternità. Aiutato nel suo lavoro dalla splendida fotografia di Bruno Delbonnel, dalle opere del Museo, da un preciso montaggio di Alexei Jankowski e Hansjorg Weissbrich, e dalla puntualissima musica firmata da Murat Kabardokov, Sokurov pecca, forse, per una necessaria verbosità nel suo accompagnare le storie. Sentiva, evidentemente, il bisogno di spiegare, di evitare equivoci, troppo importante il messaggio che lancia e che colpisce nel segno, senza Arte il nostro mondo non ha Storia. Su un altro aspetto del rapporto tra Arte e vita punta la perfetta commedia color vivace –amarognolo “Marguerite” di Xavier Giannoli. Un grande e emozionante film, ispirato alla vita della soprano americana Florence Foster Jenkins (1868-1944) famosa per la sua completa mancanza di doti canore, un vero incubo per chi l’ascoltava, un personaggio che sarà portato sullo schermo anche da Stephen Frears in un biopic che vedrà come protagonista Meryl Streep. Qui il ruolo è affidato a una straordinaria Catherine Frot, attrice che nulla ha da invidiare alla signora Streep, neppure la splendida carriera. Lei è una ricca signora, sposata con un nobile decaduto ( un bravissimo André Marcon), che lascia che la moglie si creda una grande cantante mentre è dannatamente stonata e stridula. Siamo nel 1920, lei organizza concerti nel suo castello per raccogliere fondi per gli orfani di guerra, la gente sopporta per la nobile causa, applaude e alle sue spalle ride, sapendo anche che il marito la tradisce. A uno di questi concerti arrivano, insieme a una giovane soprano (Christa Theret) due giovani, un critico (Sylvain Dieuaide)e il poeta anarchico (Aubert Fenoy). Cambieranno la sua vita, scrivendo una recensione strepitosa. Subito vogliono approfittare di lei, poi di fronte al suo candore cercano di aiutarla. L’unico vero aiuto le viene dal maggiordomo (un intenso Denis Mpunga) è lui che la segue nelle sue follie e la cura. Aiutata da un cantante che non crede in lei prepara un concerto vero in un teatro, ma il sogno si infrange nella sua bocca, chi aveva cominciato a ridere comprende finalmente il dramma di una donna sola che nella musica aveva la sua vita e che perdendo la stima in se stessa ha solo una strada: morire. Film che sorprende e che convince imprimendosi nella mente per la qualità della recitazione, per la bellezza formale la fotografia di Glynn Speeckaert, il montaggio di Cyril Nakache; la musica di Ronan Maillard e le scenografie di Pavel Tatar. Un ritratto di donna capace di celebrare lo spirito di una donna.
“L’attesa”, “The Danish Girl”, “Equals”
Il concorso ha portato al Lido il primo film italiano (in realtà è una coproduzione con la Francia e la maggior parte del film è in francese): si tratta di “L’attesa” opera d’esordio di Piero Messina, in parte ispirata a “La vita che ti diedi” di Luigi Pirandello, dramma in cui una madre si rifiuta di accettare la morte di suo figlio. L’azione si svolge interamente in un unico luogo, la villa padronale della protagonista, Anna (Juliette Binoche), il regista riesce lo stesso a non essere troppo teatrale, concentrandosi sulla danza psicologica tra la madre, Anna, che vuole nascondere a se stessa la morte del figlio, e la giovane fidanzata di lui, Jeanne (Lou de Laâge) giunta per trovarlo e a cui viene nascosta la tragedia. Il problema primo che il regista non risolve è la diversa impostazione attoriale delle due protagoniste: a fronte del perfetto minimalismo della signora Binoche, che riesce a trasmettere qualsiasi emozione con un semplice sguardo, la giovane de Laâge ha un altro “respiro”, una tecnica fisica, esteriore, di recitare, per cui spesso le loro dinamiche non si fondono. E questo porta anche a una perdita di profondità e emozione, il regista sembra volerci portare nell’intimità profonda delle due protagoniste, in realtà ci lascia, come loro, solo in superficie, una bella e patinata superficie (era aiuto di Sorrentino per “La grande bellezza”), in attesa di rivelazioni che non arriveranno mai. Sempre in Concorso “The Danish Girl” di Tom Hopper (premio Oscar per “The King Speech”) tratto dal libro omonimo di David Ebershoff che si ispirò alla vita di Einar Magnus Andreas Wegener (1882- 1931) diventato il primo uomo a cambiare sesso diventando Lili Elbe, ma morendo per l’ultima operazione che doveva finalmente regalargli la completa femminilità. Nel ruolo di Einar/Lili uno straordinario Eddie Reydmayne. Fresco del Premio Oscar, il camaleontico attore londinese, dà vita a una recita emozionante, di grande intensità, capace di coinvolgere alle lacrime il pubblico nel far vivere il dramma interiore di un uomo che sente in sé forte la pulsione femminile e non omosessuale, peccato che proprio il regista non sappia tenere le redini del discorso e trasformi il film in una banale telenovela. Hopper non riesce neppure a colorare l’interessante recita di Alicia Vikander, costretta a interpretare una dimezzata e poco credibile moglie di Einar, la pittrice Gerda Wegener (1886 -1940) di cui volutamente si dimentica la bisessualità. Innamorato com’è, giustamente, dello strabordante Reydmayne, oltre a lui si preoccupa di paesaggi e di un mondo anni ’20 del secolo scorso, visto come in cartolina. Chiaramente si tratta di un film di solida fattura, importante per l’argomento di cui parla, in un tempo in cui le scelte omosessuali e ancor di più quelle trans, sono al centro dell’attenzione. Terzo film in competizione ““Equals” di Drake Doremus, un film che ci porta in un futuro inquietante per dirci che in fondo finché ci sarà l’uomo, varrà il detto virgiliano: “Omnia vincit amor et nos cedamus amori”. In un futuro lontano scopriamo una avanzatissima civiltà umana dove l’amore, il sesso e tutto quello che ha a che fare con le emozioni umane è stato sradicato. Gli esseri umani sono come manichini alienati, qui troviamo che Nicholas Hoult che interpreta Silas, un artista nel reparto di “fiction speculativa” della corporation Atmos, e Kristen Stewart (attrice cult per il suo ruolo di Isabella “Bella” Swan in “The Twilight”) come Nia, una ragazza che passa le giornate a dettare funzioni spaziali. A loro tocca la fortuna/sfortuna di innamorarsi. Certo è difficile per il regista, e non sempre ci riesce, raccontare la nascita di un sentimento in un luogo sterilizzato come quello in cui agiscono i due protagonisti, e poi non sempre i comprimari sono di rilievo e la loro performance negativa pesa su un film dal dettato fragile, nonostante le interessanti location a Singapore (Singapore Marina Barrage e Henderson Waves Bridge), e in diverse località giapponesi (come il Museo Miho), vero futuro del nostro tempo. Di sicuro un film che celebra l’individualismo e condanna il collettivismo, in un tempo in cui ognuno pensa solo a se stesso mentre abbisognamo di società. Qualche applauso e diversi fischi, in fondo è un film per il mercato, con gli attori giusti per il botteghino.
“A Bigger Splash”, ”L’Hermine”, “El Clan”
In Concorso passano ancora tre film e a fare la figura dell’intruso purtroppo è il secondo film italiano in competizione: “A Bigger Splash” di Luca Guadagnino, una coproduzione con la Francia, tratta da una storia scritta da Alain Page “La piscina” già portata sullo schermo mirabilmente da Jacques Deray nel 1969 con un cast favoloso: Alain Delon, Romy Schneider, Jane Birkinand e Maurice Ronet. La vicenda è presto detta, un uomo e una donna stanno passando le loro vacanze al mare, la loro tranquillità viene rotta dall’arrivo di un altro uomo, l’ex di lei, con la giovanissima figlia. I due uomini cominciano a scontrarsi, ma tutto precipita dopo una giornata al mare tra la ragazza e l’uomo, forse hanno fatto l’amore, e allora il padre ubriaco sfida nella piscina della casa l’uomo della sua ex. Uno non uscirà vivo. Page, che per questo film usò lo pseudonimo Jean-Emmanuel Conil,, aveva ambientato la storia a Saint Tropez, Guadagnino la porta a Pantelleria, e mentre nel film francese, sceneggiato dal mitico Jean-Claude Carrière, il collaboratore più amato da Luis Buñuel, i vacanzieri erano lo scrittore Jean Paul e la sua amante Marianne, in questo “A Bigger Splash” la sceneggiatura di David Kajganich, nato proprio nell’anno de “La piscina”, vede Marianne (una sempre intensa Tilda Swinton) come una pop star che ha perso la voce, e Paul (Ralph Fiennes) come il suo amante, un cambiamento importante soprattutto per la significazione del rapporto tra l’uomo e la figlia (Dakota Johnson) dell’altro (Matthias Schoenaerts), qui è pura attrazione fisica, là c’era un’ altra tensione. Come abitudine ormai, ci sorbiamo la solita sagra popolare, fuori dal solito l’intervento ridicolo di Corrado Guzzanti come carabiniere da barzelletta, ma in fondo tutto il film è una presa in giro all’intelligenza dello spettatore, perché mai, neppure nei paesaggi filtra una emozione. Tutto è glaciale, anche la pietà verso gli immigrati, che il film non può dimenticare visti gli sbarchi nell’isola, ma che appartengono a altre storie non a questa malamente raccontata. Ci riconciliamo con il cinema grazie a “L’Hermine” dello scrittore-regista francese Christian Vincent. Il titolo si riferisce alla toga di ermellino che indossa Racine (un impagabile Fabrice Luchini) quando svolge il suo lavoro di Presidente della Corte d’Assise in una piccola città. Lo chiamano “il giudice a due cifre”, perché le pene che infligge sono sempre di almeno dieci anni, lo temono per questo gli imputati e lo disprezzano i colleghi avvocati che aspettano solo che vada in pensione. Lo incontriamo febbricitante mentre apre un processo contro un uomo accusato di aver ucciso la sua bambina a calci. Scopriamo che a sorprenderlo non è il caso o la noia con cui si dibatte il processo, ma perché tra i giudici popolari è stata scelta Birgit (una bravissima Sidse Babett Knudsen), l’aveva incontrata in ospedale dopo un grave incidente, lei era la dottoressa che si occupava dell’anestesia, e lui risvegliandosi dall’intervento l’aveva vista come un angelo, e ora se la ritrova vicino. Ha appena divorziato dalla moglie, vive in albergo, è segnato dalla solitudine e dall’amara consapevolezza che in Tribunale non funziona la verità ma il rispetto delle leggi. Lei diventa la sua luce, si incontrano, e intanto il gruppo dei giurati popolari si appassiona al caso, sono per lo più immigrati, integrati anche in questo gioco. Il film è una bella commedia, uno schiaffo al genere giudiziario americano e un omaggio al cinema di Sacha Guitry. La recita è stupenda e con leggerezza passano le idee e Christian Vincent dipinge la vita di oggi, quella che vediamo dalla finestra quella viviamo camminando per strada. Terzo film in Concorso il drammatico e convincente “El Clan” di Pablo Trapero, una coproduzione tra Argentina e Spagna su un caso che sconvolse il paese sudamericano all’uscita dalla terribile dittatura fascista, quello dalla famiglia Puccio che agendo proprio come un clan imperversò impaurendo il paese con tragici rapimenti. Trapero con un ritmo che lascia senza respiro mette in evidenza le collaborazioni e protezioni su cui poteva contare il capo clan, Arquímedes Puccio (interpretato da un grande Guillermo Francella), uomo legato all’estrema destra e coinvolto nel traffico di armi tra Argentina e Italia, un capo famiglia che pretendeva assoluta obbedienza da moglie e i sui tanti figli, tra cui Alex famoso astro del rugby nei Pumas e nella nazionale bianco-celeste, che più volte tentò il suicidio, anche in carcere, per salvare il suo nome dall’umiliazione. I suoi compagni di squadra e la sua ragazza sapevano che la sua partecipazione ai rapimenti fu momentanea e sotto la minaccia del padre, in realtà fu l’unico a pagare veramente, per una storia presto insabbiata in quanto i soldi dei rapimenti servivano evidentemente a finanziare la destra più dura. Trapero svela con forza una pagina buia meritando tanti applausi, per un film che non è solo il racconto di una famiglia criminale, ma la drammatica certezza che i semi delle dittature non marciscono mai.
“The Endless River”, “Rabin, the Last Day”
Per i fans floydiani, il titolo del film sudafricano “The Endless River”, rimanda al quindicesimo album dei Pink Floyd, l’ultimo in ordine di tempo, essendo uscito lo scorso autunno, per omaggiare Rick Wright, che del gruppo fu tra i fondatori. La nostra non è una disgressione, perché il film del trentatreenne Oliver Hermanus ha atmosfere proprio floydiane, nel suo road film di anime. Il regista ha il dono di saper raccontare le storie attraverso volti e traiettorie che rinchiudono momenti di dolore, senso di colpa, e desiderio di espressione. C’è in lui la potenza di un romanticismo striato dal sangue. Ed ecco che nella vastità dei paesaggi che circondano la piccola cittadina rurale di Riviersonderend (parola Afrikaner che vuol dire: fiume senza fine) nella costa ovest del Sud Africa, ci troviamo a conoscere la giovane cameriera di un piccolo locale, Tiny (una bravissima Crystal – Donna Roberts) che aspetta trepidante il ritorno a casa del marito Percy (Clayton Evertson) uscito dopo quattro anni dal carcere, e Gilles (Nicolas Duvauchelle) un francese che vive, con moglie e due figli in una grande fattoria poco lontano dal paese. Mentre Nicolas sta mangiando nel locale di Tiny, a casa sua tre bruti massacrano la sua famiglia violentando a turno anche sua moglie prima di ucciderla. Lui è sconvolto, disperato, arrabbiato contro una giustizia che gli spiega che è normale tutta questa violenza in un paese come il Sud Africa. Percy intanto tornato in libertà trascura la moglie e preferisce ubriacarsi e giocare con gli amici, una gang di bruti. La polizia passa una foto di Percy a Gilles, come traccia per ritrovare i colpevoli. La mattina dopo Percy viene trovato morto. Tiny non crede che sia stato Gilles e lui cerca insieme a lei di ricominciare una vita con una vacanza da sogno nello spettacolare, barbaro paesaggio sudafricano, ma può un nuovo amore vivere su mortali ceneri fresche? Hermanus unisce bruto realismo, favola, documentario, per dire di due anime affrante, non gli interessano le cartoline, sa che il suo paese non può permetterselo, nascondendo la violenza sotto coltri di foglie, gli interessa raccontare il vero, non il reale, e così il film è ricco di sottotesti, la polizia corrotta, il razzismo che si traduce in tutto, la povertà anche culturale di una gioventù nera senza sbocchi se non nel gratuito perdersi. Di grande emozione e forza “Rabin, the Last Day” di Amos Gitai una coproduzione tra Israele e Francia. 153’ che scivolano velocissimi. Il film ha una tensione continua e la qualità del linguaggio che tutto apre, dal documentario, all’intervista, alla finzione al gioco teatrale, per ricordare l’assassinio del Premio Nobel per la Pace e Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin che avvenne proprio vent’anni fa la sera di sabato 4 novembre 1995 al termine di un grande comizio politico organizzato nel centro di Tel Aviv. Gitai non punta sul ricordo del personaggio, di lui usa le parole più significative pronunciate tra l’accordo di Oslo, settembre 1993, e la sua morte, parole che parlano di una pace lunga da avere, ma possibile, della situazione di Gaza, del riconoscimento dei diritti dei palestinesi. Parole che chiedono alla politica di non esaltare e provocare la violenza, ma essere politica. E per questo viene ucciso da un giovane universitario ebreo ultraortodosso, istruito da feroci rabbini che predicano la distruzione degli arabi e il diritto sulle loro terre. Gitai mette in evidenza che a uccidere Rabin non è stata una mano assassina ma un sistema che coinvolge insieme l’estremismo di destra con quello religioso, con il loro parlare alla gente per renderla rabbiosa, incapace di qualsiasi ragionamento libero. Lo stesso evidenzia le falle del sistema di sicurezza in quella tragica serata. Polizia e servizi segreti non sono innocenti, e neppure le guardie del corpo. Davanti a noi si svolgono le tragedie di un uomo, il cui assassinio straordinariamente è stato fissato da un operatore video, e quelle di un paese che ha perso la ragione e la dignità. Gitai guarda a ieri per capire l’oggi, chi condusse una campagna denigratoria infame contro Rabin, è oggi alla guida di Israele, in una continuità che negli anni è costata sangue ai palestinesi e dolore agli israeliani democratici. Un grande film, necessario per capire l’oggi e piangere per un ieri tradito.
“Sangue del mio sangue”, “Anomalisa”, “Abluka”
Marco Bellocchio ha firmato un’opera magistrale, innovativa linguisticamente, emozionante e provocante per i contenuti. “Sangue del mio sangue” è frutto di una coproduzione tra Italia, Francia e Svizzera, ambientato e girato a Bobbio, città natale del regista. L’atmosfera del film è allo stesso tempo inquietante, grottesca e comica, tipica del recente lavoro del regista, che qui trova un’ispirazione nuova e più libera, quasi a chiudere un cerchio idealmente cominciato cinquant’anni fa con “I pugni in tasca”, girato come questo a Bobbio. Due le idee che lo hanno guidato al progetto, come spiega: “Il film nasce per caso dalla scoperta delle antiche prigioni di Bobbio, chiuse e abbandonate” e “l’Italia di oggi, un’Italia paesana garantita e protetta dal sistema consociativo e corruttivo dei partiti e dei sindacati che la globalizzazione sta radicalmente “trasformando” (non si capisce ancora se in meglio o in peggio)”. E nel film le prigioni diventano nel XVII secolo un convento di clausura dove una giovane monaca (Lidiya Liberman) è accusata di stregoneria per essere diventata l’amante di un sacerdote che per questo tradimento alla Chiesa si era suicidato. A quello che succede alla monaca è interessato Federico, fratello gemello del suicida inviato dalla madre a far sì che il corpo sia seppellito in terra sacra e non nel cimitero degli asini. Ma anche Federico si innamora della monaca che prima viene torturata e poi murata viva per non aver confessato di essere nelle mani di satana. Trent’anni dopo Federico diventato cardinale farà abbattere quel muro, in una memorabile scena di gran cinema. Ai giorni nostri il convento sembra completamente in rovina, ma è abitato da un fantomatico Conte (un magnifico Roberto Herlitzka) che ha abbandonato l’isterica moglie e che qui ha trovato nascondiglio. Esce solo di notte, tanto che qualcuno lo crede un vampiro, soprattutto per incontrare una specie di loggia cittadina che riunisce massonicamente dal sindaco al prete passando per il dentista, tutti i potenti di Bobbio, che tutto arrangiano con tangenti, finti invalidi, senza fatture e truffando lo Stato. Tutti tremano quando arriva un ispettore del Ministero con un russo venuto a comprare la prigione-convento per trasformarla in qualcosa. La provinciale loggia a cominciare dal prete vuole scaricare il Conte: meglio che il palazzo si venda subito così l’ispettore se ne va. E il Conte? Al ricovero! Il vecchio nobile sistema le cose, trova il tempo anche di innamorarsi prima di salutare. Al muro con l’Italia di oggi e di ieri, la vecchia Chiesa, il popolino che si accontenta e si arrabatta, l’incapacità tutta maschile di amare e le donne che si trovano da sole a mendicare amore e vita. Il film commuove per la sua bellezza, per il suo essere lezione di cinema e di vita. Di grande bellezza è anche “Anomalisa” che i coregisti Charlie Kaufman e Duke Johnson hanno diretto con superba classe. Si tratta di un film di animazione con i pupazzi, girata a passo uno, o come dicono oggi stop motion, che negli USA sarà vietato ai minori di 17 anni per le scene di sesso, ma soprattutto perché denuncia come fallimentare tutto il sistema sociale americano. Charlie Kaufman non ha bisogno di spiegarlo troppo con le parole, gli basta usare solo tre voci off per tutti i personaggi, quella di David Thewlis per Michael Stone, noto conferenziere che atterra a Cincinnati per uno dei suoi soliti incontri, Jennifer Jason Leigh per Lisa, una centralinista bruttarella, insignificante e insicura arrivata nello stesso albergo di lui con un’amica per seguire la conferenza, e la voce di Tom Noonan, che interpreta tutte le altre, dalla moglie, il figlio e gli amici di Michael, al direttore e gli impiegati dell’hotel, dall’amica di Lisa all’ex fidanzata di lui. Insomma Noonan dà voce al grigio quotidiano di tutti, mentre Michael e Lisa mantengono una loro originalità ed è per questo che si incontrano, si amano, fanno l’amore, prima che lui si confonda, non sopportando la differenza di classe sociale, e lasci disperato per la solitudine in cui ricasca, ma lei non ha cambiato voce e da quella notte trae la forza per continuare a vivere in mezzo a gente grigia e con la stessa voce. Un film pieno di belle battute, ma soprattutto pieno di disperata emozione, quella che investe chi vorrebbe vivere e non sopravvivere, e non è una questione di soldi, ma di emozioni. “Abluka” (Frenzy, titolo internazionale) del turco Emin Alper ci porta in una Istanbul di oggi segnata da violente guerriglie urbane e dal degrado umano e civile. Qui incontriamo Kadir (Mehmet Ozgur) uscito di prigione dopo quindici anni, in cerca di quello che resta della sua famiglia, sono il più giovane dei suoi fratelli Ahmet (Berkay Ates) che è pagato dal municipio per uccidere i cani randagi, un altro fratello è diventato il capo dei rivoltosi antigovernativi. Lo hanno rilasciato in anticipo per farlo diventare un informatore, vogliono prendere suo fratello il guerrigliero, ma lui nella follia in cui finisce, incapace di capire da che parte stare, volendo liberarsi del peso della polizia, condanna a morte il fratello più giovane, colpevole di aver salvato un randagio e di aver cercato di nasconderlo. Bellissima la fotografia di Adam Jandrup che richiama le luci di Vermeer, come impressionante è il lavoro dello scenografo Ismail Durmaz soprattutto per gli esterni.
“Heart of a Dog”, “11 minut”
Spiazzante questa giornata in concorso in un Lido che sta svuotandosi in attesa dell’invasione dei fans di Vasco Rossi che approderà venerdì alla Mostra accompagnando un docufilm a lui dedicato. Sotto un pallido sole si sono confrontati “Heart of a Dog” di Laurie Anderson e “11 minut” (11 Minuti) di Jerzy Skolimowski, due tra i film più attesi della Mostra, e sicuramente tra i più votati all’Arte Cinematografica. Il fatto è che entrambi gli autori, partono da una loro idea di cinema che se ne infischia dei bisogni del pubblico, non offrendosi pacificamente a quello, ribadendo una idea profondamente autoriale. Questo non vuol dire che siano spettacoli scadenti, anzi ci troviamo di fronte a due film che in modo diverso possono attrarre un pubblico attento e sensibile alle emozioni. “Heart of a Dog” è un canto funebre che Laurie Anderson dedica alle morti di sua madre e della sua cagna Lolabelle, per adombrare e celebrare il suo dolore più grande: la morte del compagno di una vita Lou Reed. Un film straziante per il profondo dolore che vi scorre, un film che celebra il bisogno di rinnovamento di un linguaggio, quello cinematografico che da troppo, come prevedevamo con Pasolini, si è asservito al dettato televisivo con conseguenze letali per il nostro futuro. Sulla scia di un dettato nato dall’underground storico, dalla lezione di Gian Vittorio Baldi e di Nam June Paik, Laurie Anderson combina un film che straborda di idee, siano esse visive che dettato filosofico esistenzialista. Il linguaggio visivo spazia tra animazione, film a 8mm dell’infanzia dell’artista, immagini stratificate e animazione grafica. Brani per violino solista, quartetti, canzoni e musica elettronica, percorrono il film fino all’ultima catartica canzone affidata alla inconfondibile voce di Lou Reed. Al centro del film c’è una meditazione sul “bardo”, secondo la filosofia buddista lo stato della mente dopo la morte, uno stato intermedio fatto di sofferenze che può durare al massimo 49 giorni, ma c’è anche un profondo afflato culturale europeo, con Wittgenstein e le sue massime, tra cui fondamentale resta, anche autocritica: “I limiti del mio linguaggio intendono i limiti del mio mondo”. Certo il linguaggio, Laurie Anderson, si mette alla prova con questo film dieci anni dopo il corto di produzione svizzera “Hidden Inside Mountains”, è un film in cui anche lei è protagonista con i suoi ricordi, come quello del periodo trascorso in ospedale, quando da bambina si ruppe la schiena, e come da questo nacque una sua diversa maniera di comprendere il collegamento tra gli eventi della realtà, e la necessità di creare racconti fantastici. Il titolo rimanda a Michail Bulgakov, ma più timide qui sono le istanze ideologiche, anche se non manca una chiara denuncia contro l’invasione della sfera privata dei cittadini da parte di uno stato fascistizzato dopo l’11 settembre. E se qui vediamo l’invasione delle telecamere nelle città, la stessa cosa viene rimarcata da Jerzy Skolimowski nel suo “11 minut” (11 Minuti) un film fortemente nichilista nel suo sarcastico e tragico assunto. Innanzitutto bisogna rendere grazie a questo autore settantasettenne che non si pone problemi nell’usare mezzi di ripresa quotidiani come una webcam, uno smartphone, un telecamera a circuito chiuso, prima di passare a un magistrale uso del widescreen, grazie al bel lavoro del direttore della fotografia Mikolaj Lebkowski. Il film è un intreccio di storie che si svolgono contemporaneamente nella citta di Varsavia, ognuna di queste storie si contiene in 11 minuti. Così conosciamo un professore pedofilo, suo figlio spacciatore, una modella attrice che si trova a fare un provino con un regista assatanato, suo marito che la sta cercando, una donna che ha appena divorziato, un’altra che gira film porno per piacere all’uomo che ama, un gruppo di suore amanti degli hot dog … inconsapevolmente tutti si ritroveranno coinvolti in un finale catartico che segnerà per sempre la loro vita.
“Remember”, “Desde allá”
Abbiamo incontrato nelle vie del Lido molti giovani e anche persone più mature, vogliose di fare cinema, inquiete soprattutto sui finanziamenti che servono per realizzare la loro idea, e tutte, queste persone, avevano un’idea hollywoodiana di far cinema, non l’idea di cosa dire con il cinema, che è diversa da una trama banale. Abbiamo ripensato a questo dopo aver visto i due film oggi in competizione “Remember” di Atom Egoyan e “Desde allá” (Da lontano) di Lorenzo Vigas. Il primo, coprodotto da Canada e Germania, racconta l’ultima scaccia ai criminali nazisti, il secondo, coprodotto da Venezuela e Messico, parla di una dolorosa omosessualità. Temi forti e importanti che né il celebrato Egoyan, né l’opera prima del venezuelanoVigas, riescono a trattare con qualità. Non basta un soggetto, magari buono, per fare cinema. Prendiamo l’esempio del giustamente pluripremiato Egoyan: egli ci porta negli Stati Uniti oggi, e in una casa di riposo ebraica ci fa conoscere due amici reduci dai campi di sterminio, Zev, un grandioso Christopher Plummer e Max (Martin Landau), il primo sofferente di demenza senile ha appena perso la moglie, l’altro su una sedia a rotelle, è deciso a usare l’amico per uccidere un comandante delle SS che si nasconde sotto falso nome nel nord degli USA o in Canada. L’idea è buona, peccato che il regista canadese, di origine armena, non sappia tradurla sullo schermo, soprattutto per l’inaffidabilità di uno scritto non adeguatamente credibile, soprattutto in quello che si annunciava essere un incandescente finale, che in realtà si trova a contraddire, in parte, il titolo: più che di fronte a ricordi ci troviamo di fronte a una vendetta, quella di Max, che approfitta della malattia dell’amico per compierla, ben sapendo che gli costerà la vita. Quello che manca al film, non sono i bravi attori, ma la credibilità dell’assunto. Peccato, sul tema esisteva almeno un film capolavoro, “The Stranger” (1946) di e con Orson Welles, Egoyan vi è lontano, forse perché oggi a settant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale, il tema del ricordo necessita di altro trattamento che il vedere una vecchia SS dire tra le lacrime “Ero un nazista”, con accenti che hanno fatto ridere il pubblico. Dal fallimento di “Remember” al compitino di Lorenzo Vigas il passo non è lungo. Anche qui ci troviamo alle prese con un personaggio dalla definizione ambigua, è un uomo di mezza età, Armando (Alfredo Castro la musa di Pablo Larraín) è un tecnico dentista specializzato nel preparare dentiere, finito al lavoro si mette a caccia di giovani, che invita a casa sua per farli denudare, non va oltre, nessun contatto fisico, eredità della violenza paterna. Siamo in una caotica e rumorosa Caracas, e la sua vita cambia con l’incontro con il giovane Elder (Luis Silva), un adolescente, prepotente e bello, che prima lo deruba e poi ne diventa il compagno preferito. Anche un amante, perché Elder vuol guarire quel grigio uomo, anzi prende una iniziativa che provocherà la fine del loro rapporto. Perché Armando, in fondo, non ha bisogno d’amore per vivere, gli basta masturbarsi con sconosciuti. Il suo è un cuore in inverno che il regista fatica a raccontare con qualche emozione, lui ha il cuore ancora più freddo del suo personaggio.
“Beixi moshuo” (Behemoth), “Per amor vostro”
Strana situazione quella che unisce i due ultimi film in concorso, il magnifico e inquietante “Beixi moshuo” (Behemoth) del cinese Zhao Liang, coprodotto da Cina, Francia e Svizzera, e “Per amor vostro” dell’italiano Giuseppe M. Gaudino, coprodotto da Italia e Francia, pur essendo il primo un documentario e il secondo un variopinto dramma napoletano, insieme partono dall’Inferno dantesco. C’è un evidente bisogno di riprendere in mano la grande cultura, per poter leggere il nostro oggi, e Dante è autore fondamentale nel suo aver osservato e descritto l’umano essere, il suo rapporto con gli altri e con il mondo che ha intorno. Behemoth è la terribile bestia descritta nei Libri di Giobbe, e politicamente legato alla furia distruttiva nazista, la visione che Zhao Liang ci offre all’inizio del film è proprio il trionfo bestiale di chi usa questo nostro pianeta e l’umanità che ci vive disprezzando entrambi: ci porta nella zona cinese della Mongolia, ci mostra le esplosioni di mine che squarciano le montagne radendole al suolo e bucano il loro sottosuolo per trarne carbone e ricchi minerali. Dove c’era un’immensa coltre verdeggiante ha trovato posto solo la polvere maledetta e la morte, i fumi delle esplosioni che salgono nel cielo sono colorati, non grigi come quello delle industrie che si nutrono di carbone e metalli. File di camion che si perdono a vista d’occhio imboccano mostri di fuoco di industrie siderurgiche primitive, dove gli esseri umani si consumano letteralmente, riportando la storia indietro di secoli e guardando questa umanità offesa ritornano alla mente le pagine de “La madre” gorkijana dove quelle industrie brutalizzavano gli uomini. E ancora il cammino dantesco continua e quei metalli fusi diventano acciaio e ferro, utili a cosa? Il film si chiude nelle strade vuote della città fantasma di Oros, costruita proprio nelle vicinanze delle miniere, file di grandi palazzi vuoti e silenzio, solo uno spazzino raccoglie svogliato qualche foglia fuori posto. Zhao Liang documenta il fallimento di una umanità guidata dalla follia del denaro e ci costringe a urlare contro chi cancella paesaggi impunito.
Spiega il regista: “Il comportamento umano si contraddistingue per follia e assurdità. Non siamo mai riusciti a liberarci dall’avidità e dall’arroganza, così il viaggio a spirale della civiltà si viene a riempire di deviazioni e regressioni. Sembra di essere posseduti da una forza mostruosa e invincibile, invece siamo noi a creare questa bestia invisibile. È la nostra volontà; siamo al tempo stesso vittime e carnefici. Mi sono ispirato a Dante. È la mia meditazione critica sulla civiltà moderna, in cui si accumula ricchezza mentre l’uomo perisce”. Anche Giuseppe M. Gaudino nel suo “Per amore vostro” affronta un fallimento umano, ispirandosi al III canto dell’Inferno, che si apre con i famosi versi: “”Per me si va ne la città dolente, / per me si va ne l’etterno dolore,/ per me si va tra la perduta gente.”, e poi condanna gli ignavi, ovvero come descrive la guida del grande poeta: “«Questo misero modo /tegnon l’anime triste di coloro / che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”, invitandolo poi a “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. La nostra ignava è Anna (una intensa Valeria Golino), vive a Napoli, divorziata si adopera in tutto per mantenere i tre figli, due ragazze adolescenti, e un ragazzo più grande sordomuto. In casa parlano tutti con il linguaggio dei segni, insieme sono felici, e ancor di più quando Anna trova un posto fisso in una tv dopo anni di precariato. La loro felicità è pero rotta dalle continue visite dell’ex marito un bruto che picchia Anna e disprezza il figlio inabile. Anna è perseguitata da un ex collega che è finito nelle mani dell’usura. Al lavoro, il divo di una telenovela si innamora di lei, e lei è felice. Ma le cose precipitano quando scopre la casa piena di gioielli e soldi frutto dell’attività di usuraio dell’ex marito. Finirà con l’essere disprezzata dai figli per aver sempre taciuto, quello che ben sapeva, prima per non rompere la famiglia, poi per aiutare i propri genitori e non far mancare niente ai figli. Un silenzio pesante che il regista risolve con un miracolo. Gaudino racconta una storia eduardiana e la condisce malamente con giochetti da video clip che insieme a togliere tensione mostrano una deludente incapacità narrativa. Peccato perché la vicenda funzionava e anche gli attori, bastava solo crederci di più.
.
.
GLI ITALIANI A VENEZIA – fils rouge
Impressioni di Carlotta Bruschi
Raccontare le mie impressioni sui film visti durante la 72° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è un compito che si rivela arduo se devo tenere alta l’attenzione di un qualunque lettore, che sia stato al Lido o meno. Di articoli in merito ne sono stati scritti, e molti film da settembre sono già passati nelle sale, quindi perderei già in partenza se mi limitassi a trascrivere una mia recensione a così tanta distanza. Per questo ho pensato di approcciarmi all’argomento nella maniera che ritengo più personale possibile, il mio punto di vista per l’appunto.
Se c’è una cosa che mi piace notare quando partecipo a una rassegna cinematografica è individuare se vi sia o meno un nesso tra le pellicole presentate. Se penso alle scorse edizioni della Mostra mi torna alla mente la n° 70 dove, per esempio, non erano poche le trame aventi un solo attore, massimo due, a sorreggere l’intera durata del film: Mia Wasikowska in “Traks” (John Curran) ha come unici compagni di viaggio dei cammelli e un cane mentre attraversa le spianate desertiche dell’Australia, Emma Dante nel suo “Via Castellana Bandiera” rimane incollata al sedile della sua auto pur di non darla vinta all’anziana nella vettura di fronte, con a bordo un’ipnotica Elena Cotta; Xavier Dolan nel suo “Tom à la ferme” deve combattere da solo i suoi fantasmi; Judi Dench e Steve Coogan in “Philomena” (Stephen Frears) si contendono l’un l’altro l’attenzione a suon di battute; Christoph Waltz è un’eremita agorafobico in “The Zero Theorem” (Terry Gilliam); Sandra Bullock in “Gravity” (Alfonso Cuarón) lotta da sola nello spazio.
Con questi precedenti capirete perché la mia curiosità nel trovare somiglianze non si arresti. Senza ulteriori indugio vi mostro il frutto dei miei voli pindarici post visione.
Con la speranza di incentivare qualche lettore a recuperarlo comincio dal documentario di Franco Maresco “Gli uomini di questa città io non li conosco-Vita e Teatro di Franco Scaldati” (Fuori Concorso). Franco Scaldati è stato un ‘attore teatrale, un regista teatrale, autore ma soprattutto poeta. A due anni dalla scomparsa Maresco omaggia colui che, pur avendo riportato in auge la Lingua Dialettale Palermitana, oggi non è che un estraneo agli occhi dei suoi concittadini. Inevitabilmente il significato del titolo viene ribaltato: è Palermo a non sapere più chi era Scaldati, come si deduce dall’inchiesta agli avventori nel foyer del teatro dove era solito esibirsi l’attore . Maresco sembra provocare per rivolgersi alle autorità cittadine affinché conferiscano il giusto riconoscimento ad un uomo che nella vita ha dato tanto, alla comunità e all’arte, senza ottenere molto in cambio. Una peculiarità del film è che il soggetto stesso, attraverso una vecchia video intervista, ne è l’effettiva colonna portante a cui immagini di spettacoli e filmati di repertorio fanno riferimento.
Stesso modus operandi che ha adottato Gianfranco Pannone, “L’Esercito più piccolo del mondo”(Fuori Concorso). Alle riprese di alcuni ragazzi durante l’addestramento per diventare Guardie Svizzere in Vaticano, il regista alterna, o accompagna sottoforma di voice over, le loro testimonianze rilasciate di fronte all’obbiettivo. Pannone riesce a dar voce ai loro pensieri dandoci la sensazione di leggere le pagine di un journal intime: riflessioni di teologia, sulla società odierna, la precarietà dovuta alla disoccupazione, il dilemma se abbandonare o no il proprio paese per costruirsi delle possibilità all’estero che altrimenti sarebbero impensabili.
Da qui non posso non collegarmi al film di Adriano Valerio, “Banat- il Viaggio” (sezione: 30° Settimana della Critica). Con non poche rinunce il protagonista, impersonato da Edoardo Gabriellini, lascia Bari per trasferirsi a Banat, in Romania. Qui vi ha trovato il lavoro dei suoi sogni e dopo tanti anni di precariato decide di abbandonare amici, e forse un nuovo amore che potrebbe nascere, per dedicarsi a ciò che lo potrà rendere finalmente appagato. Non appena si stabilisce nell’agglomerato di case, circondate da vallate deserte e fredde, inizia a non porsi più tante domande sul perché la gente del posto fugga per cercare futuro (ironia) in Italia. La metafora del cane che si morde la coda è calzante (non a caso nel film un cane fugge senza far più ritorno). Presentato alla Settimana della Critica, non solo per la tematica ma anche per le sue qualità nascoste. Immergendo i personaggi nella nebbia e nei paesaggi desolati di Banat, il regista Valerio sembra rifarsi alla corrente della nouvelle vague per trasportare lo spettatore all’interno della testa dei pensieri dei personaggi che pone costantemente, e vividamente, di fronte a dei bivi: proseguire un sentiero con lo scopo di realizzarsi attraverso ciò che ti gratifica, oppure arrendersi al fato e lasciarsi sconfiggere dai luoghi comuni?. Questo fa intendere quanto il sottotitolo, il viaggio, alluda a un percorso mentale dove o si matura e si diventa adulti o si viene fagocitati dall’avversità della vita.
Al futuro invece sembrano non pensarci proprio i due coprotagonisti di “Non Essere Cattivo” per la regia di Claudio Caligari. Malgrado il film Fuori Concorso, calato in un’atmosfera anni ’90, ci mostri le scorribande di due amici legati da spaccio e dal consumo di stupefacenti, lo spettatore non riesce a non simpatizzare per loro. Questo è reso possibile dall’umanità che traspare dalla scrittura dei personaggi, prima ancora che dalla regia, e reso credibile dall’ottima interpretazione dei due interpreti: Luca Marinelli , Cesare, e Alessandro Borghi, Vittorio.
In quanto membro della giuria ho potuto contribuire in prima persona all’assegnazione al film del 22° Premio Collaterale FEDIC. E come se non bastasse il successo della critica, ha potuto fregiarsi di essere segnalata, senza purtroppo esito positivo, di rappresentare l’Italia nella candidatura per il Miglior Film Straniero agli Oscar 2016.
Un marchio conosciuto e che ci rappresenta già nel mondo è quello dell’Harry’s Bar. In “HARRY’S BAR” (Evento Speciale) la regista Carlotta Cerquetti ripercorre la storia dell’attività del ristorante fin dalla fondazione, 1932, all’espansione odierna con sedi nelle principali metropoli. Un mio modesto parere è che se si fosse limitata a raccontare il legame storico tra il celebre locale Veneziano e gli ospiti delle edizioni passate della Mostra del Cinema di Venezia, il film ne avrebbe trovato sicuro giovamento. Invece l’avvicendarsi di aneddoti storici raccontati alla rinfusa senza un ordine preciso, le interviste a clienti vip e la ripetitività di certe immagini, mi hanno dato l’impressione di assistere a un lungo spot commerciale. Ho ritenuto curioso infine che un video che celebra un’azienda a conduzione famigliare, di famiglia ne mostri poca con ogni componente ripreso singolarmente dall’obbiettivo.
Renato De Maria in “Italian Gangsters”(sezione Orizzonti) adotta la stessa scelta registica ma in maniera ben più consona al soggetto. Ci racconta “le gesta” di sei banditi ripercorrendo la storia del nostro paese dalla ripresa post bellica fino agli anni di piombo. La peculiarità di quel che si direbbe esser un semplice documentario sta nell’alternare immagini di repertorio ai volti di sei interpreti (Ezio Barbieri, Paolo Casaroli, Pietro Cavallero, Luciano De Maria, Horst Fantazzini, Luciano Lutring). Dislocati in un luogo oscuro e vuoto, illuminato unicamente da una fonte di luce proveniente dall’alto, con la cinepresa che inquadra sempre frontalmente, si ha la sensazione di trovarsi di fronte a sei ectoplasmi.
Sono rimasta un po’ interdetta dal tentativo di umanizzare dei ladri e degli assassini, facendoli passare solo come dei ragazzi che hanno preferito intraprendere strade più semplici delle altre (il furto e l’omicidio piuttosto che il lavoro sottopagato in fabbrica e la fame) per vivere. Ma non si discute che il regia sia riuscito a creare un interessante gioco di simmetrie tra la realtà dei fatti del passato e la finzione ambientata in uno studio di posa.
Se De Maria ha prelevato a piene mani dagli Archivi Luce e di Cinecittà, il regista Alberto Caviglia ha attinto unicamente dalla sua fantasia nel realizzare un mockumentary dal titolo “Pecore in Erba” (sezione Orizzonti). Caviglia inscena un’irriverente satira attraverso la tecnica narrativa del foto romanzo, genere considerato datato, per affrontare temi attuali come la xenofobia e la lotta all’antisemitismo. Un film controverso e che ha fatto discutere molto.
Come non è stato recepito positivamente la risoluzione del film di Luca Guadagnino “A Bigger Splash” In Concorso, ma non sarò certo io a rivelarvela. A parer mio è stato sottovalutato dalla critica e acquisterà notorietà col tempo non solo per la prova recitativa di due interpreti (Tilda Swinton e Ralph Fiennes) ma anche per la sagacia della sceneggiatura. La tavola da pranzo e la piscina sono i due luoghi deputati mentre l’isola di Pantelleria è il palcoscenico dove Guadagnino mette in scena la sua commedia nera. Ci distrae con le vicissitudini di una coppia in preda alle tentazioni carnali per portare alla nostra attenzione la drammatica situazione degli sbarchi dei profughi lungo le nostre coste. Sebbene l’intento sia nobile forse è il metodo che non ha trovato un riscontro unanime tra il pubblico del Lido.
Caviglia e Guadagnino non sono gli unici che hanno affrontato temi caldi dell’attualità. Nel corto di Alice Rohrwacher, “Des Djess” (Sezione: Women’s Tales), degli indumenti trascinati a riva dalla corrente del mare vengono raccolti sul bagno asciuga, richiamandoci alla mente le vittime del Mediterraneo.
Giovanni Aloi nel suo cortometraggio dal titolo “E.T.E.R.N.I.T.” offre invece uno spaccato di vita di un emigrato insediatosi in Italia: lontano dalla famiglia, mantenuto (apparentemente) da una prostituta, l’uomo rimuove le lastre di eternit mettendo costantemente a repentaglio la sua salute. Ma non ha altra scelta, sembra che quello sia il meglio che sia riuscito a trovare per vivere.
Anche il marito di Anna, rispettivamente Massimiliano Gallo e Valeria Golino, nel film di Giuseppe M. Guadagnino “Per Amor Vostro”, non fa il più nobile dei lavori. L’uomo si disinteressa delle conseguenze che potrebbero ricadere sulla propria famiglia, che sta andando letteralmente incontro ad un ciclone.
Anna è un personaggio sfaccettato: non si impedisce di sognare ma al contempo affronta la vita senza aspettative, è forte ma al contempo fragile e condizionabile proprio in quanto sognatrice. Ed è proprio la visionarietà delle parti oniriche a caratterizzare la pellicola, seguita dalla scelta della fotografia in bianco e nero e dalla canzone popolare che si fa voce narrante. Il ruolo ha valso il Premio Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Femminile a Valeria Golino. Trovo significativo che, in un edizione dove il tema della comunicazione genitori-figli è ricorso spesso, abbia prevalso l’interpretazione di un personaggio che dialoga col figlio sordo muto attraverso il linguaggio dei segni.
Nell’ispirato lungometraggio di Carlo Lavagna, “Arianna”, l’altrettanto ispirata interprete ,Ondina Quadri, indossa i calzoncini e la canotta di una ragazza che vede stagliarsi un muro invalicabile tra lei e i suoi genitori. Il padre (Massimo Popolizio) ha da sempre vantato una certa complicità con la sua unica figlia ma adesso si è creata un’irreversibile situazione di stand- by. Arianna ha il timore di confrontarsi perché ha paura di conoscere già la risposta: in lei c’è qualcosa di sbagliato. Nessuno sembra intenzionato a svelarle un segreto inconfessabile da sempre nascosto, ma pare che il problema stia riaffiorando a galla affliggendo la ragazza già alle prese con i primi turbamenti adolescenziali e ormonali.
La battuta iniziale di Arianna, “Sono nata due volte”, potrebbe essere il sottotitolo che si confà a questo racconto cinematograficamente coraggioso, innovativo e che tratta un tema affatto facile con il quale iniziare una carriera da cineasta perché inevitabilmente crei aspettative. Vedremo se si è trattato solo di un caso isolato.
L’esordiente alla regia, Piero Messina ne “L’Attesa” cala Juliette Binoche nei panni di una madre che non confessa cosa è capitano al figlio alla ragazza di quest’ultimo venuta in visita in Sicilia. Il film omaggia i profumi, i colori, la tradizione, soprattutto culinaria (grazie ai continui riferimenti, visivi e non, alla tavola e alla rilevanza che viene attribuita alle pietanze, al film è stata assegnata la 2° Menzione Fedic –Il Giornale del Cibo) di questa terra tanto da renderla quasi un personaggio a tutto tondo e in carne ed ossa. La terra madre che offre i suoi frutti ma che al contempo ci toglie per sempre gli affetti più cari.
Una madre che stringe la mano del figlio e un uomo che vede il fratello gemello recentemente scomparso. Marco Bellocchio in “Sangue del Mio Sangue” sembra dialogare con una scena de L’Attesa: dalla morte non si fa ritorno se non in qualche sogno ad occhi aperti. Nell’arco di due episodi il regista contempla e lascia contemplare la vacuità dello scorrere del tempo di fronte all’indissolubilità della fede di rinascere a nuova vita.
Ne “La Prima Luce” , regia di Vincenzo Marra, due genitori si contendono l’affidamento del figlio. Il regista decide di rimanere super partes dando allo spettatore la possibilità di comprendere cosa spinge una madre costretta in terra straniera a portare via con sé il figlio nella sua terra natia, e cosa muova le azioni di padre deciso a tutto pur di riprenderselo.
“Viva la Sposa” Ascanio Celestini ne è il regista, l’autore del racconto che ha ispirato il film ed interpreta un padre scapestrato che pretende di insegnare al figlio come si sta al mondo, quando lui è il primo a vivere di stenti. I destini di personaggi (come direbbe Emile Zolà nel ciclo Rougon – Macquart) tarati si intrecciano nella periferia di Roma con conseguenze imprevedibili.
“Milano 2015”, Cinque corti, cinque visioni differenti della metropoli lombarda attraverso gli occhi di Elio , Roberto Bolle, Silvio Soldini, Walter Veltroni, Cristiana Capotondi e Giorgio Diritti.
Questi sono i fili conduttori più significativi che mi sono sentita di condividere. Mi congedo riportando una foto scattata al Padiglione Italia con cui potete farvi un’idea della cospicua presenza dei cineasti italiani nell’edizione 2015. Alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, ai prossimi fils-rouge.
Carlotta Bruschi
(Corte Tripoli Cinematografica)
.
A VENEZIA RIAFFIORA IL CINEMA INVISIBILE
di Vittorio Boarini
La 72. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ci ha offerto nuovamente , con la ormai consolidata sezione Venezia Classici, l’occasione di riflettere sulla Storia del cinema e sul suo enorme patrimonio, del quale riusciamo a immaginare l’ampiezza e l’importanza assistendo al riaffiorare di significativi reperti. Questa sezione, infatti, inaugurata nel 2012 e continuamente arricchita in seguito, presenta ogni anno una serie di classici restaurati accompagnata da una rassegna di documentari sul cinema, le sue tendenze e i suoi protagonisti. Quest’anno, inoltre, ha registrato una felice variante, vale a dire la Carte blanche data a Bertrand Tavernier, Leone d’oro alla carriera 2015, che ha scelto quattro classici da inserire nella rassegna, costituita da sedici film, tutti recentemente restaurati.
La selezione di Tavernier ci ha concesso di rivedere, in un’ottima copia restaurata dalla Cineteca nazionale nel laboratorio bolognese L’Immagine Ritrovata, “La lupa”, girato da Alberto Lattuada a Matera nel 1953. Il film, alla cui sceneggiatura mise mano anche Alberto Moravia, è tratto dall’omonimo racconto di Giovanni Verga e fu giudicato assai severamente dalla critica. Rivisto oggi, evidenzia la necessità di recuperare il cinema del passato poiché rappresenta un momento non trascurabile della poetica di Lattuada centrata su una figura di donna, la lupa appunto, ben interpretata da Kerima, realisticamente connotata da un’animalità arcaica, torbida e misteriosa. Notevole anche “Sonnenstrahl “ (“Viva la vita!”), di Paul Fejos, un ungherese avventuroso, esponente del folto gruppo che costituì la temperie culturale di Vienna, Berlino, Hollywood, per usare il titolo della bella rassegna prodotta nel secolo scorso proprio dalla Mostra veneziana. Il film infatti fu realizzato a Vienna, dove Fejos era tornato dopo un lungo soggiorno americano, nel 1933 e rappresenta un’opera significativa della sua filmografia, anche se non raggiunge il livello di “Lonesome”, 1928, unanimemente considerato il suo capolavoro. Né possiamo tacere dell’interessantissimo “A Matter of Life and Death” (“Scala al paradiso”), dei grandi sperimentatori Powell e Pressburger, un’opera del 1946 che anticipa, con il suo viaggio nell’altro mondo, molte soluzioni tecniche del successivo cinema fantascientifico. Infine, “Pattes blanches” (Zampe bianche, traduzione letterale), di Jean Grémillon, che avevamo visto al Cinema Ritrovato di Bologna nel 2012 e ammirato per come il regista rende esemplarmente, in quest’opera del 1948, la cupa disperazione ontologica di Jean Anouilh, che è uno degli sceneggiatori.
 In quanto alle opere scelte dalla Mostra, dobbiamo intanto apprezzare sia l’ampio spettro di cinematografie nazionali da esse rappresentato sia l’arco temporale in cui si collocano tali opere, un arco che va dal 1932, “The Trial of Vivienne Ware” (Il processo di Vivienne Ware,trad. lett.), di William K. Howard, al 1990, “To Sleep with Anger” (Dormire con rabbia, trad. lett.), di Charles Burnett. Di Howard, un autore americano con all’attivo più di venti film, girati fra il 1921 e il 1946, e presto dimenticato, è stato presentato anche “The Power and the Glory” , girato l’anno successivo e interpretato da un giovane e bravissimo Spencer Tracy. Il film, che in Italia fu distribuito con il titolo “Potenza e gloria”, non solo è linguisticamente innovativo, tanto che non fu compreso dai contemporanei, ma può essere considerato un’anticipazione del capolavoro di Orson Welles “Quarto potere”. Sempre a proposito del cinema americano e dell’apporto giunto ad esso dall’Europa, abbiamo anche potuto rivedere il primo film a colori, nonché ultimo capolavoro, di Ernst Lubisch “Il cielo può attendere” (“Heaven Can Wait”, 1943). Spiare la vita erotica raccontata dalla protagonista (Gene Tirney) al demonio, che non la ritiene degna dell’inferno, ha rafforzato la nostra ammirazione per questo americano venuto da Berlino e per il suo “tocco”.
In quanto alle opere scelte dalla Mostra, dobbiamo intanto apprezzare sia l’ampio spettro di cinematografie nazionali da esse rappresentato sia l’arco temporale in cui si collocano tali opere, un arco che va dal 1932, “The Trial of Vivienne Ware” (Il processo di Vivienne Ware,trad. lett.), di William K. Howard, al 1990, “To Sleep with Anger” (Dormire con rabbia, trad. lett.), di Charles Burnett. Di Howard, un autore americano con all’attivo più di venti film, girati fra il 1921 e il 1946, e presto dimenticato, è stato presentato anche “The Power and the Glory” , girato l’anno successivo e interpretato da un giovane e bravissimo Spencer Tracy. Il film, che in Italia fu distribuito con il titolo “Potenza e gloria”, non solo è linguisticamente innovativo, tanto che non fu compreso dai contemporanei, ma può essere considerato un’anticipazione del capolavoro di Orson Welles “Quarto potere”. Sempre a proposito del cinema americano e dell’apporto giunto ad esso dall’Europa, abbiamo anche potuto rivedere il primo film a colori, nonché ultimo capolavoro, di Ernst Lubisch “Il cielo può attendere” (“Heaven Can Wait”, 1943). Spiare la vita erotica raccontata dalla protagonista (Gene Tirney) al demonio, che non la ritiene degna dell’inferno, ha rafforzato la nostra ammirazione per questo americano venuto da Berlino e per il suo “tocco”.
Si deve anche notare che nella rassegna non mancano i capolavori, o almeno riconosciuti tali nelle storie del cinema, dal classico sovietico del 1938 “Aleksandr Nevskji, di S. M. Ėjzenštejn, all’indimenticabile “Amarcord” di Federico Fellini (1973). Aggiungerei “Akahige” (“Barbarossa”) di Akira Kurosawa, che nelle monografie dedicate al regista giapponese non viene considerato fra le sue opere maggiori. Riprendendolo ora in considerazione, mi azzardo a rivedere il giudizio consolidato, d’altra parte la riproposta dei classici in edizioni filologicamente e tecnicamente ottimali ha anche il compito di rimettere in discussione le opinioni acquisite storicamente, e a collocare “Barbarossa” se non tra i massimi capolavori del grande regista quantomeno fra i suoi film esemplari.
Le considerazioni scaturite dalla rivisitazione di quest’opera del 1965, l’ultima di Kurosawa con Toshiro Mifune come protagonista ( poi si ruppe il sodalizio fra i due) , mi sono state confermate dalla visione del documentario dedicato a questa star di fama internazionale dal nippo-americano Steven Okazaki. “Mifune: the Last Samurai” (2015), infatti, è la storia di questo leggendario personaggio, che proprio con “Barbarossa” vinse il Leone d’oro a Venezia come migliore attore, dove, ovviamente, hanno una grande rilevanza i suoi rapporti con Kurosawa, rapporti ricostruiti in forma storicamente esemplare e tale da contribuire sostanzialmente alla comprensione critica e dell’ultimo samurai e del suo regista di riferimento.
Dal momento che abbiamo sconfinato nella rassegna dei documentari, otto per l’esattezza, riteniamo giusto citare almeno i due riguardanti il cinema italiano: “Alfredo Bini, ospite inatteso”, di Simone Isola, e “Dietro gli occhiali bianchi”, di Valerio Ruiz. Il primo è la vivida ricostruzione dell’attività di uno dei nostri più coraggiosi produttori (tutti i film di Pasolini fino a “Edipo re”) e l’accorato ricordo della sua solitaria fine nel Motel Magic, ospite del generoso Giuseppe Simonelli. Un film di ottima qualità e una spina nel fianco di tutti coloro che amano il cinema. Il secondo, invece, inquadra con rigore e affetto una delle più dotate autrici del nostro cinema, Lina Wertmüller, la prima donna ad ottenere una nomination all’Oscar per la regia. Da “I basilischi”, sua premiata (Locarno 1973) opera prima ai giorni nostri, soffermandosi su “Pasqualino settebellezze” (1975), considerato il suo capolavoro, il film delinea con originalità linguistica e avvalendosi di materiali inediti la figura di questa poliedrica cineasta che, fra l’altro, è stata aiuto di Fellini sul set di “Otto e mezzo”.
Ritorniamo ai classici e, prima di concludere, osserviamo che nelle premesse a un’auspicabile rivisitazione della Storia del cinema, ci sono parsi di estremo interesse i due film francesi “Le beau Serge” e “Léon Morin,prêtre” (“Léon Morin, prete”). L’uno, realizzato nel 1958 da Claud Chabrol, uno dei cinque fondatori della Nouvelle vague, e circolato in Italia col titolo “I cugini”, si è confermato come esemplare rappresentante di questa fondamentale tendenza della Neoavanguardia europea; l’altro, dovuto al prestigioso Jean-Pierre Melville, che lo girò nel 1961 scegliendo come protagonisti il bravissimo Jean-Paul Belmondo e l’affascinante Emmanuelle Riva, ha una straordinaria tenuta nel raccontare una vicenda teologico-esistenziale in un contesto storico-politico (la Francia occupata dai nazisti e la sua liberazione) di grande impatto emotivo. Dobbiamo anche sottolineare la buona qualità dei restauri, tutti effettuati digitalmente, anche quelli realizzati in paesi, come l’Argentina e la Turchia, che non hanno una tradizione in questo settore.
Infine l’Italia che, oltre al citato “Amarcord”, era rappresentata dal film di Mario Monicelli “Vogliamo i colonnelli”,1973, “una vera farsa alla Keaton”, come egli stesso la definisce, magistralmente interpretato da Ugo Tognazzi, e dal celebre “I mostri”, 1963, ritratto feroce nella sua incisiva comicità dei caratteri tipicamente italiani, realizzato dal maestro della commedia Dino Risi. Chiudeva degnamente la selezione “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, l’opera postuma di Pier Paolo Pasolini, di cui si commemora in questi giorni il quarantennale della morte. Siamo stati felici che il film abbia vinto il Leone d’oro per il miglior restauro (curato dalla Cineteca di Bologna) perché è la prima volta che ottiene un riconoscimento questa pellicola perseguitata dalla censura quanto lo fu il suo autore dal potere e praticamente resa invisibile fino ad oggi. A quarant’anni dalla sua realizzazione, grazie anche alla Mostra veneziana, il testamento del poeta assassinato sarà finalmente nelle sale e il pubblico potrà giudicare serenamente l’ approccio crudele di Pasolini al moderno collocato in un contesto ispirato all’opera del Marchese de Sade e ambientato nella Repubblica di Salò. Buona visione a tutti.
.
.
SE DICI CORTO? “SEDICICORTO”
di Francesco Saverio Marzaduri
La XII edizione del Sedicicorto International Film Festival si è tenuta a Forlì dall’8 al 17 ottobre 2015. I cortometraggi iscritti e provenienti da 117 paesi sono stati 4.069: 215 quelli selezionati e suddivisi in quattordici sezioni, quattro delle quali competitive – “Movie,” “Cortitalia,” “AnimaLab,” “Animare” – e dieci collaterali – “Cortoinloco,” “Express,” “Cortopolis,” “Illuminami: La forza della luce,” “La forza delle donne,” “Experia,” “Focus Olanda,” “Focus Croazia,” “EuroShort” e “Autour de Minuit”.
Sezione “Cortoinloco”
Ricca di avvenimenti, fra cui meeting con gli autori, workshop, tre concorsi, quarantadue ospiti e novità nel campo dell’educazione al linguaggio cinematografico, l’edizione 2015 ha visto la partecipazione di oltre novemila spettatori alle diverse rassegne in programma.
Una particolare attenzione è stata riservata a bambini e ragazzi con appuntamenti e proiezioni a loro dedicati. Cinque le giornate del progetto Scuola Educazione Immagine (S.E.I.), di durata annuale e composto da sette laboratori di cinema d’animazione, tre attività di cineforum, critica e due mostre artistiche. Al progetto hanno collaborato l’Atelier del Cartone animato e le associazioni Artincanti, Mosè e OTTOmani: ai rispettivi rappresentanti il compito d’introdurre alcune delle dodici opere realizzate dalle scuole del territorio forlivese, proiettate nella prima giornata del festival, e illustrare le tecniche impiegate.
Del progetto S.E.I faceva parte anche la sezione “Cortopolis,” quattro giornate dedicate ai ragazzi delle scuole superiori, con otto shorts incentrati su tematiche vicine al mondo giovanile, e numerosa è stata la partecipazione delle scuole del comprensorio di Forlì.
Inoltre, il laboratorio di Teoria e Tecnica di Produzione Audiovisiva, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale “Mass Media e Politica,” ha presentato il video “Grande Capo,” format sulla leadership e il consenso che gli studenti – sostenuti dai docenti Davide Savelli e Matteo Lolletti – hanno prodotto e realizzato la scorsa primavera.
L’altra novità è stata la creazione del Campus Internazionale “EuroShort,” due giornate in cui esperti del settore – il menzionato Savelli, Jacopo Chessa, Andrea Martignoni, Rita Capucho e Ismael Martín – hanno tenuto seminari sulla situazione del mercato europeo del cortometraggio, sulla produzione e distribuzione dei corti, una tavola rotonda e sessioni di pitch training. Relativamente a quest’ultimo, i giovani registi stranieri e italiani partecipanti si sono cimentati nel “Pitching,” la presentazione del proprio progetto audiovisivo agli addetti ai lavori; l’iscrizione era gratuita e prevedeva un premio di 1.000 € per il vincitore, più un programma distributivo internazionale.
Tre i concorsi presenti al festival: l’artistico “Illuminami,” promosso dal Gruppo Hera e rivolto agli studenti del Liceo Artistico e Musicale Statale (FC); il fotografico “Cliccorto,” indetto dal Cineclub “Sedicicorto” e aperto sia al pubblico che agli addetti ai lavori presenti al festival; infine “Storie di Cinema,” concorso di scrittura sotto il segno della critica cinematografica, diviso in due categorie, ragazzi e adulti, e promosso dall’azienda di telefonia ZAL.
Per quanto concerne la vera e propria competizione, sabato 17 ottobre, serata conclusiva del festival, sono stati premiati i vincitori delle sezioni in concorso e i film che maggiormente si sono distinti nelle sezioni collaterali. Selezionato lo scorso luglio da una giuria di centoventicinque bambini e ragazzi, durante la rassegna “Animare” a Cesenatico, il miglior corto d’animazione dell’omonima sezione è stato “Cuerdas” dello spagnolo Pedro Solís García, storia di un’amicizia che vince le barriere della disabilità.
Per la sezione “AnimaLab” si è aggiudicato il premio “Mi ne mozem zhit bez kosmosa” del russo Konstantin Bronzit, protagonisti due inseparabili amici cosmonauti che dividono la vita e la morte. Menzioni speciali a “Däwit,” del tedesco David Jansen, e “Isand,” dell’estone Riho Unt.
Il premio per la sezione “Cortitalia” è andato a “Child K” di Roberto De Feo e Vito Palumbo, tratto dalla storia vera di una coppia di contadini tedeschi e di una tragica lettera indirizzata a Hitler. Lo short ricorda lo sterminio dei disabili imposto dal Führer e avviato nel 1939. Il Child K del titolo altro non è che la sigla impiegata per catalogare la morte del piccolo Gerhard Kretschmar, avvenuta il 25 luglio del ’39, ufficialmente la prima vittima dell’eutanasia tramite gas, barbarie perpetrata fino al ’41 che causò oltre 70.000 morti tra adulti e bimbi disabili, fisici e mentali.
Per la sezione “Movie,” il premio è stato assegnato a Just Philippot per “Ses souffles”. Lizon è invitato al compleanno di Marie. Lei è in comprensibile ansia: gli ospiti, la torta, le candeline, la cerimonia. Lizon desidera lo stesso per la festa dei suoi nove anni, mentre la ragazzina vuole solo condividere la torta con le candele insieme agli amici. E il fatto che viva in un’automobile sembra non costituire un problema per l’altro…
Menzioni speciali a “Ou je mets ma pudeur” del francese Sébastien Bailly e “Hole” del canadese Martin Edralin.
La sezione “Cortoinloco,” riservata ai registi romagnoli, quest’anno è stata intitolata alla memoria del regista e produttore cinematografico Gian Vittorio Baldi, originario di Lugo e scomparso lo scorso marzo. Il pubblico in sala ha assegnato il trofeo “LumìnOR” al film “Nevica” di Lu Pulici: il cortometraggio, che conta tra gli interpreti Gina Gattei, Ferruccio Crociani ed Ebano Corelli, racconta la bellezza presente nella vicenda di Nina, l’anziana protagonista. Una storia in apparenza semplice, che in realtà tratta un sentimento universale e comune a tutti, l’amore. Può l’umore di qualcuno mutare il tempo? Il sole non illumina il paese da ormai quaranta giorni, così pure lo stato d’animo di Nina non è più lo stesso. Il comportamento dell’anziana signora sembra nascondere qualcosa di più enigmatico e profondo, né le persone a lei più care riescono a comprendere i motivi di tale malessere, e nel frattempo il cielo in paese si fa sempre più opaco… Oltre al riconoscimento, il film – prodotto dalla Lumaca Film e girato tra Pennabilli e Roma – parteciperà ad un progetto distributivo internazionale previsto per il 2016.
Il premio intitolato alla memoria dello storico forlivese Gilberto Giorgetti è stato assegnato al citato “Hole,” audace ritratto di un disabile di mezza età, Billy, desideroso di rapporti umani in un mondo che preferirebbe ignorarlo. Mentre quello del pubblico, intitolato alla memoria del giornalista Enrico Zavalloni, è andato al francese “À l’amiable” di Rémy Cayuela: in questa cinica commedia noir, i protagonisti Guillaume e Caroline, sull’orlo della separazione, si giocano a dadi in salotto le loro proprietà, figlio compreso, prima di convincersi che la nascita di quest’ultimo ha causato la rottura del proprio ménage. Ciò li induce a far i conti con le insospettabili risorse e capacità di resistenza del ragazzino…
Il vincitore della categoria “Italian Short,” scelto dallo staff del cineclub “Sedicicorto” per la sua connotazione internazionale, è andato a “Mala Vita” di Angelo Licata. Habitué della gattabuia, Antonio il “Camaleonte” vive da tempo la cella, sempre la stessa, come fosse casa sua. Tornatoci un’ennesima volta scopre che il nuovo arrivato, un camorrista che ha preso possesso del letto usualmente occupato da lui, tiranneggia i compagni con prepotenza; tocca al protagonista giocare il rivale con l’abilità e l’astuzia che gli sono congeniali.
Ancora, il premio “University,” assegnato dai quindici studenti che hanno tradotto e sottotitolato i film in concorso, è andato all’iraniano Mostafa Atashmard per il documentario “We are here Mogadisciu”. Un ragazzino somalo, Abdullah, racconta delle condizioni in cui versa il proprio Paese, la guerra civile, la povertà, le malattie. E del suo sogno, à la Truffaut, di vedere il mare.
Vince per la sezione “EuroShort Network”– giuria composta dai festival di nove paesi europei – il corto “Getting Fat in Healthy Way” del bulgaro Kevork Aslanyan. Una favola ambientata in una Russia post-comunista senza una stabile gravità a causa di un incidente scientifico, dove le persone che pesano meno di 120 chili fluttuano in aria. Constantine, che ne pesa 60, è costretto a vivere segregato in casa insieme al padre Atanas, finché l’amore non cambia la sua esistenza.
Il premio “Corte Tripoli,” assegnato dai soci dell’omonimo cineclub di Pisa, è andato a “Due piedi sinistri,” per la regia di Isabella Salvetti, ironico prodotto avverso alla discriminazione, in questo caso nei confronti di una ragazzina sulla sedia a rotelle attraverso l’atavica rivalità tra romanisti e laziali.
Il premio per la miglior commedia è stato assegnato a “După ce dinozaurii au dispărut,” della romena Mihai Ghiţă, arguta commedia che mira a rivelare pudori e tabù di una società, quella romena, e delle sue persistenti difficoltà su come spiegare la sessualità ai bambini.
Al termine delle premiazioni, il direttore artistico del festival, Gianluca Castellini, ha annunciato la prossima edizione, che si terrà come sempre a Forlì dal 7 al 16 ottobre 2016.
.
.
SEDICICORTO 2015: RECENSIONI CORTITALIA
(Le recensioni sono a cura della Rivista on-line “Carte di Cinema”)
Francesco Saverio Marzaduri
“A Ciambra” di Jonas Carpignano – Suddiviso in due blocchi contrapposti, questo piccolo film segue il percorso di maturità, in poche ore, di un rom di undici anni. A una prima metà notturna e concitata, ove l’alienante violenza è strumento necessario per la sopravvivenza di Pio nella quotidianità e nel degrado di questa, ne segue una seconda più dilatata: qui a contare è l’introspezione psicologica – suggellata dall’uso frequente di primissimi piani – e il passaggio, doloroso quanto immediato, verso l’età adulta. Più che “Rocco e i suoi fratelli”, il corto di Carpignano coniuga la poetica di Truffaut, e lo sguardo cinematografico in generale sull’infanzia, con la realtà della delinquenza e del malaffare in stile “Gomorra”. E la mente torna agli olvidados di Buñuel.
“Bloodhound” di Tommaso Landucci – Chi ha visto il recente The Reach – Caccia all’uomo, non dovrebbe avere difficoltà nel ritrovare analoghi topoi anche in questo breve film, firmato da Tommaso Landucci. In realtà, lo schema cacciatore-preda è obsoleto quanto il pattern della natura ostile, pervasa da un sostrato di nero favolistico. Se non si prende troppo sul serio ci si abbandona al divertimento, giacché gli ingredienti figurano tutti. Non sviluppata sino in fondo, invece, è la psicologia dei protagonisti – ne fa spese soprattutto il personaggio di Donadoni – risultando appena abbozzata e sbrigativa.
“Detours” di Nico Bonomolo – Il collaudato gioco delle scatole cinesi è la chiave interpretativa di questa piccola, semplice idea: una palla da biliardo al centro di una serie di parentesi, a loro volta spunti per tante situazioni casuali. Una matrioška in forma di mini-favola improvvisata, con la palla destinata a tornare al punto di partenza, che le ruvide animazioni di Nico Bonomolo – memore di Luzzati e di Toccafondo – trasformano in un effettivo “quadro in movimento.” Eppure, non ci si sottrae all’impressione del déjà vu. Suadente l’accompagnamento al piano di Gioacchino Balistreri.
“How I Didn’t Become a Piano Player2 di Tommaso Pitta – Umorismo tipicamente british, cui l’italiano Tommaso Pitta rende affettuoso omaggio proponendo una vicenda paradossale, tratta dal racconto Every Good Boy di David Nicholls, al cui centro è un occhialuto enfant prodige del pianoforte. L’innato talento del piccolo Ted di nove anni – genio sorprendente dei tasti alla maniera di un Glenn Gould – non trova riscontro in famiglia; né è compreso dall’anziana insegnante, Mrs. Chin, la cui improvvisa dipartita è innesco per una nuova (definitiva?) vocazione. Simpatica favoletta sul percorso della maturità ove l’assurdo delle situazioni fa il paio col loro rovescio, rimarcato dalla voce fuoricampo del protagonista divenuto adulto.
“La valigia” di Pier Paolo Paganelli – “Da quanto tempo sono qui? Una settimana, dicono,” è la battuta-tormentone che il protagonista del film, realizzato da Pier Paolo Paganelli con un’animazione in plastilina e stop motion, costantemente declama tra le quattro misere mura di una stanzetta. In quest’anomala favola carceraria, dove la prigione è quella della mente, il flusso di coscienza del personaggio – scandito dal monologo di una voce fuoricampo – muta progressivamente a ritroso, trasformandolo da vecchio in infante attraverso l’atipica macchina del tempo indicata dal titolo. Le quattro voci prestate all’operazione (Roberto Herlitzka, Rodolfo Bianchi, Riccardo Suarez e Alex Polidori) sottolineano egoismi e rimorsi di un’esistenza prossima al congedo, che l’ultimo fotogramma, riecheggiante Welles, immortala al capezzale di un anziano: nella sua mano l’istantanea di due fratelli bambini, testimonianza dolorosa ed estrema.
“L’impresa” di Davide Labanti – L’abbiamo visto affrontato innumerevoli volte, il tema della fabbrica, al cui interno covano dissapori e frustrazioni, tornaconti personali ed egoismi interessati. Il breve film di Davide Labanti non si discosta dalla formula, e, in tempo di crisi, fa bene ricordarlo ulteriormente: dietro lo stratagemma dell’intrico thrilling, l’obiettivo della cinepresa fotografa l’interno di una piccola azienda a gestione familiare col piglio dell’inchiesta documentaristica, scrutando corpi e volti di chi vi opera e rispettivi malumori, contrapponendo due speculari concezioni di “famiglia.” Nonostante dimissioni e licenziamenti siano sempre in agguato, l’impresa del titolo – come suggerisce il fotogramma conclusivo sui titoli di coda – prosegue imperterrita.
“Mala vita” di Angelo Licata – Si noterà che buona parte dei cortometraggi presentati ruotano, più o meno, intorno a identici temi, quasi che a legare i prodotti fosse un indiretto fil rouge. Al pari de “La cella 0”, anche Mala vita è ambientato in un carcere: la feroce inchiesta di Esposito cede il passo a un apologo surreale e amaro, in cui il regista Angelo Licata concentra l’attenzione su un habitué della gattabuia. Un po’ Benigni di “Daunbailò” e un po’ Zelig (non per niente il suo soprannome è “il Camaleonte”), dietro l’apparenza di bravo ragazzo gioviale e spigliato, Antonio-Luca Argentero è il temibile Fato dai cui abili escamotage – in qualità ora di trasformista, ora di gambler – dipende l’esistenza di ognuno. Perfino quella di un giovane camorrista, il Francesco Montanari della serie tv “Romanzo criminale”. Convincenti gli interpreti, ma la confezione da fiction (produce la Rai) tradisce qualche volta l’esito. Indovinato il titolo e divertente lo storyboard a vignette sui titoli di coda.
“Sinuaria” di Roberto Carta – Gli ultimi giorni di detenzione, presso l’Asinara, del parrucchiere Michele, prima di poter tornare al proprio paese agli arresti domiciliari. Scontata quasi interamente la pena per furto, il giovane si trova di fronte a una difficile scelta: riabbracciare la fidanzata, di cui non ha più notizie, o rimanere nell’isola e contentare le affezionate clienti (tra cui la moglie del direttore del carcere). Non perfettamente riuscita la combinazione di paesaggi naturali e assunto poetico, riscattato tuttavia dal flusso di coscienza del protagonista, la cui voce off – rivolta alla compagna lontana – non nasconde il timore di abbandonare il luogo. Tale senso di malinconia pervade l’operina e ne determina l’esito. Bella fotografia di Roberto Cimatti.
Paolo Micalizzi
“Ahlem” di Alessandra Pescetta – “Ahlem” è il nome di una ragazza tunisina che lavora in un Centro d’accoglienza immigrati a Paternò (Sicilia). Le sue origini vengono evidenziate subito dalla regista che segue poi la sua vita all’interno della comunità di accoglienza in cui opera. Ma vengono evidenziati anche i sogni che rincorre insieme ad una sua coetanea. Un giorno viene annunciato al suo gruppo l’arrivo di una ventina di persone. Si prepara una festa dove ognuno porta delle pietanze, e viene imbandita una ricca tavolata. Ma nel mezzo dell’attesa, arriva una cattiva notizia: gli immigrati attesi sono dispersi. E con tristezza, la tavola viene sparecchiata. Un racconto, su una tragedia di grande attualità, essenziale e pieno d’umanità, fatto di sogni e speranze, che si avvale in alcuni momenti ,a significazione del presagio di un tragico avvenimento, della musica che Pier Paolo Pasolini utilizza ne “Il Vangelo secondo Matteo”, soprattutto nella sequenza della crocifissione e morte di Gesù.
“Due piedi sinistri” di Isabella Salvetti – Una piccola storia che punta sull’effetto sorpresa. Sia quando Mirko, il ragazzo che in un campetto gioca al pallone con dei coetanei andando a prendere il pallone caduto vicino ad un muretto scopre che la ragazza è su una sedia a rotelle sia quando, ad un certo punto della affettuosa conversazione, le dice di vergognarsi. Che sembra una frase, che si riferisce alla disgraziata situazione della ragazza e che invece ha risvolti di carattere sportivo. Per il resto, il racconto si sviluppa in maniera normale per un lavoro cinematografico, con buona fotografia e musica e corretta interpretazione dei giovani protagonisti.
“Io non ti conosco” di Stefano Accorsi – Esordio nella regia dell’attore Stefano Accorsi, che ne è anche il protagonista. Un debutto con una storia raccontatagli da un fioraio di Sanremo che l’autore si premura di ringraziare nei titoli di coda. Una storia dal sapore romantico che punta sulla presenza dell’attore affiancato da un altro volto popolare, la bella Vittoria Puccini. Ma l’interpretazione più riuscita, a nostro avviso, è quella di Gianfelice Imparato nel ruolo di un fioraio all’antica, ricco di far play e sentimento.
“L’attesa del maggio” di Simone Massi – Sguardi sulla vita contadina attraverso una persona che fa da filo conduttore al racconto, che si snoda con processioni, vita nelle miniere, lotte contadine: una vita fatta di duro lavoro. Un sentito omaggio al mondo contadino, ambientato nelle colline marchigiane. L’animazione di Simone Massi, autore consacrato da successi e dalla fiducia della Mostra di Venezia che da alcuni anni gli affida la sigla della prestigiosa manifestazione, si muove come un operatore che sta girando con la steady cam ,dandoci visioni che ci portano velocemente da una situazione all’altra. Costruendo in questo modo un racconto coinvolgente e ricco di emozioni.
“L’ultimo proiezionista” di Vito Palmieri – Siamo in una cabina cinematografica, si sta smontando il proiettore. E’ il momento epocale del passaggio dalla pellicola al digitale con le sale cinematografiche costrette dalla Legge ad adeguarsi con, purtroppo, la conseguente chiusura di molte sale. Un momento che viene raccontato da un vero proiezionista, Paolo Romagnoli, che per anni ha svolto quel lavoro in una sala cinematografica di provincia, simbolo di una situazione che si è verificata in tutt’Italia. Dalla sua storia scaturisce il racconto di una vita scandita dal cinema. E’ con “Un uomo, una donna” di Claude Lelouch(1966) che si dichiara alla futura moglie, è con “Un maggiolino tutto matto”(1969), come lui afferma, che in seguito alle risate la moglie ebbe le doglie. Certo, lezioni di aggiornamento, come il cortometraggio mostra, potranno portare i proiezionisti a svolgere il proprio lavoro con tanta capacità, ma rimarrà in chi l’ha svolto per tanti anni quel sapore nostalgico di un’epoca, fatta di tanti ricordi che sarà difficile non rimpiangere, come quello di trasportare le “pizze” con la bicicletta. Un corto che rende omaggio al lavoro dei “ vecchi” proiezionisti, cosi come Giuseppe Tornatore in “Nuovo Cinema Paradiso”(1988) lo ha reso alla sale cinematografiche di provincia che via via stavano fortemente scomparendo.
“Mathieu” di Massimiliano Cammaiti – Una commedia francese sul tema del lavoro e dell’amore. Sviluppata attraverso un simpatico protagonista che dall’essere sempre accondiscendente, sia nel lavoro che nella vita , non si accorge di ciò che c’è di vero attorno a lui, e cioè l’amore di una ragazza( la commessa del negozio accanto all’ufficio). Ed è la felicità.
“Sonderkommando” di Nicola Ragone – Un’opera su una drammatica pagina di storia, quella dei prigionieri ebrei trasportati nei lager nazisti. Ma anche un corto su una storia omosessuale. Siamo in un vagone merci che trasporta persone come bestie: c’è chi cerca di superare la situazione cucendo, chi piange, chi sviene, ma ci sono anche due uomini, un anziano e un giovane, che incrociano i loro sguardi. Ritroviamo tutte queste persone in un lager, dove la situazione è ancora più drammatica. Intanto gli sguardi tra i due sono più frequenti, ma il loro amore non si realizza e si concretizza soltanto in un bacio sospeso che accade in un certo momento del racconto. Le loro vite si dividono, e l’uomo più anziano farà parte del Sonderkommando e sarà anche costretto a mettere nel forno crematoio suoi compagni di prigionia. Un inferno, la cui atmosfera è resa molto bene dalla fotografia di Daniele Ciprì, molto incisiva. Da segnalare che il soggetto oltre che del regista è di Silvia Scola, figlia di Ettore che come Maestro del cinema viene ringraziato nei titoli di coda. Indicazioni che segnalano il Corto come un prodotto di alte ambizioni. Ed il risultato rende merito agli intenti.
“The child k” di Roberto De Feo e Vito Palumbo – Con Aktion 4 viene indicato il programma nazista di eutanasia che con l’assistenza medica ha portato alla soppressione, come viene ricordato al termine della vicenda raccontata nel cortometraggio di Roberto De Feo e Vito Palumbo di migliaia e migliaia di persone affette da malattie genetiche inguaribili, più o meno gravi malformazioni fisiche. Persone che erano considerate dal regime nazista “vite indegne di essere vissute”. L’opera dei due autori va alle origini di questa inumana decisione del Fuhrer raccontando come l’azione di eutanasia gli fu suggerita da una lettera inviatagli da un contadino tedesco ( siamo in Sassonia, nel 1937) tanto desideroso di avere un figlio che purtroppo non aveva potuto avere perché la moglie una volta partorisce un bimbo morto ed una seconda un mostro con la testa deforme e senza braccia , come quelli che i due autori ci fanno vedere nelle immagini fotografiche finali che mostrano bambini deformi. L’uomo se la prende con Dio per ciò che gli è accaduto e non trovando pace in quella che era diventata un’ossessione si rivolge al Fuhrer. Ha inizio una tragica pagina di storia dell’umanità. L’opera di De Feo e Palumbo si sviluppa con un racconto duro e realistico, dalle fasi essenziali. Facendone scaturire un’opera che coinvolge intensamente e umanamente lo spettatore.
Maurizio Villani
“All The Pain In The World” di Tommaso Pitta – Il film, in lingua inglese senza sottotitoli, è liberamente ispirato da un racconto breve di Michele Mari Tutto il dolore del mondo (pubblicato in Euridice aveva un cane, Einaudi. Torino 2004). Vi si racconta la storia di un anonimo protagonista che vede in una vetrina di un negozio di animali un piccolo pesce viola incastrato tra le finte rocce dell’acquario. Entra per comperarlo, ma il venditore gliene dà un altro, provocando una violenta reazione nell’acquirente che, in preda a crisi nevrotiche, alterna tranquilli stati d’animo a furiosi scoppi d’ira. Questo apologo su una piccola vicenda in cui si intende rappresentare una condizione tragica generale si chiude con il ritorno alla quiete della scena finale, in cui l’uomo fissa il vuoto, davanti al vaso dove galleggia inerte il piccolo pesce che era stato recuperato, senza però che potesse essere salvato.
“Corso Dante” di Gianni Saponara” – Il film è una denuncia, sobria ma penetrante e dolorosa, degli effetti letali dell’inquinamento ambientale prodotto da discariche abusive insediate in molte aree, soprattutto del sud d’Italia. Corso Dante è la strada del paese in cui è ambientato il cortometraggio lungo la quale sfilano i funerali che vanno dalla cattedrale al camposanto. La percorre anche il protagonista anonimo del film, chiuso dentro la bara trasportata dal carro funebre. La voce fuori campo esprime le riflessioni del defunto sul bilancio della propria esistenza malavitosa, che ha avvelenato il suolo con le sostanze tossiche delle discariche, causando la morte per leucemia di molte persone, tra cui – apprendiamo alla fine del film – lo stesso protagonista.
“Gas Station” di Alessandro Palazzi – Il film ha per protagonisti due profughi nord africani, che fanno i benzinai abusivi di notte in una stazioni di servizio nella periferia romana. Uno è un egiziano di mezza età, laureato in medicina, l’altro è un giovane marocchino. Durante le notti di lavoro capitano loro molti avvenimenti: fanno incontri casuali con persone più o meno disponibili, subiscono un fermo da parte di un poliziotto, ricevono in dono i più svariati oggetti che i clienti di passaggio lasciano come mance. Ai due benzinai abusivi non accade nulla di memorabile, solamente episodi di vita quotidiana banale, come è la loro condizione. Merito del film è quello di raccontare con efficacia una storia sobria, dignitosa e dolente.
“La Cella Zero” di Salvatore Esposito – Il documentario è una forte denuncia sociale delle condizioni disumane che a volte si presentano nei penitenziari italiani. “Cella Zero” descrive con impressionante realismo la vita dei detenuti nel carcere di Poggioreale a Napoli. Parlato in gran parte in lingua napoletana, con sottotitoli, il film ci presenta una serie di interviste fatte a carcerati e ad ex carcerati che narrano le angherie subite durante la reclusione. Molti primi piani di intervistati mostrano volti che, da soli, raccontano, più delle parole, storie di emarginazione e di violenze fatte e subite. Visivamente molto scioccanti sono le immagini che accompagnano le denuncia di una madre che riporta la drammatica vicenda del figlio detenuto, morto in carcere, ridotto a una maschera di sangue dai maltrattamenti inferti dalle guardie penitenziarie.
“Lazzaro vieni fuori” di Lorenzo Caproni – Prodotto dal Centro sperimentale di Cinematografia, “Lazzaro vieni fuori” è una fiction che affronta con delicatezza e misura il tema dell’omosessualità maschile. La vicenda narrata si svolge in una parrocchia, dove si sta per mettere in scena una sacra rappresentazione centrata sul miracolo della resurrezione di Lazzaro. Il protagonista invita alla recita un suo amico gay, Claudio, cui viene affidato il ruolo di Cristo. Le prove procedono tra le crescenti perplessità del parroco, che dapprima vorrebbe estromettere il giovane gay dalla recita, poi cambia idea e collabora alla riuscita dell’allestimento scenico, mettendo da parte ogni pregiudizio. Tra la soddisfazione di tutti Claudio compare tra gli attori, il cui commento è: “Sembra proprio Gesù”.
“Malaspazzatura” di Rita Rocca – Il documentario, presentato da RAI 3, denuncia le condizioni di estrema miseria economica e sociale delle plebi di Tegucigalpa, capitale dell’Honduras, cui non resta per sopravvivere che recuperare dalle grandi discariche che circondano la metropoli tutto quanto può essere utilizzato. Le immagini del film hanno una loro cruda potenza; il sonoro propone interviste in spagnolo, doppiate in italiano con sottotitoli in inglese. Il racconto mostra uomini, donne, bambini che lavorano tutto il giorno a contatto con rifiuti organici e inorganici, spesso cancerogeni. I raccoglitori sono controllati da membri di organizzazioni criminali che sorvegliano la gestione della manodopera. A questo mondo fortemente degradato si contrappongono, sul piano ambientale, la bellezza delle baie caraibiche ancora incontaminate e, a livello sociale, il mondo privilegiato delle classi ricche che abitano i quartieri eleganti.
“Pircantauri” di Buscaldi/Conigliaro/Fresta – Il pircantaturi è una figura della Sicilia tradizionale, ormai scomparsa da tempo, che aveva il compito di appostarsi davanti alla casa di un debitore insolvente per denigrare l’onore suo e dell’intera famiglia. Il corto di animazione racconta le disavventure che la comparsa del pircantaturi procura ad una coppia che vive in una assolata e deserta contrada del sud, dove regnano ancora gli arcaici modi di vita di un tempo. La bellezza del cortometraggio è data dall’esattezze formale dell’ambientazione, dalla raffinatezza della grafica, dai forti contrasti cromatici e da un appropriato accompagnamento musicale.
“Unfair Game” di Riccardo Leto – Racconto drammatico di un episodio ambientato in un paese di montagna durante l’occupazione tedesca nel corso della Seconda guerra mondiale, “Unfair Game” ha per protagonista un cecchino tedesco, la cui vera identità si rivelerà sorprendentemente sola alla fine del film. Lo sniper, per salvare la vita ad un bambino che sta per essere ucciso da un militare della Wermacht, spara al commilitone, sovvertendo così le regole di una guerra che gli deve apparire sempre più insensata e disumana. La narrazione filmica alterna nella prima parte momenti di forte tensione emotiva, sostenuti da un ritmo incalzante, e momenti di intensa partecipazione umana che nel finale coinvolgono il vecchio soldato e il bambino e che sono sottolineati da un adeguato accompagnamento musicale.
.
.
LOCARNO: RIFLESSIONE SUL PALMARES E IL CONCORSO
di Ugo Brusaporco
«Servirà sicuramente alla promozione del film , è per questo che i film vanno ai festival, quando uscirà in sala a Parigi e in altre grandi città europee o no, il film sarà segnalato e favorito per questo premio », chi parla è Paulo Branco, produttore di “Cosmos” il film che ha consegnato al suo autore, il maestro Andrzej Zulawski, il premio per la miglior regia al 68° Festival di Locarno, “Se lo aspettava, dopo gli applausi ricevuti alla proiezione con il pubblico” aggiunge. “È un premio importante proprio per la mia carriera e per il destino del film – spiega Avishai Sivan il regista di “Tikkun” il film israeliano che ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria e menzione speciale per la fotografia firmata da Shai Goldman – Locarno era il Festival giusto per il film, non poteva essere Cannes o Venezia, dove sono considerati nomi già in carriera e non avrei forse trovato spazio in un Concorso, quello di cui ha bisogno un film come il mio, girato in bianco e nero e destinato per ora solo alla distribuzione cinematografica.
La settimana prossima sarò al Festival di Sarajevo, poi a Vancouver, Stoccolma, e altri Festival, ma era importante partire da Locarno, una manifestazione rispettata e conosciuta in tutto il mondo”. Sono voci che raccogliamo al termine della Conferenza Stampa per i premi di questo Festival, unico grande assente è Hong Sangsoo, Pardo d’Oro 2015 con il suo: “Jigeumeun Matgo Geuttaeneun Teullida” (“Right Now, Wrong Then”) film che si porta a casa, stranamente, anche il premio per la miglior interpretazione maschile al protagonista, il bravo Jung Jae-Young. Stranamente perché di solito il miglior film non ha bisogno di altri premi, ma evidentemente, la giuria ha fatto una scelta da meditare, come ha sottolineato Udo Kier portavoce della Giuria imitando caricaturalmente il Gregg Turkington protagonista di “Entertainment” di Rick Alverson, la cui recitazione era tanto realista da risultare non recitata. Segno che alla Giuria serviva un vero attore e Jung Jae-Young lo è davvero come misura e capacità. Il Pardo per la miglior interpretazione femminile è andato alle attrici di “Happy Hour” il film di Hamaguchi Ryusuke, che ha affascinato e conquistato il pubblico nonostante le paventate più di 5 ore di durata. Loro, Tanaka Sachie, Kikuchi Hazuki, Mihara Maiko, Kawamura Rira, giocano con gran classe i loro ruoli di amiche, donne di mezza età che non vogliono morire schiavizzate dai loro maschi. Lo stesso film ha ricevuto il premio anche per la sceneggiatura. Sono solo quattro, infine, le opere premiate in questo Concorso internazionale con cinque premi e due menzioni. Segno chiaro che la Giuria ha individuato in questi titoli le sole eccellenze di una competizione che aveva almeno altri tre titoli da tenere in considerazione: l’iraniano “Ma dar Behesht” (Paradise) di Sina Ataeian Dena che ha comunque vinto il Swatch Art Peace Hotel Award, il francese “Suite Armoricaine” di Pascale Breton (la cui attrice principale Valérie Dréville, ha ricevuto un premio collaterale), e “Chant d’Hiver” di Otar Iosseliani, che ha visto un suo meritato premio per la regia chiuso da un Zulawski che ne aveva più bisogno per rilanciarsi, e quindi bene ha fatto la Giuria a dare fiducia al maestro polacco. Il Pardo d’oro Cineasti del presente – Premio Nescens è andato a “Thithi” di Raam Reddy, una coproduzione tra India / Stati Uniti e Canada, un film di fiction raccontato come un documentario sui problemi che sorgono in un paese di campagna per seppellire un vecchio: il film ha ricevuto anche il Premio come miglior opera prima. Interessanti i premi popolari della Piazza che hanno visto il Prix du Public UBS assegnato al tedesco “Der Staat Gegen Fritz Bauer” di Lars Kraume, si tratta di un racconto storico sulla cattura del criminale nazista Eichmann, segno che al pubblico piace ritrovare sullo schermo la Storia, una abitudine televisiva che il cinema si ricorda di sfruttare. Sempre in Piazza il Variety Piazza Grande Award è andato a “La Belle Saison” di Catherine Corsini, il film francese che celebra l’amore lesbico, il pubblico è molto più aperto di certi soloni che amano pontificare su quello che ognuno dovrebbe essere sessualmente. I festival servono anche a questo, soprattutto quando si affidano al grande pubblico, come succede a Locarno.
Nella smorfia napoletana, il numero 68 indica: “la zuppa cotta”. La zuppa, spiegano, non rappresenta la fame materiale ma quella emotiva. Indica una necessità di appagamento, di soddisfazione. Guardando da vicino, in una trasmissione radio, il direttore artistico del Festival di Locarno, Carlo Chatrian, abbiamo pensato a come bene calzava il 68 del Festival, al 68 della smorfia, perché il suo viso era soddisfatto come chi poteva annunciare che la zuppa è cotta. Certo gli ingredienti di un festival sono diversi, ma nessun direttore può sentirsi appagato, anche se ne ha bisogno. Questo, e l’ha ammesso lui stesso è stato un anno fortunato per il tempo, metereologico, che per un festival che conta molto sulle proiezioni all’aperto è un bel colpo. E il pubblico ha ben risposto, anche se non tutte le sere hanno segnato un tutto esaurito, e su questo punto forse si dovrebbe riflettere, evidentemente non tutti i film hanno lo stesso appeal, o non tutti sono promossi abbastanza. Per quel che riguarda i film delle varie sezioni, c’è da dire che il Concorso non è stato del tutto convincente, soprattutto guardando un palmares che si concentra su soli quattro film: il Pardo d’Oro “Right Now, Wrong Then” del coreano del sud Hong Sang-soo, “ Tikkun” dell’israeliano Avishai Sivan , “Cosmos” del cosmopolita Andrzej Zulawski, e “Happy Hour” del giapponese Hamaguchi Ryusuke. Pochi visto che i film erano 19 e la Giuria ha premiato tre film due volte. Quale era allora la vera qualità della selezione? Probabilmente c’erano troppi film deboli, sostenuti da piccole lobby dei media. C’erano scelte impossibili come il non film della signora Akerman o quello di Athina Tsangari o troppo televisivi come il lavoro di Alex van Warmerdam, o, ancora, opere piccole, troppo piccole per un concorso internazionale. E bastava guardare la sala sempre troppo vuota delle proiezioni stampa del Concorso e confrontarla con quelle sempre piene per i film della Semaine de la Critique, ancora una volta la miglior sezione del Festival, per chiedersi che cosa manca al Concorso. E forse, non mancano solo i giornalisti: gli accrediti stampa fino allo scorso anno avevano due sportelli di distribuzione, quest’anno solo uno, ma mancano anche i film. Certo sparsi nelle altre sezioni c’erano titoli importanti, capaci di far vivere idee diverse di cinema, pensiamo a film come “Dom Juan” di Vincent Macaigne, a “Les Êtres chers” di Anne Emond in Cineasti del Presente, a “Genitori” di Alberto Fasulo, a “Romeo e Giulietta” di Massimo Coppola, a “Histoire de Judas » di Rabah Ameur-Zaïmeche, o anche il piccolo e delicato «Deux Rémi, deux» di Pierre Léon, film visti nelle varie sezioni, cercando tra i titoli, infilandosi nelle sale già piene, perché anche questo è Locarno. Come Locarno sono le retrospettive: pensiamo non solo a quella grande dedicata a Sam Peckinpah, ma all’omaggio a Marlen Khutsiev, il bravissimo regista russo che a 90 anni (li ha compiuti il 4 ottobre) continua a sfornare film, seguendo le orme dell’indimenticato Manue De Oliveira. E ora aspettiamo il Festival numero 69, la cabala qui gioca sull’opposto dei numeri, nei sogni significa rivincita, Forza Direttore prepara un Concorso capace di far chiedere alla Giuria tanti premi in più.
.
.
SAN GIO’ VERONA VIDEO FESTIVAL / XXI
di Paolo Micalizzi
 E’ un film svizzero ad aggiudicarsi il “Best Movie” come miglior film della Sezione “Awards Short Film” del San Giò Verona Video Festival. Si tratta di “L’ile noire” di Nino Christen, film incentrato su un guardiano e il suo uccello che vivono una vita miserabile e desolata su un’isola in attesa di un qualche evento che li aiuti a sfuggire da quella noiosa situazione. Un ‘opera in bianco e nero premiata “per la qualità e l’originalità del disegno, il ritmo delle immagini e la straordinaria attualità dei contenuti”. Premio per la miglior Regia al film di Hind Boujemaa “Et Romeo èpousa Juliette” (Tunisia/Belgio) “per l’abile gioco ironico tra leggerezza e gravità nel ritrarre una situazione intima e sociale di grande urgenza”. L’urgenza è dovuta al tempo che passa e che non dà più occasioni di vivere momenti d’amore come quelli dei protagonisti, cui danno vita due attori eccezionali. In particolare Nejia Zemni premiata come miglior interprete “per una interpretazione piena di dignità e sempre in equilibrio tra naturalezza, ironia e rassegnazione”. Per la miglior sceneggiatura il premio è stato attribuito a Bruno Razum per “Tajini Laboratorij Nikole Tesle”(Croazia) “ per la costruzione di un meccanismo narrativo capace di esprimere la tensione tra essere umano e robot, con una tecnica di animazione particolarmente raffinata”. Miglior fotografia ad Ana Sofia Dominguez per “Azul cobalto” di Sarai Caprile(Messico) incentrato su Cecilia, giovane attrice che sta cercando di ottenere la parte di Ofelia in “Amleto” immedesimandosi nel personaggio al punto di causare un dramma esistenziale: cortometraggio premiato “per la forza ed eleganza del linguaggio fotografico e cinematografico”. Continuando a riferire sui Premi assegnati, da segnalare che Elena Gladkova si è aggiudicato il riconoscimento per il miglior montaggio di “Jazz Etude” (Russia)di cui è anche regista e “Federica Zammarchi quello per la musica di “Crumbling” di Marco Schiavoni. Il Premio speciale della Giuria è andato invece a “Nuggets” di Andreas Hydake (Germania) mentre “La terza riva” di Giuliana Fantoni si è meritata un Menzione speciale. La Sezione Cortometraggi è quella che al San Giò Verona Videoi Festival riscuote uno spazio più ampio. Consentendo cosi una panoramica internazionale della produzione video, a testimonianza di temi e nuovi autori che alimentano sempre più un settore in crescita.
E’ un film svizzero ad aggiudicarsi il “Best Movie” come miglior film della Sezione “Awards Short Film” del San Giò Verona Video Festival. Si tratta di “L’ile noire” di Nino Christen, film incentrato su un guardiano e il suo uccello che vivono una vita miserabile e desolata su un’isola in attesa di un qualche evento che li aiuti a sfuggire da quella noiosa situazione. Un ‘opera in bianco e nero premiata “per la qualità e l’originalità del disegno, il ritmo delle immagini e la straordinaria attualità dei contenuti”. Premio per la miglior Regia al film di Hind Boujemaa “Et Romeo èpousa Juliette” (Tunisia/Belgio) “per l’abile gioco ironico tra leggerezza e gravità nel ritrarre una situazione intima e sociale di grande urgenza”. L’urgenza è dovuta al tempo che passa e che non dà più occasioni di vivere momenti d’amore come quelli dei protagonisti, cui danno vita due attori eccezionali. In particolare Nejia Zemni premiata come miglior interprete “per una interpretazione piena di dignità e sempre in equilibrio tra naturalezza, ironia e rassegnazione”. Per la miglior sceneggiatura il premio è stato attribuito a Bruno Razum per “Tajini Laboratorij Nikole Tesle”(Croazia) “ per la costruzione di un meccanismo narrativo capace di esprimere la tensione tra essere umano e robot, con una tecnica di animazione particolarmente raffinata”. Miglior fotografia ad Ana Sofia Dominguez per “Azul cobalto” di Sarai Caprile(Messico) incentrato su Cecilia, giovane attrice che sta cercando di ottenere la parte di Ofelia in “Amleto” immedesimandosi nel personaggio al punto di causare un dramma esistenziale: cortometraggio premiato “per la forza ed eleganza del linguaggio fotografico e cinematografico”. Continuando a riferire sui Premi assegnati, da segnalare che Elena Gladkova si è aggiudicato il riconoscimento per il miglior montaggio di “Jazz Etude” (Russia)di cui è anche regista e “Federica Zammarchi quello per la musica di “Crumbling” di Marco Schiavoni. Il Premio speciale della Giuria è andato invece a “Nuggets” di Andreas Hydake (Germania) mentre “La terza riva” di Giuliana Fantoni si è meritata un Menzione speciale. La Sezione Cortometraggi è quella che al San Giò Verona Videoi Festival riscuote uno spazio più ampio. Consentendo cosi una panoramica internazionale della produzione video, a testimonianza di temi e nuovi autori che alimentano sempre più un settore in crescita.
Qualificata la selezione dei medio e lungometraggi dove il “Best Movie” è stato attribuito al documentario di Enrico Menduni “L’ultima voce”. Guido Notari che rievoca la storia di uno speaker Rai che per oltre vent’anni ha raccontato l’Italia agli spettatori, una voce mitica. Un documentario interessante quello di Menduni “che indaga anche la relazione tra i media e il potere, fino ad interrogare l’attuale rivoluzione tecnologica”. Per la miglior regia è stato premiato Alessandro Soetje che in “Old Wild Lorenz”( Germania-Italia) racconta dello sciamenisimo trasferitosi in Sud Tirolo grazie ad uno scultore, Lorenz, trasformando cosi una raduna boschiva in un luogo di culto e di raccoglimento, mentre per un film che innova il linguaggio cinematografico è stato premiato “Suenan los androides” di Ion de Sosa(Spagna- Germania), ispirato ad un romanzo di Philip K.Dick, dove l’autore “indovina un linguaggio altamente originale nel descrivere un surreale quartiere extra-urbano, dove i personaggi galleggiano in una condizione sospesa, atemporale, fra l’onirico e l’impossibile”. Altri ancora i Premi assegnati: sono stati attribuiti dalle giurie ”Social Club” e “Cineclub Verona” .Da segnalare che tutti i premi sono opere pittoriche, uniche, di Mauro Nicolini. Da sottolineare infine che il Festival che l’attivissimo Ugo Brusaporco dirige da ventun anni quest’anno voleva essere un Omaggio a due figure particolarmente legate a questa manifestazione, purtroppo recentemente scomparse: Piero Barzisa e Gian Vittorio Baldi Di quest’ultimo è stato proiettato il film “Fuoco”, opera su un fatto assurdo ( un disoccupato che all’improvviso si barrica in casa con moglie e figlioletta) che rivela un realtà tragica nell’Italia del boom economico. Opera dallo stile rigoroso e asciutto, caratteristica di un autore indipendente sia come regista che come produttore al servizio di un cinema di qualità che rifiuta l’intrattenimento ma fa riflettere sulla realtà.
.
.
CASTELLINARIA
di Andreina Sirena
Inaugurata all’indomani dell’orrendo massacro che ben potremmo chiamare l’11 settembre dell’Europa, la ventottesima edizione del Festival di Bellinzona ha immediatamente dovuto – anzi, voluto – ripensare se stessa: se l’obiettivo della manifestazione è sempre stato, fin dalla sua fondazione nel 1988, il favorire la conoscenza e la comprensione tra i popoli e le culture, questa missione ha assunto lo scorso novembre la dimensione di un accorato appello, urgente e improcrastinabile. Il Festival è divenuto consapevole risposta all’orrore, una risposta che trova nella cultura – nella sua capacità di creare legami, di sciogliere paure e pregiudizi – l’antidoto più efficace contro il nichilismo, il vuoto, il nulla esistenziale che – nutrito di superstizione e ignoranza – genera mostri, come quelli che abbiamo visto trucidare 129 vite innocenti nel corso di una sera a Parigi. Ragazzi ottenebrati da droghe e odio che sparano su civili inermi sentendosi martiri, mentre altro non sono che nullità criminali risucchiate in un buco nero che li ha privati dei più elementari sensi di umanità. Nel suo discorso introduttivo, il Presidente del Festival Gino Buscaglia ha posto la manifestazione proprio sotto questa luce: la risposta della cultura, della conoscenza contro la superstizione e l’ignoranza. Cultura come sinonimo di umanesimo. Cultura come capacità di vedere nell’altro, sempre e prima d’ogni altra cosa, una persona. Tanto quanto il fanatismo disumanizza l’altro, la conoscenza al contrario gli restituisce la sua umanità. Ed è stata proprio questa la cifra del Festival, che non a caso ha aperto proprio con lo splendido “Human” del fotografo Yann Arthus-Bertrand, film realizzato in occasione del 70° anniversario della fondazione dell’ONU, e proiettato per la prima volta a New York nella sede delle Nazioni Unite, alla presenza del Segretario Ban Ki Moon. In questo film Yann Arthus-Bertrand – fotografo che ci ha abituato a spettacolari immagini dall’alto, e ci ha svelato scenari dilatati, immensi – è sceso tra gli uomini, per raccontarne le condizioni di vita, i lavori, le esperienze che li hanno maggiormente segnati, le loro riflessioni sull’esistenza, l’amore, la felicità. Un film corale, dove però l’individuo non naufraga in un’indistinta e teorica collettività – come è sempre accaduto nei totalitarismi – ma ritrova la sua forma unica suggellata dal primo piano. Protagonista non ne è l’astratta ‘umanità’, bensì i singoli uomini e donne, d’ogni parte del pianeta, che la incarnano, ciascuno in un individuo irripetibile fatto di carne ed ossa, ricordi, gioie, sofferenze, speranze e sogni. Ed è stato proprio con una profonda disanima di sogni e desideri dell’uomo che il Festival ha celebrato la sua serata inaugurale, proponendo l’ultimo capolavoro di Matteo Garrone, “Il racconto dei racconti”, liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti (1634) di Giambattista Basile, raccolta di novelle scritte in napoletano, tra le quali possiamo annoverare La gatta Cenerentola, prima redazione della fiaba che conoscerà una fama universale nelle versioni di Perrault e dei fratelli Grimm. Garrone ha scelto tre fiabe – La cerva, La pulce e La vecchia scorticata -per accompagnarci in un’indagine sulla potenza distruttrice del desiderio che diviene ossessione.
Le narrazioni che compongono il trittico del film sono tutte storie di manie perverse che inevitabilmente portano alla tragedia, proprio contro coloro che le hanno nutrite e perseguite con tanta ostinazione. Una regina è ossessionata dal desiderio di avere un figlio: disposta a tutto, anche a mettersi nelle mani di un negromante e a sacrificare un marito amorevole senza mostrare una parvenza di cordoglio per la sua morte. Un figlio a tutti i costi: quanto è attuale questo tema, come parla di noi questa fiaba del seicento napoletano. La scienza ha sostituito la magia – oggi la regina del racconto non divorerebbe più un cuore di drago, bensì noleggerebbe un utero surrogato – ma i fini cui magia e scienza sono asservite sono i medesimi, ovvero la gratificazione di una fissa, un capriccio, in virtù del quale un figlio colmerebbe magicamente ciò che in realtà è un vuoto esistenziale. Infatti, una volta generato l’atteso pargolo, la regina scivola verso un altro assillo, stavolta di ordine sociale. Il figlio infatti non può frequentare il povero Jonah (i due ragazzi sono gemelli, essendo nati entrambi dallo stesso cuore di drago). Una simile ostinazione nel negare le aspirazioni di un figlio la troviamo nel re de La pulce: sua figlia Viola lo supplica di trovarle un marito ed egli escogita un torneo dal quale è certo non potrà uscire alcun vincitore. Un vincitore invece ci sarà, e sarà un orribile orco. Infine, ne La vecchia scorticata assistiamo alle conseguenze nefaste di un’altra fisima tanto attuale: il miraggio di una giovinezza da far durare il più a lungo possibile, anche a costo di risultati che si rivelano, al contrario, velleitari e patetici. Ma anche Garrone lascia accedere la speranza di un’armonia e dall’enigmatica fortezza di Castel Del Monte, nel finale i protagonisti levano lo sguardo al cielo, segnato dal passaggio di un equilibrista che indica l’ordine a cui anelare. Il Festival è proseguito affrontando grandi temi come la droga, il disagio sociale, l’anoressia, la disabilità, la povertà estrema, additando però ogni volta vie di rinascita. Dalle macerie è possibile edificare solide mura, dalla fragilità, forgiare armi di forza, dal rifiuto, generare l’abbraccio dell’accoglienza. “Castellinaria” ha voluto mostrare l’irrompere della luce nel buio della distruzione, della guerra, della minaccia, dell’azzeramento della nostra cultura. Il giovane Malony, protagonista de “La tête haute” di Emmanuele Bercot, sembra rassegnato a un destino di riformatori, centri di rieducazione e carcere, ma viene redento da un incontro improvviso che sovverte quella sorte cui sembrava condannato. E’ la stessa cosa che accade al tragico “Non essere cattivo”, film-testamento di Claudio Caligari, dove la disperata morte di Cesare trova un riscatto postumo nella venuta al mondo di un figlio. In “The crow’s egg” di M.Manikandan, i due bambini protagonisti vivono in una baraccopoli in India: loro sogno è poter gustare la pizza del nuovo prestigioso locale, aperto a un passo dalla loro bidonville. La pizza assurge qui a simbolo di riscatto sociale, di rottura dello schema rigido delle caste, in virtù del quale il loro ingresso in pizzeria sembra impossibile, un miraggio. Poveri ma pieni di dignità, i due ragazzi rifiutano l’avanzo di pizza offerto loro da un ricco coetaneo, e infine i loro ostinati tentativi di varcare la soglia inaccessibile della pizzeria vengono coronati da un ingresso addirittura trionfale, circondati da fotografi e giornalisti, come fossero dei divi di Bollywood. In “Les oiseaux de passage” di Olivier Ringer, la piccola Margaux, affetta da distrofia muscolare, grazie ad una provvidenziale amicizia e al dono di un anatroccolo riesce a disfarsi della sedia a rotelle, e a immergersi in un catartico bagno finale, lontana dai centri di riabilitazione, nell’abbraccio della sua amica e nella bellezza di una natura incontaminata. In “My skinny sister” di Sanna Lenken Stella è la sorella minore della bella Katja. Gelosa della sua bellezza, del suo talento di pattinatrice su ghiaccio, Stella vorrebbe imitarla, irretita com’è in un sogno di perfezione, che vede incarnato in Katja. Ma la mania di perfezione della sorella ha un costo umano altissimo, che la porterà ad un passo dalla morte. Con una presa di coscienza estremamente matura sarà proprio la piccola Stella ad allarmarsi e a chiedere quell’aiuto che salverà Katja. Dopo la tragedia di Parigi anche un film come “Il più piccolo esercito del mondo”, il primo film prodotto dal Vaticano, acquista una sfumatura tutta particolare, nel mostrarci un esercito pacifico, senza armi, chiamato a garantire la pace.
“Castellinaria”, scrive il direttore artistico Giancarlo Zappoli, propone la sua visione di un cinema a 360° gradi, capace di offrire non solamente film di qualità, ma anche una più profonda conoscenza di cosa voglia dire fare cinema. Da qui gli atelier di realizzazione di cortometraggi con REC e la mostra dell’attrezzeria Rancati, dove si sono potuti ammirare cimeli cinematografici come l’elmo e le armature di Russell Crowe ne “Il gladiatore” e le armi de “I pirati dei Caraibi”. Se il cinema è fatto della stessa materia di cui son fatti i sogni, i suoi sono sogni capaci di dilatare gli orizzonti della realtà, di aprire vie di confronto, crescita e comunicazione. In questa epoca terribile in cui la subcultura jihadista perverte e disumanizza tanti giovani, rendendoli automi fanatici, “Castellinaria” ha combattuto per la salvaguardia dell’uomo e del suo tesoro più prezioso, la sua stessa umanità, e l’ha fatto attraverso la sua arma peculiare quanto non violenta: il cinema.
.
.
IL NETWORK EUROSHORT
di Gianluca Castellini
Si parla spesso di collaborazioni in rete, anche se molte volte, risulta difficile gestirle, pur essendo in ambiti teoricamente agevoli e geograficamente molto ristretti. Una eccezione è sicuramente rappresentata dal network Euroshort. Nato nel 2013, su proposta del sedicicorto film festival, Euroshort è un network composto da 9 festival Europei: Sedicicorto (Italia), Tabor film Festival (Croazia), In the Palace (Bulgaria), Glasgow Film Festival (Scozia), Fil’m Hafizasi (Turchia), Wiz-Art (Ucraina), Avanca (Portogallo), Fec (Spagna), Busho (Ungheria) Le finalità del gruppo si possono riassumere in 3 punti principali:
1) Favorire la circolazione dei cortometraggi europei nel circuito dei Festival e tra i distributori, soprattutto di autori under ’30.
2) Favorire il dialogo tra i festival europei coinvolti,
3) Favorire lo sviluppo di azioni e progetti comuni a livello europeo.
Il gruppo di festival coordina una serie d’incontri annuali, durante i quali vengono vagliate nuove proposte ed analizzate le soluzioni programmate. Attualmente le attività consolidate sono:
1) Realizzazione di un sito: www.euroshort.com, dove vengono notificate le principali informazioni inerenti al network,
2) Meeting annuali, in una delle città’ proposte dal gruppo.
3) Premio Euroshort da assegnare all’interno di ogni festival.
4) Album vimeo promozionale che include i singoli premi Euroshort.
5) Partecipazione in fiere e mercati internazionali.
6) Retrospettive di cinema nazionale all’interno delle programmazioni dei singoli festival.
7) Suggerimenti gestionali, organizzativi, grafici.
8) Progetto editoriale 100 corti
9) Piattaforma web dove potere visionare contenuti d’interesse comune, film, liste, leggi europee, compilation , ecc.
10) Campus Euroshort
11) Interscambio e segnalazioni di giurati, nelle rispettive manifestazioni,
12) Segnalazione di film, scambio di sottotitoli, Non ultimo, il consolidamento del progetto sotto forma di rete, favorisce il recepimento delle indicazioni fornite dalla Comunità Europea, per quanto riguarda le forme di sostegno, destinate ai festival di cinema.
La maggior parte dei collegamenti tra i festival, avviene tramite scambio di mail, attraverso le quali avvengono le nuove proposte ed il monitoraggio di quelle esistenti. Ogni festival propone un paio di persone di riferimento, le quali garantiscono la regolare circolazione delle informazioni.
L’obiettivo prefissato in fase di creazione era quello di formare un gruppo costituito da 9 festival. L’adesione al network non prevede quote d’iscrizione e formalità di recesso.
Nel corso dell’anno 2015, sono state approvate le inclusioni degli ultimi 2 festival, ovvero, FEC (Spagna) e Busho( Ungheria). Sin dall’inizio si è pensato di non allargare all’infinito il network in modo da potere gestire più facilmente le azioni condivise.
L’ultimo progetto creato dal gruppo e’ rappresentato dal campus Euroshort, che ha visto in 2 giornate alternarsi 15 giovani registi under ’30, nella presentazione dei loro progetti, discussi, di fronte ad una commissione qualificata che aveva il compito di suggerire elementi utili per il miglioramento dell’idea cinematografica. I giovani autori sono stati reclutati da 4 festival del network. Ora il progetto del campus diventerà’ un evento satellite, da proporre negli anni successivi e da intendersi come ulteriore processo di crescita per gli autori, le singole manifestazioni ed il rafforzamento del network.
.
.
ITALIA IN CORTO
di Elio Girlanda
Riconoscere non solo la presenza nel cinema italiano del cortometraggio ma anche il valore dell’industria a esso collegato è il focus de L’industria del cortometraggio italiano. Report 2014, a cura di Jacopo Chessa, direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio. Si tratta del primo volume della collana “I Quaderni di Cineconomy”, curata da Antonio Urrata, direttore della Fondazione dello Spettacolo, e da Bruno Zambardino, docente di Economia e Organizzazione dello Spettacolo” a Sapienza Università di Roma. Il volume, coeditato dalle Edizioni Fondazione dello Spettacolo e dalla Direzione Generale del MiBACT, in italiano e inglese, si può acquistare al prezzo di euro 12,90 sul sito www.entespettacolo.org/.
Dopo un’approfondita ricerca su produzione e diffusione dei cortometraggi italiani, per la prima volta sono disponibili cifre e statistiche su un ambito tutt’altro che marginale e che coinvolge circa 200 festival e più di 1.000 film relativi soltanto al 2014. Dopo la prefazione del Direttore generale Cinema, Nicola Borrelli, e del presidente dell’Ente dello Spettacolo, Davide Milani, testi di approfondimento, brevi, agili e ben documentati, curati da operatori del settore su molteplici e fondamentali questioni (dalle sale ai festival, dalla televisione alla situazione degli altri Paesi europei) arricchiscono il Report di riflessioni, piste di ricerca e proposte risolutive. Alla base c’è sempre l’idea di parlare di corto, laboratorio per eccellenza nel settore degli audiovisivi soprattutto oggi con le nuove tecnologie e il digitale, da un punto di vista inedito o poco trattato: quello del mercato. Quindi L’industria del cortometraggio italiano. Report 2014 colma un vuoto negli studi sull’audiovisivo del nostro Paese, ed è il primo di una serie di studi sull’economia del cortometraggio che il Centro del Corto curerà.
 «Insomma, è opinione comune che il cortometraggio almeno in Italia e non necessariamente in altre parti d’Europa, come ben evidenzia Edoardo Peretti nel suo Lo stato del cortometraggio in Europa, non abbia una propria ragion d’essere, un proprio significato, ma che viva in funzione del supporto che può dare in maniera diretta o indiretta alle produzioni più “strutturate”. Per produzioni strutturate intendiamo, ovviamente, quale targate col simbolo del dollaro o dell’euro, quale con le quali si fa cassa, quelle che arrivano in sala e che sbancano il botteghino (quest’ultima, almeno per la nostra cinematografia, è un’evenienza sempre più rara)». Con queste parole Urrata e Zambardino ben introducono il Report, non solo spiegando i pregiudizi strutturali che impediscono al corto di diventare un driver importante dell’economia dei media, ma anche suggerendo un cambio di paradigma, basato sulla crossmedialità, necessario per realizzare tutte le potenzialità che il corto può attuare in tv, sul web e, perché no?, anche in sala e nella distribuzione theatrical.
«Insomma, è opinione comune che il cortometraggio almeno in Italia e non necessariamente in altre parti d’Europa, come ben evidenzia Edoardo Peretti nel suo Lo stato del cortometraggio in Europa, non abbia una propria ragion d’essere, un proprio significato, ma che viva in funzione del supporto che può dare in maniera diretta o indiretta alle produzioni più “strutturate”. Per produzioni strutturate intendiamo, ovviamente, quale targate col simbolo del dollaro o dell’euro, quale con le quali si fa cassa, quelle che arrivano in sala e che sbancano il botteghino (quest’ultima, almeno per la nostra cinematografia, è un’evenienza sempre più rara)». Con queste parole Urrata e Zambardino ben introducono il Report, non solo spiegando i pregiudizi strutturali che impediscono al corto di diventare un driver importante dell’economia dei media, ma anche suggerendo un cambio di paradigma, basato sulla crossmedialità, necessario per realizzare tutte le potenzialità che il corto può attuare in tv, sul web e, perché no?, anche in sala e nella distribuzione theatrical.
In tale prospettiva si muovono i contributi contenuti nel Report: dallo stato dell’arte del corto italiano nel 2015 (Descrivere il cortometraggio italiano nel 2015, Jacopo Chessa), dove si nota come investire nella produzione di corti possa essere redditizio solo se si ha una visione internazionale del mercato, fino alle diverse esperienze di distribuzione e finanziamento per i cinema d’essai (Missione “Cortometraggi che passione” per le sale FICE, Mario Mazzetti) o per le Film Commission con fondi dedicati come quello del Piemonte (Corti e territorio. L’esperienza dello Short Film Fund in Piemonte, Enrico De Lotto, Paolo Manera, Alfonso Papa). E ancora. I festival italiani sono chiamati non più ad essere solo una «piattaforma distributiva informale» quanto ad «assumere un ruolo più strutturato, rafforzando gli scambi all’interno della rete dell’Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC), creando sinergie con le sale cinematografie dei territori« (I festival italiani e corti, Federico Pommier Vincelli; Sistemi di distribuzione e scambio nel circuito dei festival del corto, Enrico Vannucci), mentre le reti televisive commerciali, avvezze a mandare in onda cortometraggi da almeno 10 anni, sono ora interessate non solo ai canali digitali a pagamento ma anche a gemellarsi con festival nazionali (Acquistare per le tv, Paola Ruggeri).
In tal senso l’animazione, in questo momento particolarmente attiva in Italia con nuovi studi di produzione e molti giovani artisti, costituisce l’aspetto più innovativo e promettente del settore (Cortometraggi d’animazione in Italia: produzione e distribuzione, Emiliano Fasano, Maurizio Forestieri). Considerando anche il grande interesse dei Festival internazionali e la situazione generale in Europa, dove il corto, soprattutto della durata massima di 20 minuti, gode da tempo di condizioni favorevoli alla produzione, alla circolazione e alla promozione. Incentivi giusti anche se non sufficienti, tranne nei casi della Francia e della crescita europea dei corti d’animazione con il loro impatto numerico ed economico, «a creare un vero e forte mercato del cortometraggio, sia dal punto di vista della circolazione sia da quello del guadagno» (Peretti).
La pubblicazione si chiude utilmente con le parti dedicate alla produzione e alla diffusione: dati, tabelle, raffronti statistici, sui costi reali e stimati dei film, i contributi statali e locali, fino alla ripartizione geografica dei festival che hanno programmato cortometraggi e all’origine nazionale dei corti programmati, dalla ricorrenza dei titoli nei festival italiani (il primo è Un uccello molto serio di Lorenza Indovina del 2013 con 25 presenze) fino ai film acquistati dalle tv. Tutto contribuisce a fare di questo Report un vero strumento di lavoro per produttori, autori, responsabili e programmatori di festival e di cineclub, oltreché un agevole manuale d’uso per autori, critici e spettatori amanti al corto.
.
.
CLASSICI
 ELEONORA DUSE: LA GRANDE LEI
ELEONORA DUSE: LA GRANDE LEI
di Ivana Baldassarri
Nel 2001, sui muri di Pesaro l’immagine di un viso bellissimo comunicava la mostra veneziana dedicata alla “Divina Eleonora” che la Fondazione Giorgio Cini di Venezia aveva scelto per festeggiare il 50° anniversario della propria istituzione.
Visione fugace fra semafori e clacson rabbiosi, visione fuori da ogni tempo e da ogni moda, la “Divina Eleonora” si offriva ai rapidi, distratti o sedotti sguardi con quel palpitante interrogativo di cui sapeva riempire i suoi occhi, come nessuna “diva” mai.
«Pettinata come nella tempesta» diceva di lei Papini.
Eleonora Duse cent’anni (il ritratto del manifesto è del 1905), è cosi viva e ardente che sa proporre brucianti curiosità e chiedere amore e amicizia con quel suo tendersi verso noi, in uno slancio di generosa confidenza e disarmato abbandono. Proprio la generosità irragionevole e sconsiderata fu il suo blasone e il suo calvario, fino al trionfo incontrastato, alla transitoria ricchezza, alla assoluta povertà all’umiliante solitudine, alla lacerazione e alla morte.
Tutti noi sappiamo qualcosa di lei: icona teatrale assurta a mito, amante sfortunata “dell’infernale e divino orbo veggente”, viaggiatrice instancabile per teatrali necessità, ma appassionata e convinta sedentaria in luoghi silenziosi e ameni, specie quando si verificavano i suoi sempre più gravi attacchi di tisi. Una conoscenza, quella della Duse, tramandata spesso dalle chiacchiere delle nonne ammirate ed eccitate da sommari racconti intrisi di peccaminosità.
Oggi in quello splendido viso che non sorride, si configura una lunga e straordinaria storia intessuta di tenaci proponimenti, di febbrili immaginazioni, di teatrali ardori, di travolgenti amori e di una segreta disponibilità alla visionaria immedesimazione interpretativa che, con originali risolvimenti di stile conquistò uomini, donne, artisti e re con quel che di squisito, di sfuggente e di struggente, con cui si esprime sempre il fascino dei malinconici.
Eleonora Duse nacque a Vigevano il 3 ottobre 1858 da genitori veneti, attori, o meglio guitti di professione: il padre si chiamava Vincenzo – in arte Alessandro Duse – e proveniva da un’agiata famiglia di marinai e pescatori.
Solo il padre di Vincenzo, Luigi, per quegli imponderabili cambi di rotta che determinano sempre straordinari destini, aveva preferito il teatro al mare, portando poi suo figlio Vincenzo, più debole, meno dotato di lui e segretamente desideroso di essere pittore, a continuare il mestiere di attore. Mestiere di fame e di freddo, nel quale Vincenzo coinvolse, naturalmente, anche sua moglie, la dolce Angelica Cappelletto, ventunesima figlia di una povera e dignitosa famiglia vicentina.
Eleonora nacque a Vigevano per necessità teatrale dei suoi genitori che proprio per il parto si permisero un rarissimo lusso, quello di far partorire Angelica all’albergo “Cannon d’oro”, lasciando per pochi giorni il carrozzone dei comici con il quale giravano l’Italia settentrionale, Istria e Dalmazia comprese. Recitavano drammi popolari, farse, commedie e perfino sacre rappresentazioni, ultimi epigoni di quella gloriosa schiera di attori della Commedia dell’arte, ormai tramontata.
Si dice che il giorno del battesimo la neonata, secondo l’usanza del luogo, fosse portata in chiesa dentro una piccola urna di cristallo e che il corteo battesimale fosse affiancato da un drappello di soldati che, credendo di vedere nell’urna un piccolo santo, resero gli onori militari. Presagio di futuri onori e trionfali riconoscimenti o di un eterno avventuroso girovagare?
La piccina cresce nella feroce necessità dell’irrinunciabile nomadismo teatrale: bisogna sempre partire, senza fermarsi mai, non si può avere una casa, una scuola, amicizie infantili.
Durante una sosta un po’ più lunga Eleonora riceve per qualche tempo, da una famiglia amica, pasti caldi, un soffice letto e una bambola.
Quando le dissero che bisognava partire, la bimba urlò, si disperò come non mai. Poi improvvisamente tacque, aveva capito che quello era il suo destino. Non frequentò mai scuola regolare, fu il padre ad insegnarle a leggere e scrivere.
Pare che ad una sosta più lunga, una maestra comprensiva accogliesse la bimba in classe, ma in un banco a parte, lontana dagli altri bambini che la sbeffeggiavano perché i figli degli attori erano “fioi de ciarlatan”. Ma già fin d’allora i genitori si accorsero che quella loro figliolina esile e dallo sguardo sempre interrogativo, era una bimba speciale.
A quattro anni fu Cosetta nei “Miserabili”, a cinque ebbe una piccola parte in “Coriolano”; nei 1863 il suo nome comparve per la prima volta in cartellone: fu al “Nobile Teatro” di Zara, in “Angelo, tiranno di Padova” con la compagnia diretta da Giuseppe Lagunaz e Enrico Duse, zio di Eleonora.
La ragazzina fu subito notata per l’estrema naturalezza con cui interpretava due parti nello stesso spettacolo. Con i primi magrissimi guadagni, Eleonora correva a comprarsi quanti più libri poteva.
La sua mamma, la dolcissima e generosa Angelica, si ammalò gravemente; le sue ripetute assenze venivano rimpiazzate proprio dalla figlia che tra una scena e l’altra correva a vedere come stava sua madre. Proprio in queste occasioni indosserà costumi di scena “da grande” e sarà “Francesca da Rimini” di Silvio Pellico e “Pia de’ Tolomei” di Carlo Marenco.
Nel 1875, a Verona, fu per la prima volta Giulietta, non la celebre Giulietta di Shakespeare ma quella del veronese Giuseppe Daldò. Sarà stata forse Verona, sarà stata forse la sua adolescenza acerba già addestrata alla responsabilità e alla sofferenza, ma quella sera la piccola Eleonora sentì con tutte le fibre del suo essere, che recitare non era per lei il mestiere di famiglia, ma un’arte, una folgorazione, un ideale a cui avrebbe dedicato tutta la sua vita.
Calato il sipario, la piccola, come in delirio camminò per Verona senza meta, seguita dal padre che aveva capito l’accendersi folgorante della sua vocazione. Poi lei si lasciò guidare verso casa, ormai certa di essere preda della potente malia che si sprigiona misteriosamente dal teatro.
Per sempre.
La sera del 15 Sett.1875 a Verona, proprio fra un atto e l’altro di “Giulietta e Romeo” arriva un telegramma con la notizia della morte di Angelica rimasta all’Ospedale di Ancona. Eleonora, disperata, rimanda le lacrime alla fine dello spettacolo.
I Duse padre e figlia cercano scritture presso compagnie possibilmente stabili e sicure.
L’ambiente è durissimo e crudele e le umiliazioni sono all’ordine del giorno: nel 1878 Eleonora – da sola, suo padre non era stato accettato – entra a far parte della compagnia “Ciotti-Belli-Blanes”: Francesco Ciotti è un uomo di larghe vedute, ha capito che le pose eroiche e roboanti con la loro irrigidita convenzionalità, hanno fatto il loro tempo e di quella ragazza appena ventenne ossuta, acerba, pallida e apparentemente scialba d’aspetto, lo convince subito quel modo di recitare strano e appassionato senza enfasi e senza guittismi: Eleonora viene scritturata come “amorosa”.
Tutte le biografie dusiane ascrivono al 3 ottobre 1878 la prima grande prova teatrale di Eleonora Duse in “Pamela nubile” e nella “Locandiera” di Goldoni al Teatro dei Fiorentini di Napoli.
Nei giochi misteriosi del destino, il veneziano Goldoni, segna per la Duse la consacrazione che la riallaccia alle sue radici venete, a suo nonno Luigi che aveva lasciato le barche per diventare insuperabile attore goldoniano.
Nel procedere segreto delle emozioni di lei, molta parte pare abbiano avuto, il richiamo alle tradizioni, il legame indissolubile con le sue origini sceniche e un’affezione intensa ai destini del teatro veneto.
Eleonora pare già avvolta in un’aurea di solitaria austerità, dalla quale trae un’orgogliosa autonomia, protezione e coraggio. Le gazzette scrivono che quella giovanetta pare una piccola zingara famelica e il pubblico sconcertato non l’applaude più di tanto, ma il vecchio custode del Teatro dei Fiorentini dice a tutti: «Signurì, chesta è essa!»
Proprio a Napoli ha la fortuna di farsi notare da Giovanni Emanuel, un attore intelligente che intuisce subito il suo straordinario talento tanto da convincere la Principessa Santobuono, proprietaria del teatro, a formare una compagnia con la famosissima Giacinta Pezzana e l’esordiente Eleonora Duse.
Scriverà più tardi lo stesso Giovanni Emanuel, ricordando quegli esordi “era una donna che ogni sera ti prendeva il cuore e te lo strizzava come un fazzoletto!”
Inimmaginabile ai nostri giorni la varietà e la moltitudine di testi teatrali che formavano le programmazioni stagionali di una compagnia teatrale. Nel 1878 la Duse fu “Ofelia e Desdemona” di Shakespeare, Teresa Raquin di Zola e Elettra di Alfieri: proprio quest’ultimo personaggio uscirà, per merito della sua interpretazione, da un classicismo di stucco e segnerà per lo stesso Alfieri un breve momento di rinascita.
Eleonora riscatta con una recitazione impetuosa ed umanissima la pallida rigidità dei versi impeccabili delineando una vergine ellenica dal selvaggio cuore mediterraneo.
Il pubblico napoletano un po’ irritato, un po’ stupefatto ebbe però un mirabile intuito; riconobbe in quella creatura singolare qualcosa di speciale che rendeva possibile quel mistero che ha nome “arte” e arrivò perfino il pubblico a perdonarle la sua singolarità. La stessa Giacinta Pezzana, già celebre ed amatissima dal pubblico era al colmo dell’entusiasmo: «Mi domando un po’ di tempo – disse una sera- ma vi assicuro che questa gracile creatura diventerà la più grande attrice italiana». Si delinea già la dimensione segreta di Eleonora che la porterà ad essere tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento un personaggio-mito conosciuto ed amato per l’intensità e forse l’unicità della sua apparizione.
In lei il teatro trovò non soltanto un’interprete di eccezionale sensibilità e di temperamento stravolgente, ma anche un’operatrice di rara intelligenza, appassionata ai nuovi temi che la scena europea andava proponendo, generosa nel sostenere gli autori più impegnati a rinnovare forme e contenuti teatrali. Lo fece senza divismi deteriori a cui le circostanze avrebbero potuto disporla, senza l’enfasi della bieca retorica che dominava tanta parte del teatro del suo tempo.
Ma torniamo alla stagione 1878. Siamo a Napoli.
Eleonora ha 20 anni, e conosce attraverso amici sinceri come Matilde Serao che le sarà fedele per tutta la vita, Martino Cafiero, uomo colto ed esperto, vero seduttore che intuisce immediatamente la profonda sete di vita di quella creatura ancora tutta racchiusa nella solitudine e nella timidezza: Cafiero di 15 anni più vecchio di Eleonora, possiede alte doti intellettuali e come tutti i “viveur” viziati dalle donne e dalla vita, è seducente, appassionato, disponibile e accogliente.
Giornalista, direttore del recentissimo “Corriere del mattino”, poliglotta, autore di romanzi e novelle ambientate nel bel mondo, Cafiero è un irriducibile “tombeur de femmes” che schiude alla piccola Eleonora così incapace di frivolezze e di civetterie, un mondo totalmente sconosciuto, stregandola con romantiche passeggiate in carrozzella, con cenette intime nei ristoranti alla moda, con visite ai musei e mostrandole, nelle notte di luna, Posillipo e Marechiaro.
Eleonora si innamora pazzamente di lui. Intanto la compagnia del capocomico Cesare Rossi, attore fanese, insieme alla Pezzana, ai due Duse (anche il papà questa volta fu scritturato) a Claudio e Teresa Liegheb, al bell’amoroso Flavio Andò e al giovane caratterista Tebaldo Checchi, hanno affittato a Torino per 3.000 lire e per un intero anno, il Teatro Carignano.
Un’occasione splendida che fa tutti felici, tranne Eleonora che deve lasciare Napoli e Cafiero.
Ma al momento della partenza, il maturo “viveur’’ non si presenta neppure alla Stazione per salutarla: ha ben altro da fare e poi per lui l’avventura è già finita.
A Torino, dopo pochi giorni, Eleonora scopre di essere incinta: a Roma, dove qualche mese dopo avverrà un umiliantissimo incontro con Cafiero, Eleonora apre finalmente gli occhi. Dolore, mortificazione, vertigine, vergogna e delusione cocente: amore e desiderio le sembrano perfino una contaminazione.
Recitare, recitare, bisogna tornare subito a recitare!
A Torino si esibisce fino a che il suo corpo glielo permette: poi a Marina di Pisa, allora poco più di un villaggio, dà alla luce un bimbo che vivrà solo due giorni. Solo Matilde Serao le è vicina.
Il 22 Aprile 1880 Eleonora Duse è ancora a Torino, dove l’aspettano ruoli nuovi: “il Conte Rosso” di Giacosa, “La sposa di Menecle” di Felice Cavallotti, “Il cavallo di Troia” di Romolo Monti, “La principessa di Bagdad” di Dumas figlio, e quel “Facciamo divorzio!” di Sardou e Najac che diventerà uno dei suoi cavalli di battaglia.
E proprio nel 1880 e precisamente il 22 Agosto, Eleonora recita a Pesaro, al Teatro Rossini. Sarà la sua unica esibizione pesarese segnata da un indicibile successo reso ancora più sorprendente perché ottenuto sostituendo la celebre Pezzana quella sera indisposta.
È ancora la Pezzana, con la sua repentina decisione di lasciare la compagnia Rossi, a determinare, nei 1881, un’importante svolta nella carriera della Duse che diventa prima donna della Compagnia: il suo debutto come prima attrice avviene all’arena Nazionale di Firenze il 19 Agosto 1881 in “Scrollina” commedia agrodolce di Achille Torelli.
La Duse rimarrà sempre legata al ricordo delia Pezzana con affetto e nostalgia: era stata lei ad insegnarle i giochi sublimi delle trasformazioni, le duttilità dell’espressione fra naturalità e artificio, la padronanza del linguaggio dei piccoli gesti: proprio lei le aveva fatto capire che una grande artista deve emanare una fascinazione così potente da far tremare le vene ai polsi.
È questo, per Eleonora, un momento durissimo.
L’umiliante storia con Cafiero, la morte del suo piccolo e l’aumentata responsabilità nel lavoro – resa più pesante dalle insistite avance di Cesare Rossi – che la considera ormai una sua creatura – la fanno vivere in una costante sensazione di pericolo e di delusione: le programmazioni le sembrano ammuffite e anche l’adorato recitare diventa per lei un vero tormento.
L’aiuto le giunge in forma anomala e inattesa.
Nella compagnia c’è un collega gentile, un uomo sulla trentina, non di grande talento, ma attore misurato e abile, bravo ragazzo, ottimo camerata; si chiama Tebaldo Checchi che diventa a forza di cordialità e di tranquille premure, l’amico di cui aver fiducia anche quando si è colpiti dalle più tristi vicende.
Con lui Eleonora parla e si confida, pour tacendogli il quotidiano tormento che il vecchio capocomico le infligge: tutti sanno e nessuno la difende, tranne lui, il giovane amoroso, che alla stima per quella ragazza pallida e severa, va aggiungendo ogni giorno di più un tenace sentimento d’amore. Tebaldo Checchi decide di proteggere quella creatura delicata e disposta quasi geneticamente a soffrire, vegliando lo schiudersi di quella strana genialità che si rivela sulla scena e che le condiziona totalmente la vita.
Sa, Checchi, che l’impresa sarà difficilissima anche perché qualcuno gli ha detto che Eleonora è affetta dalla “smara”, quella malattia veneziana dell’anima che passa nel sangue come la nebbia nei canali, che guizza nelle vene come una brama, come una malinconia appassionata rendendo fatalmente inquieta la persona che ne soffre. Decide di sposarla ed Eleonora, grata, accetta quel matrimonio rispettabile e borghese come un riscatto, rassicurata e avvolta dalle commoventi tenerezze di lui.
Matilde Serao, come sempre presente, come sempre affettuosa e comprensiva, fa da testimone alle nozze: è il 7 settembre 1881: Eleonora ha 23 anni, Tebaldo 37.
Quando Cesare Rossi sa del matrimonio, con vero camaleontismo teatrale, si comporta come se la sua passione per Eleonora non fosse mai esistita; anzi si esibisce come protettore della novella coppia, subito assalita dai pettegolezzi impietosi e crudeli della compagnia tutta.
Eleonora recita anche se incinta. Il 7 Gennaio 1882 nasce Enrichetta e la Duse si ammala gravemente: è una delle prime repentine gravissime rivelazioni del male che non l’abbandonerà più.
Pare una coincidenza, ma mentre la Duse vive la difficile convalescenza, fa tappa a Torino la tournée teatrale di Sarah Bernard. La grande attrice francese si esibisce al Carignano e adopera il camerino della Duse.
Fra deliri e trionfi la Bernard recita “La dame aux camelias” di Dumas e “Frou frou” di Meilhac e Halevy, e la Duse, con incondizionata ammirazione e sincera umiltà la osserva, l’ascolta, la studia.
Per la nostra è come partecipare a corsi di perfezionamento, spinta sempre, la Duse, dalla consapevolezza dell’importanza dei suo ruolo d’attrice nei quale confluivano, assieme alle tendenze decadentistiche, le esperienze dell’umana e reale fatica del vivere.
La Duse ha un grande miraggio: essere sul palcoscenico una persona comune, con i dolori, le tragedie, le allegrie, le perfidie e le sconsideratezze di tutta l’umanità; diventerà invece un mito ineguagliabile, un’icona teatrale che non tramonta e che soggioga ancora irresistibilmente chi la studia, chi guarda le sue fotografie, chi legge le sue lettere.
Altro di lei non rimane. Neppure la sua voce ci è nota.
Nel 1896, durante la sua gloriosa tournée americana, la Duse fu invitata nello studio di Thomas Alva Edison che volle registrare proprio la sua magica voce: lei ne fu orgogliosa e felice, fino alla commozione. Destino volle che pochi giorni dopo un terribile incendio devastasse lo studio di Edison portandosi via, fra le fiamme, anche la voce di Eleonora che recitava “La signora delle camelie”.
Come sarà stata quella sua voce? I contemporanei ne rimasero ammaliati, gli amici sedotti e gli estranei alla sua vita e al suo teatro, una volta ascoltata per caso, non la dimenticarono mai più.
Fu certamente lo strumento docile di un’anima speciale che attraverso febbrili immaginazioni, trapassi spirituali e un che di squisito e struggente, si incamminava a proiettare il suo stesso personaggio nei segreti disegni della leggenda.
Neppure la sua intensa e misurata gestualità e la sua mimica che dilatava i silenzi a dismisura, non hanno riscontri documentari. Non ci bastano i pochi traballanti fotogrammi del film “Cenere” girati quando lei era ormai vecchia: la dilavata sinopia semmai non fa che acuire curiosità e struggimenti.
.
.
Il buio e il silenzio che sempre avvolgono le leggende si animano solo, grazie alle sue lettere, alle sue fotografie e alle correzioni e ai segni che l’attrice faceva sui copioni: mille segni a più colori, quasi un suo personale linguaggio associativo-simbolico per delineare un’analisi tematica in grado di comporre con vera istintualità d’artista, quell’aspirazione al sublime, che fu sempre un suo obiettivo.
Anche le fotografie sono rivelatrici: i capelli che sfuggono alla tirannia del pettine sottolineano la malinconia del viso e quella – come dissero i suoi contemporanei – «patetica sciatteria di carattere lagunare», e le mani, e la positura del busto e la scelta degli abiti ci richiamano alle sue incessanti metamorfosi.
Ma è l’assoluta meraviglia dello sguardo, mai diretto, sempre altrove e carico di tensioni, che ci illude di entrare nel respiro della sua anima, nell’ordito dei suoi pensieri, nelle contraddizioni dei suoi sentimenti, nella seduzione dei suoi silenzi: oltre la fissità di quegli attimi fermati dalla fotografia, pensiamo di poter cogliere le mutazioni espressive suggerite dalla grazia, dalla passione e dall’esuberanza di lei, che elabora, con assoluto rigore, la propria fisicità, procedendo dalla zona del pensiero interpretato, fino alla sua stessa intimità, alla sua sognante malinconia e alla sua “corporale tristezza”.
Altro tramite seducentissimo per configurare almeno in parte la sua presenza scenica, sono i suoi abiti, ora conservati alla Fondazione Cini; icone di tattili suggestioni ancora freschi di tessuti e di ornamenti, senza sospetto di consunzione.
Abiti di linea sciolta, senza cintura, studiati per commentare ogni possibilità di gesto che la stoffa doveva sottolineare con forme d’ombra: ricamati o dipinti nei toni del bronzo o dell’oro o dell’argento opaco sullo stille di Mariano Fortuny, alcuni abiti conservano ancora le etichette di sartoria.
Molti sono a chimono, i colori sono nero, viola, bianco, qualche grigio, raro il celeste e solo broccato verde forse per “La donna del mare”. Molta seta di grana fina, le fodere, perfette, come i vestiti. Bellissimo l’abito per “La città morta” in crespo di Cina, lievemente avorio foderato di “charmeuse” candida con un ricamo leggero alla scollatura.
Ma Eleonora, anima risentita e nascosta, meravigliosa maschera tragica, nonostante le tante notizie raccolte, continua ad essere un volto che resta nell’ombra di lirica virtualità.
L’aver assistito ai trionfi di Sarah Bernhardt le offre la consapevolezza di un’assoluta autonomia da chiunque, anche dai migliori.
Sa, che il suo comportamento scenico fra naturalezza ed artificio, è talmente autentico e personale rispetto le categorie del protagonismo teatrale, che nulla e nessuno può contaminarlo: sa di produrre smarrimento fra i suoi stessi ammiratori e capisce che proprio quello smarrimento è garanzia di rinnovamento e quando, finalmente, avrà la possibilità di scegliere da sola le figure da incarnare, si orienterà verso un repertorio i cui personaggi le diano modo di sviluppare le zone oscure della sua coscienza.
Sardou e Dumas scrissero molto di lei puntualizzando comportamenti e atteggiamenti scenici: «La voce – dissero – ha una strana vibrazione e la sua genialità, quasi una ritrosia ad apparire, ha uno strano procedere, un po’ strascicante, come piegato in avanti, con le spalle raccolte. Come chi deve lottare col vento. La Duse non dà sulla scena né troppo, né troppo poco».
Il suo modo di recitare è l‘attuarsi creativo di una polifonia interiore, un far teatro aspirando sempre ad una liberazione, o alla propria o a quella dello spettatore, configurando quella catarsi con la quale la scena e il teatro sembrano anticipare alcuni elementi della psicoanalisi.
Quando riprende a recitare, siamo alla fine della estate 1882, dopo la nascita di Enrichetta, affidata da subito ad un coppia di sani e affettuosi montanari di Leynì e dopo la sua prima grave crisi polmonare, Eleonora protetta e sostenuta dall’affettuosissimo e sempre vigile Tebaldo, interpreta nella stagione del Valle di Roma: 7 “Odette”, 4 “Frou frou”, 2 “Signore dalle camelie”, 2 “Femande”, 3 “Scrolline” e 6 “Le mogli di Claudio”.
Come per una silenziosa sfida con Sarah Bernhardt, fu una “Signora dalle camelie” insuperabile e originalissima.
Scrive Pirandello, che l’ha vista al Valle: «Giovane ancora, ma già al culmine della sua arte: non dimenticherò mai il romantico incanto, la serena dolcezza e la sconvolgente passione che solo essa era capace di esprimere in misura così grande nella parte di Margherita».
Il sentimentalismo di Dumas si trasforma in naturalezza dusiana e ne trae vantaggio la concezione dell’opera tutta.
Eleonora sente già le estreme tensioni artistiche del primo ‘900, capisce che il cammino verso l’arte non può che contemplare oltre la vitalità e la liricità dei testi, una compenetrazione fra silenzi e apparenze, fra emotività inconscia e necessità comunicativa: la sua sensibilità di artefice dell’illusione, che si nutre di incontri e di solitudini, di letture e di scambi epistolari, di amori e di delusioni, sente che l’arte teatrale non è una posa per snob, né un modello da esibire, ma un impulso a vivere, una ricerca febbrile, uno stato di tensione interiore: è il desiderio di creare.
Nel delinearsi prepotente di questa consapevolezza la Duse sa che, per non rimanere schiacciata dall’incombente pericolo della routine, deve ancorarsi alla sfera della più alta elaborazione culturale.
Nel 1884 per intercessione e pressante interessamento del buon Tebaldo, la Duse diventa socia di Cesane Rossi e, come prima uscita della compagnia Duse-Rossi, la sera del 4 gennaio, si mette in scena un’assoluta novità: “La cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga; la Duse è Santuzza, il bel siciliano Flavio Andò, maggior attor giovane del tempo, è Turiddu e Tebaldo Checchi è Compar Alfio: l’arte quasi sempre anticipa la vita…
È un vero trionfo!
Durante una serata di gala a Milano nel maggio 1884, in un locale molto mondano chiamato “Cova” Eleonora siede fra il sindaco di Milano e Arrigo Boito.
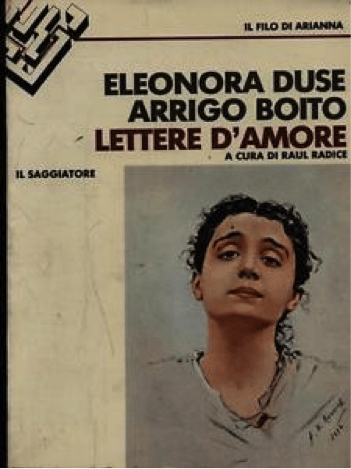 Presentazioni, sorrisi, scambi arguti di battute e bigliettini, poesiole con garbati calembour. Comincia così in tono leggero un’amicizia che qualche anno dopo diventerà una relazione importante e che si trascinerà fino al 1898.
Presentazioni, sorrisi, scambi arguti di battute e bigliettini, poesiole con garbati calembour. Comincia così in tono leggero un’amicizia che qualche anno dopo diventerà una relazione importante e che si trascinerà fino al 1898.
Nel Novembre di quel 1884, muore a Napoli di colera Martino Cafìero: Checchi lo comunica per lettera alla Serao con queste parole: «Oggi vado fuori Roma. Voglio liberare Eleonora almeno per un giorno almeno dalla mia presenza, perché si possa abbandonare senza riguardo alla sua pena. Andate voi da lei e statele vicina!».
Sembra impossibile che un uomo abbia una sensibilità come questa.
Ma sensibilità, generosità, discrezione e tenace fedeltà non gli serviranno per tenere il difficile rapporto con Eleonora. Nel corso della prima tournée argentina i due si dividono: la Duse crede di avvertire nella protezione del marito, accorto amministratore, collega di scena e cavalier servente, un limite e un impedimento alla sua libertà.
Durante una discussione più dolorosa e stizzosa di altre, Eleonora salta su a dire: «Credi forse che senza di te non potrei fare lo stesso? Io sono un’individualista e devo fare da sola».
A complicare le cose c’è anche l’attrazione fortemente erotica che Eleonora sente, in quel momento, per Flavio Andò, il bel siciliano dalla elegantissima figura, partner appassionato di ogni rappresentazione teatrale.
È a Rio de la Plata, dopo tre mesi di successi incondizionati, che si decide la fine del matrimonio fra Eleonora e Tebaldo. L’attrice si impegna a pagare i debiti di Tebaldo con la compagnia e di assumere il mantenimento della figlia che rimarrà affidata alle sue cure.
Tebaldo le giura amore per tutta la vita assicurandole la sua presenza ogni volta che lei l’avesse richiesta. Sapeva Checchi che Eleonora era innamorata di Flavio e voleva che fosse felice. Poi scomparse nell’immensa Buenos Aires senza salutare nessuno.
In Argentina trovò amici di prim’ordine che lo aiutarono ad entrare in diplomazia dove rimase onorevolmente fino alla sua morte avvenuta qualche anno dopo a Lisbona. Alle sue adorate donne, Eleonora ed Enrichetta lasciò in eredità il piccolo gruzzo dei suoi risparmi: qualche migliaio di lire.
La cerchia degli amici sinceri di sempre, Gegè Primoli un po’ impresario e un po’ giornalista, Matilde Serao la fedelissima e Giuseppe Giacosa, si scambiano pensieri e progetti per cercare di aiutare Eleonora stretta da mille difficoltà economiche, organizzative e sentimentali. Ma nulla si poteva fare contro l’assoluta imprevedibilità delle occasioni e delle reazioni di lei.
Tra il 1885 e il1904 Eleonora Duse visse due grandi amori che avrebbero avuto importantissimi riflessi sulla sua vita artistica: Arrigo Boito e Gabriele D’Annunzio.
Il capriccio di Flavio Andò era stato di breve durata: pur bello, disponibile e comprensivo, non possedeva il carisma intellettuale che Eleonora cercava, quasi a supplire la mancanza di quel blasone di studi appropriati avrebbero potuto fornirle.
Anima inquieta e mai paga, Eleonora ha bisogno, per placare il suo perdurante complesso di inferiorità culturale, di avere vicino a sé, personaggi il più qualificati possibile, per offrire alla sua recitazione l’imprimatur alto della intellettualità.
Ogni lavoro intrapreso dall’attrice ruota attorno alla sete di certezza soggettiva, all’ansia di raggiungere nuovi equilibri, un’ansia continuamente rilanciata e mai paga.
Al primo incontro nel 1884 con Arrigo Boito, era seguito uno scambio di lettere un po’ allusivo e un po’ audace; le lettere di un tempo erano palestra di conquista e seduzione. I due si ritrovano poi nel Febbraio del 1887 al Teatro Manzoni di Milano, mentre Eleonora recita “Pamela” di Goldoni.
Eleonora ha 27 anni, Boito ne ha 45 ed è al culmine della fama per aver composto “Mefistofele” e scritto il libretto di “Otello” per Verdi. Non si sa come siano andate esattamente le cose, ma grazie alla precisione quasi maniacale di Boito, conosciamo la data del loro primo incontro amoroso: è il 20 febbraio 1887.
Boito nel suo diario scriveva infatti nel 1888 in occasione del 1° anniversario dell’evento: «Un anno abbiamo vissuto nel sogno, un anno esatto, né un’ora di più, né un’ora di meno!»
Fu la loro una strana relazione, soprattutto epistolare. Si scambiano lettere, telegrammi, bigliettini perché si vedranno di rado, entrambi presi dal loro lavoro e da una miriade di impegni. I primi tempi, però, furono inebrianti e appassionati.
Tutto di lui desta l‘ammirazione di Eleonora: la purezza della vita, la bontà verso gli altri, la severità verso se stesso, l’ironia, la raffinatezza, la pienezza del suo sapere e soprattutto la sua ineffabile arte. Come è bella la sua musica!
Lei è piena di smania di sapere: ascoltano insieme la musica di Beethoven, vanno per musei a guardare quadri e statue, si immergono estasiati nella poesia.
Lei lo chiama “Santo”, lui “Lenor”.
Il legame con Boito ampliò la cultura di lei, affinò il suo gusto e le fece sentire i limiti delle opere teatrali del tempo, indirizzandola verso i grandi testi. Boito tradusse per lei “Antonio e Cleopatra” di Shakespeare (1888) e l’attrice fu una Cleopatra nevrotica, altalenante fra le follie dell’isteria e le allucinazioni del sentimento d’amore.
Eleonora arrivò a sognare di ritirarsi dalle scene e di andare a vivere con Arrigo Boito ed Enrichetta a Venezia. Ma fu “malattia” brevissima, che contraddiceva tute le ferree leggi teatrali da cui era dominata.
Contro i gusti e i consigli di Boito, cominciò ad interessarsi sempre più vivamente al teatro di Ibsen. Porterà infatti “Casa di bambola” nella sua lunga tournée in Russia, e poi a Vienna, a Berlino e negli Stati Uniti, ricevendone sempre, prima sospettosa diffidenza e poi travolgente successo. Fu per l’attrice il consolidamento di una fama internazionale al di sopra di ogni più rosea aspettativa.
Ma anche l’amore per Boito cominciò ad affievolirsi: i due si andavano progressivamente allontanando e la rottura definitiva avvenne qualche anno dopo. Boito era il tipico scapolone convinto e pur avendo avuto molte amanti, le aveva saputo tenere sempre a rispettosa distanza dalla sua bela e severa casa milanese, al numero 1 di Via Principe Amedeo.
Voleva assolutamente evitare di cadere nelle trappole matrimoniali.
La storia d’amore di Boito e la Duse, che fu pur sincera e palpitante, si concluse formalmente il 24 novembre 1898.
Il pignolissimo Boito lasciò scritto in un biglietto: «Ultima volta: giovedì 24 nov. ’98 alle 6 pomeridiane. Lenor vista l’ultima volta nella sua camera dell’Hotel Hasser».
Il loro amore era diventato col tempo estremamente cerebrale, si scrissero ancora e con accenti di sincera amicizia.
Ma erano già pronti i nuovi amori: Boito si era legato a Velleda Ferretti altrettanto problematica, ma meno celebre della Duse, e la Duse ha già nel sangue il virus dell’inquieto fascino che suscita in lei il giovane D’Annunzio, “infernale e divino” come lei aveva scritto in una lettera a Boito: «Preferirei morire in un cantone, piuttosto che amare un’anima tale… D’Annunzio, lo detesto e lo amo!»
La divina è già in pericolo.
I primi incontri fra la Duse e D’Annunzio sono rappresentativi di quella temperie culturale vivida e visionaria che si nutriva di scapigliatura, simbolismo e decadentismo. Tutto nella vita, nelle lettere, nei gesti sembra declamato per suscitare deliri e smarrimenti.
Una sera a Roma, siamo ancora nel 1882, durante la recita de “La signora dalle camelie”, la Duse alla fine del secondo atto si avvia, piangente di stanchezza e di sovreccitazione, al suo camerino: le si fa incontro un giovane che fissandola con occhi chiari e ardenti le dice:
«Oh, grande amatrice!»
Ella non risponde parola; più tardi le diranno che gli occhi metallici di quel ragazzo esile ed elegante sono di Gabriele D’Annunzio.
Poi il tempo passa, portando all’uno e all’altra la gloria; si sono incontrati a volte, a volte si sono parlati e scritti così, come succede a tutti, sempre.
Finché, una notte a Venezia, avviene il loro primo fatale incontro.
Autunno 1894; la Duse ha stabilito, proprio a Venezia, il suo primo domicilio in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo sul Canal Grande; dalle finestre si può godere la vista dei tetti, delle cupole, dei campanili, delle altane della città e sul retro dell’appartamento, tutta la laguna.
Proprio in quell’autunno, il “Vate” è giunto a Venezia per incontrare il suo traduttore francese: Gabriele ha 31 anni, è il poeta più famoso e discusso d’Italia; Eleonora ha 36 anni ed è considerata la più attrice europea.
In una notte insonne Eleonora esce dalla sua camera e dalla sua casa dove non trova né pace, né respiro e con una gondola gira per ore nel labirinto silenzioso dei canali. Solo quando nel cielo appaiono le prime striature di verde e di rosa, decide, rabbrividendo, di tornare.
Insieme alla sua gondola ne approda un’altra dalla quale scende un uomo, anche lui spinto da insonnie inquietanti ad uscire nella notte.
Eleonora lo riconosce, lo chiama e insieme camminano per le calli ancora deserte.
“Tutte le pietre e tutta l’acqua sono un miracolo d’oro e d’opale”.
Ad un tratto la Duse chiede a bruciapelo a D’Annunzio perché non scrive per il teatro: «… e il poeta mi rispose col sorriso di un fanciullo» ricorda la Duse.
Appena rientrata in casa, invia al Vate il seguente vibrante biglietto: «Vedo il Sole e ringrazio tutte le buone forze della terra per avervi incontrato. A voi ogni bene e ogni augurio».
Subito dopo l’attrice parte per un lunga tournée in Germania, Olanda e Belgio, nel giugno 1895 è a Londra; ed è qui che G.B. Shaw scrive una lunga analisi di straordinaria vivezza e sincerità sulle due massime attrici del momento: Sarah Bernhardt ed Eleonora Duse, dove fra l’altro si legge:
«Di fronte alla Bernhardt siamo colti da un lungo incantamento che può dare un minuto intero, ma la Duse con un tremito di labbra che si intuisce prima di vederlo e che non dura più di un attimo, ci prende di colpo il cuore e la vita. Per sempre».
Il continuo nomadismo teatrale che freneticamente porta la Duse da un Wagon-lit ad un piroscafo, da un grande albergo ad una reggia, da un teatro all’altro, si interrompe sempre più spesso per quegli attacchi di tisi che prostrano Eleonora fino alla paura di morirne; si rifugia allora in montagna o al mare, si rincantuccia per giorni fra cuscini e coperte calde per riprendere forza e respiro.
È terrorizzata che il suo corpo non le risponde più.
Ma ogni volta “risorge” più pallida, più magra, più forte e determinata.
I giorni di malattia e convalescenza li adopera per leggere, per scrivere, per stare con la figlia Enrichetta che cresce bella e intelligente e che ha il dono raro, come suo padre, di capire e di amare sua madre per come è: quasi sempre lontana, ma sempre miracolosamente presente.
Nel settembre 1895 i due futuri amanti, Eleonora e Gabriele, reduci dal loro girovagare per il mondo, sono di nuovo a Venezia: Gabriele al Danieli sulla riva degli Schiavoni, Eleonora nel suo appartamento di Palazzo Wolkoff dall’altra parte del Canal Grande.
Nel taccuino di Gabriele troviamo una nota scarna e lapidaria: «Amori et dolori sacrum: 28 Sett. 1895. Hotel Royal Danieli».
La sintonia artistica coinvolge i sentimenti; il fuoco divampa e nel delirio che li assale i due stabiliscono un patto: Gabriele avrebbe scritto drammi che poi l’attrice avrebbe rappresentato.
È questa la vera trappola, dentro la quale l’attrice precipita senza difese.
Si delinea già da subito un paradosso che avvolge i meandri della psiche e il guazzabuglio del cuore: l’equivoco di fondo di questo amore fu che D’Annunzio voleva essere amato come un superuomo, mentre Eleonora venerava e curava in lui solo lo scrittore, il poeta e la guida verso l’arte.
La loro “liaison” comunque finirà per diventare l’amore emblematico della “belle époque”: la vicenda del Vate e della Divina strapperà la ribalta dei regnanti del tempo, suscitando la morbosa curiosità nei salotti mondani e nei fogli del nascente giornalismo d’assalto.
Nel 1896, reduce dalla trionfale tournée in America, dove la Duse è stata perfino invitata ad un tè alla Casa Bianca, l’attrice trova un’amara, umiliante sorpresa.
“La città morta” scritta e pensata per lei da D’Annunzio è stata offerta e accettata in sua assenza da Sarah Bernhardt e il poeta, che vorrebbe mantenere ancora la cosa segreta, chiede alla Duse un allestimento in così breve tempo che l’attrice non può accettarlo. A questo suo rifiuto, il vate fedifrago dice allora alla Duse che “La città morta” sarà della Bernhardt.
«È stato – disse la Duse – come raccogliere tutte le rose del mondo e rifiutarle poi a chi le desidera!»
Questo imperdonabile affronto costituisce la prima rottura con D’Annunzio, che poi il comune amico il conte Giuseppe Napoleone Primoli (Gegè) riesce a ricomporre.
Ma il patto rinnovato fra i due non produce buoni frutti; la Duse ormai prigioniera di una passione irragionevole si rioffre ancora come sua Musa, sua amante consolatrice e redentrice, in un groviglio di torbide suggestioni fra il mistico e il perverso.
E quello che sarà per Eleonora un sodalizio sentimental-intellettuale alto, per Gabrielle sarà solo una ditta di cui lei pagherà sempre generosamente le spese e lui riscuoterà i profitti. Anche teatralmente per la Duse sarà un cattivo affare; i pubblici italiani e stranieri, pur tributando a lei omaggi di sincera ammirazione, fischieranno selvaggiamente i testi dannunziani.
Lei si macera nel dolore e nello sforzo di essere sempre più “unica” sulla scena, lui, dietro le quinte si dà da fare con attrici, cantanti, sartine e cuoche.
Ma il peggio non è ancora scoppiato.
D’Annunzio dà alle stampe il suo romanzo “Il fuoco” terminato dopo una gestazione e proprio su istanza della Duse.
In esso, sullo sfondo di una splendida Venezia evocata con un linguaggio fastoso e decadente, è narrata la vicenda d’amore di Stello Effrena descritto come un giovane splendido, con Foscarina un’anziana donna appassionata e seducente, “con i vestigi di cento maschere sul viso che aveva simulato il furore delle passioni morali”.
La gran donna dagli occhi di pianto e d’infinito, ha quarantun anni e non fa nulla per dissimularli, non nasconde le prime rughe, le chiama anzi il lasciapassare della sua umanità; è refrattaria ai trucchi e ai belletti, rifiuta perfino la cipria, figurarsi il cerone; quando sale sul palcoscenico il suo pubblico deve poter vedere quando arrossisce o impallidisce veramente!
Per il super Narciso Gabriele quei cinque anni in più di Eleonora sono una gran differenza in suo favore, ma non sa che alcune donne scrivono cose terribili di lui.
Una è Simone Benda, moglie dell’attore Charles De Bargy che nelle sue memorie così lo ricorda: «… aveva capelli di un castano slavato ed erano poco meno che ripugnanti. Gli occhi prominenti e privi di ciglia e di sopracciglia non erano né grigi, né azzurri, li si sarebbe detti acqua e sapone; le labbra pallide rivelavano strani dentini irregolari e guasti…».
Perfino Sarah Bernhardt, che in pubblico lo blandiva, in privato diceva che «D’Annunzio ha due occhi come due piccole cacche».
Se a questo aggiungiamo la sua piccola statura, non arriva al metro e sessanta, ci si potrebbe chiedere le ragioni del fascino che esercitava sulla maggioranza delle donne ancor prima di aver sfoggiato quel “gonfalon selvaggio” o “quella catapulta perpetua” che ne faceva un “homo eroticus” avido di sempre nuove e fresche conquiste.
Il rapporto fra Eleonora e Gabriele è come un invasamento, una febbre onirica, un brivido visionario, alterato da un eloquio aulico farcito di suggestioni poetiche e mitologici richiami in atmosfere iniziatiche.
Il vate sapeva che con la Duse la sua bacchetta magica non era il “gonfalon selvaggio”, ma la parola che sapeva usare splendidamente: la parola che diventava anche un tramite e un invito all’eros, del quale la Duse, nonostante tutti i suoi amori, parve abbastanza inesperta.
Lo scoprì con stupore e sorpresa tardivamente con Gabriele e fu un’implosione, consapevolezza di una voglia insaziata, fu perdimento e perversione.
Credette forse di riscattare la sua severità giovanile, la castità nei letti di tante bettole, la fame e la fatica; pensò anche che quel vivere finalmente un amore senza limitazioni, potesse essere uno squarcio di luce nuova per la sua arte.
Ne fu abbagliata proprio perché l’oratoria dei sensi, era espressa con parola poetica alta, colta, seduttiva; anche quando era lontana, il poeta le tornava sempre dinanzi; nello sguardo di lui l’attrice si illuse di scorgere l’infinità della terra, del cielo e tutta la sua giovinezza perduta e tutta la forza misteriosa dell’indole sua e la fiamma della sua trepida inquietudine che chiedevano l’adempimento in lui.
In un primo tempo cercò di sottrarsi, ma poi si abbandonò coscientemente, vinta da fatale ardore e selvaggia possessività.
Furono, quelli con D’Annunzio, nove anni di umiliazioni, di rapimenti, di offese, d’illusioni, di amare consapevolezze, d’infedeltà, di speranze e di pazze spese.
Aveva sottomessa se stessa e la sua arte alla volontà di lui, credendo alle sue lusinghe, assecondando impudiche eccentricità: firmava contratti solo con chi accettava il repertorio di “Gabri”, a recite finite falsificava le cifre degli incassi per fargli riscuotere diritti d’autore maggiorati.
Lui per sdebitarsi le scrive e le dedica “Francesca da Rimini”.
Se “La città morta” e “La figlia di Iorio” erano state dirottate con perfida noncuranza su Sarah Bernhardt e Irma Grammatica, questa “Francesca” sarà tutta di Eleonora; “Gabri” gliela dedica con le famose parole «Alla divina Eleonora Duse».
Lei spende patrimoni in scene e costumi, macchine da guerra, fiori e luci, illudendosi di essere finalmente di fronte all’evento teatrale che da tanto aspetta.
Non fu così, “Francesca da Rimini” il poema del sangue e della voluttà (andata in scena, per la prima volta il 9 febbraio 1901), pur essendo ricca di versi splendidi e fastosi, fu accolta, specie a Napoli, in un baccanale di scherno ostile.
.
.
Questo la Duse proprio non se l’aspettava e si disperò fino a riammalarsi pericolosamente.
Hermann Bahr, il grande critico che le aveva fatto da battistrada in tutto il mondo, scriveva:
«La Duse è stata la più grande attrice del mondo prima di D’Annunzio: ella non aveva bisogno di lui, artisticamente sarebbe “la grande lei” anche senza il piccolo pelato abruzzese. Ma come donna ci è diventata infinitamente più cara per la sua fedeltà, per il suo resistere a tutti i moniti, ai dubbi meschini e ai giudizi ingenerosi».
Eleonora aveva accettato di essere scavalcata dalla Bernhardt e dalla Grammatica in due debutti che le appartenevano di diritto, aveva subito in silenzio la pubblicazione de “Il Fuoco” che alludeva senza discrezione al loro tempestoso ménage mettendo a nudo intimità e segreti, aveva speso per lui somme di denaro ingenti togliendolo spesso da situazioni pericolose, poi, un giorno, Eleonora trovò nel loro letto, alla Capponcina, chiostro laico, sacello, bordello e fucina di pensieri, come diceva il vate, due fucine dorate della bionda Alessandra di Rudini.
Capì che più nulla avrebbe potuto salvare il loro turbinoso sodalizio, e si riappropriò allora di tutta la sua dignità, del rigore, dell’autostima e scrisse “all’orbo veggente”: «Prima mi pareva che avrei potuto fare per te le cose più umili e più alte, e ora mi sembra di non poter fare se non un cosa sola: andarmene, scomparire, lasciarti libero con la tua sorte.»
Erano le parole di Foscarina nel “Fuoco” che richiudevano il cerchio tossico della loro relazione.
Ruppero senza scene madri.
Lei ritrova conforto nella sua arte, nel suo teatro e nel suo pubblico. Riattraversa continenti e oceani e torna ad essere per tutti “la Divina”! La circonda una nuova fama e una nuova gloria, trasfigurata e illuminata però dalla leggenda del suo amore e del suo dolore.
Ma incominciò a desiderare solo la pace. Stava scendendo da un Calvario: gloria sublime e incontrastata, laceranti umiliazioni e voluttà sovrumane avevano vinto sulla sua fortissima tempra, sul suo vero fuoco che, ora, senza fiamme e senza scintille la sta totalmente consumando.
Lascia il teatro: dal 1909 al 1921 si interessa della questione femminile, organizza incontri, fa conferenze, scrive lettere; nel 1914 realizza “La libreria delle donne”, ma fra lo scoppio della Prima guerra Mondiale, il reale disinteresse culturale delle donne e delle attrici e mille bieche critiche, specie maschili, l’iniziativa fallisce senza scampo.
Poi la guerra, la vecchiaia, la malattia.
Una luce fugace nel 1916, quando, avvicinatasi all’emergente mondo del cinema, gira “Cenere”. Ne è entusiasta.
Compie qualche apparizione per i soldati al fronte, diventa mamma di guerra, genera e disponibile, fa la postina fra la prima linea e i familiari dei soldati.
I capelli sono tutti bianchi, ha imparato ad assistere gli invalidi, a rivedere Boito con serenità e a riscrivere a D’Annunzio senza esserne lacerata; ha imparato a sopportare la dolorosa maturazione dell’inevitabile, ha finalmente armonizzato “l’oblio col ricordo”. Le è d’aiuto declamare agli amici il “Cantico” di San Francesco e lo fa con speciale fervore cercando di dimenticare gli abissi del passato per concentrarsi nel mistero e nell’inquietudine di una Fede ancora senza nome.
Nel 1921, finita la guerra, Eleonora è colta di nuovo dalla febbre mai sopita del teatro; teme di ripresentarsi al suo pubblico dopo dodici anni vissuti o in solitudine o in Inghilterra in casa della sua figlia Enrichetta; dispone di poco denaro, il suo corpo è ancora più fragile, il viso più pallido e ancora più bello.
Ma prepara il rientro con cura “per non morire prima di essere morta”, avvolta nella dignità della sua vecchiaia, delle sue sofferenze e della sua immacolata povertà.
Il 5 maggio 1921 a Torino recita “La donna del mare” dell’adorato Ibsen e mai ritorno fu accolto così trionfalmente; questa accoglienza lusinghiera e rigeneratrice la incoraggia a ricominciare a girare il mondo fino il lunedì di Pasqua del 1924 quando nella fredda Pittsburg piena di neve, Eleonora Duse termina il suo delirante divagare.
Muore sola, a sessantasei anni stroncata dalla tubercolosi. Le ultime, sommesse e ansiose parole sono state:
«Partiamo, andiamo, c’è da lavorare…» per poi spegnersi in un «copritemi, riscaldatemi, ho freddo…»
In Italia ebbe funerali di Stato.
Ora guardando le sue immagini, le fotografie di scena, le caricature, gli abiti, ritratti, sentiamo sulla pelle, come un brivido, la sua appassionata inquietudine celata dalla dolcezza, dalla dignità e da quella assoluta e totalizzante vocazione teatrale.
Vorremmo poter parlare, ascoltare i suoi racconti, accarezzare i suoi capelli, sottrarla alla stupidità e agli sguardi indiscreti, offrirle rose bianche e sorrisi per consolarla di essere stata così straordinariamente e dolorosamente divina.
.
.
QUALITÀ IN SERIE
MOZART IN THE JUNGLE
a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
Serie ideata da Roman Coppola, Jason Schwartzman, Alex Timbers, Peter Weitz
1° episodio: “Mozart è tornato”
2° episodio: “Il quinto oboe”
3° episodio: “Sinfonia del silenzio”
4° episodio: “Insultare Tchaikovski”
5° episodio: “Sono con il maestro”
6° episodio: “Prove all’aperto”
7° episodio: “A caccia d’ispirazione”
8° episodio: “Un Mozart con il bacon”
9° episodio: “Ora, fortissimo!”
10° episodio: “La sera della prima”
Personaggi principali:
Gloria Windsor (Bernadette Peters) è la presidente del Comitato di gestione dell’Orchestra Sinfonica di New York. In tempi di crisi tocca a lei riuscire a convincere i benefattori a elargire generose somme di denaro e a prendere decisioni importanti, come il rinnovamento dell’immagine dell’istituzione.
Thomas Pembridge (Malcolm McDowell) è il direttore d’orchestra di stampo tradizionalista, un po’ cinico e incattivito dal tempo, costretto, con le difficoltà economiche, a cedere il proprio posto al nuovo arrivato, Rodrigo. Sarà tuttavia direttore musicale esecutivo emerito.
Rodrigo De Souza (Gael Garcia Bernal) è il nuovo direttore, a lui il compito di risollevare le sorti dell’ensemble e rivitalizzare la programmazione. Brillante e fuori dalle regole, con l’ossessione per la bellissima Ana Maria, una violoncellista geniale quanto imprevedibile…
Hailey Ruthledge (Lola Kirke) giovane oboista che sopravvive dando lezioni private, nell’attesa di trovare l’occasione giusta. Il suo sogno sembra coronarsi quando, dopo aver fatto un’audizione alla New York Symphony, Rodrigo decide di darle una chance. Ma la ragazza non è forse ancora pronta per il palcoscenico e fallisce nell’impresa. Tuttavia il maestro le propone di divenire la propria assistente personale.
Cynthia Taylor (Saffron Burrows) è l’affascinante secondo violoncello della New York Symphony, nonché capo del comitato orchestrale.
Union Bob (Mark Blum) è flautista, oltre ad essere il sindacalista dell’Ensemble, sempre puntuale nel rivendicare i diritti della compagnia per le pause durante le prove o il riconoscimento degli straordinari.
Betty (Debra Monk) oboista competitiva e inflessibile nei confronti della giovane Hailey, ciononostante decide di aiutarla e darle lezioni.
La serie ruota intorno all’Orchestra Sinfonica di New York le cui sorti sembrano vacillare, non certo per via dei suoi componenti, ma per difficoltà meramente economiche. Per dare nuovo impulso e incentivare l’ingresso di danaro, il Comitato di gestione decide di rinnovare la direzione dell’orchestra e di licenziare il maestro Thomas Pembridge che l’ha diretta per numerose stagioni, nominando il geniale ed estroso Rodrigo De Souza. Viene quindi messo a punto un vero e proprio restyling dell’Orchestra, con una serata di fundraising dove presentare ai suoi sostenitori, il nuovo affascinante maestro. L’arrivo di Rodrigo e il nuovo cartellone saranno sufficienti a sollevare le sorti della premiata Orchestra? Prodotta da Amazon Prime, la prima stagione di “Mozart in the jungle” è giunta sugli schermi italiani a metà luglio e proiettata da Sky Atlantic. Dieci episodi della durata di una trentina di minuti l’uno, che trae spunto dalle memorie dell’oboista Blair Tindall, “Sex, Drugs and Classical Music” il cui sottotitolo recita: “Quello che accade dietro le quinte della Symphony può essere altrettanto accattivante di quello che accade sul palco”. La vicenda ruota intorno al personaggio di Rodrigo De Souza, ispirato, anche se non dichiaratamente, al maestro venezuelano trentaquattrenne Gustavo Dudamel (l’enfant prodige notato da Claudio Abbado sin da giovane età, direttore d’orchestra di Göteborg, successivamente dell’orchestra nazionale del Venezuela e ora della prestigiosa Los Angeles Philarmonic) e ai componenti della sua nuova orchestra. A farci da guida in questa universo quanto mai variegato, la giovane oboista Hailey Ruthledge, su cui si apre il pilot. “Ogni respiro è un ponte verso un altro respiro”. Dall’appartamento lussuoso con una vista mozzafiato su New York che riprende la musicista intenta a dare lezioni al proprio allievo, la scena si sposta sul palcoscenico dove Thomas Pembridge sta dirigendo l’ultimo concerto. Il tono è presto definito da uno scambio di battute tra il violino solista e il direttore: “Non sarò andato troppo veloce per te, vero?” chiede il primo, “no, ti ho trovato un po’ lento”, replica il secondo. Nel raccontare i retroscena della vita di un gruppo di artisti, paure, rancori, debolezze, eccentricità, “Mozart in the jungle” è un congegno perfetto di ironia intelligente, freschezza, levità. Una scrittura dal ritmo impeccabile, sempre attenta a cogliere ogni più piccola variazione, a caratterizzare al meglio le psicologie dei suoi protagonisti, che per l’appunto mette in scena il mondo della musica classica da un’angolazione decisamente inedita, dalle prove al duro lavoro di chi intraprende una carriera in questo ambiente, alla necessità di trovare momenti di svago. Ideata da Roman Coppola e Jason Schwartzman (figlio e nipote di Francis Ford Coppola) sceneggiatore di Wes Anderson, il primo, attore feticcio che lo stesso Anderson ha visto crescere, da “Rushmore” passando per “Il treno per il Darjeeling” a “Moonrise Kingdom” fino al recentissimo “Grand Budapest Hotel” il secondo, insieme all’autore e regista di Broadway, Alex Timbers, e a Peter Weitz, “Mozart in the jungle” ha un’originalità che la differenzia da qualsiasi altra serie, per quel suo respiro cinematografico e quel suo lato, come qualcuno ha osservato, decisamente indie. Se ad essere protagonista indiscussa della serie è certamente la musica classica, colonna sonora che quasi ininterrottamente da Mozart a Tchaikovski, da Bach a Sibelius accompagna i suoi protagonisti in quel loro dibattersi, lo è certamente anche New York (da questo punto di vista la serie ha qualche punto in comune con Sex and the City, prodotta da HBO), che entra nel tessuto narrativo, è parte integrante delle vicende. Oltre e al di fuori del teatro, infatti, lo spazio urbano è presente coi suoi pub, le sue strade affollate, i suoi quartieri degradati dove improvvisare concerti non autorizzati, le sue eleganti dimore dove organizzare feste esclusive. Ma “Mozart in the jungle” deve anche la sua riuscita e unicità a un cast veramente d’eccezione, a partire da Malcom Mc Dowell, nei panni del canuto direttore d’orchestra ad un talentuoso e più che mai ispirato Gael Garcia Bernal, in quelli di Rodrigo, alla giovanissima Lola Kirke, a Bernadette Peters a Debra Monk a Mark Blum, a un indimenticabile Wallace Shawn nei panni di un pianista dalla fama leggendaria, ossessionato dalla figura materna.
Luisa Ceretto
.
.
HOME VIDEO
GRANDI STORIE PER LEGGERE IL PRESENTE
a cura di Giancarlo Zappoli
 COFANETTO SELEZIONE SPECIALE BIOGRAFIM FESTIVAL
COFANETTO SELEZIONE SPECIALE BIOGRAFIM FESTIVAL
Gli appassionati di cinema e di documentario sanno quanto il Biografilm Festival che si tiene annualmente a Bologna sia una delle manifestazioni più importanti in materia anche perché chi lo organizza si è scelto un ambito prima mai esplorato con rigore professionale. In collaborazione con Cine Hollywood nella collana Documentaria è uscito di recente un cofanetto che raccoglie i 5 docu-film vincitori al Festival, tutti di grande interesse.
Ne riportiamo qui le informazioni fondamentali
.
.
.
.
Regia: Joshua Oppenheimer
Definito da Werner Herzog come “il film più potente, surreale e spaventoso dell’ultimo decennio” il documentario fa riferimento a quando, nel 1965, i paramilitari del movimento Pancasila realizzarono un colpo di stato che si trasformò in un genocidio. Oltre un milione di ‘comunisti’vennero massacrati. Gli assassini di allora sono oggi delle persone benestanti che qui ‘fanno del cinema’. Ricostruiscono e mettono in scena i loro atti criminosi giungendo anche a interpretare il ruolo delle vittime. Il regista segue il loro compiacimento ma anche le loro riflessioni su quanto hanno fatto.
.
Regia: Errol Morris
Donald Rumsfeld è stato membro del congresso, consigliere di quattro presidenti degli Stati Uniti e due volte Segretario della Difesa. Può essere considerato uno dei principali fautori dell’entrata in guerra in Iraq. Si confronta con Errol Morris utilizzando i suoi innumerevoli appunti che i collaboratori definivano ‘fiocchi di neve’: Convinto com’è che la vera pace possa sorgere solo dalla forza si mostra freddo e controllato ma la camera che indaga sul suo volto rivela talvolta anche il non detto.
.
.
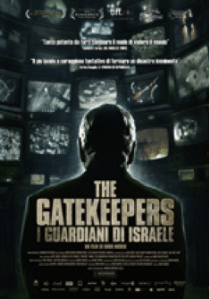 THE GATEKEEPERS. I GUARDIANI DI ISRAELE
THE GATEKEEPERS. I GUARDIANI DI ISRAELE
Regia: Dror Moreh
Sei capi del temutissimo “Shin Bet” la forza di sicurezza più segreta che opera in Israele raccontano la loro verità su numerosi eventi che li hanno visti coinvolti. Si va dalla Guerra dei Sei Giorni alle Intifade fino ai negoziati di pace. Si tratta di un documentario che è stato candidato all’Oscar e che ha fatto molto discutere anche in Israele sollevando dubbi sull’affermata “logica superiore” che presiede alla difesa dello Stato.
.
.
.
 FEMEN. L’UCRAINA NON E’ IN VENDITA
FEMEN. L’UCRAINA NON E’ IN VENDITA
Regia: Kitty Green
Un documentario sulle Femen che hanno movimentato in più occasioni la scena internazionale con le loro provocatorie esibizioni potrebbe risolversi facilmente in una celebrazione del femminismo in forma ucraina. Kitty Green non si accontenta di una versione stereotipata del movimento ed indaga portando alla luce le strutture patriarcali che stanno alla base del movimento rivelando così un suo aspetto che di femminista ha ben poco.
.
.
 25%. I SEGRETI DELLA GUERRA ALLA DROGA
25%. I SEGRETI DELLA GUERRA ALLA DROGA
Regia: Eugene Jarecki
Esistono le droghe dei ricchi e quelle dei poveri. Cerca di spiegarne il motivo il documentarista Eugene Jarecki partendo da un dato forse poco noto: il 25% della popolazione carceraria mondiale si trova negli Stati Uniti. Questo lo spinge ad interrogarsi chiedendosi se le leggi promosse sia dai repubblicani che dai democratici abbiano o meno arginato il mondo del crimine che gira intorno allo spaccio degli stupefacenti. La risposta di questo film vincitore al Sundance non è ottimistica.
.
.
.
THE EPIC OF EVEREST. IL MISTERO DI MALLORY E IRVINE
di Giancarlo Zappoli
 George Herbert Leigh Mallory e Andrew “Sandy” Irvine sono stati i primi due scalatori in assoluto a tentare l’ascesa dell’Everest nel 1924. L’impresa li condusse alla morte dopo che furono visti per l’ultima volta a circa 245 metri dalla vetta. Il corpo di Mallory è stato ritrovato solo nel maggio del 1999 e resta ancora materia di discussione se i due fossero ancora nella fase di ascesa o in quella di ritorno. Il documentario “The Epico f Everest. Il mistero di Mallory e Irvine” fornisce una testimonianza di interesse eccezionale sia per chi sia appassionato di montagna o abbia apprezzato il film “Everest” di Baltasar Kormákur che aperto la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2015. Perché si tratta non della ricostruzione a posteriori dell’impresa ma delle riprese che il capitano John Noel realizzò al seguito della spedizione. Restaurato dal British Film Institute e vincitore (grazie alla colonna sonora musicale originale) dell’Ivor Novello Award del 2014 il film non solo descrive con abbondanza di particolari (numerosi sono i cartelli di accompagnamento) lo spirito dell’impresa ma offre anche le prime immagini realizzate da occidentali sulla vita degli abitanti del Tibet.
George Herbert Leigh Mallory e Andrew “Sandy” Irvine sono stati i primi due scalatori in assoluto a tentare l’ascesa dell’Everest nel 1924. L’impresa li condusse alla morte dopo che furono visti per l’ultima volta a circa 245 metri dalla vetta. Il corpo di Mallory è stato ritrovato solo nel maggio del 1999 e resta ancora materia di discussione se i due fossero ancora nella fase di ascesa o in quella di ritorno. Il documentario “The Epico f Everest. Il mistero di Mallory e Irvine” fornisce una testimonianza di interesse eccezionale sia per chi sia appassionato di montagna o abbia apprezzato il film “Everest” di Baltasar Kormákur che aperto la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2015. Perché si tratta non della ricostruzione a posteriori dell’impresa ma delle riprese che il capitano John Noel realizzò al seguito della spedizione. Restaurato dal British Film Institute e vincitore (grazie alla colonna sonora musicale originale) dell’Ivor Novello Award del 2014 il film non solo descrive con abbondanza di particolari (numerosi sono i cartelli di accompagnamento) lo spirito dell’impresa ma offre anche le prime immagini realizzate da occidentali sulla vita degli abitanti del Tibet.
 BEATLES 1 A Magical Tour
BEATLES 1 A Magical Tour
di Marco Incerti Zambelli
Deluxe Edition è un precisa definizione di The Beatles 1+ : il piacere inizia già nell’estrarre l’elegante cofanetto dalla custodia rossa e blu: due bluray, un cd, un booklet che accompagna, canzone per canzone, tutte le tracce audio e video, ricchissimo di immagini ed informazioni.
Il cd contiene, rimasterizzate, le 27 canzoni che raggiunsero il primo posto nelle classifica di vendita, il primo bluray video clip delle stesse 27 canzoni ed il secondo, o meglio l ‘1+ , 23 ulteriori video, sia di pezzi diversi che Alternative Takes.
E qui il piacere diventa meraviglia : il restauro delle immagini è superbo e la resa sonora sontuosa, con tre possibilità: stereo PCM, DTS HH master 5.1, Dolby digital. Le clip sono di diverso tipo, tratte da concerti dal vivo, apparizioni televisive, filmati girati espressamente e precursori dei video musicali, animazioni, montaggi di situazioni diverse. Alcuni di questi erano stati messi in commercio e circolavano da tempo, altri noti solo ai collezionisti, qualcuno del tutto inedito o prodotto appositamente per questa edizione. Anche le tracce audio dei bluray sono di differente origine, spesso sono le registrazioni live originali, a volte incisioni da studio, in altri casi un mix di basi preregistrate e esibizione dal vivo, rese necessarie dal sorprendente divieto della BBC a metà degli anni sessanta che vietava il playback ed i Beatles diedero fondo alla loro inventiva per aggirare il divieto (il booklet è prodigo di informazioni al riguardo) I primi filmati fotografano perfettamente la nascita della Beatlemania, i quattro ragazzi si divertono e divertono, pure un poco ingessati tra giacche edoardiane e cravatte, in educate riprese televisive o anonime riprese di concerti , anche se non manca una sorprendente Twist and shout dal sapore espressionista. A fare da trait d’union con la fase successiva sono le immagini che accompagnano Eight days a week, estratte dal concerto allo Shea Stadium di New York del 1965 (dove, comunque, non eseguirono quella canzone): i Beatles erano diventati un successo planetario, erano richiesti da ogni parte, ogni canale televisivo li invitava e così venne loro in mente di realizzare dei filmati da inviare ai programmi di tutto il mondo per promuovere i loro dischi.
Il 23 novembre del ’65 dal tardo pomeriggio alla mattina successiva girarono 10 (dieci !) clip in bianco e nero di 5 canzoni, la maggior parte dei quali si possono qui vedere, con alla regia Joseph McGrath ( che poco dopo debuttò nel cinema con Casino Royal)
In una assoluta povertà di mezzi, in uno studio praticamente spoglio, con elementari oggetti di scena, un ombrello, un pungiball, una cyclette, la creatività è sorprendente, basti confrontare in 1+ le due versioni di Day Tripper (tracce 5 e 6 ): la prima non avrebbe sfigurato nel coevo Studio Uno, con quelle ballerine all’inizio che paiono coreografate dal primo Don Lurio ed i quattro sorridenti in impeccabile abito scuro, la seconda, girata venti giorni dopo, in una atmosfera stralunata, su un impossibile aereo di cartone e dentro un vagone di legno, le giacche dello Shea Stadium, con Ringo grande protagonista che, tra un colpo di tamburello ed una rullata su una batteria che non c’è, prova a distruggere con una sega la scenografia. E la loro espressione beata non lascia molti dubbi su che tipo di viaggio stiano cantando. Oppure l’inedito I Feel Fine , ribattezzato I Feel Fried perché vede i quattro intenti a mangiare Fish & Chips direttamente dall’involto di carta di giornale, mentre mimano a stento le parole, così irriverente da essere stato bandito dal manager Brian Epstein.
I Beatles si muovono con disinvoltura di fronte alla macchina da presa , avevano già girato A hard days’s night e Help per la regia di Richard Lester ed a quel tipo di cinema, pur nella estrema scarsezza di tempo e mezzi, si ispirano questi proto videoclip; lo stesso McGrath aveva lavorato ad una prima stesura della sceneggiatura di Help.
Il colore arriva pochi mesi con i promo (doppi) di Rain e Paperback Writer.
Alla regia è Michel Lindsay Hogg che i quattro avevano conosciuto per il suo lavoro in Ready, Steady go, una trasmissione musicale della ITV che presentava ogni venerdì molti dei gruppi rock dell’epoca.
Lindasy Hogg, presunto figlio naturale di Orson Welles, al quale fisicamente assomiglia sorprendentemente e che il genio americano volle sul palco con lui a teatro e che favorì all’inizio della sua carriera, divenne una figura centrale nel nascente mondo delle produzioni di filmati musicali, diresse altre clip dei Beatles, il film Let it be e lavorò a lungo anche con i Rolling Stones. Realizzerà nel 2000 un film tv, “Two of us”, dal titolo di una canzone di Let it be, che immagina l’incontro nella New York del 1976 tra John Lennon e Paul McCartney.
Pur nella loro semplicità, i quattro filmati, soprattutto i due in esterno, ambientati in un parco, preludono alla esplosione psichedelico-creativa dell’inizio del ’67.
Paul McCarney, in uno dei non trascendentali commenti ad alcuni video ( più divertenti le svagate introduzioni di Ringo), racconta che incontrarono Peter Goldman, un regista televisivo svedese, in un locale notturno e a partire da una comune passione per Ingmar Bergman (!) decisero di realizzare dei promo del loro singolo in uscita. Il divieto della BBC al mimic li spinse a liberare al massimo la loro creatività: abbandonarono completamente la messa in scena dell’esecuzione delle canzoni e crearono così i primi video rock come li conosciamo oggi.
Se il filmato di Penny Lane, pur estremamente innovativo e segnato da un allegro surrealismo pop, rimane comunque una più o meno letterale visualizzazione del testo, Strawberry Fields Forever, è un’altra cosa: Richard Lester che incontra Kenneth Anger nella Twilight Zone, come ebbe a dire un critico all’epoca, in una dimensione fortemente segnata dalla psichedelia, l’accompagnamento visivo perfetto per quella canzone in quel periodo: ambientazioni magiche, giochi di luce, sovrapposizioni di immagini, accelerazioni e rallentamenti, enigmatici primi piani dei quattro.
Ma è A day in the life, di totale paternità Beatles, che segna l’apice della fantasia creativa, dell’originalità inventiva di quell’epoca. Girata in poche ore, dalle otto di sera all’una del mattino, è la cronaca serenamente allucinata della seduta di registrazione della prodigiosa minisuite, uno dei massimi capolavori dei quattro, tra ospiti prestigiosi (i Rolling Stones, Donovan), un’orchestra di 40 professionisti totalmente coinvolti senza alcun imbarazzo in quella follia, travestimenti ed invasioni di fans. E’ del tutto sorprendente pensare che i primi videoclip filmati in bianco e nero erano di solo un anno prima.
Alcune delle suggestioni di quella sera, opportunamente addolcite, torneranno per la celeberrima All you need is love, trasmessa in diretta mondovisione per la prima volta via satellite nel programma Our world e qui riproposta in una versione a colori. E’ l‘apoteosi di quella incredibile estate, con John Lennon che canta, magnificamente, dal vivo ad occhi chiusi mentre beatamente mastica chewing gum.
 A fare da raffinata cornice alla stagione psichedelica le animazioni di “Yellow Submarine” (creata appositamente a partire dai materiali originali del cartoon omonimo) ed Eleonor Rigby, insieme al filmato di Within you, without you/Tomorrow never knows, suggestivo collage di immagini di quel periodo.
A fare da raffinata cornice alla stagione psichedelica le animazioni di “Yellow Submarine” (creata appositamente a partire dai materiali originali del cartoon omonimo) ed Eleonor Rigby, insieme al filmato di Within you, without you/Tomorrow never knows, suggestivo collage di immagini di quel periodo.
La fase “high” sfuma nelle riprese di Hello Goodbye, qui presente in tre versioni che poco aggiungono l’una all’altra, se non il mostrare il piacere di suonare insieme e la allora ancora ben salda sintonia del gruppo.
Ed è proprio il suonare insieme il leitmotiv della maggior parte dei video seguenti.
I Beatles avevano smesso di esibirsi in pubblico dal 1966 ma non avevano certamente smesso di fare musica e produrre dischi, era necessario quindi rispondere all’esigenza di presentare le nuove composizioni.
Dopo la curiosa clip di Lady Madonna (i quattro, ripresi in studio, stanno in realtà registrando Hey,
bulldog, oggetto di un altro filmato) viene richiamato Michel Lindasy Hogg, che dirige Revolution e la esibizione live Hey Jude. “Il problema era come visualizzare i 4 minuti del lungo coro finale” racconta il regista “e venne in mente a Paul che avremmo potuto chiamare un gruppo di persone, non i soliti fans che stazionavano fuori dalla studio, ma uno spaccato di persone di diversa età, di diverso colore, di diverse professioni che avrebbero potuto cantare in coro ed aiutare la resa visiva della canzone come i Beatles stessi: e funzionò meglio di quanto potessimo mai aspettarci perché la interazione tra il pubblico ed il gruppo fu formidabile”.
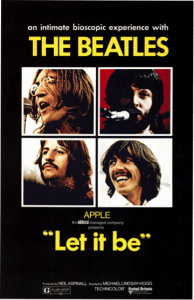 Le 80 ore di materiale che verranno utilizzate per il film “Let it be”, compreso il famoso Rooftop concert, ultima esibizione dal vivo, formano la base per molti dei video di quel periodo per questa raccolta.
Le 80 ore di materiale che verranno utilizzate per il film “Let it be”, compreso il famoso Rooftop concert, ultima esibizione dal vivo, formano la base per molti dei video di quel periodo per questa raccolta.
E’ sorprendente la naturale eleganza dei Beatles, la loro sorprendente capacità di essere icone pop, che indossino vestiti mod o ornamenti hippie, i quotidiani abiti in sala di incisione o i giacconi per difendersi dal freddo nel concerto sul tetto, i capelli più o meno lunghi, con la barba e senza.
Il vertice di coolness è nei due filmati autoprodotti di Something e The ballad of John and Yoko.
Nel primo i quattro ormai del tutto separati, sono ripresi, con suggestivi primi piani, nelle loro dimore di campagna con le rispettive compagne dell’epoca, nel secondo alle immagini reali del matrimonio di John e Yoko si alternano, nel ritornello, le sedute di incisione in studio del gruppo al completo, come a ribadire che quella è ancora una canzone dei Beatles (anche se in realtà sono solo John e Paul ad inciderla, suonando tutti gli strumenti). Il finale non può che essere virtuale: se Come Togheter è decisamente modesto, risentendo delle limitazioni dell’epoca, pensato per la rete quando la velocità dei modem era di 56K, Real Love alterna felicemente riprese della reunion del 1995, nella quale i tre superstiti realizzano a partire da un demo di John un “nuovo“ disco dei Beatles, con inedite e commoventi immagini di repertorio.
Ed è Free as a Bird, nato nelle stessa occasione, che fa tuffare in un meraviglioso ed emozionante percorso tra decine di citazioni beatllesiane, un poetico e toccante viaggio in una avventura indimenticabile.
Vale la pena regalarsi un paio d’ore per ripercorrerla tutta di seguito.
E, naturalmente, play it loud.
.
.
.
PANORAMA LIBRI
a cura di Paolo Micalizzi
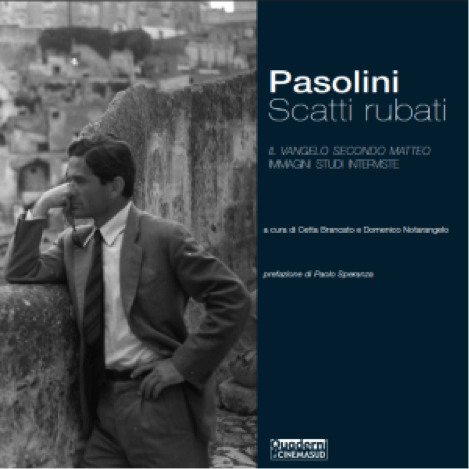 PASOLINI. SCATTI RUBATI
PASOLINI. SCATTI RUBATI
IL VANGELO SECONDO MATTEO
IMMAGINISTUDIINTERVISTE
a cura di Cetta Brancati e Domenico Notarangelo
Quaderni di Cinema Sud 2015,
pagg.75,
Euro 12.00
“Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini è un film mitico. Sul set della sua realizzazione a Matera era presente Domenico Notarangelo. Questa esperienza la racconta in questo volume che ha curato insieme a Cetta Brancati. Aveva il compito di vigilare , come segretario dei giovani comunisti materani, sulla persona di Pier Paolo Pasolini per evitare, come si temeva, che potesse essere oggetto di aggressione da parte di neofascisti, cosi come era avvenuto in altre città. Ma non era per quel motivo che Pasolini lo volle incontrare bensì per cercare una cinquantina di volti che potessero svolgere il ruolo dei sacerdoti e dei farisei, “facce stronze” precisò Pasolini. Li cercò nella sezione del Partito Comunista “schiodandoli dai tavoli da gioco”. Portatili in albergo da Pasolini, lo scrittore-regista li trovò adatti. In seguito Pasolini lo volle come “comparsa speciale”: il centurione romano che seguì Gesù sulla strada per il Golgota. Ebbe l’intuizione di fotografare Pasolini e il set: quando era di scena nascondeva le fotocamere fra le gambe sotto il gonnellino di centurione e quando era libero, essendo considerato amico di Pasolini, circolava liberamente sul set a fotografare, anche se il fotografo ufficiale era Angelo Novi. Furono, insomma, “scatti rubati”. Ma l’intervista a Notarangelo ci porta a scoprire dati interessanti della realizzazione del film: la scelta delle comparse, l’affettuoso rapporto tra Paolini e la madre Assunta, i dialoghi con il Cristo Enrique Irazoqui che aveva conosciuto Pasolini perché, per incarico del sindacato clandestino antifranchista, voleva che andasse a Barcellona per fare conferenze all’università. Lo scrittore- regista glielo promise, e mantenne, a patto che Irazoqui diventasse il Cristo. E fu una scelta, come si constatò poi, molto indovinata.
 IL CINEMA DI CLAUDIO GORA
IL CINEMA DI CLAUDIO GORA
a cura di Emiliano Morreale
Rubbettino 2013,
pagg.142,
Euro 9,90
Claudio Gora è uno dei grandi autori italiani da riscoprire. Attore che si è avuto modo di apprezzare in modo particolare in film come “Un maledetto imbroglio” (1959) di Pietro Germi e “Una vita difficile” (1961) di Dino Risi. Ma ha offerto incisivi ritratti in tanti altri film , a partire dal 1939 fino al 1991.E’ stato anche regista di opere che si sono distinte nel cinema italiano degli anni Cinquanta. Il riferimento è in particolare a “Il cielo è rosso”( 1950) tratto dal romanzo di Giuseppe Berto ed a “Febbre di vivere” (1953), liberamente tratto dal dramma “Cronaca” di Leopoldo Trieste, che gli valse un Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista.. Due opere sulla crisi di valori della nuova generazione uscita dalla guerra. Importante è anche “La contessa azzurra”, con protagonista Amedeo Nazzari, che per Morreale è un autoritrattro del regista. Una personalità multiforme quella di Claudio Gora ( il cui vero nome è Emilio Giordana, da cui il figlio Andrea nato dal suo matrimonio con l’attrice Marina Berti, anch’essa ingiustamente dimenticata) che questo volume di Emiliano Morreale porta alla ribalta fornendo alcune analisi di firme qualificate come Goffredo Fofi, Anton Giulio Mancino, Paolo Mereghetti e altri. Importante anche il suo pensiero sul suo cinema che si può conoscere attraverso alcune interviste ed importante è anche la sua attività teatrale, televisiva e di doppiatore che emerge dai saggi di Ennio Bispuri ed Enrico Lancia. Senza trascurare il ritratto affettuoso di “mamma e papà” tracciato dalla figlia Cristina. Un Omaggio più che doveroso ad uno ( anzi a due) protagonisti del nostro cinema. Un’ampia filmografia dà conto della sua intensa attività cinematografica che aiuta a ricordarlo come figura di rilievo del cinema italiano.
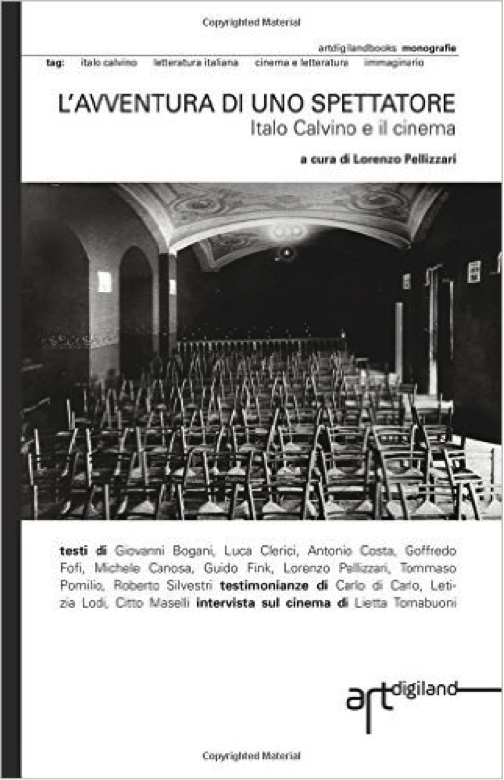 L’AVVENTURA DI UNO SPETTATORE
L’AVVENTURA DI UNO SPETTATORE
Italo Calvino e il cinema
a cura di Lorenzo Pellizzari
artdigiland boox 2015,
pagg. 229, s.i.p
Si tratta della nuova edizione di un volume edito nel 1990, motivata dal trentennale della scomparsa di un illustre letterato: Italo Calvino. Un’edizione, a cura di Lorenzo Pellizzari, che ripropone oltre al suo Saggi di Goffredo Fofi, Antonio Costa, Michele Canosa, Guido Fink, Giovanni Bogani presentati in occasione dei Colloqui calviniani ideati da Stefano Beccastrini e svoltosi nel 1986 e 1987 a San Giovanni Valdarno dove rivestiva il ruolo di Assessore Comunale. Un’edizione ampliata con due nuovi saggi, dovuti a Roberto Silvestri ed a Luca Clerici, contenente anche alcune testimonianze come quelle di Francesco Maselli , Carlo di Carlo e Letizia Lodi ed un’intervista a Lietta Tornabuoni realizzata in occasione di Italo Calvino giurato alla Mostra di Venezia 1981.Ne risulta un’edizione che riporta alla ribalta “l’avventura di uno spettatore”, come recita il sottotitolo del libro. Il volume comprende anche interessanti informazioni sulle opere, sia per il cinema che per la televisione, tratte da testi di Calvino e da alcuni articoli cinematografici dello scrittore che illuminano sul suo pensiero sul cinema.
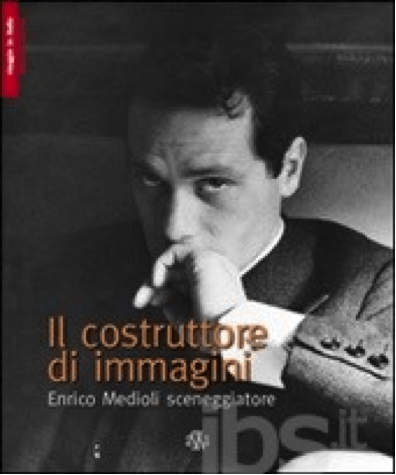 IL COSTRUTTORE DI IMMAGINI
IL COSTRUTTORE DI IMMAGINI
ENRICO MEDIOLI SCENEGGIATORE
a cura di Roberto Mancini e Francesca Medioli
Aska edizioni 2015,
pagg. 143, s.i.p.
Un volume su Enrico Medioli, sceneggiatore di origine parmense, che ha avuto, a partire dal 1960, un intenso sodalizio artistico con Luchino Visconti (“ Rocco e i suoi fratelli”, ”Il Gattopardo”,” L’Innocente”, tra gli altri) ma anche con Valerio Zurlini( “La ragazza con la valigia” e “La prima notte di quiete” innanzitutto) ed ha collaborato, tra gli altri, con Giuliano Montaldo, Alberto Lattuada, Vittorio Caprioli, Mauro Bolognini, Liliana Cavani, Sergio Leone. Un’attività di tutto rispetto, soprattutto con Autori con la A maiuscola e con altri di primo piano del cinema italiano. Un impegno al cinema, il suo, dove si considerava un “costruttore” con il mestiere di “narrare immagini” per agganciare l’attenzione dello spettatore. Sul suo lavoro testimonia Gianluigi Rondi che annota come Medioli “portava splendidamente il suo contributo di ispirato narratore senza mai sopraffare il regista-autore, uno dei suoi molti e più grandi meriti”. Alcuni interventi su “Il mestiere di scrivere” danno poi un contributo significativo alla conoscenza dello sceneggiatore, cosi come alcune testimonianze di gente di cinema che lo ha conosciuto nella sua attività. Il volume nasce grazie alla volontà della nipote Francesca per omaggiare i 90 anni di questo Maestro, uno sceneggiatore di primo piano del cinema italiano.
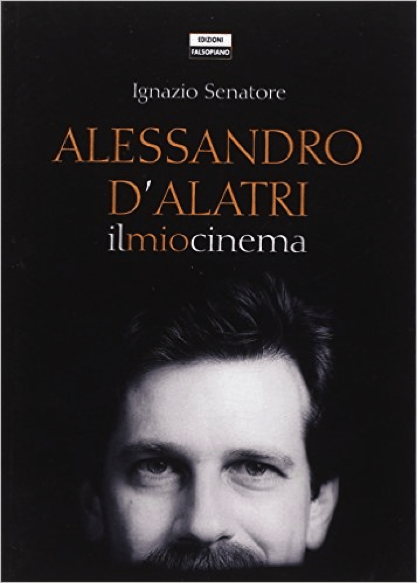 ALESSANDRO D’ALATRI
ALESSANDRO D’ALATRI
il mio cinema
di Ignazio Senatore
Edizioni Falsopiano 2015,
pagg. 179,
Euro 20,00
Una conversazione, anzi conversazioni, piacevolissima, come afferma l’autore del libro nell’introduzione, che affronta vari temi legati all’attività cinematografica di Alessandro D’Alatri, figura di rilievo del cinema italiano. Conversazioni che partono dalla visione dei primi film accompagnato dal padre pittore e dalle sue prime esperienze , a 8 anni, di attore teatrale per Visconti e, successivamente, per gli sceneggiati televisivi di Bolchi e Cottafavi, ma anche dei Caroselli dove faceva pubblicità per la Lambretta Innocenti. Poi, il cinema con il film “Come, quando, perché” di Antonio Pietrangeli che, morto in un incidente sul set venne portato a termine da Valerio Zurlini, dove interpretava Philippe Leroy bambino. Indi, l’importante esperienza ne “Il giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica. E finalmente, nel 1991, l’esordio dietro la macchina da presa con “Americano rosso” con il quale, pur essendo stata una sconfitta sul piano commerciale, vinse il David di Donatello come miglior debutto ed il Ciak d’oro oltre ad essere invitato a numerosi festival internazionali: “ In qualche modo avevo preso la patente di regista di cinema” ha dichiarato l’autore. Il film successivo fu “Senza pelle”( 1994) cui fecero seguito, dopo un mancato film in America con Jovanotti, “I giardini dell’Eden”(1998), “Casomai” (2002”), “La febbre”(2004), “Commediasexi”(2006) e ”Sul mare”(2010). Film sui quali D’Alatri si diffonde nelle sue conversazioni con Ignazio Senatore raccontandone vicissitudini, positive e negative, che forniscono elementi interessanti per la loro valutazione sul risultato finale. Film dei quali viene redatta una scheda comprendente anche un’”antologia critica” che stimola a meglio inquadrare il loro valore. Il libro è arricchito da un inserto fotografico di immagini sul set e sui film.
AUTORI
Nella sezione dedicata agli autori troverete la biografia di ognuno.
Credits n.7
Carte di Cinema
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: cartedicinema@hotmail.com CONTROLLARE INDIRIZZO E-MAIL
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi
Direttore editoriale: Roberto Merlino
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 6 dalla rivista online: Ivana Baldassarri, Laura Biggi, Vittorio Boarini, Bruno Brusaporco, Carlotta Bruschi, Eleonora Carrara, Gianluca Castellini, Luisa Ceretto, Vittorio Giacci, Elio Girlanda, Roberto Lasagna, Stefano Macera, Francesco Saverio Marzaduri, Paolo Micalizzi, Judit Pintér, Andreina Sirena, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Marco I. Zambelli, Giancarlo Zappoli.