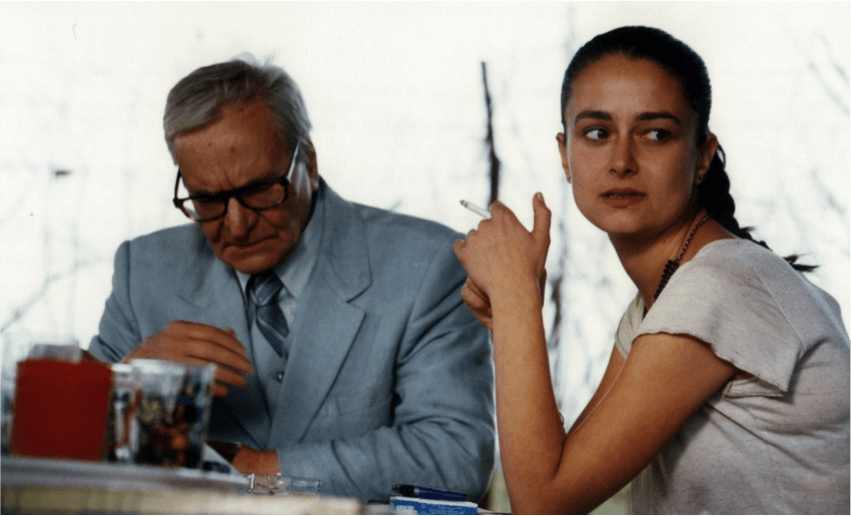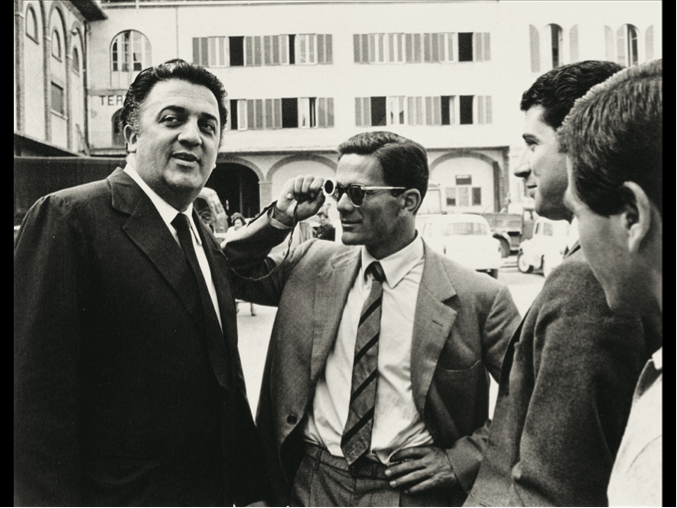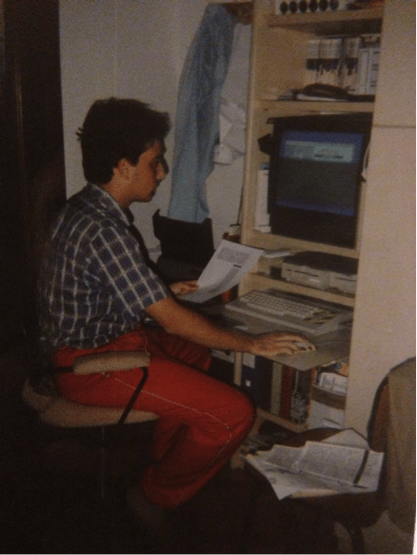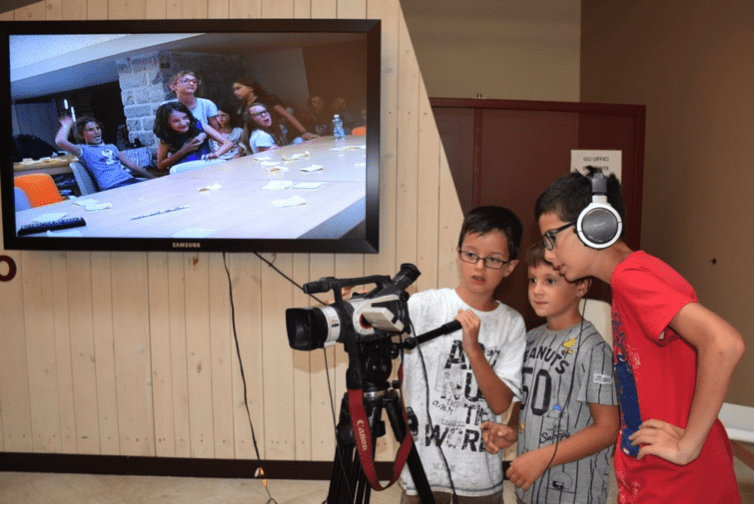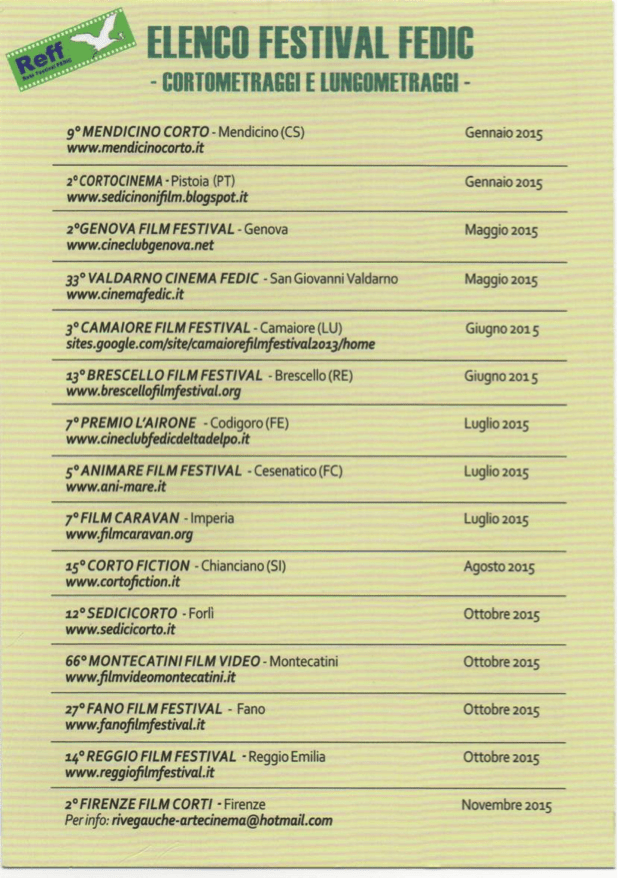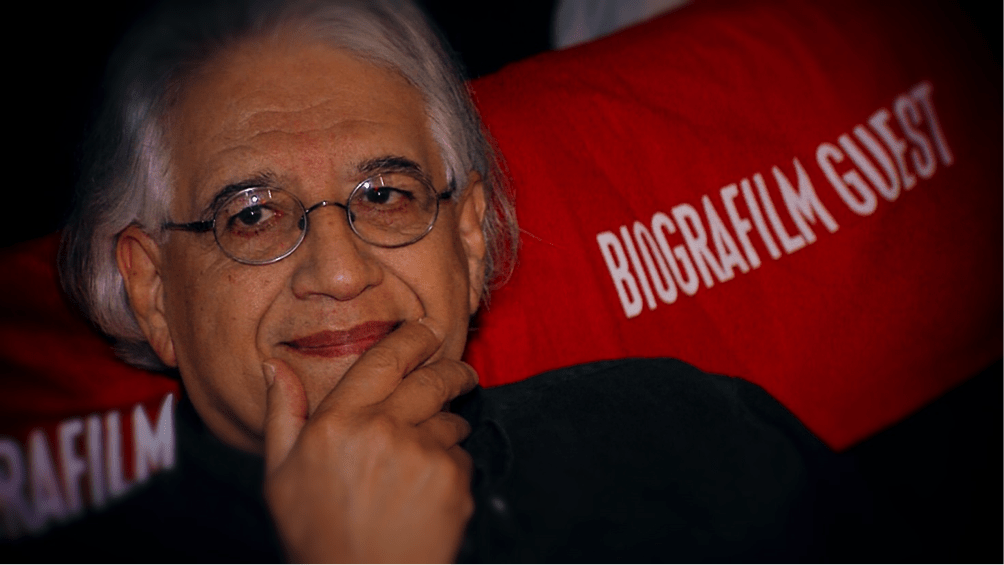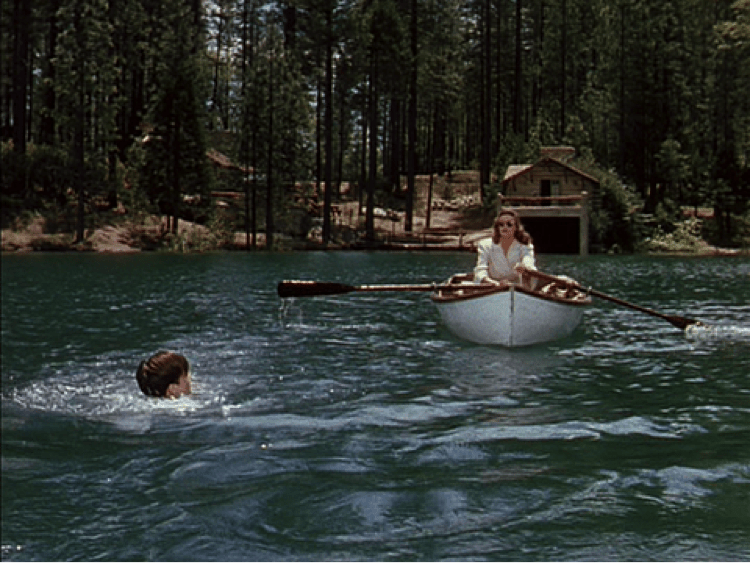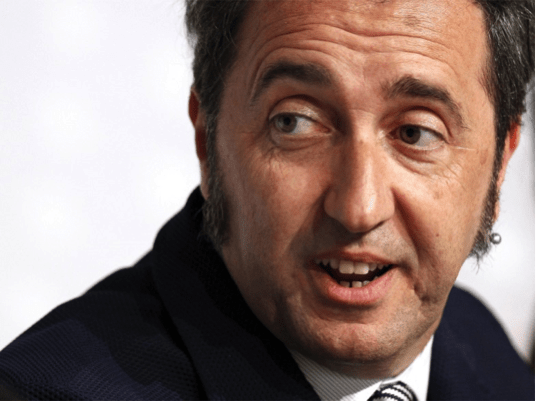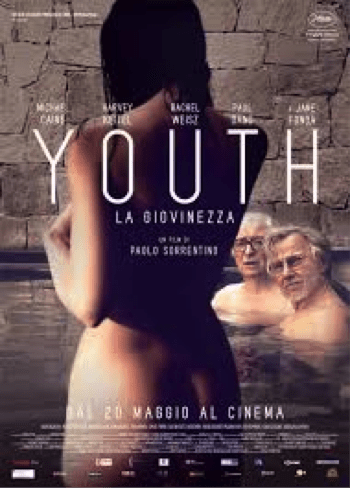Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 5.1 CANNES 2015: UN’EDIZIONE NON PROPRIO BRILLANTE di Giancarlo Zappoli
- 5.2 WE WILL ALWAY HAVE CANNES di Laura Cacciamani e Francesca Bernardi
- 5.3 RIVER TO RIVER FLORENZE FILM FESTIVAL: PAS DE DEUX di Maria Pia Cinelli
- 5.4 IL NUOVO CORSO DELLA MOSTRA DI PESARO di Paolo Micalizzi
- 5.5 BIOGRAFIE E STORIE DI VITA AL BIOGRAFILM FESTIVAL DI BOLOGNA di Paolo Micalizzi
- 5.6 DEDICATO A GIAN MARIA VOLONTÈ IL CAMAIORE FILM FESTIVAL 2015 di Paolo Micalizzi
- 5.7 UN QUALIFICATO E SIMPATICO FESTIVAL NEL PAESE DI DON CAMILLO di Paolo Micalizzi
- 6 CLASSICI
- 7 OCCHIO CRITICO
- 8 NEO-CINEMA a cura di Elio Girlanda
- 9 VISTI DA LONTANO
- 10 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
- 11 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 12 Credits n.6
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
PINTILIE LA SOTTILE LINEA (ROSSA) di Francesco Saverio Marzaduri
Maestro indiscusso del cinema romeno, dietro un apparente classicismo, Lucian Pintilie rivela un’enigmatica complessità ch’è fonte d’ispirazione per i giovani registi del Noul Val, sia nella denuncia verso le contraddizioni del Paese, sia nella tecnica cinematografica con cui esprimere tale politique.
SAGGI
PASOLINI E LA PRODUZIONE: LE AVVENTURE DI UN AUTORE INDIPENDENTE AL CENTRO DELL’INDUSTRIA CULTURALE di RobertoChiesi
Scrittore e regista spesso perseguitato dalla censura, Pier Paolo Pasolini ha goduto quasi sempre di una certa libertà produttiva, paradossalmente, anche grazie al successo di “scandalo” di alcuni suoi film. Rappresenta un caso emblematico di autore che ha mantenuto la propria indipendenza creativa lontana dai compromessi e dalle “normalizzazioni” dell’industria culturale pur rimanendo sempre al centro dell’industria stessa.
VOSCENZA BENEDICA di Giulio D’Amicone
In Italia (come in altri paesi) siamo da sempre avvezzi al doppiaggio. Alla maggior parte del pubblico sembra naturale vedere Harrison Ford o Meryl Streep muovere le labbra e parlare in italiano, senza riflettere che, in realtà, si tratta di un assurdo. In questo articolo si tenta un breve elenco di improprietà – alcune piuttosto gravi – imputabili alle scelte e ai problemi relativi al doppiaggio.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
FILMMAKER ALLA RIBALTA: ETTORE DI GENNARO di Paolo Micalizzi
Un ampio profilo di un autore Fedic i cui film, realizzati per e con altri soci della 3dproduction, tendono, soprattutto, a sperimentazioni di tipo parodistico.
CINEMA E SCUOLA di Laura Biggi
Resoconto degli obiettivi e delle attività recenti di Fedic Scuola
REFF – RETE FESTIVAL FEDIC.” I FESTIVAL SONO VICINI” di Gianluca Castellini
Articolo che riferisce su scopi e obiettivi della Rete Festival Fedic
TREDICESIMO STAGE FEDIC: INTERVISTA AD ALESSANDRO GRANDE di Roberto Merlino
Intervista al regista e sceneggiatore Alessandro Grande , docente dello Stage diretto dal Presidente Fedic Roberto Merlino
FESTIVAL ED EVENTI
CANNES 2015: UN’EDIZIONE NON PROPRIO BRILLANTE di Giancarlo Zappoli
Resoconto dell’edizione del 2015, di una tra le più prestigiose vetrine internazionali. Anche quest’anno Cannes ha confermato un programma ricco di opere interessanti, di maestri ma anche di giovani autori. Insieme ad uno “sguardo” esperto e rinomato nel mondo della critica cinematografica, ne proponiamo uno “inedito” di due giovani cinefile, che hanno aderito al progetto dell’Agis, Premio David Giovani, in qualità di giurate (sezione di Bologna), oltre ad aver collaborato al blog di “Cinefilia ritrovata“.
WE WILL ALWAY HAVE CANNES di Laura Cacciamani e Francesca Bernardi
Resoconto dell’edizione del 2015, di una tra le più prestigiose vetrine internazionali. Anche quest’anno Cannes ha confermato un programma ricco di opere interessanti, di maestri ma anche di giovani autori. Insieme ad uno “sguardo” esperto e rinomato nel mondo della critica cinematografica, ne proponiamo uno “inedito” di due giovani cinefile, che hanno aderito al progetto dell’Agis, Premio David Giovani, in qualità di giurate (sezione di Bologna), oltre ad aver collaborato al blog di “Cinefilia ritrovata”.
RIVER TO RIVER FLORENCE FILM FESTIVAL 2015: PAS DE DEUX di Maria Pia Cinelli
Breve viaggio al centro della danza indiana fra musica classica e jazz in compagnia di un film estraneo al sistema Bollywood.
IL NUOVO CORSO DELLA MOSTRA DI PESARO di Paolo Micalizzi
Excursus su una Mostra che ha compiuto 50 anni ed è ripartita con un nuovo Direttore artistico che punta alle forme più giovani e innovative del linguaggio cinematografico contemporaneo.
BIOGRAFIE E STORIE DI VITA AL BIOGRAFILM FESTIVAL di Bologna di Paolo Micalizzi
Manifestazione dedicata alle biografie che s’inserisce sempre più con maggiore prestigio nel Panorama dei Festival nazionali.
DEDICATA A GIAN MARIA VOLONTE’ LA 2^ EDIZIONE DEL CAMAIORE FILM FESTIVAL di Paolo Micalizzi
Resoconto di una nuova manifestazione che tende ad avere qualificato prestigio nel Panorama dei Festival Fedic.
UN QUALIFICATO E SIMPATICO FESTIVAL NEL PAESE DI DON CAMILLO di Paolo Micalizzi
XIII edizione, ricca di iniziative, nel paese dove è stata ambientata la saga di Giovannino Guareschi.
CLASSICI
LEAVE HER TO HEAVEN O IL MELODRAMMA INATTESO di Mathias Balbi
Nel cinema americano degli anni Cinquanta il mélo è forse il genere hollywoodiano per eccellenza e il suo realizzatore più riconosciuto e ammirato è il tedesco Douglas Sirk: è curioso allora indagare sulle origini di questo genere attraverso un film (Leave Her To Heaven) che Sirk “eredita” da un altro regista (John M. Stahl), rintracciandone le peculiarità più significative.
OCCHIO CRITICO
IL FILM “CERNIERA” DI NANNI MORETTI di Roberto Lasagna
Mia madre, film intimo e fuori dal coro, e’ un nuovo slittamento di senso nella filmografia di Moretti, opera-cesura tra il privato e il collettivo che esprime la volonta’ di dare una risposta al disagio attraverso la riflessività.
L’IMPOSSIBILITÀ DI ESSERE NORMALE: DOVE ERAVAMO RIMASTI di Francesco Saverio Marzaduri
Dopo aver lasciato la famiglia per inseguire la carriera di cantante rock, l’ultracinquantenne Ricki Rendazzo viene raggiunta da una telefonata dell’ex marito Pete: la figlia Julie attraversa un momento difficile, dopo che il marito l’ha lasciata per un’altra donna. Per Ricki è l’occasione di un amaro esame di coscienza…
FOCUS SU PAOLO SORRENTINO
CONVERSAZIONE CON PAOLO SORRENTINO. LO STILE E LA BELLEZZA di Federico Govoni
Il cinema di Paolo Sorrentino ha una forte impronta personale, lo stile del regista caratterizza tutta le sue opere rendendole occorrenze di un organico ed unico sentire l’immanente fatica del vivere.
Le inquadrature ricercano armonia e compiutezza nel costante disagio esistenziale dei personaggi.
Il regista Paolo Sorrentino si racconta con sincerità ed ironia.
YOUTH: IL COMPIMENTO DE LE CONSEGUENZE DELL’AMORE di Andreina Sirena
Un’analisi sui temi de ”Le conseguenze dell’amore”, secondo film di Paolo Sorrentino, ripresi e sviluppati in “Youth”, il suo ultimo film. L’articolo esalta il legame tra i due lavori nella caratterizzazione dei personaggi, dell’ambientazione e delle scelte registiche.
YOUTH. UNA MEDITAZIONE SUL TEMPO di Maurizio Villani
L’articolo riflette su una particolare chiave di lettura del film di Sorrentino centrata sulla tematica della temporalità. Viene indagato il complesso rapporto tra Il tempo della giovinezza e quello della vecchiezza, attraverso le vicende dei due anziani che vivono il declinare di un’esistenza ormai prossima alla morte. Il declino fisico dei corpi e la dinamiche della psiche misurano le scorrere inesorabile del tempo.
NEO-CINEMA
A cura di Elio Girlanda
NUOVI OCCHI, NUOVI SGUARDI di Elio Girlanda
Nella Rubrica, dove si commenta tutto ciò che sta trasformando il cinema (forme e pratiche, ibridazioni mediali e modelli di esperienza), si esplora l’inizio di una nuova epoca per le immagini in movimento grazie a dispositivi di ripresa e di proiezione sempre più piccoli ed economici.
VISTI DA LONTANO
A cura di Andreina Sirena
TARKOVSKIJ E LA NOSTALGIA DI UN’ARMONIA ASSOLUTA di Andreina Sirena
Viaggio nell’universo simbolico del regista russo Andrey Tarkovskij attraverso “Nostalghia”, film del 1983 girato in gran parte nelle terre toscane . La condizione nostalgica dell’esilio dalla terra d’origine apre all’urgenza di ritrovare la perduta armonia con gli uomini.
QUALITÀ IN SERIE
A cura di Giancarlo Zappoli e Luisa Ceretto
1992 SERIE TV IN 10 EPISODI Giancarlo Zappoli
- Un anno che è stato decisivo per l’Italia e i cui protagonisti sono fissati con precisione nella memoria di chi abbia più di 40 anni. E’ l’anno dell’operazione denominata Mani Pulite. Come raccontare quell’anno di profondi rivolgimenti andando oltre la ricostruzione documentaristica e attraendo anche chi in quell’anno non era ancora nato o era bambino? Questa serie ci ha provato fondendo documentazione ed entertainment.
PANORAMA LIBRI
A cura di Paolo Micalizzi
Segnalazione di alcuni libri: 3 volumi di Giacomo Gambetti relativi, rispettivamente, al Neorealismo, al nuovo cinema ungherese e a ritratti di personaggi del cinema da lui conosciuti; il cinema di Giorgio Pàstina; il nuovo cinema turco; Kubrick tra cinema, estetica e filosofia; cinema e matematica.
.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
PINTILIE LA SOTTILE LINEA (ROSSA)
di Francesco Saverio Marzaduri
A ben vedere, l’intera filmografia di Lucian Pintilie, regista tra i migliori e paradossalmente tra i più misconosciuti d’Europa, autore di un cinema originale e corrosivo, feroce ma carico di speranza, è caratterizzata da un connubio. E se la dicotomia è il pattern che meglio identifica la produzione cinematografica del Noul Val Românesc, e dichiarati debitori dell’opera di Pintilie sono le firme di tale corrente, una tra le contrapposizioni presenti in Pintilie, benché non l’unica, è quella tra il vero e il presunto. Binomio che soprattutto negli ultimi tempi – grazie anche alla scissione della barriera tra pubblico e privato, dovuta ai mezzi mediatici – ha preso piede nella vita di tutti i giorni da suonare convenzionale, ridondante, stucchevole. Il cinema romeno della “nuova onda,” dal canto proprio, non si mostra insensibile alla tematica, cogliendo l’occasione per prenderla di petto in alcuni dei lavori più rappresentativi tra quelli recenti. E il coraggio di farlo ben si amalgama al fattore della denuncia, più di quanto in precedenza, durante e subito dopo Ceauşescu, non fosse concesso.
Nel caso di Pintilie, il discorso si fa carico di profonda rilevanza, e di profondo valore, giacché la gran parte dei topoi che sempre più suggellano l’ultima produzione romena, divenendone un distintivo marchio, si ritrovano tali e quali nella filmografia di questo cineasta, già molti anni prima perfettamente cosciente dei malumori che incombevano dietro la superficie oltranzista. Non è nemmeno azzardato sostenere che proprio con Pintilie – parallelamente a un altro nome illustre, Liviu Ciulei – la cinematografia del Paese acquisti status d’identità mostrando di essere qualcosa d’altro a dispetto della confezione di genere, sin lì in voga immediatamente dopo la fine del conflitto mondiale, e perfino rispetto all’influsso neorealista, che comunque eleva a modello al pari delle cinematografie dei paesi cosiddetti “minori.”
Eppure, prima ancora che da innato spirito di ribellione, la scelta di un cinema controcorrente, in Pintilie, trova un suo varco in un’altra influenza, del tutto in linea col dirompente mutamento di un costume, di un gusto, di una nuova ricezione del cinema quale arte del guardare. Non è un segreto che se la cinematografia est-europea riesce a produrre opere di lodevole qualità e considerevole originalità, viceversa la Romania, da cenerentola culturale dell’Europa orientale, sconti l’esigenza di ricostruire, con mezzi minori, strutture e attrezzature perdute nella guerra: impresa perseguita con la nazionalizzazione dell’industria filmica, il reclutamento e l’addestramento di nuove maestranze, l’imposizione di parametri funzionali al Sistema e al regime che si è imposto. Nella Romania del dopo-conflitto si devono ricreare dal nulla strutture di base e apprendimento tecnico e, in tale fase, l’influenza che il citato Neorealismo ha sul cinema internazionale non manca di esercitare seduzioni, sul modo di trattare temi e materiali di popolo. Pure, in Romania, e un po’ in tutti i paesi dell’Asse, la scelta di forme linguistico-espressive anticonformiste è ciò che conferisce al cinema la patina di medium eversivo: le manifestazioni artistiche sono sottoposte al vaglio d’una massiccia operazione di controllo, e talvolta irreggimentate, eliminando generi di stampo o derivazione democratica. Ben pochi sono i registi che godono di qualche relativa, se non eventuale, autonomia progettuale.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Le firme più prestigiose ed autorevoli della cinematografia romena si riducono, in quel momento, a tre nomi – Victor Iliu, Liviu Ciulei e, appunto, Pintilie – e occorre attendere che il Neorealismo influenzi il panorama mondiale e dia modo a molti paesi di elargire nuove correnti culturali, di fresca impronta (anche in fatto di ortografica filmica), non insensibili alla denuncia e d’immediata condiscendenza presso il pubblico, di preferenza la fascia più giovane, della quale analizzare disagi e inquietudini. Col suo sconvolgere le regole cinematografiche, Godard ha certamente fatto scuola, benché non sia da considerare il solo nome cui i movimenti culturali internazionali, e specificatamente est-europei, facciano riferimento. Tuttavia, in quella che probabilmente è la prima opera contro del cinema romeno, più per la chiave in cui è gestito l’argomento che per il suo significato, “La ricostruzione” (conosciuta anche come “Il sopralluogo”), datata 1968, appaiono presto chiare le influenze, gli influssi occidentali (rischiosi per l’epoca) e gli echi di un certo (modo di fare) cinema.
Ebbene: rivedendo un prodotto di simile portata – invecchiato nei codici utilizzati dall’autore, e ancora potente nella determinatezza con cui si affronta una tematica per l’epoca sorprendente – fa sorridere che la contrapposizione tra vero e presunto potesse scuotere gli organi di Potere, infastidirli sino ad obbligarli a un’azione di censura per l’intero arco di tempo in cui Ceauşescu fu in carica. E tacciare il film, come il suo autore, di maledetto. In tempi odierni, abituati come siamo a un’ormai azzerata demarcazione tra pubblico e privato, non fa più caldo né freddo la finta inchiesta su un episodio di cronaca nera, che, senza essere mostrato, vede due giovani teppisti venir alle mani tra loro in stato di ubriachezza. Una volta distrutto un bar e aggredito il cameriere che cercava di fermarli, entrambi sono obbligati dalle autorità a rielaborare il fatto davanti alla cinepresa e registrarlo su pellicola per realizzare un film educativo. Ricondotti alla loro più intima e sordida essenza – in un’atmosfera sempre più opprimente e kafkiana – i due giovani si picchiano tanto realisticamente di fronte alla cinepresa che uno, colpito troppo duramente, rimane ucciso durante la rielaborazione.
Progressivamente, il cinema sostituisce alla realtà vissuta una finzione tanto vera da rendere impossibile ai ragazzi di recitare per finta: qual è la verità dell’accaduto, se soltanto sul set si consegue la conclusione più tragica? Svelando allo spettatore i meccanismi di una rappresentazione, il film medesimo si mostra auto-analiticamente quale ricostruzione (e resta il sospetto di una verità anche più vera dietro la m.d.p. di Pintilie), ricostruzione di uno spettacolo ch’è però anche l’unica realtà davvero concepibile. Data l’atipicità del plot, il film è un forte apologo morale: un invito rivolto alla presa di coscienza dello spettatore alla ricerca della verità, al di là delle manipolazioni del regime; il che, naturalmente, suscita l’atteggiamento ostile delle autorità. Nondimeno, l’incessante gioco della verità e della finta verità che sopperisce alla prima, memore perfino di Welles e a favore di uno spettacolo che sia il più realisticamente convincente per l’osservatore (il cui obiettivo è il medesimo dell’intera arte cinematografica), è il primo determinante topos nel cinema romeno dagli anni Sessanta in avanti. A mo’ di esempio, in “A est di Bucarest” di Corneliu Porumboiu lo testimonia il parallelo tra i due estremi, nella grottesca rielaborazione di quanto accadde il 21 dicembre ’89 prima delle 12.08, nel bel mezzo di una diretta televisiva dagli esiti sempre più sbracati e inattendibili.
Soprattutto, è il primo determinante pattern nella filmografia di Pintilie, eversivo esponente di un rinverdimento cinematografico del Paese nell’introduzione di forma e contenuto nuovi, contrapposto senza invidia (e con più di un’eco) alla Nouvelle Vague: in un godardiano gioco di specchi – servito da un poveristico bianco e nero d’inestimabile nitore – l’autore mira a un’interpretazione al contempo critica e sociale, etica e politica della Romania, dei suoi mutamenti e condizionamenti, delle realtà che vi si vivono e, non ultimo, delle infide promesse del governo comunista. Lettura, in sostanza, di carattere sociale, senza venir meno a quella, autocritica, sulla realtà della mediazione cinematografica dietro la patina della finzione filmica, egualmente di forte impatto. Il senso di quel che potrebbe essere, luogo canonico incessante in tutta la produzione di Pintilie, trae la propria derivazione dai ricordi di una comunità tollerante e cosmopolita: per la precisione da Tarutina, un villaggio di lingua tedesca nel sud della Bessarabia – oggi parte dell’Ucraina – e al tempo popolato da un vero mosaico etnico e multiculturale (non solo romeni, ma anche turchi, tartari, ebrei, e manco a dirlo ucraini e russi).
Per la straordinaria lucidità dell’assunto, l’opera viene giudicata una tra le vette del cinema europeo del decennio, cui fungono da contrappunto alcune temerarie dichiarazioni dell’autore, nell’invitare i colleghi a fare “salutari incursioni nella zona proibita della realtà, così da rimpiazzare un cinema di mistificazione con un cinema fedele, fanaticamente fedele alla verità.” Non sorprende che “La ricostruzione” sia visto con sospetto dalle autorità censorie romene e occorra attendere due anni prima che il film trovi la via della programmazione pubblica, dietro l’avvertenza che il prodotto mostra deleteri influssi occidentali (in Italia si vedrà solo alla IV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, per non esser più distribuito).
Come noto, attraverso il filtro non sempre attendibile dei media, il processo violento, feroce e secondo molti irrazionale, che pone bruscamente fine all’Epoca de Aur di Ceauşescu è assai più radicale in Romania che negli altri paesi del blocco orientale. La bottiglia a lungo sigillata, contenente l’unica vera pellicola dissidente della fine del decennio, viene miracolosamente ritrovata e aperta: nel 1990, “La ricostruzione” sembra ancora nuovo, rivoluzionario per stile e contenuti, scatenando una vera e propria sindrome da “Ricostruzione anno zero” tra la critica e tra il pubblico, e all’unanimità è salutato come il primo contributo romeno all’arte cinematografica contemporanea. Ugualmente, però, fa sorridere la tornata di critici nazionali che, all’epoca dell’uscita, valutano a fatica la riuscita di un lavoro coraggioso, dal tiro indubbiamente spiazzante, indispensabile nel suo elemento di scossa per le menti del pubblico, e tuttavia commerciale, furbesco e non completamente onesto nei nobili intenti.
.
L’esatto contraltare della pellicola d’esordio, “Duminică la ora 6,” scoperto esercizio di scrittura filmica che prende a pretesto una vicenda d’amore, lealtà e tradimento ambientata durante la Resistenza per mettere in evidenza – per ammissione dello stesso regista – “il tormento della forma.” Ciò perché discrepante è la situazione politica nel Paese.
“Era il periodo precedente gli inizi di Ceauşescu. Ogni regista, a un certo punto della carriera, si trova a dover fare un “Domenica alle 6,” in cui, in maniera quasi obbligatoria, i personaggi appartengono alla gioventù comunista. Però ho voluto cambiare la conclusione: non volevo che il film terminasse con un finale eroico, perciò ho inserito la morte dell’eroina verso la fine, e a questo ho aggiunto un elemento ancora più tragico, il tradimento. Come l’uomo resta solo, è anche tradito. L’idea era accentuare lo shock della morte della protagonista. In questo modo, ho modificato strutturalmente lo spunto per una storia eroica.”
Permeato di un linguaggio impressionistico, fenomenologico e onirico, e abbastanza rivoluzionario per il cinema romeno, “Duminică” racconta dell’inusuale storia d’amore, nella Romania del ’40, di due giovani impegnati in attività clandestine, l’uno all’insaputa dell’altra, per contrastare il regime fascista; la qual cosa rende complessa e disperata la relazione tra i due amanti. Il debutto di Pintilie ottiene subito importanti riconoscimenti da parte della critica e dei festival internazionali: l’autore inscena lo smarrimento dei personaggi con l’uso di flashback che portano sostanzialmente a non distinguere tra passato e presente. L’amore sembra essere un riparo, ma la guerra prevale su tutto, entrando di peso nei destini degli individui. A dispetto de “La ricostruzione,” “Duminică” non incontra il favore del pubblico meno esigente, tanto meno soddisfa i discepoli di Godard, ché il cineasta gioca a carte scoperte senza ricorrere ad ambiguità: gli eroi sono giovani e simpatici, e ci si affeziona a loro perché odiano il fascismo senza porsi troppe domande. Proprio in questo film, tenero e commovente, la formazione teatrale, l’abilità nella direzione degli interpreti, l’uso di un dialogo straniante, la visione di un emisfero paradossale e dominato dal Caso – derivante dal Teatro dell’Assurdo – influenzano il linguaggio cinematografico di Pintilie. Ma nel cinema, il “selvaggio,” come ama definirlo Ionesco, riesce a lavorare come assistente di Victor Iliu (allievo di Ėjzenštejn e a cui “La ricostruzione” è dedicato), per esordire nell’epoca del “disgelo,” agli albori del regime di Ceauşescu.
Nel divario, nemmeno troppo sottile, fra il teatro e il cinema risiede l’opera (e l’esistenza) del regista romeno, frapposta a un perenne nomadismo, tradotto in un confino, che alterna la patria al territorio francese, con predilezione per Parigi. Formatosi a diciassette anni all’Istituto d’Arte Teatrale e Cinematografica di Bucarest – come molto più tardi capiterà a tanti nomi del Noul Val – Pintilie è già rinomato regista teatrale, di levatura europea: celebrato in patria sin dal ’59 e, nel decennio seguente, direttore di molti teatri fino agli anni Ottanta (a cominciare dal Bulandra, sino ai Théâtre National de Chaillot e il De la Ville), s’impone come l’esponente più significativo del nuovo teatro romeno, proponendo innovativi adattamenti da Gor′kij, Shaw, Frisch, Čechov, Gogol′, Caragiale, Dürrenmatt. E poi Ibsen, Bizet, Frisch, Saroyan, Gozzi, nella maggior parte dei casi ottenendo premi, riconoscimenti, consensi internazionali, e lavorando perfino negli Stati Uniti. Spettacoli che sono testimonianza di una grande sensibilità autoriale: in una regia televisiva per la Jugoslavia, Pintilie realizza “Paviljon VI,” trasposizione del famoso racconto di Čechov, a causa della cui distribuzione in Romania l’autore opta per la Francia per qualche tempo, prima di stabilirvisi per circa dieci anni, in seguito a una nuova azione di censura.
La paranoia che interpretazioni culturali anticonformiste destino la coscienza collettiva, inducendola a pensare, fanno del regista un esiliato ancor prima che un maledetto, e per tutta la vita, anche in ambito teatrale. Per sfuggire alla condanna dovuta al secondo film, Pintilie è costretto ad abbandonare il cinema, e insieme all’amico e collega Liviu Ciulei sceglie di lavorare a un allestimento de “L’ispettore generale” di Gogol′, che solleva polemiche tali da costargli l’ennesimo ostracismo. Il testo, come noto, è una pantomima al vetriolo che con piglio da commedia degli equivoci mette a nudo il conformismo ottuso e la miseria morale della classe dirigente della Russia zarista, tanto corrotta da essere presa al laccio dei suoi stessi inganni. E facile è riconoscere l’allusione agli apparati di partito, ai burocrati e ai politicanti romeni dell’Età dell’oro.
Dualismo della circostanza: nel 1990, anno in cui “La ricostruzione” torna a vedere la luce sugli schermi nazionali, altri lavori bloccati dalla censura vengono distribuiti, a cominciare da quel feroce ritratto della vita di provincia ipocrita, gretta e immorale, ch’è “De ce trag clopotele, Mitică?” (in italiano “Perché suonano le campane, Mitică?”), tratto da Caragiale. Lo stesso anno, tornato definitivamente in patria e nominato direttore del settore cinema del Ministero della Cultura, Pintilie riprende a girare nel periodo romeno di transizione, dopo il crollo del regime e l’avvento della democrazia, realizzando una serie di drammi senza esclusione di colpi e commedie nere sulla vita e le proprie assurdità. E mentre due di queste pellicole del periodo post-comunista approdano ai circuiti internazionali – “Balanţa” (letteralmente “La bilancia”) e “Prea tîrziu” (“Troppo tardi”) – gli storici del cinema sono tentati di ravvisare nella filmografia di Pintilie il progetto coerente di una trilogia storico-sociale romena, introdotta vent’anni prima con “La ricostruzione.” Come rileva Eugenia Voda:
“Le scene, i dialoghi e le immagini de “La ricostruzione” sono ormai entrati a far parte della coscienza collettiva, sono diventati veri e propri riflessi della memoria […] Il film ci appare strano perché è così vicino alla nostra vita di tutti i giorni. Basterebbe modificare pochissimo, cambiare i cartelloni pubblicitari e il tipo di musica, sostituire la macchina da presa con una più sofisticata videocamera, e ci ritroveremmo con un ritratto fedele della vita contemporanea. A ciò si aggiungano una fotografia dal taglio documentaristico e un sonoro estremamente fresco e moderno.”
Espediente auto-riflessivo piuttosto comune nel cinema modernista occidentale, ma raramente attestato nella cinematografia est-europea fine anni Sessanta, il prologo di Pintilie si rivela un flash forward nell’istante in cui è riproposto, identico, al termine del film, quando i giovani uligani devono inscenare la ricostruzione giudiziale del crimine da loro compiuto, durante la quale uno dei due è ferito a morte. Anche il secondo discorso in cornice, quello dell’apparecchio televisivo, diviene un accorgimento stilistico assiduo in quelle trame secondarie codificate, così ricorrenti nella produzione di Pintilie. Inoltre, l’effetto sinestetico che scaturisce dalla simultanea presenza di stimoli sonori differenti (i dialoghi, la musica alla radio e in televisione, gli animali, la porta del gabinetto, gli esasperanti rumori fuoricampo) è un omaggio alla teoria dell’immagine-cristallo di Deleuze: spazio e tempo sono letteralmente sospesi, la vicenda si carica di un’aura eterna, mitica e mistica.
.
Il primo film di Pintilie in epoca post-totalitaria, “Balanţa,” è di più ampio respiro, benché simile a molti dei titoli precedenti nel tono, nelle strategie discorsive, nel tipo di universo morale che ritrae. In una scena d’apertura mozzafiato, accompagnata da una citazione musicale alquanto suggestiva estrapolata dal “Lohengrin” di Wagner, la protagonista rimira un home movie insieme al padre, ex ufficiale degli alti ranghi comunisti ormai in fin di vita. Ancora una volta, la politique di Pintilie ricorre all’autoriflessività (e all’immagine-cristallo), ma in una veste nuova e del tutto originale. Un filmino amatoriale in super8, girato in bianco e nero, mostra un’allegra festa di Natale per degenerare rapidamente in un omicidio macabro e surreale: il personaggio principale riversa soggettivamente tutto l’odio e il disgusto che prova verso il regime comunista sulle immagini della propria infanzia, reinventandole in una chiave deformante.
Si deve, inoltre, notare come nelle pellicole dagli anni Novanta in poi, al pari degli esordi, vi è un’attenzione del regista rivolta all’inquietudine giovanile, al suo collocamento generazionale nel corso dei decenni, ossia nel corso della Storia. Quella Storia di cui la nazione, e anche Pintilie, non può far a meno, spettro la cui icona è ben lungi dallo scomparire. Una generazione, quella romena, che sin da Ceauşescu si sente orfana di un pensiero dirompente, della possibilità di alzare il pugno e paradossalmente, una volta caduto il Conducător, impossibilitata al totale distacco dal Potere vigente, scevra da qualsiasi occasione di ribellione anticonformista e di gioia nel ripartire da zero. Già da “La ricostruzione,” prima che ad occuparsene siano i cineasti del Noul Val (gli unici a gridare quel che prima non si poteva), le figure giovanili sono pedine manovrabili dal Potere, pronti ad essere annientati come niente. Ombre inquiete, come, in “Balanţa,” lo sono i due amanti protagonisti alle prese con una contrapposizione, si diceva all’inizio, tra quel che sembra e quel ch’è realmente, tra quanto viene impartito (e si rivela fallace) e quanto nascosto (ed è accertata verità), tra ciò che s’impone quale indispensabile condizione (a compromissione di vite umane) e ciò che dovrebbe essere equa soluzione (e quasi mai vi si ricorre). Una sequela di binomi che dà modo non solo d’illustrare caratteri ed emisferi divergenti, anche se non troppo, ma pure lo sguardo di Pintilie verso il mondo: sguardo, appunto, sul perenne ago della bilancia.
Nella politique dell’autore vi è la mera denuncia di personaggi destinati a un involontario esilio. Perché di esilio si tratta, giacché solo un ostracizzato quale Pintilie può carpire una simile condizione di disagio. Il confinato, reso tale a causa di circostanze da lui non richieste né desiderate – casi di coscienza, insomma – indotto a sottostare alla prevaricazione del Potere e della Storia (e a rispettivi, annessi strumenti), e farsi carico, quando non è sua la responsabilità, di ignominiose ingiustizie o, peggio, di atroci soprusi. Accade al capitano Dumitriu di “Un’estate indimenticabile,” indotto a reprimere un moto contadino in uno sperduto avamposto militare della Dobrugia, o alla dottoressa di “Stare de fapt” (titolo firmato Stere Gulea, inedito in Italia, del quale Pintilie firma il soggetto), nel rifiutarsi di firmare false diagnosi su alcuni pazienti uccisi durante la rivoluzione e, di conseguenza, indicibilmente punita. E ancor più a fondo capita ai dropout di “Terminus Paradis – Capolinea Paradiso”: non due bravissime persone, a differenza di Dumitriu e della moglie o di Nela e Mitică, e tuttavia emarginate effigi. Innamorati allo sbando tra le disillusioni di una devastata, angosciante Bucarest post-comunista, nella quale trionfano povertà e violenza, romantici sbandati consapevoli di un’irregolarità non confacente a schemi precostituiti ed oppressivi e, dunque, votati alla sconfitta; ma il sacrificio ha luogo in nome del legame, dell’unione, dell’amore. La libertà sintattica e l’impeto ribellistico, specialmente in “Terminus,” evocano il cinema indipendente americano anni Settanta, s’è vero che il giovane guardiano di porci, disperato e rabbioso, immola sé stesso assurgendo a simbolo dell’annientamento delle speranze di un Paese. E se la Storia, anche per la Romania, si reitera e si tramanda, non resta che raccogliere lo scettro per consegnarlo ai nascituri, gli unici custodi possibili di un testimonio inappellabile (come richiede la “situazione di fatto,” secondo l’omonimo titolo, che obbliga la protagonista a cercare il suo aguzzino, padre del bimbo che ha in grembo).
Ancora un ritratto generazionale, e un’altra allegoria sul presente della nazione, è al centro di “Niki e Flo”: i personaggi sono tutti calati in una dimensione apatica e insofferente, indipendentemente se giovani o anziani, gli uni disarmati di fronte a un futuro ostile – bigger than life, come si suol dire – e gli altri condannati all’anacronismo di un tempo non più loro. Al secondo caso, per nuovo connubio, appartengono un colonnello in pensione e un nostalgico della vita bohémienne, legati dal matrimonio dei rispettivi figli, questi ultimi – viziati, annoiati, indisponibili – riconducibili al primo assetto. Il dualismo tra vero e falso, qui, miscela la serenità di un filmato casalingo, inerente un banchetto nuziale in apparenza allegro (come la festività natalizia nell’home movie di “Balanţa”), a una realtà in cui basta una manciata di minuti per conferire l’impressione di un alveo domestico, e un periodo, dove qualunque proposito d’idillio è inesistente. A mo’ di fattore complementare, la dicotomia che vede il concetto di amicizia alternarsi a un atteggiamento finto-amichevole per questioni di tornaconto personale, e si conclude con la sanguinosa vendetta dell’ex militare sul diabolico consuocero, reo di averlo privato non solo dei figli ma anche dell’orgoglio e della dignità. A conti fatti, “Niki e Flo,” penultima fatica di Pintilie, si avvicina maggiormente a un paradigma estetico-minimalista: apologo sarcastico, statico e in fondo desolante sui nuovi romeni, il film si concentra sui due ragazzi, sintomatici simboli del caos sociale post-dicembrista, pronti a partire alla volta degli Stati Uniti nel macabro scenario successivo all’undici settembre, alla ricerca di una migliore esistenza materiale, laddove la morte accidentale di una vittima innocente (il primogenito del colonnello) è registrata in un film amatoriale mostrato in televisione. Con questo lavoro, Pintilie riconferma la propria predilezione per la mise en abîme autoriflessiva quale strategia per far vacillare, in misura costante, i limiti tra finzione e realtà e usare la forza delle immagini in chiave destabilizzante.
Anche maggiore è il grado di sperimentalismo formale in “Prea tîrziu,” quasi a voler chiudere con un segno indelebile il trittico sui mali del totalitarismo (ma il paradigma è ancora molto attiguo a quello de “La ricostruzione”). L’opera segue le vicende di un pubblico ministero, cui sono affidate le indagini sulla morte “accidentale” di un manovale in una miniera di carbone, nella valle del fiume Jiu. In una scena, gli operai picchettano contro la paventata chiusura delle miniere, e contemporaneamente il procuratore li osserva da un monitor del proprio ufficio: quella che potrebbe apparire una parentesi autocritica, a metà tra la tecnica godardiana e il linguaggio del documentario (l’ennesima contrapposizione), è invece il corrispondente in “rima” di un segmento del film più noto di Pintilie, in cui uno schermo televisivo diffonde un’ambulanza diretta a una partita di calcio e poi, tramite una panoramica a schiaffo, lo spettatore è condotto sul luogo ove effettivamente si svolge la scena. Il tempo della Storia e quello della ricezione si assemblano in un’unica entità di significato coerente. A Bucarest, alla prima di “Prea tîrziu,” la reazione di film makers del calibro di Mircea Daneliuc e del citato Gulea è quella di far notare come la sollevazione violenta e parossistica dei minatori del ’90, fomentata dal regime neo-comunista di Iliescu, avesse lasciato tracce importanti anche nelle loro produzioni. Diversi anni dopo, penserà il Radu Muntean di “Hârtia va fi albastră” (titolo letterale “La carta sarà blu”) a ricreare un analogo climax di ansia e oppressione che mischia i malumori di chi è immerso nello scontro e la restituzione dell’evento attraverso una veridicità mediatica, che quand’anche si propone fedele resta fredda, passiva, inscatolata in un video e dunque più travisata che documentata.
Non è comunque possibile dissertare sulla filmografia di Pintilie, dietro la figura canonica del parallelismo, senza riservare un posto sommo a “Il pomeriggio di un torturatore,” nel confronto tra un’agghiacciante realtà e l’impossibilità di raccontarla per ricompensare l’ingiustizia della Storia. Ma quanto si può narrare, in un’epoca che potrebbe consentirlo (e il malaugurato Fato ugualmente non rende possibile), è ostacolato dall’incombenza di un Presente che trasforma i reduci dell’orrore, vissuto in prima persona, a creature ammortizzate incapaci del minimo sentimento, alla totale mercé di un quotidiano costituito da ultrà, aritmetica eredità del passato oltranzista. Passato che questi ultimi hanno rimosso alla svelta e del quale non desiderano diffondere testimonianze: strumento di minaccia, la violenza è la sola ancora esistente per mostrarsi nazione fugacemente mutata come qualunque altra (e altresì la rende identica, in peggio, al trascorso totalitarismo). Il confine risiede nella contraddizione tra l’estrema lucidità e la paurosa confusione, e Pintilie, conscio di non poter fare diversamente, opta per il disegno di una figura mostruosa – tutt’altro che innocente nonostante la trance – sia dall’interno che dall’esterno.
“Quando si ha di fronte un torturatore che arriva a confessare come ciò che lo spingeva ad agire non fosse ordinato da superiori, ma un piacere segreto, che nemmeno riesce a descrivere nella sua interezza e forse va anche oltre la testimonianza, per un regista è terribile e, al contempo, appassionante.”
Il protagonista è un esiliato, ridotto a larva umana come la consorte, isolato dal resto del mondo tanto quanto l’anziano giornalista incaricato di registrare la sua deposizione per una diretta televisiva. Ma il Fato (del Presente, della Storia) dispone diversamente, e sulla bobina non è incisa alcuna parola. E chi si addormenta per tutto il tempo della testimonianza, solo nell’epilogo si abbandona a una verità non meno raggelante: ciò, perché i posteri hanno rifiutato gli anacronismi di ieri, rendendoli incapaci di qualsiasi tentativo di essere ascoltati. Ma il regista sembra suggerire che nessuna parola è così dirompente quanto le immagini: la possibilità di suggerire in modo ellittico senza obbligatoriamente svelare, mediante l’utilizzo di simbolismi figurativi, campi e controcampi, incessanti successioni tra passato e presente prive di filologica continuità. Una terza possibilità – come ammonisce il titolo del suo ultimo lavoro – non è concessa. “Tertium non datur,” appunto.
Dagli esordi, lungo una carrellata di titoli che sono, al contempo, il nitido riverbero della trasformazione (deformazione?) di un Paese e una mentalità, Pintilie non viene meno all’interpretazione del mezzo filmico paragonato alla presenza, massiccia quando non ingombrante, dello schermo in ogni sua forma e all’irrinunciabile rilevanza che la Romania ha offerto ad esso. Ma anche il cinema, elevato a fenomeno morboso e finanche a mercimonio, non esce illeso dalla critica dell’autore, come suggella il morboso girato di Florian, attraverso il quale l’uomo tenta di trarre proficuo guadagno e invece sancisce la sua fine.
La “nuova onda” romena non ha mancato di riconoscere l’enorme debito verso Pintilie, il solo cineasta romeno che in era post-comunista, dopo un lungo confino, ha portato avanti un proprio discorso mantenendosi su identici livelli di eccellenza artistica. Il tributo è evidente nel rifiuto generalizzato (in parte anche motivato economicamente) di produrre opere spettacolari – pellicole d’azione ambientate in scenari esotici con profusione di star nazionali e/o internazionali, dovizia di effetti speciali e magari accattivanti colonne musicali, colme di hit di facile richiamo. In misura meno esplicita, col loro “credo” artistico, le nuove firme mostrano di dare ancora pieno credito a linguaggi visivi e verbali, radicati nella “psiche nazionale,” in un certo tipo d’ironia e di senso dell’assurdo, che anche il pubblico internazionale, d’altronde, può essere in grado di apprezzare. Va precisato, però, che il modello estetico corrente, che porta registi come Cristian Mungiu, Cristi Puiu o Porumboiu a conseguire riconoscimenti internazionali, si afferma solo all’inizio del nuovo secolo, dopo una fase che si potrebbe definire “di passaggio,” e annovera tra i portabandiera Nae Caranfil o Cătălin Mitulescu.
Ognuno di essi, chi più chi meno, ostenta le gravose lacune di una nazione, sulla carta, desiderosa di mettersi al passo coi tempi. Nondimeno, ancora carente ai limiti dell’irrecuperabile in quanto orfana della linea oltranzista da cui è stata sottomessa per oltre un trentennio, fantasma ancora serpeggiante nelle viscere di usi, costumi, tradizioni. E se l’apicultore ex carnefice de “Il pomeriggio di un torturatore” esprime la propria concezione di libertà asserendo di non sapere che farsene, l’idea di libertà di Pintilie pare fondarsi, non senza difficoltà, da una concezione soggettiva inerente l’utilizzo che se ne vuol fare (una “scheda tecnica,” afferma, per sapere come adoperarla). La troppa libertà di pensiero o azione, dovuta a un utilizzo non corretto, viceversa ispira sfiducia in qualsiasi area: nei minimi scorci di libertà offerti, un regista, o il Paese cui appartiene, si rivela versatile e consegue i risultati migliori.
“Con piccoli frammenti di libertà riesci a ricostruire un mondo libero e moderno, ovunque. Vi sono artisti morti nei campi di concentramento: ma il loro umano destino non ha rapporti con l’opera. È importante che tutti cerchino di trovare un mezzo per riuscire a realizzare i propri lavori.”
Tale interpretazione di libertà – confrontata con quella, fallace, imposta da standard precostituiti e dagli organi di potere – è vantaggiosa anche per la censura e/o per i partiti politici, ché, consenzienti in superficie ai voleri di un autore, detengono il vantaggio di poter tardare la distribuzione, gli stessi tempi di lavorazione di progetti malgraditi. È sufficiente solo questa constatazione, per chiarezza e lucidità, a dire della grandezza di un autore come Pintilie quale imprescindibile riferimento, benché ancora non completamente corrisposto dal pubblico internazionale. Le leve del Noul Val, insieme ai più attenti cultori della Settima Arte, da un bel pezzo se ne sono accorti.
.
SAGGI
PASOLINI E LA PRODUZIONE:
LE AVVENTURE DI UN AUTORE INDIPENDENTE AL CENTRO DELL’INDUSTRIA CULTURALE
di Roberto Chiesi
Nel 1971, rispondendo alle domande di un’intervista televisiva di Enzo Biagi, IIIB facciamo l’appello, Pier Paolo Pasolini riassumeva i termini del proprio rapporto con l’industria culturale del suo tempo, come un “braccio di ferro”.
Era un’immagine che esemplificava un confronto basato sull’inevitabile resistenza che l’autore deve esercitare rispetto alle pressioni e ai compromessi che un produttore può volere indurre o imporre nel tentativo di rendere il film più commerciale e accattivante, mentre l’artista cerca di condurre a termine il progetto nella forma più vicina a quella in cui l’ha immaginato.
Il caso di Pasolini è uno dei più esemplari perché poté realizzare la maggior parte dei progetti cinematografici a cui teneva, nel modo in cui voleva e nella forma in cui li aveva pensati (come risulta da un confronto dei film con le sceneggiature originarie, pur con tutte le inevitabili differenze nel passaggio dalla pagina al film finito).
Esemplare anche per le condizioni paradossali in cui si trovò ad operare: numerosi film di Pasolini suscitarono scandali e denunce, alcuni diventarono addirittura dei casi limite per il numero di denunce accumulate (Il Decameron ne subì addirittura ottanta) o per il tempo che durò il sequestro (Salò o le 120 giornate di Sodoma rimase nelle mani dei censori per oltre un anno). Ma questi scandali finirono quasi sempre, appunto paradossalmente, per giovare alla fortuna commerciale dei film, in particolare proprio Il Decameron fu il maggior successo del cinema di Pasolini e uno dei più clamorosi esiti al box-office degli anni ’70.
Per tornare alla sua dialettica con la produzione, Pasolini ne sperimentò la prassi fin dagli anni in cui era sceneggiatore e già allora imparò a sue spese quali disavventure possono capitare, come risulta, per esempio, dall’episodio di Una vita violenta (1962): il film, diretto da Paolo Heusch e tratto dal romanzo omonimo di Pasolini, era nato anche dall’apporto dello scrittore alla sceneggiatura ma senza che tale collaborazione gli venisse accreditata ufficialmente e tantomeno retribuita.
 Quando Pasolini diventò regista, sperimentò le avversità più rilevanti solo nei primi anni di carriera.
Quando Pasolini diventò regista, sperimentò le avversità più rilevanti solo nei primi anni di carriera.
È noto l’episodio della Federiz, la società di Angelo Rizzoli e Federico Fellini che nel 1960 avrebbe dovuto produrre Accattone e invece annullò la produzione dopo che erano state girate due sequenze di prova, a causa dell’ostilità di Rizzoli nei confronti di Pasolini e della non volontà da parte di Fellini di difenderne il progetto.
In seguito, nel 1962, quando ormai Pasolini aveva già esordito nella regia, si verificò un vero e proprio conflitto con un produttore, Roberto Amoroso, che inizialmente avrebbe dovuto produrre La ricotta. Lo stesso Pasolini, nella poesia autobiografica Poeta delle Ceneri, evocò questa vicenda:
Un giorno dei primi Anni Sessanta / (il periodo in cui tutto questo accadde) / consegnai a un piccolo re del cinema di nome Amato e al suo compare Amoroso / una sceneggiatura che porta l’agreste titolo di: / «Ricotta». / Forse avrete visto questo mio film / al Festival di New York di qualche anno fa. / In quello scenario, / scritto come scrive uno scrittore, / c’era qualche parola non lieve, / e poca grazia verso la religione della borghesia cattolica / del mio paese. / Per una delle tante ragioni che tu, critico cinematografico conosci bene, / il film andò a monte, Loved morì, / e Loving, / mi intentò un processo accusando il mio copione / scabroso per il pubblico medio / di avergli impedito di fare il suo film. / Sarebbe come se il Sig. Crawther / consegnasse a Levin, per richiesta dello stesso Levin, / un manoscritto troppo roseo, buono solo per educande, /e il Sig. Levin, non trovandolo buono, / per ragioni sue, / gli facesse un processo perché l’eccessivo color roseo / del copione di Crawther, del dolce Crawther, / gli aveva impedito di realizzare il film ch’egli voleva. / Ho perso anche questo processo e non so quante decine di milioni / dovrei sborsare a quella perla del signor Loving / rovinato da quella mia prima stesura / di un copione inadatto agli italiani medi. /
Giuseppe Amato era un potente produttore che finanziò o cofinanziò Umberto D (1952) di De Sica, Don Camillo (1952) di Julien Duvivier e La dolce vita (1959) di Fellini, per citarne solo tre, e fu anche regista non disprezzabile. In realtà morì non nel 1963 ma nel 1964, quindi un anno dopo che La ricotta (episodio di RoGoPaG) aveva debuttato nelle sale e quasi subito sequestrato sotto l’accusa di vilipendio della religione. Roberto Amoroso (1911-1994) fu un produttore più modesto che intentò causa contro Pasolini appunto perché scandalizzato dal contenuto della Ricotta e con questa azione anticipò in un certo senso la denuncia per vilipendio subìta dal poeta-regista dopo l’uscita del film.
L’altra disavventura, meno grave, fu invece vissuta da Pasolini col piccolo produttore Gastone Ferranti di La rabbia, realizzato fra il 1962 e il 1963. Ferranti possedeva i diritti di una serie di cinegiornali, “Mondo libero”, e voleva riciclarne i materiali con l’intenzione di ricavarne un film sensazionalistico sulla scia del successo ottenuto da Mondo cane (1962) di Gualtiero Jacopetti. Propose il progetto a Pasolini che riuscì a trasformare la commissione in qualcosa di completamente diverso: un poema per immagini, al tempo stesso lirico e politico, basato sul materiale di repertorio rimontato. Ma quando Ferranti vide il primo montaggio del film, probabilmente si spaventò per l’esaltazione del comunismo di varie sequenze e decise di ridurre il film di Pasolini per affiancargli un altro episodio, dall’impostazione politica opposta, affidandolo allo scrittore e disegnatore umoristico Giovannino Guareschi. Pasolini fu così costretto a ridurre il suo film ma inorridì quando scoprì la parte montata da Guareschi, che non esitava a rivendicare il colonialismo e il razzismo. In un primo tempo lo scrittore-regista volle ritirare la firma poi se ne astenne, forse in considerazione dell’assoluto insuccesso del film nelle sale. Dopo questo incidente, Pasolini scelse con maggiore cautela i produttori dei suoi film e probabilmente anche le condizioni contrattuali.
Il rapporto più lungo lo strinse con Alfredo Bini (1926-2010), che all’inizio degli anni ’60 era nella fase più felice della sua carriera (Il bell’Antonio di Bolognini del 1960, A cavallo della tigre di Comencini del 1961). Bini produsse e difese il primo film pasoliniano, Accattone (1961), quindi Mamma Roma (1962), La ricotta (1963), Sopralluoghi in Palestina per Il Vangelo secondo Matteo, girato nel 1963 ma montato nel 1965, un mediometraggio non destinato alle sale ma a persuadere i possibili finanziatori del Vangelo che Pasolini non era animato da intenzioni blasfeme, poi Comizi d’amore (1964), appunto Il Vangelo secondo Matteo (1964), che fu il primo successo internazionale del cinema pasoliniano, Uccellacci e uccellini (1966), infine Edipo Re (1967), che, nonostante il successo, segnò la fine del loro sodalizio.
 Già con il suo secondo film, Mamma Roma, Pasolini accettò di dirigere un’interprete professionista e di grandissima fama come Anna Magnani, ma la scelta di ricorrere ad attori affermati non costituì mai una mera concessione ai produttori, perché nel caso della Magnani – come dei successivi Orson Welles, Totò, Silvana Mangano, Alida Valli, Massimo Girotti, Terence Stamp, Ugo Tognazzi, Maria Callas e altri – si trattò sempre di personalità che corrispondevano alla concezione che il poeta-regista aveva di quel personaggio e dell’attore che doveva dargli volto e corpo. Non si verificò mai il caso che l’autore di Accattone dovesse ricorrere ad un attore malvolentieri e per cedere ad un’imposizione o ad un compromesso. Non così avvenne per altri cineasti, che erano anche autori dei propri film ed è particolarmente significativo, nel suo caso, proprio perché si trattava di film che trasgredivano, talvolta in modo flagrante, le convenzioni narrative e i tabù morali del cinema del loro tempo.
Già con il suo secondo film, Mamma Roma, Pasolini accettò di dirigere un’interprete professionista e di grandissima fama come Anna Magnani, ma la scelta di ricorrere ad attori affermati non costituì mai una mera concessione ai produttori, perché nel caso della Magnani – come dei successivi Orson Welles, Totò, Silvana Mangano, Alida Valli, Massimo Girotti, Terence Stamp, Ugo Tognazzi, Maria Callas e altri – si trattò sempre di personalità che corrispondevano alla concezione che il poeta-regista aveva di quel personaggio e dell’attore che doveva dargli volto e corpo. Non si verificò mai il caso che l’autore di Accattone dovesse ricorrere ad un attore malvolentieri e per cedere ad un’imposizione o ad un compromesso. Non così avvenne per altri cineasti, che erano anche autori dei propri film ed è particolarmente significativo, nel suo caso, proprio perché si trattava di film che trasgredivano, talvolta in modo flagrante, le convenzioni narrative e i tabù morali del cinema del loro tempo.
Contemporaneamente al sodalizio con Bini, Pasolini sperimentò anche le grosse produzioni, come la De Laurentiis, che finanziò La terra vista dalla luna (1966), episodio di Le streghe (1966) e Che cosa sono le nuvole? (1967), episodio di Capriccio all’italiana.
Ma è significativo che per i lungometraggi il poeta-regista abbia privilegiato i rapporti con produttori con cui esisteva una certa sintonia, come Franco Rossellini (1935-1992), che finanziò Teorema (1968), Medea (1969) e parzialmente Il Decameron (1971), così come con piccoli produttori indipendenti come Gian Vittorio Baldi (1930-2015), anche regista, che con la IDI Cinematografica produsse un film audace e difficile come Porcile (1969) e Appunti per un’Orestiade africana (1970), l’unico film del poeta-regista rimasto inedito fino alla sua morte, perché rifiutato dalla RAI Tv che avrebbe dovuto trasmetterlo.
L’ultima fase della carriera cinematografica di Pasolini è segnata dalla collaborazione con uno dei più potenti e accorti produttori del cinema italiano, Alberto Grimaldi (classe 1925), che con la PEA finanziò i fortunatissimi film della Trilogia della Vita, Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore delle Mille e una notte (1974) e Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), uscito postumo.
Le limitazioni esercitate da Grimaldi riguardavano le durate dei film – che non dovevano superare le due ore – ma a parte questo, Pasolini aveva ormai assoluta libertà di azione negli ultimi quattro anni di attività cinematografica: dopo il trionfo della Trilogia della vita era diventato infatti uno dei registi italiani di maggior successo, condizione che può apparire decisamente paradossale se si pensa alla natura anticonvenzionale del suo cinema e all’assenza di qualsiasi compromesso che ha sempre contraddistinto il suo percorso. Era una libertà creativa che il poeta-regista aveva saputo mantenere rovesciando strategicamente proprio i termini dell’ostilità di quella parte della società italiana che lo osteggiava, ossia trasformando il clamore dello scandalo in un veicolo per attirare l’attenzione del pubblico sulla propria opera (pur con tutte le conseguenze anche negative che questo poteva comportare, come i processi). In questo modo, Pasolini combatté con il suo cinema perché il moralismo dei benpensanti perdesse quota e terreno, tranne poi rendersi conto, negli ultimi anni, che l’industria culturale aveva sfruttato quelle battaglie per ‘normalizzare’ (e quindi degradare) la rappresentazione della sessualità al cinema. Ma la battaglia per Salò, che avrebbe dovuto aprire un nuovo corso, Pasolini purtroppo non poté combatterla.
“VOSCENZA BENEDICA”
di Giulio D’Amicone
- Dal punto di vista filologico, il doppiaggio è un illecito; dal punto di vista pratico, un assurdo. E’ assurdo infatti assistere a una rappresentazione in cui attori stranieri muovono la bocca mentre le loro battute vengono pronunciate fuori sincrono (il doppiaggio è sempre fuori sincrono) in un’altra lingua. Non so fino a che punto risponda a verità che i nostri doppiatori sono i migliori del mondo (e non so francamente quanto coloro che sostengono questa tesi abbiano avuto occasione di verificarla), però so per certo che nessun doppiatore, per quanto bravo, riuscirà mai a trasformare un “why” in un altrettanto convincente “perché”. Ovviamente, la necessità di rispettare il più possibile “il labiale” ha obbligato traduttori, adattatori e direttori di doppiaggio a compiere talvolta salti mortali, licenziando manipolazioni che in alcuni casi si sono dimostrate gratuite. D’altro canto il problema investe (o perlomeno ha investito) pure il nostro cinema: penso che al giorno d’oggi nessuno possa prendere per buono il doppiaggio di “Rocco e i suoi fratelli” (o anche di opere minori come “Il demonio” di Brunello Rondi), perché si sente benissimo che nessuna delle voci è autenticamente meridionale. Senza contare che in talune opere tale impresa, anziché agevolare, contribuisce a confondere le idee: bisogna compiere un certo sforzo per capire il motivo per cui, in “Vincitori e vinti”, all’avvocato difensore Maximilian Schell viene inoltrata la richiesta di parlare più lentamente altrimenti “l’interprete non riesce a seguirlo”: evidentemente nell’originale egli si esprime in tedesco. Una situazione sotto taluni aspetti simile si può constatare nel recente film francese “La cuoca del presidente”: la protagonista si trova a contatto con personaggi coi quali ogni tanto fatica a comprendersi poiché parlano lingue diverse; ma anche qui nella versione italiana la cosa va perduta. Una soluzione potrebbe essere quella di decidere di volta in volta quali film potrebbero tradursi senza danni e quali invece andrebbero sottotitolati; ma mi rendo conto di entrare nel regno dell’utopia.
- Parlando in generale, è noto per esempio come gli angloamericani usino sovente concludere le frasi interrogative con un “isn’t it?” o formule simili, che nel doppiaggio vengono tradotte letteralmente “non è così?”: però nessun italiano si esprime in tal modo (nel linguaggio parlato si utilizzano altre formule: “vero?”, “giusto?” ecc.). Similmente, l’avverbio “unfortunately” suona “sfortunatamente”, che nel nostro idioma non ha mai avuto fortuna (in tali casi si preferisce “purtroppo”).
Ma cominciamo con qualche piccola perla. In “Fronte del porto” Rod Steiger esorta ironicamente Marlon Brando a recarsi in chiesa dicendogli “Join the congregation” (Partecipa al raduno); ma noi udiamo “Vai a recitare il rosario”! Anni fa dedicai uno studio a “L’uomo che uccise Liberty Valance”, scoprendo che la versione italiana (peraltro tecnicamente ottima) aveva eliminato o ritoccato talune espressioni gergali. Quando James Stewart all’inizio domanda al bandito “Ma che razza di uomini siete?”, quegli risponde “Di questa razza!”, gratificandolo di un brutale colpo di frusta; mentre nell’originale la risposta è “This kind, dude!”, ovvero: “Di questa razza, damerino!” E la sera del duello Valance grida: “Dove sei, morto in piedi?” mentre in inglese la frase suona: “Hashslinger, are you out there? ” (“Sei là fuori, lavapiatti?”). In un bel western di Arnold Laven, “Due stelle nella polvere” (“Rough night in Jericho”, 1967), ricorre la locuzione “any time”, cioè “in qualsiasi momento”: stilema iterativo che capita spesso nei film americani. Ma poiché nella versione italiana la traduzione è ogni volta diversa, il senso del refrain si perde. Nel finale del “Mucchio selvaggio” di Sam Peckinpah il capobanda Pike (William Holden) incita i suoi accoliti con un semplice “Let’s go”, a cui Warren Oates risponde “Why not?”: non si comprende perché questa semplice risposta sia divenuta “Sì andiamo” invece del letterale “Perché no?”.
- In taluni casi la versione italiana appesantisce l’originale. Si guardi per esempio la nota scena di “Vertigo” (“La donna che visse due volte”) in cui James Stewart e Barbara Bel Geddes esaminano un reggipetto. Stewart dice: “I’ll never run across one like that”, cioè all’incirca “Non mi sono mai imbattuto in uno simile”, mentre noi udiamo “Non ne ho mai tolto uno del genere”: battuta di cattivo gusto oltretutto pronunziata da un personaggio che non dà l’impressione di un dongiovanni. Per l’edizione italiana dei “Guerrieri della notte” di Walter Hill gli adattatori si inventano una serie di termini “disinvolti” che non trovano riscontro nell’originale (“elmetti”, “montoni”, “fighette”, “maschietti” ecc.); inoltre, visto che il film si svolge tra bande giovanili, non ci si lascia scappare la ghiotta occasione di appesantire a piacere i dialoghi, stravolgendo così lo spirito dell’opera e ponendo i protagonisti in una luce molto peggiore di quella voluta dallo sceneggiatore David Shaber. Quando per esempio alcuni componenti della banda incontrano un gruppo di ragazze intenzionate a tender loro una trappola, queste affermano di essere “real cripples” (cioè “realmente zoppe” nel senso di sole, prive di compagnia); ma noi udiamo “Siamo vedove e senza muscolo”! Le dichiarazioni della coprotagonista “Friday nights are pretty good and Saturday nights are better” si trasformano in “Il venerdì sera è bello fottere e il sabato ancora meglio” – e via sovraccaricando.
Non ho mai avuto occasione di vedere la versione inglese di un sottovalutato film di fantascienza uscito in sordina nel 1974, “Flesh Gordon” di Ziem e Benveniste, ma ricordo bene che un personaggio si esprimeva in dialetto siciliano e un altro faceva allusioni al centrosinistra e a “Pier Paolo”… Nel celeberrimo “Lo squalo”, il personaggio del poliziotto Brody interpretato da Roy Scheider viene chiamato capitano mentre nell’originale è “chief”; e non credo che nel posto di polizia confinario in cui si svolge il film sia previsto un ufficiale del grado suddetto. Senza parlare delle infinite volte, partendo dalla saga del “Padrino”, in cui siamo stati afflitti dal “sicilianese”- cantilena modulata dai vari “voscienza benedica” e “amunnine picciotti” (anche quando nell’originale si parla in inglese, come in “Summer of Sam” di Spike Lee, 1999).
- Il vezzo (vizio?) di cambiare i nomi dei personaggi inizia da lontano. Nel lontano 1932 il personaggio di Tony Camonte in “Scarface” si tramutò in Tony Kermont. Nel “Massacro di Fort Apache”, il colonnello Thursday (Henry Fonda) diviene Turner; in “Sentieri selvaggi”, il capo indiano Scar diviene Scout, equiparato quindi ad un giovane esploratore; nel film di Ritt “Un urlo nella notte” Troy e Leola, marito e moglie, diventano Roy e Lola. Ma a volte si ha l’impressione che certe modifiche non abbiano altra giustificazione che quella dell’abusivismo. Per quale motivo, nell’episodio “The little people” della serie “Ai confini della realtà”, l’astronauta Craig (Joe Maross) viene ribattezzato Knauff? Per quale motivo, nello splendido western “La notte dell’agguato”,
il guerriero indiano Salvaje diventa Kataua? Per quale motivo in “Magic” (una delle prime prove di Anthony Hopkins) il nome del pupazzo viene alterato da Fats a Forca?
C’è di peggio. “L’agguato” (“The trap”, 1959) scritto da Richard Simmons e diretto da Norman Panama, vede Richard Widmark nei panni dell’avvocato difensore (redento) di un criminale chiamato Manolescu. Rumeno? Così parrebbe; sennonché in due occasioni si vede chiaramente, nell’ufficio dello sceriffo, una locandina “reward” col nome e la foto del malavitoso (l’interprete è Lee J. Cobb): Victor Massonetti. La censura dell’epoca non arretrava neppure di fronte al ridicolo. Due anni prima, nel “Ladro” di Hitchcock, il personaggio italiano di Henry Fonda, chiamato Balestrero, era diventato Bannister; e nel 1966 Mateo, il messicano del bellissimo “A sud ovest di Sonora” (Sidney Furie, 1966) interpretato da Marlon Brando, diviene Matt: di conseguenza non si capisce perché, quando fa ritorno alla casa paterna, i suoi consanguinei (che si chiamano Paco, Ana ecc…) lo salutano come uno di loro. Il ciclo di “Star Wars”, infine, subisce diverse ferite. La principessa Leia diviene Leila, Darth Vader diviene Lord Fenner (londinese?), il robotino R2-D2 diviene C1; e per sovrappiù, l’originaria “light saber”, cioè “sciabola di luce”, diviene la celebre “spada laser” (chi pratica scherma sa che spada e sciabola sono due cose diverse).
Infine, probabilmente in un momento di spirito, nel “Roger Rabbit” di Zemeckis il nero giudice Doom interpretato da Christopher Lloyd diviene Morton.
Termina qui questo piccolo florilegio, ma se avessi lo spazio per approfondire l’argomento potrei ricavarne un volume.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
FILMMAKER ALLA RIBALTA: ETTORE DI GENNARO
di Paolo Micalizzi
E’ il matrimonio del fratello, dove gli viene chiesto di fare l’operatore, che fa scoprire a Ettore Di Gennaro il piacere delle riprese cinematografiche. Ed è il mestiere del padre, pittore di vedute ottocentesche, che gli fa apprendere il disegno donandogli cosi il gusto per la grafica pubblicitaria e la fotografia. Intanto la sua mente s’affolla di storie e quindi con i suoi compagni di Liceo Paolo D’Alessandro e Francesco De Gregorio fonda il sodalizio artistico 3dproduction( dalle iniziali dei tre cognomi) in cui tentano sperimentazioni video nel genere parodistico. Il passo dai filmati di famiglia a storie autonome è compiuto. Fondamentale in quel periodo è l’acquisto, da parte di suo padre, di una centralina per effetti video e audio, con cui realizzare il bianco e nero, dissolvenze incrociate, doppiaggio audio e mix vari.
Dopo alcuni tentativi nasce nel 1994 il suo primo cortometraggio. S’intitola “Gli impensabili-Profumo di crimine”, una sgangherata story sull’onda de “Gli intoccabili” di Brian De Palma. Seguiranno nel 1995 “Agente 081 Rhys Blond-Missione Transex” ispirato alla saga di James Bond e via via, per i successivi 16 anni, altre parodie e piccoli clip di sperimentazione. Ettore e il suo gruppo erano ormai decisi a raccontare e raccontarsi per immagini, interpretando i loro sogni e le loro passioni da protagonisti e non più da spettatori. Da quel momento la vita e l’evoluzione artistica di Ettore Di Gennaro e della 3dproduction si intrecciano saldamente, arrivando a disegnare personalmente tutte le locandine e il materiale grafico.
Realizzano anche il 3d notiziario, mezzo di comunicazione, con cui informare gli amici di ogni novità. Arriva il computer, ci dice Ettore Di Gennaro, ed è con il primo Pentium II e scheda di acquisizione video Maxtor che le riprese in VHS-C vengono riversate sul disco rigido e poi montate a piacimento con Adobe Premiere aumentando cosi il poter creativo del gruppo. Il pieno controllo delle loro operazioni arriva, continua Ettore, con Adobe After Effects e 3dstudio Max, due software che permettono di realizzare effetti speciali e animazioni digitali, offrendo la possibilità di “ piegare” ogni singola ripresa alle proprie necessità: il potere creativo può superare cosi i limiti tecnici.
Il gruppo, intanto, cresce includendo nuovi collaboratori. Ma poi, per motivi di lavoro, tra il 2001 e 2003 il gruppo si disperde: Ettore Di Gennaro, infatti, si trasferisce da Napoli a Parma dove vive tutt’ora ed altri membri vanno ad abitare a Milano, Roma e Firenze. L’amore di raccontare con il cinema però è sempre vivo ed Ettore Di Gennaro realizza opere parodistiche come “Sverminator” con evidente riferimento alla saga di “Terminator”, “Strambo III”, “sCOPpiat” ed il cartoon “I 3d tenors”.Nel 2009 poi trasforma il sodalizio con quel gruppo di amici sparsi in tutt’Italia in Associazione Culturale nella quale riversa tutte le sue energie artistiche. Nel tentativo di filmare e produrre insieme film, ogni anno viene creato un evento riservato ai soci per ”respirare cinema” insieme per 2-3 giorni.
.
.
.
.
.
Per superare poi l’essere autodidatti e potersi confrontare con altri autori con cui si divide la stessa passione, il gruppo s’iscrive alla Fedic. E il primo passo è l’inizio della collaborazione con il musicista Sergio Brunetti: da quel momento le storie di Ettore Di Gennaro possono avvalersi di musiche originali e del taglio ironico necessario a reggere il racconto.
Importante è anche la collaborazione nel 2011 con il fotografo Antonio Castaldo che curerà la fotografia dei cortometraggi insegnando al gruppo l’importanza di illuminare correttamente un set e la pazienza per una messa in scena corretta e meticolosa.
Intanto Ettore Di Gennaro scopre il mondo di Youtube e dei social network e partecipa per due volte al concorso “Short Movie La3” indetto dal digitale terrestre La3 e dalla compagnia telefonica mobile omonima. E si piazza primo nel 2012 con “Arma micidiale”, parodia della saga poliziesca con Mel Gibson e Danny Glover scritta da Paolo D’Alessandro, e secondo nel 2013 con ”Sbatman”, di cui è anche coautore della sceneggiatura: una parodia anch’essa del telefilm anni 60 del famoso supereroe a fumetti. Molta attiva in questi anni la sua produzione grafica al servizio della 3dproduction. Ogni anno realizza un calendario che promuove il corto di prossima uscita, ma anche un gioco dell’oca sul tema del cinema dilettantesco soprannominato Gioco dell’o scars in cui la grafia del gioco dell’oca e dell’oscar si fondono con la frase in dialetto napoletano “lo scarso” creando un mix allusivo fra voglia di fare grandi cose e povertà di mezzi e risultati.
Dal 2014, una svolta nella sua attività: si divide fra il ruolo di regista al servizio di storie scritte da Paolo D’Alessandro e quella di autore completo con regie e sceneggiature proprie. Nasce “E penso a te”, dove con un taglio da commedia nera, cerca ,in tre minuti, di delineare il labile confine che esiste fra come ci vediamo e come ci vedono gli altri. E’ un corto girato interamente con uno smartphone iphone5 in cui,per sperimentazione, grazie a software dedicati realizza effetti pioggia e impossibili panoramiche a volo d’uccello. Il tutto in bianco e nero con la sola eccezione di una lettera del protagonista, unico elemento colorato in scena, che lega la prima parte(illusione) con la seconda(la rivelazione): il cortometraggio, ci informa l’autore, è stato presentato nella sala comunale di Calci(Pisa) provocando discussione per il cinismo messo in scena attraverso l’immagine cinica della donna e della società in genere. E’ il ventennale dell’Associazione ed Ettore Di Gennaro cura, con la collaborazione per i testi di Paolo d’Alessandro il libro “Moriremo nel tentativo di farcela”, un titolo che racchiude, come spiega nella prefazione, una speranza e un timore: vivere nel continuo e precario equilibrio della sua produzione, che oscilla pericolosamente tra le due conclusioni possibili, successo o disfatta! Ma anche un libro, tra l’altro ben corredato da fotografie, tutto da leggere che rivela lo spirito scautistico di gioiosa amicizia con il quale il gruppo ha operato sin dalla sua nasciata un libro al quale noi, insieme ad altri appunti dell’autore, abbiamo attinto per questo Profilo.
 Un Concorso, a durata e tema fisso, indetto nel 2014 dalla Persol stimola la 3dproduction a realizzare 5 storie noir: sono racconti dal taglio e stile eterogeneo. “A good plan”, scritta da Alessandro Pavino e diretto da Ettore Di Gennaro ha al centro della storia un losco scambio in un garage sotterraneo, mentre “The clue”, scritto da Paolo D’Alessandro, narra di un investigatore che osservando delle foto di una scena del crimine scova l’indizio risolutivo. “Reporter” e “The bedroom”, scritte e dirette da Ettore Di Gennaro, raccontano della pericolosa ossessione di un giornalista e di una donna fatale che attende come una mantide il suo amante. Chiude la pentalogia “The door” , scritto e diretto da Antonio Castaldo per il quale Ettore Di Gennaro cura il montaggio e la post-produzione. Sono storie scritte da autori diversi che Ettore Di Gennaro , per non disperdere esperienza e impegno profuso dagli associati, unisce e completa in un unico racconto dal titolo eloquente di “3dproduction Noir Tales”. La storia passa da 5 a 10 scene e vengono realizzati espressamente per questa versione nuove scene di raccordo aggiungendo anche nuovi personaggi. L’ esercizio stilistico in bianco e nero e l’uso della luce come personaggio in scena risultano stimolanti e inediti:alla produzione partecipa anche Giorgio Sabbatini, come voce narrante in apertura e chiusura del corto.
Un Concorso, a durata e tema fisso, indetto nel 2014 dalla Persol stimola la 3dproduction a realizzare 5 storie noir: sono racconti dal taglio e stile eterogeneo. “A good plan”, scritta da Alessandro Pavino e diretto da Ettore Di Gennaro ha al centro della storia un losco scambio in un garage sotterraneo, mentre “The clue”, scritto da Paolo D’Alessandro, narra di un investigatore che osservando delle foto di una scena del crimine scova l’indizio risolutivo. “Reporter” e “The bedroom”, scritte e dirette da Ettore Di Gennaro, raccontano della pericolosa ossessione di un giornalista e di una donna fatale che attende come una mantide il suo amante. Chiude la pentalogia “The door” , scritto e diretto da Antonio Castaldo per il quale Ettore Di Gennaro cura il montaggio e la post-produzione. Sono storie scritte da autori diversi che Ettore Di Gennaro , per non disperdere esperienza e impegno profuso dagli associati, unisce e completa in un unico racconto dal titolo eloquente di “3dproduction Noir Tales”. La storia passa da 5 a 10 scene e vengono realizzati espressamente per questa versione nuove scene di raccordo aggiungendo anche nuovi personaggi. L’ esercizio stilistico in bianco e nero e l’uso della luce come personaggio in scena risultano stimolanti e inediti:alla produzione partecipa anche Giorgio Sabbatini, come voce narrante in apertura e chiusura del corto.
 Importante per Ettore Di Gennaro è la partecipazione nel 2014 al XII stage Fedic sul tema della Regia diretto da Roberto Merlino e che vede come docente il regista Giuseppe Ferlito. Un’esperienza che gli permette di confrontarsi con altri filmmakers e, come lui dichiara, di saggiare l’atmosfera che si respira su un vero set, disegnando anche gli storyboard per le scene d’apertura.
Importante per Ettore Di Gennaro è la partecipazione nel 2014 al XII stage Fedic sul tema della Regia diretto da Roberto Merlino e che vede come docente il regista Giuseppe Ferlito. Un’esperienza che gli permette di confrontarsi con altri filmmakers e, come lui dichiara, di saggiare l’atmosfera che si respira su un vero set, disegnando anche gli storyboard per le scene d’apertura.
Alla fine dello stesso anno alla sua filmografia si aggiungono “RendezVous!” e “7:30 AM”, due storie originali di Paolo D’Alessandro: dirige uno dei corti e si mette al servizio del collega regista/sceneggiatore come operatore e montatore dell’altro, ruolo che da allora rivestirà sempre in tutta la produzione della 3dproduction. In “RendezVous”, informa l’autore, si assiste ad un raffinato gioco di inganni in cui preda e cacciatore si alternano sullo schermo. Dissemina la narrazione di briciole verso un sentiero di lettura fuorviante, per poi virare d’improvviso sulla cruda realtà, portando lo spettatore a dedurre ciò che inizialmente risulta nascosto ad una sbrigativa visione. Ciò che l’aveva attratto della sceneggiatura era,infatti, il tema della sorpresa e della differenza tra ciò che appare da ciò che accade. Ad interpretarlo chiama Elena Chiappini, cosplayer molto nota nel mondo delle fiere e manifestazioni quali Luccacomics, etc. Per l’attività cinematografica di Ettore Di Gennaro il 2015 inizia con la regia di “Offerta”, scritto sempre da Paolo D’Alessandro, per il Concorso “Acqua” della Fedic. Racconta in una breve clip uno scambio di doni fra due soli protagonisti, uomo e donna, che fa pensare ad un atto d’amore. Utilizzando musiche elettroniche di Fabius Noxe( al secolo Fabio Bellini) il suo intento, sottolinea, è di portare lo spettatore ad immergersi in un dialogo muto riempito solo da gesti misurati e precisi che allegoricamente rimandano alla vita. Ma il carnet di Ettore Di Gennaro si riempie di tante altre storie che aspettano di essere raccontate: tra esse “Maschere” scritto anch’esso da Paolo D’Alessandro. sul tema dell’essere e apparire, e “Ci ripenso” che si ricollega al precedente “E penso a te” per la tematica del percepito di sé e degli equivoci che ciò può generare.
FILMOGRAFIA
CLIP
(1994) (Dis)Ghost
Agente 0823 Stefano Bond (clip)
(1999) Mancuso Antidroga (clip)
(2000) Bleearh (clip)
Lo zio (clip)
I CHIPster (clip)
Mancuso in vacanza (clip)
(2008) sCOPpiat (clip)
I 3d tenors (clip)
Cliffhungry (clip)
(2010) Una preda stupefacente (clip)
Il trucco (clip)
(2011) Io sto leggendo (clip)
Mars s’attack (clip)
(2013) La fretta (clip)
(2014) E penso a te (clip)
(2014) Grattamy (clip)
CORTOMETRAGGI
(1994) Gli Impensabili: profumo di crimine
(1995) Agente 081 Rhys Blond: missione Transex
(1997) Ailanter l’ultimo immorale
(1998) The X false
(1999) Chiattestein
(2000) Strambo
(2001) Night Pipp
(2002) Tirannic Park
(2003) Strambo II
(2006) Sverminator
(2007) Strambo III
(2009) Brocky
(2010) Indiana Jeans e la ricerca della menta pizzicosa
(2011) Arma Micidiale
(2012) Sbatman
(2013) Sfiga da New York
(2014) L’invasione degli Ultrapolpi
(2014) RendezVous!
(2015) Offerta
CINEMA E SCUOLA
di Laura Biggi
 Fedic Scuola, costituita nel 1985 è la sezione della Fedic (Federazione Italiana Cineclub) che si occupa della divulgazione e del linguaggio cinematografico in tutti gli ambienti formativi, scuole di ogni ordine e grado ( dalla scuola dell’Infanzia alle Università) ed associazioni culturali del territorio nazionale.
Fedic Scuola, costituita nel 1985 è la sezione della Fedic (Federazione Italiana Cineclub) che si occupa della divulgazione e del linguaggio cinematografico in tutti gli ambienti formativi, scuole di ogni ordine e grado ( dalla scuola dell’Infanzia alle Università) ed associazioni culturali del territorio nazionale.
La “MISSION” di Fedic Scuola ( che ha un comitato formato da Laura Biggi, MariaTeresa Caburosso e Giorgio Ricci) è di promuovere, sostenere e coordinare progetti di cinematografia scolastica a tutti i livelli dell’istruzione mediante fruizione e produzione di cortometraggi ed organizzare workshop per alunni e docenti.
L’obiettivo è quello di avviare alla decodifica dii messaggi visivi, soprattutto dinamici, analizzarli e padroneggiarli, rendendo il video una modalità comunicativa alla portata di tutti.
Dal 2014 è stato attivato un Campus Estivo denominato “NaturalmenteCinema” a carattere residenziale al quale possono partecipare bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia, un’occasione per coniugare socialità, divertimento ed apprendimento.
I giovani corsisti sperimentano le varie tecniche cinematografiche, la realizzazione del film è l’obiettivo comune che favorisce il lavoro di squadra, la condivisione e la ripartizione di incarichi nel gruppo.
Si è appena conclusa l’edizione 2015 del suddetto Campus,
Il trailer del film “Il sentiero della bolla d’ombra” scritto e diretto da Margherita Caravello e Daniele Corsi è sul canale YouTube Trailer film campus https://www.youtube.com/watch?v=pd_SF834C4w
E il videoclip https://www.youtube.com/watch?v=mHtHfFVIF4&feature=share
L’attività di Fedic Scuola è sempre molto intensa, ogni anno si ampliano le attività formative .
Le proiezioni nelle scuole sono state talvolta associate ad incontri con gli autori finalizzati sia all’analisi filmica che alla conoscenza delle fasi salienti della realizzazione di un film ( ideazione, realizzazione, post-produzione con riferimenti sia di ordine tecnico, montaggio, sonorizzazione sia pratico, come ricerca location e risorse economiche).
Durante l’anno scolastico appena terminato, in collaborazione con il MISFF (Montecatini International Short Film Festival) si sono svolti laboratori nelle classi terminali della scuola primaria ( 40 ore di laboratorio con oltre 150 alunni coinvolti), naturalmente sono state presentate le diverse attività inerenti il cinema; approccio alla videocamera (inquadratura e messa a fuoco), story board, sceneggiatura, documentario, chromakey (effetti speciali), doppiaggio ed animazione.
Da un recente sondaggio effettuato tra i cineclub Fedic, è emerso che meno della metà svolge attività in collaborazione con le scuole del proprio territorio. I presidenti riferiscono difficoltà nel contattare e coinvolgere le istituzioni scolastiche, già oberate di progettualità in corso.
Da docente, confermo che la scuola in questo periodo storico è sottoposta a molte pressioni e vive in un clima di incertezza, il mio consiglio è di non desistere nell’impresa, ma intraprendere procedure di sensibilizzazione, con presentazione di progetti con la richiesta di diffusione a tutte le scuole sia in ambito locale che nazionale, attraverso i canali istituzionali : innanzitutto, l’Ufficio Scolastico Provinciale ( ex Provveditorato agli Studi) al quale, per esempio, proporgli, attraverso i Presidi, anche la proiezione di una serie, ecc. ecc.
Un approccio molto più diretto è chiedere appuntamento ad un Dirigente Scolastico (Preside) per proporgli inizialmente la proiezione di una serie di film realizzati in ambito scolastico ( compilation dei cortometraggi selezionati e premiati nell’ambito dei vari festival, ad esempio SVMI Scuola VideoMultimedia Italia).
Naturalmente Fedic Scuola garantisce la disponibilità per consulenze ed indicazioni inerenti tutte le progettualità di cinema-scuola dei cineclub, non solo Fedic, che ne facciano richiesta.
La rete dei Festival Fedic è in incremento ogni anno, sarebbe auspicabile che ognuno avesse una sezione scuola, ma purtroppo non è ancora così,
Fedic Scuola sta attuando strategie affinché ciò possa avvenire.
La comunicazione in ambito Fedic (sia in orizzontale tra cineclub, che in verticale tra il vertice e la base) è migliorata molto negli ultimi anni, grazie anche alle pubblicazioni on line “Nuovo Fedic Notizie”, “Carte di Cinema” e ai social network.
La tecnologia ci consente di mantenerci in contatto, per informare, confrontare, progettare, tenendo presente che la Fedic non è una persona fisica ma è costituita da tutti coloro che ne fanno parte.
REFF – RETE FESTIVAL FEDIC. ”I FESTIVAL SONO VICINI”
di Gianluca Castellini
Ad inizio 2013, prende corpo l’idea di mettere in rete i festival organizzati da cineclub FEDIC. Sotto l’acronimo REFF ( Rete Festival FEDIC), si riuniscono 15 realtà, diverse tra loro, ma unite da un doppio filo conduttore, la passione per il cinema e l’appartenenza alla FEDIC. Gia ‘ nel triennio 2008/2010, era maturata un’esperienza di condivisione in rete con l’istituzione del FEDIC d’oro, ideato da Gianluca Castellini e Roberto Merlino. Il circuito che vedeva coinvolti festival e cineclub, aveva espresso nei tre anni, numeri partecipativi di rilievo caratterizzando un movimento che dava l’idea di un certo risveglio artistico. Nel periodo di riferimento furono assegnati 3 premi FEDIC d’oro, con la partecipazione media di 27 cineclub, 10 festival, e con un totale di 400 cortometraggi. Poi una certa indolenza e una fase di rinnovamento hanno congelato la crescita del movimento.
Ma il desiderio di conservare l’importanza di un sodalizio è rimasto immutato, perciò è risultato facile ripartire da un’eredità culturale, di fatto mai esaurita.
Nelle singole formulazioni artistiche ogni festival ha individuato caratteristiche provenienti da origini diverse. C’è chi si orienta sull’aspetto internazionale , sul genere, sulla sperimentazione tematica, sulla capacità di creare itinerari geografici, sulla tradizione del territorio ed altri elementi. E’ importante evidenziare, come in tutte le realtà della rete, il pubblico risulta crescente e ricettivo, quasi in controtendenza rispetto ai circuiti distributivi tradizionali che hanno visto tante sale entrare in profonde letargie o addirittura sparire.
Nella programmazione dei singoli eventi si cerca sempre più di sensibilizzare l’appartenenza alla FEDIC, con la promozione di premi personalizzati, meeting, vetrine di autori, azioni d’immagine, condivisioni di social network, conferenze. Altre azioni sinergiche sono in fase di studio per creare un rafforzamento della rete. Il singolo festival non deve snaturare la propria impostazione, ma sa che può attingere da altri festival REFF, per arricchire in maniera costante le singole idee.
I contenuti diventano permeabili, di facile accesso. I festival si scambiano film, pareri, sottotitoli, partecipano ad azioni comuni. Si possono impostare azioni pubblicitarie più incisive se non altro per promuovere in modo capillare i singoli eventi, ad esempio con un portale dedicato, dove visualizzare in modo aggiornato le caratteristiche principali degli eventi, dead line, regolamenti, date di svolgimento e comunicazioni di servizio.
Un festival è di per sé un grande catalizzatore di contenuti e cercare di metterli in rete è un sicuro vantaggio per tutti gli addetti ai lavori.
La digitalizzazione ha offerto grandi vantaggi ai festival in genere, ma nuove sfide vanno affrontate e il sistema di messa in rete deve rappresentare una opportunità di crescita o di sopravvivenza. Non ultimo il concetto di rete può significare un elemento rafforzativo nei rapporti con le istituzioni e determinare un maggior grado di attenzione verso un collettivo.
I 15 Festival che aderiscono al network sono: (in ordine di calendario), Mendicino Corto, Cortocinema di Pistoia, Genova Film Festival, Valdarno Cinema Fedic, Camaiore Film Festival, Festival del Cinema di Brescello, Premio l’Airone di Codigoro, Animare di Cesenatico, Film Caravan d’Imperia, Corto Fiction di Chianciano, Sedicicorto di Forlì, Film Video di Montecatini, Fano Film Festival, Reggio Film Festival di Reggio Emilia, Firenze Film Corti.
TREDICESIMO STAGE FEDIC: INTERVISTA AD ALESSANDRO GRANDE
di Roberto Merlino
Lo Stage Nazionale FEDIC di Formazione ed Approfondimento è diventato, nel corso degli anni, un fiore all’occhiello per la Federazione Italiana dei Cineclub ed un punto di riferimento per quei videomaker che vogliono migliorare la loro preparazione in modo serio e qualificato.
La 13.a edizione, svoltasi a Calci (PI) dal 3 al 7 settembre, ha avuto come docente Alessandro Grande, regista e sceneggiatore calabrese che, a dispetto della giovane età, ha già avuto oltre 150 riconoscimenti e premi in giro per il mondo.
Quella che segue è un’intervista ad Alessandro Grande, fatta da Roberto Merlino, Presidente FEDIC e Direttore dello Stage FEDIC fin dalla prima edizione.
Roberto Merlino: Tanto per cominciare ti faccio fare lo stesso esercizio che tu hai richiesto ai partecipanti ad inizio Stage: “descriviti in quattro righe”.
Alessandro Grande: Sono un sognatore, sempre più innamorato dalla grande possibilità che offre il cinema, far vivere nuovi mondi e condividerli con gli altri è un privilegio bellissimo e cerco ogni volta di sfruttarlo dando il massimo.
Roberto Merlino: Come ti sei avvicinato al mondo del cinema?
Alessandro Grande: E’ stato grazie all’Università: ho studiato comunicazione multimediale e regia, laureandomi nel 2006. Come tesi finale ho presentato un cortometraggio, per prova, per gioco. Un cortometraggio che rappresentava, in chiave moderna, “la colpevolezza dell’innocenza”, una tematica già affrontata da Pasolini attraverso un suo cortometraggio nel 1968. Questo mio lavoro, inaspettatamente, è andato talmente bene che ho vinto diversi festival, tra cui uno nell’ambito delle Università. Pian piano ho iniziato a crederci e mi son detto “quasi quasi faccio il secondo” e poi “quasi quasi faccio il terzo”. Nello stesso tempo ho portato avanti il percorso di studi ed ho finito l’Università, conseguendo la laurea Specialistica in Storia e critica del cinema. Da allora sono convinto che il cinema è il più grande mezzo di comunicazione.
Roberto Merlino: Nella vita cosa fai?
Alessandro Grande: Nella vita provo a fare cinema. Provo… perché è difficile. Perché richiede una costanza e una determinazione smisurata. Realizzo lavori prettamente legati all’audiovisivo, cioè cortometraggi, documentari, spot. Lavoro in TV e poi mi dedico a raccontare la mia esperienza -come sto facendo qui allo Stage della FEDIC- attraverso corsi e seminari di sceneggiatura e di regia.
Roberto Merlino: Che spazio ha il corto in Italia?
Alessandro Grande: Negli anni sessanta, il cortometraggio anticipava nelle sale cinematografiche la proiezione dei film e per questo lo spettatore di allora era più sensibilizzato verso il cinema breve. Purtroppo, per una serie di problematiche prettamente economiche, questo meccanismo si è interrotto e, piano piano, il cortometraggio è sparito dalle sale, pur rimanendo vivo nell’underground del cinema indipendente. Negli ultimi anni invece, grazie al digitale, che permette di lavorare con costi abbordabili, e a tutti gli eventi culturali e organizzazioni che prediligono questa forma d’arte rispetto ad altre, il cortometraggio sta diventando un mezzo di comunicazione sempre più conosciuto nel nostro Paese e necessario per far nascere nuove leve.
Roberto Merlino: Cosa suggerisci a chi si avvicina al mondo del cinema indipendente?
Alessandro Grande: Il suggerimento principale che mi sento di dare è quello di “essere sé stessi”. E’ importante guardarsi attorno ed essere umili. Ma, soprattutto, avere sempre fame, perché in questo mondo è facile scoraggiarsi e ancora più facile è illudersi quando si fa qualcosa di buono. Bisogna stare sempre coi piedi per terra e trovare dentro di noi quella voglia che ci spinge a superarci e a fare sempre meglio. Soltanto così, tenendo accesa questa fiamma, riusciamo a metterci in gioco e a dare sempre il meglio di noi.
Roberto Merlino: Cosa pensi della FEDIC?
Alessandro Grande: La FEDIC, deve essere ancora più conosciuta, merita più spazio e merita un ruolo primario in Italia. E’ molto difficile divulgare questa forma d’arte in un paese come il nostro ed è difficile trovare sostegni e contributi. La FEDIC è una delle realtà che mantiene vivo il cinema e se esistiamo noi autori, è anche grazie ad entità come la FEDIC. Per giunta, se la FEDIC esiste, è anche grazie a noi. Quindi, in qualche modo, ci “compensiamo” ed abbiamo bisogno l’uno dell’altro.
Roberto Merlino: Com’è che sei venuto qui a condurre il 13° Stage Nazionale FEDIC?
Alessandro Grande: Sono stato ospite durante la precedente edizione dello Stage FEDIC, in quanto vincitore di un premio con un mio cortometraggio. Con Roberto Merlino è stato un colpo di fulmine ed abbiamo trovato l’intesa giusta per poter raccontare l’anno successivo, cioè oggi, la mia esperienza e il mio pensiero riguardo il cinema.
Roberto Merlino: Siamo soltanto al secondo dei cinque giorni di lavoro che caratterizzano lo Stage, ma credo tu possa già dare un’impressione di quello che sta succedendo.
Alessandro Grande: Se il buongiorno si vede dal mattino…! I partecipanti stanno reagendo bene e stanno lavorando tanto. Questo è importante perché vuol dire che sono entrati nell’ottica di cosa significa fare un mestiere come questo. Un mestiere che non si può improvvisare. Un mestiere che deve diventare un’ossessione. Dino Risi diceva “non riesco a far capire a mia moglie che anche quando guardo fuori della finestra sto lavorando”. Questo per dire che il cervello resta sempre acceso, resta sempre collegato a quello che stiamo scrivendo, perché stiamo ricostruendo un mondo, quindi ci vuole tanto impegno, tanto sacrificio e soprattutto tanta, tanta dedizione. Mi sembra che i partecipanti stiano comprendendo cosa significhi essere sceneggiatore e, oltre all’impegno, stanno rispondendo bene anche dal punto di vista creativo.
Roberto Merlino: Finiamo “alla Marzullo”. Fatti una domanda e poi rispondi.
Alessandro Grande: Difficile così su due piedi, ci provo: “Riuscirò a trasmettere ai partecipanti la mia passione per il cinema?” La risposta ovvia sarebbe “Dovremmo chiederlo a loro!”. Però, credo che quello che conta realmente sia essere in pace con se stessi, sapendo di aver dato il massimo. E io sto dando tutto me stesso.
Roberto Merlino: OK perfetto …
Alessandro Grande: Beh la “marzullo” mi ha messo in difficoltà… La marzullata non me la dovevi fare!
Roberto Merlino: Eh, eh, eh
FESTIVAL ED EVENTI
CANNES 2015: UN’EDIZIONE NON PROPRIO BRILLANTE
di Giancarlo Zappoli
 E’ stata l’edizione della grande delusione per l’Italia che ha avuto in Concorso tre autori importanti (Garrone, Moretti, Sorrentino) e ha portato a casa, come avrebbe detto Mourinho, “zero tituli”. Ma va detto che, a parte alcune (poche) eccezioni, non abbiamo assistito a un’edizione particolarmente esaltante anche se le premesse avrebbero fatto pensare a ben altro esito. Il Palmares è stato il seguente:
E’ stata l’edizione della grande delusione per l’Italia che ha avuto in Concorso tre autori importanti (Garrone, Moretti, Sorrentino) e ha portato a casa, come avrebbe detto Mourinho, “zero tituli”. Ma va detto che, a parte alcune (poche) eccezioni, non abbiamo assistito a un’edizione particolarmente esaltante anche se le premesse avrebbero fatto pensare a ben altro esito. Il Palmares è stato il seguente:
Palma d’Oro al miglior film: “Dheepan” di Jacques Audiard
Gran Premio della Giuria: “Son of Saul” di László Nemes
Miglior regia: Hou Hsiao-Hsien per “The Assassin”
Premio della giuria: “The Lobster” di Giorgos Lanthimos
Miglior sceneggiatura: Michel Franco per “Chronic”
Miglior attrice: ex aequo Rooney Mara per Carol e Emmanuelle Bercotper “Mon Roi”
Miglior attore: Vincent Lindon per “La loi du marché”
Palma d’Oro alla carriera: Agnès Varda
Camera d’Or: “La tierra y la sombra” di Cesar Augusto Acevedo
La Giuria, formata da Joel ed Ethan Coen (Presidenti), Rossy De Palma, Guillermo Del Toro, Xavier Dolan, Jake Gyllenhaal, Sophie Marceau, Sienna Miller, Rokia Traoré si è comportata come ormai consuetudine prevede. Abbiamo riportato i nomi dei componenti perché ognuno potesse verificare di persona se quanto segue corrisponda o meno a verità: i giurati dei principali festival internazionali amano premiare film alla cui ideazione e/o realizzazione non parteciperebbero mai come registi o come attori. Più le opere in Concorso si distanziano dal modo di fare cinema dei giurati e più hanno la possibilità di vincere un premio. Con questo non si vuole dare un giudizio di positività o negatività ma semplicemente rilevare un dato. Per ripensare all’edizione 2015 del festival di cinema più importante del mondo abbiamo scelto la formula delle brevi schede su tutte le opere in competizione in rigoroso ordine alfabetico.
“Carol” di Todd Haynes
 Therese Belivet nella New York del 1952 è una commessa corteggiata da due uomini. Ma la sua attenzione è rivolta a un’affascinante cliente, Carol, una madre che vuole divorziare dal marito. La loro attrazione creerà non pochi problemi.
Therese Belivet nella New York del 1952 è una commessa corteggiata da due uomini. Ma la sua attenzione è rivolta a un’affascinante cliente, Carol, una madre che vuole divorziare dal marito. La loro attrazione creerà non pochi problemi.
Todd Haynes si conferma come un inarrivabile rilettore del mélo alla Douglas Sirk senza che però questo lo trasformi in un manierista. Il miracolo avviene anche grazie alla scelta degli attori. Nello specifico accanto a una sempre più cesellante Kate Blanchett si affianca una Rooney Mara che ha ben meritato il premio quale migliore attrice.
.
.
.
“Chronic” di Michel Franco
 David Wilson è un’infermiere che si occupa dell’assistenza domiciliare a pazienti terminali con i quali instaura rapporti che vanno oltre il professionale nell’ostinata ricerca di una famiglia che non ha più. Questo film, direttamente commissionato dal protagonista al regista, si regge sulla recitazione di Roth ma lascia più di una perplessità. Il finale è la più grande.
David Wilson è un’infermiere che si occupa dell’assistenza domiciliare a pazienti terminali con i quali instaura rapporti che vanno oltre il professionale nell’ostinata ricerca di una famiglia che non ha più. Questo film, direttamente commissionato dal protagonista al regista, si regge sulla recitazione di Roth ma lascia più di una perplessità. Il finale è la più grande.
.
.
.
.
“Dheepan” di Jacques Audiard
 Shri Lanka. Deephan fugge dalla guerra civile fingendo una famiglia con una donna e una bambina. Arrivati a Parigi lui trova un lavoro da guardiano di complesso abitativo e lei da badante. Ma la violenza torna a farsi presente sotto un’altra forma.
Shri Lanka. Deephan fugge dalla guerra civile fingendo una famiglia con una donna e una bambina. Arrivati a Parigi lui trova un lavoro da guardiano di complesso abitativo e lei da badante. Ma la violenza torna a farsi presente sotto un’altra forma.
Jacuqes Audiard conquista il massimo riconoscimento con un film che non è dei suoi migliori. Dice cioè delle cose giuste sui problemi dei migranti (da qualunque parte del pianeta arrivino) ma lo fa con uno stile che sembra essersi troppo edulcorato nonostante le accensioni di rivalità e di tragedia. Il finale è lì a testimoniare questo mutamento di rotta.
.
.
“Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone
 Ispirato a tre novelle de “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile il film di Garrone rappresenta una svolta, seppure nella continuità, per il suo cinema. In queste vicende di re lussuriosi e di regine spasmodicamente alla ricerca della maternità il regista affronta per la prima volta un cast internazionale e, al contempo, gli effetti speciali che realizza artigianalmente. La continuità è data dalla prosecuzione della ricerca sulla possibilità della bellezza in un mondo di cui si racconta il profondo degrado.
Ispirato a tre novelle de “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile il film di Garrone rappresenta una svolta, seppure nella continuità, per il suo cinema. In queste vicende di re lussuriosi e di regine spasmodicamente alla ricerca della maternità il regista affronta per la prima volta un cast internazionale e, al contempo, gli effetti speciali che realizza artigianalmente. La continuità è data dalla prosecuzione della ricerca sulla possibilità della bellezza in un mondo di cui si racconta il profondo degrado.
.
.
.
.
“La loi du marché” di Stéphane Brizé
 Thierry ha 51 anni una moglie e un figlio disabile. È disoccupato, ha frequentato corsi di formazione che non gli hanno portato un nuovo lavoro e le sue ricerche non producono esiti positivi. Finché un giorno viene assunto in un ipermercato con il ruolo di controllo nei confronti di tentativi di furto. Tutto procede regolarmente fino a quando un giorno si trova davanti a una scelta.
Thierry ha 51 anni una moglie e un figlio disabile. È disoccupato, ha frequentato corsi di formazione che non gli hanno portato un nuovo lavoro e le sue ricerche non producono esiti positivi. Finché un giorno viene assunto in un ipermercato con il ruolo di controllo nei confronti di tentativi di furto. Tutto procede regolarmente fino a quando un giorno si trova davanti a una scelta.
Vincent Lindon è uno degli attori più sobriamente intensi del cinema francese e internazionale e ha ben meritato il premio come migliore interprete maschile per un film che, senza retorica ma con profondo senso dell’umanità che ancora sopravvive in questo mondo di lupi (di Wall Street e non), racconta della quotidianità di chi ha bisogno di un lavoro e dei compromessi che può (o non può) accettare per conservarlo.
.
“Louder Than Bombs” di Joachim Trier
 I fratelli Jonah e Conrad si trovano a dover fronteggiare insieme al padre la morte della madre Isabelle Reed, apprezzata fotografa di guerra. Trier realizza un film ineccepibile sul piano formale ma troppo narcisistico nella sostanza finendo per proporre al pubblico degli stereotipi narrativi camuffati da indagine psicologica.
I fratelli Jonah e Conrad si trovano a dover fronteggiare insieme al padre la morte della madre Isabelle Reed, apprezzata fotografa di guerra. Trier realizza un film ineccepibile sul piano formale ma troppo narcisistico nella sostanza finendo per proporre al pubblico degli stereotipi narrativi camuffati da indagine psicologica.
.
.
.
.
.
“Macbeth” di Justin Kurzel
 Macbeth cede, sollecitato dalla moglie, nel credere alla profezia che lo vuole futuro re di Scozia. Per attuarla dovrà circondarsi di morte e sospettare di chiunque lo circondi.
Macbeth cede, sollecitato dalla moglie, nel credere alla profezia che lo vuole futuro re di Scozia. Per attuarla dovrà circondarsi di morte e sospettare di chiunque lo circondi.
I predecessori cinematografici di peso in materia (Welles, Kurosawa, Polanski) non mancano e Kurzel, pur non essendone intimidito, ne è consapevole. Realizza allora una rilettura molto cupa e anche molto virile a cui contribuiscono anche echi (forse inconsapevoli) de “Il trono di spade”. Ne consegue una versione corretta con pochi lampi di originalità.
.
“Marguerite et Julien” di Valérie Donzelli
 I due protagonisti si amano fin da bambini ma c’è un problema: sono fratello e sorella. Ci si ispira a una storia realmente accaduta in Francia nel ‘600 e a una sceneggiatura che François Truffaut non tradusse mai in cinema. Forse c’era una ragione che Donzelli non ha saputo comprendere realizzando così il film più patchwork dell’intera manifestazione riuscendo a superare anche le scelte più azzardate del cinema di Claude Lelouch cadendo, purtroppo, nel ridicolo.
I due protagonisti si amano fin da bambini ma c’è un problema: sono fratello e sorella. Ci si ispira a una storia realmente accaduta in Francia nel ‘600 e a una sceneggiatura che François Truffaut non tradusse mai in cinema. Forse c’era una ragione che Donzelli non ha saputo comprendere realizzando così il film più patchwork dell’intera manifestazione riuscendo a superare anche le scelte più azzardate del cinema di Claude Lelouch cadendo, purtroppo, nel ridicolo.
.
.
.
.
“Mia madre” di Nanni Moretti
 La regista Margherita che sta girando un film non facile su una situazione di tensione sociale, si trova a dover affrontare, insieme al fratello, la malattia e la morte della madre. Un film in cui Moretti torna ad affrontare temi a lui cari dopo aver sperimentato direttamente la scomparsa della genitrice. L’equilibrio tra dolore ed ironia è più che apprezzabile ma forse per la Giuria proprio i temi non hanno rappresentato nulla di nuovo nella filmografia del regista/attore.
La regista Margherita che sta girando un film non facile su una situazione di tensione sociale, si trova a dover affrontare, insieme al fratello, la malattia e la morte della madre. Un film in cui Moretti torna ad affrontare temi a lui cari dopo aver sperimentato direttamente la scomparsa della genitrice. L’equilibrio tra dolore ed ironia è più che apprezzabile ma forse per la Giuria proprio i temi non hanno rappresentato nulla di nuovo nella filmografia del regista/attore.
.
.
.
.
“Mon Roi” di Maïwenn Le Besco
 Tony, quarantenne e madre di un bambino, si infortuna gravemente un ginocchio sciando. Durante il lungo periodo necessario per la riabilitazione ha il tempo per ripensare al proprio rapporto con Georgio e a come dall’amore siano arrivati ai contrasti più accesi. Un film in cui il punto di vista femminile è esplicitamente dichiarato e affermato in un mondo (quello del cinema) in cui le donne registe sono poche e le sceneggiatrici pure. Destinato a non piacere a molti maschi ma ricco di annotazioni decisamente realistiche.
Tony, quarantenne e madre di un bambino, si infortuna gravemente un ginocchio sciando. Durante il lungo periodo necessario per la riabilitazione ha il tempo per ripensare al proprio rapporto con Georgio e a come dall’amore siano arrivati ai contrasti più accesi. Un film in cui il punto di vista femminile è esplicitamente dichiarato e affermato in un mondo (quello del cinema) in cui le donne registe sono poche e le sceneggiatrici pure. Destinato a non piacere a molti maschi ma ricco di annotazioni decisamente realistiche.
.
.
.
.
.
“Mountains May Depart” di Jia Zhang-ke
 Mentre la Cina si appresta a ristabilire la propria sovranità su Macao Tao, una giovane donna di Fenyang, non sa decidere a chi appartenere. Corteggiata da Zhang, proprietario di una stazione di servizio che si sogna capitalista, e Lianzi, minatore umile che estrae speranze e carbone, Tao sceglie Zhang e getta nella disperazione Lianzi, che abbandona casa e città. Inizia così il nuovo capitolo della ricerca che il regista cinese dedica ai veloci mutamenti impressi dal corso degli eventi alla società cinese scandagliati con uno stile molto personale.
Mentre la Cina si appresta a ristabilire la propria sovranità su Macao Tao, una giovane donna di Fenyang, non sa decidere a chi appartenere. Corteggiata da Zhang, proprietario di una stazione di servizio che si sogna capitalista, e Lianzi, minatore umile che estrae speranze e carbone, Tao sceglie Zhang e getta nella disperazione Lianzi, che abbandona casa e città. Inizia così il nuovo capitolo della ricerca che il regista cinese dedica ai veloci mutamenti impressi dal corso degli eventi alla società cinese scandagliati con uno stile molto personale.
.
.
.
“Our Little Sister” di Hirokazu Kore-eda
 Nella cittadina giapponese di Kamakura vivono tre sorelle (Sachi, Yoshino e Chika) il cui padre le ha lasciate da 15 anni per iniziare una nuova convivenza. In occasione del suo funerale le ragazze fanno la conoscenza della sorellastra adolescente Suzu che accetta volentieri l’invito ad andare a vivere con loro. Il punto di riferimento è la graphic novel “Umimachi’s Diary” di cui Kore-eda ha conservato l’impianto di fondo riservandosi però, con il consenso dell’autore Yoshida Akimi, la più ampia libertà di rilettura. Ha così focalizzato il racconto non solo sulla giovanissima Suzu ma anche sulla più adulta delle sorelle, Sachi. Ha potuto così leggere con grande sensibilità diversi aspetti dell’animo femminile e non solo. Perché sa anche universalmente mostrare come alcuni sentimenti, ritenuti in passato immutabili, possano trasformarsi nel corso del tempo.
Nella cittadina giapponese di Kamakura vivono tre sorelle (Sachi, Yoshino e Chika) il cui padre le ha lasciate da 15 anni per iniziare una nuova convivenza. In occasione del suo funerale le ragazze fanno la conoscenza della sorellastra adolescente Suzu che accetta volentieri l’invito ad andare a vivere con loro. Il punto di riferimento è la graphic novel “Umimachi’s Diary” di cui Kore-eda ha conservato l’impianto di fondo riservandosi però, con il consenso dell’autore Yoshida Akimi, la più ampia libertà di rilettura. Ha così focalizzato il racconto non solo sulla giovanissima Suzu ma anche sulla più adulta delle sorelle, Sachi. Ha potuto così leggere con grande sensibilità diversi aspetti dell’animo femminile e non solo. Perché sa anche universalmente mostrare come alcuni sentimenti, ritenuti in passato immutabili, possano trasformarsi nel corso del tempo.
.
.
.
“Sicario” di Denis Villeneuve
 La lotta contro il cartello della droga in Messico condotta dalle forze di contrasto americane. Al centro una giovane agente dell’FBI che ben presto scoprirà che la presenza del Male non va debellata ma solo contrastata (con misura).
La lotta contro il cartello della droga in Messico condotta dalle forze di contrasto americane. Al centro una giovane agente dell’FBI che ben presto scoprirà che la presenza del Male non va debellata ma solo contrastata (con misura).
Film dalla doppia possibilità di lettura: attori di qualità sono al servizio di un buon film di azione che ha anche giuste pretese di denuncia. Quello che però ci si è chiesto in tanti è cosa ci facesse in Concorso a Cannes. La risposta stava tutta (o quasi) nel tappeto rosso.
.
.
.
.
.
“Son of Saul” di László Nemes
 Ottobre 1944. Saul, deportato ad Auschwitz-Birkenau, viene scelto come sonderkommando addetto cioè alla raccolta e alla cremazione dei cadaveri. Il suo unico desiderio è sopravvivere fino a quando tra i morti riconosce il corpo del figlio.
Ottobre 1944. Saul, deportato ad Auschwitz-Birkenau, viene scelto come sonderkommando addetto cioè alla raccolta e alla cremazione dei cadaveri. Il suo unico desiderio è sopravvivere fino a quando tra i morti riconosce il corpo del figlio.
Nemes affronta il tema con la consapevolezza di quanto lo ha preceduto in materia sullo schermo. Ciò gli consente di concentrare l’azione sul desiderio di degna sepoltura che Saul cerca per quel giovane corpo in un universo concentrazionario in cui l’assuefazione all’abiezione domina.
.
.
.
“The Assassin” di Hou Hsiao-Hsien
 Nella Cina del IX scolo Nie Yinniang, giovane donna abilissima con la spada, ha l’incarico di uccidere il governatore Tian Ji’an. Costui è suo cugino e fu suo promesso sposo. Ora Nie dovrà decidere se obbedire agli ordini ricevuti.
Nella Cina del IX scolo Nie Yinniang, giovane donna abilissima con la spada, ha l’incarico di uccidere il governatore Tian Ji’an. Costui è suo cugino e fu suo promesso sposo. Ora Nie dovrà decidere se obbedire agli ordini ricevuti.
Hou Hsiao-Hsien che affronta una storia di wuxiapian (duelli). Come poteva un regista molto distante da Ang Lee dedicarsi a un tema simile? Molti se lo sono chiesti ma chi ne conosceva a fondo la filmografia sapeva che non si sarebbe focalizzato sul piano dell’azione ma su quello del tempo e della sua incommensurabilità. Dopo aver omaggiato i primi film del genere Hou Hsiao-Hsien rarefa l’azione per consentirci di esplorare la perfezione delle inquadrature in cui incastona la vicenda narrata bloccandola come una pietra preziosa.
.
“The Lobster” di Giorgos Lanthimos
 Nel futuro rimanere single dopo una certa età sarà assolutamente proibito. In caso contrario si verrà deportati in un hotel dove si avranno 45 giorni di tempo per poter trovare un’anima gemella pena l’essere trasformati in un animale a propria scelta.
Nel futuro rimanere single dopo una certa età sarà assolutamente proibito. In caso contrario si verrà deportati in un hotel dove si avranno 45 giorni di tempo per poter trovare un’anima gemella pena l’essere trasformati in un animale a propria scelta.
Con la complicità di un Colin Farrell baffuto il regista greco porta sullo schermo la difficoltà di trovare qualcuno con cui condividere la vita dopo che la si è vissuta in solitario. L’astrazione parafantascientifica è interessante. Lo è meno la molteplicità dei bersagli sociologici non sempre messi adeguatamente a fuoco.
.
.
.
.
“The Sea of Trees” di Gus Van Sant
 Alle pendici del monte Fuji c’è una foresta in cui è possibile entrare per non dover tornare mai più trovandovi la morte. E’ quanto accade al professore di Fisica Arthur Brennan e al giapponese Akumi Aokigahara che, essendo sceso nella classifica aziendale, vuole morire. Gus Van Sant ‘suicida’ il suo cinema precedente per inseguire una storia che si basa su dati reali ma che qui affonda nella retorica dando luogo a una delle peggiori prestazioni autoriali del regista.
Alle pendici del monte Fuji c’è una foresta in cui è possibile entrare per non dover tornare mai più trovandovi la morte. E’ quanto accade al professore di Fisica Arthur Brennan e al giapponese Akumi Aokigahara che, essendo sceso nella classifica aziendale, vuole morire. Gus Van Sant ‘suicida’ il suo cinema precedente per inseguire una storia che si basa su dati reali ma che qui affonda nella retorica dando luogo a una delle peggiori prestazioni autoriali del regista.
.
.
.
.
.
“Valley of Love” di Guillaume Nicloux
 Isabelle e Gérartd sono stati sposati ed hanno avuto un figlio, Michael. Non si sono più visti per anni ma ora è una situazione estremamente particolare a riunirli. Hanno infatti entrambi ricevuto una lettera dal figlio che annuncia loro di aver deciso di suicidarsi precisando la data. Chiede loro però di recarsi nella Valle della Morte negli Usa in una precisa settimana sei mesi dopo la sua morte. Dovranno seguire l’itinerario che lui indica e potranno incontrarlo per l’ultima volta.
Isabelle e Gérartd sono stati sposati ed hanno avuto un figlio, Michael. Non si sono più visti per anni ma ora è una situazione estremamente particolare a riunirli. Hanno infatti entrambi ricevuto una lettera dal figlio che annuncia loro di aver deciso di suicidarsi precisando la data. Chiede loro però di recarsi nella Valle della Morte negli Usa in una precisa settimana sei mesi dopo la sua morte. Dovranno seguire l’itinerario che lui indica e potranno incontrarlo per l’ultima volta.
Il regista è stato mosso da un’esigenza personale nel realizzare il film. Huppert e Depardieu lo assecondano riuscendovi meglio però fino a quando debbono dare corpo al perché la loro storia d’amore è nata e poi si è spenta. Quando il ‘fantasma’ si approssima però finiscono con il perdere in sincerità recitativa.
.
“Youth – La giovinezza” di Paolo Sorrentino
 In un elegante albergo ai piedi delle Alpi Fred e Mick, due vecchi amici alla soglia degli ottant’anni, trascorrono insieme una vacanza primaverile. Fred è un compositore e direttore d’orchestra in pensione, Mick un regista ancora in attività. Sanno che il loro futuro si va velocemente esaurendo e decidono di affrontarlo insieme.
In un elegante albergo ai piedi delle Alpi Fred e Mick, due vecchi amici alla soglia degli ottant’anni, trascorrono insieme una vacanza primaverile. Fred è un compositore e direttore d’orchestra in pensione, Mick un regista ancora in attività. Sanno che il loro futuro si va velocemente esaurendo e decidono di affrontarlo insieme.
“La grande bellezza” aveva diviso gli spettatori e la critica tra sostenitori e detrattori. Chi scrive apparteneva alla seconda categoria. Questo non implica il fatto di dover conservare il pregiudizio sull’opera successiva che infatti si rivela sgravata da quel barocchismo eccessivo che, a tratti, zavorrava il film precedente. Il Sorrentino sceneggiatore e il Sorrentino regista hanno trovato un accordo armonioso che permette al film di svilupparsi grazie a un maggiore controllo.
.
WE WILL ALWAY HAVE CANNES
di Laura Cacciamani e Francesca Bernardi
Cannes, il tapis rouge, il Palais du Festival, alla fine della Croisette. Le star, i vip a due passi da noi. Tutto questo ci è letteralmente piombato addosso, quando noi, due ragazze italiane senza esperienza in materia di festival, siamo scese dal treno (viaggio dell’avventura peraltro) nella calda cittadina di Cannes. L’interesse per la settima arte ci ha spinte a fare quella che pensavamo fosse una follia, ma che poi si è rivelata una bellissima esperienza.
Siamo arrivate impreparate, l’enorme offerta del festival ci ha fatto rabbrividire: a fare da cornice alla “séléction officielle” v’erano varie sezioni parallele, quali la “semaine de la critique”, la “quinzaine des réalisateurs”, “le cinema sur la plage” e “le marché du film” (sezione specifica dedicata ai nuovi film sul mercato).
Il primo giorno, per ambientarci volevamo seguire il classico stereotipo dei turisti ai festival: vedere i famosissimi vip. In realtà siamo state travolte dalla folla, che usando ogni tipo di mezzo cercava di sovrastare i vicini nella speranza di scorgere una qualsiasi parte di una star. Anche noi, come loro, possiamo vantarci di aver visto le scarpe di Margherita Buy, il vestito di Natalie Portman e i pochi capelli di Nanni Moretti, ma pochi istanti dopo non ci sentivamo più parte della folla urlante. Dovevamo scoprire quello che il festival aveva veramente in riserbo per noi. Ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo iniziato a capire quello che potevamo vedere, pur non avendo uno di quei magnifici badge rosa che apre tutte le porte.
Per la modica cifra di quattro euro a film, siamo riuscite a guardare ben quattro film della quinzaine de réalisateur: “Greeen Room”, “Les Cowboys”, “Mustang”, e infine “Le Tout Nouveau Testament”. Gli ultimi due ci hanno veramente colpito: “Mustang”, film di Deniz Gamze del 2015, è una storia per molti versi autobiografica: la stessa regista, alla fine del film, confessa di aver vissuto sulla propria pelle – e quindi poi aver voluto rappresentare- l’episodio cardine del film, in cui le cinque sorelle protagoniste, festeggiando l’ultimo giorno di scuola, giocano al mare con dei coetanei maschi. Episodio di per se innocente e naturale, che varrà però come condanna per le cinque ragazze, giudicate male da una società arretrata presente tutt’oggi in gran parte della Turchia (escludendo grandi città come Istanbul). In seguito a questo film ci siamo buttate a capofitto su una commedia surreale e ironica che ci estraniasse per due ore dalla dura realtà che avevamo “vissuto” nel realistico film Turco: “Le Tout Nouveau Testament” (Belgio, 2015 di Jaco Van Dormael), film unico nel suo genere, parla di Ea, figlia di Dio. Storia che fa della religione un’intelligente commedia, senza però virare nel ridicolo e nell’offensivo.
Un’altra sezione alla portata degli sprovvisti di badge era la “Semaine de la Critique”, a cui si accedeva tramite la richiesta di biglietti omaggio, senza alcuno sforzo. Abbiamo visto solo un film della “Semaine”: “Dégradé” (Palestina e Francia, 2015, Arab e Tarzan Abunasser,) Una storia di donne che si ritrovano chiuse in un coiffeur nella striscia di Gaza: una promessa sposa accompagnata da madre e suocera, un’anziana tradizionalista che critica la sua vicina, logorroica e occidentalizzata, una donna incinta in procinto di partorire e una ricca donna di mezz’età che si prepara per un appuntamento galante con il suo avvocato divorzista. A chiudere il quadro la parrucchiera, una russa immigrata per seguire il marito, e la sua dipendente più giovane, innamorata di un guerrigliero che proprio al di fuori del negozio viene coinvolto in alcuni scontri. Si notano due climax: uno della guerra al di fuori del negozio, e uno fra le donne all’interno, che arrivano anche alle mani, coinvolgendo l’intera sala che vive l’angoscia delle donne.
La sera, per non farci mancare nulla, siamo andate al “Cinema sur la plage”, rassegna di cui abbiamo visto un film inedito: “Enragés” (2015, Francia, Eric Hennezo) quattro criminali in fuga in seguito ad una rapina andata male si imbattono e prendono in ostaggio un uomo alla guida della sua macchina assieme alla presunta figlia, malata e stranamente silenziosa. Finale pieno di colpi di scena rende questo road-movie un piacevolissimo film da vedere sotto le stelle di Cannes accompagnato dallo scrosciare delle onde.
 Non potevamo di certo farci mancare il tapis rouge: grazie a due inviti racimolati qua e là siamo riuscite a entrare intacchettate alla prima di “Mon Roi” (Maïwenn, 2015, Francia), film della séléction officielle, che vede come protagonisti il bel Vincent Cassel, presente in sala con il resto del cast, e Emmanuelle Bercot, che vincerà poi il premio come miglior attrice protagonista, regalandoci un ricordo ancor più speciale di quell’ultima notte a Cannes.
Non potevamo di certo farci mancare il tapis rouge: grazie a due inviti racimolati qua e là siamo riuscite a entrare intacchettate alla prima di “Mon Roi” (Maïwenn, 2015, Francia), film della séléction officielle, che vede come protagonisti il bel Vincent Cassel, presente in sala con il resto del cast, e Emmanuelle Bercot, che vincerà poi il premio come miglior attrice protagonista, regalandoci un ricordo ancor più speciale di quell’ultima notte a Cannes.
Per citare a modo nostro il fascinoso Humphrey Bogart in Casablanca, “we will always have Cannes”(1).
(1) “Per sempre Cannes”
.
RIVER TO RIVER FLORENZE FILM FESTIVAL: PAS DE DEUX
di Maria Pia Cinelli
In un salone riccamente arredato, un gruppo di uomini seduti intorno a un grande tappeto assiste a una performance musicale. Subito la mdp stacca in primo piano su due piedi nudi ornati da cavigliere che battono ritmicamente per terra, introducendo l’esibizione di una danzatrice che asseconda il suono con giravolte, mimica facciale e movenze ben calibrate di braccia e piedi. Il montaggio alterna le evoluzioni della donna ai musicisti e allo sguardo rapito degli astanti in un crescendo ipnotico e sensuale, finché il plauso dell’audience culmina con il metter mano al portamonete da parte di un invitato per gratificare l’artista, gesto che il padrone di casa si accinge prontamente a interrompere bloccandogli il polso con l’impugnatura del bastone, poiché ‘chi ospita si riserva il diritto del primo dono’.
Il rimando non può essere che al momento clou di Jalsaghar (La sala di musica, 1958) di Satyajit Ray: il canto del cigno del possidente decaduto inteso come lezione di gusto per il vicino di casa banchiere rampante è una delle tre sequenze musicali che il regista bengalese decise di includere nel film per renderlo più fruibile al pubblico indiano, visto l’insuccesso al botteghino del precedente Aparajito[1]. Se anche il maestro che forte della lezione di Renoir e con un occhio al neorealismo italiano consacrò in patria l’autorialità si vide in un certo qual modo costretto a venire a patti con l’utenza su questo punto, ciò la dice lunga sulla centralità di musica e danza nel cinema e in generale nella cultura indiana.
Certo con il film di Ray – un omaggio alla musica colta in contrapposizione a quella popolare imperante, dove le tre sequenze hanno un ruolo imprescindibile nella struttura narrativa dando luogo al capo d’opera passato alla storia – siamo ben lontani dalla comune picturisation, vale a dire la messa in scena con canto e ballo che ha nei film mainstream di Bollywood[2] la sua apoteosi.
Elemento sintattico a beneficio di un pubblico di massa, la picturisation vanta tuttavia radici nobili, quale diretta discendente dell’antica rappresentazione artistica indiana (ricordiamo che samgita – il termine sanscrito per musica – include i concetti di canto, recitazione e danza), tramandata dal teatro al cinema muto e in seguito al parlato, figlia dello stretto rapporto fra vita quotidiana e tradizione musicale, rapporto spesso oggetto d’attenzione dal punto di vista antropologico, sociale, storico di molte produzioni indipendenti, che si rivelano un’utile chiave di lettura del sistema culturale nato sulle rive del Gange.
Fra questi rientra di buon grado UPAJ (= Improvvisare) dello statunitense Hoku Uchiyama[3], ospitato negli eventi speciali della 14° edizione del River to River Florence Film Festival (Firenze, 6-12 dicembre 2014), l’unica manifestazione italiana interamente dedicata al cinema indiano. Il documentario offre una particolare immersione nell’universo della danza Kathak in associazione al per noi più familiare Tip-tap, ricostruendo la creazione e seguendo il tour dell’ India Jazz Suites[4], uno spettacolo frutto della collaborazione fra il maturo guru del Kathak Pandit Chitresh Das e il giovane afro-americano Jason Samuels Smith, noto performer della Tap dance contemporanea.
La peculiarità del gioco dei piedi in entrambe le discipline, che grazie alle cavigliere ornate da oltre 100 sonagli (ghunghru) per l’una e i rinforzi metallici nelle scarpe (claquettes) per l’altra trasformano i ballerini in veri e propri percussionisti, non è il solo fattore che accomuna nella stessa esibizione due personaggi distanti per età, etnia, formazione, poiché forte traspare in entrambi il desiderio di preservare e tramandare le loro tradizioni artistiche.
Il Kathak è una danza classica[5] dell’India del Nord accompagnata dalla musica hindustani[6]. Nata come danza devozionale per narrare gesta della mitologia indù – il suo nome in sanscrito significa più o meno ‘raccontare una storia’ – fu in seguito arricchita da componenti persiane e musulmane con il suo ingresso nelle corti e ancora oggi mantiene aspetti religiosi e laici, fondendo spiritualità e sensualità. Oltre al movimento ritmico dei piedi (taktar) le sue caratteristiche sono l’espressione del viso, la lieve gestualità degli arti superiori, salti e piroette, come ben ci mostrano i superbi sette minuti di Jalsaghar citati all’inizio.
Per taluni derivato dalla Juba, danza rituale africana, e germinato fra il 1700 e inizio 1800 fra gli schiavi delle piantagioni, per altri importato in Usa dagli irlandesi e ispirato al ballo popolare Giga, è invece nei vicoli che il Tip-tap prese forma per poi arrivare alla massima diffusione a ritmo di Jazz[7] nella prima metà del secolo scorso e alla notorietà internazionale grazie a Hollywood. Sebbene col tempo abbia sviluppato movimenti codificati, è ampio lo spazio concesso all’improvvisazione, presente anche nel Kathak e che da il titolo al film in quanto elemento chiave dell’ India Jazz Suites, intesa come capacità di creare del nuovo pur restando ancorati alle proprie radici.
Secondo Pandit Chitresh Das ogni forma artistica per sopravvivere deve saper comunicare con la gente e a tal scopo è essenziale semplificare e rinnovare, poiché ‘è la tradizione che deve seguire l’arte e non il contrario’. Questa da sempre la politica del maestro di Calcutta – scomparso inaspettatamente a 70 anni il 4 gennaio 2015 – che dopo aver mosso i primi passi con i genitori insegnanti di danza si perfezionò alle scuole di Jaipur e di Lucknow[8] e fece della diffusione della sua disciplina una vera e propria missione, fondando a San Francisco la Chitresh Das Dance Company e portando le sue esibizioni in tutto il mondo.
L’incontro con il pluripremiato tapper freestyle newyorkese emulo di Savion Glover e Gregory Hines, altrettanto interessato a salvaguardare la propria arte, e l’idea condivisa di associare l’India antica e l’America contemporanea in uno spettacolo itinerante rientrano a pieno diritto in questa filosofia, risultando una carta vincente, a giudicare dall’impatto sulle platee dei più giovani, in particolare sui connazionali di Das.
Girato in alcune città Usa e soprattutto in India, il documentario monta specularmente le due esperienze umano-professionali, facendo emergere al di là dei singoli profili i tratti universali di ogni formazione artistica, a partire dalla rilevanza del passaggio di conoscenze (in entrambi è forte il ricordo nostalgico dei maestri di riferimento, la parte in cui il guru ormai celebre rievoca la morte del proprio insegnante visitando i luoghi del passato è fra le più coinvolgenti) e dedica l’attenzione dovuta ai duetti in palcoscenico.
Estrapolate da varie tappe del tour e sempre diverse l’una dall’altra, non solo le performance live sono eloquenti sull’amicizia, il rispetto, la competizione giocosa, l’abilità e l’impegno fisico dei due danzatori – per un pubblico occidentale il maggior fascino proviene giocoforza dal Kathak, con la sua complessità ritmica e l’aspetto recitativo/scenografico – ma soprattutto il regista Uchiyama riesce a restituirci due culture e due forme artistiche che si scrutano, confrontano, cercano un terreno comune di dialogo per apprendere l’una dall’altra, senza tuttavia arrivare ad alcun tipo di fusione, e per sperimentare di continuo, sotto la spinta dell’improvvisazione cara a entrambe, poiché l’improvvisazione è vita.
[1] titolo italiano L’invitto. Il film ottenne il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1957.
[2] filone principale dei film prodotti negli studios di Bombay (Mumbay); di natura estremamente popolare forma un genere a sé, con amori contrastati a immancabile lieto fine, di solito in ambientazione esotica, interpuntati da sequenze di canto e ballo che ne costituiscono la maggiore attrattiva.
[3] distintosi nel mondo del cortometraggio, ha al suo attivo anche regie pubblicitarie e videoclip musicali, dopo aver ottenuto ancora da studente il ‘Cannes Young Directors Award’. Upaj (Usa/India, 2013) è il suo primo documentario
[4] l’India Jazz Suites debuttò nel 2005 a San Francisco per poi girare il mondo in lungo e in largo (nel 2013 toccò oltre 40 città). Nel 2007 ottenne l’ ‘Isadora Duncan Award for best ensemble’.
[5] oltre al Kathak le danze classiche indiane sono: Bharathanatyam, Kathakali, Odissi, Kuchipudi e Manipuri
[6] la musica hindustani è tipica del Nord, mentre nel Sud dell’India si ha la musica karnatica
[7] in effetti prima di assumere la denominazione di Tap dance per due decenni si chiamò Jazz dance. In Italia prese invece il nome di Tip-tap.
[8] la terza scuola è quella di Banaras. Ogni scuola (Gharana) ha un proprio stile particolare
IL NUOVO CORSO DELLA MOSTRA DI PESARO
di Paolo Micalizzi
 Un anno importante il 2015 per la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che all’insegna di “50+1” ha voluto sottolineare come abbia compiuto 50 anni e riparte, con l’intento di essere profonda e innovativa, con la direzione artistica di Pedro Armocida (che per anni ne è stato l’organizzatore) che tende a legare il “nuovo cinema” alle forme più giovani ed innovative del linguaggio cinematografico contemporaneo. E lo ha fatto con una serie di iniziative tra cui significativo è stato l’Evento speciale, come sempre dedicato al cinema italiano, che quest’anno era intitolato “ Esordi italiani. Gli anni Dieci al cinema” in cui sono stati presentati venti opere prime, le più interessanti prodotte dal 2010 ad oggi.
Un anno importante il 2015 per la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che all’insegna di “50+1” ha voluto sottolineare come abbia compiuto 50 anni e riparte, con l’intento di essere profonda e innovativa, con la direzione artistica di Pedro Armocida (che per anni ne è stato l’organizzatore) che tende a legare il “nuovo cinema” alle forme più giovani ed innovative del linguaggio cinematografico contemporaneo. E lo ha fatto con una serie di iniziative tra cui significativo è stato l’Evento speciale, come sempre dedicato al cinema italiano, che quest’anno era intitolato “ Esordi italiani. Gli anni Dieci al cinema” in cui sono stati presentati venti opere prime, le più interessanti prodotte dal 2010 ad oggi.
.
 A completamento del programma un libro che costituisce un importante punto di riferimento per conoscere quest’aspetto del cinema italiano, in cui vengono fornite delle analisi e presentate interviste agli autori che ne sono protagonisti. Alcuni dei quali hanno preso parte ad una Tavola Rotonda per fare il punto sulle ultime tendenze del cinema italiano. Un incontro in cui alcuni autori hanno raccontato come è avvenuto il loro esordio, spesso coraggioso e affrontato da solo anche come produzione: tutti d’accordo però che occorre un investimento economico. Gianluca Arcopinto ,dal canto suo, si è dichiarato contrario alla logica produttiva secondo la quale i film debbono essere fatti comunque, senza budget e senza pagare le persone che ci lavorano. Ha, comunque, sottolineato che ha sostenuto film, girati ad ogni costo anche producendoseli e ciò perché è bene che quel tipo di cinema non debba sparire ma ritiene che non sia un modello da seguire. Ha poi sostenuto che “ un paese civile dovrebbe permettere ad alcuni registi di realizzare più film ed ha riferito che lui dal 1991 ad oggi ha fatto esordire 29 registi. Tra gli esordi, opere già apparse sugli schermi italiani, alla Mostra di Pesaro è stato presentato in anteprima “La nostra quarantena” di Peter Marcias. Un film incentrato sulla vicenda cagliaritana di quindici marinai marocchini entrati in sciopero per la difesa del posto di lavoro, persone che stavano vivendo una situazione assurda e drammatica, non ricevendo da tempo lo stipendio. Una vicenda che il regista ha preso come spunto per mettere in evidenza la situazione italiana dei giovani, scaturita da un’indagine approfondita che è diventata, come l’autore ha tenuto a sottolineare, sociologica e specchio del quadro italiano dei nostri tempi. Un film, tra documentario e fiction ben armonizzato. Un’altra Tavola rotonda ha riguardato Pier Paolo Pasolini, a dimostrazione che il suo pensiero è tuttora vivo, anche per la sua presenza cinquant’anni fa alla Mostra di Pesaro. Infatti, alla prima edizione. Pier Paolo Pasolini presentò nell’ambito di un Convegno sulla critica cinematografica una relazione, divenuta storica, su “Il cinema di poesia” che, come ha affermato Bruno Torri fondatore insieme a Lino Miccichè della Mostra di Pesaro, fu “un testo molto innovativo e creativo che rifletteva lo stato della ricerca teorica sul cinema e i suoi tentativi di rinnovamento”. Un “Cinema di poesia” ricordato nel Convegno dal titolo “Pasolini nostro contemporaneo e Pasolini pesarese” anche per sottolineare che egli scrisse molto articoli su Pesaro che definì “un luogo dello spirito”. Nel ricordare il magistero della sua vita, il filosofo Giacomo Marramao ha sottolineato l’attualità del pensiero di Pasolini intesa come un’aderenza al proprio tempo, mentre Roberto Chiesi( responsabile del Centro Studi Pasolini della Cineteca di Bologna) si è soffermato su l’elemento onirico che dopo l’intervento pesarese inizia a contaminare in maniera più marcata il suo cinema. Interessante, tra gli altri, l’intervento del cantautore Pierpaolo Capovilla, che alla Mostra ha anche tenuto un reading su “La religione del mio tempo”, che ha evidenziato il Pasolini poeta e il Pasolini resistente chiedendosi cosa avrebbe pensato dell’Italia d’oggi, considerato che nell’ultima intervista rilasciata a Furio Colombo diceva che gli italiani erano diventati macchine che cozzano l’una contro l’altra. Circa la poesia di Pasolini, secondo lui il poeta la considerava come “la narrazione della verità, quella verità che non vogliamo vedere e che invece Pasolini raccontò con rabbia e amore immenso”. Ed è per questo, ha sostenuto, che la poesia è cosi invisa al potere. Il Concorso “Pesaro Nuovo Cinema- Premio Lino Miccichè” ha visto vincitore “Un jeune poète” di Damien Manivel con protagonista un ragazzo più che adolescente che sogna di diventare poeta e incantare il mondo con versi indimenticabili. Va in cerca d’ispirazione armato di penna e taccuino, ed in attesa di decidere da dove incominciare non fa altro che bere. La Giuria( composta da diciassette studenti provenienti dalle università e dalle scuole di cinema italiane) lo ha premiato “ per la sua eleganza espressiva, la ricerca di un’essenzialità delle forme; ma anche per una specifica cifra autoriale, che guarda consapevole al cinema del passato sfociando in un linguaggio narrativo e visivo originale che racchiude in sé la forza della poesia e dell’arte, un confronto stimolante tra ambienti e personaggi ed un’efficace stilizzazione del reale”. La Giuria ha inoltre deciso di assegnare una Menzione speciale all’interpretazione dell’intero cast del film “La madre del Cordero” dei cileni Enrique Farias & Rosario Espinosa “per la sua essenzialità ed intensità, per un’amichevole e costante ricerca della verità e per la sua forza emotiva”. Il film ruota su Cristina, quarantanovenne vedova e malata, che per tutta la vita si è presa cura della madre, rimanendo single, senza lavoro e senza amici. Quando incontra Sandra, un’amica dei tempi della scuola che è tornata al paese per il funerale del padre e che vive in maniera libera, entra in crisi mettendo in discussione il proprio modo di vivere. Menzione speciale alla sperimentazione linguistica a “Terra” di Marco De Angelis & Antonio Di Trapani “per la sua natura innovativa, la sua complessa mappatura simbolica e per la sua scrittura visiva che trascina lo spettatore dentro ed oltre le immagini”. Attraverso la mescolanza di immagini documentarie, materiali d’archivio e foto d’epoca, il film ci porta in un mondo dalle molteplici suggestioni visive che fa riflettere sulla sorte del nostro pianeta, la cui speranza d salvezza è affidata ad un’intelligenza extraterrestre. Il pubblico, invece, che ha seguito la proiezione dei film in “piazza” ha dato invece la sua preferenza a “Petting zoo” della regista americana Micah Magee con protagonista una diciassettenne , la cui gravidanza inaspettata la porta a cambiare le scelte di vita.
A completamento del programma un libro che costituisce un importante punto di riferimento per conoscere quest’aspetto del cinema italiano, in cui vengono fornite delle analisi e presentate interviste agli autori che ne sono protagonisti. Alcuni dei quali hanno preso parte ad una Tavola Rotonda per fare il punto sulle ultime tendenze del cinema italiano. Un incontro in cui alcuni autori hanno raccontato come è avvenuto il loro esordio, spesso coraggioso e affrontato da solo anche come produzione: tutti d’accordo però che occorre un investimento economico. Gianluca Arcopinto ,dal canto suo, si è dichiarato contrario alla logica produttiva secondo la quale i film debbono essere fatti comunque, senza budget e senza pagare le persone che ci lavorano. Ha, comunque, sottolineato che ha sostenuto film, girati ad ogni costo anche producendoseli e ciò perché è bene che quel tipo di cinema non debba sparire ma ritiene che non sia un modello da seguire. Ha poi sostenuto che “ un paese civile dovrebbe permettere ad alcuni registi di realizzare più film ed ha riferito che lui dal 1991 ad oggi ha fatto esordire 29 registi. Tra gli esordi, opere già apparse sugli schermi italiani, alla Mostra di Pesaro è stato presentato in anteprima “La nostra quarantena” di Peter Marcias. Un film incentrato sulla vicenda cagliaritana di quindici marinai marocchini entrati in sciopero per la difesa del posto di lavoro, persone che stavano vivendo una situazione assurda e drammatica, non ricevendo da tempo lo stipendio. Una vicenda che il regista ha preso come spunto per mettere in evidenza la situazione italiana dei giovani, scaturita da un’indagine approfondita che è diventata, come l’autore ha tenuto a sottolineare, sociologica e specchio del quadro italiano dei nostri tempi. Un film, tra documentario e fiction ben armonizzato. Un’altra Tavola rotonda ha riguardato Pier Paolo Pasolini, a dimostrazione che il suo pensiero è tuttora vivo, anche per la sua presenza cinquant’anni fa alla Mostra di Pesaro. Infatti, alla prima edizione. Pier Paolo Pasolini presentò nell’ambito di un Convegno sulla critica cinematografica una relazione, divenuta storica, su “Il cinema di poesia” che, come ha affermato Bruno Torri fondatore insieme a Lino Miccichè della Mostra di Pesaro, fu “un testo molto innovativo e creativo che rifletteva lo stato della ricerca teorica sul cinema e i suoi tentativi di rinnovamento”. Un “Cinema di poesia” ricordato nel Convegno dal titolo “Pasolini nostro contemporaneo e Pasolini pesarese” anche per sottolineare che egli scrisse molto articoli su Pesaro che definì “un luogo dello spirito”. Nel ricordare il magistero della sua vita, il filosofo Giacomo Marramao ha sottolineato l’attualità del pensiero di Pasolini intesa come un’aderenza al proprio tempo, mentre Roberto Chiesi( responsabile del Centro Studi Pasolini della Cineteca di Bologna) si è soffermato su l’elemento onirico che dopo l’intervento pesarese inizia a contaminare in maniera più marcata il suo cinema. Interessante, tra gli altri, l’intervento del cantautore Pierpaolo Capovilla, che alla Mostra ha anche tenuto un reading su “La religione del mio tempo”, che ha evidenziato il Pasolini poeta e il Pasolini resistente chiedendosi cosa avrebbe pensato dell’Italia d’oggi, considerato che nell’ultima intervista rilasciata a Furio Colombo diceva che gli italiani erano diventati macchine che cozzano l’una contro l’altra. Circa la poesia di Pasolini, secondo lui il poeta la considerava come “la narrazione della verità, quella verità che non vogliamo vedere e che invece Pasolini raccontò con rabbia e amore immenso”. Ed è per questo, ha sostenuto, che la poesia è cosi invisa al potere. Il Concorso “Pesaro Nuovo Cinema- Premio Lino Miccichè” ha visto vincitore “Un jeune poète” di Damien Manivel con protagonista un ragazzo più che adolescente che sogna di diventare poeta e incantare il mondo con versi indimenticabili. Va in cerca d’ispirazione armato di penna e taccuino, ed in attesa di decidere da dove incominciare non fa altro che bere. La Giuria( composta da diciassette studenti provenienti dalle università e dalle scuole di cinema italiane) lo ha premiato “ per la sua eleganza espressiva, la ricerca di un’essenzialità delle forme; ma anche per una specifica cifra autoriale, che guarda consapevole al cinema del passato sfociando in un linguaggio narrativo e visivo originale che racchiude in sé la forza della poesia e dell’arte, un confronto stimolante tra ambienti e personaggi ed un’efficace stilizzazione del reale”. La Giuria ha inoltre deciso di assegnare una Menzione speciale all’interpretazione dell’intero cast del film “La madre del Cordero” dei cileni Enrique Farias & Rosario Espinosa “per la sua essenzialità ed intensità, per un’amichevole e costante ricerca della verità e per la sua forza emotiva”. Il film ruota su Cristina, quarantanovenne vedova e malata, che per tutta la vita si è presa cura della madre, rimanendo single, senza lavoro e senza amici. Quando incontra Sandra, un’amica dei tempi della scuola che è tornata al paese per il funerale del padre e che vive in maniera libera, entra in crisi mettendo in discussione il proprio modo di vivere. Menzione speciale alla sperimentazione linguistica a “Terra” di Marco De Angelis & Antonio Di Trapani “per la sua natura innovativa, la sua complessa mappatura simbolica e per la sua scrittura visiva che trascina lo spettatore dentro ed oltre le immagini”. Attraverso la mescolanza di immagini documentarie, materiali d’archivio e foto d’epoca, il film ci porta in un mondo dalle molteplici suggestioni visive che fa riflettere sulla sorte del nostro pianeta, la cui speranza d salvezza è affidata ad un’intelligenza extraterrestre. Il pubblico, invece, che ha seguito la proiezione dei film in “piazza” ha dato invece la sua preferenza a “Petting zoo” della regista americana Micah Magee con protagonista una diciassettenne , la cui gravidanza inaspettata la porta a cambiare le scelte di vita.
Eventi interessanti della Mostra, un Omaggio a Gianni Amico, una rassegna di “Sguardi femminili russi” all’insegna degli esordi, una sezione dedicata all’animazione, la proiezione del film “La dolce Siria” dove la guerra è vista attraverso gli occhi dei bambini, una rassegna sul regista turco Tayfun Pirselimoglu e la consegna del “ Premio Pesaro Nuovo Cinema” al libro di Stefania Parigi “Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra”. E, inoltre, una Mostra dal titolo “Lino Miccichè. Immagini e parole” realizzata a 10 anni della sua scomparsa ripercorre la storia di un grande intellettuale che è stato uno dei critici, studiosi e organizzatori culturali più importanti degli ultimi cinquant’anni. Vedere i documenti esposti ha significato per chi scrive rivivere momenti importanti della vita cinematografica italiana.
.
.
BIOGRAFIE E STORIE DI VITA AL BIOGRAFILM FESTIVAL DI BOLOGNA
di Paolo Micalizzi
 “El boton de Nacar” (Il bottone di madreperla) del cileno Patricio Guzman è stato considerato, da una Giuria Internazionale presieduta dal regista Silvio Soldini, il miglior film( premiato come Best Film Unipol Award) del Biografilm Festival 2015. “Un film, per la giuria( che era composta anche da Angela Baraldi, Elena Fortes e Gloria Giorgianni) di grande impatto visivo e di profonda riflessione sulla vita, sul passato e sulla memoria attraverso un linguaggio che riesce a coniugare poesia e scienza con una forte denuncia storico-politica. Un film che ci guida alla ricerca del nostro posto nell’universo”. Partendo dal ritrovamento di un bottone di madreperla incrostato nella ruggine di una rotaia in fondo al mare, il film racconta la storia del centro di detenzione Villa Grimalda a Santiago, sotto la dittatura di Pinochet. Una storia che il regista accomuna, attraverso il tintinnio delle cascate, a quella della popolazione dei Selknams, popolazione nativa sudamericana trucidata dai colonizzatori. Due massacri che hanno come chiave narrativa la memoria dell’acqua. Il Biografilm Festival ha reso omaggio al cinema di Patricio Guzman con altre storie del suo Paese da lui raccontate. Tra esse “Nostalgia de la luz” (2010) dove , attraverso la storia di astronomi e archeologi che studiano l’origine dell’uomo e quella di parenti dei desaparecidos che nel deserto sperano di ritrovare i frammenti dei loro cari, ricostruisce vicende drammatiche della dittatura cilena per invitare a non dimenticare ciò che è accaduto e mantenere viva la memoria civile cilena. Seguiamo le orme del suo cinema in “Filmer obstinèment, rencontre avec Patricio Guzman” di Boris Nicot: i film più importanti, le idee, i principi che guidano il suo lavoro, le tappe cruciali di una vita che ha conosciuto l’esilio e la prigione. Un cinema, quello del regista cileno, che insegue al contempo l’accuratezza del linguaggio cinematografico e la verità politica. Il suo è, infatti, un viaggio che parte dalla presa di potere di Pinochet e arriva ai giorni nostri. Premiato con il Life Tales Award “per il travolgente racconto biografico” il film di Chad Gracia “The Russian woodpecker” incentrato su un artista ucraino, Fedor Alexandrovic, che aveva quattro anni quando avvenne il disastro di Chernobyl. Scegliendo oggi di indagare su quella catastrofe scopre che nei pressi della centrale nucleare i sovietici avevano costruito la Duga, una gigantesca e misteriosa antenna che produce il rumore di un picchio e doveva servire a interferire con le comunicazioni occidentali, disturbarle e infiltrarvi la propaganda filo-sovietica. Un’antenna che, secondo l’autore, potrebbe non essere estranea allo scoppio del reattore. Fedor dovrà scegliere se rivelare questa verità pericolosa o non farlo per proteggere se stesso e la sua famiglia. La giuria lo ha premiato con la seguente motivazione:” La vita, l’arte, l’attivismo politico in un film fuori dagli schemi, che attraverso un personaggio creativo e visionario si domanda i perché di una tragedia come quella di Chernobyl”. Menzione speciale al film “A Syrian love story” di Sean MacAllister “per il coraggio e la tenacia di raccontare, con un linguaggio diretto e senza filtri, una storia d’amore e di guerra portandoci dentro la quotidianità di una famiglia stravolta dall’idealismo e dalla violenza”. Protagonisti sono due prigionieri, Amer e Raghda, incarcerati in Siria per aver partecipato alle proteste contro il Governo, che s‘innamorano guardandosi attraverso il buco nel muro. Una volta liberati i due si sposano, ma con l’arrivo della primavera araba lei viene di nuovo arrestata. Un film che racconta il dramma di una donna divisa tra l’amore per il marito e i figli e l’impegno per la libertà del suo Paese. Premi anche al cinema italiano con il “Biografilm Italia”, la cui Giuria era presieduta da Antonietta De Lillo e composta da Michele Fornasero e Enrico Salvatore. Miglior film, ”Napolislam” di Ernesto Pagano con protagonisti dei napoletani convertiti all’Islam. Persone diverse, dichiara l’autore, che hanno trovato nel Corano una risposta all’ingiustizia sociale, al consumismo sfrenato al blackout della speranza. Un sistema di regole che viene da una cultura lontana. Come conciliarla con la propria getta una luce nuova, divertita e amara, sulla nostra società. Per la giuria, “un film necessario, un affresco di un’Italia islamica nella cattolica Napoli di oggi, negli anni della islamofobia. Una regia che con bravura e naturalezza mette assieme tante storie in un unico racconto”. Menzioni speciali per “L’equilibrio dell’orecchino” di Adriano Sforzi e per “Samsara Diary” di Ramchandra Pace che ne ha ottenuta un’altra dal “Premio Hera. Nuovi talenti” perché” pone lo sguardo su una storia intima e personale di un padre e un figlio che si rispettano profondamente e che ci consentono di esplorare le nostre stesse relazioni familiari”. Otto i Premi del pubblico: tra essi quello attribuito a “El boton de nacar” di Patricio Guznam.
“El boton de Nacar” (Il bottone di madreperla) del cileno Patricio Guzman è stato considerato, da una Giuria Internazionale presieduta dal regista Silvio Soldini, il miglior film( premiato come Best Film Unipol Award) del Biografilm Festival 2015. “Un film, per la giuria( che era composta anche da Angela Baraldi, Elena Fortes e Gloria Giorgianni) di grande impatto visivo e di profonda riflessione sulla vita, sul passato e sulla memoria attraverso un linguaggio che riesce a coniugare poesia e scienza con una forte denuncia storico-politica. Un film che ci guida alla ricerca del nostro posto nell’universo”. Partendo dal ritrovamento di un bottone di madreperla incrostato nella ruggine di una rotaia in fondo al mare, il film racconta la storia del centro di detenzione Villa Grimalda a Santiago, sotto la dittatura di Pinochet. Una storia che il regista accomuna, attraverso il tintinnio delle cascate, a quella della popolazione dei Selknams, popolazione nativa sudamericana trucidata dai colonizzatori. Due massacri che hanno come chiave narrativa la memoria dell’acqua. Il Biografilm Festival ha reso omaggio al cinema di Patricio Guzman con altre storie del suo Paese da lui raccontate. Tra esse “Nostalgia de la luz” (2010) dove , attraverso la storia di astronomi e archeologi che studiano l’origine dell’uomo e quella di parenti dei desaparecidos che nel deserto sperano di ritrovare i frammenti dei loro cari, ricostruisce vicende drammatiche della dittatura cilena per invitare a non dimenticare ciò che è accaduto e mantenere viva la memoria civile cilena. Seguiamo le orme del suo cinema in “Filmer obstinèment, rencontre avec Patricio Guzman” di Boris Nicot: i film più importanti, le idee, i principi che guidano il suo lavoro, le tappe cruciali di una vita che ha conosciuto l’esilio e la prigione. Un cinema, quello del regista cileno, che insegue al contempo l’accuratezza del linguaggio cinematografico e la verità politica. Il suo è, infatti, un viaggio che parte dalla presa di potere di Pinochet e arriva ai giorni nostri. Premiato con il Life Tales Award “per il travolgente racconto biografico” il film di Chad Gracia “The Russian woodpecker” incentrato su un artista ucraino, Fedor Alexandrovic, che aveva quattro anni quando avvenne il disastro di Chernobyl. Scegliendo oggi di indagare su quella catastrofe scopre che nei pressi della centrale nucleare i sovietici avevano costruito la Duga, una gigantesca e misteriosa antenna che produce il rumore di un picchio e doveva servire a interferire con le comunicazioni occidentali, disturbarle e infiltrarvi la propaganda filo-sovietica. Un’antenna che, secondo l’autore, potrebbe non essere estranea allo scoppio del reattore. Fedor dovrà scegliere se rivelare questa verità pericolosa o non farlo per proteggere se stesso e la sua famiglia. La giuria lo ha premiato con la seguente motivazione:” La vita, l’arte, l’attivismo politico in un film fuori dagli schemi, che attraverso un personaggio creativo e visionario si domanda i perché di una tragedia come quella di Chernobyl”. Menzione speciale al film “A Syrian love story” di Sean MacAllister “per il coraggio e la tenacia di raccontare, con un linguaggio diretto e senza filtri, una storia d’amore e di guerra portandoci dentro la quotidianità di una famiglia stravolta dall’idealismo e dalla violenza”. Protagonisti sono due prigionieri, Amer e Raghda, incarcerati in Siria per aver partecipato alle proteste contro il Governo, che s‘innamorano guardandosi attraverso il buco nel muro. Una volta liberati i due si sposano, ma con l’arrivo della primavera araba lei viene di nuovo arrestata. Un film che racconta il dramma di una donna divisa tra l’amore per il marito e i figli e l’impegno per la libertà del suo Paese. Premi anche al cinema italiano con il “Biografilm Italia”, la cui Giuria era presieduta da Antonietta De Lillo e composta da Michele Fornasero e Enrico Salvatore. Miglior film, ”Napolislam” di Ernesto Pagano con protagonisti dei napoletani convertiti all’Islam. Persone diverse, dichiara l’autore, che hanno trovato nel Corano una risposta all’ingiustizia sociale, al consumismo sfrenato al blackout della speranza. Un sistema di regole che viene da una cultura lontana. Come conciliarla con la propria getta una luce nuova, divertita e amara, sulla nostra società. Per la giuria, “un film necessario, un affresco di un’Italia islamica nella cattolica Napoli di oggi, negli anni della islamofobia. Una regia che con bravura e naturalezza mette assieme tante storie in un unico racconto”. Menzioni speciali per “L’equilibrio dell’orecchino” di Adriano Sforzi e per “Samsara Diary” di Ramchandra Pace che ne ha ottenuta un’altra dal “Premio Hera. Nuovi talenti” perché” pone lo sguardo su una storia intima e personale di un padre e un figlio che si rispettano profondamente e che ci consentono di esplorare le nostre stesse relazioni familiari”. Otto i Premi del pubblico: tra essi quello attribuito a “El boton de nacar” di Patricio Guznam.
Biografie e storie di vita quindi al Biografilm Festival di Bologna( 5-15 giugno 2015), giunto all’undicesima edizione, grazie alla passione e capacità del Direttore artistico Andrea Romeo. Un programma densissimo con ben 755 anteprime, delle quali 22 mondiali, che ha immerso lo spettatore (in totale oltre 16.000 presenze per tutto il Festival) in una varietà di proposte che hanno soprattutto il documentario come punto di forza. Un Festival inaugurato con l’anteprima ( dopo Cannes) italiana( in Gala d’inaugurazione) del film “Steve McQueen: The man &Le mans” di Gabriel Clarke e John McKenna che, attraverso il racconto del figlio dell’attore, ricostruisce un appassionato ritratto del padre e del suo amore per le corse motociclistiche e automobilistiche, ed ha avuto come apertura ufficiale un’altra anteprima italiana proveniente dal Festival francese: la proiezione di “Amy The girl behind the name” di Asif Kapadian, una drammatica ricostruzione della vita di Amy Winehouse morta a soli 27 anni per abuso di stupefacenti e alcol. E che si è concluso con l’anteprima europea dell’atteso “Going clear:Scientology e la prigione della fede” di Alex Gibney che investiga sulla Setta e sulla figura del suo fondatore, sulle vite degli adepti fra cui celebrità hollywoodiane come Tom Cruise. Passando per tante opere di particolare interesse, tra cui, in anteprima mondiale, “Jannacci. Lo stradone col bagliore” di Ranuccio Sodi, omaggio in musica, parole e immagini a Milano e all’arte di un uomo per cui comporre e fare spettacolo è stato anche un modo di stare al mondo: ironico, dignitoso,brillante e discreto. Tra le opere viste, singolare è la figura di Iris Apfel in “Iris” di Albert Mayles, una stilista americana che ha fatto della sua eccentricità uno stile di vita. Un personaggio che ha cambiato il design della Casa Bianca per ben nove Presidenti, da Truman a Clinton, che a 93 anni continua la sua passione per il lavoro e gli esperimenti di stile. Interessante anche “The Troublemaker” di Roberto Salinas,incentrato sulla figura del prete Miguel d’Escoto Brokman, sospeso a divinis da Papa Giovanni Paolo II per il suo appoggio al Fronte Sandinista in Nicaragua. Un uomo, che è stato nel 2008 controverso Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso la cui testimonianza resa al regista ci fa scoprire l’ONU ed il suo funzionamento con le complesse correnti che uniscono e dividono gli Stati membri.
Omaggio al Biografilm Festival anche al regista italiano Matteo Garrone, che ha ricevuto il “Celebration of lives Awards 2015”, con una Retrospettiva comprendente i suoi primi lavori documentaristici fino ad arrivare al recente lungometraggio “Il racconto dei racconti” che ha confermato il valore autoriale del suo cinema. Un omaggio che ha riportato alla luce opere come “Terra di mezzo”(1997), “Oreste Pipolo fotografo di matrimoni”(1998), “Ospiti”(1998) e “Estate romana”(2000). Uno sguardo sulla realtà che Matteo Garrone coniuga con la capacità di costruirne un racconto. Un omaggio anche alla regista napoletana Antonietta De Lillo che ha festeggiato trent’anni di cinema. E della quale il “Biografilm Festival” ha presentato alcuni dei suoi ritratti. Da “Promessi sposi”(1993) a “Let’s Go” del 2014 che racconta l’odissea di un uomo, Luca Musetta, che da fotografo di un certo successo in seguito alla crisi è stato costretto a perdere lavoro, negozio, famiglia e casa e oggi vaga per le strade di Milano campando di lavoretti. Passando per ”Racconti di Vittoria”(1996),un capolavoro incentrato su tre episodi che ha per filo conduttore il dolore e la morte visto dalle prospettive teatrale, letteraria e televisiva. Il film, che meriterebbe di essere spesso riproposto, ha ricevuto al 52° Festival di Venezia una Menzione particolare Fedic. Di Antonietta De Lillo anche la trilogia sul cinema con gli interessanti ritratti di Tonino Guerra, Lucio Fulci e il fotografo di scena Angelo Novi e “’O sole mio”(1998) film, che attraverso la celebre canzone del 1898 di Eduardo Di Capua su versi del giornalista Giovanni Capurro, racconta i due volti di Napoli, quello paradisiaco, luminoso delle cartoline e quello oscuro, misterioso dei vicoli. Un cinema indipendente, quello di Antonietta De Lillo, che la impone tra i filmmaker più prestigiosi del panorama italiano.
.
.
DEDICATO A GIAN MARIA VOLONTÈ IL CAMAIORE FILM FESTIVAL 2015
di Paolo Micalizzi
 Ha celebrato Gian Maria Volonté la 2^ edizione del Camaiore Film Festival (10-14 giugno 2015). Lo ha fatto con la proiezione di un film di cui è stato prestigioso ed intenso interprete( “Giordano Bruno” di Giuliano Montaldo) e con una Tavola Rotonda in cui è stato presentato il documentario di Ferruccio Marotti “Un attore contro: Gian Maria Volonté“. E’ stato lo stesso Marotti a presentarlo ricordandolo come uno dei maggiori attori de mondo, simbolo di una stagione felice del nostro cinema, quella che ha legato l’arte all’impegno. Un personaggio scontroso, lontano dal mondo dello show businnes. Uomo che ha influenzato profondamente la sua generazione come emerge dalle testimonianze di persone che hanno lavorato con lui. La singolare e complessa personalità di Gian Maria Volonté è emersa poi dagli interventi di Steve Della Casa (coordinatore della Tavola Rotonda), Caterina Taricano che ha sottolineato soprattutto il rapporto di Volonté con il regista Giuliano Montaldo, Riccardo Rossi che ha ricordato una sua esperienza con Volonté, ed anche di chi scrive che ha ricordato il giudizio di Francesco Rosi( che lo ha avuto interprete di ben 5 film): Gian Maria Volontè è un attore unico. Per tempi, sguardi, intensità” e affermato che ritiene Volonté un attore che esprimeva con gli occhi e il volto l’intensità con cui diceva le cose che pensava. In omaggio all’attore anche l’esposizione di tavole della graphic novel “Gian Maria Volontè” disegnata da Paolo Castaldi e pubblicata da “Becco Giallo”. Al Camaiore Film festival, organizzato dal Baita Film Group e la collaborazione di Corte Tripoli Cinematografica, con la direzione artistica di Roberto Merlino e la fattiva organizzazione di Joel De Petris, 24 i cortometraggi internazionali in Concorso. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior film( Ulivo d’argento, manufatto in ferro battuto dell’artista Michelangelo Bianchi, e 500 euro) lo spagnolo “Mi ojo deperecho” (Bello di nonna) di Josecho de Linares, opera in cui un uomo riflette sul suo affettuoso rapporto con la nonna.
Ha celebrato Gian Maria Volonté la 2^ edizione del Camaiore Film Festival (10-14 giugno 2015). Lo ha fatto con la proiezione di un film di cui è stato prestigioso ed intenso interprete( “Giordano Bruno” di Giuliano Montaldo) e con una Tavola Rotonda in cui è stato presentato il documentario di Ferruccio Marotti “Un attore contro: Gian Maria Volonté“. E’ stato lo stesso Marotti a presentarlo ricordandolo come uno dei maggiori attori de mondo, simbolo di una stagione felice del nostro cinema, quella che ha legato l’arte all’impegno. Un personaggio scontroso, lontano dal mondo dello show businnes. Uomo che ha influenzato profondamente la sua generazione come emerge dalle testimonianze di persone che hanno lavorato con lui. La singolare e complessa personalità di Gian Maria Volonté è emersa poi dagli interventi di Steve Della Casa (coordinatore della Tavola Rotonda), Caterina Taricano che ha sottolineato soprattutto il rapporto di Volonté con il regista Giuliano Montaldo, Riccardo Rossi che ha ricordato una sua esperienza con Volonté, ed anche di chi scrive che ha ricordato il giudizio di Francesco Rosi( che lo ha avuto interprete di ben 5 film): Gian Maria Volontè è un attore unico. Per tempi, sguardi, intensità” e affermato che ritiene Volonté un attore che esprimeva con gli occhi e il volto l’intensità con cui diceva le cose che pensava. In omaggio all’attore anche l’esposizione di tavole della graphic novel “Gian Maria Volontè” disegnata da Paolo Castaldi e pubblicata da “Becco Giallo”. Al Camaiore Film festival, organizzato dal Baita Film Group e la collaborazione di Corte Tripoli Cinematografica, con la direzione artistica di Roberto Merlino e la fattiva organizzazione di Joel De Petris, 24 i cortometraggi internazionali in Concorso. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior film( Ulivo d’argento, manufatto in ferro battuto dell’artista Michelangelo Bianchi, e 500 euro) lo spagnolo “Mi ojo deperecho” (Bello di nonna) di Josecho de Linares, opera in cui un uomo riflette sul suo affettuoso rapporto con la nonna.
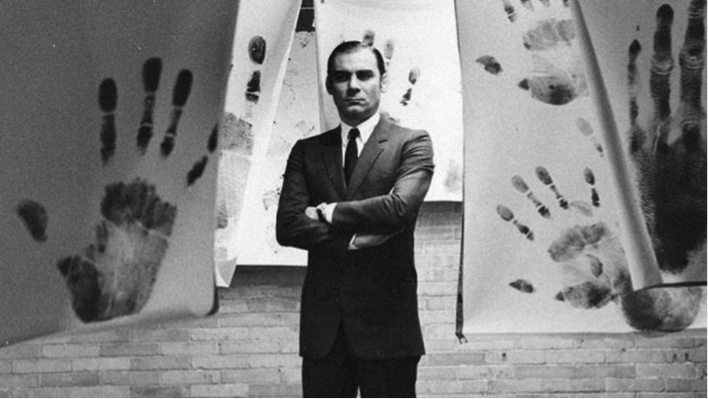 E’ stato premiato “per la delicatezza e la sensibilità con cui viene affrontato il tema del tempo che tutto consuma e perturba”. Miglior documentario “I’ M Festival” di Alessio Persiano e Mario Vezza incentrato su un gruppo di clown che porta allegria e felicità in un paese turco in guerra, facendo sognare ad un ragazzo di poter fuggire da quella realtà. Una storia ,tra sogno e realtà, in un cortometraggio che è stato premiato “per la grande capacità di aver raccontato una storia che potrebbe essere quella di molti”. Premio alla migliore animazione a “Mute” degli olandesi Job Joris & Marieke che raccontano, con una grafica raffinatissima, una storia surreale dai toni horror. Premio anche per i Videoclip, altra sezione del Festival. Ha vinto “Desperados” di Mirko Vigliotti e Giancarlo D. Vasta, incentrato su una rapina in banca finita male, che è raccontato con ritmo incalzante e con l’utilizzo di un’accurata scenografia. Protagonisti, gli Ushas, una rock band romana. La giuria popolare ha premiato “Chi fa Otello?” di David Fratini, ironica e dissacrante critica ad un modello di società ancora troppo razzista e classista. Per la migliore regia il premio è stato attribuito a “Preto ou branco”( Nero o bianco) del brasiliano Alison Zago, opera sul terrorismo fotografata in un suggestivo bianco e nero che richiama il noir anni 50. Nel Palmares del Festival anche il “Premio Scuola” che è stato attribuito a “Cipi” di Sally Galotti e Franco Pieri, e il premio pari opportunità Elvira notari a “ Punto di vista” di Matteo Petrella. Miglior fotografia a “Teatro” dello spagnolo Ivan Ruiz Flores, miglior sceneggiatura ad “Have Sweet Dreams “ di Ciprian Juhar e miglior montaggio e colonna sonora allo spassoso “In passing” di Alan Miller.
E’ stato premiato “per la delicatezza e la sensibilità con cui viene affrontato il tema del tempo che tutto consuma e perturba”. Miglior documentario “I’ M Festival” di Alessio Persiano e Mario Vezza incentrato su un gruppo di clown che porta allegria e felicità in un paese turco in guerra, facendo sognare ad un ragazzo di poter fuggire da quella realtà. Una storia ,tra sogno e realtà, in un cortometraggio che è stato premiato “per la grande capacità di aver raccontato una storia che potrebbe essere quella di molti”. Premio alla migliore animazione a “Mute” degli olandesi Job Joris & Marieke che raccontano, con una grafica raffinatissima, una storia surreale dai toni horror. Premio anche per i Videoclip, altra sezione del Festival. Ha vinto “Desperados” di Mirko Vigliotti e Giancarlo D. Vasta, incentrato su una rapina in banca finita male, che è raccontato con ritmo incalzante e con l’utilizzo di un’accurata scenografia. Protagonisti, gli Ushas, una rock band romana. La giuria popolare ha premiato “Chi fa Otello?” di David Fratini, ironica e dissacrante critica ad un modello di società ancora troppo razzista e classista. Per la migliore regia il premio è stato attribuito a “Preto ou branco”( Nero o bianco) del brasiliano Alison Zago, opera sul terrorismo fotografata in un suggestivo bianco e nero che richiama il noir anni 50. Nel Palmares del Festival anche il “Premio Scuola” che è stato attribuito a “Cipi” di Sally Galotti e Franco Pieri, e il premio pari opportunità Elvira notari a “ Punto di vista” di Matteo Petrella. Miglior fotografia a “Teatro” dello spagnolo Ivan Ruiz Flores, miglior sceneggiatura ad “Have Sweet Dreams “ di Ciprian Juhar e miglior montaggio e colonna sonora allo spassoso “In passing” di Alan Miller.
Un Festival , quello di Camaiore, appena alla seconda edizione, che rivela una grande passione per il cinema da parte degli organizzatori e una grande volontà di meglio inserirsi nel panorama del cinema corto.
.
UN QUALIFICATO E SIMPATICO FESTIVAL NEL PAESE DI DON CAMILLO
di Paolo Micalizzi
 A cinquant’anni della prima uscita nelle sale (18 settembre 1965) del film “Il compagno Don Camillo” di Luigi Comencini, il film è stato proiettato nella Piazza di Brescello dove campeggia la statua in bronzo del celebre prete, a conclusione della XIII edizione del “BrescelloFilmFestival”. Un omaggio importante ad un personaggio, nato dalla prolifica penna di Giovannino Guareschi, che negli anni 50, soprattutto, ha conquistato il pubblico italiano, e non solo, e tuttora lo attrae nelle varie proiezioni televisive che ripropongono la celebre saga. E nel nome dello scrittore il Festival si era inaugurato. In un incontro con i giornalisti Fulvio Fulvi e Dino Frambati si è parlato di “Guareschi e Laureni: segni dal Lager- Testimonianze di due internati militari” sul cui tema è stata allestita una Mostra, a cura di Anna Krekic e Francesco Fait. “Il Cinema Dimenticato nella Provincia di Reggio Emilia” a cura di Marco Incerti Zambelli che, nell’ambito del Festival, ha condotto alcuni incontri su “Il cinema raccontato”. Ospiti alcuni autori: Roberto Campari che ha presentato il suo libro “L’amicizia virile in Occidente da Omero al cinema”, Steve Della Casa, uno degli autori di “I 100 colpi di Hollywod Party”, Paolo Micalizzi che ha scritto il libro “Là dove scende il fiume. Il Po e il cinema”.
A cinquant’anni della prima uscita nelle sale (18 settembre 1965) del film “Il compagno Don Camillo” di Luigi Comencini, il film è stato proiettato nella Piazza di Brescello dove campeggia la statua in bronzo del celebre prete, a conclusione della XIII edizione del “BrescelloFilmFestival”. Un omaggio importante ad un personaggio, nato dalla prolifica penna di Giovannino Guareschi, che negli anni 50, soprattutto, ha conquistato il pubblico italiano, e non solo, e tuttora lo attrae nelle varie proiezioni televisive che ripropongono la celebre saga. E nel nome dello scrittore il Festival si era inaugurato. In un incontro con i giornalisti Fulvio Fulvi e Dino Frambati si è parlato di “Guareschi e Laureni: segni dal Lager- Testimonianze di due internati militari” sul cui tema è stata allestita una Mostra, a cura di Anna Krekic e Francesco Fait. “Il Cinema Dimenticato nella Provincia di Reggio Emilia” a cura di Marco Incerti Zambelli che, nell’ambito del Festival, ha condotto alcuni incontri su “Il cinema raccontato”. Ospiti alcuni autori: Roberto Campari che ha presentato il suo libro “L’amicizia virile in Occidente da Omero al cinema”, Steve Della Casa, uno degli autori di “I 100 colpi di Hollywod Party”, Paolo Micalizzi che ha scritto il libro “Là dove scende il fiume. Il Po e il cinema”.
Omaggi all’attrice Valentina Cervi, intervistata da Steve Della Casa, ed a Francesco Munzi di cui è stato proiettato il film “Anime nere”, opera premiatissima in alcuni importanti Festival che per questo motivo non ha potuto essere presente a Brescello.

Domenico Criaco (autore del libro Anime Nere da cui è stato tratto il film) intervistato da Marco Incerti Zambelli
C’era invece l’autore del libro Domenico Criaco con il quale si è svolta un’interessante conversazione relativa alla realizzazione del film. Altre le iniziative che hanno vitalizzato il Festival. Momento importante, quello della premiazione. Il premio relativo a “Cosi lontano, cosi vicino: Storie del mondo piccolo” è stato attribuito al cortometraggio “The Loss” dell’israeliano Dekel Nitzan, opera sulla memoria che ritorna a vivere attraverso la storia di un vecchio produttore di vini che ha perso il figlio, Isaac, in guerra. Quando il comandante di Isaac arriva all’azienda vinicola per ridare le cose del figlio, nel padre nasce la necessità di confrontarsi con i sentimenti di dolore e colpa repressi. Premio “Pace e Solidarietà” attribuito dal Rotary a “Nel silenzio” di Lorenzo Ferrante dove un fratello rifiuta la condizione di stato vegetativo in cui si trova il fratello maggiore in seguito ad un incidente. E ad insaputa dei genitori intraprende con lui, portandoselo sulle spalle, un viaggio che li riporta nei luoghi della memoria: è un ultimo disperato tentativo di ritrovarsi. Un’opera di toccante umanità.
Il Premio della CIR-Food relativo a “Itinerari del gusto” è stato appannaggio del corto spagnolo “TABA. El juego de la Mesa” di Pep Gatell incentrato su una esperienza culinaria giapponese dove in una forma caolina il gioco è alla base della sua creazione. “Culurzones” di Francesco Giusiani (CC. Corte Tripoli Cinematografica) è invece il vincitore del Premio Fedic: un corto interpretato da Carlo Delle Piane nel ruolo di un anziano che prende in simpatia una giovane ragazza marocchina che va in casa, nella campagna sassarese, di una coppia di anziani per aiutarli. Ma tra le due donne ci sarà tensione, e sarà l’uomo insieme al nipotino a contribuire a migliorare la situazione. Premio anche a filmakers emiliano-romagnoli. E’ stato attribuito a “Ritornello d’amore” corto d’animazione di Silvia Capitta, Alessandra Atzori, Francesca de Bassa e Ludovica Di Benedetto. Spazio anche alla Scuola con proiezione di cortometraggi realizzati da studenti di Scuole Secondarie di Primo grado coinvolti in “Laboratori di Cinema” organizzati dal Videoclub Brescello. Un Festival dedicato agli Autorti e alla scuola, che si svolge in una simpatica atmosfera grazie anche alle cene preparate in piazza delle Redzore. Un omaggio alla cucina emiliano- romagnola.
.
CLASSICI
LEAVE HER TO HEAVEN O IL MELODRAMMA INATTESO
di Mathias Balbi
John M. Stahl, cineasta nato nel muto e scomparso precocemente nel 1950, veniva sbrigativamente posto dalla critica del suo tempo nella cerchia dei registi specializzati in drammi o nei cosiddetti “women’s pictures”: come viene curiosamente suggerito in una corposa pubblicazione monografica sul regista di alcuni fa, proprio la scomparsa di Stahl in un’epoca in cui – e solo per pochissimi anni di differenza – la critica cinematografica in terra statunitense non era ancora divenuta la disciplina matura della modernità[1] sembra costituire quel disallineamento sufficientemente colpevole a relegare il regista nel limbo degli autori invisibili, underground ante litteram e nondimeno (o proprio per questo) sottostimati.
Una chiave di lettura dopotutto plausibile se, oltre a ciò, si deve ricordare che il destino autoriale di Stahl fu paradossalmente affidato alla fortuna artistica e commerciale di un altro cineasta, come lui non americano di nascita (Stahl era di famiglia russa), ovvero il tedesco Douglas Sirk, al secolo Detlev Sierck, fuggito dalla natia Germania nel 1937 per approdare come molti altri colleghi mitteleuropei nell’America hollywoodiana degli anni Trenta.
Sirk, tra il 1954 e il 1959, dirige per lo Studio tre film che costituiscono il remake di altrettanti titoli stahliani realizzati in quegli anni Trenta e fondano l’antonomastico mélo sirikiano: La Magnifica Ossessione (Magnificent Obsession, 1954) e Lo specchio della vita (Imitation of Life, 1959), i più celebri, a cui si aggiunge Interludio (Interlude, 1957), che prende le mosse dallo stesso romanzo di James M. Cain da cui Stahl aveva derivato Vigilia d’amore (When Tomorrow Comes, 1939): quella che in termini più prosaici appare come una semplice e lineare operazione commerciale di riproposizione di un materiale cinematografico narrativamente forte e di grande impatto drammatico da parte di Universal Pictures (che ancora deteneva tout-court i diritti dei film degli anni Trenta), si trasformava, nelle mani della critica, nella discutibile teorizzazione di una continuità tra le due prassi cinematografiche che suggeriva quasi un rapporto simbiotico Sirk-Stahl[2].
Una riassuntiva premessa, questa, utile non solo e non tanto a sancire una differenziazione ed una separazione tra due registi storicamente accomunati e tra due approcci cinematografici entrambi peculiari e non assimilabili, ma soprattutto ad introdurre l’eccentricità di Leave Her to Heaven (1945) all’interno della stessa filmografia di Stahl e contemporaneamente nella sua formalizzazione cinematografica.
Se il mélo di Sirk era una maniera o addirittura un manierismo coltivato e sedimentatosi attraverso i citati capolavori dei Cinquanta, costruiti nello sfarzo cromatico-espressivo dell’imperante Technicolor, nella filmografia dello Stahl degli anni Trenta, che contempla la maggior parte dei suoi drammi (Back Street, 1932; Letter of introduction, 1938) si devono al contrario ravvisare un rigore ed un’austerità che trovano nella monocromia del bianco e nero la loro unica gamma espressiva.
L’apparizione, nel 1945, di Leave Her to Heaven è dunque un evento doppiamente contrastante e scioccante e lo diventa a partire dal momento in cui si identifica il genere a
cui il film appartiene e lo si osserva nella maniera in cui Stahl decide di dirigerlo: Leave Her to Heaven si dichiara in apertura come un romance, per poi tramutarsi rapidamente, disseminando in maniera canonica la trama di dettagli inquietanti[3], in un noir.
Ed in questa apertura si schiude però anche l’enigma formale di Leave Her to Heaven, con la sua eccentricità visiva che costituisce inoltre la brusca virata di un autore verso una maniera totalmente alternativa al suo stile abituale nel trattare il materiale che trova a sua disposizione: questo enigma è racchiuso eminentemente dall’utilizzo spiazzante, inusuale, quasi anarchicamente scorretto si potrebbe dire azzardando – o, ancora si può dire, eccentrico – , del Technicolor, che imposta il film in una chiave inattesa.
Il Technicolor, pietra filosofale degli anni Cinquanta e merce preziosa per il successivo mélo sirkiano, in Leave Her to Heaven è il meccanismo compositivo colpevole dello spiazzamento, e di uno spostamento delle pedine consuete del genere, utile a creare quell’effetto disorientante che d’altro canto è solitamente proprio dell’arte: nel film di Stahl non troviamo le cose famigliari al loro posto e queste si identificano con la presenza del colore che ci aspetteremmo di buon grado da altri generi cinematografici e da un materiale narrativo differente; Stahl sembra anticipare l’operazione analoga e contraria di Veronika Voss (1982) di Fassbinder (amante del mélo di Sirk, con il quale collabora dopo il rientro in Europa del regista), dove la componente melodrammatica della storia è come raffreddata da l’uso di un bianco e nero luminoso.
Il genere noir qui, proprio per l’intervento inusuale e sproporzionato del Technicolor, confluisce mano a mano nelle volute di un melodramma, ma con tempi e modi inattesi: tanto più che il materiale fornito dalla sceneggiatura di Jo Swerling può ben definirsi incandescente, dotato com’è di una carica di sadismo – e di una corrispondente successione di episodi in cui esplode la furia della protagonista Ellen Berent (Gene Tierney), quali il masochistico gesto dell’aborto auto-indotto con la volontaria caduta dalle scale e l’annegamento del ragazzino invalido – inusuale se non unica per la sua epoca: ne deriva un film il cui risultato formale è narrativamente imperniato sulla rappresentazione funerea di un’anima tormentata dalle sue stesse pulsioni masochistiche, una figura ossessionata, paradossalmente, dalla paura, dall’horror vacui derivante dall’abbandono da parte dell’uomo che sostituisce (sovrapponendovisi in maniera non meno funerea) la figura del defunto padre, oggetto di un amore abnorme che stende l’ombra dell’incesto sulla vicenda; terrore inoltre della negazione dell’affetto esclusivo dell’uomo, il romanziere Richard Harland, interpretato da Cornel Wilde, che progressivamente si allontana dalla donna per cercare l’amore della sorellastra Ruth (Jeanne Crain), causa scatenante del dramma conclusivo: in fondo, non si può non concordare con la critica francese che definiva Leave Her to Heaven “la version satanique de Magnificent Obsession” rintracciandone le inedite corrispondenze di azioni e figure, ma ribaltate e focalizzando l’attenzione su quanto “Avec l’acharnement maniaque d’un metter en scène, Ellen s’emploie à faire revivre une passion qui devient l’unique but de sa vie”, con la sadica caparbietà di chi “ne peut fonctionner en société”[4].
E’ realmente anche questo aspetto sociopatico, di irriducibilità di Ellen ai termini usuali e canonici della socialità e del vivere civile, che segna il suo agire malato e smisurato con i tratti di una primordialità comportamentale non omologabile da un consesso civile ordinario, a condurre all’amplificazione drammaturgica del film e alla sua esasperazione figurativa (principalmente realizzata dal colore).
Sembra di ritrovare la sauvagerie dei folli amanti protagonisti del successivo Duel in the Sun (1947) di Vidor, altro trionfo artistico in Technicolor, anche se qui il personaggio di Gene Tierney appare depositario di una follia più fredda rispetto all’indigena Arabella interpretata da Jennifer Jones: ma apparentandosi visualmente all’ancestrale furia di alcuni momenti del film di Vidor, come nella cavalcata in circolo per il sentiero desertico a spargere le ceneri del padre dall’urna funeraria che poi lancia in aria e infrange sulle rocce sottostanti, nel tributo forsennato ed anche nella rottura del cristallo che contiene l’idealizzata e morbosa immagine paterna, di cui ha appena individuato il sostituto.
In ogni caso, in questa aurorale rappresentazione di una creatura che ha martirizzato sé stessa attraverso la reclusione e il distacco da qualsiasi gruppo sociale allargato a più persone – tra i boschi del Maine e il deserto del Messico – non solo un utilizzo capillarmente simbolico del colore che comprende persino la scelta dei vestiti[5], ma anche l’attento cadrage di ogni sequenza del film sono le sottolineature formali di un mélo “ipercodificato” rispetto alle convenzioni del genere, già fondato di per sé sull’eccesso della rappresentazione.
Si vedano la sequenza dei due protagonisti appena tornati dal viaggio di nozze, inquadrati al tavolo da pranzo con uno sfondo domestico perfettamente canonico e rassicurante, come una quinta teatrale, con lei che dichiara la sua dedizione totale (e morbosa), rifiutando anche l’assunzione di domestici e con lui che la definisce una “born-slave”; o ancora quella con la sorella Ruth, che appare al mattino sulla testa di Richard a curare le rose sul pergolato della fattoria sotto il quale lui scrive a macchina, con una ripresa dal basso in alto, quasi a suggerirne una natura più celestiale, eterea, più vicina all’heaven di quanto non sia la tetra Ellen, lei quasi più vicina, nelle sue pulsioni e morbosità, alla gravitas della materia bruta e alla terra; Ellen che un attimo dopo apparirà invece emergendo dal fondo del laghetto ma anticipandosi come una figura bruna e informe sotto il pelo dell’acqua, come un indistinto mostro marino (“monster” sarà definita da Richard nel processo che chiude la vicenda), a sostituire sovrapponendovisi l’altra figura femminile.
Ma questo perché soprattutto nel film di Stahl vi è la presenza ingombrante della morte, che nel mélo diventa iperbole della finzione, indicata anche nella sua importanza semantica da Alberto Pezzotta che soprannominava Leave Her to Heaven un “film-reliquiario”: “In un mélo, dove tutto è assoluto, ipercodificato, dove ci si innamora a prima vista e dove il confine tra normalità e follia è così labile, rappresentare la morte, far finta che qualcuno muoia, significa esibire, quasi metalinguisticamente, il massimo di finzione possibile. La simulazione (e la coscienza che di simulazione si tratta) che in un mélo avvolge lo scorrere delle immagini non può non arretrare e incrinarsi di fronte alla morte. […] Eppure, con tutta la sua inverosimiglianza, la morte si dà come nodo di senso, evento privilegiato attorno a cui ruotano investimenti e identificazioni, i modi di fare e di vivere il film. […] Il film di Stahl è giocato su un alternarsi di piacere sadico, di adesione alla morte – e di ritrarsi di fronte al vuoto”[6].
E funereo è ad esempio il fatto che l‘incubo di Ellen su Danny (vero o inventato che sia) coincida con un evento fatale che lei riesce a mettere in opera nella realtà: questa operatività maligna è, al pari della morte (e di concerto con essa), il “nodo di senso” che concorre alla degradazione, figurale e psicologica, del personaggio di Ellen, magnete che emana un’energia negativa e nera e che si ritaglia uno spazio esclusivo sì – come lei stessa voleva in fondo – ma segnato dall’assenza del contatto con gli altri, che, come la madre stessa, evitano sempre più il suo contatto fisico e intimo, ritagliandola nella più completa e definitiva solitudine sociale.
A sigillare quella chiusura e quella circolarità mortuaria che indicava Pezzotta, esige di essere cremata come il padre, in un’identificazione e riunione totale con il suo corpo, non avendo avuto il possesso (“Io non ti lascerò mai andare”) del marito.
Il mélo inaspettato – e anche il romance vero e proprio – sembra giungere e realizzarsi solo nel finale giudiziario e poi dopo la reclusione con il ritorno di Richard al cottage del Maine, nel ricongiungimento con Ruth: prima, il mélo era nascosto e serpeggiante sotto la superficie di un noir che era il racconto sadico di una creatura tragica, “quel genere di mostro che era in realtà Ellen” come proclama Richard stesso nella deposizione-confessione in tribunale.
Allusività/ambiguità di nomi e titoli: l’Heaven, il Paradiso, è lo smisurato orizzonte – bigger than life come vuole una tradizione, anche iconografica, intrinseca al mélo – delle sue pulsioni, dei suoi desideri, delle sue smanie, ma in una dimensione e con un’ambizione proprio di assoluto che nulla ha di celestiale ma che per converso ha una sostanza molto nera (noir), come l’altrettanto allusivo nome del cottage (l’heimlich) sulle rive del lago: “Back of the Moon”, ovvero il lato in ombra, scuro della luna (che diventa quindi l’unheimlich), che formalmente e in maniera però sommamente ambigua viene replicato nella penombra serale che chiude circolarmente il film, con l’abbraccio finale tra l’appena scarcerato Richard e la sorellastra Ruth sul pontile del cottage.
E’, infine, la tragedia di una femminilità azzerata e soffocata in ragione del perseguimento caparbio di un impulso sadico e mortuario, dentro a cui sta anche la sterilizzazione della maternità: ed ecco che si scopre il senso cui partecipa il sibillino ma fin troppo significante titolo del film, che muove dall’Amleto shakespeariano (Act I, Scene V), laddove il fantasma consiglia al protagonista di non cercare vendetta contro la madre Gertrude:
“But howsomever thou pursues this act,
Taint not thy mind, nor let thy soul contrive
Against thy mother aught. Leave her to heaven,
And to those thorns that in her bosom lodge
To prick and sting her.”
(“Ma, comunque tu persegua quest’atto, non ti macchiare l’animo, né far che il tuo spirito disegni contro tua madre cosa alcuna; lasciala al cielo, e a quelle spine che nel suo seno albergano, per pungerla e trafiggerla.”)
[1] Cfr. Miguel Marìas, “The Unknown Mr. Stahl”, in: “John M. Stahl” (Edicion a cargo de Valeria Ciompi e Miguel Marias), San Sebastian, Festival Internacional de Cine de San Sebastian, 1999, p. 19.
[2] Si veda quello che dice a tal proposito sempre Marìas: “One might well have imagined that Stahl had been a kind of forerunner of Sirk, and that, like Sirk, he was a fan of melodrama as a narrative form and as repertoire of subject matter. I very much doubt the truth of such an undocumented assumption. His reputed specialisation in this genre […] was not as systematic as has been supposed, nor was it at all complete and exclusive. All this is to say that Stahl’s work – as it very gradually re-emerges – has been almost reflexively compared to that of Sirk, and appraised by Sirkian standards […] some critics have claimed to find Stahl’s originals as good or better than Sirk’s remakes. But what seems never to have occurred to any of them, even after seeing some of his films, was that Stahl might have almost nothing in common with Sirk”, Ibidem, p. 20.
[3] Un giovane romanziere, Richard Hartland, viene avvicinato in treno da una bella e ricca ereditiera, Ellen Berent, che in breve tempo, invaghitasi di lui, lascia il fidanzato e annuncia alla famiglia il loro imminente matrimonio. Nonostante sia la madre che la sorellastra Ruth tentino di mettere in guardia Richard dal carattere troppo possessivo di Ellen – che era stata legata al padre recentemente morto da un rapporto molto stretto, forse incestuoso – Richard non sa resistere al suo fascino ed i due si sposano pochi giorni dopo essersi conosciuti. Inizialmente il matrimonio sembra felice. Ellen è molto innamorata e pare circondare Richard di premure ed attenzioni. In realtà, la donna vorrebbe che Richard non avesse occhi che per lei e cerca di allontanare tutte le persone che si possono frapporre fra lei ed il marito, in primo luogo il fratellino handicappato di questi. Durante una gita in barca sul lago presso cui sorge la loro casa, Ellen, gelosa dell’affetto che Richard nutre nei confronti del ragazzo, lo spinge a fare una nuotata e poi lo lascia annegare, simulando una disgrazia. Rimasta incinta, teme che il figlio non ancora nato le sottragga le attenzioni di Richard che, nel frattempo, si è avvicinato a Ruth. Resa folle dalla gelosia, Ellen dapprima fa in modo di perdere il bambino che porta in grembo facendosi cadere dalle scale, poi si suicida col veleno dopo aver scritto una lettera in cui accusa la sorellastra. Durante il processo l’ex fidanzato di Ellen tenta di dimostrare la colpevolezza di Ruth ed il tradimento di Richard, ma questi rivela alla giuria i suoi sospetti sulla morte del fratello, facendo assolvere la cognata. Richard, una volta scontato un breve periodo di prigione per non aver denunciato a suo tempo il delitto, potrà ricostruirsi una nuova vita con Ruth, che lo ama da sempre (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Femmina_folle).
[4] Si veda la rassegna critica su Stahl in Yann Tobin, “Sur Back Street, Imitation of life, Magnificent Obsession, Parnell, Holy Matrimony, Leave Her to Heaven”, ‘Positif’, n. 220/221, juillet-aout 1979, pp. 107-110.
[5] Cfr. Marshall Deutelbaum, “Costuming and the Color System of Leave Her to Heaven”, originariamente pubblicato in ‘Film Criticism’, XI/3, summer 1987, pp. 11-20, ora in “John M. Stahl”, cit., pp. 309-325.
[6] Alberto Pezzotta, “Morte nella finzione”, ‘Filmcritica’, XXXVII, n. 364, maggio 1986, pp. 229-230.
.
.
OCCHIO CRITICO
IL FILM “CERNIERA” DI NANNI MORETTI
di Roberto Lasagna
Il nuovo film di Moretti si eleva nelle tracce di un racconto doloroso, uno scavo esistenziale scevro da compiacimenti, per darsi come forma del lento maturare interiore, riflesso di un progressivo approfondimento attuato assieme allo spettatore a cui il cineasta guarda come al suo umanissimo doppio e confidente. Messi da parte i manierismi di “Habemus Papam”, deposte le accuse politiche frequenti ne “Il caimano”, il regista di “Caro diario” e “Aprile” conserva il tono comunicativo immediato nella ricerca di una complicità tra il suo personaggio e lo spettatore in cerca del suo paladino. Ma il paladino qui esprime non tanto un’afasia comunicativa, quanto una singolare esitazione nell’esprimere segnali in una prospettiva comunicativa socio-politica, quella che tutto il popolo di Moretti sembra ogni volta attendere. Paiono così trascorsi molti anni dai “Girotondi”, da quando la priorità dei bersagli del regista era da cogliere nella tavola di una partecipazione alla scena politica che si manifestava in uscite più o meno plateali e divertenti, in esortazioni a D’Alema a “dire qualcosa di sinistra”, a prendere partito e posizione malgrado il riconoscimento di una vertiginosa caduta nell’incultura da parte del Belpaese.
 Ma tutto il cinema di Moretti, che con “Mia madre” perviene al dodicesimo lungometraggio, si mostra come percorso in cui i deragliamenti dei personaggi sono costantemente espressione di disagio, di una difficoltà a seguire un cammino tracciato o prevedibile. Tra i film dalla vocazione diaristica, come “Caro diario” e “Aprile”, e i film che privilegiano uno sguardo sul collettivo, permane l’elemento di continuità offerto da una narrazione i cui registri oscillano tra il realismo e la dimensione onirica, con i piani che sovente si confondono con il culmine ottenuto nel finale de “Il caimano” e in quasi tutto “Palombella rossa”, sorta di “Shining” di Nanni Moretti, teatro della mente dove le pulsioni e i pensieri dell’autore si rapprendono in quello che resta uno dei film più personali ed originali del regista. Laddove, nel film in cui Michele Apicella perde la memoria e cerca a fatica di rammentare il suo ruolo di deputato del partito comunista in un momento di trasformazione del suo partito, Moretti a ben vedere parte dall’individuo per raccontare le oscillazioni della mente, le fluttuazioni dei desideri e degli ideali, gli scarti tra apparenza ed immaginazione che lambiscono il pensiero di un uomo prima del politico, in quel film era Michele Apicella ad essere il doppio di Moretti. In “Mia madre”, il regista-attore, memore dei suoi precedenti espressivi, cerca una misura che ancora una volta alterni e confonda i registi espressivi, e qui il suo racconto procede con maggiore asciuttezza e controllo rispetto, perlomeno, al precedente film sulla figura del papa. Moretti si affida ad una figura femminile per portare in scena il doppio del suo ruolo di cineasta, a quella Margherita Buy che può finalmente interpretare il ruolo prediletto di donna in crisi lasciando passare nel suo personaggio le inquietudini di una persona che, operando nell’Italia di oggi e volendo esserne un’interprete, esprime propriamente confusione, difficoltà nel trovare un senso al proprio agire. Quando, lei giovane regista, si trova a dover mettere in scena la rappresentazione di un corteo di manifestanti ad uno sciopero, durante una pausa concitata di lavorazione commenta con stupore il comportamento di uno degli attori, il quale, pur essendo chiamato ad interpretare un ruolo pacifico, apprezzerebbe invece sfogarsi con gli altri e mettere in gioco la sua carica aggressiva. Nel contesto di un film, quello dentro il film, in cui la regista va alla ricerca di una messa in scena problematica del mondo del lavoro, la regista si accorge che il suo punto di vista non è condiviso, non è partecipato. E si accorge che perfino le sue indicazioni tipiche (dice agli attori: “devi essere il personaggio, ma devi essere anche a fianco del personaggio”) risuonano come parole vane o perfino vuote. Tanto vuoto e scoramento risuona con piena evidenza al confronto con il dolore del lutto, con l’attesa della morte di una persona cara che rappresenta quell’accudimento, quella cura, quel legame con il tempo e con il proprio mondo fondativo che sappiamo essere un riferimento preciso e costante nel cinema di Moretti. “Non torneranno più le merendine della mamma”, urlava Michele Apicella in “Palombella rossa”. La vita offre momenti di disperazione che, in un film tutto giocato sul teatro della mente come quello sulla pallanuoto, era plausibile e particolarmente interessante vedere inseriti e dipinti in un quadro di destabilizzante autarchia onirica, in una cornice in cui la piscina era il luogo eletto per tuffare aspirazioni, tic e nevrosi del deputato incapace di tracciare una rotta diversa e nuova al proprio vivere e al proprio partito (“Michele, se guardi a destra, lo so che poi tiri a destra”, confidava il portiere della squadra avversaria ad un Apicella smarrito dinanzi alla sconfitta). Ma in “Mia madre” Moretti, trovandosi ad essere regista di una narrazione più piana e non solo autore di una rappresentazione centrata sul Sé, affida opportunamente ad altri il compito di esprimere che la vita va avanti, che la vita è imprevedibile, irrispettosa (il personaggio dell’attore interpretato da John Turturro), mentre per se stesso egli sceglie, senza possibilità di appello, il ruolo del figlio che alla morte della madre lascia silenziosamente il lavoro, in attesa che qualcosa lo muova o lo motivi di nuovo. Un silenzio che risuona e dice più del dire. Un momento inatteso per i tanti osservatori del cinema di Moretti, uno smarrimento apparente che può lasciare sorpresi e far notare come al cineasta, questa volta, interessi in fondo poco il lato sociale e politico della rappresentazione. Ma forse il coraggio di una rappresentazione veritiera passa anche per questa strada e per questo riconoscimento di confusione. Tra tanti slogan e tante parole, quelli della politica attuale, Moretti, con un film sul dolore e le ferite dell’esistenza, sceglie di sottrarsi al dialogo scontato e convenzionale, per darsi in definitiva come diario intimo, come lettura personale di un disagio che può offrire via via sprazzi di una visione condivisa. Il vero film-cerniera tra il Moretti allegorico di “Palombella Rossa” e il Moretti ‘mimetizzato’ nell’interpretazione di personaggi quotidiani di “La stanza del figlio”.
Ma tutto il cinema di Moretti, che con “Mia madre” perviene al dodicesimo lungometraggio, si mostra come percorso in cui i deragliamenti dei personaggi sono costantemente espressione di disagio, di una difficoltà a seguire un cammino tracciato o prevedibile. Tra i film dalla vocazione diaristica, come “Caro diario” e “Aprile”, e i film che privilegiano uno sguardo sul collettivo, permane l’elemento di continuità offerto da una narrazione i cui registri oscillano tra il realismo e la dimensione onirica, con i piani che sovente si confondono con il culmine ottenuto nel finale de “Il caimano” e in quasi tutto “Palombella rossa”, sorta di “Shining” di Nanni Moretti, teatro della mente dove le pulsioni e i pensieri dell’autore si rapprendono in quello che resta uno dei film più personali ed originali del regista. Laddove, nel film in cui Michele Apicella perde la memoria e cerca a fatica di rammentare il suo ruolo di deputato del partito comunista in un momento di trasformazione del suo partito, Moretti a ben vedere parte dall’individuo per raccontare le oscillazioni della mente, le fluttuazioni dei desideri e degli ideali, gli scarti tra apparenza ed immaginazione che lambiscono il pensiero di un uomo prima del politico, in quel film era Michele Apicella ad essere il doppio di Moretti. In “Mia madre”, il regista-attore, memore dei suoi precedenti espressivi, cerca una misura che ancora una volta alterni e confonda i registi espressivi, e qui il suo racconto procede con maggiore asciuttezza e controllo rispetto, perlomeno, al precedente film sulla figura del papa. Moretti si affida ad una figura femminile per portare in scena il doppio del suo ruolo di cineasta, a quella Margherita Buy che può finalmente interpretare il ruolo prediletto di donna in crisi lasciando passare nel suo personaggio le inquietudini di una persona che, operando nell’Italia di oggi e volendo esserne un’interprete, esprime propriamente confusione, difficoltà nel trovare un senso al proprio agire. Quando, lei giovane regista, si trova a dover mettere in scena la rappresentazione di un corteo di manifestanti ad uno sciopero, durante una pausa concitata di lavorazione commenta con stupore il comportamento di uno degli attori, il quale, pur essendo chiamato ad interpretare un ruolo pacifico, apprezzerebbe invece sfogarsi con gli altri e mettere in gioco la sua carica aggressiva. Nel contesto di un film, quello dentro il film, in cui la regista va alla ricerca di una messa in scena problematica del mondo del lavoro, la regista si accorge che il suo punto di vista non è condiviso, non è partecipato. E si accorge che perfino le sue indicazioni tipiche (dice agli attori: “devi essere il personaggio, ma devi essere anche a fianco del personaggio”) risuonano come parole vane o perfino vuote. Tanto vuoto e scoramento risuona con piena evidenza al confronto con il dolore del lutto, con l’attesa della morte di una persona cara che rappresenta quell’accudimento, quella cura, quel legame con il tempo e con il proprio mondo fondativo che sappiamo essere un riferimento preciso e costante nel cinema di Moretti. “Non torneranno più le merendine della mamma”, urlava Michele Apicella in “Palombella rossa”. La vita offre momenti di disperazione che, in un film tutto giocato sul teatro della mente come quello sulla pallanuoto, era plausibile e particolarmente interessante vedere inseriti e dipinti in un quadro di destabilizzante autarchia onirica, in una cornice in cui la piscina era il luogo eletto per tuffare aspirazioni, tic e nevrosi del deputato incapace di tracciare una rotta diversa e nuova al proprio vivere e al proprio partito (“Michele, se guardi a destra, lo so che poi tiri a destra”, confidava il portiere della squadra avversaria ad un Apicella smarrito dinanzi alla sconfitta). Ma in “Mia madre” Moretti, trovandosi ad essere regista di una narrazione più piana e non solo autore di una rappresentazione centrata sul Sé, affida opportunamente ad altri il compito di esprimere che la vita va avanti, che la vita è imprevedibile, irrispettosa (il personaggio dell’attore interpretato da John Turturro), mentre per se stesso egli sceglie, senza possibilità di appello, il ruolo del figlio che alla morte della madre lascia silenziosamente il lavoro, in attesa che qualcosa lo muova o lo motivi di nuovo. Un silenzio che risuona e dice più del dire. Un momento inatteso per i tanti osservatori del cinema di Moretti, uno smarrimento apparente che può lasciare sorpresi e far notare come al cineasta, questa volta, interessi in fondo poco il lato sociale e politico della rappresentazione. Ma forse il coraggio di una rappresentazione veritiera passa anche per questa strada e per questo riconoscimento di confusione. Tra tanti slogan e tante parole, quelli della politica attuale, Moretti, con un film sul dolore e le ferite dell’esistenza, sceglie di sottrarsi al dialogo scontato e convenzionale, per darsi in definitiva come diario intimo, come lettura personale di un disagio che può offrire via via sprazzi di una visione condivisa. Il vero film-cerniera tra il Moretti allegorico di “Palombella Rossa” e il Moretti ‘mimetizzato’ nell’interpretazione di personaggi quotidiani di “La stanza del figlio”.
.
.
L’IMPOSSIBILITÀ DI ESSERE NORMALE: DOVE ERAVAMO RIMASTI
di Francesco Saverio Marzaduri
“È una maledetta vita impossibile…”
ROBBIE ROBERTSON, Ultimo valzer, 1978
In apertura di commento sul trentunesimo lavoro cinematografico dell’ormai ultrasettantenne Jonathan Demme, ironicamente, si potrebbe utilizzare il titolo di una commedia nostrana, Scusate il ritardo, giacché troppa è la latitanza che separa Dove eravamo rimasti dall’ultima pellicola a soggetto del film maker di Baldwin, Rachel sta per sposarsi. Non è da trascurare però lo spazio da quest’ultimo riservato alla musica (che pure, nel caso in oggetto, ha un peso determinante grazie all’inclusione di brani di Tom Petty, dei Canned Heat, degli Stones o persino di Lady Gaga), come riprovano i documentaristici Neil Young: Trunk Show o Enzo Avitabile Music Life. Ma se si eccettua un inedito – A Master Builder, tratto da Ibsen – l’assenza del regista dagli schermi italiani con un prodotto di finzione risale a sette anni fa.
Questo preambolo è esemplificativo: serve a inquadrare meglio un’operina che i preview, sbrigativamente, hanno spacciato per commedia degli equivoci. O, data anche la presenza di Meryl Streep, per un musical in stile Mamma mia!. Un equivoco c’è, in Dove eravamo rimasti: ma non è quella la sorpresa che l’autore vuole riservare allo spettatore. E se ugualmente nel film non mancano parentesi ilari, a dominare è l’ingrediente della malinconia, al contempo detonatore per topoi specifici di un apologo dolce-amaro. Il rimorso, ma non il rimpianto. Il tempo trascorso, appunto, troppo fugacemente. Il desiderio, nonostante tutto, di abbandonarsi ancora all’euforia come nulla fosse. E quello, all’origine, di essere normale – o meglio di sembrarlo, se non di volerlo essere – che finisce per scontrarsi con la propria impossibilità, anche se si tratta di un’impossibilità conquistata a fatica.
Proprio quest’ultimo pattern, a ben guardare, si rivela una condizione standard nella produzione di Demme: se il tema dell’ambiguità è sin troppo caro agli aficionados del suo cinema dai tempi del meraviglioso Il segno degli Hannan, è sufficiente rammentare, di tale filmografia, due eponime figure, condotte in una sfera che le induceva a fare i conti con la propria natura, messa a nudo da una seconda parete tesa a rivelarne la profonda precarietà. Nel caso di Clarice Starling, dietro un’apparente scorza di poliziotta determinata, era il background psicodrammatico cui la sottoponeva Hannibal Lecter – l’antagonistica dark inside – a permetterle di trovare la chiave dell’enigma e riuscire dove la polizia non poteva. Soluzione, come noto a tutti, risiedente nel retroterra più riposto dell’inconscio della protagonista, tanto vulnerabile da non consentire nemmeno a “The Cannibal” di sopraffarne la psiche e farne una delle sue innumerevoli vittime. Nel caso di Andrew Beckett, per contro, l’orgoglio e la gioia della propria natura gay (collimante con un’appassionata interpretazione del termine “diritto”) spogliava di ogni orpello il superficiale alveo della “città dell’amore fraterno,” anch’esso irto di pregiudizio e bigottismo, smascherando l’inconsapevolezza di chi – convinto liberal, oltretutto di pelle nera – doveva altrettanto confrontarsi con un ego non meno codino. Nel primo esempio, si tratta di un raggio più conciso. Nel secondo di uno più ampio che, partendo da un singolo, via via abbraccia un intero ambito che finisce inevitabilmente disarmato, nella misura in cui, sfregiata nell’orgoglio, l’ostinazione di Andy nel restituire l’umiliazione gli garantiva la vittoria, benché solo in un’aula giudiziaria.
Solo questi due esempi basterebbero a ricondurre l’intrico narrativo di Dove eravamo rimasti, a dir il vero flebile, su un binario identificabile: ancora una volta, lo spettatore si trova di fronte una figura aliena (come lo era Howard, il misterioso clochard di Una volta ho incontrato un miliardario). E per “alieno,” manco a sottolinearlo, s’intende un personaggio estraneo a una condizione di realtà lontana dai propri dogmi, poco interessa se mesta, squallida o fondata sull’apparenza, qui personificata dal principale – un altro nero – del supermarket in cui la protagonista è impiegata alla cassa, e che a quest’ultima “consiglia” cordialità e finti sorrisi, anziché cinismo e, appunto, alienazione. La contrapposizione tra apparente e reale è sempre dietro l’angolo: Demme non perde occasione per rammentarcelo fin dalla sequenza d’apertura, quando Ricki & the Flash – il nome del complesso rock, oltreché il titolo originale – si esibiscono in uno scalcinato locale notturno californiano. Il pubblico di avventori, però, è ridotto a una grama manciata, non tanto composta di giovani quanto di persone mature, bolse e usurate dal tempo. Esattamente come i due leader della band, che a brano concluso, sul perenne filo in bilico tra pubblico e privato, intrattengono il locale punzecchiandosi a vicenda con le rispettive vicissitudini personali. E la protagonista Ricki sigla “Sono più affermazioni da backstage che da palco.”
Il cuore dell’assunto risiede proprio nell’ostinazione di un personaggio che deliberatamente ha scelto di fare dell’esistenza qualcosa di travolgente, finendo – suo malgrado o meno – per incappare nel labile confine realtà-artificiosità. Tale figura – aliena, si diceva – è calata in un contesto dove luci e fragore dello spettacolo musicale (l’euforia di un ritaglio esistenziale) vanno in rotta di collisione, nella vita reale, con un miserevole impiego (l’usualità quotidiana), a propria volta non esente da falsità e apparenze. Senza spingersi troppo oltre, la medesima apparizione di Ricki – a mezza strada tra Bonnie Raitt e Cher – è il controcanto di un binomio: look costituito da pantaloni e stivali neri, chiodo borchiato e catenella, chitarra elettrica alla mano, sotto la cui icona è una signora in avanti con gli anni (e c’è da sospettare che pure il biondo dei suoi capelli non sia naturale), affascinante sebbene non avvenente, dai lineamenti fisionomici da tempo segnati. Per di più, la dirompente leader dei Flesh non si chiama Ricki, pseudonimo accattivante con cui ogni sera si rilascia al rock e alla carica eversiva contro tutti e tutto che ciò costituisce.
Ecco infatti una telefonata da Minneapolis raggiungere la donna, poco dopo l’esibizione: l’ex marito Pete Brummel (il Kevin Kline che fu partner della Streep nello straziante La scelta di Sophie), distinto signore e facoltoso uomo d’affari, la prega di raggiungerlo a causa di un’emergenza. È il momento, per Ricki, di un delicato back to the roots che la induce ad accantonare il nome d’arte per riappropriarsi di quello anagrafico, Linda Rendazzo. Un “ritorno alle radici” che, ineludibile, la pone di fronte ai suoi egoismi, non esattamente infondati, perlopiù dovuti a un desiderio – diventare una rockstar – ormai anacronistico, nel quale solo lei ha finito per credere (e al suo attivo ha visto pubblicato un solo LP), impossibile per quanto non impensabile. La presenza di Ricki/Linda, entro un nucleo familiare che le è estraneo, non può che gettare scompiglio giacché la trasgressione (di facciata) della protagonista è la trasgressione (forse sincera) di una dropout il cui egocentrismo ha seminato incomprensioni, inquietudini, complessi di colpa. Dietro un atteggiamento superficiale, Ricki sa bene di non poter tornare sui propri passi: occorre interpretare la parte del baro fino in fondo, pena il rischio di affrontare un ruolo, quella della patetica, ben peggiore.
Dietro la parvenza di commedia brillante, l’ultima fatica di Demme è una rancida operina basata sul non detto, sul silenzio che i familiari di Ricki/Linda a lungo hanno covato per il disagio, se non l’imbarazzo, nei confronti di una personalità debordante. È un’opera malinconica, debitrice di molto cinema statunitense anni Settanta, benché guardi ai rotocalchi, alle inchieste rosa o al feuilleton d’appendice, più che all’intimismo in sottrazione o a uno psicologismo giocato sull’ellissi. Questo non significa che sia priva di segmenti umoristici (e il lancio pubblicitario, almeno in questo, si è rivelato onesto): n’è un esempio la scena in cui la protagonista, seduta al tavolo di un ristorante insieme all’ex coniuge e alla figlia Julie (Mamie Gummer) per incontrare la futura nuora, scopre che il secondogenito Adam (Nick Westrate) è omosessuale. E trasecola, come già dopo il tentato suicidio di Julie, per non esserne stata messa al corrente. Immediata l’eco con Philadelphia, ma l’episodio – non privo di risvolti da pochade grossolana – ulteriormente svela l’atteggiamento di una figura contraddittoria, omofoba, reazionaria e orgogliosa di dichiararlo senza fronzoli: l’american girl del brano in apertura. Ancora, mentre è con Julie in una tavola calda, la donna con fare trasgressivo apostrofa un cliente seduto al tavolo accanto, intento a consumare un sandwich con la figlioletta e infastidito dalle chiacchiere troppo personali che lei declama a voce alta. E nell’avventore lo spettatore riconosce un cameo non accreditato del mimo Bill Irwin, che in Rachel sta per sposarsi, non a caso, vestiva i panni di un padre frustrato.
Dove eravamo rimasti, parafrasando il titolo italiano, è un invito allo spettatore e/o seguace del cineasta a reiterare un ritorno a casa seguito da un imminente sposalizio, prima del quale i preparativi al centro della vicenda sono occasione per un piccolo esame di coscienza. È, a sua volta, una dicotomia tra una sfera pubblica permeata di festosità, e una sfera privata tutt’altro che festosa. E un guado tra due diverse concezioni nel ritratto della protagonista: a una Ricki indomabilmente immatura, quale si conosce all’inizio, ne segue forse una più conscia e responsabile ma non più matura. Il riavvicinamento, il dolore provato e l’amore restituito ai cari attraverso pochi gesti lasciano il segno. Lo prova l’indecisione di Julie nel varcare la soglia della “normalità,” mentre in veste di testimone del fratello avanza lentamente verso l’altare e per un istante si arresta. L’indecisione ne frena la volenterosità: tornano le lacrime, prima che lo sguardo materno di Ricki le infondano il coraggio sufficiente per proseguire.
Non poco, ovviamente, contribuisce il recupero (urgente) del loro legame, nel corso del quale Ricki, nella scena del centro estetico, cerca di trasmettere un po’ della propria cinica filosofia outsider a una Julie sempre più languida e confusa, allo scopo di farne un’aliena una volta tanto con causa, e non un’aliena “normale” in preda a un’irreversibile crisi. Ancora, si pensi al drammatico scontro con l’uomo per il quale Julie ha tentato l’estremo gesto e chiesto il divorzio, svergognato da Ricki in presenza della nuova partner, dopo che la figlia, per caso, scopre un graffito di dubbio gusto che la ritrae sul vetro posteriore di un’auto. E se Demme, del resto, si è sempre dichiarato amante del kitsch, Dove eravamo rimasti non rinuncia a qualche battuta un po’ pesante (“Un giorno ti sveglierai e scoprirai un filo argentato” – si rivolge, impudica, la madre alla figlia – “e non parlo della testa!”). Come non poco lasciano il segno i teneri episodi in cui la famiglia, eccezionalmente riunita, si abbandona a una notte di ricordi: la melodia da Ricki intonata alla chitarra per i suoi cari; la scoperta che Pete – nonostante l’infedeltà verso di lei, e anch’egli dunque personaggio contraddittorio – non ha mai cessato di amarla e di amare la sua musica (l’unico vinile dell’ex moglie, custodito in cantina); il gesto di Ricki di rimboccare la coperta a una Julie assopitasi sul divano. E perfino un’ironica battuta di Pete alla figlia, mentre si dirige al bagno (“Non suicidarti là dentro”): perbenista qual è, l’uomo si stupisce un secondo dopo di averlo detto, mentre una Ricki anche più stupefatta esplode in una risata. Pur nascosta tra le pieghe, la voglia di giocare è ancora forte.
Se Dove eravamo rimasti pare leggersi Rachel sta per sposarsi, occorre ricordare che numerosi sono i punti di contatto fra i due film (in entrambi le nozze hanno luogo in giardini paradisiaci), ma differente è la scelta di campo: Kym era il detonatore conflittuale in contrasto con un alveo che, nel matrimonio della sorella, mirava al ritorno di una stabilità, laddove il suo arrivo, in teoria irto di buoni propositi, rivelava rancori mai sopiti, quando non esplosioni di collera, da parte di tutti i componenti. L’occasione per mostrare la pur presente invidia, dovuta al raggiungimento della normalità, si rivelava, senza camuffarsi più di tanto, in espressioni finto-umoristiche di un imbarazzante discorso d’auguri, senza capo né coda, rivolto agli sposi. Invece, nel caso in questione, Ricki, che sulle prime sembrerebbe ripetere l’azione di Kym, preferisce siglare le nozze, ormai avvenute, con pochi segnali di commozione lasciando che a restituire l’allegria sia il suo gruppo musicale, col quale interpreta My Love Will Not Let You Down (“Il mio amore non vi deluderà”), scritta da Bruce Springsteen. Non potrebbe apparire benedizione migliore, anch’esso un last embrace. Pure il diverbio con Maureen (Audra McDonald), la donna che ne ha preso il posto in famiglia dopo la sua partenza, nonostante l’astio e l’invito della rivale ad andare via, non si conclude a schiaffi e spintoni come accadeva tra Kym e la madre Abby.
La musica è coefficiente al contempo artistico e generazionale per Demme – sin dai tempi del concerto dei Talking Heads, documentato trent’anni prima – nella misura in cui Ricki/Linda è married to the rock. Qualcuno ricorderà quello sfortunato film, diretto e sceneggiato da Paul Schrader, ch’era La luce del giorno, la cui title track pure recava la firma di Springsteen. Anch’esso un film di famiglie (divise). Anch’esso un film di desideri, di difficile concretizzazione, e speranze, frustrate ma non riposte. Ma lì l’apologo era condotto e avviato verso la sfera di redenzione, costante tra le predilette del cineasta: e Patti non era personaggio meno caparbio di Ricki, pronto a qualsiasi prezzo pur di coronare il sogno, prima che la malattia e la morte della madre determinassero il suo rientro all’ovile. In Dove eravamo rimasti un’occasione drammatica – un background – spinge Ricki a tornare madre per una volta. In ambedue i titoli, però, ugualmente è presente l’esplosione di gioia, il contagio dell’allegria mediante la musica. E l’atteggiamento esuberante di Kym, che pure si ritrova nell’aplomb di Ricki, si moltiplica anche in altri personaggi, tra cui la stessa Julie: ma l’esito, là elegiaco, qui si traduce in un bastian contrario, grondando vitalità.
Film di famiglie, l’ennesimo nella filmografia di Demme, Dove eravamo rimasti è un prodotto in due metà, riverbero dei due distinti (ma non distanti) sguardi della donna, la trasandatezza prima e la consapevolezza dopo. Demarcazione che s’infrange quando, unica a non esser stata invitata alle nozze del primogenito Joshua (Sebastian Stan), nella seconda parte riceve l’invito. E a siffatta conseguita maturità – la scelta di Ricki/Linda, si potrebbe ribattezzare – la porta il pegno d’amore del chitarrista Greg (vendere la Fender per consentirle il secondo viaggio), aggrinzito hippy innamorato di lei e da lei strapazzato per quanto riamato. Come Ricki, un’anima divisa in due trascorsi, uno non esattamente idilliaco e un altro convinto della propria scelta. Teneramente intonato a due voci, Drift Away (“Allontanati”) di Dobie Gray suggella, guancia a guancia, il ritrovamento e la complicità dei due personaggi.
L’ultima prova registica di Demme è una via di mezzo tra un cinema démodé e la media confezione di maniera, che non nasconde di appartenere al cinema delle favole e dei buoni sentimenti, dove famiglia e calore trionfano su ogni cosa. Non è un segreto che l’autore, come nel menzionato Rachel, guardi al prodotto underground in cui il vero, costante e incessante, si amalgama alla finzione, come pure adocchia all’opera del compianto Arthur Penn. Pure, in Dove eravamo rimasti la lezione à la Cassavetes torna a fare capolino nei segmenti tra madre e figlia – nella finzione e nella vita reale – aggiungendo un pizzico di verità in più, quel valore aggiunto ch’è tra le cose più riuscite del film. E anche il nome d’arte “Ricki” è un elemento di richiamo finzione-verità, dato che il chitarrista Greg è impersonato da Rick Springfield. Pazienza se la sceneggiatura di Diablo Cody presenti più d’una lacuna, né importa troppo che la vicenda si rifaccia all’esistenza della suocera, componente di una band in un locale del New Jersey. Branchia di Juno e di Young Adult, storie di tormenti e inquietudini giovanili, primi approcci sessuali e voglia di musica e libertà, Dove eravamo rimasti, soprattutto, è un’opera che ancora una volta si poggia sulla performance recitativa e musicale della Streep, non nuova in qualità di urlatrice, da Cartoline dall’inferno a Mamma mia!, sino a Radio America. In una pellicola costituita di campi e controcampi, piani lunghi e lenti movimenti di macchina, l’epilogo è un rutilante tripudio di colori (la fotografia è di Declan Quinn), dove l’iniziale disagio degli invitati cede il posto alla baraonda, ricordando l’altmaniano Una coppia perfetta. Anche la musona Julie si lascia andare alla musica del cuore, quando l’impossibilità (ma quanto impossibile, poi?) di essere normale si traduce, da scapestrata filosofia, in una verità meritoriamente saggia. La verità su (e di) Ricki/Linda.
.
.
.
FOCUS SU PAOLO SORRENTINO
CONVERSAZIONE CON PAOLO SORRENTINO. LO STILE E LA BELLEZZA
di Federico Govoni
Lo stile
“Lo stile cinematografico indica una serie di tratti testuali appartenenti al livello della forma dell’espressione (aspetti visivi, ritmici, cromatici…) oppure al livello della forma del contenuto (per esempio determinati schemi narrativi) che si presentano con una certa regolarità e con una stabilità di collegamenti all’interno di un gruppo più o meno ampio di opere e che permettono di riconoscere immediatamente un certo testo o un suo frammento come appartenente a un corpus sufficientemente individuato (l’opera di un autore, ma anche le opere di una certa scuola o di un certo periodo storico).
Appartengono allo stile non solo i movimenti di macchina o l’uso del primo piano o dell’illuminazione, ma anche il modo di costruire le strutture narrative, di plasmare il tempo del racconto, di far muovere i personaggi, di articolare il punto di vista.”[1]
Il cinema di Paolo Sorrentino è riconoscibile perché ha una forte impronta personale e lo stile del regista caratterizza tutta le sue opere rendendole occorrenze di un organico ed unico sentire l’immanente fatica del vivere.
La narrazione viene sostituita dalla suggestione di quadri animati dove i colori, i movimenti della macchina da presa, il ritmo del montaggio, la musica si amalgamano plasticamente per suscitare emozioni. Il regista non vuole raccontare una storia ma trasmettere un “sentire” esistenziale. Le scene e le inquadrature oltrepassano il realismo per assumere un valore simbolico e concettuale. I diversi codici che si intrecciano nella realizzazione dei film raggiungono una estrema perfezione estetica sotto cui si nasconde un assordante vuoto.
Lo squallore di una vita povera di umanità, sotto il velo ordinato e luccicante dell’apparenza, è un pensiero ricorrente del regista: si manifesta con una messa in scena geometrica che suggerisce lo sforzo di razionalità dei personaggi di tenere sotto controllo, in modo schizofrenico, il Mondo fino a quando qualche evento li mette in crisi e il peso della maschera, sopra l’autenticità dell’Io, si fa insostenibile.
I dialoghi raffinati, spesso ricchi di citazioni letterarie e di ciniche battute, racchiudono scintille di saggezza e di pietà rivelando un’estrema cura formale al limite tra l’abisso morale e l’elevazione spirituale.
“È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l’emozione e la paura… Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile.”
Il valore del cinema di Sorrentino non risiede nella capacità di raccontare, ma semmai di descrivere le emozioni nascoste sotto la superficie del reale che non è la verità ma ciò che si vuole fare apparire. I grandi autori non si limitano a denunciare il male ma si accaniscono a trovare frammenti di bello e di bene superstiti per dare speranza anche quando l’indifferenza e il fallimento sembrano prevalere.
In tutti i film di Sorrentino si sente la vertigine di un malessere, i suoi personaggi sembrano incapaci di realizzarsi pienamente perché soffocati da un ruolo non congruente con la spontaneità della vita.
La fatica del vivere e la bellezza
(Conversazione avvenuta il 18 aprile 2015 presso la Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba in un incontro con il pubblico)
Domanda: cosa aggiungono le inquadrature geometriche, quasi astratte, uno stile così unico, al contenuto spesso filosofico e poetico dei suoi film?
Sorrentino: quando vado al cinema, vado per vedere qualcosa che sia verosimile ma che non sia esattamente la vita che è per lo più sciatta, disordinata e approssimativa.
Anche nella realtà, nella quotidianità, ogni tanto, si vedono degli improvvisi sprazzi di armonia e questo da spettatore mi piace vederlo. Mi piace vedere qualcosa di verosimile altrimenti non mi si attivano le emozioni ma, nello stesso tempo, penso che voglio vedere qualcosa che nella vita fatico a trovare, un’armonia, una compiutezza e quindi nasce la ricerca dell’inquadratura che poi avviene per ragioni misteriose.
Mia madre stava tanto al telefono con mia zia e faceva lunghe discussioni circa la distinzione nel mondo tra chi ha gusto e chi non ce l’ha ma che cosa fosse questo gusto non si sapeva. Per me è la stessa cosa. C’è bisogno di gusto.
Domanda: per lei la bellezza è una categoria estetica o si connota anche di significati morali?
Sorrentino: “La grande bellezza” è un film ambizioso che vuole parlare di tutto e per tutto si intende la bellezza della natura, delle cose.
Nel film c’è l’armonia architettonica della città di Roma, prima di tutto, poi c’è una bellezza sotterranea, molto spesso identificata con l’antitesi della bellezza che confina con la decadenza, con la volgarità che, invece, secondo me, presenta, essendo legata alla natura delle cose, aspetti interessanti.
Il film è stato fortemente equivocato, considerato come una sorte di critica alla società che è decaduta, invece il mio intento era di raccontare la grazia e il desiderio che si annida anche nelle forme di decadenza e volgarità perchè, a mio parere, anche nei momenti più duri per l’essere umano, ci sono degli interstizi, degli spazi di bellezza.
L’unico esempio che mi viene in mente è quando una ballerina cade, il momento più bello, secondo me, non è quando è al massimo delle sue capacità professionali e realizza il suo migliore gesto possibile, ma quando sbaglia: nell’errore, nell’imprevedibilità, si annida una forma di bellezza.
(“La bellezza” che Paolo Sorrentino rappresenta nei suoi film è sinonimo di “umanità”)
Sorrentino: lo spettatore segue delle proprie linee morali nell’interpretazione dei film, per me, invece, c’è del buono e del bello anche in ciò che è definito volgare, decadente, eccessivo, qui si annida una propria forma di “bellezza”.
Domanda: i tuoi film sono riconoscibili e identificabili con la cultura italiana?
Sorrentino: penso che i miei film siano una piacevole combinazione del particolare con l’universale, è una cosa che noi italiani sappiamo fare molto bene quando vogliamo. Il particolare italiano ha una sua capacità di diventare universale quando segue uno schema legato all’intelligenza e alla fantasia.
E’ riconoscibile da tutti anche per l’avventura del protagonista che è un’avventura di costante disagio esistenziale e questo è qualcosa che riguarda tutti gli uomini, per questo i film hanno una loro riconoscibilità ovunque. Gli spettatori riescono ad entrare in empatia con i film, seguendo la difficoltà e la fatica dello stare al mondo di questo protagonista.
Domanda: perché nei suoi film molti personaggi sono negativi?
Sorrentino: il racconto, per esistere, ha bisogno di conflitto e il conflitto ha bisogno anche degli elementi negativi. I film raramente presentano personaggi positivi perchè in questi il conflitto tende ad essere sfumato, ad attenuarsi mentre nella rappresentazione del negativo delle cose si alimenta e si arricchisce la narrazione e, per contrasto, nasce il bello.
Domanda: ha scritto un bellissimo libro “Hanno tutti ragione”. Qual è il suo rapporto con la letteratura?
Sorrentino: Mi sono molto formato sulla letteratura, infatti tendo a fare film più debitori nei confronti dei libri che ho letto che non dei film che ho visto. Conosco meglio degli scrittori che non i film e sono più vicino alle sfumature degli scrittori che non a quelle dei registi.
Nel film “La grande bellezza” si parla continuamente di scrittura, si parla di scrittori francesi ma anche di scrittori italiani, lo stesso protagonista è molto mutuato da scrittori come Arbasino, La Capria. Ho rubacchiato da Arpino e da scrittori che a me piacciono molto, a volte dimenticati.
Domanda: quando scrive un romanzo o un film parte dal personaggio o dalla storia?
Sorrentino: sinceramente non so cosa è la storia. Io non so scrivere le storie, infatti mi accusano che nei miei film non ci sono storie. Io so far vivere i personaggi, so raccontare il loro emozionarsi, trovarsi a disagio, essere felici. I miei film precedenti partivano da una situazione di consolidato successo e poi decadevano e questo era il massimo della trama.
Parto e arrivo con i personaggi, anche in questo senso mi sento vicino alla letteratura che mi piace perchè racconta a tutto tondo.
L’unica cosa che mi sta veramente a cuore è la grande fatica del vivere dell’essere umano, della fatica dello stare al mondo dell’essere umano che coincide con la grandissima bellezza del vivere. Passare dal momento di scoramento al momento della massima eccitazione, è questo che racconto dei personaggi.
Domanda: nei suoi film i personaggi si riabilitano rispetto a una condizione moralmente negativa. Si tratta di un filo conduttore?
Sorrentino: i miei personaggi sono apparentemente disperati, tragici e drammatici, hanno a che fare con sentimenti ostili, ma anche con desideri, con la speranza e la ricerca della grazia e della bellezza in modo tortuoso. Per essere verosimile l’uomo è tortuoso e ha una spiccatissima tendenza a fare del male e a farsi del male, ma anche a fare del bene ed io provo a raccontare questa dicotomia.
“L’amico di famiglia” è la storia di un uomo che pur senza possibilità di accedere al bello ci prova in qualche modo attraverso un prestito ad usura ritenendo che il suo comportamento, nel suo meccanismo ammalato, sia una forma di beneficenza: dimenticando il passaggio dell’interesse, crede di fare del bene. Noi tutti abbiamo degli scheletri negli armadi, però nei momenti che ci piace raccontare, spesso mentendo a noi stessi, facciamo finta di non averli.
Domanda: i protagonisti dei suoi film non sono giovani, perché?
Sorrentino: ne “La giovinezza” c’è una battuta che non è mia ma di Novalis: “Che cosa ti manca? Che cosa fai?”- “ Io faccio sempre la stessa cosa, io cerco sempre il padre, sto andando sempre alla casa del padre”.
E’ quello che fanno moltissimi narratori, si occupano da ragazzi di cercare il padre ed io ho messo in scena personaggi più grandi. Ora cercherò i figli.
Domanda: può riassumere la trama de “La giovinezza”?
Sorrentino: si tratta di un film umano, sull’amicizia tra due ottantenni e su come vivono la loro amicizia. Il tema del film, che mi sta a cuore, è come due ottantenni si pongono di fronte al futuro, non al passato, quale idea riescono a formulare rispetto al loro futuro. Questa è una domanda che ci si pone in modo più pressante quando si diventa più grandi e non solitamente da giovani. Spesso l’idea che si ha del futuro è poco collegata, a quell’età, con la volontà e quindi come il futuro sia una sorta di inevitabile destino e di accadimento incontrollabile.
Il tono, apparentemente, è triste perchè si condanna l’essere umano allo stare fermi e lo stare fermo ha l’assonanza con la morte (ci sono persone che devono stare ferme in piscina, a farsi fare i massaggi, a subire i fanghi in un esclusivo centro benessere che ricorda “La montagna incantata”).
Molti mi dicono anche che ci sono dei toni grotteschi, io invece penso di essere realistico, solo che tendo a notare il nucleo grottesco che c’è nella vita quotidiana.
Domanda: quanto ha influito nella tua formazione la “napoletanità”?
Sorrentino: io sono un napoletano atipico, perchè io scelgo con i miei film di fare commedie che però non riesco a realizzare. Forse la principale qualità in positivo che hanno i napoletani, in negativo c’è una lunga lista, è l’ironia. I napoletani sono grandi produttori di ironia, molti pensano di essere ironici e non lo sono e poi ci sono quelli che lo sono veramente. L’unica cosa in cui credo si manifesti la mia napoletanità è cercare costantemente l’ironia. Io appartengo alla schiera di coloro che presumono di essere ironici ma non lo sono.
.
YOUTH: IL COMPIMENTO DE LE CONSEGUENZE DELL’AMORE
di Andreina Sirena
“Youth”, ”notre palme d’or” ha sentenziato “Le Figaro” in prima pagina, coronando l’immagine di Michael Caine che solleva la mano in cenno di saluto, quasi ad erigere un invisibile trofeo mai conferitogli. Così la critica dell’illustre quotidiano francese, alla vigilia della cerimonia ufficiale di chiusura, suggellava il capolavoro di Sorrentino, risarcendolo anzitempo di una immeritata indifferenza. Con un Michael Caine definito ‘imperiale’ e un Harvey Keitel falsamente bonario (‘faussemente débonnaire’) il “mal aimé” del Festival – secondo la testata – aveva fatto soffiare sulla Croisette, l’aria della grande Cinecittà.
Dalla genialità sognante e ossessiva di Fellini non si udivano espressioni di giubilo così lapidarie sul cinema italiano.
In realtà l’ultimo lavoro di Sorrentino non è che il compimento e la sublimazione de “Le conseguenze dell’amore”, il suo secondo film, autentica crisalide cinematografica di “Youth”. Ambedue scelgono l’hotel e l’ambientazione svizzera. In “Youth” siamo in alta quota, nel Schatzalp Hotel di Davos (lo stesso de”La montagna incantata” di Thomas Mann.) dove un direttore d’orchestra – Fred Ballinger- viene costantemente supplicato ad accettare la proposta di dirigere un concerto dinanzi alla Regina d’Inghilterra. Il suo rifiuto è ostinato quanto incomprensibile e svela il suo totale disinteresse a donarsi ancora al pubblico. Anche Titta Di Girolamo ne “Le conseguenze dell’amore” trascorreva le sue giornate in un hotel svizzero, interiormente blindato nel suo segreto inconfessabile, ridotto ad origliare, nelle sue notti insonni, i discorsi deliranti dei suoi vicini di stanza con uno stetoscopio incollato alla porta. Quasi a carpire un battito di vita. Ma non coglieva altro che ulteriori inconfessabili segreti di una coppia di ricchi anziani finiti in disgrazia, che abitavano la stanza dell’hotel che un tempo era loro. L’uomo era un giocatore baro incallito che esprimeva il desiderio di voler morire in modo rocambolesco; sua moglie ricordava sprezzante tutte le ricchezze perdute per colpa del suo vizio di giocare d’azzardo nei casinò. I due anziani sembravano odiarsi e sopportarsi a stento. Anche in “Youth” i due coniugi che consumano i pasti in hotel senza rivolgersi la parola, altro non sono che l’estremizzazione della coppia del precedente film di Sorrentino; così come Miss Universo non è che la metafisica apparizione del personaggio de “Le conseguenze dell’amore” interpretato da Olivia Magnani, qui assurta a visione.
In “Youth” i temi de “Le conseguenze dell’amore” vengono portati a compimento in un grandioso florilegio estetico. Due film che segnano l’alfa e omega di un medesimo tema. Sorrentino gioca ancora una volta sull’ antitesi dell’età, sulla diversa percezione del tempo, sugli ultimi colpi di coda da sferzare sul viale del tramonto, prima di spegnersi. Entrambi i film, si diceva, sono ambientati in un hotel. L’hotel è un luogo di passaggio, di brevi soggiorni, uno spazio dove il cliente non puo’ mettere radici, un luogo nuovo che non richiama la memoria di qualcos’altro e che di per sé, esprimendo transitorietà, non rappresenta una stabilità familiare e affettiva rispetto all’ancoraggio domestico. Eppure Titta di Girolamo ci viveva da anni, Fred Ballinger sembra dimorarvi con la figlia, il suo amico Mick ha scelto quel luogo per trovare l’ispirazione al film della sua vita. In entrambi i film allora l’hotel diviene uno stato mentale, un terreno dove riaffiorano conflitti, dilemmi, aspirazioni, desideri. Proprio i desideri in questo non-luogo, in questa dimensione di sospensione dal reale, sembrano materializzarsi, prendere forma. Ne “Le conseguenze dell’amore”, il protagonista, nel suo silenzio imperscrutabile, vedeva risvegliarsi il sogno di un amore. In “Youth” tra i vapori dell’acqua termale che dona sollievo ai corpi avvizziti ed esalta la superba nudità giovanile, in una immaginaria passerella stagliata in piazza San Marco, l’anziano disilluso incrocerà la venere adamantina, nel suo incedere altezzoso. Attraverso il crudo monologo della figlia, Fred vedrà riaffiorare tutta l’esistenza, in un fiume di errori e manchevolezze e ne sarà come destato, dalla sua malinconica anestesia, a desiderare ancora, a volere un riscatto, a cercare il perdono, a dirigere ancora le sue leggendarie ‘Canzoni semplici’. D’altro canto proprio sua figlia Lena piange per un amore perduto, ma non smette di desiderare una nuova relazione che sembra sbocciare e prendere il volo dalle ceneri di un tradimento. E questo nuovo amore che prende quota viene rappresentato appunto nell’ascensione, dalla scalata sul climbing wall al volo col paracadute, su altezze dell’animo da sempre agognate. Così come i volti degli interpreti del sospirato film di Mick , ripresi in circolo mentre provano ad offrire un finale alla storia, in una grandiosa scena corale che consegna allo schermo l’effetto di un rosone che schiude i suoi petali vitrei sulla facciata di una basilica medievale; allo stesso modo il giovane divo americano vuole trovare il suo personaggio, la chiave di una delle interpretazioni più complesse che la carriera gli domanda. E sembra trovarlo proprio osservando i suoi compagni d’hotel. Quando appare, in una scena shock, nella sala della colazione, dinanzi allo stupore e all’incredulità dei presenti, è Hitler che somiglia più a “Il Grande Dittatore” di Chaplin che al perfido tiranno nazista. La sua distruttività si limita ad un sonoro e risibile pugno sul tavolo. E’ l’antitesi del pure citato Marx, che giganteggia nella schiena di un obeso e ormai vecchio calciatore, al quale non resta che tirare in alto una grottesca pallina da tennis e sognare il ‘futuro’mentre rivolge il pensiero allo storico goal del passato.
Sorrentino ama immortalare i fuochi serali prima del buio eterno, ma anche il dolore estremo di chi non sopravvive all’incalzare della notte. Così ne “Le conseguenze dell’amore”, una volta infranta la speranza dell’amore, Titta di Girolamo lasciava l’hotel, scegliendo di consegnarsi alla morte. Non più l’ascesa, la leggerezza e la levità della speranza nutrita da una storia appena iniziata (rappresentata dalla salita dell’ascensore, delle scale mobili, dall’indugio sulla gru che vedeva dalla finestra della sua stanza) ma la discesa, il declivio verso il vuoto, magistralmente ritratto nel lento calare del protagonista nel cemento fresco. Un finale segnato dal ritorno alle radici, così caro al regista se pensiamo anche al finale de “La grande bellezza”. Titta di Girolamo, deluso dall’esistenza, rivolgeva il suo ultimo pensiero a Nino Giuffrè, il suo migliore amico, che non vedeva e non sentiva da vent’anni (‘perché quando si è amici una volta, lo si è per tutta la vita’). E proprio mentre discendeva verso la morte, il suo ultimo sguardo saliva, in mezzo alla neve, in cima alle Alpi del Trentino, sul palo della luce dove l’amico di un tempo lavorava. E le sue ultime parole in vita, in un finale crudo quanto struggente, indicavano nell’amicizia l’unica certezza. Così come il direttore d’orchestra, sul finale di “Youth”, esce dall’hotel e torna sulla tomba del suo maestro, torna a trovare la moglie ricoverata in un sanatorio, pietrificata con la fronte contro un vetro e la bocca semiaperta, come ad intonare una delle ‘Canzoni semplici’ che suo marito le aveva dedicato e delle quali era interprete ineguagliabile. Anche Fred, nell’ultimo fotogramma del film, rivolgerà lo sguardo al suo migliore amico, che ha scelto la discesa della morte (dinanzi ai suoi occhi impotenti) all’ascensione del desiderio e della speranza.
.
YOUTH. UNA MEDITAZIONE SUL TEMPO
di Maurizio Villani
Il tempo della giovinezza e quello della vecchiezza sono due della fasi in cui si scandiscono le età della vita di ciascun uomo e di ciascuna donna. Alla disamina del loro complesso rapporto è dedicato l’ultimo film di Paolo Sorrentino, “Youth – La giovinezza” ( 2015). L’intuizione originaria dell’autore consiste nell’aver messo a tema la giovinezza (così si evince dal titolo del film) attraverso la trattazione delle vicende di due anziani protagonisti – mirabilmente interpretati da Michael Caine (nella parte di Fred Ballinger) e da Harvey Keitel (in quella di Mick Boyle) – che vivono il declinare di un’esistenza ormai prossima alla morte.
Una delle chiavi di lettura del film è racchiusa nella tematica della temporalità, nelle cui dimensioni si presenzializza il vissuto delle persone. Secondo un’antica concezione, risalente ad Aristotele, il tempo è la misura del cambiamento. Il film di Sorrentino ci mostra che la miglior misura del cambiamento ci è data dal declino fisico del nostro corpo e che la consapevolezza di tutto questo ha il proprio centro nella psiche, le cui dinamiche ci consentono di fare l’esperienza del tempo. La riflessione filosofica ha mostrato quanto sia difficile definire il tempo, la cui consistenza ontologica pare sfuggirci, tra passato che non c’è più, un presente che svanisce ad ogni attimo che passa e un futuro che non c’è ancora. Ma proprio la psiche riesce a dare densità all’esperienza del tempo percependone la durata, misurandolo e rendendo presente alla coscienza il passato – sotto forma di ricordo – e il futuro – sotto forma di attesa. Sicché corpo e anima, soma e psiche si intrecciano e si compenetrano nei vissuti temporali. Possiamo ritrovare tutti questi elementi in “Youth”, la cui storia seguiremo attraverso alcune citazioni di passi del romanzo-sceneggiatura scritto da Paolo Sorrentino, La giovinezza, Rizzoli, Milano 1015 (nel prosieguo del testo le indicazioni delle pagine si riferiscono a questa edizione).
La locandina del film, scelta evidentemente per ragioni commerciali, può essere interpretata anche come metafora visiva del trascorrere del tempo scandito dal mutamento fisico dei corpi: la giovinezza prorompente di Miss Universo e la vecchiezza inflaccidita e nostalgica di Fred e Mick.
Nella scena quinta del film una prima contrapposizione tra la vecchiezza piena di acciacchi dei due protagonisti e la “bella” giovinezza è così rappresentata:
In piedi nella stanza ci sono Fred Ballinger e un altro anziano, anche lui sugli ottanta, ancora un bell’uomo, i capelli leggermente lunghi, gli occhi chiari, lucenti, onnivori e vitali. Si chiama Mick Boyle.
I nostri due anziani osservano in silenzio il gruppo dei ragazzi che dormono. Il violino svanisce dopo un tempo.
«Hai pisciato oggi?» chiede Fred.
«Due volte. Quattro gocce. Tu?»
«Uguale. Più o meno.»
«Più o meno?» «Meno.»
«Guarda come sono belli» dice Mick. «Sì, sono belli.» (Pagg. 23-24).
La problematica urologica ritorna più volte nelle conversazioni dei protagonisti e nelle parentesi mediche del soggiorno montano. Fino a che, in una scena del finale del film, la supposta patologia prostatica dl Fred si rivela inesistente e serve solo a disvelare quale sia la sua unica, vera, inguaribile malattia, quella di essere vecchio:
Il medico si siede alla sua scrivania. Prende una cartella clinica. La apre. «Ho i risultati di tutti i check-up che ha fatto in queste settimane.»
«E cosa dicono?»
«Lei è sano come un pesce, signor Ballinger.» E Fred, quasi speranzoso, chiede: «Almeno la prostata?».
L’altro è sorpreso. «La prostata? Lei non ha mai avuto problemi di prostata. E se non ha mai avuto problemi finora non comincerà certo adesso.»
Fred Ballinger alza lo sguardo sul dottore. In modo del tutto inatteso, sorride. E dice: «Dunque, sono vecchio, ma non si capisce perché sono vecchio». (Pagg. 179-180).
Il tema del corpo infiacchito, riproposta attraverso le contrapposizioni passato-futuro e giovani-vecchi, ritorna due scene dopo e, ancora, nella scena 21, che la sceneggiatura descrive in questi termini:
In mezzo ai fumi delle saune e dei bagni turchi, corpi nudi di tutte le età sembrano morti e abbandonati, in controluce, al caldo e al sudore. Corpi tonici e lucidi, corpi abbondanti e rotondi, corpi vecchissimi e sfasciati. Così è fatta la fatica del benessere. Così, alcuni provano ad allungare il futuro o a inseguire goffamente il passato della giovinezza. (Pag. 70).
 Altro tema che si incontra nel film è quello del ricordo e della sua possibile manipolazione. È il ricordo della giovinezza che riemerge nelle conversazioni tra Fred Ballinger e Mick Boyle, a proposito del loro comune amore per la fascinosa attrice Gilda Black.
Altro tema che si incontra nel film è quello del ricordo e della sua possibile manipolazione. È il ricordo della giovinezza che riemerge nelle conversazioni tra Fred Ballinger e Mick Boyle, a proposito del loro comune amore per la fascinosa attrice Gilda Black.
«Hai capito benissimo. Sessant’anni fa mi giurasti che non ci eri andato a letto per rispetto del mio amore per lei. Ora parli diversamente.»
«Guarda, io devo farti una confessione.»
«Bravo, falla!»
«La tragedia vera e, credimi, è proprio una tragedia, è che io non mi ricordo se sono andato a letto con Gilda Black.»
«Stai dicendo sul serio?»
«Purtroppo sì. Te lo giuro.»
«Be’, questo cambia le cose.»
«In che senso?»
«Se avessi avuto la certezza che ci fossi andato, la nostra amicizia adesso sarebbe finita. Invece così, diciamo… che posso convivere con il dubbio.»
«E comunque, se ci sono andato a letto e non me lo ricordo significa che non valeva vent’anni di vita. Non credi?»
«Sì, hai ragione. Gilda Black è un capitolo chiuso tra noi due.» (Pagg. 42-43).
Un perno strutturale del film, fondamentale per la presente analisi sulla temporalità e per la comprensione del senso del passato e del futuro, si trova alla scena 33, in cui il rapporto tra ciò che è stato e ciò che sarà è genialmente rappresentato non temporalmente, ma spazialmente nell’episodio del cannocchiale.
Giungono alla sommità, un meraviglioso belvedere, dove si può sentire quel silenzio sospeso dell’aria pulita e apprezzare la magnifica vista delle Alpi e della valle.
Sul belvedere c’è un cannocchiale, di quelli turistici, con la monetina.
Il gruppetto, in silenzio, osserva il panorama. Mick si stacca da loro e infila una moneta nel cannocchiale.
Poi dice ai giovani: «Venite a vedere qui».
Va per prima la ragazza. Mick la istruisce, mentre gli altri stanno a sentire. «Ora ascolta. Vedi quella montagna di fronte?»
«Sì. Sembra vicinissima.»
«Esatto. Questo è quel che si vede da giovani. Si vede tutto vicinissimo. E quello è il futuro. Ora vieni con me.»
La prende per mano e la invita a guardare nel cannocchiale, ma dal lato opposto.
La ragazza osserva i volti dei suoi giovani amici che, nella lente rovesciata, appaiono lontanissimi anche se sono a due metri da lei.
«E questo è quel che si vede da vecchi. Si vede tutto lontanissimo. E quello è il passato.» (Pagg. 100-101).
In una conversazione, che prende lo spunto dal progetto, mai realizzato da Fred, di scrivere le memorie, si viene ad affrontare il tema della morte.
Mick : «Un libro sul tuo lavoro, su quello che hai vissuto, rimarrà per sempre. Servirà ai giovani musicisti, a tutti. È importante…»
Fred lo interrompe: «È importante… Lasciare la memoria ai posteri, tramandare il sapere, sono anni che sento questi ritornelli, ma sono solo alibi traballanti, Mick, per fingere di non vedere l’unico problema».
«E qual è l’unico problema?»
«La morte, Mick! La morte così vicina.»
«Così, mentre pensi alla morte che si avvicina, non vivi. Anche se sei vivo.» (Pagg. 115-116)
Da argomento di amabile colloquio salottiero la morte però si trasforma in evento tragico di lì a poco, irrompendo a spezzare la relazione di amicizia tra i due protagonisti, dopo che Mick capisce che è fallito il progetto del film che stava preparando.
Che farai dopo, Fred?»
«Cosa vuoi che faccia! Torno a casa. La solita routine.»
«Io no. Io nella routine non ci so stare. Io sai cosa faccio, Fred? Io mi dedico a un altro film. Tu hai detto che le emozioni sono sopravvalutate, ma è una stronzata. Le emozioni sono tutto quello che abbiamo.»
Poi Mick si solleva, va alla finestra, la apre, esce sul balcone e, con grande semplicità, mette un piede sulla poltroncina di vimini del terrazzino, un altro piede sul davanzale e si lascia cadere di sotto dal quarto piano.
Fred ha avuto giusto il tempo di alzarsi in piedi nella stanza, ma Mick è stato abbastanza rapido e imprevedibile da non avergli dato la possibilità di fare nulla per salvarlo. (Pag. 173)
Il suicidio di Mick disorienta nel profondo Fred. Tra i due amici il cineasta pareva il più vitale dei due, meno vittima dell’apatia che sempre affliggeva Fred. Il quale decide di far proprio il messaggio dell’amico – si deve vivere, non sopravvivere – e compie delle scelte che riattivano il suo interesse per la vita. Si reca dapprima a Venezia a portare dei fiori alla moglie ricoverata in una clinica per una grave malattia mentale. Poi accetta l’invito della regina d’Inghilterra per ritornare, dopo anni di silenzio, a dirigere un concerto a Buckingham Palace in occasione del compleanno del Principe Filippo di Edimburgo. Invito che aveva più volte rifiutato, sostenendo di aver composto quelle melodie esclusivamente perché fossero eseguite dalla moglie Melanie, che ora non può più cantare. Due segnali forti di superamento dello stato di apatia che lo aveva accompagnato per anni e che aveva coinciso con le vecchiaia sempre più incombente. È lo slancio del un vecchio musicista verso una ideale nuova giovinezza.
Un gesto del braccio di Fred e archi e fiati si affievoliscono fino a sparire. Rimane solo il violino.
Fred volge lo sguardo a Sumi Jo. Con un cenno degli occhi le dà l’attacco.
Sumi Jo rilancia; un altro, clamoroso, lungo e perfetto acuto.
Fred non può fare a meno di fissare il soprano sud coreano mentre si produce nell’acuto. Anche lei lo guarda.
Allora Fred continua a guardarla, ma in realtà è come se stesse guardando un’altra persona… la moglie, Melanie.
Al piano ammezzato dell’ospedale.
I bianchi capelli sfatti, il viso distrutto dalla malattia, gli occhi perduti nel nulla e la bocca aperta, come se stesse cantando. (Pagg. 191-192).
Alla fine del film l’ordine del tempo viene invertito. Il vecchio Fred Ballinger (Michael Caine) riprova le emozioni della giovinezza tornando a dirigere in un concerto i brani che aveva scritto per la moglie e che ora lascia cantare al soprano coreano Sumi Jo.
.
NEO-CINEMA
a cura di Elio Girlanda
NUOVI OCCHI, NUOVI SGUARDI
Notizie recenti: la Sony entra nella produzione di droni, anche per esplorare nuove opportunità d’impiego dal momento che sta approfondendo la capacità di adattare le innovazioni alle tecnologie più diverse come videocamere e sensori. Infatti i nuovi droni saranno attrezzati con sensori di immagine targati Sony ovvero con prodotti già impiegati negli smartphone. D’altronde i droni sono ormai al servizio delle produzioni cinematografiche, professionali e non, potendo visualizzare dall’alto scene e location con angolazioni suggestive inedite, come ben si vede ne “Il racconto dei racconti” (2015) di Matteo Garrone per il Castel del Monte in Puglia. L’avvento dei droni cinematografici è forse paragonabile a quando Nadar, nel 1856, brevettò la fotografia aerea grazie a una macchina fotografica trasportata su un pallone aerostatico.
 L’altra notizia riguarda più direttamente i nostri occhi. Sono prossime le “lenti smart”, realizzate da Google e Novartis, la Casa farmaceutica, ovvero le prime lenti a contatto “intelligenti”, in grado cioè di monitorare la glicemia per i diabetici. Sulla stessa linea di ricerca la startup Innovega ha sviluppato una lente che permette di vedere un film su un display in miniatura da una distanza super ravvicinata, fino a farlo apparire come su un grande schermo Imax. È l’inizio di una nuova epoca per le immagini in movimento in fase sia di ripresa che di proiezione. Il dispositivo cinema, nella sua parte originaria e più tecnologica (“Cinématographe” dei Lumière), non solo si miniaturizza sempre più e si personalizza, abbassando anche i costi relativi al minimo, ma estende le sue possibilità di punti di vista e di angolazioni come mai è accaduto nella storia della visione, e del cinema stesso. Forse si potrebbe pensare già a una sorta di classificazione, individuando oggi la preistoria delle tecnologie digitali e mobili della visione (le tecnologie di servizio), rappresentata da smartphone e tablet con microcamere inserite che permettono di riprendere e montare foto e video. Ho già segnalato in questa rivista il film “Tangerine” del 2015, realizzato con iPhone 5S e presentato al Sundance Film Festival.
L’altra notizia riguarda più direttamente i nostri occhi. Sono prossime le “lenti smart”, realizzate da Google e Novartis, la Casa farmaceutica, ovvero le prime lenti a contatto “intelligenti”, in grado cioè di monitorare la glicemia per i diabetici. Sulla stessa linea di ricerca la startup Innovega ha sviluppato una lente che permette di vedere un film su un display in miniatura da una distanza super ravvicinata, fino a farlo apparire come su un grande schermo Imax. È l’inizio di una nuova epoca per le immagini in movimento in fase sia di ripresa che di proiezione. Il dispositivo cinema, nella sua parte originaria e più tecnologica (“Cinématographe” dei Lumière), non solo si miniaturizza sempre più e si personalizza, abbassando anche i costi relativi al minimo, ma estende le sue possibilità di punti di vista e di angolazioni come mai è accaduto nella storia della visione, e del cinema stesso. Forse si potrebbe pensare già a una sorta di classificazione, individuando oggi la preistoria delle tecnologie digitali e mobili della visione (le tecnologie di servizio), rappresentata da smartphone e tablet con microcamere inserite che permettono di riprendere e montare foto e video. Ho già segnalato in questa rivista il film “Tangerine” del 2015, realizzato con iPhone 5S e presentato al Sundance Film Festival.
All’ultimo Festival di Locarno è stato presentato “No Home Movie” (2015), un film realizzato con le immagini della madre (defunta) registrate al computer nelle conversazioni via Skype dalla regista Chantal Ackerman: «Questo è prima di tutto un film su mia madre, mia madre che non c’è più. Su questa donna arrivata in Belgio nel 1938, in fuga dalla Polonia, dalle atrocità e dai pogrom. Questa donna che vediamo soltanto nel suo appartamento. Un appartamento di Bruxelles. Un film sul mondo che cambia e che mia madre non vede».
 Anni fa la moltiplicazione delle telecamere di sorveglianza o a circuito chiuso stimolò registi britannici come Mike Figgis (“Hotel”, 2001) e Andrea Arnold (“Red Road”, 2007), destrutturando non solo le immagini ma anche i racconti. Più recentemente cineasti come Park Chan-wook (“Old Boy”) e Pippo Delbono hanno mostrato veri e propri lungometraggi di finzione realizzati con la tecnologia minimale dello smartphone. È il caso, appunto, di “Amore carne”, presentato al Festival di Venezia nel 2011.
Anni fa la moltiplicazione delle telecamere di sorveglianza o a circuito chiuso stimolò registi britannici come Mike Figgis (“Hotel”, 2001) e Andrea Arnold (“Red Road”, 2007), destrutturando non solo le immagini ma anche i racconti. Più recentemente cineasti come Park Chan-wook (“Old Boy”) e Pippo Delbono hanno mostrato veri e propri lungometraggi di finzione realizzati con la tecnologia minimale dello smartphone. È il caso, appunto, di “Amore carne”, presentato al Festival di Venezia nel 2011.
 D’altronde l’evoluzione tecnologica della rete e dei dispositivi della comunicazione mobile, contrassegnati ormai dal primato delle immagini e dei video come dalle sinergie tra social media, canali video e app (come YouTube o Periscope per Twitter), fa delle riprese filmate il veicolo principale del marketing e della pubblicità correnti. La quantità e la qualità dei prodotti disponibili o in preparazione non sono paragonabili a quelle di altre epoche con l’avvento di nuove macchine fotografiche e videocamere per tutti. Forse l’unico termine possibile di paragone è quello delle origini, legato ai Lumière, quando nei primi 4-5 anni dopo il 1895 furoreggiarono solo gli ambulanti e gli amatori. Non a caso recentemente il celebre regista John Lasseter della Pixar ha dichiarato di aspettarsi di vedere, un giorno, premiato un film girato con queste nuove tecnologie: “Le persone vi diranno che non potrà funzionare, e invece funzionerà. La ragione per cui lo dicono è solo che non ci sono abituati”.
D’altronde l’evoluzione tecnologica della rete e dei dispositivi della comunicazione mobile, contrassegnati ormai dal primato delle immagini e dei video come dalle sinergie tra social media, canali video e app (come YouTube o Periscope per Twitter), fa delle riprese filmate il veicolo principale del marketing e della pubblicità correnti. La quantità e la qualità dei prodotti disponibili o in preparazione non sono paragonabili a quelle di altre epoche con l’avvento di nuove macchine fotografiche e videocamere per tutti. Forse l’unico termine possibile di paragone è quello delle origini, legato ai Lumière, quando nei primi 4-5 anni dopo il 1895 furoreggiarono solo gli ambulanti e gli amatori. Non a caso recentemente il celebre regista John Lasseter della Pixar ha dichiarato di aspettarsi di vedere, un giorno, premiato un film girato con queste nuove tecnologie: “Le persone vi diranno che non potrà funzionare, e invece funzionerà. La ragione per cui lo dicono è solo che non ci sono abituati”.
 Da tempo il mercato mette a disposizione di tutti anche videocamere per riprese difficili o rischiose, come quelle della gamma GoPro o “action camera “, adattabili a qualsiasi attività d’avventura e sportiva, compresa quella subacquea, montabili su supporti in movimento e dotate di numerose modalità software. Oppure ci sono quelle indossabili con una memoria h24 per un minidiario scaricabile in rete per il “lifelogging”. E ancora. Un giovane regista di Massa, Giancarlo Fruzzetti, ha realizzato un film sperimentale d’autore (a detta di Pier Marco de Santi) interamente con una reflex e senza una troupe, dal titolo: “Tutta colpa di una figlia alimentata ad elio!!!”. È quasi un trattato di parapsichiatria, un’opera che supera la linearità narrativa spazio-temporale a cui siamo abituati al cinema per «descrivere solamente il pensiero umano, con i suoi diversi gradi di coscienza e di rivoluzione, di ricerca interiore e conoscenza di sé», come dichiara l’autore. Che aggiunge: «A questo è dovuta l’adozione di un modello descrittivo piuttosto che di uno drammaturgico, nel senso che il pensiero viene prima dell’azione».
Da tempo il mercato mette a disposizione di tutti anche videocamere per riprese difficili o rischiose, come quelle della gamma GoPro o “action camera “, adattabili a qualsiasi attività d’avventura e sportiva, compresa quella subacquea, montabili su supporti in movimento e dotate di numerose modalità software. Oppure ci sono quelle indossabili con una memoria h24 per un minidiario scaricabile in rete per il “lifelogging”. E ancora. Un giovane regista di Massa, Giancarlo Fruzzetti, ha realizzato un film sperimentale d’autore (a detta di Pier Marco de Santi) interamente con una reflex e senza una troupe, dal titolo: “Tutta colpa di una figlia alimentata ad elio!!!”. È quasi un trattato di parapsichiatria, un’opera che supera la linearità narrativa spazio-temporale a cui siamo abituati al cinema per «descrivere solamente il pensiero umano, con i suoi diversi gradi di coscienza e di rivoluzione, di ricerca interiore e conoscenza di sé», come dichiara l’autore. Che aggiunge: «A questo è dovuta l’adozione di un modello descrittivo piuttosto che di uno drammaturgico, nel senso che il pensiero viene prima dell’azione».
Una delle novità radicali è rappresentata dal web che costituisce il “canale-schermo” che più di altri (sala, schermi urbani, monitor, smartphone, tablet ecc.) è diventato il medium più adeguato non solo a diffondere i nuovi prodotti a low budget e per un pubblico di massa, ma anche a stimolare nuovi formati e contenuti come le webseries. Un’altra linea di rinnovamento sarà rappresentata dai confini, più o meno rigidi, che “aprono” o rivoluzionano la secolare “finestra” della visione fissata da Leon Battista Alberti, all’origine della nostra concezione di spettacolo, di schermo e di immagine cine-fotografica, oltreché pittorica. Alcuni esempi recenti sono quelli di una macchina fotografica plenottica, che dà la possibilità di riattingere nel tempo ai dati memorizzati per visualizzare altri punti di vista e altri effetti di profondità, oppure dei corti girati unicamente con le telecamere che sulle automobili consentono di vedere le manovre di parcheggio, ma anche di retromarcia, le Rear View Camera, oggetto di un lancio internazionale della Fiat Freemont per un festival promozionale dedicato (https://vimeo.com/127202381).
Su questa linea si va sviluppando la serie di camere sferiche, piccole e spesso economiche, dai nomi evocativi (BublBublcam, Panono, KodakSP360, Giropctic360Cam, Google Jump, VirtualMindReal ecc.), che riprendono, appunto, a trecentosessanta gradi. Sono modelli diversi, anche di fascia alta o per usi professionali e militari, ma tutti eliminano di fatto l’inquadratura classica. Da sottolineare che anche in questo caso sembra ritornare il precinema con i dispositivi stereoscopici come il Panorama di Barker (1788) e il Kaiserpanorama di Fuhrmann (1880). Nota Jaime D’Alessandro: «Il futuro della narrazione visiva ha una forma curiosa. È una sfera costellata da bulbi vitrei, che tanto ricorda il remoto d’addestramento con il quale Luke Skywalker veniva iniziato alla via della forza sull’astronave di un contrabbandiere nel primo “Star Wars”. Per diventare cavalieri serve a poco in realtà, ma è perfetta per cercare contenuti a trecentosessanta gradi, poco importa che si tratti di un documentario, serie tv, film. Niente più inquadratura: per seguire il protagonista si muove lo smartphone, oppure il cursore del mouse o ancora la testa quando si indossano degli occhiali per la realtà virtuale» (“La Repubblica”, 15 agosto 2015).
Tutti questi dispositivi tecnologici, dotati di nuovi “occhi”, piccoli, rigidi o deformanti che siano, possono far scaturire opere con linguaggi e stili nuovi, in modo simile a quanto avvenuto in passato con macchine o formati non convenzionali, almeno parzialmente poiché lo standard di riferimento rimaneva comunque quello cinematografico corrente. Si pensi al 16mm e poi all’8mm o alla pellicola in super16mm, alla base della Nouvelle Vague e del “cinéma direct”, fino al Portapak della Sony nel 1967, videoregistratore/videocamera portatile all’origine di tanti documentari del cinema americano nonché della “guerrilla television” e della stessa videoarte. Oppure si pensi a quello straordinario pioniere intermediale che è stato Chris Marker, fino a “Level Five” (1997), realizzato con le immagini elaborate dal computer e un videogioco. Dunque con i nuovi “occhi” cinefotografici a disposizione è proprio il caso di dire: staremo a vedere!
Elio Girlanda
.
.
VISTI DA LONTANO
TARKOVSKIJ E LA NOSTALGIA DI UN’ARMONIA ASSOLUTA
di Andreina Sirena
Penultimo film di Andrey Tarkovskij, scritto insieme al poeta italiano Tonino Guerra. E’ la storia di Gortčakov, un poeta russo che giunge in Italia per indagare sul passato culturale di Pavel Sasnowskj, compositore del XVIII secolo. Giunto in Toscana, il poeta si imbatte in Domenico, chiamato ‘il matto’, il quale dichiara che il mondo sta per finire e che per salvarlo bisogna compiere un singolare rito. Gortčakov decide di andare a fondo al senso di questa profezia.
Girato in luoghi d’Italia estremamente suggestivi come Monterchi (dove è custodita la Madonna del Parto di Piero Della Francesca), l’Abbazia di San Galgano, Bagno Vignoni, la Val d’Orcia e la piazza del Campidoglio a Roma; cadenzato sulle note del Requiem di Verdi, acceso sul finale dalla potenza del coro della Nona di Beethoven, “Nostalghia” mostra come l’arte cinematografica possa attingere ovunque e arricchirsi di riferimenti culturali, dai simboli iconografici alle partiture musicali fino all’universo simbolico. I paesaggi appaiono pervasi da uno sfumato leonardesco, di vapori e nebbie che a sprazzi coprono o svelano il mistero della natura, dove il protagonista si muove costantemente su un pavimento d’acqua, accompagnato dal suono variabile di quest’ultima: uno scrosciare, rigare o stillare di gocce.. “Nostalghia” non è solo il vuoto di un’assenza, il desiderio di un ritorno al luogo d’origine, il richiamo all’inesorabile legame materno, ma un anelito assoluto all’unità primordiale di tutte le cose, simboleggiato dal continuo scorrere dell’acqua, dalla miriade di gocce che formano un solo flusso, un’unica corrente. Con quell’enigmatico 1+1=1 affisso nella parete grondante della dimora del matto (e citato anche in “Deserto rosso” di Antonioni), Tarkovskij definisce il suo ‘Ut Omnia unum sint’. Perché ‘una goccia insieme ad un’altra goccia non fanno due gocce ma una più grande’. Così le bottiglie a terra che raccolgono l’acqua diventano il tentativo di preservare una memoria, di trattenere l’incessante scorrere del tempo; ma questo conservare, voler imbottigliare la corrente della vita non fa che creare divisioni all’interno dell’ esistenza stessa, su ciò che la natura ha reso unito. Il tempo trascorre e l’uomo tenta di possedere il tempo, trattenere la vita e i giorni che si inseguono con i luoghi di un tempo e l’immagine infantile che non è più. Forse così si può interpretare il monito di Dio a Santa Caterina raccontato da Domenico: ‘Tu sei quella che non è, io invece Colui che sono’. Tutto muta in continuazione e viene disfatto, noi non siamo se non in un’unità più grande in grado di restituirci una identità. Dalle prime frasi pronunciate dal poeta russo all’inizio del film, in apparenza sconnesse e slegate, si fa avanti l’idea di un mondo nuovo (‘Voi non sapete nulla della Russia. Bisogna distruggere le frontiere dello Stato’). L’affinità che non trova con la sua traduttrice (interpretata da una metafisica Domiziana Giordano) nasce proprio con colui che è escluso dalla comunità: il matto del villaggio che ha tenuto chiusa la sua famiglia per sette anni. Sarà lui a dirgli che bisogna avere delle idee più grandi (‘prima ero egoista, volevo salvare la mia famiglia, ma bisogna salvare tutto il mondo intero’) e di celebrare un rito che da anni non riesce a portare a termine: attraversare la piscina di Santa Caterina con la candela accesa, per salvare l’umanità. Entrambi i personaggi compiono un sacrificio per la salvezza di tutti. Finiscono con l’identificarsi. Diventano la stessa persona o forse smettendo di esserlo, perdendo l’identità personale e smarrendosi in una più ampia. Si spegneranno contemporaneamente, l’uno ardendosi e l’altro percorrendo la piscina con l’esile cero acceso. Il poeta dovrà compiere il rituale tre volte per ottenere che la fiamma non si spenga nonostante il vapore dell’acqua. Una sorta di lotta fra gli opposti per conservare e preservare la luce. Prima di compiere il gesto sacrificale nella piazza del Campidoglio a Roma, Domenico pronuncerà queste parole: “Il nostro cuore è coperto d’ombra, bisogna ascoltare le voci che sembrano inutili. […]Bisogna alimentare il desiderio, dobbiamo tirare l’anima da tutte le parti come se fosse un lenzuolo dilatabile all’infinito.
Se volete che il mondo vada avanti, dobbiamo tenerci per mano, ci dobbiamo mescolare, i cosiddetti sani e i cosiddetti ammalati.
Ehi, voi sani!
Cosa significa la vostra salute? […]
Dove sono, quando non sono nella realtà e neanche nella mia immaginazione? Faccio un nuovo patto con il mondo, che ci sia il sole di notte e nevichi d’agosto.
Le cose grandi, finiscono!
Sono quelle piccole che durano!
La società deve tornare unita e non così frammentata; basterebbe osservare la natura per capire che la vita è semplice e che bisogna tornare al punto di prima, in quel punto, dove voi avete imboccato la strada sbagliata.
Bisogna tornare alle basi iniziali della vita, senza sporcare l’acqua.”
Mentre si toglie la vita, imperversa il coro della Nona di Beethoven, l’inno all’umanità unita nella luce della fratellanza (‘Deine Zauber binden wieder was die Mode streng geteilt, alle Menschen erden Brüder wo dein sanfter Flügel weilt. Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt!’I tuoi incantesimi tornano a legare ciò che la moda ha severamente diviso; tutti gli uomini divengono fratelli dove la tua dolce ala si posa. Abbracciatevi, moltitudini! Un bacio al mondo intero!). Il discorso sull’unità va a frapporsi con il medesimo intento espresso dall’ode schilleriana, in una sorta di dottrina delle corrispondenze, tanto cara al cinema di Tarkovskij. Intanto il poeta si spegne nelle note del Requiem verdiano, in quella strofa straziante che pronuncia ‘et lux perpetua luceat eis’. Il matto brucia innanzi al mondo la sua identità. Il poeta muore tentando di consegnare la luce al mondo. Il cerchio si chiude. Tutto diviene ordinato. Ogni cosa si accorda con l’altra, senza più contraddizioni. Il paesaggio della sua infanzia in Russia, con la casa materna, la pozza d’acqua e il cane, sono accolti dentro l’ampia e solenne struttura di San Galgano in Toscana. Il luogo d’origine e il luogo d’esilio si uniscono per sempre, l’uno dentro l’altro, come due gocce che si legano diventando una più grande. La morte segna un ridestarsi in una nuova e desiderata armonia, che vede l’infanzia nella cornice della maturità, in una linearità che mette insieme ciò che la vita aveva tenuto separato nel narcisismo o nel confronto agonistico tra sé e gli altri. Il film inizia con il rito propiziatorio della Madonna del Parto (in una scena immaginifica che vede uno stormo di rondini scaturire dal ventre della Vergine) e termina con la morte, inizia con una cantilena infantile (una ninnananna russa) che diventa un requiem (quello di Verdi), termina nuovamente con quest’ultimo che va a sfumare con la nenia di partenza. Tutto è connesso in una grandiosa visione olistica. Il punto di partenza diventa quello finale e viceversa. La stessa armonia si riflette sull’intersecazione degli spazi temporali. Il regista alterna il colore del presente al bianco e nero dei ricordi d’infanzia, frapponendo le due dimensioni, fino a confonderle. Nella stanza d’albergo di Gortčakov in Toscana, il tempo e lo spazio si dilatano, popolandosi di immagini recondite: il cane dell’infanzia, la madre gravida, la visione della casa natale, del mondo contadino perduto. In “Nostalghia” che precede e prepara “Sacrificio”, Tarkovskij ci regala una delle pagine più intense e più complesse del cinema russo, dove ogni elemento naturale, ogni personaggio, ogni animale, ogni oggetto, ogni frase, rivestono una cifra simbolica, e ogni singolo fotogramma è sospeso in una transazione continua tra il fugace e l’Eterno.
QUALITA’ IN SERIE
a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
1992
 Regia: Giuseppe Gagliardi
Regia: Giuseppe Gagliardi
Sceneggiatura: Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo
Interpreti:Stefano Accorsi, Alessandro Roja, Miriam Leone, Guido Caprino, Tea Falco, Domenico Diele, Pietro Ragusa, Silvia Degrandi, Elena Radonicich, Tommaso Ragno, Irene Casagrande, Antonio Gerardi
Produzione: Wildside
Durata: 600 min. ca.
Numero episodi: 10.
Italia 2015.
Stimolata forse dalla notevole qualità di un numero sempre più elevato di serie televisive statunitensi e non anche la produzione televisiva italiana (con il sostanziale apporto economico della pay tv Sky) è entrata nell’arena e si è conquistata una posizione ragguardevole. Basta pensare a “Romanzo criminale” e a “Gomorra” (le serie ovviamente non i film) per rendersene conto. Il compito che attendeva però la Wildside (che si era già fatta le ossa in particolare con l’apprezzato remake italiano della serie israeloamericana “In Treatment”) in questa occasione era decisamente più arduo. Perché se le due opere citate trattavano temi scottanti e legati alla realtà socioeconomica e politica di decenni di storia italiana qui il focus era decisamente più legato a un anno che è stato decisivo per l’Italia e i cui protagonisti sono fissati con precisione nella memoria di chi abbia più di 40 anni. Come mettere in scena l’operazione denominata Mani Pulite, come raccontare quell’anno di profondi rivolgimenti andando oltre la ricostruzione documentaristica e attraendo anche chi in quell’anno non era ancora nato o era bambino? Qui stava il problema.
L’idea della serie è di chi poi si è caricato del ruolo più ambiguo ma anche più illuminante: Stefano Accorsi. L’attore ha intuito il potenziale attrattivo che poteva avere la descrizione, non solo della ‘Milano da bere’ ma del sistema nel suo complesso nonché di una Roma che stava costruendo quella decadenza che Paolo Sorrentino ha raccontato ne “La grande bellezza”.
La scelta narrativa operata dai tre più che validi sceneggiatori è stata quella di mescolare vicende e personaggi della cronaca e della storia reale (con tanto di datazioni a segnalarne lo sviluppo cronologico) con personaggi di finzione. Tanto da decidere di tutelarsi con una didascalia di apertura che invita a distinguere i personaggi reali da quelli di fantasia senza cercare di attribuire a quelli inventati identità riconoscibili. Da questa opzione deriva una struttura narrativa coraggiosa che utilizza il meglio della fiction non dimenticando mai però di tornare a fare riferimento puntuale a quanto accaduto.
Per chi voglia rinfrescare la memoria in relazione a quegli avvenimenti può risultare utile questo link: https://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite
“1992” non rinuncia a fare uso di materiale documentario dell’epoca ma lo tratta come elemento aggiuntivo facendo dei telegiornali la finestra su avvenimenti che si intersecano con le indagini come ad esempio le uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ci sono Antonio Di Pietro (interpretato con ruvida efficacia da Antonio Gerardi) e un occhiuto ma non sempre intuitivo Marcello Dell’Utri (interpretato con grande adesione anche fisiognomica da Fabrizio Contri) e così via. I ‘motori’ dell’azione sono però i personaggi di invenzione che finiscono con il rappresentare gli aspetti più ambigui e oscuri di un’Italia in disfacimento.
Descriviamo i più importanti.
Leonardo Notte (Stefano Accorsi)
 E’ un importante creativo pubblicitario che ha alle spalle una militanza nei gruppi extraparlamentari di sinistra e la morte di una giovane donna per la quale viene ricattato. Notte diventa l’emblema dell’amoralità della Milano da bere su una molteplicità di piani e funge anche da interessante occasione di riflessione su una generazione di padri e sul frutto del loro esempio sui figli (in questo caso l’adolescente Viola che resta a vivere con lui per alcuni mesi). Notte però ha un grande senso del marketing e individua, nonostante lo scetticismo di molti, in Silvio Berlusconi colui che potrà trarre vantaggio dallo sconvolgimento creato dall’inchiesta.
E’ un importante creativo pubblicitario che ha alle spalle una militanza nei gruppi extraparlamentari di sinistra e la morte di una giovane donna per la quale viene ricattato. Notte diventa l’emblema dell’amoralità della Milano da bere su una molteplicità di piani e funge anche da interessante occasione di riflessione su una generazione di padri e sul frutto del loro esempio sui figli (in questo caso l’adolescente Viola che resta a vivere con lui per alcuni mesi). Notte però ha un grande senso del marketing e individua, nonostante lo scetticismo di molti, in Silvio Berlusconi colui che potrà trarre vantaggio dallo sconvolgimento creato dall’inchiesta.
.
.
Pietro Bosco (Pietro Caprino).
 Soldato nella Guerra del Golfo, giocatore di rugby, di bassa estrazione culturale incappa nella Lega Nord e viene eletto al Parlamento. Qui sarà costretto ad accorgersi della realtà degli intrighi e della difficoltà di far trionfare la verità, seppure in modo naif, quando a prevalere sono gli interessi di una parte o dell’altra.
Soldato nella Guerra del Golfo, giocatore di rugby, di bassa estrazione culturale incappa nella Lega Nord e viene eletto al Parlamento. Qui sarà costretto ad accorgersi della realtà degli intrighi e della difficoltà di far trionfare la verità, seppure in modo naif, quando a prevalere sono gli interessi di una parte o dell’altra.
.
.
.
.
.
Veronica Castello (Miriam Leone).
 Una giovane e avvenente ragazza che vuole ad ogni costo sfondare nel mondo dello spettacolo televisivo. Il costo è accompagnarsi ad uomini che non ama ma che possono farla entrare in quel mondo. Il personaggio diviene così un concentrato di aspettative prive di un fondamento professionale rappresentando uno spaccato molto vicino alla realtà di quegli anni (e forse non solo).
Una giovane e avvenente ragazza che vuole ad ogni costo sfondare nel mondo dello spettacolo televisivo. Il costo è accompagnarsi ad uomini che non ama ma che possono farla entrare in quel mondo. Il personaggio diviene così un concentrato di aspettative prive di un fondamento professionale rappresentando uno spaccato molto vicino alla realtà di quegli anni (e forse non solo).
.
.
.
.
.
.
Beatrice “Bibi”Mainaghi (Tea Falco).
 E’ la figlia di un industriale coinvolto nell’indagine che si trova, dopo la morte del padre a dover gestire l’azienda cercando di tenere nascosto un illecito traffico di sangue infetto. L’interpretazione monocorde (a tratti al limite del catatonico) di Tea Falco non aiuta lo sviluppo del personaggio anche se a tratti offre allo spettatore la sensazione che Bibi cerchi di restare letteralmente fuori da un mondo che intuisce come troppo corrotto.
E’ la figlia di un industriale coinvolto nell’indagine che si trova, dopo la morte del padre a dover gestire l’azienda cercando di tenere nascosto un illecito traffico di sangue infetto. L’interpretazione monocorde (a tratti al limite del catatonico) di Tea Falco non aiuta lo sviluppo del personaggio anche se a tratti offre allo spettatore la sensazione che Bibi cerchi di restare letteralmente fuori da un mondo che intuisce come troppo corrotto.
.
.
.
.
.
.
Luca Pastore (Domenico Diele)
 E’ un poliziotto che lavora nel team di Mani Pulite ma che è al contempo ossessionato dal desiderio di punire l’industriale Mainaghi essendo rimasto contagiato da una trasfusione di sangue infetto contrabbandato da una delle aziende del gruppo facente capo all’imprenditore. Questo personaggio si rivela utile per allargare il campo di osservazione anche ad altre realtà di malaffare che andavano oltre l’oggetto dell’inchiesta.
E’ un poliziotto che lavora nel team di Mani Pulite ma che è al contempo ossessionato dal desiderio di punire l’industriale Mainaghi essendo rimasto contagiato da una trasfusione di sangue infetto contrabbandato da una delle aziende del gruppo facente capo all’imprenditore. Questo personaggio si rivela utile per allargare il campo di osservazione anche ad altre realtà di malaffare che andavano oltre l’oggetto dell’inchiesta.
Essendo coprodotta da “La7” la serie vedrà una sua diffusione anche su quella rete (dopo essere stata trasmessa con un buon esito di ascolti su Sky Atlantic). Ci sarà così occasione per un più ampio confronto su un modo di fare memoria su un passato non poi così lontano ma che a tratti, se confrontato con quanto accaduto successivamente, può sembrare distante anni luce. Può anche consentire riflessioni su ‘chi diceva cosa’ allora e su come la situazione sia cambiata. In meglio o in peggio? La risposta spetta ad ognuno di noi.
Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
.
.
PANORAMA LIBRI
a cura di Paolo Micalizzi
TRE LIBRI DI GIACOMO GAMBETTI
Film e ricordi. Il mio Neorealismo
Edit Faenza, 2010- pagg. 172, Euro 22,50
Più di 100 ricordi-ritratti cinematografici pubblici e (a volte)
privati raccolti in decenni di lavoro
Edit Faenza 2010- pagg.189, Euro 25,00
Breve storia del cinema ungherese, autori e opere
Edit Faenza 2010- pagg. 129, Euro 25,00
Tre volumi di Giacomo Gambetti, critico cinematografico di vaglia che è stato anche dirigente Rai e Direttore della Biennale di Venezia. Alla sua attività di scrittore, in cui figurano volumi importanti su Zavattini e Gassman, si aggiungono adesso queste ultime opere ,frutto della sua esperienza di critico attento a tutti gli aspetti del cinema. Nella prefazione a “Film e ricordi. Il mio Neorealismo”, Francesco Maselli che lo ebbe collaboratore scrive che Giacomo Gambetti era un intellettuale che dal 1945 a oggi è stato al servizio di un’idea dell’arte e della cultura come punto essenziale di un processo di rinnovamento morale e sociale che possiamo definire a tutti gli effetti e nel senso più alto ‘nuovo umanesimo’”. Ricordando ancora come all’interno della Biennale riformata Giacomo Gambetti, in una situazione difficile per tutti, mantenne una coerenza e un’energia indimenticabili” In questo volume Giacomo Gambetti ripercorre sulla base dei suoi ricordi e della riflessione a quell’esperienza cosi fondamentale data da film del periodo di guerra. Ricordi personali che per lui hanno un grande significato “di fronte a ogni tipo di avvenimento, di fronte a ogni circostanza della vita”. Tanti i personaggi che rivivono in questo libro di Gambetti, ma altri riemergono in ”Più di 100 ricordi-ritratti cinematografici e( a volte) privati raccolti in decenni di lavoro”. Appunti, come lui avverte nell’introduzione, anche se circostanziati, attorno ad alcuni incontri, a vario titolo, nel campo del cinema, nell’ambito di oltre sessant’anni di lavoro. E sono appunti su registi, attori, critici, personalità della cultura che rivivono attraverso i ricordi dell’autor, facendo rivivere a chi scrive personaggi incontrati che sono stati importanti per la sua formazione nel cinema. Nel terzo volume, una cavalcata nel cinema ungherese basata sull’esperienza dell’autore che ne mette in evidenza, per informazione e conoscenza diretta, alcuni autori. Una proposta la sua, volta a stimolare critica e spettatori italiani ad un impegno di vero approfondimento. Un quadro non completo, come sottolinea, “ per virtù sia delle carenze di mercato sia di notevoli difficoltà pratiche”. Ne scaturisce una “breve storia del cinema ungherese”, come indica il titolo del volume, con profili di autori noti e meno noti che portano alla conoscenza di una cinematografia che ha un notevole rilievo nella Storia del Cinema.
 IL CINEMA DI GIORGIO PÀSTINA
IL CINEMA DI GIORGIO PÀSTINA
( a cura di Vito Attolini)
Edizioni dal Sud, 2014, pagg. 191, Euro 15,00
Giorgio Pàstina è, secondo la definizione di Tullio Kezich, uno dei “militi ignoti” del cinema italiano, che hanno avuto un’attività artigianale di tutto rispetto nutrendo il nostro cinema, negli anni 40-50, di commedie e opere di carattere popolare. Vito Attolini ne recupera la memoria riportando alla luce l’attività di questo regista e sceneggiatore di origine pugliese svolta per poco più di un decennio(1943-1955). Un’attività nata come sceneggiatore attingendo i suoi film più significativi dalla letteratura, soprattutto quella del tardo ottocento. Sceneggiature su commissione per film diretti da alri che sono state, come scrive Attolini, una sorta di apprendistato al suo lavoro dietro la macchina da presa. La sua prima sceneggiatura è stata scritta per il film “Fedora” di Camillo Mastrocinque, tratto dal dramma di Victorien Sardou. Era il 1942, anno di intenso lavoro per Giorgio Pàstina che ne scrisse altre due, sempre per Mastrocinque. Poi, nel 1943, il passaggio alla regia con “Enrico IV”, dal dramma di Luigi Pirandello, interpretato da Osvaldo Valenti e Clara Calamai non abbandonando però l’attività di sceneggiatore. Vito Attolini dà conto anche di alcuni film non realizzati. Un cinema, il suo, più attento al cinema calligrafico che al neorealismo. Da annoverare anche alcuni film che comprendono una piccola galleria di ritratti femminili costituendo una tetralogia relativa a donne in drammatici conflitti con le leggi non scritte della società, dal potere condizionante. Ma anche commedie, poiché Pàstina tendeva ad esperienze in più generi. Poi una tetralogia napoletana, spinto anche da esigenze puramente “alimentari”, che costituisce la sua ultima produzione. Un’attenzione alle opere di Giorgio Pàstina quella di Vito Attolini, che viene approfondita poi con saggi di altri critici che ne mettono a punto altri aspetti significativi del suo cinema. Il volume è completato da un’ampia filmografia corredata da recensioni dell’epoca e da immagini di locandine di film da lui diretti.
 NUOVO CINEMA IN TURCHIA.
NUOVO CINEMA IN TURCHIA.
NURI BILGE CEYLAN E GLI ALTRI AUTORI
di Giovanni Ottone
Edizioni Falsopiano,2015,pagg. 165, Euro 18,00
Si tratta di uno studio critico sistematico, il primo pubblicato in Italia, sul cinema d’autore di questa realtà che è, secondo l’autore, una delle più interessanti a livello mondiale: Giovanni Ottone ne analizza caratteristiche, protagonisti, topoi e stili. Perché occuparsi del cinema turco, lo precisa Giovanni Spagnoletti nella prefazione al libro. E lo spiega ricordando i successi ottenuti negli ultimi dieci anni in Festival di assoluto prestigio, in primis quello di Cannes dove l’autore più prestigioso Nuri Bilge Ceylan, di cui nel libro si occupa ampiamente Ottone, è stato presente ben tre volte n Concorso e nel 2014 ha vinto la Palma d’Oro con “Il regno d’inverno”. Poi Semih Kaplanoglu vincitore con “Bal” dell’Orso d’Oro alla Berlinale del 2010 , Yesim Ustaglu la Concha de Oro con “Pandora’s Box” al Festival di San Sebastian del 2008 e lo scrittore- regista Tayfun Pirselimoglu, autore al quale la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro 2015 ha dedicato una retrospettiva, che ha vinto nel 2013 con “I am Not Him” alcuni festival. Un brillante medagliere nell’ultimo quinquennio, precisa Spagnoletti, che pochi possono vantare. Il cinema turco, riferisce Giovanni Ottone, ha realizzato dal 1914 fino al 2014, in cui ha festeggiato il suo centenario di vita, circa 6.300 lungometraggi. Un’ottima occasione questo libro per ripercorrerne l’ultima produzione.
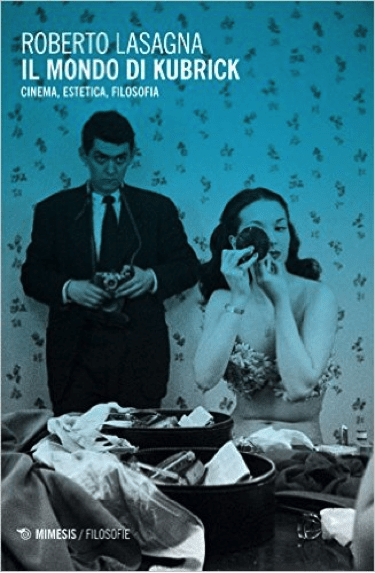 IL MONDO DI KUBRICK. CINEMA, ESTETICA, FILOSOFIA
IL MONDO DI KUBRICK. CINEMA, ESTETICA, FILOSOFIA
di Roberto Lasagna
Mimesis/Filosofie-2014,pagg.174,Euro 16,00
Roberto Lasagna, che è anche prestigioso collaboratore di questa Rivista s’immerge, e ci immerge, nell’universo Kubrickiano analizzandone alcuni aspetti essenziali. Un lavoro che fa seguito al precedente volume “I film di Stanley Kubrick”, scritto insieme a Saverio Zumbo. In questo, il cinema di Kubrick è affrontato con uno sguardo rivolto soprattutto all’estetica e alla filosofia. Per Roberto Lasagna, Kubrick è “un cineasta filosofo, un rabdomante della visione calato nella vertigine delle più angoscianti domande”. E nel suo cinema il pensiero viene accolto e reso figuralità attraverso una messa in forma originalissima, dove il lavoro dei migliori collaboratori confluisce in una partitura sorvegliata e complessa. E, secondo Lasagna, vale per lui la definizione di” cineasta totale e illuminato, che persegue un disegno d’autore all’interno dell’industria culturale in cui si muove come un caso esemplare piuttosto che come una variante eccentrica”. Sono alcune considerazioni di un’ampia analisi in sei capitoli densi di riflessione su aspetti significativi del cinema di questo grande Maestro
.
.
.
.
 IL CINEMA E LA MATEMATICA
IL CINEMA E LA MATEMATICA
Recensione di Maurizio Villani
Stefano Beccastrini, Maria Paola Nannicini,
Erickson, 2010 Trento.
È un’associazione inconsueta quella tra cinema e matematica, cui è dedicato il libro di Stefano Beccastrini e Maria Paola Nannicini, che si intitola appunto Il cinema e la matematica. Sulle tracce di una promettente amicizia, edito in una collana di Strumenti per la didattica della matematica, diretta da Bruno D’Amore (Prefazioni di Bruono D’amore e Martha Isabel Fandigño Pinilla e di Massimo Maisetti). Si tratta di uno studio ampio e documentato che intende mostrare come «lo sviluppo linguistico-tecnologico del cinema è strettamente connesso alla matematica» e come «queste due culture apparentemente distanti possano non solo convivere ma anche diventare fonte di reciproci scambi». C’è una famosa frase di Galileo, citata più di una volta nel libro, che guida questa interpretazione multidisciplinare sottesa alle analisi critiche delle opere cinematografiche: è il passo del Saggiatore in cui si legge che «l’universo (…) è scritto in lingua matematica». Sia la matematica sia il cinema sono, dunque, linguaggi, con diversità e affinità, entrambi votati alla raffigurazione del mondo. Fa eco a questa affermazione galileiana una notazione di Peter Greenaway che, parlando del suo fare cinema, scrive: «I numeri aiutano, possono significare strutture definibili, facilmente comprensibili in tutto il mondo» ( pag. 55). Il libro è strutturato in cinque parti e venti capitoli. Ogni parte affronta una tematica particolare: nella prima parte si prende in esame quanto la matematica abbia contribuito alle origini e allo sviluppo storico del cinema; nella seconda viene analizzata la presenza dei numeri nei film; segue poi la terza parte, dedicata ai modi con cui il cinema ha mostrato la matematica (dagli aspetti disciplinari alle biografie dei matematici); le ultime due parti trattano rispettivamente del rapporto tra il cinema e la storia della matematica e del tema, squisitamente didattico, «di come il cinema abbia affrontato le questioni e le situazioni relative all’insegnamento della matematica nella scuola, e a tutti i suoi livelli, università compresa». Quale sia stato l’impegno degli autori in questa loro ricostruzione storico-critica del rapporto cinema-matematica è attestato dall’indice analitico dei film citati nel libro: si tratta di ben 253 titoli. Per il suo carattere trasversale il libro si propone all’attenzione sia degli studiosi di cinema, sia di chi si occupa di matematica e di didattica di questa disciplina.
.
.
Credits n.6
Carte di Cinema
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: cartedicinema@hotmail.com
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi
Direttore editoriale: Roberto Merlino
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 6 dalla rivista online: Mathias Balbi, Francesca Bernardi, Laura Biggi, Laura Cacciamani, Gianluca Castellini, Roberto Chiesi, Maria Pia Cinelli, Giulio D’Amicone, Elio Girlanda, Federico Govoni, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Roberto Merlino, Paolo Micalizzi, Andreina Sirena, Maurizio Villani, Giancarlo Zappoli.