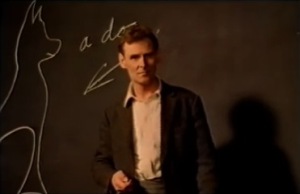Cambio di Direttore alla Rivista
Con questo numero lascio la direzione della rivista a causa di impegni di insegnamento che richiedono più tempo che in passato. La lascio non in buone mani bensì in ottime. Paolo Micalizzi, che assume la direzione, non è solo un giornalista, critico e scrittore di grande qualità ma è stato direttore di festival dei cinema ed è anche, dote non secondaria, uno scrupoloso organizzatore.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla rivista in questi anni consentendole di ritagliarsi uno spazio ben preciso nel panorama della critica cinematografica che l’ha portata nel 2011 a ricevere alla 20^ edizione del Premio Meccoli il riconoscimento quale miglior periodico specializzato.
Giancarlo Zappoli
Un grazie, di cuore e sentito, all’amico Giancarlo, che ha diretto la nostra Rivista con intelligenza, competenza e spirito innovativo. Ci tranquillizza il fatto che, ad ogni buon conto, Giancarlo continuerà ad essere presente e non ci farà mancare il suo aiuto e la sua esperienza. Piena fiducia a Paolo che, ne siamo certi, saprà mantenere alto il livello qualitativo di “Carte di Cinema”.
Roberto Merlino
Presidente FEDIC
Sommario
- 1 SAGGI
- 2 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 3 FESTIVAL
- 3.1 ANNECY 2014 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM D’ANIMAZIONE. UN FESTIVAL CHE VOLA.
- 3.2 67° FESTIVAL DEL FILM LOCARNO. UN FESTIVAL CHE SI RINNOVA CONSERVANDO LA PROPRIA IDENTITÀ.
- 3.3 71° MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
- 3.3.1 UNA MOSTRA CON FILM DI QUALITA’ ED UN’IMPORTANTE PRESENZA ITALIANA
- 3.3.2 HIGHLIGHTS DA VENEZIA
- 3.3.2.1 Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) di Alejandro González Iňárritu.
- 3.3.2.2 One on One di Kim Ki-Duk
- 3.3.2.3 The Look of Silence di Joshua Oppenheimer.
- 3.3.2.4 Im Keller di Ulrich Seidl
- 3.3.2.5 Ich sehe, ich sehe (Goodnight Mommy) di Veronika Franz
- 3.3.2.6 Dio è negli occhi di chi guarda
- 3.3.3 VENEZIA ORIZZONTI
- 3.4 LA RISCOPERTA DEL CINEMA D’ANIMAZIONE DI LIBERIO PENSUTI NEI 50 ANNI DELLA MOSTRA DI PESARO
- 3.5 CHAPLIN ILLUMINA LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO
- 4 VISTI DA LONTANO
SAGGI
RODOLFO VALENTINO: VITA E MORTE DI UN MITO DEL CINEMA
di Ivana Baldassarri
 Rodolfo Guglielmi era stato un gracile bambino pugliese di Castellaneta deriso dai suoi coetanei per le orecchie a punta e gli occhi strabici: era quello che si dice uno scricciolo scuro e poco socievole che sua madre Gabrielle Marie Bardin, una francesina dolce e affettuosissima, consolava con canzoni e carezze.
Rodolfo Guglielmi era stato un gracile bambino pugliese di Castellaneta deriso dai suoi coetanei per le orecchie a punta e gli occhi strabici: era quello che si dice uno scricciolo scuro e poco socievole che sua madre Gabrielle Marie Bardin, una francesina dolce e affettuosissima, consolava con canzoni e carezze.
Suo padre Giovanni, veterinario di Castellaneta, ex capitano di cavalleria e appassionato di araldica, aveva deciso di avere ascendenze nobili e aveva aggiunto al cognome di Guglielmi l’altisonante titolo di Valentina d’Antonguella.
Vivevano in una bella e grande casa circondata da tanta terra fertile, una serena vita di proprietari terrieri.
Ma poco dopo il trasferimento a Taranto, Giovanni Guglielmi muore prematuramente vittima dei suoi studi sulla malaria del bestiame, lasciando la sua numerosa famiglia (i Guglielmi hanno tre figli, Alberto, Maria e il piccolo Rodolfo) in gravi difficoltà dato che i loro possedimenti sono in comproprietà con i fratelli di Giovanni, tanto che Rodolfo fu mandato nel collegio dell’”Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani” di Perugia dove rimase per tre anni. Rodolfo continuava ad essere un ragazzino ancor più bruttarello e indisciplinato: soffriva la mancanza delle cure affettuose della sua dolce mamma lontana, l’unica a comprendere la sua esasperata sensibilità che lo rendeva insofferente e insicuro.
Nel 1909 a 14 anni Rodolfo Guglielmi tenta di entrare nel Collegio Navale Morosini di Venezia, ma viene scartato per l’insufficiente circonferenza toracica e per la debolezza della sua vista. Questa esclusione costituisce una cocente delusione per i sogni e i progetti del giovane. Venendo da famiglia di possidenti agricoli Rodolfo accetta di studiare agraria nel “Regio Istituto Sant’Ilario” di Nervi dove si diploma con onore, deciso a dedicarsi agli interessi di famiglia.
Nonostante questa assunzione seria e sincera di responsabilità il ragazzo chiede ed ottiene dalla famiglia un periodo di vacanza a Parigi quasi per proiettare, in una esperienza insolita e ambiziosa, un sogno segreto che lo avvicina ancora di più a sua madre che parigina si sente ancora.
A 17 anni, accompagnato da mille consigli e commosse benedizioni materne, Rodolfo parte: sul treno che lo condurrà verso l’entusiasmante avventura parigina il ragazzo percepisce per la prima volta la lontananza e la vastità geografica del mondo.
Assieme all’emozione, al respiro esaltante della libertà, l’insicurezza da “brutto anatroccolo” e il timore di non saper fronteggiare quella improvvisa e tanto bramata realtà.
Sarà un’avventura travolgente!
Eccola Parigi, La “Ville Lumiere” romantica, diabolica, tentatrice, ecco la città dei sogni e dei peccati, dell’amore e dello champagne!
“Qui c’è vita” si ripete Rodolfo pensando alla claustrofobica situazione da profondo sud del suo paese! Tutto lo seduce, i palazzi, le strade, le luci, i locali notturni, la gente, il suono melodioso della lingua che gli ricorda continuamente la voce dolce di sua madre: per giorni rimane come in trance, stordito, inebriato, felice!
Poi l’amicizia con Paul Duval un parigino disinvolto, frequentatore abituale di locali notturni alla moda. Duval lo accompagna al Café Anglais e alle Folies Bérgères dove si balla e si fa amicizia con splendide soubrettes.
È facile, quasi naturale partecipare alle danze: prima come timido neofita poi come richiestissimo ballerino. Il tango lo ammalia: il ragazzo sente che seguendo quel ritmo carnale e travolgente potrebbe trovare la forza di esprimere quella sua celata passionalità che lo turba, lo esalta e spesso lo travolge.
Ma ha anche chiara la sua situazione incerta e pericolosa: sa che i soldi sono pochi e stanno per finire e presto dovrà tornare a casa dove lo zio Giuseppe ricomincerà a rimproverarlo con durezza. Lasciando Parigi sente però che qualcosa in lui è cambiato e non sa cosa, forse ha acquistato la capacità di sognare.
In casa circola la storia di un paesano tal Domenico Savino musicista e compositore che aveva lasciato le Puglie e l’Italia ed era emigrato in America al seguito del tenore Tito Schipa, facendo fortuna.
Rodolfo comincia a rimuginare su Domenico Savino come fa un prigioniero esaltato, pensando alla libertà. Savino diventa così metafora di libertà e di successo.
Il Nuovo Mondo, l’America sconfinata e generosa, dove tutto è possibile, dove la gente non ristagna nell’unico bar di paese a scambiarsi maldicenze, ma mette a frutto le proprie potenzialità diventando qualcuno!
Giorno per giorno Rodolfo si convince che l’America è la sua vera meta: pensa anche, fantasticando, di diventare un proprietario terriero come lo sono i Guglielmi, ma in America dove tutto è grande e dove tutto si può espandere e ciascuno può diventare ricco e felice!
Suo zio Giuseppe, che si sente responsabile di quel nipote difficile e sognatore, appoggia il folle progetto americano di Rodolfo, pensando così, spregiudicatamente, di liberarsi di lui. Convince perfino la dolce Marie Gabrielle, che non vede di buon occhio l’avventura americana di suo figlio, di farlo partire con tutto il gruzzolo (4000 dollari col cambio americano) dell’eredità di suo padre.
La mattina del 9 dicembre 1913, quando al porto di Napoli la sirena urla ripetutamente la partenza della nave, il distacco è dolorosissimo: con in tasca il biglietto di 1° classe ed elegantemente vestito il 18nne ragazzo di Castellaneta stringe forte sua madre in lacrime:
“Ti voglio bene” le dice, “Addio mon cheri” balbetta sua madre.
Rodolfo arriva a New York il 23 dicembre in piena rutilante atmosfera natalizia frastornato e felice.
Nei primi tempi non bada a spese: frequenta costosi ristoranti e locali notturni alla moda, sfoggia il suo guardaroba italiano e fa amicizie importanti, come quella con il Conte Alex Salm, un viveur europeo, che lo introduce nella vita mondana notturna.
“Così, tu saresti un bravo ballerino di tango!?” gli chiede una sera il Conte con aria canzonatoria
“Ho imparato a muovermi un po’ a Parigi, ma forse non sono un gran che” gli risponde Rodolfo con umiltà.
“Ti metteremo alla prova!” insiste il Conte facendo cenno ad una ragazza del locale di ballare con il giovane italiano!
Quando lo vede volteggiare in pista sicuro, elegante e armonioso non gli nasconde complimenti e incoraggiamenti sinceri.
“Dovresti fare il ballerino di professione – preconizza il Conte – ci sai proprio fare col tango e mi sembra anche con le donne!”
Per tutto l’inverno 1914, illuso anche dal suo gruzzolo che pur si va assottigliando, Rodolfo vive alla grande: di sera i luoghi più esclusivi di New York danzando fino all’alba, ma di giorno frequenta biblioteche e musei e studia seriamente l’inglese e consulta libri di agricoltura, quasi per lasciarsi aperto quel progetto di coltivatore che lo lega ancora alla terra, alla madre e all’ Italia!
Ma finiti i soldi è costretto a pensare ad un lavoro vero, serio e remunerato: si impiega prima come giardiniere, poi custode al Central Park per finire poi sguattero in un ristorante e occasionale venditore di giornali. Rodolfo non riesce ad ingranare, è solo, senza soldi e senza speranze.
Finché un giorno mentre è sdraiato su una panchina di un parco pubblico di Manhattan, perché non ha altro luogo dove andare, un signore ben vestito passandogli vicino nota la sua faccia disperata e si ferma a parlare con lui.
È proprio con questa prodigiosa apparizione che ha inizio, come tutte le favole che si rispettano, la mitica vicenda americana di Rodolfo Valentino, il divo dei divi, l’uomo più desiderato del pianeta, la metafora di tutti i sogni femminili del suo tempo!
“Da dove vieni ragazzo?”
“Dalla Puglia” risponde Rodolfo
Per un povero ragazzo solo e disperato, il destino aveva scritto un avvio banale per preconizzare un futuro straordinario.
La leggenda e il mito si incaricheranno poi a tracciarne la prodigiosa, eccentrica e brevissima parabola.
Quel gentile signore è un italiano:
“Come ti chiami ragazzo?”
“Rodolfo Guglielmi” risponde
“Guglielmi? – si infervora il signore fulminato – ma i Guglielmi erano miei carissimi amici! Io sono Domenico Savino e anni fa sono venuto in America al seguito di Tito Schipa”
Verità e sogni, desideri e progetti, fatalità e mistero, tutto si confonde e si mescola, tutto si fissa e si svolge nell’imprevedibile gioco della vita.
Si abbracciano come due vecchi amici che si sono ritrovati:
“Ora stai tranquillo, andiamo a casa! Non sei più solo!”
Savino venuto a conoscenza della propensione di Rodolfo a ballare il tango, gli regala un tight e lo introduce come danzatore al Maxim. Diventa così “taxi-dancer”, guadagna bene e rimpolpa lo stipendio con le laute mance che le ricche signore gli lasciano.
Con eleganza e signorilità arricchita dal fascino esotico del suo aspetto latino, Rodolfo entra nella storia dello spettacolo attraverso il tango come ballerino a noleggio.
 “C’è un divino danzatore latino al Maxim che balla il tango in un modo paradisiaco”. La voce si sparge in città, le signore che frequentano il locale sono ricche e ingioiellate e la prospettiva di un tango con Rodolfo le stravolge e le eccita!
“C’è un divino danzatore latino al Maxim che balla il tango in un modo paradisiaco”. La voce si sparge in città, le signore che frequentano il locale sono ricche e ingioiellate e la prospettiva di un tango con Rodolfo le stravolge e le eccita!
Dopo il taxi-dancer, Rodolfo forma un duo con la ballerina Bonnie Glass con la quale si esibisce negli spettacoli di varietà col nome di Rudy di Valentina; in questa occasione conosce un personaggio che avrà una fondamentale importanza nella vita di Rodolfo, Norman Kerry, che con tetragono ottimismo e una forte dose di affettuosa insistenza lo convince a trasferirsi a Hollywood.
Norman Kerry è convinto che Rodolfo sia adatto al grande schermo: i tratti regolari del viso, i capelli nerissimi e lucidi, la pelle bruna e delicata, gli occhi malinconici e profondi, il corpo armoniosamente muscoloso lo rendono, nei progetti coraggiosi di Norman un futuro divo dello schermo cinematografico, che sta polarizzando le attenzioni di industriali, impresari, attori e gli stupori ammirati di un pubblico nuovo e curioso.
Ma “il paradiso della celluloide” è difficilissimo da penetrare: iniziano così per Rodolfo e per Norman le quotidiane peregrinazioni per trovare lavoro: un percorso durissimo e umiliante segnato da mille rifiuti; un vero calvario fino a che una mattina, siamo nel 1917, una delle Segretarie della Metro, che si era abituata a vederlo quasi tutti i giorni, gli dice che il regista Emmett Flynn ha un piccolo ruolo in “Alimony”: la segretaria sarà abbracciata, baciata, benedetta in tutte le lingue da quel ragazzo impazzito di felicità.
Sembra che la vita di Rudy sia costantemente su un’altalena: alle prime affermazioni seguono lunghi periodi di stasi che portano il suo morale a terra nonostante la stimolante vicinanza di Norman che, forte del suo ottimismo, continua ad incoraggiarlo. Sono proprio questi periodi di incertezza e di pessimismo che acuiscono nostalgie, esasperano sensibilità e gli indeboliscono il fisico.
Il desiderio di sua madre si fa pressante e spasmodico, per lenirlo scrive poesie che dimentica nei cassetti o nei libri sparsi un po’ ovunque.
“Esiste un’oscurità misteriosa ove mi trovo…
ma odo il chioccolio d’una fontana
e la risatina piumata dei suoi zampilli”.
Il 1917 e il 1918 sono anni duri per Rodolfo che, sfuggito miracolosamente alla “spagnola” che miete vittime specie fra i giovani, deve ora affrontare la durissima prova della morte di sua madre. Legato come è alla sua dolce mamma, Rudy si sente totalmente perduto e forse per la prima volta ha la consapevolezza di una lacerante, immensa solitudine.
Insieme però alla sincera e profonda disperazione, Rudy avverte chiaramente che la scomparsa di Marie Gabrielle gli interrompe tutti i legami col passato, tutte le nostalgie e tutte le tentazioni di un ipotetico ritorno.
Rudy ora sa per certo che la sua vita è e deve essere solo americana. Si seppellisce nel lavoro e senza curarsi dei ruoli che gli assegnano, accetta qualsiasi offerta. Solo nel 1919 girerà ben 8 film e questa super attività gli fornisce, oltre molto denaro, una corroborante eccitazione e la forte determinazione di inseguire un vero e duraturo successo.
È lontano ormai il ricordo umiliante dell’emigrante sbarcato in cerca di fortuna carico di sogni e di illusioni: desidera rimuovere da sé anche Rodolfo Guglielmi di Castellaneta, le orecchie a punta, la miopia e la terra.
Ora vuol pensare solo a Rodolfo Valentino che molti già chiamano Rudy: si guarda allo specchio e quasi non si riconosce, ma si piace di più: continua a lavorare a testa bassa in ruoli di cattivo senza cuore guadagnando sostanziosi cachet.
Un giorno viene a sapere che la Metro sta progettando un super colosso tratto dal romanzo di Blasco Ibanez intitolato “I 4 cavalieri dell’Apocalisse”: incuriosito decide di leggere il libro.
Più si addentra nella lettura del romanzo più si innamora del personaggio di Julio il giovane danzatore che ne è il protagonista.
Con le decisioni rapide e ineludibili dei veri timidi, Rudy chiede di essere ricevuto da Maxwell, che era il direttore della produzione della Metro e si propone appassionatamente per il ruolo di Julio: dimostra conoscenza approfondita del romanzo, capacità di analisi degli ambienti e dei personaggi, dicendosi pronto ad affrontare un ruolo diverso da quelli che aveva già fatto in ben 25 film.
Ma la grande macchina hollywoodiana del cinema muto, forse per quell’impronta assolutamente seriale che le produzioni si erano imposte per favorire l’uso consumistico, che stava funzionando benissimo, non intende rischiare cambiamenti di percorso procurati da scelte non collaudate. Era quello della celluloide uno strano mondo, condizionato da una spasmodica accelerazione produttiva ma poco attenta alla creatività e alle esigenze artistiche, affidata solo al movimento e all’espressività fisica esasperata dei visi e dei corpi.
Non c’erano le parole ad illuminare i tempi e gli spazi del cinema: la mimica di occhi bistrati e di gesti eccessivi era così esibita da non favorire nessuna nuance interpretativa.
“Si accontenti dell’ottima carriera che sta facendo e degli ottimi guadagni che ottiene!” tuona duro Maxwell “ ho bisogno di un attore romantico e lei ormai è uno specialista dei ruoli noir!”
Sembrò la risposta definitiva e negativa ad un altro grande sogno, ma Rex Ingram un grande regista della Casa di produzione vede proprio in Rudy l’interprete ideale per Julio: capisce che la sua figura sprigiona bellezza e magnetismo e la sua sensazione diventa certezza quando Valentino, durante un provino, si lascia andare in una scena di tango scatenato.
È ancora il tango a decidere della vita professionale di Rodolfo Valentino, ancora il tango a stabilire il contatto diretto con gli spettatori avidi di cinema e a creargli quel ruolo incontrastato di “divino” del bianco e nero primo novecento, capace di sedurre uomini e donne fino alla idolatria.
Con I quattro cavalieri dell’Apocalisse Rudy si conferma “sex simbol” per eccellenza, divo dal fascino magnetico, “latin lover” ambiguo e misterioso, vero e proprio oggetto del desiderio destinato al culto di massa, e il suo fascino diventa, sorretto anche da quella sua contraddittoria personalità di malinconico tenace, una bomba ad orologeria.
In un’epoca in cui il cinema muto muove i primi passi imperiosi, Rudy diventa leggenda , perdendo le sue vere connotazioni per assumere quelle che la prepotente celebrità gli attribuisce.
Le donne, gli amori, le trasgressioni, le virtù, i trionfi professionali, diventano tutti strumenti nel gran tritacarne della costruzione mediatica del mito, di cui l’organizzazione cinematografica si avvarrà senza scrupoli.
Ma nel suo privato, nella sfera personale Rodolfo Valentino è una creatura inappagata e insoddisfatta.
Le donne della sua vita non sono state mai felici con lui e Valentino non è mai stato felice con loro.
Abissale la differenza fra verità e celluloide: nella verità c’è un giovane attore travolto sentimentalmente da un unico fatale incontro quello con Natacha Rambova, nella celluloide lo stesso giovane attore è assalito e fatto segno dell’amore incondizionato e irragionevole di milioni di donne.
Anche la cifra di questa preferenza fatale per Natacha dipende da quell’aggressivo e strisciante complesso di inferiorità che assilla Rodolfo dalla sua infanzia.
Valentino e Natacha si sposano, dopo varie vicissitudini, il 14 Marzo 1923 a Crow Point nell’Indiana alla presenza di due soli amici-testimoni; poco dopo partono per un lungo viaggio che li porta in Europa e in Italia.
Natacha Rambova è una splendida donna molto apprezzata a Hollywood per gli scenari e i costumi che disegna: ha una fortissima personalità, viva intelligenza, spiccata tendenza al dominio e all’autostima. Di lei Valentino si innamora perdutamente forse attratto soprattutto dal suo carattere impositivo e combattivo, come se l’attore cercasse protezione e rassicurazione, come se lui stesso non fosse in grado di sostenere quel personaggio di “conquistatore cosmico” che gli avevano cucito addosso.
Più che l’amore di Valentino, Natacha è l’ambiziosa professionista, l’esigente collaboratrice, la sicura imprenditrice, il Cerbero, che lo pilota fra ingaggi, scelte di ruoli e contratti, fino a che le Case di Produzione non sopportando più l’ invasiva intromissione di lei, la escludono per contratto, da ogni decisione artistica e professionale che riguardi il lavoro di suo marito.
Naturalmente il loro rapporto non resiste a una prova così: Natacha non sopporta di essere messa da parte e preferisce andarsene, lasciando Valentino nella disperazione più assoluta.
Il divo si sente perduto senza la sua “adorato bambolina”, senza quel “tourbillon” di energia e di decisionalità che caratterizzava i desideri di lui e i progetti di lei.
Ma Rodolfo Valentino, ormai, è entrato nella storia del cinema mondiale con I quattro cavalieri dell’Apocalisse e Lo Sceicco del 1921, Sangue e Arena e Il giovane Rjah del 1922, e Notte nuziale del 1924 e l’Aquila Nera del 1925, solo per nominare alcuni dei suoi film di successo; ha consolidato il mito dell’amante latino nell’immaginario femminile universale con i suoi cappotti foderati di cincillà, le automobili fuori serie, i capelli impomatati, gli smoking eleganti e gli stivali alti, complice quello sguardo obliquo e tagliente simbolo di tormento d’amore e di esibito erotismo.
I muri di tutte le città del mondo sono ricoperti dei manifesti dei suoi personaggi: spicca e seduce lo Sceicco.
Sguardo triste, capo gloriosamente avvolto dal “kefiah” stretto dall’intreccio bianco dell’“egat”, pugnale d’argento infilato alla cintola, abiti incastonati da pietre preziose, dita inanellate; ogni donna lo brama.
.
.
Il mito virtuale nutre se stesso e diventa sogno,mania, patologia, delirio.
Forse troppo per un timido ragazzo pugliese dalle orecchie a punta e dallo sguardo miope diventato ormai, per prodigio cinematografico, leggenda.
Nei suoi appunti però sono state ritrovate queste parole:
“Le donne non sono innamorate di me, ma della mia immagine sullo schermo. Io sono solamente la tela sulla quale le donne dipingono i loro sogni!”
Consapevolezza e disincanto, che contraddicono l’immagine di divo di carta pesta che il mutare delle mode e dei gusti gli attribuiranno.
I suoi ruoli di arabo, di spagnolo, di esotico rubacuori, lo fanno affiorare nelle sale buie e mute del vecchio cinema in bianco e nero come l’idea stessa dell’amore alla quale nessuna donna sa resistere.
Nella costruzione dei miti avviene come in certi riti totemici, una sorta di appropriazione o di divoramento magico e virtuale dell’oggetto venerato; assistere e partecipare emotivamente a tutti i film di Valentino equivale per tutti i suoi fans, ad un nutrirsi di lui, ad assimilarlo per soddisfare brame e correggere malinconiche quotidianità
Il vero creatore del suo inossidabile mito, il regista omosessuale Rex Ingram, tentò senza fortuna, perfino di contrapporgli un altro attore, Ramon Novarro, che morì assassinato in un delitto fra gay; poi Hollywood gli contrappone Douglas Fairbanks cercando di costruire quelle false rivalità che piacciono tanto al pubblico, ma tutto fu inutile, Rodolfo Valentino rimase saldo nel suo fragile trono di celluloide.
La fine definitiva e oltremodo sofferta del suo rapporto con Natacha Rambova lo porta a vivere una quotidianità disordinata e senza regole.
Valentino acquista otto acri panoramici a Beverly Hills e si insedia nella splendida villa detta il “Nido del Falco”: rossi damaschi, soffici tappeti orientali, broccati italiani e velluti di Smirne, ricami veneziani, ferri battuti, piante lussureggianti, libri rari, incisioni preziose, vetri di Murano, cristalli di Boemia, argenti e armi da collezione; tutto per scacciare il fantasma di Natacha e il suo dolcissimo e travolgente ricordo.
Gli sono vicini i pochi amici sinceri che hanno sempre nutrito per lui sentimenti di umana simpatia e di sincera complicità: sono Gloria Swanson,
George Ulmann, Nita Naldi, Fred Niblo regista e June Mathis sceneggiatrice che per prima aveva intuito, assieme a Norman Kerry, la carica irresistibile di seduzione che Valentino avrebbe esercitato sul pubblico cinematografico.
Era stata proprio June Mathis a sceneggiare per lui, dopo il trionfo dei 4 Cavalieri, tutte le trame dei suoi film, standogli vicina silenziosamente e meritando da lui l’affettuoso epiteto di “piccola madre” che si riagganciava al ricordo sempre vivo di Marie Gabrielle.
Ma la voragine, creata dall’assenza di Natacha, non riesce a colmarsi in nessun modo.
Gli spasmi intestinali di cui Rudy soffre da tempo, si infittiscono, ma durano poco, per questo riesce ancora a nasconderli a chi gli sta vicino.
Valentino vive da qualche tempo con Pola Negri un’ attrice bella e tenebrosa, ha 31 anni, ha appena terminato il suo ultimo film intitolato Il figlio dello Sceicco che uscirà postumo perché la sua mitica stella, come tutte le meteore troppo luminose sta per spegnersi.
Il 15 Agosto 1926, Rudy che si trova all’Hambassador di New York, sviene improvvisamente perdendo i sensi: ricoverato d’urgenza al Policlinico viene subito operato. Il bollettino medico parla di peritonite inarrestabile, setticemia diffusa con l’aggravante di debole resistenza del paziente.
Al suo capezzale oltre al fratello che da qualche tempo è suo ospite, il mondo imprenditoriale Hollywoodiano, gli amici, i giornalisti e gli attori che avevano lavorato con lui: lo assiste in silenziosa e fattiva vicinanza June Mathis fedele e affettuosa:
Quando, dopo l’intervento Rudy riaprendo gli occhi la vede, sorride e trovando ancora un barlume d’ironia le dice.
“Piccola madre, anche tu alle mie esequie?”
Lei commossa, ma vitale e premurosa come sempre, gli dice che sono molte le cose che devono ancora fare assieme!
È il 20 Agosto quando Rudy, ulteriormente peggiorato, implora l’amico George Ulmann di cercare Natacha.
Non la troveranno e il 23 Agosto Rodolfo Valentino chiuderà per sempre i suoi occhi miopi e tentatori: nella bara solo un gioiello, un bracciale da schiavo che Natacha gli aveva regalato: ancora lei, la sua bambolina crudele per la quale Valentino aveva scritto queste parole: “A volte trovo una squisita amarezza nei tuoi baci!”
La cronaca dei suoi funerali, le spettacolari e false insinuazioni di avvelenamento, l’insistito cordoglio di grandi, la maniacale partecipazione con isterismi collettivi delle fans, sono ormai consegnate alla Storia. Con lui si spegne la gloria del cinema muto lasciando un vuoto che non sarà mai più colmato.
Più di centomila telegrammi di condoglianze si riversano da ogni parte del globo, una folla isterica e frenetica di oltre 125.000 persone si allinearà lungo i dieci isolati dove transita il corteo funebre.
Rodolfo Valentino verrà sepolto in un mausoleo di marmo bianco del Memorial Cemetery di Hollywood.
Non è leggenda metropolitana la storia della dama in nero che fino al 1955 depone rose sulla sua tomba.
Si chiamava Ditra Flann, era una violinista conosciuta da Valentino quando lui lavorava come danzatore a noleggio. Ditra aveva 14 anni quando si ammalò gravemente e all’ospedale dove Valentino andò a trovarla, si promisero che, chi dei due fosse vissuto di più, non avrebbe dimenticato l’altro e avrebbe portato rose sulla sua tomba. Ditra, che si era salvata, non dimenticò.
Oggi mi piace salutare Rodolfo Valentino, che fu prigioniero del mito di se stesso e l’idolo di tutte le nostre mamme e nonne e zie, con le belle parole che Charlie Chaplin disse in occasione della sua inattesa e sconvolgente scomparsa: “La morte di Valentino è una delle più grandi tragedie che abbia mai colpito il mondo del cinema. Come attore egli possedeva arte e distinzione, come amico riscuoteva affetto e ammirazione. Noi che apparteniamo all’Arte Cinematografica con la sua morte perdiamo un carissimo amico e un compagno di grande valore.”
A SPROPOSITO
di Giulio d’Amicone
1. Non ho mai capito perché nel nostro paese (come in altri) non vengano quasi mai rispettati i titoli originali; e non mi riferisco solo al cinema (di cui ovviamente tratterò qui), ma anche alla letteratura. Se si volesse stilare un elenco completo degli abusi commessi in questi ambiti non basterebbe un numero intero della rivista; vedrò quindi di restringere le mie osservazioni a pochi argomenti.

 Il proposito di stimolare l’attenzione di un pubblico il più vasto possibile si è sempre agganciato, dal punto di vista dei lemmi, a pochi stereotipi. Tra gli aggettivi proliferano ‘ultimo’ (relativo sia a cose sia a persone: donne, spiagge, avventurieri, inesistenti “buscaderi”), ‘strano’ (Strano vizio della signora Ward, Strana voglia di Jean), ‘perverso’ (Gioco perverso, Allucinazione perversa), mentre fra gli avverbi riscuote gran successo ‘oltre’ (Oltre ogni limite, Oltre l’urlo del demonio). Tra i sostantivi – passati i tempi dei ‘peccatori’ che oltre a vestirsi (orrore!) con i blue-jeans arrivarono al punto da essere… senza peccato – hanno sempre funzionato ‘mistero’ (del falco, dell’acqua, dei templari), ‘caso’ (Il caso del dottor Gailland, Il caso Katarina Blum) e ‘orgia’ (Z l’orgia del potere, L’orgia del vampiro). Gran fortuna ottiene poi ‘ribelle’, usato sia come aggettivo sia come sostantivo (Il ribelle dell’Anatolia, Mc Arthur il generale ribelle); quando invece la parola si trova nel titolo originale (Rebel without a cause) non viene considerata e il film diventa Gioventù bruciata! Inutile aggiungere che nella maggioranza dei casi si tratta di vocaboli usati a sproposito.
Il proposito di stimolare l’attenzione di un pubblico il più vasto possibile si è sempre agganciato, dal punto di vista dei lemmi, a pochi stereotipi. Tra gli aggettivi proliferano ‘ultimo’ (relativo sia a cose sia a persone: donne, spiagge, avventurieri, inesistenti “buscaderi”), ‘strano’ (Strano vizio della signora Ward, Strana voglia di Jean), ‘perverso’ (Gioco perverso, Allucinazione perversa), mentre fra gli avverbi riscuote gran successo ‘oltre’ (Oltre ogni limite, Oltre l’urlo del demonio). Tra i sostantivi – passati i tempi dei ‘peccatori’ che oltre a vestirsi (orrore!) con i blue-jeans arrivarono al punto da essere… senza peccato – hanno sempre funzionato ‘mistero’ (del falco, dell’acqua, dei templari), ‘caso’ (Il caso del dottor Gailland, Il caso Katarina Blum) e ‘orgia’ (Z l’orgia del potere, L’orgia del vampiro). Gran fortuna ottiene poi ‘ribelle’, usato sia come aggettivo sia come sostantivo (Il ribelle dell’Anatolia, Mc Arthur il generale ribelle); quando invece la parola si trova nel titolo originale (Rebel without a cause) non viene considerata e il film diventa Gioventù bruciata! Inutile aggiungere che nella maggioranza dei casi si tratta di vocaboli usati a sproposito.
- Ma andiamo in dettaglio. Il cinema francese non ha subito maltrattamenti meno gravi di quello statunitense. Per esempio, i film del bravo Granier-Deferre avevano titoli semplicissimi: Le fils, Le chat, Le train… Ebbene, non uno di questi ottiene grazia: Un battito d’ali dopo la strage, L’implacabile uomo di Saint-Germain, Noi due senza domani… Medesima sorte è riservata a Sautet (César et Rosalie → E’ simpatico ma gli romperei il muso), Girod (René la canne →Tre simpatiche carogne), Molinaro (L’homme pressé → L’ ultimo giorno d’amore per un film che non ha nulla di romantico). Persino un autore come Melville, i cui titoli sono particolarmente indicativi, subisce tale sorte: l’enfatico Le iene del quarto potere sostituisce Deux hommes dans Manhattan, l’incomprensibile Tutte le ore feriscono l’ultima uccide sostituisce Le deuxieme souffle, lo sgrammaticato I senza nome sostituisce Le cercle rouge, l’improprio Notte sulla città sostituisce Un flic. E l’urbanità di Truffaut, espressa anche attraverso la bellezza e la semplicità dei suoi titoli? Non mi riferisco soltanto al famigerato Non drammatizziamo… è solo questione di corna, ma anche al cattivo gusto di La calda amante al posto di La peau douce e a un pesante La mia droga si chiama Julie al posto di La sirène du Mississipi. Le cose vanno meglio a Godard, tranne per un inopinato Bandito delle undici (Pierrot le fou) e a un virulento Crepa padrone indebitamente aggiunto al suo ironico Tout va bien.
 Ma certe abitudini hanno purtroppo origini remote. Trasferendoci in America, non si può dire che i titoli di Ford abbiano mai goduto di buona salute: partendo dalla pur ingegnosa sinestesia di Ombre rosse (comunque infedele al semplice Stagecoach originale), My darling Clementine muta in un assurdo Sfida infernale, She wore a yellow ribbon diventa un ingiustificato Cavalieri del nord-ovest (esemplato sul Passaggio vidoriano precedente di qualche anno), The searchers cambia in Sentieri selvaggi, e neppure uno splendido titolo come Cheyemne autumn viene risparmiato, divenendo Il grande sentiero. E che cosa dire di un Rio Grande che per qualche incomprensibile ragione si modifica in Rio Bravo, dimodoché quando Hawks realizzò un effettivo Rio Bravo i nostri ineffabili titolisti si videro costretti a escogitare alla mafiosa Un dollaro d’onore? (1)
Ma certe abitudini hanno purtroppo origini remote. Trasferendoci in America, non si può dire che i titoli di Ford abbiano mai goduto di buona salute: partendo dalla pur ingegnosa sinestesia di Ombre rosse (comunque infedele al semplice Stagecoach originale), My darling Clementine muta in un assurdo Sfida infernale, She wore a yellow ribbon diventa un ingiustificato Cavalieri del nord-ovest (esemplato sul Passaggio vidoriano precedente di qualche anno), The searchers cambia in Sentieri selvaggi, e neppure uno splendido titolo come Cheyemne autumn viene risparmiato, divenendo Il grande sentiero. E che cosa dire di un Rio Grande che per qualche incomprensibile ragione si modifica in Rio Bravo, dimodoché quando Hawks realizzò un effettivo Rio Bravo i nostri ineffabili titolisti si videro costretti a escogitare alla mafiosa Un dollaro d’onore? (1)
- Per un certo periodo, tra gli anni sessanta e i settanta, i titolisti nostrani si erano ammalati di “ispettorite”: qualsiasi fosse il grado rivestito dal rappresentante USA delle forze dell’ordine, il personaggio veniva ipso facto promosso ispettore. Così successe per il ciclo Tibbs (in cui Sidney Poitier in realtà recitava nei panni di un lieutenant), per il tenente Brannigan di John Wayne (Ispettore Brannigan la morte segue la tua ombra) e per il semplice sergente Walter Matthau (L’ispettore Martin ha teso la trappola); subì tale sorte perfino l’investigatore privato Sutherland (Una squillo per l’ispettore Klute). L’unico che ne avesse diritto era Eastwood, il cui semplice Dirty Harry divenne però Ispettore Callaghan [in realtà Callahan] il caso Scorpio è tuo!! (notare l’abbondanza di punti esclamativi).
 Altro stratagemma diffuso da tempo è il vezzo dei falsi titoli originali, sempre escogitati tenendo presente un inglese elementare. Pesco a caso: Lifeforce di Tobe Hooper diventa Space vampires, Van Wilder diventa Maial college (complimenti per il buon gusto), Battle Los Angeles diventa World invasion, Wild things diventa un solleticante (?) Sex crimes, Haywire diventa Knock out… Si tocca il fondo col film francese di Fred Cavayé Pour elle tramutato in Anything for her: qui neppure l’origine viene rispettata. Quando invece i titoli originali, specialmente se facili, si potrebbero mantenere, la fantasia si scatena. Il semplice Hoffman con Peter Sellers non è abbastanza stuzzicante: ecco spuntare il brillante O ti spogli o ti denuncio. La parola fool (stupido oppure matto) viene rifiutata per due volte: Fools diventa Ha l’età di mio padre ma l’amo pazzamente, e per April fools ci si inventa Sento che mi sta succedendo qualcosa. Pure To kill a mockingbird (Uccidere un tordo), forse giudicato traumatico, si trasforma nell’arzigogolato Il buio oltre la siepe. Ma la punta di diamante si ottenne forse col ciclo della Pantera Rosa. Infatti nel 1975 The return of the pink panther fu modificato chissà perché in La pantera rosa colpisce ancora; di conseguenza, quando Edwards l’anno dopo diresse The pink panther strikes again (cioè proprio colpisce ancora) si dovette ricorrere a un La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau. Fin troppo facile commentare che un simile pasticcio poteva essere evitato semplicemente rispettando la fonte. Analogo imbarazzo avrebbe potuto essere scansato, a suo tempo, lasciando a Laura di Preminger tale nome invece dell’immotivato Vertigine, dimodoché quando uscì Vertigo di Hitchcock, non potendo rispettare l’originale, gli addetti non avrebbero dovuto inventarsi un assurdo La donna che visse due volte.
Altro stratagemma diffuso da tempo è il vezzo dei falsi titoli originali, sempre escogitati tenendo presente un inglese elementare. Pesco a caso: Lifeforce di Tobe Hooper diventa Space vampires, Van Wilder diventa Maial college (complimenti per il buon gusto), Battle Los Angeles diventa World invasion, Wild things diventa un solleticante (?) Sex crimes, Haywire diventa Knock out… Si tocca il fondo col film francese di Fred Cavayé Pour elle tramutato in Anything for her: qui neppure l’origine viene rispettata. Quando invece i titoli originali, specialmente se facili, si potrebbero mantenere, la fantasia si scatena. Il semplice Hoffman con Peter Sellers non è abbastanza stuzzicante: ecco spuntare il brillante O ti spogli o ti denuncio. La parola fool (stupido oppure matto) viene rifiutata per due volte: Fools diventa Ha l’età di mio padre ma l’amo pazzamente, e per April fools ci si inventa Sento che mi sta succedendo qualcosa. Pure To kill a mockingbird (Uccidere un tordo), forse giudicato traumatico, si trasforma nell’arzigogolato Il buio oltre la siepe. Ma la punta di diamante si ottenne forse col ciclo della Pantera Rosa. Infatti nel 1975 The return of the pink panther fu modificato chissà perché in La pantera rosa colpisce ancora; di conseguenza, quando Edwards l’anno dopo diresse The pink panther strikes again (cioè proprio colpisce ancora) si dovette ricorrere a un La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau. Fin troppo facile commentare che un simile pasticcio poteva essere evitato semplicemente rispettando la fonte. Analogo imbarazzo avrebbe potuto essere scansato, a suo tempo, lasciando a Laura di Preminger tale nome invece dell’immotivato Vertigine, dimodoché quando uscì Vertigo di Hitchcock, non potendo rispettare l’originale, gli addetti non avrebbero dovuto inventarsi un assurdo La donna che visse due volte.
 Capita anche che non si abbiano scrupoli nel modificare i nomi (la Rachel Rachel di Paul Newman diviene La prima volta di Jennifer); oppure si gioca sull’omografia per indurre a credere che opere francesi siano di produzione USA (Mr. Klein di Losey e L’insolito caso di Mr. Hire: dove Mr., cioè Monsieur, può essere letto come Mister)…
Capita anche che non si abbiano scrupoli nel modificare i nomi (la Rachel Rachel di Paul Newman diviene La prima volta di Jennifer); oppure si gioca sull’omografia per indurre a credere che opere francesi siano di produzione USA (Mr. Klein di Losey e L’insolito caso di Mr. Hire: dove Mr., cioè Monsieur, può essere letto come Mister)…
Potrei andare avanti ancora per molto ma mi fermo qui, non senza aggiungere che se qualcuno – per puro caso – si illudesse che la situazione attuale sia migliorata, può gettare uno sguardo ai titoli dell’ultima stagione. Qualche esempio: C’era una volta a New York (The immigrant); Come ti spaccio la famiglia (We’re the Millers); Io sono tu (Identity thief). E’ sufficiente?
_____
(1) L’attenzione riservata dal regista alle donne non ha mai trovato riscontro in Italia: anche l’ultimo film, intitolato Seven women, viene modificato in Missione in Manciuria (‘missione’ è un altro dei vocaboli prediletti dalla nostra équipe)
.
JARMAN, WITTGENSTEIN E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
di Maurizio Villani
La ricorrenza del centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale ha visto la proliferazione di convegni, studi, cicli commemorativi volti a ricordare uno degli eventi decisivi per la storia contemporanea d’Europa. Con questo articolo si vuole sottoporre all’attenzione del lettore una felice coincidenza di riferimenti, che consente di ricostruire un momento dell’esperienza di guerra del filosofo Ludwig Wittgenstein attraverso le sequenze di un importante film a lui dedicato dal regista inglese Derek Jarman.
Nel 1914 Wittgenstein aveva 25 anni, essendo era nato Vienna nel 1889. Apparteneva ad una ricchissima e colta famiglia di origini ebraiche, ma battezzata con il rito cattolico. Studiò inizialmente ingegneria, poi si dedicò agli studi di filosofia, frequentando le lezioni di Russell e di Moore. Allo scoppio della guerra si arruolò volontario nell’esercito austriaco, combattendo prima sul fronte orientale e poi su quello meridionale, dove nel 1918 venne catturato dagli italiani. Prigioniero a Cassino fino all’agosto del 1919, custodì nello zaino il manoscritto del “Tractatus”, che pubblicherà nel 1921. Nel 1929 ritornò a Cambridge, riprendendo poi l’insegnamento filosofico. Morì di cancro nel 1951.
La decisione di arruolarsi volontario, anche se un’operazione all’ernia lo aveva esentato dal servizio militare, e la richiesta di andare in prima linea, per potersi trovare faccia a faccia con la morte, sono indicative di una personalità complessa e tormentata. «La decisione di andare volontariamente in guerra e di esporsi deliberatamente alle situazioni più pericolose era stata concepita da Wittgenstein come la prova del fuoco del suo carattere, per fare i conti con se stesso, per afferrare l’opportunità di diventare “un uomo decente”, perché la morte soltanto libera l’individuo nel senso precisamente che soltanto di fronte alla morte un uomo raggiunge la propria solitudine[i].»
Wittgenstein venne assegnato ad un reggimento di artiglieria stanziato a Cracovia, coinvolto in una della più sanguinose battaglie del fronte orientale tra austro-ungarici e russi. Durante la vita militare, tra momenti di depressione profonda e altri di entusiasmo vitalistico, Wittgenstein racconta nei Diari di aver fatto la “grande scoperta” che è al centro del “Tractatus”: la “Teoria del linguaggio come raffigurazione”, secondo cui il linguaggio rappresenta il mondo e lo fa attraverso proposizioni sensate, che possono raffigurare stati di cose. Ma negli anni di guerra, attraverso la lettura della “Spiegazione dei Vangeli di Tolstoj e de “L’anticristo” di Nietzsche, matura in lui la riflessione filosofica verso problematiche esistenziali, che, preludono alla parte “mistica” del “Tractatus”[ii].
Questa premessa biografica serva per introdurre il “Wittgenstein” di Jarman. Derek Jarman nacque a Northwood, Middlesex, da padre neozelandese e da madre britannica di origine ebraica; studiò a Londra dal 1960 al 1963 al King’s College e poi alla Slade School of Art. Nel 1994 morì di Aids. La sua filmografia è ricca di opere: oltre a molti corti e mediometraggi, i film più noti sono: Sebastiane (1976), The Tempest (1979), Caravaggio (1986), The Last of England (1987), War Requiem (1989), Edoardo II (1991), Wittgenstein (1993) e Blue (1993).
Il film su Wittgenstein[iii] nacque all’interno di un progetto di Channel Four[iv] per dare vita ad un ciclo sulla filosofia ispirato da testi filmici biografici di carattere divulgativo. Dei dodici film previsti, solo le sceneggiature su Spinoza di Tarq Ali, su Locke di D. Edgar, e su Wittgenstein di Terry Eagleton furono affidate a tre registi per la trasposizione filmica. Il film ha più l’aspetto di un’opera teatrale filmata in cui gli attori agiscono in una scenografia minimalista. Più che una biografia si tratta di una messa in scena del pensiero del filosofo, anche se sono rappresentati alcuni momenti emblematici della sua vita: l’educazione familiare, l’esperienza di soldato durante la Prima guerra mondiale, la decisione di vivere in povertà, la fallimentare esperienza di maestro elementare, il ritorno a Cambridge, l’attività di insegnamento, le amicizie (in particolare quella con Bertrand Russell), gli ultimi anni sino alla morte. Due citazioni rendono bene la cifra ironica, dilettevole e introspettiva che ha guidato sceneggiatori e regista nella rappresentazione della figura di Wittgenstein. Così si espresse Terence Francis Eagleton[v], il principale autore della sceneggiatura del film: «Solo se utilizziamo queste proposizioni impossibili come scale gettate via a calci non appena ci si è montato sopra, vedremo il mondo nel modo giusto; e in questo senso il “Tractatus” si cancella in un atto di autoironia modernista»[vi]. E Jarman affermò che suo intento era quello di “lasciare apparire”, la vita di Wittgenstein: «Il mio film non ritrae Wittgenstein né lo tradisce: è lì per svelare». Questo “atteggiamento ricettivo” della biografia del filosofo austro-inglese porta il regista ad adottare un approccio di grande intelligenza interpretativa e uno stile divertente e lieve, nonostante la complessità dei contenuti rappresentati. Nella visione di Jarman questo fa di Wittgenstein una sorta di asceta, di monaco, mistico e meccanico nel contempo, «che agognava nostalgicamente la simplicitas tolstoiana, un gigante della filosofia con scarso rispetto per la filosofia stessa, un autocrate irascibile con sete di santità[vii]».
La resa filmica di questa interpretazione della vita del protagonista passa attraverso le scelte stilistiche di Jarman, che ha adottato «un linguaggio obliquo, idiosincrasico e a tratti ironico: lo scarto fra l’ascetico aristocraticissimo dell’uomo e della prima fase del suo pensiero e gli esiti “behavioristici” dell’opera serve al regista per riprodurre la complessità freudiana del suo essere così, apparentemente, spiazzato nella storia, nel contempo arcaico e all’avanguardia, rivolto vero l’elegia di un passato ma con lo sguardo rivolto al futuro. Jarman rende tutto ciò attraverso la mescolanza di materiale citazionista e immaginario, imprimendo molta carica drammatica alla sceneggiatura che, invece, sembra più rivolgersi alle idee che non al personaggio[viii]».
Illuminante su tutte queste tematiche è la sequenza del film che mostra una scena notturna della vita militare che bene rende la cupa visione crepuscolare dell’esistenza del protagonista. Wittgenstein, in divisa da soldato, circondato da commilitoni, da lui sentiti come del tutto estranei ai suoi tormenti interiori, fa questa riflessione: «Lo so che questo mondo esiste, ma il suo significato è problematico. Io sono buono o cattivo? Quando la mia coscienza altera il mio equilibrio, allora non sono in accordo con qualcosa. Che cos’è: è il mondo o è Dio?».
La scena è emblematica di quella mutazione di baricentro teoretico che nella elaborazione del “Tractatus”, durante gli anni di guerra, sostituisce la centralità della logica con l’interrogazione sui temi dell’etica, dell’estetica, del “mistico”. Ha osservato un autorevole biografo che «se Wittgenstein avesse trascorso l’intera guerra nelle retrovie, il “Tractatus logico-philosophicus” sarebbe rimasto quello che con ogni probabilità era nella prima concezione del 1915: un trattato di logica. Infatti, le osservazioni contenute nella versione definitiva relative all’etica, all’estetica, all’anima, al senso della vita trassero origine, precisamente, dall’impulso (…) generato dalla consapevolezza della morte, della sofferenza, della miseria[ix]».
Nella sequenza sopra citata, ambientata durante la campagna di guerra in Galizia, in cui Jarman deve dare conto dei tormenti interiori del suo protagonista travagliato dai dubbi etici e religiosi, si fa evidente la coerenza tra le scelte del tipo di linguaggio filmico fatte dal regista e l’impostazione contenutistica del racconto. Tanto essenziale è lo sviluppo narrativo della biografia di Wittgenstein, quanto altrettanto volta al minimalismo figurativo è la scelta stilistica di Jarman, che passa attraverso l’utilizzo di una serie di precise opzioni formali: una maniacale attenzione per le scelte cromatiche, dominate dall’uso del “nero” come segno di stacco tra le sequenze e come sfondo per le azioni dei personaggi, l’insistenza sui primi piani, la mancanza di una ricerca scenografica fatta a vantaggio di un antidecorativismo ambientale, la teatralità della maniera recitativa. Sono tutte caratteristiche che confermano la conseguenzialità tra il contenuto speculativo del film e la sua forma espressiva.
_____
[i] Aldo G. Gargani, “Introduzione” a Wittgenstein “Diari segreti”, Editori Laterza, Roma-Bari 1987, p. 9.
[ii] Per una documentazione di questi temi si veda L. Wittgenstein, “Quaderni 1914-16”, in L. Wittgenstein, “Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-16”, pp. 217-219; la loro formulazione definitiva si trova nel “Tractatus” dalla proposizione 6.4 alla proposizione 7, cfr. op. cit. pp. 169-175. Einaudi, Torino 1995,
[iii] Wittgenstein, Gran Bretagna, 1993, durata 75 min., regia: Derek Jarman; soggetto: Ken Butler, Terry Eagleton, Derek Jarman; sceneggiatura: Ken Butler, Terry Eagleton, Derek Jarman; interpreti principali; Karl Johnson (Ludwig Wittgenstein), Michael Gough (Bertrand Russell), Tilda Swinton (Ottoline Murrell), Jill Balcon (Leopoldine Wittgenstein), John Quentin (John Maynard Keynes).
[iv] Channel Four un canale televisivo inglese di servizio pubblico, alternativo alla BBC, istituito nel 1980 dopo anni di scontro tra laburisti e conservatori sull’opportunità di dare una nuova concessione televisiva. Ha iniziato a trasmettere i suoi programmi nel 1982. È di proprietà del Channel Four Television Corporation, un ente pubblico istituito nel 1990 per questo scopo. A differenza dei canali di servizio pubblico della BBC, Channel Four pur essendo di proprietà pubblica non riceve alcun fondo pubblico.
[v] Terence Francis Eagleton (Salford, 1943) è un drammaturgo e un critico letterario inglese di orientamento marxista eterodosso. È stato professore di letteratura inglese all’Università di Oxford, all’Università di Manchester e all’Università di Lancaster. Due suoi saggi sono stati tradotti in italiano: “Figure del Dissenso” (1987), Moltemi, 2997 e “Ideologia: Storia e Critica di un’Idea Pericolosa”, Fazi, 2007.
[vi] AA.VV. “Wittgenstein”, Ubulibri, 1993, p.15. Il testo presenta la sceneggiatura curata da Terry Eagleton per la realizzazione del film.
[vii] AA.VV. “Wittgenstein”, op. cit., p.14.
[viii] C. Barocchi, “Ludwig Wittgenstein attraverso il cinema di Derek Jarman”, in ‘Comunicazione Filosofica’ n. 10, maggio 2002, http://www.sfi.it/archiviosfi/cf/cf10/articoli/boracchi1.htm
[ix] R. Monk, “Wittgenstein”, Bompiani, Milano 1990, p. 144.
.
KAPÒ, FUOR DI RETORICA
di Roberto Lasagna
Le emozioni, sempre molte e tumultuose, parlano, nel campo di Kapò, con voci diverse e talvolta dissonanti. Il male di un universo concentrazionario, ripiegato sul bios e sull’incatenamento al corpo, si distingue non semplicemente per la sua banalità, come titola un celebre libro di Hannah Arendt, ma per la sua spietata e sistematica razionalità, che nel trionfo di una tracotante arroganza colpisce a caso, e provoca orrori non prevedibili ne’ tantomeno sempre pienamente comprensibili. Il mondo oscuro e razionale dei lager è il luogo di un “esperimento” mostruoso e sconcertante che esemplifica lo scacco più accecante dell’umano. Un film come Kapò (1959) di Gillo Pontecorvo, che cerca di fare luce su un tale scacco, non poté che essere un film rischioso, come lo fu il lavoro del produttore Franco Cristaldi, forse il solo tra i grandi produttori del cinema italiano ad avere perseguito e difeso nel tempo una coerenza ideologica espressa nella difesa del percorso degli autori. A lui si devono film importanti del cinema italiano quali, tra gli altri, L’udienza di Marco Ferreri e La Cina è vicina di Marco Bellocchio.
 Cristaldi sarà anche il produttore capace di mediare i contrasti tra Gillo Pontecorvo e lo sceneggiatore Franco Solinas, divisi su più punti inerenti la vicenda e gli sviluppi drammatici di Kapò, un film importante che Gillo Pontecorvo avrebbe voluto più rigoroso e meno condizionato, in special modo dall’esigenza di inserire una storia d’amore che porterà la protagonista, giovane ebrea divenuta Kapò nel lager in cui ha visto la fine degli amati genitori, verso la redenzione e il sacrificio a favore dei deportati. Ma si tratta indubbiamente di un film che, pur nei limiti di una rappresentazione condizionata, non aveva tra i suoi difetti anche quello dell’abiezione, espressione a cui allora alludeva Jacques Rivette in un suo celebre articolo sul presunto sensazionalismo bieco che nel film sarebbe palesato dal traveling che si soffermerebbe sul suicidio di una internata sfinita e senza prospettiva, decisa a risolvere il suo destino gettandosi sul filo spinato attraversato dalla corrente elettrica. La scure del dogmatismo, pertanto, non è e non fu mai in alcun modo utile alla causa del lavoro analitico e Kapò, opera con dei limiti ma intellettualmente lontana dall’ambiguità, porta in scena il lager e la disavventura tragica di una quattordicenne ebrea catapultata in un geometrico e sconcertante abisso di degrado. Il film inizia con l’immagine parigina di una giovane studentessa di musica impegnata al pianoforte. L’insegnante di musica non fa in tempo ad avvertire la giovane Edith in merito alla telefonata che annuncia l’arrivo dei nazisti nella casa dei suoi genitori. Così Edith torna a casa camminando tranquillamente tra le vie della città e finisce per vedere con i suoi occhi i genitori rapiti dai sicari di Hitler. Anche lei verrà deportata e nel campo saranno azzerate le sue illusioni. Quello che le si prospetta è un mondo capovolto dove la violenza e la morte sono preannunciate come un inevitabile destino.
Cristaldi sarà anche il produttore capace di mediare i contrasti tra Gillo Pontecorvo e lo sceneggiatore Franco Solinas, divisi su più punti inerenti la vicenda e gli sviluppi drammatici di Kapò, un film importante che Gillo Pontecorvo avrebbe voluto più rigoroso e meno condizionato, in special modo dall’esigenza di inserire una storia d’amore che porterà la protagonista, giovane ebrea divenuta Kapò nel lager in cui ha visto la fine degli amati genitori, verso la redenzione e il sacrificio a favore dei deportati. Ma si tratta indubbiamente di un film che, pur nei limiti di una rappresentazione condizionata, non aveva tra i suoi difetti anche quello dell’abiezione, espressione a cui allora alludeva Jacques Rivette in un suo celebre articolo sul presunto sensazionalismo bieco che nel film sarebbe palesato dal traveling che si soffermerebbe sul suicidio di una internata sfinita e senza prospettiva, decisa a risolvere il suo destino gettandosi sul filo spinato attraversato dalla corrente elettrica. La scure del dogmatismo, pertanto, non è e non fu mai in alcun modo utile alla causa del lavoro analitico e Kapò, opera con dei limiti ma intellettualmente lontana dall’ambiguità, porta in scena il lager e la disavventura tragica di una quattordicenne ebrea catapultata in un geometrico e sconcertante abisso di degrado. Il film inizia con l’immagine parigina di una giovane studentessa di musica impegnata al pianoforte. L’insegnante di musica non fa in tempo ad avvertire la giovane Edith in merito alla telefonata che annuncia l’arrivo dei nazisti nella casa dei suoi genitori. Così Edith torna a casa camminando tranquillamente tra le vie della città e finisce per vedere con i suoi occhi i genitori rapiti dai sicari di Hitler. Anche lei verrà deportata e nel campo saranno azzerate le sue illusioni. Quello che le si prospetta è un mondo capovolto dove la violenza e la morte sono preannunciate come un inevitabile destino.
 I sogni di gioventù non trovano alcun terreno e ogni idealismo è bandito come pericoloso. Occorre guardarsi attorno perché’ il sospetto e la delazione dettano legge alla vita nel campo. Nella sua baracca la donna ebrea interpretata da Emanuelle Riva sembra l’ultima depositaria, a voce alta, di ciò che resta di valori morali, così che le sue parole sono in evidente contrasto con le intenzioni disumanizzanti dei nazisti. Cerca di stare vicino a Edith, sostiene anzi che i nazisti non possono rubarle la dignità nemmeno volendolo. Ma Edith non sembra tanto convinta, dando così piena ragione ad uno scacco etico e umano. Lei è un animo fragile che si dimostra pronto a scendere ben presto a patti con la logica disumanizzante dei campi, vede i genitori denudati e umiliati portarsi alla morte, il suo sgomento la condanna ad un dolore intimo e sordo cui lo sguardo con gli occhi grandi e “abbagliati” di Susan Strasberg restituisce attonito e un po’ stranito rispecchiamento. Presto la ragazza fragile capisce che deve cambiare e che per sopravvivere deve alzare la testa e crearsi come una corazza. Aiutata da un’ospite totalmente disillusa, riceverà una nuova identità dal medico del campo, che la farà passare per una criminale con la stella nera e nasconderà la sua origine ebrea. E in questo tetro mimetismo, la paura e la fame (per cui ogni internato diventa un potenziale nemico) spingono Edith a vendersi ai nazisti. Venderà la sua verginità sessuale e diverrà una Kapò, maschera subdola e ingannatrice disposta a tutto pur di assecondare gli aguzzini. Il film mostra come l’animo più debole, posto in condizioni così eccezionali, possa trasformarsi in uno strumento di crudeltà. In questo scenario, per i tedeschi l’unico volere è la nazione, ovverosia l’amore fanatico di patria confermato dalle parole del militare Karl, un tipo laconico ed insoddisfatto che si annoia nel lager comprendendo del luogo non tanto l’abiezione quanto piuttosto la fine di un progetto. Nello stesso tempo, l’unica cosa che tiene in vita Edith è un cinismo interiorizzato e fatto proprio, schermo di adattamento portato con algida rassegnazione.
I sogni di gioventù non trovano alcun terreno e ogni idealismo è bandito come pericoloso. Occorre guardarsi attorno perché’ il sospetto e la delazione dettano legge alla vita nel campo. Nella sua baracca la donna ebrea interpretata da Emanuelle Riva sembra l’ultima depositaria, a voce alta, di ciò che resta di valori morali, così che le sue parole sono in evidente contrasto con le intenzioni disumanizzanti dei nazisti. Cerca di stare vicino a Edith, sostiene anzi che i nazisti non possono rubarle la dignità nemmeno volendolo. Ma Edith non sembra tanto convinta, dando così piena ragione ad uno scacco etico e umano. Lei è un animo fragile che si dimostra pronto a scendere ben presto a patti con la logica disumanizzante dei campi, vede i genitori denudati e umiliati portarsi alla morte, il suo sgomento la condanna ad un dolore intimo e sordo cui lo sguardo con gli occhi grandi e “abbagliati” di Susan Strasberg restituisce attonito e un po’ stranito rispecchiamento. Presto la ragazza fragile capisce che deve cambiare e che per sopravvivere deve alzare la testa e crearsi come una corazza. Aiutata da un’ospite totalmente disillusa, riceverà una nuova identità dal medico del campo, che la farà passare per una criminale con la stella nera e nasconderà la sua origine ebrea. E in questo tetro mimetismo, la paura e la fame (per cui ogni internato diventa un potenziale nemico) spingono Edith a vendersi ai nazisti. Venderà la sua verginità sessuale e diverrà una Kapò, maschera subdola e ingannatrice disposta a tutto pur di assecondare gli aguzzini. Il film mostra come l’animo più debole, posto in condizioni così eccezionali, possa trasformarsi in uno strumento di crudeltà. In questo scenario, per i tedeschi l’unico volere è la nazione, ovverosia l’amore fanatico di patria confermato dalle parole del militare Karl, un tipo laconico ed insoddisfatto che si annoia nel lager comprendendo del luogo non tanto l’abiezione quanto piuttosto la fine di un progetto. Nello stesso tempo, l’unica cosa che tiene in vita Edith è un cinismo interiorizzato e fatto proprio, schermo di adattamento portato con algida rassegnazione.
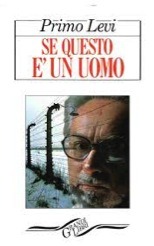 Le Kapò, anello di congiunzione tra i detenuti e il comando del campo, sono in Pontecorvo figure tratte direttamente dai ricordi evocati in “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Sono figure graduate, addestrate alla ferocia, che cercano un riscatto dalla loro condizione di semplice numero per accedere ad una posizione, pur provvisoria e ambigua, di dominio. In loro covano e si esprimono le peggiori qualità dell’individuo e sono l’emblema stesso dell’assenza di solidarietà, in una volontà di annientamento che l’“esperimento” dei lager traduce in riduzione della dimensione collettiva ad astrazione, regola che coinvolge l’umano piegandolo in un subdolo e antiumanistico ammassamento sul corpo e sul fisico, giogo di morte che cancella ogni spiritualità. Edith, sradicata dalla sua terra, rinnegata nella sua vera identità, si vendica con gli innocenti, divenendo l’incarnazione stessa del male. Non un male metafisico ma un male concreto, fisico, umiliante. Con disprezzo, questa quattordicenne venduta e sfruttata, si vendicherà con gli internati dei dolori patiti. Il film, a tratti sensazionalistico e retorico, mostra un Pontecorvo attento ai movimenti di macchina, alle panoramiche che esprimono al meglio una visione in cui le persone compongono un paesaggio veritiero e mentale, ma sono altresì elemento pittorico e scenografico principale. Il bianco e nero “nebbioso” di alcune sequenze, ottenuto controtipando il negativo della pellicola, restituisce il sapore di una visione plumbea e fantasmatica, dove i volti sono sagome spettrali pronte ad essere presto sostituite nel magma dell’indistinzione, dove peraltro l’intento dell’autore favorisce il riconoscimento, secondo una suggestione che sarà frequentata molti anni dopo anche dallo Spielberg di Schindler’s list. Il dolore e la rassegnazione sui volti dei reclusi è contestuale alle smorfie di derisione nei confronti dei carcerieri e in Kapò ciò che vediamo obbedisce ad un exploit espressivo di efficace mimetismo estetico. La speranza è bandita dal campo, mentre dominano l’angoscia e il tramonto dell’ideale. Edith ad un certo punto del suo nuovo “status” riconosce di stare meglio rispetto al momento del suo ingresso al campo. Ha da mangiare, non patisce il freddo, può riposarsi. Il suo temporaneo equilibrio è però minacciato dal futuro incerto. Nel film assistiamo infatti alla riproduzione di un periodo piuttosto lungo in cui i nazisti, dapprima impegnano gli internati per farli lavorare e produrre quindi, quando lo spettro della disfatta del sogno del Reich millenario diviene tangibile, si affrettano a cancellare le tracce del loro operato criminale.
Le Kapò, anello di congiunzione tra i detenuti e il comando del campo, sono in Pontecorvo figure tratte direttamente dai ricordi evocati in “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Sono figure graduate, addestrate alla ferocia, che cercano un riscatto dalla loro condizione di semplice numero per accedere ad una posizione, pur provvisoria e ambigua, di dominio. In loro covano e si esprimono le peggiori qualità dell’individuo e sono l’emblema stesso dell’assenza di solidarietà, in una volontà di annientamento che l’“esperimento” dei lager traduce in riduzione della dimensione collettiva ad astrazione, regola che coinvolge l’umano piegandolo in un subdolo e antiumanistico ammassamento sul corpo e sul fisico, giogo di morte che cancella ogni spiritualità. Edith, sradicata dalla sua terra, rinnegata nella sua vera identità, si vendica con gli innocenti, divenendo l’incarnazione stessa del male. Non un male metafisico ma un male concreto, fisico, umiliante. Con disprezzo, questa quattordicenne venduta e sfruttata, si vendicherà con gli internati dei dolori patiti. Il film, a tratti sensazionalistico e retorico, mostra un Pontecorvo attento ai movimenti di macchina, alle panoramiche che esprimono al meglio una visione in cui le persone compongono un paesaggio veritiero e mentale, ma sono altresì elemento pittorico e scenografico principale. Il bianco e nero “nebbioso” di alcune sequenze, ottenuto controtipando il negativo della pellicola, restituisce il sapore di una visione plumbea e fantasmatica, dove i volti sono sagome spettrali pronte ad essere presto sostituite nel magma dell’indistinzione, dove peraltro l’intento dell’autore favorisce il riconoscimento, secondo una suggestione che sarà frequentata molti anni dopo anche dallo Spielberg di Schindler’s list. Il dolore e la rassegnazione sui volti dei reclusi è contestuale alle smorfie di derisione nei confronti dei carcerieri e in Kapò ciò che vediamo obbedisce ad un exploit espressivo di efficace mimetismo estetico. La speranza è bandita dal campo, mentre dominano l’angoscia e il tramonto dell’ideale. Edith ad un certo punto del suo nuovo “status” riconosce di stare meglio rispetto al momento del suo ingresso al campo. Ha da mangiare, non patisce il freddo, può riposarsi. Il suo temporaneo equilibrio è però minacciato dal futuro incerto. Nel film assistiamo infatti alla riproduzione di un periodo piuttosto lungo in cui i nazisti, dapprima impegnano gli internati per farli lavorare e produrre quindi, quando lo spettro della disfatta del sogno del Reich millenario diviene tangibile, si affrettano a cancellare le tracce del loro operato criminale.
 Quando nel campo sopraggiungono i soldati russi che raccontano a tutti l’evoluzione della Guerra (lo sbarco degli alleati sul fronte occidentale e l’avanzata dell’armata rossa), Edith, che nel frattempo si è innamorata del soldato Sascha, sente con le sue orecchie che le ex compagne di cella saranno liquidate al ritmo cinquemila al giorno, e anche per lei si profila un destino tetro. Il sacrificio finale, una traiettoria drammaturgica beatificante e assolutoria (con Edith che sceglie di liberare i prigionieri andando incontro a morte certa), non era nelle intenzioni di Pontecorvo, che avrebbe preferito lasciare alla coscienza di Edith il compito di dolersi e rimuginare. Forzature drammaturgiche, accenti retorici, tratti di patetismo e momenti di dubbia plausibilità, non snaturano l’efficacia espressiva di un film bello e necessario pur nella sua evidente incompiutezza, tra i primi a mostrare la logica dei lager e le fosse dei cadaveri. Ispirandosi a Primo Levi, Pontecorvo resta, con la sua estetica precisa e limpida, ben lontano dall’estetismo decadente di altri autori che si avvicineranno al nazismo e alle sue espressioni di ottenebrante autoreferenzialità. In Pontecorvo il totalitarismo germanico è colto nel suo momento di accecante azzeramento dell’umano, ma il film non travalica nell’immagine del mostro assetato di sangue che conosciamo tramite una vasta mitografia. Proprio come in Levi, di cui Kapò rispetta l’umanità profonda, non si esprimono accuse affrettate e non si generalizza sulle corresponsabilità.
Quando nel campo sopraggiungono i soldati russi che raccontano a tutti l’evoluzione della Guerra (lo sbarco degli alleati sul fronte occidentale e l’avanzata dell’armata rossa), Edith, che nel frattempo si è innamorata del soldato Sascha, sente con le sue orecchie che le ex compagne di cella saranno liquidate al ritmo cinquemila al giorno, e anche per lei si profila un destino tetro. Il sacrificio finale, una traiettoria drammaturgica beatificante e assolutoria (con Edith che sceglie di liberare i prigionieri andando incontro a morte certa), non era nelle intenzioni di Pontecorvo, che avrebbe preferito lasciare alla coscienza di Edith il compito di dolersi e rimuginare. Forzature drammaturgiche, accenti retorici, tratti di patetismo e momenti di dubbia plausibilità, non snaturano l’efficacia espressiva di un film bello e necessario pur nella sua evidente incompiutezza, tra i primi a mostrare la logica dei lager e le fosse dei cadaveri. Ispirandosi a Primo Levi, Pontecorvo resta, con la sua estetica precisa e limpida, ben lontano dall’estetismo decadente di altri autori che si avvicineranno al nazismo e alle sue espressioni di ottenebrante autoreferenzialità. In Pontecorvo il totalitarismo germanico è colto nel suo momento di accecante azzeramento dell’umano, ma il film non travalica nell’immagine del mostro assetato di sangue che conosciamo tramite una vasta mitografia. Proprio come in Levi, di cui Kapò rispetta l’umanità profonda, non si esprimono accuse affrettate e non si generalizza sulle corresponsabilità.
 Quando Edith va a interrompere la corrente elettrica per liberare il campo, gli ebrei scappano e molti rimangono uccisi, nessuno è un eroe e nessuno tra i tedeschi rinuncia a sparare l’ultima inevitabile pallottola. I fatti parlano da soli e la storia procede con una furia inarrestabile. Il sistema nazista arriva alle sue estreme conseguenze pseudoscientifiche e non si sottrae dinanzi all’inevitabile scempio. Ma non per questo il film generalizza sul male facendone un’entità metafisica. In precise condizioni storiche, in un mondo che ha capovolto i valori, ciò che è stato pensato secondo una logica totalitaria ha espresso i suoi devastanti ed imperdonabili effetti. L’uomo intrappolato, piegato al biologico, incatenato alla sua condizione fisica (una condizione di cui ci ha parlato il filosofo Emanuel Levinas), è una spasmodica deriva della ratio occidentale, che deve suggerire il monito della riflessione e chiama i suoi imputati dinanzi al tribunale delle responsabilità storiche. Il racconto di Pontecorvo propende per un’oggettività pur lambita dalle forzature e dalle briglie di un certo cinema che si pretende libero ma che subisce nondimeno i condizionamenti della produzione corrente. Il nazista, il grande imputato, nel suo film resta ancora da sottoporre ai riflettori dell’accusa, perché’ lo sguardo di Pontecorvo fotografa, non accusa. Lui, ebreo coinvolto direttamente nella resistenza, con il suo film permette ai contemporanei di riflettere, ma non induce a conclusioni rapide e irriflesse. Il suo sgomento non glielo permette. In questo senso il riferimento a Levi, alla sua profonda riflessione, è il miglior segno di onestà intellettuale.
Quando Edith va a interrompere la corrente elettrica per liberare il campo, gli ebrei scappano e molti rimangono uccisi, nessuno è un eroe e nessuno tra i tedeschi rinuncia a sparare l’ultima inevitabile pallottola. I fatti parlano da soli e la storia procede con una furia inarrestabile. Il sistema nazista arriva alle sue estreme conseguenze pseudoscientifiche e non si sottrae dinanzi all’inevitabile scempio. Ma non per questo il film generalizza sul male facendone un’entità metafisica. In precise condizioni storiche, in un mondo che ha capovolto i valori, ciò che è stato pensato secondo una logica totalitaria ha espresso i suoi devastanti ed imperdonabili effetti. L’uomo intrappolato, piegato al biologico, incatenato alla sua condizione fisica (una condizione di cui ci ha parlato il filosofo Emanuel Levinas), è una spasmodica deriva della ratio occidentale, che deve suggerire il monito della riflessione e chiama i suoi imputati dinanzi al tribunale delle responsabilità storiche. Il racconto di Pontecorvo propende per un’oggettività pur lambita dalle forzature e dalle briglie di un certo cinema che si pretende libero ma che subisce nondimeno i condizionamenti della produzione corrente. Il nazista, il grande imputato, nel suo film resta ancora da sottoporre ai riflettori dell’accusa, perché’ lo sguardo di Pontecorvo fotografa, non accusa. Lui, ebreo coinvolto direttamente nella resistenza, con il suo film permette ai contemporanei di riflettere, ma non induce a conclusioni rapide e irriflesse. Il suo sgomento non glielo permette. In questo senso il riferimento a Levi, alla sua profonda riflessione, è il miglior segno di onestà intellettuale.
.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
Vivere il Cinema 12o Stage Fedic
di Giorgio Sabbatini
foto di Giorgio Sabbatini
Per chi ama le immagini, per chi desidera “raccontare” con le immagini o per chi ha una passione per il Cinema e vuole viverlo in prima persona esistono vari modi, oggi, per documentarsi sia da un punto di vista propriamente tecnico sia dal lato del linguaggio filmico.
Conoscere, studiare e capire i meccanismi che regolano il mondo delle immagini, sono tre fasi importanti per crescere culturalmente e per verificare quale sia l’effettivo interesse che ci spinge ad affrontare e risolvere le non poche problematiche che si incontrano nella realizzazione di una breve fiction.
Se, talvolta, la “teoria” obbliga a seguire percorsi particolarmente impegnativi, per apprendere le basi necessarie ad entrare in sintonia con il linguaggio delle immagini, non dobbiamo dimenticare che la “pratica” sia un fantastico modo per sperimentare direttamente le nostre capacità realizzative e, naturalmente, i nostri limiti.
 Quest’anno la Fedic, con l’insostituibile supporto tecnico-organizzativo di ‘Corte Tripoli Cinematografica’, ha offerto ai suoi iscritti la possibilità di partecipare al 12o Stage in un ambiente molto accogliente come l’Agriturismo ‘I Felloni’ (Foto 1), a Calci in provincia di Pisa. Lo Stage nazionale di Formazione ed Approfondimento è stato dedicato alla ‘Regia’, un argomento di grande spessore che ha visto impegnati numerosi partecipanti sotto la guida del Docente e Regista Giuseppe Ferlito (Foto 2).
Quest’anno la Fedic, con l’insostituibile supporto tecnico-organizzativo di ‘Corte Tripoli Cinematografica’, ha offerto ai suoi iscritti la possibilità di partecipare al 12o Stage in un ambiente molto accogliente come l’Agriturismo ‘I Felloni’ (Foto 1), a Calci in provincia di Pisa. Lo Stage nazionale di Formazione ed Approfondimento è stato dedicato alla ‘Regia’, un argomento di grande spessore che ha visto impegnati numerosi partecipanti sotto la guida del Docente e Regista Giuseppe Ferlito (Foto 2).
.
.
.
.
L’argomento ‘Regia’ è sempre molto complesso da trattare poiché richiede la conoscenza di numerosi settori tecnici necessari per la realizzazione di un “corto”. In quattro giorni di completa attività destinata alla discussione della sceneggiatura, alle riprese ed al montaggio è, praticamente, impossibile soffermarsi su alcune scelte tecniche poiché manca il tempo minimo da impiegare per un’approfondita spiegazione. Tutto ciò è comprensibile ma spiace, specialmente per alcuni giovani che per la prima volta affrontano i problemi del set, dovere operare senza conoscere le singole problematiche che sono risolte, in modo quasi automatico, dal ‘Regista’.
Tutti i partecipanti, alcuni giorni prima dell’inizio dello Stage, hanno ricevuto la sceneggiatura, dal titolo Vendita porta a porta, scritta da Paolo Beatini, per prenderne visione ed, eventualmente, proporre delle modifiche o integrazioni. Da una prima lettura si intuisce subito che l’azione che si sviluppa nel racconto è piuttosto statica poiché la trama si basa sul dialogo dei due personaggi principali, attraverso i quali si susseguono alcune scene di non facile interpretazione per le difficoltà emotive che gli attori devono sapere esprimere.
Nel primo giorno dello Stage si effettua una lettura collettiva con le prove degli attori che si sono proposti ad interpretare i personaggi richiesti. Il Regista Giuseppe Ferlito è assente per un impegno di lavoro e la lettura è condotta da Roberto Merlino che (Foto 3), con l’aiuto di tutti, cerca di impostare alcune soluzioni di ripresa valutando, di volta in volta, le migliori proposte da prendere in considerazione. È un momento formativo interessante poiché obbliga tutti ad essere propositivi in breve tempo e, quindi, ad interpretare, registicamente, lo sviluppo del racconto con diverse soluzioni.
L’arrivo di Giuseppe Ferlito impone subito la scelta di coloro che dovranno interpretare i due personaggi principali, un uomo ed una donna, oltre alla decisione di chi coinvolgere nella parte della ‘morta’. La breve fiction, infatti, ha un risvolto piuttosto lugubre e tragico poiché la trama si accentra sulla figura di un uomo psicopatico che vive il suo dramma interiore in una irreversibile follia.
.
Si effettuano brevi provini leggendo alcune battute previste dalla sceneggiatura e, dopo una veloce valutazione di Ferlito, la scelta cade su Valerio Cibrario (Foto 4), che interpreterà la parte del professore Franco Ferri, e su Antonella Santarelli (Foto 5) che rappresenterà la figura di Cecilia, una venditrice di cosmetici. La parte della ‘morta’ è assegnata ad Alessandra Ubiali (Foto 6), nel ruolo di Valentina Rosetti, una ex allieva del professore Ferri,
Si discute, quindi, la sceneggiatura e Ferlito, per creare un po’ di atmosfera ed un minimo di azione, propone una modifica iniziale inserendo un temporale, la fine della pioggia e l’arrivo della macchina di Cecilia nel luogo dove vive il professore Ferri. Per visualizzare le immagini che potrebbero diventare reali inquadrature della fiction la mano esperta di Ettore Di Gennaro (Foto 7), della 3dproduction, disegna un inizio di storyboard con pochi tratti ben definiti che danno una chiara idea di ciò che si vuole realizzare. Purtroppo non c’è il tempo necessario per approfondire questo momento altamente creativo e si decide di iniziare le riprese poiché altre rilevanti modifiche alla sceneggiatura non devono essere apportate.
Sono stato sempre convinto che nella realizzazione di un’opera collettiva alla quale tutti gli interessati devono potere partecipare nel modo più completo, sia necessario, per non dire indispensabile, organizzare dei gruppi di persone assegnando particolari mansioni inerenti il lavoro che si sta affrontando.
.
.
.
Faccio un esempio banale sperando di chiarire il mio pensiero. Per le riprese negli interni è necessario utilizzare delle sorgenti di luce artificiale e si può demandare ad un gruppo di persone di creare una giusta illuminazione del set, in accordo con il Regista, cercando di proporre le atmosfere previste nella sceneggiatura, mentre un ridotto gruppo si occupa della taratura della telecamera e della scelta del migliore diaframma per una buona resa fotografica. Nello stesso tempo, sempre per coinvolgere il maggiore numero di partecipanti allo Stage, possono essere raddoppiati i ruoli di ‘aiuto regista’ e ‘segretaria di edizione’. Anche la figura dell’operatore può essere assegnata a due o tre persone che possano alternarsi durante le riprese facendo, quindi, un’esperienza diretta sempre importante e stimolante. Altri possono organizzarsi per intervenire in caso di ‘rumori estranei’ ed informare tutti dell’inizio della singola ripresa per mantenere il ‘silenzio’ durante la fase di registrazione.
 Vari ruoli operativi permettono una maggiore partecipazione al lavoro che si sta facendo e dall’esperienza collettiva si possono trarre benefici di carattere tecnico-culturale particolarmente significativi per chi vuole crescere e comprendere meglio il complesso meccanismo del ‘racconto filmico’. Quattro giorni di intenso lavoro, comunque, hanno permesso a chi era realmente interessato di portare a termine la lavorazione della fiction (Foto 8) e di seguire ogni fase delle riprese relative alle differenti scene cercando di osservare con attenzione il modo di operare del Regista.
Vari ruoli operativi permettono una maggiore partecipazione al lavoro che si sta facendo e dall’esperienza collettiva si possono trarre benefici di carattere tecnico-culturale particolarmente significativi per chi vuole crescere e comprendere meglio il complesso meccanismo del ‘racconto filmico’. Quattro giorni di intenso lavoro, comunque, hanno permesso a chi era realmente interessato di portare a termine la lavorazione della fiction (Foto 8) e di seguire ogni fase delle riprese relative alle differenti scene cercando di osservare con attenzione il modo di operare del Regista.
.
.
.
.
Devo dire che il mio maggiore interesse, nella realizzazione della breve fiction, è stato catturato dal coinvolgente lavoro di Ferlito nel modo di istruire i due attori suggerendo, in base allo sviluppo del racconto (Foto 9), il comportamento più adatto alla scena da realizzare. Una grande pazienza e conoscenza dell’animo umano per stimolare le giuste reazioni e cogliere gli attimi migliori che i due attori, alle prime armi, potevano esprimere con innata naturalezza. Non tutti i partecipanti, purtroppo, hanno avuto la costanza di seguire questo specifico modo di operare professionalmente con ‘attori non attori’ rendendo, talvolta, con pochi chiari interventi del Regista, semplice un lavoro certamente complesso per le varie possibilità che parole ed atteggiamenti gestuali possano trasmettere sensazioni ed emozioni allo spettatore.
Non tutte le scene realizzate sono state utilizzate ai fini del racconto. Infatti, alcune, introdotte durante la lavorazione, si sono rivelate inadatte e, di conseguenza, eliminate cercando di dare maggiore ritmo e consistenza alla trama originaria. L’impegno dei due attori è stato davvero notevole e, gradatamente, durante lo svolgersi delle riprese entrambi sono riusciti ad ‘entrare’ nei personaggi rappresentati dando modo di valorizzare alcuni loro atteggiamenti naturali.
A riprese ultimate si è passato ad una delle più belle fasi realizzative: il montaggio (Foto 10). È un momento di grande creatività che permette al Regista di armonizzare le diverse inquadrature cercando di esprimere al meglio tutte le possibili emozioni vissute e destinate ad essere trasferite al pubblico.
Anche in questo caso la capacità di creare dipende dalla pazienza di sapere scegliere le migliori immagini ed il giusto ‘taglio’ di ‘continuità’ o ‘collegamento’. Essere attenti nella ‘continuità’ tra due inquadrature osservando la posizione degli attori, dei loro sguardi senza dimenticare gli oggetti posti nella scenografia, è indispensabile per non incorrere in facili errori. E, ancora, inventando il ‘collegamento’ più funzionale tra due scene si può dare uno stile al racconto. Un lavoro che si dovrebbe fare senza problemi di tempo ma liberi di operare nell’assoluta tranquillità della propria conoscenza tecnica.
Il montaggio rappresenta un momento creativo, coinvolgente e di grande interesse che, però, può essere apprezzato solo da chi possiede una grande passione per l’arte delle immagini ed è disposto a considerare prezioso, per una continua crescita della propria esperienza, tutte le ore trascorse di fronte ad un computer ed al suo monitor. In questa fase finale dello Stage pochi partecipanti hanno sentito la necessità di vedere come possa crescere e svilupparsi una fiction che dalla scrittura di una sceneggiatura prende forma nel modo più ampio possibile attraverso le immagini e la colonna sonora. Una ‘colonna sonora’, in parte originale, composta dal maestro Sergio Brunetti (Foto 11), ed integrata da alcuni brani musicali scelti dal Regista, con il preciso intento di sottolineare alcuni momenti di particolare interesse emotivo.
Un intenso lavoro per uno Stage ricco di momenti aggregativi durante i quali è stato possibile conoscere ed apprezzare le varie fasi relative alla realizzazione di una breve fiction, con tutte le problematiche che il set può fornire con inaspettata puntualità.
La proiezione dell’opera finita, e rinominata Make-up, ha dato modo a tutti di essere orgogliosi e soddisfatti per un lavoro portato a termine in così breve tempo e di essere stati protagonisti di un momento molto creativo e di grande importanza per l’esperienza fatta e per una propria crescita culturale che, nel tempo, potrà essere sempre più apprezzata.
.
Campus Estivo “NaturalmenteCinema”
di Laura Biggi
foto di Lorenzo Caravello
Lo scorso Luglio si è tenuto a Fivizzano, in Lunigiana (MS), il 1° Campus estivo di Cinema per bambini e ragazzi di Fedic Scuola denominato “NaturalmenteCinema”. L’idea risale a circa due anni fa, quando, analizzando le varie opportunità formative offerte dalla nostra federazione, tra cui lo Stage Nazionale Fedic, ho constatato che mancava, a livello istituzionale, un’iniziativa similare rivolta ai giovanissimi. Per questo motivo ho pensato di proporre un’attività che, in oltre 60 anni di Fedic, non era mai stata realizzata: un campus residenziale rivolto ad alunni dai 7 ai 14 anni d’età.
Dall’ideazione alla realizzazione è stato un percorso ad ostacoli, una gimcana tra procedure burocratiche, soprattutto per stabilire e mantenere contatti e rapporti comunicativi e progettuali sistematici e proficui con i vari partner del progetto. Superata una iniziale, e tuttavia comprensibile diffidenza, verso una proposta ritenuta forse inusuale, e dopo numerosi incontri con rappresentanti dell’amministrazione comunale di Fivizzano, la nostra idea è stata ritenuta interessante sia per il valore culturale e formativo, che come strumento di promozione del territorio lunigianese in ambito nazionale.
Il patrocino del comune di Fivizzano, della Pro Loco e del Parco delle Apuane hanno consentito di ottenere gratuitamente il trasporto e gli ingressi durante le escursioni, in particolare alla Grotta, al museo e alle piscine termali di Equi Terme, piccolo borgo famoso per l’acqua solforosa e per ritrovamenti archeologici di epoca preistorica, (resti dell’orso speleo).
L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, che ha sostenuto il progetto, ha consentito di effettuare due escursioni guidate alla scoperta delle peculiarità dell’ambiente naturale (specie endemiche) e delle tradizioni locali. Lungo impervi sentieri di montagna, sotto le fronde dei castagni, rinfrescati dalle acque dei ruscelli, bambini e ragazzi hanno imparato a conoscere ed esplorare la natura, non solo con i propri sensi, ma catturando immagini e suoni tramite “l’occhio e l’orecchio di videocamera e fotocamera”.
.
.
.
I partecipanti erano bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, alcuni di origine straniera, provenienti sia dalla Lunigiana che da altre località italiane erano alloggiati in coloratissime camere dell’ ex convento degli Agostiniani, affascinante edificio, in cui sono state ambientate anche alcune scene del cortometraggio prodotto durante il soggiorno.
.
.
.
.
Come docente ho avvertito la necessità di organizzare un campus estivo che avesse validi requisiti pedagogici, formativi ed educativi, ed al contempo metodologie e contenuti accattivanti. I ragazzi con i quali ci rapportiamo quotidianamente sono “nativi digitali”, costituiscono la generazione nata e cresciuta con internet e le nuove tecnologie, questo favorisce indubbiamente la comunicazione e condivisione in tempo reale di informazioni (testi ed immagini). Esiste però il rischio, non del tutto remoto, che l’uso massiccio dei media conduca i più giovani all’isolamento e al progressivo distacco dalla realtà. Il compito dell’adulto-educatore sarà quello di non demonizzare la tecnologia, bensì di avvalersene per favorire percorsi didattici che consentano al ragazzo di essere protagonista del proprio percorso formativo, passando da una conoscenza sequenziale ad una reticolare, nell’ottica di un apprendimento attivo e condiviso. La tecnologia, e quindi il linguaggio cinematografico, saranno dunque strumento prezioso, ma non potranno o dovranno sostituire le capacità di pensiero, creazione, elaborazione e relazione proprie dell’individuo. Giochi motori ed attività espressive, proposti fin dalla prima giornata, hanno favorito la socializzazione, la condivisione di esperienze e il raggiungimento di un obiettivo comune (raggiungere la vetta della montagna… o realizzare un film) hanno contribuito a costituire un gruppo affiatato, un clima di familiarità e collaborazione in cui potersi divertire ed imparare elaborando insieme strategie di situazioni problematiche (problem solving).
La modalità ludica ed esperienziale ha consentito di istaurare rapporti interpersonali significativi e proficui da cui sono emersi spunti creativi e proposte interessanti. Già dal secondo giorno è iniziato il lavoro di realizzazione di un film, scegliendo insieme la storia, adattandola alle esigenze dei bambini e dello staff, ed individuando personaggi ed interpreti. Nel corso della settimana i ragazzi hanno potuto sperimentare direttamente diverse tecniche espressive di recitazione ed interpretazione grazie alle attività proposte da Margherita Caravello (attrice teatrale formatasi con maestri internazionali del panorama teatrale e diplomata presso Teatro Senza Tempo Accademia di Roma, laureata in Teatro e Arti Performative presso l’Università La Sapienza). Altri giovani hanno fornito la propria competenza professionale: Nadia Abate Diplomata al Centro di Cinematografia sezione Animazione di Torino ha realizzato una breve sigla animata presentata in apertura del progetto video finale; Marco Segnan giovane musicista di origine carrarese ha frequentato il SAE Institute a Milano conseguendo le seguenti specializzazioni: Audio Engineer e Bachelor of Arts Audio Production; ha composto ed interpretato il brano musicale Ciak si impara, sigla e tormentone dell’intera settimana e colonna sonora del relativo videoclip di backstage. Lo staff tecnico del Gruppo Cineamatori delle Apuane (Cineclub Fedic) in particolare Lorenzo Caravello, Corrado Armanetti, Marino Santini, Alberto Cavanna, ha realizzato riprese video e montaggio durante tutte le fasi del progetto.
 I ragazzi si sono inoltre avvicinati all’uso della telecamera e delle altre strumentazioni tecniche per un primo approccio al linguaggio cinematografico. Molteplici sono state le attività svolte: uso della telecamera a circuito chiuso, (piani e campi di ripresa, regolazione manuale del fuoco), esperienza di doppiaggio di alcune clip di un film di animazione, sperimentazione chroma-key per gli effetti speciali, uso della go-pro per riprese dinamiche e subacquee.
I ragazzi si sono inoltre avvicinati all’uso della telecamera e delle altre strumentazioni tecniche per un primo approccio al linguaggio cinematografico. Molteplici sono state le attività svolte: uso della telecamera a circuito chiuso, (piani e campi di ripresa, regolazione manuale del fuoco), esperienza di doppiaggio di alcune clip di un film di animazione, sperimentazione chroma-key per gli effetti speciali, uso della go-pro per riprese dinamiche e subacquee.
.
.
.
A fine settimana, alla presenza del sindaco di Fivizzano Paolo Grassi, di fronte a familiari e concittadini è stato proiettato il cortometraggio realizzato: “Una storia incredibile” ispirato al libro “L’incredibile storia di Lavinia” di Bianca Pitzorno. Inoltre sono state presentate brevi clip video delle esperienze vissute.
La città di Fivizzano, per una settimana, è stata animata da un cast colorato e vivace di ragazzi che hanno invaso con la loro carica vitale strade e piazze, recitando, cantando e ballando a qualsiasi ora e con ogni condizione climatica. Corsisti ed organizzatori si sono dichiarati molto soddisfatti per la riuscita dell’evento, senza dubbio un’esperienza da riproporre.
A SIPARIO CALATO:
SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2014
di Francesco Saverio Marzaduri
La rassegna che ogni anno Forlì dedica al cortometraggio, il “Sedicicorto International Film Festival,” ha appena concluso la sua undicesima edizione. Lo sforzo organizzativo è stato ripagato dal pubblico, che ha risposto con slancio, intervenendo numeroso, non solo alle proiezioni dei film in concorso – 136 selezionati su un totale di ben 4.608, inviati da 122 nazioni; ma anche alle iniziative collaterali: sei rassegne fuori concorso – “Cortinloco,” “Focus Romania,” “Focus Dog,” “Centocorti,” “Experia,” “Retro Feijó/Pessoa.” Lezioni di cinema, due laboratori per la realizzazione di film d’animazione, una conferenza dedicata al western all’italiana, un concerto interamente dedicato a temi musicali western e i consueti incontri con registi, attori e sceneggiatori dei cortometraggi in competizione.
Segno evidente del fatto che il cortometraggio si presenta quale interessante occasione tesa a stimolare la curiosità non soltanto di chi desideri cimentarsi in tale ambito, ma anche di un pubblico disponibile ad osservare con occhi attenti nuove strade e nuovi orizzonti.
Il 3 ottobre presso il cinema Astoria, la sezione “Cortinloco” ha inaugurato il festival, proiettati dieci fra i migliori cortometraggi della produzione romagnola degli ultimi anni.
.
.
 Il “Focus Romania” si è tenuto il giorno seguente all’Auditorium Cariromagna, i nove lavori presentati, divisi tra fiction, sperimentale e animazione, hanno messo in luce come la produzione cinematografica del Paese, rifiorita in questi ultimi anni, documenti le enumerabili contraddizioni della realtà anche attraverso storie in apparenza semplici. Al termine delle proiezioni, per allargare l’ambito della comprensione culturale, è stato offerto un buffet a base di specialità gastronomiche romene.
Il “Focus Romania” si è tenuto il giorno seguente all’Auditorium Cariromagna, i nove lavori presentati, divisi tra fiction, sperimentale e animazione, hanno messo in luce come la produzione cinematografica del Paese, rifiorita in questi ultimi anni, documenti le enumerabili contraddizioni della realtà anche attraverso storie in apparenza semplici. Al termine delle proiezioni, per allargare l’ambito della comprensione culturale, è stato offerto un buffet a base di specialità gastronomiche romene.
.
.
.
Domenica 5, il glorioso cinema-teatro Apollo ha ospitato la sezione “Experia,” dedicata al corto sperimentale, con nove opere presentate, e il “Focus Dog,” nove film dove il miglior amico dell’uomo ricopriva i ruoli più disparati, da poliziotto narcolettico ad implacabile salvatore di un aspirante suicida. Non sono mancati i disegni animati, ora divertenti o dissacranti, ora ispirati a tragici episodi realmente accaduti agli amici a quattro zampe.
.
.
.
.
Alcuni ragazzi hanno partecipato al festival da vicino, scoprendo cosa accende e alimenta la macchina dei sogni e quali siano i trucchi del mestiere, adottati in una forma – il cortometraggio, appunto – complessa e coinvolgente. Tutto ciò, attraverso un laboratorio d’animazione in stop motion dal titolo “Il buono, il brutto, il cattivo,” che ha visto coinvolti alunni di quinta elementare; e con un secondo laboratorio, “Il lungo, il corto e…,” nel quale ragazzi di terza media erano impegnati nella scoperta di tecniche più complesse, quali: flipbook , pixillation, flash e self-made drawings.
Entrambi i corsi, diretti da Claudio Tedaldi, hanno realizzato due cortometraggi animati, intitolati come i rispettivi laboratori, anch’essi presentati nel corso della serata di premiazione del festival.
Il “Sedicicorto” ha inoltre offerto la possibilità ai ragazzi di partecipare ad una serie di lezioni di cinema, tenute da Riccardo Salvetti, uno dei registi di Closed Box – A scatola chiusa, cortometraggio presentato e premiato al festival lo scorso anno col “Fedic”. Nel corso di tali incontri, tanti i temi trattati: dall’analisi di un film all’approccio con la macchina da presa, dall’ elaborazione d’idee alla loro stesura, fino al soggetto e alla realizzazione di un documentario. Tema di quest’ultima edizione della rassegna è stato lo “spaghetti western,” in onore del leoniano Per un pugno di dollari e del suo cinquantesimo compleanno. Sabato 11, all’Apollo, ha avuto luogo una conversazione sui western di produzione italiana, a cura di un esperto quale Andrea Bruni, durante il quale il pubblico è intervenuto con osservazioni e domande. Ad aprire l’incontro il documentario L’America a Roma, realizzato da Gianfranco Pannone, incentrato sui volti più frequentemente visti, e magari più facilmente dimenticati, di questo specifico genere.
Nell’Auditorium, la premiazione è stata preceduta dall’esecuzione di celebri colonne sonore western, a firma di Ennio Morricone, Luis Bacalov e Elmer Bernstein, eseguite per l’occasione da Yuri Ciccarese al flauto e da Elena Indellicati al pianoforte. Sullo schermo, nel frattempo, scorrevano immagini tratte dal picaresco Occhio alla penna, diretto da Michele Lupo e interpretato da Bud Spencer.
.
.
.
.
Veniamo ora ai vincitori delle quattro categorie in gara “Animalab,” “Animare,” “Cortitalia” e “Movie”. Per la sezione “Movie,” il premio della giuria – composta da un’attrice, un regista, una produttrice e due critici – è stato assegnato al film di produzione vietnamita Xe tải của bố del brasiliano Mauricio Osaki. Il premio della sezione “Animalab” è andato al croato Simulacra di Ivana Bošnjak e Thomas Johnson, ritenuto capace secondo la giuria, formata da registi di animazione, di accostare immaginario e reale in modo sorprendente. Il premio “Cortitalia” finisce nelle meritevoli mani di Valerio Vestoso, il suo Tacco 12 è un mockumentary divertente sulla pericolosità sociale dei balli di gruppo, pretesto per una critica sulla televisione del dolore.
.
 Il film di animazione tedesco Dustin di Kristina Jäger, che narra la convivenza domestica tra un cane ed un aspirapolvere, conquista il premio “Animare.” Il pubblico ha assegnato il premio “Cortinloco,” sezione non competitiva ma particolarmente sentita, che incensa le migliori produzioni del territorio romagnolo, a E’ Divéri di Silvia Bigi.
Il film di animazione tedesco Dustin di Kristina Jäger, che narra la convivenza domestica tra un cane ed un aspirapolvere, conquista il premio “Animare.” Il pubblico ha assegnato il premio “Cortinloco,” sezione non competitiva ma particolarmente sentita, che incensa le migliori produzioni del territorio romagnolo, a E’ Divéri di Silvia Bigi.
.
.
.
.
.
.
.

Premiati dal presidente Fedic Roberto Merlino il regista Francesco Zucchi (centro) e l’attore Roberto Agostino (destra)
Si è infine aggiudicato il premio “Fedic” Piove, autori Francesco Zucchi e Lu Pulici, girato interamente a Pennabilli, mentre l’interprete Roberto Agostino ha ricevuto il premio quale miglior attore.
.
.
.
.
.
.
.
.
Archiviata, ad maiora, quest’edizione del festival, l’organizzazione già pensa alla prossima, che si terrà dal 8 al 17 ottobre 2015. Il suo tema è stato rivelato nel corso della serata finale. Che sarà Maciste e i forzuti.
.
.
.
.
.
FESTIVAL
ANNECY 2014 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM D’ANIMAZIONE.
UN FESTIVAL CHE VOLA.
Di Giancarlo Zappoli
 Molti degli appassionati di cinema conoscono sicuramente il Festival di Annecy che si può ritenere, senza tema di essere smentiti, la più importante manifestazione legata al cinema d’animazione che si tenga in Europa (e forse anche in un ambito più vasto). Non tutti però forse sono a conoscenza di cosa accade in molte delle sale prima dell’inizio delle proiezioni. Con i fogli formato A4 su cui vengono riportati programma o informazioni varie si fanno (chi è capace ovviamente) degli aeroplanini che vengono lanciati dal fondo verso il palco. Quelli che lo raggiungono ottengono un applauso, gli altri vengono raccolti e rilanciati indietro. Perché raccontare ciò? Perché fa comprendere il clima di vera festa del cinema che si vive nella splendida cittadina francese nei giorni della manifestazione a cui si aggiunge il fatto che l’aeroplanino di carta è diventato un simbolo della stessa ed è entrato a far parte del breve filmato di animazione che lancia le serate e si rinnova ogni anno. Ad Annecy vengono proiettati in prima nazionale od internazionale dei lungometraggi ma il vero cuore della manifestazione sono le diverse sezioni di concorso (e fuori concorso) di cortometraggi tutti rigorosamente d’animazione gran parte dei quali davvero originali per soggetto e grafica. Quest’anno però si è avuta un’eccezione nei lungometraggi: si tratta di O menino e o mundo di Ale Abreu.La vicenda tratta di un bambino il cui padre abbandona la famiglia non per disamore ma per mancanza di lavoro. Il figlio decide di andare a cercarlo, conosce il mondo con le sue ingiustizie ma gli resta sempre come fonte di colore e di vita l’amore dei suoi genitori tra di loro e per lui. Abreu ha utilizzato quasi tutte le tecniche possibili dell’animazione (tranne la tridimensionalità) senza mai scadere nell’autocompiacimento manieristico anzi offrendo allo spettatore una miriade di occasioni di piacere per gli occhi che sostanziano al contempo la narrazione.
Molti degli appassionati di cinema conoscono sicuramente il Festival di Annecy che si può ritenere, senza tema di essere smentiti, la più importante manifestazione legata al cinema d’animazione che si tenga in Europa (e forse anche in un ambito più vasto). Non tutti però forse sono a conoscenza di cosa accade in molte delle sale prima dell’inizio delle proiezioni. Con i fogli formato A4 su cui vengono riportati programma o informazioni varie si fanno (chi è capace ovviamente) degli aeroplanini che vengono lanciati dal fondo verso il palco. Quelli che lo raggiungono ottengono un applauso, gli altri vengono raccolti e rilanciati indietro. Perché raccontare ciò? Perché fa comprendere il clima di vera festa del cinema che si vive nella splendida cittadina francese nei giorni della manifestazione a cui si aggiunge il fatto che l’aeroplanino di carta è diventato un simbolo della stessa ed è entrato a far parte del breve filmato di animazione che lancia le serate e si rinnova ogni anno. Ad Annecy vengono proiettati in prima nazionale od internazionale dei lungometraggi ma il vero cuore della manifestazione sono le diverse sezioni di concorso (e fuori concorso) di cortometraggi tutti rigorosamente d’animazione gran parte dei quali davvero originali per soggetto e grafica. Quest’anno però si è avuta un’eccezione nei lungometraggi: si tratta di O menino e o mundo di Ale Abreu.La vicenda tratta di un bambino il cui padre abbandona la famiglia non per disamore ma per mancanza di lavoro. Il figlio decide di andare a cercarlo, conosce il mondo con le sue ingiustizie ma gli resta sempre come fonte di colore e di vita l’amore dei suoi genitori tra di loro e per lui. Abreu ha utilizzato quasi tutte le tecniche possibili dell’animazione (tranne la tridimensionalità) senza mai scadere nell’autocompiacimento manieristico anzi offrendo allo spettatore una miriade di occasioni di piacere per gli occhi che sostanziano al contempo la narrazione.
I bambini sono stati al centro anche di due cortometraggi davvero interessanti e toccanti che hanno meritato gli apprezzamenti ricevuti. Uno è Nul poisson où aller di Nicola Lemax e Anne Nadeau in cui si racconta di un paese in cui la guerra civile sconvolge la vita di tutti e in primis di due bambine che continuano a restare amiche nonostante tutto. L’altro è La Petite Casserole d’Anatole di Eric Montchaud in cui un bambino vive trascinandosi dietro una pentolina da cui non può staccarsi e che gli è d’intralcio costante. Fino a quando una coetanea gli spiega come ci può convivere. Questi costituiscono solo tre esempi di una programmazione che tocca tutta il vasto mondo dell’animazione: da quella televisiva a quella su commissione passano attraverso la sperimentazione e i corti di diploma degli studenti. Insomma 360° tutti disegnati!
.
67° FESTIVAL DEL FILM LOCARNO.
UN FESTIVAL CHE SI RINNOVA CONSERVANDO LA PROPRIA IDENTITÀ.
di Giancarlo Zappoli
Carlo Chatrian al secondo anno di direzione della manifestazione locarnese ha avuto modo di focalizzare ancor meglio il modo in cui intende costruire un festival che deve costantemente rinnovarsi pur conservando un’identità ben precisa. Lo ha dichiarato nella presentazione: “Il programma quest’anno ancora una volta scavalca gli steccati. Lo farà a partire da una retrospettiva che accoglie la sfida di raccontare la più grande fabbrica di sogni del cinema italiano, la Titanus. Il progetto di far convivere il cinema popolare e quello d’autore si ritrova anche nella varie sezioni.” Così è stato e lo si è visto nelle tre più importanti sezioni: Il Concorso ufficiale, la Piazza e la retrospettiva appunto.
Partiamo da quest’ultima per sottolineare come Locarno resti uno dei pochi Festival importanti davvero attenti al valore di una retrospettiva a cui va dedicata una cura non residuale ma precisa e direi quasi amorevole. Il focalizzarsi su una grande casa di produzione come la Titanus ha consentito di adempiere ancora una volta a quello straordinario compito che è il fare memoria. Numerosi spettatori hanno così potuto incontrare film e autori che non conoscevano. Hanno amato La ragazza con la valigia, hanno scoperto come ci si emozionava con i film di Matarazzo o come Fellini raccontava l’Italia in un suo film forse meno famoso (Il bidone). La selezione non si è però limitata a proporre film d’autore, Dario Argento compreso, ma è andata anche a scovare quelle produzioni decisamente popolari che un tempo riempivano le sale come i film di Franchi e Ingrassia (Il giorno più corto) o Non stuzzicate la zanzara di una giovane Lina Wertmüller con Rita Pavone come protagonista. Vera e propria riscoperta La legge della tromba del troppo facilmente dimenticato Augusto Tretti. Ovviamente non poteva mancare l’omaggio in Piazza dove nello splendore dello schermo all’aperto più grande d’Europa migliaia di persone hanno potuto ri-vedere Il Gattopardo. La Piazza appunto, con i suoi 8000 posti è il crocevia notturno del Festival. Vi si incrociano i cinefili più duri e puri con coloro che vogliono trascorrere una serata diversa senza quasi sapere che cosa verrà proiettato. Anche quest’anno la Piazza, tra alti e bassi, ha tenuto esplicitando senza parole quanto poi Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, avrebbe esposto apertamente. E’ tempo di dire basta a quel vezzo che fa sì che i festival più grandi debbano riempire le sezioni di prime ‘mondiali’ finendo talvolta per scegliere opere di minor valore rispetto ad altre che hanno già fatto uscite in altre manifestazioni a cui però il 99% del pubblico non ha partecipato. Ecco allora che la programmazione della Piazza ha chiuso con l’interessante Geronimo di Tony Gatlif e la sera prima aveva mostrato agli spettatori svizzeri un film ambientato in territorio elvetico: Sils Maria di Olivier Assayas. Entrambi i film erano stati visti a Cannes.Tra le novità va sicuramente sottolineata la presenza di Lucy di Luc Besson, un film che sotto la patina commerciale dell’action movie nasconde una profonda riflessione filosofico che affonda le radici nel taoismo a cui si aggiunge il divertente Schweizer Helden di Peter Luisi. La cartina al tornasole in particolare di una manifestazione come questa che non dimentica mai il proprio impegno di ricerca di un fare cinema non adagiato su schemi già noti resta il Concorso Ufficiale dei lungometraggi. La giuria, presieduta da Gianfranco Rosi (vincitore con Sacro Gra del Leone d’oro a Venezia 2013 affiancato da due attrici, di generazioni ed esperienze, Alice Braga e Connie Nielsen e da due registi, Diao Ynan (vincitore dell’Orso d’oro alla Berlinale 2014 con Black Coal Thin Ice e Thomas Arslan è stata posta dinanzi ad opere estremamente diverse tra loro e ha trovato l’unanimità (dichiarata) solo sul Pardo d’oro. Mula sa kung ano ang noon di Lav Diaz, proiettato il primo giorno della competizione, non ha mai perso la prima posizione vincendo il record di durata di proiezione (338 minuti) ma anche quello di tenuta stilistica grazie a una rivisitazione del periodo in cui Marcos si apprestava ad instaurare la legge marziale riletto da una prospettiva distante dalla capitale (la campagna filippina) con una messa in scena in cui la fotografia è affidata ad un rigore assoluto. Il fatto che il film abbia ottenuto un riconoscimento anche dalla giuria di “Cinema & Gìoventù” formata da studenti dai 17 ai 22 anni dimostra quanto Chatrian abbia avuto ragione nel rischiare con la messa in competizione di un’opera apparentemente così anomala.
 Tra i film proposti almeno tre meritano una menzione particolare. Uno è Durak del russo Yury Bykov che ha messo una volta tanto d’accordo pubblico e critica per l’asprezza con cui denuncia la situazione politica della Russia attuale attraverso la metafora di un palazzo che rischia di crollare. La giuria ufficiale non lo ha amato assegnandogli solo il doveroso premio per il migliore attore mentre i giovani lo hanno molto apprezzato conferendogli la prima posizione. Altrettanto ‘politico’ quanto splendidamente raffinato dal punto di vista stilistico Cavalo Dinheiro di Pedro Costa che rievoca on una rarefatta sospensione la Rivoluzione dei garofani portoghese. Distante da questi temi ma impegnato invece sul fronte della memoria individuale e della ri-costruzione di legami il raffinato e rarefatto Gyeongju di Zhang Lu ha mostrato ancora una volta quanto la cinematografia della Corea del Sud abbia individuato una molteplicità di scelte linguistiche che fanno sì che molte delle opere costituiscano una vera e propria scoperta.
Tra i film proposti almeno tre meritano una menzione particolare. Uno è Durak del russo Yury Bykov che ha messo una volta tanto d’accordo pubblico e critica per l’asprezza con cui denuncia la situazione politica della Russia attuale attraverso la metafora di un palazzo che rischia di crollare. La giuria ufficiale non lo ha amato assegnandogli solo il doveroso premio per il migliore attore mentre i giovani lo hanno molto apprezzato conferendogli la prima posizione. Altrettanto ‘politico’ quanto splendidamente raffinato dal punto di vista stilistico Cavalo Dinheiro di Pedro Costa che rievoca on una rarefatta sospensione la Rivoluzione dei garofani portoghese. Distante da questi temi ma impegnato invece sul fronte della memoria individuale e della ri-costruzione di legami il raffinato e rarefatto Gyeongju di Zhang Lu ha mostrato ancora una volta quanto la cinematografia della Corea del Sud abbia individuato una molteplicità di scelte linguistiche che fanno sì che molte delle opere costituiscano una vera e propria scoperta.
.
 71° MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
71° MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
UNA MOSTRA CON FILM DI QUALITA’
ED UN’IMPORTANTE PRESENZA ITALIANA
di Paolo Micalizzi
Ha conquistato il “Leone d’Oro” alla 71° Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film giusto. Ampi consensi per il massimo riconoscimento della Mostra, diretta anche quest’anno con passione e competenza da Alberto Barbera con la presidenza di Paolo Baratta, al film dello svedese Roy Andersson.
.
Un piccione seduto su un ramo che riflette sull’esistenza, una storia che inizia con due commessi viaggiatori che vendono strani oggetti innovativi che nessuno compra, come denti di Dracula, il sacchetto che ride, ecc. e che poi si sviluppa con una serie di altri personaggi senza rapporti apparenti ma tutti volti a mostrare storie quotidiane unite da un filo ironico: una vecchietta in punto di morte che si tiene stretta la borsa anche quando i figli cercano di strappargliela sul letto d’ospedale; un uomo che muore al self service su un traghetto mettendo in imbarazzo il personale perché aveva già pagato il pranzo e non sanno cosa fare. Ed altri surreali episodi del genere. Destini umani messi in evidenza da Roy Andersson come se fossero raccontati da un uccello seduto su un albero. Un film bizzarro, permeato di un umorismo nero che prosegue quella singolare ricerca “sull’essere un essere umano” iniziata da Andersson con due suoi film precedenti: Song from the Second Floor (2000) e Yeus the Living (2007). Un “Leone d’Oro” attribuito da una Giuria presieduta dal musicista francese Alexandre Desplat ( e comprendente anche Carlo Verdone , che pare abbia avuto un peso rilevante nelle decisioni) che ha assegnato poi il “Leone d’Argento” al film di Andrej Konchalovskij Le notti bianche del postino incentrato su una comunità di uno sperduto villaggio russo separato dal resto del mondo da un lago. Nonostante nelle vicinanze sorga una base spaziale, la vita degli abitanti procede in maniera arcaica e l’unico collegamento con il mondo esterno è il postino. Che deciderà ad un certo momento di trasferirsi in città a causa dell’amore per una donna che ha deciso di abbandonare quella comunità. Ma poi il postino ritornerà presto al suo villaggio. Una storia in cui emergono conflitti quotidiani, sentimenti e sogni dei personaggi, confinati in un mondo bello ma inospitale dai toni poetici. Gran Premio della Giuria a The look of silence di Joshua Oppenheimer, un capolavoro secondo il giurato Tim Roth, che mette d’accordo tutti sul riconoscimento assegnato. Un film incentrato sul genocidio in Indonesia negli anni ’60 di un milione di presunti comunisti da parte delle squadre della morte, qui raccontato mettendo a confronto superstiti e assassini. Assassini, non pentiti dell’atroce sterminio, che sono ancora al potere e contro i quali è impossibile ribellarsi. Una convivenza, secondo il regista, senza possibilità di riconciliazione. Un documentario che sconvolge e che risveglia le coscienze.
 Delusione per il cinema italiano che poteva benissimo aspirare ad uno di questi premi importanti. Innanzitutto , a nostro avviso, con Anime nere di Francesco Munzi, che presenta il mondo della criminalità( in questo caso la ‘ndrangheta calabrese) dall’interno dei protagonisti , rivelando conflitti interiori. Tratto dal romanzo omonimo di Gioacchino Criaco , il film, spostando l’azione ai giorni nostri e trasformando tre amici in tre fratelli, propone una soluzione che indica come il male va combattuto estirpando le radici, tesi estrema che nei film sulla “mafia” non è stata mai considerata perché interessati a sfruttare, soprattutto, questo fenomeno in maniera romanzata e spettacolare. Una Calabria inedita, Africo d’Aspromonte, fuori dagli stereotipi con l’uso del dialetto per rendere il racconto più vero e dargli maggior senso d’identità. Avvalorato dall’uso di “attori” presi dal popolo, che conferiscono al film maggiore veridicità. Ma anche con Il giovane favoloso di Mario Martone che poteva ricevere il premio per il miglior attore per la straordinaria e intensa interpretazione di Elio Germano nel ruolo del poeta di Recanati. Ma forse la Giuria poteva pensare a qualcosa di più per questo film che ci porta nel cuore di una riflessione poetica e filosofica su una figura chiave dell’800 italiano. ll film ne ripercorre la vita, dall’educazione familiare alla sua formazione culturale che lo porterà a desiderare una vita all’esterno e non imprigionata dalla severità del padre e dal bigottismo della madre, fino al suo ingresso nell’alta società italiana, e al suo amore, diviso con il suo amico Ranieri che lo introduce nell’ambiente culturale, per Fanny. Ma anche la sofferenza per l’accentuarsi della sua deformazione fisica che gli procura tanta derisione. Un film che restituisce un genio che amava la libertà, audace e anticonformista, un personaggio più vero, cosi lontano dagli studi scolastici. La Coppa Volpi per il miglior attore è stata invece attribuita ad Adam Driver di Hungry Hearts di Saverio Costanzo, che offre una buona interpretazione ma che è più debole rispetto ad altre valide candidature. (Oltre a Elio Germano, infatti, la Giuria ha trascurato attori del calibro di Al Pacino, Michael Keaton e di un Wilhelm Dafoe molto convincente, anche nella sua somiglianza impressionante, nella sua interpretazione del Pasolini di Abel Ferrara). Tanto più che la Coppi Volpi per la migliore attrice è stata attribuita all’altra protagonista del film di Costanzo, la bravissima Alba Rohrwacher che con questo ennesimo riconoscimento acquista una definitiva consacrazione. Un personaggio, il suo, in cui ha dato anima e cuore. Le due Coppe Volpi suonano però come un contentino per un film come questo di Saverio Costanzo che poteva ambire a un riconoscimento all’opera in se stessa. Il tema affrontato è estremamente importante ed attuale trattando dell’educazione dei figli. Che qui , poiché la madre è vegana, si tramuta di tensione in tensione, in un conflitto che porta a conseguenze estreme, che il regista sa esprimere in maniera realistica ed efficace. I due film, quello di Martone e quello di Costanzo, potevano benissimo, per esempio, ricevere il Premio speciale della Giuria che invece è stato assegnato al regista turco Kaan Mujdeci per Sivas che racconta la storia , ambientata in un desolato villaggio turco, di un ragazzino di undici anni, e Sivas un malandato cane da combattimento, visti nelle loro lotte esistenziali. Un film che rivela un regista promettente, in fase di maturazione.
Delusione per il cinema italiano che poteva benissimo aspirare ad uno di questi premi importanti. Innanzitutto , a nostro avviso, con Anime nere di Francesco Munzi, che presenta il mondo della criminalità( in questo caso la ‘ndrangheta calabrese) dall’interno dei protagonisti , rivelando conflitti interiori. Tratto dal romanzo omonimo di Gioacchino Criaco , il film, spostando l’azione ai giorni nostri e trasformando tre amici in tre fratelli, propone una soluzione che indica come il male va combattuto estirpando le radici, tesi estrema che nei film sulla “mafia” non è stata mai considerata perché interessati a sfruttare, soprattutto, questo fenomeno in maniera romanzata e spettacolare. Una Calabria inedita, Africo d’Aspromonte, fuori dagli stereotipi con l’uso del dialetto per rendere il racconto più vero e dargli maggior senso d’identità. Avvalorato dall’uso di “attori” presi dal popolo, che conferiscono al film maggiore veridicità. Ma anche con Il giovane favoloso di Mario Martone che poteva ricevere il premio per il miglior attore per la straordinaria e intensa interpretazione di Elio Germano nel ruolo del poeta di Recanati. Ma forse la Giuria poteva pensare a qualcosa di più per questo film che ci porta nel cuore di una riflessione poetica e filosofica su una figura chiave dell’800 italiano. ll film ne ripercorre la vita, dall’educazione familiare alla sua formazione culturale che lo porterà a desiderare una vita all’esterno e non imprigionata dalla severità del padre e dal bigottismo della madre, fino al suo ingresso nell’alta società italiana, e al suo amore, diviso con il suo amico Ranieri che lo introduce nell’ambiente culturale, per Fanny. Ma anche la sofferenza per l’accentuarsi della sua deformazione fisica che gli procura tanta derisione. Un film che restituisce un genio che amava la libertà, audace e anticonformista, un personaggio più vero, cosi lontano dagli studi scolastici. La Coppa Volpi per il miglior attore è stata invece attribuita ad Adam Driver di Hungry Hearts di Saverio Costanzo, che offre una buona interpretazione ma che è più debole rispetto ad altre valide candidature. (Oltre a Elio Germano, infatti, la Giuria ha trascurato attori del calibro di Al Pacino, Michael Keaton e di un Wilhelm Dafoe molto convincente, anche nella sua somiglianza impressionante, nella sua interpretazione del Pasolini di Abel Ferrara). Tanto più che la Coppi Volpi per la migliore attrice è stata attribuita all’altra protagonista del film di Costanzo, la bravissima Alba Rohrwacher che con questo ennesimo riconoscimento acquista una definitiva consacrazione. Un personaggio, il suo, in cui ha dato anima e cuore. Le due Coppe Volpi suonano però come un contentino per un film come questo di Saverio Costanzo che poteva ambire a un riconoscimento all’opera in se stessa. Il tema affrontato è estremamente importante ed attuale trattando dell’educazione dei figli. Che qui , poiché la madre è vegana, si tramuta di tensione in tensione, in un conflitto che porta a conseguenze estreme, che il regista sa esprimere in maniera realistica ed efficace. I due film, quello di Martone e quello di Costanzo, potevano benissimo, per esempio, ricevere il Premio speciale della Giuria che invece è stato assegnato al regista turco Kaan Mujdeci per Sivas che racconta la storia , ambientata in un desolato villaggio turco, di un ragazzino di undici anni, e Sivas un malandato cane da combattimento, visti nelle loro lotte esistenziali. Un film che rivela un regista promettente, in fase di maturazione.
La Giuria ha poi laureato, con il Premio Marcello Mastroianni, come miglior attore esordiente, il giovane Roman Paul, protagonista del film di Alix Delaporte, Le dernier coup de marteau, opera su un giovene che a quattordici anni vive la sua prima emozione artistica e sentimentale. E per la sceneggiatura, la signora del cinema iraniano Rakhshan Banietemad per il film “Ghessea (Racconti) del quale è anche regista: un premio condiviso con l’altra sceneggiatrice, Farid Mostafavi. Un film sull’Iran contemporaneo che, tra fiction e documentario, mette a fuoco storie di uomini e donne di diversi strati sociali. Un Premio importante è poi il “Leone del Futuro- Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis”, che è stato attribuito, da un’apposita Giuria presieduta da Alice Rohrwacher, al film Court (Tribunale) dell’indiana Chaitanya Tamhane: un premio da 100.000 USD che saranno suddivisi in parti uguali tra regista e produttore, uno stimolo ulteriore per un nuovo film. La stessa opera, prodotta grazie ad un premio vinto al Festival di Rotterdam, ha ricevuto anche il “Premio Orizzonti” da una Giuria presieduta da Ann Hui. Il film getta una luce inquietante sul sistema giudiziario indiano attraverso il processo ad un vecchio cantante accusato di aver suonato una canzone che ha istigato un uomo ad uccidersi. In questa Sezione vi è stato un importante riconoscimento per un film italiano, Belluscone. Una storia italiana di Franco Maresco incentrato sulla storia del rapporto, politico e personale, tra Silvio Berlusconi e la Sicilia raccontata attraverso le disavventure dell’impresario palermitano Ciccio Mira. Vicissitudini di un film mai finito ricostruito dal critico cinematografico Tatti Sanguineti. Film con grande gusto del paradosso. Da quest’anno premi anche per “Venezia Classici” i cui riconoscimenti sono stati attribuiti da una Giuria di 28 studenti provenienti da diverse Università italiane presieduta dal regista Giuliano Montaldo. Miglior film restaurato è stato considerato Una giornata particolare di Ettore Scola, opera cult della Storia del Cinema italiano, con due grandi attori come Sophia Loren e Marcello Mastroianni, che è giusto sottrarre dall’usura e riproporre per non essere dimenticata. E miglior documentario sul cinema, Animata Resistenza di Francesco Montagner e Alberto Girotto con protagonista Simone Massi apprezzato regista del cinema d’animazione ( è anche da tre anni l’autore della sigla della Mostra di Venezia) che qui racconta la sua terra( le colline marchigiane) attraverso le riflessioni e i ricordi di alcuni anziani che hanno vissuto personalmente la guerra e la Resistenza. Un’opera-omaggio alla civiltà contadina.
Il documentario ha avuto quest’anno alla Mostra una particolare attenzione. Opere che hanno focalizzato personaggi e tematiche della Storia del cinema italiano, ma non solo. Tra essi, Giulio Andreotti. Il cinema visto da vicino di Tatti Sanguineti; Gian Luigi Rondi: vita, cinema, passione di Giorgio Treves; Donne nel mito: Sophia racconta la Loren di Marco Spagnoli (La Loren è stata anche oggetto di un’interessante Mostra fotografica allestita al Palazzo del Cinema dall’Ente dello Spettacolo); Poltrone rosse- Parma e il cinema di Francesco Barilli. Italiano è anche Fango e gloria di Leonardo Tiberi, film realizzato per il centenario della Grande Guerra, pensato soprattutto come strumento didattico e divulgativo. Vi erano anche documentari riguardanti il regista Robert Altman( di Ron Mann) e Arthur Penn (di Amir Naderi). E ad un documentarista, l’americano Frederick Wiseman, che nelle sue opere s’interroga sul mondo e sull’esistenza, è stato attribuito un “Leone d’Oro” alla carriera: un altro è stato consegnato alla montatrice dei film di Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker.
L’Istituto Luce ha poi presentato, fra l’altro, alcuni documentari per celebrare i suoi 90 anni: Lo sguardo del Luce di Carlo di Carlo; Me ne frego! di Valeria Della Valle e Vanni Gandolfo; Maschere crude di Flavio Bernardinis.
Altri film in Concorso, non insigniti da Premi, meritano particolare attenzione. Mi riferisco, soprattutto, tra quelli visti, a Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu (USA) che, imperniato su un attore teatrale( un bravissimo Michael Keaton), mescola con un lungo piano sequenza cinema-vita-teatro; Nobi (Fores on the plain) del giapponese Shinya Tsukamoto, remake in chiave di esagerata violenza ma dai toni visionari del film Fuochi nella pianura (1959) di Kon Ichikawa; Loin des hommes, tratto da un racconto di Albert Camus, girato dal francese David Oelhoffen come se fosse un western, che è imperniato su un maestro di scuola francofono coinvolto, suo malgrado, nelle violente contraddizioni di un’Algeria anni ’50 con un pensiero alla Palestina e al Medio Oriente. Su Birdman e su altri film della Mostra si soffermano, poi, in questo numero della Rivista le analisi di Andreina Sirena e l’articolo di Giampiero Raganelli.
“La Settimana Internazionale della Critica” e le “Giornate degli Autori” hanno messo in luce, come è ormai tradizione, nuovi talenti. Alla SIC ha vinto il serbo-croato Nicija Dete (Figlio di nessuno) di Vuk Rsumovic, cui è andato il Premio “Raro Video” assegnato dal pubblico. Racconta la storia di un bambino selvaggio vissuto tra i lupi che viene ritrovato nel 1988 tra le montagne della Bosnia. Sarà inviato in Serbia, ma nel 1992 nel pieno della guerra le autorità locali lo obbligano a tornare il Bosnia, dove viene armato di fucile e spedito al fronte. Il regista pone soprattutto l’accento sulle vicissitudini umane del ragazzo-lupo, un “figlio di nessuno” la cui crescita avviene sullo sfondo della guerra dei Balcani.
Negli “Autori” la Giuria ,presieduta da Diego Leman, ha premiato il film Retour a Ithaca. Ritorno a l’Avana del francese Laurent Cantet, che attraverso l’incontro di un gruppo di amici per celebrare il ritorno di uno di loro dopo sedici anni di esilio, parla di ideali e delusioni all’epoca di Fidel Castro. Un’opera sulle contraddizioni di un mito, Cuba.
 Tra i film più premiati della Mostra, l’italiano Io sto con la sposa di Antonio Augugliaro, Gabriele del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry presentato “Fuori Concorso“ nella sezione Orizzonti. Ha vinto tre premi, tra cui quello della Fedic destinato “all’opera che meglio rifletta l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore”. Il riconoscimento gli è stato attribuito da una Giuria presieduta da Roberto Barzanti (Presidente delle “Giornate degli Autori”) che nella motivazione sottolinea che trattasi di “un prototipo di un modello possibile di cinema indipendente e partecipato a livello produttivo, in quanto finanziato attraverso il contributo di migliaia di potenziali spettatori divenuti mecenati del cinema che vorrebbero”. Il film, infatti, è nato attraverso un’operazione di crowdfunding che ha premiato così un’opera d’impegno civile coraggiosa che racconta come, coll’espediente di un finto matrimonio, i tre autori, che partecipano al film anche come protagonisti, riescono a far arrivare dall’Italia alla Svezia cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa. La stessa Giuria (che era anche composta da Ugo Baistrocchi, Lorenzo Bianchi Ballano, Daniele Corsi, Giuliano Gallini, Ferruccio Gard, Carlo Gentile, Fausto Ghiretti, Franco Mariotti, Paolo Micalizzi, Italo Moscati, Elisabetta Randaccio e Giancarlo Zappoli) ha assegnato una “Menzione Fedic – Il Giornale del Cibo” destinata “all’opera che propone la scena più significativa legata al cibo e all’alimentazione” al film Italy in a day. Un giorno da italiani di Gabriele Salvatores, presentato fuori concorso. E’ un Premio assegnato per la prima volta grazie alla collaborazione con questa testata giornalistica. Il film documenta una giornata come tante nella vita del Paese(26 ottobre 2013). Un’istantanea dell’Italia che coglie momenti di vita focalizzati soprattutto sui temi dell’infanzia, famiglia, amicizia. Un ritratto in cui, come ha rilevato la Giuria, “la preparazione del cibo e il suo consumo vengono rappresentati come momenti di gioia, creatività, identità”.
Tra i film più premiati della Mostra, l’italiano Io sto con la sposa di Antonio Augugliaro, Gabriele del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry presentato “Fuori Concorso“ nella sezione Orizzonti. Ha vinto tre premi, tra cui quello della Fedic destinato “all’opera che meglio rifletta l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore”. Il riconoscimento gli è stato attribuito da una Giuria presieduta da Roberto Barzanti (Presidente delle “Giornate degli Autori”) che nella motivazione sottolinea che trattasi di “un prototipo di un modello possibile di cinema indipendente e partecipato a livello produttivo, in quanto finanziato attraverso il contributo di migliaia di potenziali spettatori divenuti mecenati del cinema che vorrebbero”. Il film, infatti, è nato attraverso un’operazione di crowdfunding che ha premiato così un’opera d’impegno civile coraggiosa che racconta come, coll’espediente di un finto matrimonio, i tre autori, che partecipano al film anche come protagonisti, riescono a far arrivare dall’Italia alla Svezia cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa. La stessa Giuria (che era anche composta da Ugo Baistrocchi, Lorenzo Bianchi Ballano, Daniele Corsi, Giuliano Gallini, Ferruccio Gard, Carlo Gentile, Fausto Ghiretti, Franco Mariotti, Paolo Micalizzi, Italo Moscati, Elisabetta Randaccio e Giancarlo Zappoli) ha assegnato una “Menzione Fedic – Il Giornale del Cibo” destinata “all’opera che propone la scena più significativa legata al cibo e all’alimentazione” al film Italy in a day. Un giorno da italiani di Gabriele Salvatores, presentato fuori concorso. E’ un Premio assegnato per la prima volta grazie alla collaborazione con questa testata giornalistica. Il film documenta una giornata come tante nella vita del Paese(26 ottobre 2013). Un’istantanea dell’Italia che coglie momenti di vita focalizzati soprattutto sui temi dell’infanzia, famiglia, amicizia. Un ritratto in cui, come ha rilevato la Giuria, “la preparazione del cibo e il suo consumo vengono rappresentati come momenti di gioia, creatività, identità”.
Il cinema italiano ha presentato nelle varie Sezioni della Mostra film di qualità. Ad iniziare da quelli in Concorso la cui scelta si è rivelata , ed è stata una delle poche volte, giusta. Poi sono da citare, a nostro avviso, oltre a quelli già segnalati in questo articolo, La zuppa del demonio (presentato “Fuori Concorso”) di Davide Ferrario, interessante documentario sul progresso in Italia raccontato attraverso il film industriale; Perez (anch’esso “Fuori Concorso”) di Edoardo De Angelis, film che ruota attorno alla figura di un avvocato(un Luca Zingaretti convincente, emancipato dal ruolo di Montalbano) che per difendere la vita di sua figlia innamorata di un criminale infrange ogni regola. Una storia ambientata in una Napoli inedita, dai toni metallici; I nostri ragazzi , film in cui il regista Ivano De Matteo, così come aveva fatto nelle sue precedenti opere, continua a indagare nel microcosmo familiare attraverso la storia di due famiglie borghesi travolte da una tragica bravata dei rispettivi figli con conseguenza mortale. Lanciando anche un atto d’accusa sulla dipendenza dei giovani da Internet che li astrae dalla realtà e nega loro una capacità reattiva. Opera equilibrata che eccede però nell’allusivo finale. Il film era nelle “giornate degli autori”, mentre nella SIC partecipava Arance e martello di Diego Bianchi Zoro che racconta 24 ore, in una bollente giornata estiva, di un popolare quartiere romano dove il Comune vuole chiudere il mercato. Una satira divertente e dissacrante che coinvolge popolani e politici. Un film italiano anche nella “Biennale College-Cinema”, un’iniziativa giunta alla seconda edizione che favorisce la realizzazione di progetti di qualità. Si tratta di Short Skin di Duccio Chiarini che racconta con sensibilità il percorso di formazione sessuale e affettiva di un giovane che si vede costretto ad isolarsi dalle ragazze a causa delle paure e incertezze dovute a una malformazione del suo sesso.
Anche quest’anno la Mostra ha annoverato momenti importanti in iniziative che avvengono al suo interno. Nello Spazio dell’Ente dello Spettacolo, come negli anni precedenti, si è svolta la cerimonia del “Premio Bresson”, uno dei registi più rigorosi, più spirituali della Storia del cinema, un grande Maestro: ha laureato l’attore Carlo Verdone che lo ha dedicato al padre Mario, grande figura di storico del cinema a cui molti critici, e fra essi anche il sottoscritto, hanno fatto riferimento per i loro studi. Nel ritirare il Premio, Carlo Verdone ha dichiarato che esso lo avvicina a quel cinema d’autore amato dal padre, anche se poi lui si è dedicato al cinema popolare, soprattutto alla commedia che, secondo lui, se fatta con onestà può essere un’opera seria. Una giusta rivalutazione di un genere che ha dato film importanti ed ha segnato la carriera di autorevoli registi. Molto significativo poi, nello stesso Spazio, un Convegno, per iniziativa della Lucana Film Commission, per ricordare Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini.

Forum Fedic – Tavolo dei relatori: da sinistra, Giorgio Sabbatini, Stefania Ippoliti, Roberto Merlino e Paolo Micalizzi
Nello Spazio del “Venice Film Market”, alcuni Convegni importanti. Tra essi, Il Forum Fedic che quest’anno era incentrato sul tema “Essere filmmaker nell’era digitale” nel quale hanno svolto interessanti interventi
Giorgio Sabbatini che ha sottolineato le sue esperienze di filmaker nel passaggio dalla pellicola al digitale (ha raccontate brevemente le sue anche il filmaker Beppe Rizzo), Vittorio Boarini (docente universitario e noto organizzatore di prestigiosi Eventi cinematografici) che si è soffermato sugli aspetti estetici del digitale, mentre Laura Biggi( responsabile Fedic Scuola) ha messo in evidenza il valore della videonarrazione da parte dei bambini come potenziale pedagogico e didattico e Marcello Zeppi (Presidente “FilmVideo”) ha rilevato alcuni aspetti della comunicazione in Europa. Il Forum si è aperto con un saluto di Stefania Ippoliti( Presidente dell’Italian Film Commission) che ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto dalla Fedic come operazione di inseminazione, passione e conoscenza per chi ama il cinema ma vuole anche raccontarlo attraverso questo strumento particolare. E’ intervenuto anche il Presidente Fedic Roberto Merlino che ha osservato come l’era digitale ha portato un grosso cambiamento dal punto di vista tecnologico e nel modo di pensare e fare comunicazione con le immagini in movimento, ed ha riferito che la Fedic per stare ai passi con i tempi sta operando su tre fronti: sostegno economico, didattica, visibilità.
Una Mostra, in conclusione, che anche quest’anno come si conviene ad una manifestazione che vuole tenere presente anche le aspettative divistiche del pubblico ha mostrato la sua vitalità anche con la presenza sul Red Carpet di alcune Star, innanzitutto Al Pacino accolto da un bagno di folla.
Cultura e mondanità, come si conviene ad un Evento di grande prestigio internazionale com’è, malgrado i suoi detrattori, sostenitori soprattutto di altri Festival, indiscutibilmente la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
HIGHLIGHTS DA VENEZIA
di Andreina Sirena
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) di Alejandro González Iňárritu.
 Riggan Thomson, famoso anni addietro per aver interpretato in tre film di successo il ruolo di un supereroe pennuto – una sorta di Papageno trasformato in eroe ma che, del buon selvaggio mozartiano, conserva la ridicola parure – anela fortemente ad un riscatto artistico che dimostri agli occhi del mondo quanto in realtà sia un autentico attore, dedicando tutte le sue energie all’allestimento di una versione teatrale del racconto di Raymond Carver,” Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”. In realtà, il riscatto cui anela Riggan non è soltanto artistico, bensì in primis umano ed esistenziale. Versione postmoderna, deforme dell’Antonius Block del Settimo sigillo – e fatalmente priva della nobile, dolente e pacata compostezza dell’eroe bergmaniano – anche Riggan Thomson sembra alla ricerca di un senso, di un’azione, di un evento che gli permetta di riscrivere e ripensare una vita di cui è terribilmente insoddisfatto. Antonius Block ha combattuto insulse crociate, Riggan ha recitato in insulsi film. E se l’ateo Antonius Block cerca ‘un conforto, qualcosa in cui credere’, e vorrebbe con tutto il cuore che gli si provasse l’esistenza di un Dio di cui ha bruciante nostalgia, Riggan è alla disperata ricerca di una prova che mostri a se stesso e agli altri quanto l’Ego enfiato ed ipertrofico al quale continua ad aggrapparsi, a dispetto delle continue smentite della realtà, trovi invece la sua giustificazione, la sua ragion d’essere e infine la sua meritata affermazione.
Riggan Thomson, famoso anni addietro per aver interpretato in tre film di successo il ruolo di un supereroe pennuto – una sorta di Papageno trasformato in eroe ma che, del buon selvaggio mozartiano, conserva la ridicola parure – anela fortemente ad un riscatto artistico che dimostri agli occhi del mondo quanto in realtà sia un autentico attore, dedicando tutte le sue energie all’allestimento di una versione teatrale del racconto di Raymond Carver,” Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”. In realtà, il riscatto cui anela Riggan non è soltanto artistico, bensì in primis umano ed esistenziale. Versione postmoderna, deforme dell’Antonius Block del Settimo sigillo – e fatalmente priva della nobile, dolente e pacata compostezza dell’eroe bergmaniano – anche Riggan Thomson sembra alla ricerca di un senso, di un’azione, di un evento che gli permetta di riscrivere e ripensare una vita di cui è terribilmente insoddisfatto. Antonius Block ha combattuto insulse crociate, Riggan ha recitato in insulsi film. E se l’ateo Antonius Block cerca ‘un conforto, qualcosa in cui credere’, e vorrebbe con tutto il cuore che gli si provasse l’esistenza di un Dio di cui ha bruciante nostalgia, Riggan è alla disperata ricerca di una prova che mostri a se stesso e agli altri quanto l’Ego enfiato ed ipertrofico al quale continua ad aggrapparsi, a dispetto delle continue smentite della realtà, trovi invece la sua giustificazione, la sua ragion d’essere e infine la sua meritata affermazione.
Riggan desidera emanciparsi dal personaggio di Birdman, è insofferente dell’identificazione che il pubblico ancora compie tra lui e il supereroe pennuto, eppure è proprio dall’osmosi col suo alter ego cinematografico che mutua quel delirio di onnipotenza grazie al quale cerca un momentaneo sollievo alla sua frustrazione, alterando la realtà e ridisegnandola secondo le proprie proiezioni. Ma questo espediente non può che esacerbare la sua stessa frustazione: la maschera – in questo caso, anche in senso letterale: quella di Birdman – che egli indossa per nascondere a se stesso e agli altri il suo vero sé annichilito non fa che inasprire la desolazione, la solitudine, il vuoto. E più si aggrappa alla maschera che dovrebbe salvarlo dalla frustrazione, più questa stessa frustrazione aumenta e dilaga, nel toccare con mano lo scarto tra l’immagine ideale di sé – la maschera appunto – e la realtà. Riggan viene così irretito in un circolo vizioso per uscire dal quale non escogita migliore risoluzione che la morte. Ma la sua viltà trasforma anche il suicidio in una farsa, non riuscendo a portarlo a compimento ma forgiandone uno spettacolo dentro uno spettacolo. E se il pur odiato Birdman vanta poteri immaginari, l’ego smisurato di Riggan, con la sua voce mostruosa, grave e maligna si fa continuamente beffe di lui, lo umilia, lo tortura e gli promette il fallimento. Una presenza che pertanto si fa sinistra e malevola, come l’Horla nell’omonimo racconto di Maupassant. Più Riggan lotta per il riconoscimento di quel valore senza la presunzione del quale nemmeno riuscirebbe a sopravvivere, più la realtà manda in frantumi ogni illusione. “Ammettilo, papà, tu fai tutto questo perché sei spaventato a morte – come tutti noi – al pensiero di non contare nulla… ed è proprio così… tu non conti nulla”, gli rinfaccia la figlia. In una scena del film il protagonista resta chiuso fuori dal teatro – quasi a simboleggiare la sua inadeguatezza, la sua indegnità, il suo essere in fondo un profano, un non-iniziato cui viene interdetto l’ingresso al tempio – e si trova costretto a camminare in mutande per le strade della città, come il re ne I vestiti nuovi dell’imperatore di Andersen. Riggan è smascherato, messo a nudo nella sua miseria vestita solo di velleità e chimere.
A quale ignoranza fa cenno il sottotitolo, e quale ne sarebbe l’esito virtuoso? Riggan Thomson approccia la piéce tratta da Carver adattandola in modo da riceverne tutta la gloria, dal monologo appena prima dell’intervallo, fino al finale – escogitato appositamente per questa versione teatrale – in cui il protagonista si dovrebbe far saltare il cervello davanti al pubblico. Questo è il tipico approccio al teatro di una stella del cinema – questa l’ignoranza di Riggan -, poiché un vero attore teatrale al contrario fa in modo che i suoi co-protagonisti possano anch’essi rifulgere. Riggan invece si circonda di professionisti, all’unico scopo di servirsene affinché lui possa fare una figura migliore. Le sue ambizioni riceveranno però un duro colpo quando Mike Shiner – nome che potremmo, con una piccola forzatura, tradurre come “più splendente”, che rifulge più di Riggan – entrerà a far parte della compagnia. L’approccio cinematografico di Riggan al teatro viene però premiato dal successo della rappresentazione: il pubblico apprezza l’”ultra-realismo” del colpo di pistola che lui effettivamente si spara – benché non alla tempia – in sala: la sua “ignoranza” pertanto ha dato dei frutti inaspettati, segno – questo – di come, se è cambiato l’approccio dell’attore al teatro, è parimenti cambiato anche quello dello spettatore. Gli artifici, le esigenze del cinema entrano prepotentemente nella prassi teatrale, contaminandone lessico e consuetudini.
Il racconto da cui Riggan trae la sua opera, “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”, vede i quattro protagonisti assorti in una serrata discussione sulla natura, appunto, dell’amore. L’amore è la possessività e la violenza di Ed? E’ la luna di miele di Laura e Nick, verosimilmente destinata a degenerare in vacua abitudine? E’ il sentimento fuggente, illusorio e inaffidabile che Mel ha provato per la moglie, e che ora prova per Terry? No. L’amore, che cosa sia l’amore ce lo racconta Mel: parla di due vecchietti, travolti da un furgone e fatti praticamente a pezzi. Sopravvivono, bendati e ingessati da capo a piedi. Il marito della coppia è profondamente depresso. Mel – è un chirurgo, e ha operato la coppia – suppone ovviamente che la causa della depressione sia lo spaventoso incidente subìto. Invece no. Il dramma del marito sta nel fatto che, essendo totalmente ingessato, non riesce a girare la testa e vedere la moglie attraverso i buchetti per gli occhi. Questo è l’amore. Riggan Thomson, invece, ripiegato com’è su se stesso, è fatalmente incapace di vedere – e quindi vedersi – e amare. Non gli resta allora che gettarsi dalla finestra e morire – o tramutarsi – in quella maschera di supereroe pennuto che è quasi un’icona della sua estraneità a se stesso e agli altri.
One on One di Kim Ki-Duk
 Nel presentare il suo nuovo film al Festival di Venezia, Kim Ki-Duk ha desiderato sensibilizzare l’opinione pubblica su una devastante tragedia avvenuta in Corea lo scorso 16 aprile, il naufragio colposo del traghetto Sewol. L’imbarcazione trasportava tre volte il peso massimo consentito, e mai durante quella strage arrivò l’ordine di abbandonare la nave, mentre il comandante ed altri membri dell’equipaggio salirono sulle scialuppe di salvataggio, abbandonando i passeggeri ad una morte certa. Frutto di corruzione e di omertà, questo incidente è carico di una valenza simbolica, effetto com’è di una crisi morale e politica in seno alla società coreana che se da una parte partorisce una classe dirigente capace di ogni nefandezza (poiché sa che resterà impunita), dall’altra educa la gioventù ad un’obbedienza ottusa e cieca che non può non avere conseguenze devastanti: “Il prezzo della cultura coreana che viene trasmesso ai propri figli è l’obbedienza, quindi se un adulto avesse loro detto di non muoversi – ai ragazzi a bordo del traghetto, n.d.r. – loro sicuramente non si sarebbero mossi” (Un giornalista della CNN, due giorni dopo il disastro). Ed omertoso e criminale è il mondo che ci racconta nel suo ultimo film, che si apre con l’uccisione inspiegabile di una giovane studentessa: evento, questo, di portata universale, una sineddoche che allude ai mali del mondo tout court. Kim Ki-Duk infierisce sullo spettatore e lo costringe a confrontarsi coi mostri dell’omologazione e della corruzione. Descrive un mondo omertoso, di fidanzatini assassini che si scambiano tenerezze a tavola con le loro ignare ragazze. Un mondo costituito da una sottile patina di conformità e perbenismo, sotto il quale ogni sorta di mostruosità germina e prospera indisturbata. Il tema dell’omertà – dell’occultamento della verità – è ricorrente nel cinema coreano: pensiamo a Poetry di Lee Chang-dong (2010), dove l’unica preoccupazione dei genitori degli studenti colpevoli era volta a nascondere il crimine e a comprare il silenzio della madre della vittima. In One on one al male eseguito per obbedienza fa seguito il male per vendetta, portato avanti da ignote frange pseudo-militari che agiscono nell’ombra. E’ un susseguirsi di imputati in un tribunale privato e sotterraneo, in una sorta di grotta delle torture, tra le maglie di un patibolo che diviene sempre più scontato, nel ripetersi ossessivo del medesimo copione per ciascun personaggio coinvolto nel delitto: richiesta della confessione scritta del crimine commesso, rifiuto da parte del colpevole, tortura sanguinosa cui segue una resa coatta, redazione di quanto avvenne quello sciagurato 9 maggio con tanto di timbro apposto da una mano grondante sangue. Kim Ki Duk ci mostra la fatica immane dei responsabili nel riconoscere e verbalizzare la verità, nell’ imprimerla su un foglio con le proprie impronte, come un marchio definitivo. Paradossalmente, l’ammissione della colpa sembra costituire un peso insostenibile, maggiore della colpa stessa. Il regista ci offre una disamina impietosa della coscienza assopita dei suoi connazionali, della loro intrinseca, genetica sudditanza, sfociante in una universale, irredimibile banalità del male. Vittime e carnefici nella loro sete di sangue finiscono con l’assomigliarsi e convergere. La vendetta non fa che generare e perpetuare l’ingiustizia. Siamo lontani dalla lirica delicatezza di un padre che sveglia la figlia sulle note della “Gymnopédie No.1” di Erik Satie ne La samaritana, o dall’infelice moglie de Il soffio, che ricrea i colori delle stagioni per un condannato a morte. Un marginale respiro poetico è ritagliato in uno scorcio di meditazione o nella furtiva presenza di un monaco buddhista Il regista indugia quasi compiaciuto su una inestirpabile radice di violenza, sui ributtanti dettagli di inesauste sevizie e massacri, che solo in un istante fugace mostrano la disperazione e il dolore che celano.
Nel presentare il suo nuovo film al Festival di Venezia, Kim Ki-Duk ha desiderato sensibilizzare l’opinione pubblica su una devastante tragedia avvenuta in Corea lo scorso 16 aprile, il naufragio colposo del traghetto Sewol. L’imbarcazione trasportava tre volte il peso massimo consentito, e mai durante quella strage arrivò l’ordine di abbandonare la nave, mentre il comandante ed altri membri dell’equipaggio salirono sulle scialuppe di salvataggio, abbandonando i passeggeri ad una morte certa. Frutto di corruzione e di omertà, questo incidente è carico di una valenza simbolica, effetto com’è di una crisi morale e politica in seno alla società coreana che se da una parte partorisce una classe dirigente capace di ogni nefandezza (poiché sa che resterà impunita), dall’altra educa la gioventù ad un’obbedienza ottusa e cieca che non può non avere conseguenze devastanti: “Il prezzo della cultura coreana che viene trasmesso ai propri figli è l’obbedienza, quindi se un adulto avesse loro detto di non muoversi – ai ragazzi a bordo del traghetto, n.d.r. – loro sicuramente non si sarebbero mossi” (Un giornalista della CNN, due giorni dopo il disastro). Ed omertoso e criminale è il mondo che ci racconta nel suo ultimo film, che si apre con l’uccisione inspiegabile di una giovane studentessa: evento, questo, di portata universale, una sineddoche che allude ai mali del mondo tout court. Kim Ki-Duk infierisce sullo spettatore e lo costringe a confrontarsi coi mostri dell’omologazione e della corruzione. Descrive un mondo omertoso, di fidanzatini assassini che si scambiano tenerezze a tavola con le loro ignare ragazze. Un mondo costituito da una sottile patina di conformità e perbenismo, sotto il quale ogni sorta di mostruosità germina e prospera indisturbata. Il tema dell’omertà – dell’occultamento della verità – è ricorrente nel cinema coreano: pensiamo a Poetry di Lee Chang-dong (2010), dove l’unica preoccupazione dei genitori degli studenti colpevoli era volta a nascondere il crimine e a comprare il silenzio della madre della vittima. In One on one al male eseguito per obbedienza fa seguito il male per vendetta, portato avanti da ignote frange pseudo-militari che agiscono nell’ombra. E’ un susseguirsi di imputati in un tribunale privato e sotterraneo, in una sorta di grotta delle torture, tra le maglie di un patibolo che diviene sempre più scontato, nel ripetersi ossessivo del medesimo copione per ciascun personaggio coinvolto nel delitto: richiesta della confessione scritta del crimine commesso, rifiuto da parte del colpevole, tortura sanguinosa cui segue una resa coatta, redazione di quanto avvenne quello sciagurato 9 maggio con tanto di timbro apposto da una mano grondante sangue. Kim Ki Duk ci mostra la fatica immane dei responsabili nel riconoscere e verbalizzare la verità, nell’ imprimerla su un foglio con le proprie impronte, come un marchio definitivo. Paradossalmente, l’ammissione della colpa sembra costituire un peso insostenibile, maggiore della colpa stessa. Il regista ci offre una disamina impietosa della coscienza assopita dei suoi connazionali, della loro intrinseca, genetica sudditanza, sfociante in una universale, irredimibile banalità del male. Vittime e carnefici nella loro sete di sangue finiscono con l’assomigliarsi e convergere. La vendetta non fa che generare e perpetuare l’ingiustizia. Siamo lontani dalla lirica delicatezza di un padre che sveglia la figlia sulle note della “Gymnopédie No.1” di Erik Satie ne La samaritana, o dall’infelice moglie de Il soffio, che ricrea i colori delle stagioni per un condannato a morte. Un marginale respiro poetico è ritagliato in uno scorcio di meditazione o nella furtiva presenza di un monaco buddhista Il regista indugia quasi compiaciuto su una inestirpabile radice di violenza, sui ributtanti dettagli di inesauste sevizie e massacri, che solo in un istante fugace mostrano la disperazione e il dolore che celano.
The Look of Silence di Joshua Oppenheimer.
 Nel 1965 in Indonesia i paramilitari del movimento Pancasila effettuano un colpo di Stato che sfocia in un genocidio. Più di un milione di comunisti vengono torturati e sterminati. In questo seguito di The Act of Killing, il regista Joshua Oppenheimer segue questi anziani killer benestanti attraverso il punto di vista di un oculista ambulante che li intervista, spinto dal desiderio di far luce sui crimini passati. Direttamente colpito dalla furia omicida di questi assassini – responsabili dell’uccisione di suo fratello – li incontra, mosso forse anche dall’intento di donare a questi mostri la possibilità di pentirsi, di conquistare uno sguardo diverso su quegli orrori distanti nel tempo ma ancora così prepotentemente presenti, dal momento che i carnefici che li hanno perpetrati sono tuttora, vergognosamente, al potere. Conquistare uno sguardo diverso: nella prima scena del film assistiamo appunto ad una prova delle lenti, a due occhi stralunati che cercano di individuare la gradazione più idonea alla loro vista. Quegli occhiali da specialista alla ricerca della lente più adatta assurgono a metafora della ricerca di questo nuovo sguardo, di una chiarezza sulla violenza commessa. Nonostante l’età avanzata, i carnefici non sembrano pentiti. Anzi, ridono compiaciuti al ricordo delle atrocità commesse. Non c’è ombra di coscienza, non un brandello di umanità e consapevolezza. Il loro sguardo sugli eventi resta vitreo, crudele e incosciente. L’oculista e le sue lenti sono impotenti innanzi a questa sconcertante miopia, a questa cecità dell’anima. Le storie che i killer ricordano – o che grottescamente rimettono in scena – con tanto divertimento, raccontano di vittime sventrate, castrate, atrocemente e inspiegabilmente mutilate, mentre imploravano pietà. Il segreto per sopravvivere a questi ignobili crimini è bere il sangue della vittima, sentire il sangue umano che – a detta loro – è allo stesso tempo dolce e salato. Racconti che evocano gli orrori leggendari di Elizabeth Bathory (1560-1614), la sadica, psicotica contessa ungherese che faceva il bagno nel sangue di ragazze vergini, persuasa che in tal modo sarebbe rimasta per sempre giovane. Bere il sangue delle vittime era l’unico modo per non impazzire, spiegano i carnefici: forse qualcosa nella loro coscienze assopite e buie sollevava un dubbio circa la bontà, la liceità, la giustizia delle loro azioni? Tanto da dover escogitare un rimedio, a sua volta mostruoso e inumano quanto i crimini commessi, le conseguenze dei quali suddetto rimedio avrebbe dovuto neutralizzare? La preoccupazione dei carnefici, volta non allo strazio delle vittime trucidate bensì alla salvaguardia della loro salute mentale, è perversa, ributtante. La vittima non è minimamente presa in considerazione, l’orrore delle stragi tutt’al più potrebbe divenire un dramma psicologico per gli assassini. Ciò ci ricorda molto da vicino le parole che Heinrich Himmler rivolge alle sue SS nel suo celebre discorso tenuto a Poznan il 4 ottobre 1943: “La maggioranza di voi sa che cosa significhi vedere cento cadaveri che giacciono insieme, o cinquecento, o mille. Essere passati attraverso tutto ciò e, a parte qualche caso – esempio di debolezza umana – essere rimasti decenti, questo ci ha reso duri. Questa è una pagina gloriosa nella nostra storia che non è mai stata scritta né sarà mai più scritta in futuro”.
Nel 1965 in Indonesia i paramilitari del movimento Pancasila effettuano un colpo di Stato che sfocia in un genocidio. Più di un milione di comunisti vengono torturati e sterminati. In questo seguito di The Act of Killing, il regista Joshua Oppenheimer segue questi anziani killer benestanti attraverso il punto di vista di un oculista ambulante che li intervista, spinto dal desiderio di far luce sui crimini passati. Direttamente colpito dalla furia omicida di questi assassini – responsabili dell’uccisione di suo fratello – li incontra, mosso forse anche dall’intento di donare a questi mostri la possibilità di pentirsi, di conquistare uno sguardo diverso su quegli orrori distanti nel tempo ma ancora così prepotentemente presenti, dal momento che i carnefici che li hanno perpetrati sono tuttora, vergognosamente, al potere. Conquistare uno sguardo diverso: nella prima scena del film assistiamo appunto ad una prova delle lenti, a due occhi stralunati che cercano di individuare la gradazione più idonea alla loro vista. Quegli occhiali da specialista alla ricerca della lente più adatta assurgono a metafora della ricerca di questo nuovo sguardo, di una chiarezza sulla violenza commessa. Nonostante l’età avanzata, i carnefici non sembrano pentiti. Anzi, ridono compiaciuti al ricordo delle atrocità commesse. Non c’è ombra di coscienza, non un brandello di umanità e consapevolezza. Il loro sguardo sugli eventi resta vitreo, crudele e incosciente. L’oculista e le sue lenti sono impotenti innanzi a questa sconcertante miopia, a questa cecità dell’anima. Le storie che i killer ricordano – o che grottescamente rimettono in scena – con tanto divertimento, raccontano di vittime sventrate, castrate, atrocemente e inspiegabilmente mutilate, mentre imploravano pietà. Il segreto per sopravvivere a questi ignobili crimini è bere il sangue della vittima, sentire il sangue umano che – a detta loro – è allo stesso tempo dolce e salato. Racconti che evocano gli orrori leggendari di Elizabeth Bathory (1560-1614), la sadica, psicotica contessa ungherese che faceva il bagno nel sangue di ragazze vergini, persuasa che in tal modo sarebbe rimasta per sempre giovane. Bere il sangue delle vittime era l’unico modo per non impazzire, spiegano i carnefici: forse qualcosa nella loro coscienze assopite e buie sollevava un dubbio circa la bontà, la liceità, la giustizia delle loro azioni? Tanto da dover escogitare un rimedio, a sua volta mostruoso e inumano quanto i crimini commessi, le conseguenze dei quali suddetto rimedio avrebbe dovuto neutralizzare? La preoccupazione dei carnefici, volta non allo strazio delle vittime trucidate bensì alla salvaguardia della loro salute mentale, è perversa, ributtante. La vittima non è minimamente presa in considerazione, l’orrore delle stragi tutt’al più potrebbe divenire un dramma psicologico per gli assassini. Ciò ci ricorda molto da vicino le parole che Heinrich Himmler rivolge alle sue SS nel suo celebre discorso tenuto a Poznan il 4 ottobre 1943: “La maggioranza di voi sa che cosa significhi vedere cento cadaveri che giacciono insieme, o cinquecento, o mille. Essere passati attraverso tutto ciò e, a parte qualche caso – esempio di debolezza umana – essere rimasti decenti, questo ci ha reso duri. Questa è una pagina gloriosa nella nostra storia che non è mai stata scritta né sarà mai più scritta in futuro”.
In The Look of Silence non vi sono rimpianti. La sola eccezione, la figlia di un criminale che ascolta incredula e attonita il padre mentre questi racconta, tutto compiaciuto, di come un giorno aveva portato la testa di una donna decapitata in un bar gestito da un cinese. Agghiacciante la descrizione del seno mutilato di una donna (“… se tagli il seno di una donna sembra un filtro per il latte di cocco…”). Altrove, uno zio diviene responsabile dell’uccisione del nipote. Sostiene che la politica “è il processo di realizzazione dei propri ideali”, tipica mistificazione criminale che abbiamo visto operare in ogni tempo e luogo: ogni qual volta un qualsivoglia “ideale” viene messo davanti alle persone – impedendone così la vista stessa – l’orrore è alle porte, i carnefici sono in incubazione. I genitori dell’oculista-intervistatore non serbano rancore. Sono pacificati. La moglie attribuisce al marito la veneranda età di 140 anni. Forse un modo per dire che ha vissuto, visto troppo. Lui, a sua volta, è convinto di averne soltanto 16: un desiderio di fuga, il sogno di una regressione ad un’età ancora ignara degli orrori a venire? La moglie tiene in mano dei bozzoli di farfalla: larve di una speranza in nuce, un già ma non ancora cui il regista anela. Un embrione timido e tremante che cela la vita, una vita che segretamente lotta per venire alla luce. Ed è al coronamento di questa speranza cui anela l’ottuagenaria madre dell’oculista, interrogando il bozzolo, trepidante: “Voglio vederti, vieni fuori, sei proprio qui?”
Im Keller di Ulrich Seidl
 Un tempo centro di un enorme impero multinazionale poi smembrato all’indomani della fine della prima guerra mondiale, l’Austria – che il Trattato di Versailles aveva ridotto ad un microscopico staterello, con una ormai sproporzionata capitale, Vienna, assomigliante ad una testa privata del suo corpo – aveva accolto con entusiasmo l’ingresso di Adolf Hitler e la conseguente annessione al Grande Reich germanico. Smarrita la grandezza di un tempo, una nazione alla ricerca di nuove identità e punti di riferimento era rimasta irretita dall’equivoca grandezza della confinante Germania nazionalsocialista, il cui potere sembrava destinato ad accrescere ed espandersi irresistibilmente, di contro al lassismo impotente delle democrazie occidentali. Cedendo la sua sovranità e prostituendosi alle gratificazioni svilenti di una grandezza riflessa e vassalla – e rendendosi in tal modo connivente col regime più odiato della storia d’Occidente – l’Austria si è ammalata di un senso di colpa impossibile da elaborare, e che ha cercato pertanto di occultare. Ma poiché, come insegnava l’austriaco Sigmund Freud, ciò che viene rimosso non sparisce affatto, ma anzi agisce nell’inconscio con una forza che è proporzionale all’intensità con cui è stato negato, ecco che Ulrich Seidl ci accompagna in un vero viaggio negli inferi dell’inconscio collettivo austriaco, scegliendo una metafora di cristallina chiarezza, immediatamente intelligibile, finanche didascalica: la cantina. Un fondale marcio, una discarica dell’anima, il volto nascosto di una nazione. Il regista ci trascina in interni squallidi, sgradevoli, con tappezzerie obsolete che individui apparentemente normali popolano di riti, depravazioni partorite da istinti repressi, regressioni folkloristiche e nostalgiche. In questi abissi, in queste cantine dell’anima, troviamo divise e cimeli nazisti – tra questi, un dipinto del Fűhrer, omaggio di nozze – o il paranoico esercitarsi al poligono di tiro contro una fantomatica minaccia turca, memore delle interminabili guerre che Vienna aveva combattuto contro l’Impero ottomano. La dinamica vittima/carnefice, sadico/masochista è il tessuto che intrama e lega tutti gli episodi di un film narrato con piglio documentaristico, che nel suo procedere assume toni sempre più assurdi e grotteschi. Dalla prima scena del porcellino d’India divorato da un anaconda, ad una boteriana prostituta chiusa in gabbia fino ad una donna che adora essere frustata e una moglie che ama dominare ed appendere il marito per i testicoli, Seidl ci mostra un universo incancrenito nella contraddizione: la donna che chiede la verga e le umiliazioni verbali è nella vita di tutti i giorni un’impiegata della Caritas che si occupa proprio di violenza sulle donne! Le cantine austriache paiono rifiutare quella mediazione democratica che viene rivendicata in superficie, e raggiungono le vette del piacere nell’istinto prevaricatore a braccetto con la sudditanza più strisciante, come avviene in “Venere in pelliccia”, dell’austriaco Von Sacher-Masoch (1836-1895), sul modello del quale lo psichiatra austriaco Von Krafft-Ebing aveva coniato l’espressione “masochismo” nella sua “Psychopatia sexualis” (1886). I crocifissi dominano ogni ambiente, anche questo memoria di un’Austria baluardo della cattolicità, ma allo stesso tempo intrisa di una religiosità controriformista, rococò, formale e mondana che diviene facilmente mero costume, ‘abito’ sociale, suggestione e narcosi da incenso che ci ricordano le estasi liturgiche di Hitler bambino davanti all’opulenza del cerimoniale cattolico narrate nel suo “Mein Kampf”. E il pensiero corre ancora ad Hitler lungo un’altra scena del film: la grande difesa alle minacce mondiali cui accennavamo avviene in un garage e chi spara si ritrova solo allo specchio ad intonare “Mamma, solo per te la mia canzone vola…”. Paranoia e odio verso il mondo esterno possono scaturire proprio da questa fissazione alla madre, unica rassicurante fonte di bene e di amore, di contro ad un mondo ostile, da combattere, da cui difendersi. E Hitler incarna perfettamente questa morbosa fissazione alla madre, tanto da costituire un esempio da manuale – con la sua avversione, di contro, per il padre – del romanzo familiare edipico descritto dall’austriaco Freud per la prima volta ne “L’interpretazione dei sogni” (1899). Il regista indugia ossessivamente sul fallo, ridotto ormai a giocattolo senza virilità, da zavorrare, appendere, tirare, sollevare. L’Austria ritratta da Seidl è una nazione alla ricerca di una punizione che la sgravi da colpe e responsabilità che non vuole riconoscere, perpetuando in tal modo il bisogno di punizione e incancrenendolo in un aporetico supplizio di Sisifo. E’ un popolo senza padre – il fallo, la virilità svilite, derubricate a giocattoli – e senza madre: nessuna donna nel film sembra avere un figlio, e il senso materno frustrato trova una sorta di allucinato risarcimento nella donna che colleziona bambole di neonati in scatola, inquietanti surrogati da cullare e ai quali insegnare le coordinate geografiche di uno Stato che non esiste più. Seidl ci racconta l’introversione sadomasochista di una nazione. Già l’austriaco Musil, ne “I turbamenti del giovane Tőrless”, aveva raccontato il clima di sevizie, torture, sadico bullismo in cui ha luogo l’”educazione” del giovane cadetto militare Tőrless, nome che possiamo tradurre come “blindato”, “chiuso”. E così ci appaiono le cantine descritteci da Seidl: finché domina la rimozione, i personaggi del film non saranno mai liberi. Incapaci di azione, sempre ricattati da quanto hanno rimosso, non potranno trovare la via per risalire alla luce.
Un tempo centro di un enorme impero multinazionale poi smembrato all’indomani della fine della prima guerra mondiale, l’Austria – che il Trattato di Versailles aveva ridotto ad un microscopico staterello, con una ormai sproporzionata capitale, Vienna, assomigliante ad una testa privata del suo corpo – aveva accolto con entusiasmo l’ingresso di Adolf Hitler e la conseguente annessione al Grande Reich germanico. Smarrita la grandezza di un tempo, una nazione alla ricerca di nuove identità e punti di riferimento era rimasta irretita dall’equivoca grandezza della confinante Germania nazionalsocialista, il cui potere sembrava destinato ad accrescere ed espandersi irresistibilmente, di contro al lassismo impotente delle democrazie occidentali. Cedendo la sua sovranità e prostituendosi alle gratificazioni svilenti di una grandezza riflessa e vassalla – e rendendosi in tal modo connivente col regime più odiato della storia d’Occidente – l’Austria si è ammalata di un senso di colpa impossibile da elaborare, e che ha cercato pertanto di occultare. Ma poiché, come insegnava l’austriaco Sigmund Freud, ciò che viene rimosso non sparisce affatto, ma anzi agisce nell’inconscio con una forza che è proporzionale all’intensità con cui è stato negato, ecco che Ulrich Seidl ci accompagna in un vero viaggio negli inferi dell’inconscio collettivo austriaco, scegliendo una metafora di cristallina chiarezza, immediatamente intelligibile, finanche didascalica: la cantina. Un fondale marcio, una discarica dell’anima, il volto nascosto di una nazione. Il regista ci trascina in interni squallidi, sgradevoli, con tappezzerie obsolete che individui apparentemente normali popolano di riti, depravazioni partorite da istinti repressi, regressioni folkloristiche e nostalgiche. In questi abissi, in queste cantine dell’anima, troviamo divise e cimeli nazisti – tra questi, un dipinto del Fűhrer, omaggio di nozze – o il paranoico esercitarsi al poligono di tiro contro una fantomatica minaccia turca, memore delle interminabili guerre che Vienna aveva combattuto contro l’Impero ottomano. La dinamica vittima/carnefice, sadico/masochista è il tessuto che intrama e lega tutti gli episodi di un film narrato con piglio documentaristico, che nel suo procedere assume toni sempre più assurdi e grotteschi. Dalla prima scena del porcellino d’India divorato da un anaconda, ad una boteriana prostituta chiusa in gabbia fino ad una donna che adora essere frustata e una moglie che ama dominare ed appendere il marito per i testicoli, Seidl ci mostra un universo incancrenito nella contraddizione: la donna che chiede la verga e le umiliazioni verbali è nella vita di tutti i giorni un’impiegata della Caritas che si occupa proprio di violenza sulle donne! Le cantine austriache paiono rifiutare quella mediazione democratica che viene rivendicata in superficie, e raggiungono le vette del piacere nell’istinto prevaricatore a braccetto con la sudditanza più strisciante, come avviene in “Venere in pelliccia”, dell’austriaco Von Sacher-Masoch (1836-1895), sul modello del quale lo psichiatra austriaco Von Krafft-Ebing aveva coniato l’espressione “masochismo” nella sua “Psychopatia sexualis” (1886). I crocifissi dominano ogni ambiente, anche questo memoria di un’Austria baluardo della cattolicità, ma allo stesso tempo intrisa di una religiosità controriformista, rococò, formale e mondana che diviene facilmente mero costume, ‘abito’ sociale, suggestione e narcosi da incenso che ci ricordano le estasi liturgiche di Hitler bambino davanti all’opulenza del cerimoniale cattolico narrate nel suo “Mein Kampf”. E il pensiero corre ancora ad Hitler lungo un’altra scena del film: la grande difesa alle minacce mondiali cui accennavamo avviene in un garage e chi spara si ritrova solo allo specchio ad intonare “Mamma, solo per te la mia canzone vola…”. Paranoia e odio verso il mondo esterno possono scaturire proprio da questa fissazione alla madre, unica rassicurante fonte di bene e di amore, di contro ad un mondo ostile, da combattere, da cui difendersi. E Hitler incarna perfettamente questa morbosa fissazione alla madre, tanto da costituire un esempio da manuale – con la sua avversione, di contro, per il padre – del romanzo familiare edipico descritto dall’austriaco Freud per la prima volta ne “L’interpretazione dei sogni” (1899). Il regista indugia ossessivamente sul fallo, ridotto ormai a giocattolo senza virilità, da zavorrare, appendere, tirare, sollevare. L’Austria ritratta da Seidl è una nazione alla ricerca di una punizione che la sgravi da colpe e responsabilità che non vuole riconoscere, perpetuando in tal modo il bisogno di punizione e incancrenendolo in un aporetico supplizio di Sisifo. E’ un popolo senza padre – il fallo, la virilità svilite, derubricate a giocattoli – e senza madre: nessuna donna nel film sembra avere un figlio, e il senso materno frustrato trova una sorta di allucinato risarcimento nella donna che colleziona bambole di neonati in scatola, inquietanti surrogati da cullare e ai quali insegnare le coordinate geografiche di uno Stato che non esiste più. Seidl ci racconta l’introversione sadomasochista di una nazione. Già l’austriaco Musil, ne “I turbamenti del giovane Tőrless”, aveva raccontato il clima di sevizie, torture, sadico bullismo in cui ha luogo l’”educazione” del giovane cadetto militare Tőrless, nome che possiamo tradurre come “blindato”, “chiuso”. E così ci appaiono le cantine descritteci da Seidl: finché domina la rimozione, i personaggi del film non saranno mai liberi. Incapaci di azione, sempre ricattati da quanto hanno rimosso, non potranno trovare la via per risalire alla luce.
Ich sehe, ich sehe (Goodnight Mommy) di Veronika Franz
 Una casa isolata nella campagna, circondata da boschi e campi di granoturco. Due fratelli gemelli di nove anni – Lukas ed Elias – attendono la loro madre, ricoverata in ospedale. Quando lei fa ritorno, è bendata da capo a piedi, reduce da un intervento chirurgico. Anche il suo carattere sembra temporaneamente mutato, è severa, distante: affaticata com’è dall’operazione, ha bisogno di pace. I due figli iniziano a dubitare che si tratti effettivamente della loro madre, e faranno ricorso ad ogni espediente, anche il più sadico e perverso, per appurare la verità. “Un film d’orrore? Un film d’autore?” commenta la regista, “il nostro film vuole essere entrambe le cose. Amiamo il cinema di grande impatto, capace di sopraffare lo spettatore. Ma allo stesso tempo, con la nostra narrazione intendiamo formulare interrogativi di ordine esistenziale. Interrogativi attinenti alla concretezza dell’esistenza, all’educazione, e ai rapporti di forza all’interno della famiglia. Interrogativi sull’identità, e soprattutto sulla mostruosità che alberga negli esseri umani. Abbiamo voluto realizzare un film che dica qualcosa sulle nostre vite, e che allo stesso tempo ci faccia gelare fino alle ossa”. Veronika Franz ci racconta il progressivo ripiegamento su se stessi dei due protagonisti, la loro regressione, l’introversione in un mondo anti-sociale, emotivamente autistico e intramato di rabbia, ostilità, sospetto. Il volto nascosto della madre è possente metafora dell’amore che i figli sentono che lei sta trattenendo, sottraendo loro: questa percezione è talmente insopportabile da generare appunto il dubbio sull’identità stessa di quella persona, di quella donna a loro ormai estranea, che si spaccia per madre. Se in Time (2006) di Kim Ki-Duk, la maschera, l’occultamento del proprio volto era l’espediente di una donna follemente innamorata per conquistare il proprio compagno, ossessionata com’era dall’idea che lui potesse assuefarsi a lei e desiderare nuovi volti; qui il volto coperto minaccia la recisione dei più elementari legami filiali. L’ostilità crescente dei figli nei confronti della madre degenera infatti in una spirale di orrore che porterà a quanto di più inaudito e innaturale vi possa essere: la recisione del legame d’amore che una madre prova per i propri figli. La donna diviene vittima di tutta una costellazione psichica infantile fatta di paranoie, cospirazioni, false premesse e fatali conclusioni, come avviene nell’agghiacciante Riflessi sulla pelle (1990) di Philip Ridley, dove il ragazzino Seth tormenta una giovane vedova, erroneamente convinto trattarsi di un vampiro (conclusione che trae notando la somiglianza tra l’abbigliamento della vedova – in nero, gli occhi sempre celati dietro degli occhiali da sole – con quello di una donna-vampiro di un fumetto che sta leggendo). Come gli Inquisitori nei processi per “stregoneria” nei secoli XVI-XVII (circa 60.000 persone giustiziate, in stragrande maggioranza donne), i bambini di questo film – persuasi come sono di una tesi folle – si industriano in tutti i modi per distorcere i fatti e fabbricare essi stessi quelle prove che poi li convinceranno della verità delle loro farneticazioni. Coraline, nel perturbante romanzo omonimo di Neil Gaiman – divenuto poi film nel 2009 – attraverso una piccola porta misteriosa della sua casa accede a quella che sembra essere pur sempre la sua casa, eppure si tratta di una sorta di doppio incantato e sinistro, dove trova quelli che sembrano essere i suoi genitori, l’Altra Madre e l’Altro Padre, dei doppelgänger identici agli originali, se non fosse che hanno dei bottoni cuciti al posto degli occhi. Nel corso della narrazione Coraline scoprirà che l’Altra Madre in realtà altro non è che una strega, che ha distorto il mondo della ragazzina per attrarla a sé e cibarsi della sua anima. In Ich sehe ich sehe Lukas ed Elias invece danno la caccia ad una strega che non c’è. Ciò contro cui lottano è soltanto il fantasma costruito dalle loro paure, dalla loro paura dell’abbandono, dalla loro paura di non essere amati. E se il sonno della ragione genera mostri, anche la convinzione di non essere amati può farlo. Resi carnefici per il timore di essere vittime, Lukas ed Elias non scorgono più, nella mummia vivente che si trovano innanzi, l’essere umano che li ha generati, bensì vedono soltanto – Ich sehe Ich sehe significa, per l’appunto, ‘Io vedo Io vedo’ – il feticcio creato dalle loro paure e pronto per essere immolato in una spietata, fanatica ordalia.
Una casa isolata nella campagna, circondata da boschi e campi di granoturco. Due fratelli gemelli di nove anni – Lukas ed Elias – attendono la loro madre, ricoverata in ospedale. Quando lei fa ritorno, è bendata da capo a piedi, reduce da un intervento chirurgico. Anche il suo carattere sembra temporaneamente mutato, è severa, distante: affaticata com’è dall’operazione, ha bisogno di pace. I due figli iniziano a dubitare che si tratti effettivamente della loro madre, e faranno ricorso ad ogni espediente, anche il più sadico e perverso, per appurare la verità. “Un film d’orrore? Un film d’autore?” commenta la regista, “il nostro film vuole essere entrambe le cose. Amiamo il cinema di grande impatto, capace di sopraffare lo spettatore. Ma allo stesso tempo, con la nostra narrazione intendiamo formulare interrogativi di ordine esistenziale. Interrogativi attinenti alla concretezza dell’esistenza, all’educazione, e ai rapporti di forza all’interno della famiglia. Interrogativi sull’identità, e soprattutto sulla mostruosità che alberga negli esseri umani. Abbiamo voluto realizzare un film che dica qualcosa sulle nostre vite, e che allo stesso tempo ci faccia gelare fino alle ossa”. Veronika Franz ci racconta il progressivo ripiegamento su se stessi dei due protagonisti, la loro regressione, l’introversione in un mondo anti-sociale, emotivamente autistico e intramato di rabbia, ostilità, sospetto. Il volto nascosto della madre è possente metafora dell’amore che i figli sentono che lei sta trattenendo, sottraendo loro: questa percezione è talmente insopportabile da generare appunto il dubbio sull’identità stessa di quella persona, di quella donna a loro ormai estranea, che si spaccia per madre. Se in Time (2006) di Kim Ki-Duk, la maschera, l’occultamento del proprio volto era l’espediente di una donna follemente innamorata per conquistare il proprio compagno, ossessionata com’era dall’idea che lui potesse assuefarsi a lei e desiderare nuovi volti; qui il volto coperto minaccia la recisione dei più elementari legami filiali. L’ostilità crescente dei figli nei confronti della madre degenera infatti in una spirale di orrore che porterà a quanto di più inaudito e innaturale vi possa essere: la recisione del legame d’amore che una madre prova per i propri figli. La donna diviene vittima di tutta una costellazione psichica infantile fatta di paranoie, cospirazioni, false premesse e fatali conclusioni, come avviene nell’agghiacciante Riflessi sulla pelle (1990) di Philip Ridley, dove il ragazzino Seth tormenta una giovane vedova, erroneamente convinto trattarsi di un vampiro (conclusione che trae notando la somiglianza tra l’abbigliamento della vedova – in nero, gli occhi sempre celati dietro degli occhiali da sole – con quello di una donna-vampiro di un fumetto che sta leggendo). Come gli Inquisitori nei processi per “stregoneria” nei secoli XVI-XVII (circa 60.000 persone giustiziate, in stragrande maggioranza donne), i bambini di questo film – persuasi come sono di una tesi folle – si industriano in tutti i modi per distorcere i fatti e fabbricare essi stessi quelle prove che poi li convinceranno della verità delle loro farneticazioni. Coraline, nel perturbante romanzo omonimo di Neil Gaiman – divenuto poi film nel 2009 – attraverso una piccola porta misteriosa della sua casa accede a quella che sembra essere pur sempre la sua casa, eppure si tratta di una sorta di doppio incantato e sinistro, dove trova quelli che sembrano essere i suoi genitori, l’Altra Madre e l’Altro Padre, dei doppelgänger identici agli originali, se non fosse che hanno dei bottoni cuciti al posto degli occhi. Nel corso della narrazione Coraline scoprirà che l’Altra Madre in realtà altro non è che una strega, che ha distorto il mondo della ragazzina per attrarla a sé e cibarsi della sua anima. In Ich sehe ich sehe Lukas ed Elias invece danno la caccia ad una strega che non c’è. Ciò contro cui lottano è soltanto il fantasma costruito dalle loro paure, dalla loro paura dell’abbandono, dalla loro paura di non essere amati. E se il sonno della ragione genera mostri, anche la convinzione di non essere amati può farlo. Resi carnefici per il timore di essere vittime, Lukas ed Elias non scorgono più, nella mummia vivente che si trovano innanzi, l’essere umano che li ha generati, bensì vedono soltanto – Ich sehe Ich sehe significa, per l’appunto, ‘Io vedo Io vedo’ – il feticcio creato dalle loro paure e pronto per essere immolato in una spietata, fanatica ordalia.
Dio è negli occhi di chi guarda
Su Words with Gods di Guillermo Arriaga, Hector Babenco, Alex de la Iglesia, Bahman Ghobadi, Amos Gitai, Emir Kusturica, Mira Nair, Hideo Nakata, Warwick Thornton.
 Nato da un’idea del romanziere, sceneggiatore, regista e produttore messicano Guillermo Arriaga, Words with Gods intende instaurare un dialogo critico e rispettoso sul significato della religione, sul significato di Dio e degli dei. In nove cortometraggi, ciascuno dedicato ad una religione o confessione religiosa – spiritualità aborigena, cattolicesimo, islam, ebraismo, shintoismo/buddhismo, cristianesimo ortodosso, umbanda (culto brasiliano sincretistico, che mescola religioni africane e cattolicesimo), induismo e ateismo – il film presenta diversi punti di vista sul ruolo che la religione assume nella vita dell’uomo. “Nel film si affronta una singola religione per cortometraggio, ed ogni regista si è impegnato religiosamente, socialmente e culturalmente nel descrivere la propria fede. Non doveva esserci alcun tipo di giudizio esterno nelle storie. Che il regista fosse credente o meno, non era importante, ma doveva parlare ed esprimersi secondo le norme e le credenze della sua cultura religiosa (Guillermo Arriaga).
Nato da un’idea del romanziere, sceneggiatore, regista e produttore messicano Guillermo Arriaga, Words with Gods intende instaurare un dialogo critico e rispettoso sul significato della religione, sul significato di Dio e degli dei. In nove cortometraggi, ciascuno dedicato ad una religione o confessione religiosa – spiritualità aborigena, cattolicesimo, islam, ebraismo, shintoismo/buddhismo, cristianesimo ortodosso, umbanda (culto brasiliano sincretistico, che mescola religioni africane e cattolicesimo), induismo e ateismo – il film presenta diversi punti di vista sul ruolo che la religione assume nella vita dell’uomo. “Nel film si affronta una singola religione per cortometraggio, ed ogni regista si è impegnato religiosamente, socialmente e culturalmente nel descrivere la propria fede. Non doveva esserci alcun tipo di giudizio esterno nelle storie. Che il regista fosse credente o meno, non era importante, ma doveva parlare ed esprimersi secondo le norme e le credenze della sua cultura religiosa (Guillermo Arriaga).
Questa è la cifra espressiva che più colpisce in Words with Gods: ben lontano dall’apologia come dalla condanna, ben lontano dallo scherno del documentario americano Religiolous (2008) – eloquente neologismo nato dall’incrocio tra gli aggettivi religious e ridiculous – il film a episodi concepito da Arriaga e supervisionato dal premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa ha il pregio di coniugare l’obiettività dello sguardo e un’oggettività tipica dello stile epico, diremmo quasi omerica, con un approccio allo stesso tempo simpatetico e carico di pietas. Poiché parlare della religione – con le sue eterne questioni: presenza/assenza di Dio, bene e male, amore, sofferenza, morte e aldilà – significa parlare dell’uomo stesso. Pertanto in Words with Gods teologia e antropologia diventano tutt’uno, e nel rapporto dell’uomo col suo dio si rinviene un punto di vista privilegiato per esplorare il mondo interiore dell’uomo stesso. Se troppo spesso la religione ha diviso e divide, questo film sembra coltivare l’ambizione di fondare – proprio sulle differenze religiose – la possibilità di un nuovo umanesimo, a partire dalle comuni, insopprimibili esigenze di senso dell’uomo di ogni epoca e luogo. “Penso che la religione, qualunque religione, debba tirare fuori il meglio dalle persone. La storia ci ha dimostrato che quando s’impone una religione, quando Dio diventa una scusa per generare intolleranza e persecuzioni, la religione perde la sua essenza. La vera religione è un invito ad essere migliore, a sentire la compagnia di un essere superiore che ci osserva e che si prende cura di noi. Io sono ateo e spesso sono stato criticato per questo. I credenti non accettano chi non crede. Molti pensano che siamo atei perché ci mancano dei valori o perché non crediamo che ci sia un occhio sempre vigile su di noi e quindi siamo fuori controllo e non ci comportiamo come dovremmo. Nulla di tutto ciò è più lontano dalla verità. Immaginiamo che un ateo diventi umanista. Dal momento che non crediamo in qualcos’altro o in un’entità superiore, l’umanità dovrebbe diventare il centro della nostra vita. Noi non guardiamo in alto, non guardiamo giù. Guardiamo dritto negli occhi delle persone. Questa è la cosa più importante per me, che ogni ateo – nel profondo del suo cuore – sia però un umanista” (Arriaga).
Guardare dritto negli occhi delle persone: questa è l’essenza del vero credente, questa l’essenza dell’ateo umanista. Ogni autentico sentire religioso deve necessariamente significare empatia, amore per il prossimo. Qualsiasi forma religiosa che alieni l’individuo dai propri simili, o addirittura li renda ai suoi occhi dei nemici da combattere, è falsa, perversa. In diversi episodi di Words with Gods la religione effettivamente ‘tira fuori il meglio dalle persone’: ne L’uomo che rubò un’anatra (Hector Babenco) un marito violento è abbandonato dalla moglie, lascia morire di stenti suo figlio neonato, e finisce per trascinarsi – ormai sull’orlo della follia – per le strade di San Paulo, come un clochard. L’imbattersi nella celebrazione di un rito para-cristiano cambierà la sua vita, infondendogli il desiderio di riscatto e resurrezione. Lo vedremo alla fine dell’episodio di nuovo nella sua casa, finalmente ripulita dall’immondizia che vi aveva accumulato. Lui si è lavato, ed è completamente nudo: una nuova nascita, un lavacro di rigenerazione, un nuovo battesimo. Ne La confessione (Alex de Iglesia) un killer viene scambiato per un prete cattolico: questo equivoco dai toni – sulle prime – farseschi lo porterà ad un inatteso finale di redenzione e perdono. Ne La nostra vita (Emir Kusturica) un prete ortodosso vive in solitudine il suo cammino di ascesi ed espiazione. Ne I veri dei (Warwick Thornton) la protagonista – una giovane donna incinta – trova nel culto delle Madri la forza per ritirarsi in un deserto australiano e partorire da sola. Non ha bisogno di ospedali, medici, ostetriche: sente la presenza della Madre, non le serve altro. “E nella profondità dei miei sogni ho cercato la potenza, il giusto, l’originario, ovvero il creatore. Ma lì nel buio da solo ho trovato mia madre, mia sorella e mia nonna. Questo mi ha riempito di gioia e mi ha illuminato. Ero circondato da divinità, che fanno miracoli ogni giorno, realizzano il miracolo della nascita. Per me, una persona che può dare la vita è un Dio” (Thornton). In Sofferenze (Hideo Nakata), la religione diviene strumento di riconciliazione con se stessi e con la vita da parte di un marito e padre che ha perso tutta la sua famiglia nello tsunami che ha devastato il Giappone nel 2011.
La religione però, “ha saputo dividere (…) sa come escludere e mettere da parte” (Vargas Llosa): è quanto avviene nella grottesca vicenda di due fratelli siamesi uniti per la testa in A volte alza lo sguardo (Bahman Ghobadi): l’uno fervente musulmano, l’altro miscredente: quest’ultimo ha fissato un appuntamento con una donna via Facebook, e il fratello devoto – che ovviamente non potrà che essere presente all’incontro – ne è inorridito. Il loro conflitto – benché mantenuto su toni surreali e tragicomici – è potenzialmente fratricida. Il nesso religione-violenza è invece il cuore stesso dell’impressionante episodio di Amos Gitai, Il libro di Amos. Mentre alcuni attori – che abbiamo già visto recitare nei suoi film – camminano per le strade di Tel Aviv declamando passi dell’omonimo libro biblico, civili e soldati lottano sullo sfondo. Le parole enfatiche, l’esaltazione fanatica tipica dell’antico linguaggio profetico trovano una sorta di terribile conferma e attuazione in una attualità politica carica di tensione e violenza. La religione, oltre che potenzialmente fratricida (A volte alza lo sguardo) e guerrafondaia (Il libro di Amos), è spesso anche, più semplicemente, ipocrisia: è quanto avviene ne La stanza di Dio (Mira Nair), dove una facoltosa famiglia di Mumbai “si trasferisce in un appartamento di lusso con vista sul mare e sugli slums. Il simbolo di una famiglia multigenerazionale che vuole vivere sotto lo stesso tetto in armonia, si rompe poco dopo a causa di una discussione sulla disposizione delle stanze, anzi sulla disposizione della stanza per il Dio” (Nair), come se Dio davvero avesse bisogno di una stanza, come se – non più Essere, ma derubricato ad ente – fosse un bene ‘disponibile’, governabile, addomesticabile, un’ennesima ricchezza da esibire nella casa di una famiglia socialmente affermata. Ma “mentre la famiglia discute e rivela il suo lato ipocrita, solo il piccolo della famiglia vede che Dio è ovunque … che Dio è negli occhi di chi guarda. La casa di Dio è dentro di noi, e non fuori” (Nair).
Se il rapporto dell’uomo con Dio si traduce di volta in volta nella rinascita, nella redenzione e nel riscatto (Babenco, de la Iglesia, Kusturica), nel rigenerarsi alla fonte stessa della vita (Thompson), nell’accettazione e quindi nella trasformazione della sofferenza (Nakata), nel conflitto fratricida (Ghobadi), in un detonatore di violenza (Gitai), in una osservanza burocratica e ipocrita (Nair), questo rapporto si traduce infine nella negazione stessa di un rapporto: l’assenza di Dio, la solitudine dell’uomo, l’ateismo. Siamo all’ultimo episodio, Sangue di Dio, girato dall’ideatore dell’intero progetto, Arriaga. Un anziano padre sconvolto chiama d’urgenza il figlio. Il figlio si precipita da lui, e il padre gli confida d’aver sognato Dio, quella notte. Dio gli ha confessato di non poterne più, di essere stanco, stravolto: desidera uccidersi. Il figlio prende congedo, convinto che il padre stia delirando: eppure, una volta messosi alla guida della sua auto, una pioggia torrenziale di sangue si riversa sulla Terra. Dio si è ucciso: è suo il sangue che scroscia sul mondo. Immagini impressionanti, memori della prima piaga d’Egitto, la trasmutazione dell’acqua in sangue. E se nel libro dell’Esodo l’Egitto tinto di sangue è dimostrazione portentosa della presenza e potenza di Dio, e se parimenti nel Nuovo Testamento il sangue col quale Cristo suggella la nuova, eterna alleanza è segno di una presenza, di una vicinanza totale di Dio all’uomo, qui al contrario il sangue diviene prova della morte di Dio, del suo irreversibile sparire dall’orizzonte umano, dello stato di totale abbandono e solitudine dell’uomo.
Si può credere o non credere in Dio, si può dubitare che le religioni istituzionali possano portare a Dio, che possano dire qualcosa di autentico su di Lui: ciò che è certo, è che le religioni dicono moltissimo sull’uomo. La religione di un popolo è una chiave di lettura unica per comprendere, di questo popolo, mentalità, attitudini, forze e debolezze, sogni e paure. Tutta la cultura di un popolo trapassa nella religiosità che adotta, e viceversa la sua religione non potrà che portare l’inconfondibile cifra espressiva della sua cultura. E’ affascinante infatti, come dice Vargas Llosa, “come la religione riesca a esprimere una certa cultura e a conservarne le tradizioni e rappresentarle nella poesia e nell’arte. In altre parole, la religione fornisce all’umanità gli strumenti per esistere, vivere e condividere”. In queste ultime parole, Vargas Llosa sembra assegnare alla religione un ruolo propulsore nello sviluppo della civiltà, in accordo con le recenti teorie evoluzioniste sviluppate nell’ambito della psicologia cognitiva, della filosofia della scienza, delle neuroscienze: il nostro cervello sarebbe predisposto a credere ad una mente creatrice superiore, poiché questa interpretazione del mondo in termini di obiettivi ed intenzioni costituirebbe un forte vantaggio evolutivo (cfr. Vallortigara, Pievani, Girotto “Nati per credere”, Codice Edizioni, 2008). E se una risposta, per quanto sbagliata, è inevitabilmente più rassicurante e motivante dell’assenza di risposte, le religioni certo non hanno mai smesso, tra le altre cose, di rassicurare e motivare l’uomo, nel corso del suo impervio ‘pellegrinaggio’ terreno.
.
VENEZIA ORIZZONTI
di Giampiero Raganelli
Le nuove correnti del cinema mondiale. Con questo, impegnativo, sottotitolo si presenta la sezione collaterale veneziana, ideata nell’era mülleriana, più o meno con l’idea della Quinzaine, e ora al secondo anno della gestione Barbera. Difficile trarre un bilancio. I film più importanti, vedi quest’anno Belluscone – Una storia siciliana, suscitano semmai l’indignazione per non essere stati presi in concorso ed essere stati relegati in una sezione ritenuta ‘minore’. Gli umori, e i malumori, sono effettivamente gli stessi della Quinzaine. Le opere che comunque giustificano la vocazione della sezione, i nuovi orizzonti del cinema, non sono mancate. E neanche poche. Heaven Knows What di per esempio, di Josh Safdie e Benny Safdie, una storia disperata di tossicodipendenza, che parte da Kids, da quello che vorrebbero essere Larry Clark e Harmony Korine senza riuscirci, evitando il loro compiacimento e moralismo, per avvicinarsi ad Anna di Alberto Grifi, nel mettere in scena una vera tossicodipendente presa dalla strada. Tra macchina a mano disturbante e musica angosciante, elettronica e dubstep, il film non concede nessuna via di fuga.
Notevole anche il film vincitore della sezione, Court di Chaitanya Tamhane, un viaggio nel sistema giudiziario indiano in una lunga ed estenuante ripresa di processi di un tribunale di Mumbai, tra requisitorie, arringhe e sentenze. Tutto fa capire che siamo di fronte a un documentarista che ha assimilato le lezioni di Frederick Wiseman o Nicolas Philibert: il dipanarsi lento delle situazioni, l’entrare nei gangli di un’istituzione, il seguire avvocati e pubblici ministeri anche a casa loro o mentre fanno la spesa. In realtà si tratta di ricostruzioni fedeli di processi reali, visto che in India vige la proibizione di riprendere i processi nelle aule di giustizia. Ne emerge comunque un quadro verista di un paese con ancora forti sacche di analfabetismo, mentre il film scivola verso l’atto di denuncia, ma mai diretto e mai in forma di invettiva, e mostra anche irruzioni e soprusi delle forze dell’ordine, nei confronti di artisti, impedendo la manifestazione del libero pensiero.
Orizzonti si è accaparrata anche l’ultima opera del sudcoreano festivaliero Hong Sangsoo, Hill of Freedom. Regista prolifico, capace di sfornare uno o due film l’anno, Hong confeziona un’opera che sembra non discostarsi dal suo lavoro abituale. Un racconto secco, la storia di una separazione e di un tentativo di rintracciare la ex compagna, che si gioca tra tavolini di bar e locande, fatte di lunghe chiacchierate, momenti di convivialità a base di alcol. Puntuale spunta un personaggio, metacinematografico, legato al mondo del cinema. Ma all’interno di questa struttura, Hong gioca, con lo stratagemma dei fogli del diario non datati che cadono per terra scompigliandosi, sullo sconvolgimento e rimescolamento dell’ordine cronologico in cui si susseguono gli elementi narrativi.
Parallelamente all’ultimo devastante film di Ulrich Seidl, In the basement, fuori concorso a Venezia, Orizzonti ha presentato un’opera da lui prodotta Goodnight Mommy della moglie e braccio destro Veronika Franz con l’altra sua collaboratrice Severin Fiala. Un horror canicolare e agreste, protagonisti due gemelli e una madre che forse non è più la vera madre: tornano l’orrore e i mostri che si annidano nel quotidiano che qui si incarnano in un horror che è un Seidl normalizzato, che trae evidente ispirazione dalla Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf.
 Da ricordare anche Near Death Experience di Benoît Delépine e Gustave Kervern, sulla carta un buon acquisto per Orizzonti, ma che si è rivelato una delusione. La premessa maggiore per questo film veniva dalla presenza, fisica e scenica, dello scrittore Michel Houellebecq come protagonista. Il film è il peregrinare nella natura, tra colline e boschi, di un uomo che ha fissato un appuntamento con la morte via suicidio. Un film che esibisce la sua estrema sobrietà e povertà – è stato realizzato con una troupe di sole sette persone nelle montagne della Provenza – e che si struttura come una lunga galleria di paesaggi. A non funzionare è lo scarto tra l’impianto letterario dato dalla voce off e le immagini, come se i due elementi si rincorressero invano per tutto il film, senza che nessuno dei due riesca mai a giustificare l’altro.
Da ricordare anche Near Death Experience di Benoît Delépine e Gustave Kervern, sulla carta un buon acquisto per Orizzonti, ma che si è rivelato una delusione. La premessa maggiore per questo film veniva dalla presenza, fisica e scenica, dello scrittore Michel Houellebecq come protagonista. Il film è il peregrinare nella natura, tra colline e boschi, di un uomo che ha fissato un appuntamento con la morte via suicidio. Un film che esibisce la sua estrema sobrietà e povertà – è stato realizzato con una troupe di sole sette persone nelle montagne della Provenza – e che si struttura come una lunga galleria di paesaggi. A non funzionare è lo scarto tra l’impianto letterario dato dalla voce off e le immagini, come se i due elementi si rincorressero invano per tutto il film, senza che nessuno dei due riesca mai a giustificare l’altro.
Delusione anche per un’altra opera su cui le aspettative erano alte, Cymbeline di Michael Almereyda. Il, bravo, regista indipendente americano torna a un’operazione come quella di Hamlet 2000, attualizzare un testo shakespeariano e inserirlo in un contesto contemporaneo. Così il protagonista dell’opera del grande Bardo diventa il boss di una gang di motociclisti. L’operazione è però quella di non modificare il testo originario, creando così un vistoso scarto tra immagini e situazioni contemporanee e i dialoghi antichi e con riferimenti a un mondo arcaico. Il giochino dell’anacronismo esibito, perché di giochino si tratta, può anche essere intrigante ma si esaurisce dopo cinque minuti, e in definitiva, la ricerca dello straniamento porta ad anestetizzare la grandezza del testo di Shakespeare.
 Veniamo infine al film che non avrebbe dovuto essere in Orizzonti, e che vi è stato relegato forse solo per motivi di convenienza. Belluscone – Una storia siciliana ha comunque rappresentato uno dei casi della Mostra del Cinema di quest’anno, anche per l’inevitabile strascico di polemiche. Franco Maresco torna a parlare della Sicilia e dell’Italia attraverso un impresario del mondo dello spettacolo, Ciccio Mira, talent scout di cantanti ‘neomelodici’, così come aveva fatto, ancora in coppia con Ciprì, nel documentario Enzo, domani a Palermo! sul titolare di un’agenzia di casting cinematografico palermitana. La società dello spettacolo diventa la chiave per interpretare la realtà siciliana che è a sua volta metafora dell’Italia. I cantanti popolari dei quartieri poveri di Palermo, quelli che inviano messaggi via televisione dei famigliari ai detenuti del carcere dell’Ucciardone, i loro talent scout e quelli, più in grande, dei talent show nazionali, Berlusconi che con il suo passato di chansonier sulle navi da crociera, Renzi con la sua comparsata da Maria de Filippi. Tutto rientra nello stesso calderone dello show business. Il film, in realtà mai portato a termine da Maresco e ricostruito con un’operazione wellesiana, sul cinema e sul suo farsi, da Tatti Sanguinetti, si presterebbe a innumerevoli altre interpretazioni. I suoi orizzonti vanno ben oltre quelli della sezione Orizzonti che, pure meritatamente, l’ha ospitato.
Veniamo infine al film che non avrebbe dovuto essere in Orizzonti, e che vi è stato relegato forse solo per motivi di convenienza. Belluscone – Una storia siciliana ha comunque rappresentato uno dei casi della Mostra del Cinema di quest’anno, anche per l’inevitabile strascico di polemiche. Franco Maresco torna a parlare della Sicilia e dell’Italia attraverso un impresario del mondo dello spettacolo, Ciccio Mira, talent scout di cantanti ‘neomelodici’, così come aveva fatto, ancora in coppia con Ciprì, nel documentario Enzo, domani a Palermo! sul titolare di un’agenzia di casting cinematografico palermitana. La società dello spettacolo diventa la chiave per interpretare la realtà siciliana che è a sua volta metafora dell’Italia. I cantanti popolari dei quartieri poveri di Palermo, quelli che inviano messaggi via televisione dei famigliari ai detenuti del carcere dell’Ucciardone, i loro talent scout e quelli, più in grande, dei talent show nazionali, Berlusconi che con il suo passato di chansonier sulle navi da crociera, Renzi con la sua comparsata da Maria de Filippi. Tutto rientra nello stesso calderone dello show business. Il film, in realtà mai portato a termine da Maresco e ricostruito con un’operazione wellesiana, sul cinema e sul suo farsi, da Tatti Sanguinetti, si presterebbe a innumerevoli altre interpretazioni. I suoi orizzonti vanno ben oltre quelli della sezione Orizzonti che, pure meritatamente, l’ha ospitato.
.
 LA RISCOPERTA DEL CINEMA D’ANIMAZIONE DI LIBERIO PENSUTI NEI 50 ANNI DELLA MOSTRA DI PESARO
LA RISCOPERTA DEL CINEMA D’ANIMAZIONE DI LIBERIO PENSUTI NEI 50 ANNI DELLA MOSTRA DI PESARO
di Paolo Micalizzi
Una mostra ricca di proposte, nella linea degli ultimi anni, quella Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che nel 2014 ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni. Tre le Sezioni principali per onorare l’impegnativo traguardo: un Focus sul cinema indipendente USA con i suoi interessanti aspetti di novità e sperimentazione, tante celebrazioni per le cinquanta edizioni del Festival che hanno costituito il 28° Evento Speciale che, curato da Adriano Aprà , Bruno Torri e Vito Zagarrio, ha incentrato la sua attenzione anche su una Retrospettiva di film(15 titoli in edizione originale) scelti tra le opere più importanti presentate durante le prime dieci edizioni della Mostra pesarese, consentendo cosi di ri(vedere) film di Autori innovativi come Nemec, Skolinosky, Makavejev, Godard, Schifano, Amico, Oshima, Iosseliani, Erice e Gutierrez Alea. E poi un ricco Focus sull’animazione italiana contemporanea con la proposta di oltre cento opere in cui emergono lavori dedicati ad autori più recenti. Ma anche uno speciale sull’animazione di regime di Liberio Pensuti. E questa è stata una novità interessante sulla quale si è incentrata ,data la nostra limitata presenza alla mostra per la crisi che da alcuni anni sta investendo anche i festival non consentendo cosi agli addetti ai lavori di seguirla in maniera più completa. Le opere di Liberio Pensuti, quindi, riunite in una Retrospettiva dal titolo significativo di “Cartoon e moschetto”, curata da Sergio Toffetti e Matteo Pavesi con la collaborazione dell’Archivio Luce, dell’Archivio Nazionale Cinema Impresa –CSC e della Cineteca Italiana di Milano. Sette le opere presentate, realizzate tra il 1935 e il 1942. Opere incentrate soprattutto sulla lotta alla tubercolosi come La taverna del tibicci (1935) di Lamberto Ristori con animazione di Pensuti, Il pericolo pubblico n.1. Vita e misfatti del bacillo di koch (1938) di Liberio Pensuti e Ugo Amadoro, Crociati’900 (1939) e A colpi d’ariete (1940) di Liberio Pensuti. Ma anche opere su avvenimenti politici: L’Inghilterra contro l’Europa (1940) di R.Quattrocchi con animazione di Pensuti in cui l’Inghilterra è rappresentata come un ragno velenoso che dai tempi di Giulio Cesare tesse le sue trame per la conquista dell’Europa, ma che è tempo di combattere; Il principio della fine (1940) di Liberio Pensuti sulle vicende coloniali italiane con la denuncia delle trame inglesi;
 Dottor Churkill (1942), anch’esso realizzato da Pensuti, che rappresenta lo Statista britannico “come un orrendo Mister Hyde contro cui devono combattere il fascio littorio e la svastica nazista con un bombardamento possente sui suoi possedimenti per evitarne la demoplutocrazia”. Sono opere in cui Liberio Pensuti realizza efficaci e fantasiosi cartoni animati di propaganda politica. Ad accompagnare la Retrospettiva sull’animazione italiana contemporanea una Tavola Rotonda dal titolo “Il mouse e la matita”, coordinata da Bruno Di Marino e Giovanni Spagnoletti che sono anche gli autori di un volume( edito da Marsilio) che approfondisce momenti, scuole e tecniche, e autori le cui biografie vengono segnalate in un prezioso dizionario.
Dottor Churkill (1942), anch’esso realizzato da Pensuti, che rappresenta lo Statista britannico “come un orrendo Mister Hyde contro cui devono combattere il fascio littorio e la svastica nazista con un bombardamento possente sui suoi possedimenti per evitarne la demoplutocrazia”. Sono opere in cui Liberio Pensuti realizza efficaci e fantasiosi cartoni animati di propaganda politica. Ad accompagnare la Retrospettiva sull’animazione italiana contemporanea una Tavola Rotonda dal titolo “Il mouse e la matita”, coordinata da Bruno Di Marino e Giovanni Spagnoletti che sono anche gli autori di un volume( edito da Marsilio) che approfondisce momenti, scuole e tecniche, e autori le cui biografie vengono segnalate in un prezioso dizionario.
La “Tavola Rotonda” ha consentito l’incontro-confronto di una ventina tra autori, docenti, e critici per fare il punto sulla situazione odierna. Ed a suggerire iniziative per formare un pubblico per questo tipo di cinema, cosi come quella annunciata da Giovanni Spagnoletti ,cioè la proiezione in oltre venti sale delle Marche delle opere passate a Pesaro. Un’uscita dal ”ghetto”, come ha affermato Simone Massi, nel quale sono state confinate per molti anni. Vedere come incontrare il pubblico è uno dei problemi più importanti del cinema d’animazione italiano, messo in evidenza anche da altri autori.
 Fra le iniziative della Mostra, il Concorso Pesaro Nuovo Cinema dedicato a Lino Miccichè: ha visto laureato il film indiano Liar’s Dice della regista Geethu Mohandas che racconta il lungo viaggio, sullo sfondo delle allarmanti condizioni politiche e sociali dell’India di oggi, di una giovane donna che con la figlia di tre anni va alla ricerca del marito operaio di cui non ha notizie da cinque mesi, aiutata durante il percorso da un disertore dell’esercito. La motivazione della Giuria, presieduta dalla regista Maria De Medeiros e composta dalla sceneggiatrice Francesca Marciano, dal regista Daniele Vicari e dal critico Silvio Danese, sottolinea, fra l’altro, che il Premio le è stato attribuito “per aver filmato con straordinaria sensibilità umana e artistica una storia apparentemente semplice, comune” concludendo che “nel contesto del film il casuale incontro delle due protagoniste, la giovane madre e la sua bambina, con un uomo a sua volta solo e sbandato, costruisce l’unico appiglio che la vita offre loro. La regista, con un finale spiazzante, suggerisce l’idea che quel destino crudele è comune alla maggior parte dell’umanità, nessuno può sentirsi davvero al riparo: dentro il villaggio innevato e inanimato del finale, potremmo esserci anche noi”. Menzione Speciale al film Tierra en la lengua del colombiano Rubèn Mendoza ”per aver costruito una allegoria tragica capace di alludere sottilmente alle terribili vicende politiche e sociali della Colombia e del Cono Sur in generale”. Il film, che è imperniato su un uomo donnaiolo e violento che vicino alla morte chiama due nipoti alla sua fattoria affinché dividano le terre e lo aiutino a morire ricevendo da loro un rifiuto allo scopo di prolungarne l’agonia, ha ottenuto anche il Premio “Pesaro Cinema Giovane”. Il pubblico ha invece decretato vincitore Les ponts de Sarajevo, diretto da 13 autori fra cui gli italiani Leonardo Di Costanzo e Vincenzo Marra oltre a Jean-Luc Godard, realizzato per commemorare i cento anni dell’attentato dell’Arciduca Ferdinando nella città bosniaca che ha dato inizio alla Prima Guerra Mondiale.
Fra le iniziative della Mostra, il Concorso Pesaro Nuovo Cinema dedicato a Lino Miccichè: ha visto laureato il film indiano Liar’s Dice della regista Geethu Mohandas che racconta il lungo viaggio, sullo sfondo delle allarmanti condizioni politiche e sociali dell’India di oggi, di una giovane donna che con la figlia di tre anni va alla ricerca del marito operaio di cui non ha notizie da cinque mesi, aiutata durante il percorso da un disertore dell’esercito. La motivazione della Giuria, presieduta dalla regista Maria De Medeiros e composta dalla sceneggiatrice Francesca Marciano, dal regista Daniele Vicari e dal critico Silvio Danese, sottolinea, fra l’altro, che il Premio le è stato attribuito “per aver filmato con straordinaria sensibilità umana e artistica una storia apparentemente semplice, comune” concludendo che “nel contesto del film il casuale incontro delle due protagoniste, la giovane madre e la sua bambina, con un uomo a sua volta solo e sbandato, costruisce l’unico appiglio che la vita offre loro. La regista, con un finale spiazzante, suggerisce l’idea che quel destino crudele è comune alla maggior parte dell’umanità, nessuno può sentirsi davvero al riparo: dentro il villaggio innevato e inanimato del finale, potremmo esserci anche noi”. Menzione Speciale al film Tierra en la lengua del colombiano Rubèn Mendoza ”per aver costruito una allegoria tragica capace di alludere sottilmente alle terribili vicende politiche e sociali della Colombia e del Cono Sur in generale”. Il film, che è imperniato su un uomo donnaiolo e violento che vicino alla morte chiama due nipoti alla sua fattoria affinché dividano le terre e lo aiutino a morire ricevendo da loro un rifiuto allo scopo di prolungarne l’agonia, ha ottenuto anche il Premio “Pesaro Cinema Giovane”. Il pubblico ha invece decretato vincitore Les ponts de Sarajevo, diretto da 13 autori fra cui gli italiani Leonardo Di Costanzo e Vincenzo Marra oltre a Jean-Luc Godard, realizzato per commemorare i cento anni dell’attentato dell’Arciduca Ferdinando nella città bosniaca che ha dato inizio alla Prima Guerra Mondiale.
.
CHAPLIN ILLUMINA LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO
di Ugo Brusaporco
Non succedeva da tempo e forse oggi suona strano che un Festival cinematografico apra con un film razzista, antifemminista e capace di traviare la fonte letteraria da cui proviene. È successo a Pordenone dove Le Giornate del Cinema Muto hanno evidentemente scelto di portare la croce per la loro edizione numero 33.
Sul banco degli imputati un film When a Man Loves del 1927 che in Italia fu presentato all’epoca come Per amore di una donna, e proprio vedendolo si comprende come trovasse posto in sala in un’epoca in cui in Italia dominava l’ideologia fascista. Il film diretto da Alan Crosland su una sceneggiatura che Bess Meredyth aveva molto liberamente tratto dal capolavoro settecentesco dell’abate Prévost: “Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut”, diventa nella traduzione cinematografica un libello di cattivo gusto, non solo per l’artificiosità inverosimile del film, ma soprattutto perché all’interno gelano frasi come “Tutte le donne amano solo gioielli e ricchezza” sottintendendo, non troppo che per questo tutte sono disposte a tutto, o un’intera sequenza in cui John Barrymore – Des Grieux, qui nella sua più fiacca interpretazione, che incita i prigionieri neri di una nave a mostrarsi diversi dalle bestie stupide, animalesche, inumane che sono! Si freme di fronte alla violenza e di più inquieta la scelta della sceneggiatura di tradire il finale dell’opera che prevede gli amanti morenti nel deserto americano, trasformandola in una fuga in barca verso la costa americana fonte di un roseo futuro!
Se a questo aggiungiamo una regia pressappochista, una generale impronta di basso teatro nell’interpretazione, ci si chiede il perché del film come inaugurazione, e non può bastare il fatto della colonna sonora di Henry Hadley registra nel sistema Vitaphone.
Per capire la qualità di questo sistema bastavano i preludi operistici tra cui il quartetto finale del Rigoletto registrato nello stesso 1927 con un cast stellare dominato da un incredibile Beniamino Gigli e da un superbo Giuseppe De Luca. Il pubblico si è commosso e ha applaudito come all’opera. Molto meglio è andata la chiusura della manifestazione con City Lights di Chaplin.
“Charlie non mi era mai piaciuto, dichiarò la protagonista molti anni dopo, e io non ero mai piaciuta a lui”. Lei, la protagonista, la fioraia cieca, del capolavoro chapliniano City Lights (Luci della città, 1931) era Virginia Cherrill (1908-1988, fu sposa anche di Cary Grant), allora una ventenne della buona società di Chicago, che Chaplin aveva scelto per la sua capacità di sembrare cieca senza risultare offensiva, sgradevole. Queste sue parole non inficiano la straordinaria bellezza di un film destinato all’eternità della poesia umana.
Un film che denuncia l’impossibilità di amare incondizionatamente e insieme la straordinaria bellezza di innamorarsi. Un film che inoltre regala l’amara condizione delle classi sociali e insieme il bisogno di vivere per avere l’emozione dell’essere vivo.
Con questo film, la cui lavorazione durò 683 giorni totali, di cui 179 per le riprese e i restanti 504 per la preparazione di set e costumi, prove con gli attori, montaggio, lavoro sulla musica, Le Giornate del Cinema Muto hanno chiuso la loro edizione numero 33, segnata da tanti momenti importanti come la presentazione del Ben Hur a colori di Fred Niblo, film di grande respiro spettacolare con la magia della presenza di un Gesù che per contratto non doveva essere visto e che Niblo magicamente riesce a far immaginare al pubblico dalla nascita alla Passione, emozionando. O come la proiezione del memorabile I Nibelunghi di Fritz Lang, film ingiustamente accusato di favorire l’ideologia nazista, che in realtà lega la leggenda alla piena cultura cinematografica, o l’incredibile spezzone di The Eternal City un drammone fascistizzante di George Fitzmaurice che ha come protagonista lo stesso Benito Mussolini celebrato da Hollywood come araldo contro il comunismo. Curiosamente il film non fu mai presentato in Italia, ma fu, all’epoca un successo tra gli immigrati italiani negli USA, prima di scomparire senza lasciare altri segni che questo curioso lacerto.
Nell’ultimo giorno si è visto anche un film in Technicolor, a cui è stata qui dedicata una bella retrospettiva, che ha rivelato anche una ironica Clara Bow con i capelli rossi, si tratta di un film tratto dall’Isola misteriosa di Verne The Mysterious Island firmato nel 1929 da Lucien Hubbard.
.
.
.
.
.
Tra le cose da non dimenticare capolavori del grande maestro Yakov Protazanov a cominciare da Gornichnaya Dzhzenni (La cameriera Jenny) che il regista aveva girato nel 1918, e che ha ha ridato il gusto del cinema russo al pubblico di Pordenone. Si tratta di una commedia leggera in cui emerge la bravura di un’attrice indimenticata come Olga Gzovskaya nei panni di una giovane contessa che per disgrazie familiari si ritrova a far la cameriera nella nobile famiglia dell’uomo di cui si innamora. La regia è di uno splendore senza tempo. Questo è il Cinema delle Giornate! E di lui si è visto anche la corrosiva commedia La festa di Sant’Iorgen, un film che in Russia è diventato il più grande successo economico del periodo muto tanto da essere poi reso sonoro. Un attacco alla fallacità delle religioni, come quella cattolica, che legano al denaro e alla mercificazione dei loro detti il loro esistere. Girato e montato come “Dio comanda” il film ha ancora oggi il peso di una satira senza tempo. L’appuntamento ora è dal 3 al 10 ottobre del prossimo anno per Le Giornate numero 34. Un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema.
.
VISTI DA LONTANO
di Andreina Sirena
El estudiante (Lo studente)
 Regia: Santiago Mitre
Regia: Santiago Mitre
Argentina 2011
Roque Espinosa è una sorta di giovane olandese volante in cerca di un’identità della quale sembra fatalmente sprovvisto: rimbalza da una facoltà all’altra – si è appena iscritto a Scienze politiche, dopo aver provato Arte ed Economia – e la sua vita sentimentale sembra non elevarsi più in là di facili, insignificanti avventure. Frequenta un’università che è un vero e proprio microcosmo pullulante di gruppi studenteschi, associazioni, partitini, in una ridda infinita di sigle di fazioni in lotta tra loro. La vita politica della facoltà non lo interessa particolarmente, e nei dibattiti in aula non riesce ad intervenire con affermazioni più brillanti e originali dell’abusatissimo, inflazionato “i politici sono tutti uguali”. Quando però si invaghisce di Paula, bella docente a capo di uno dei suddetti movimenti studenteschi, si butta a capofitto nella lotta politica, scoprendo trattarsi effettivamente della sua vocazione. Il critico argentino Leonardo d’Esposito lo ha definito come “un thriller politico pieno di suspense, sgambetti, di piccole vittorie, di tradimenti, di sesso, di manipolazioni. Una spietata radiografía del potere che utilizza come scenario l’università. Un ritratto dell’Università di Buenos Aires (…) che tratta in modo trasparente della miseria e della grandezza della nostra vita politica e, al di là di questo, della natura e della gestione del potere, un tema che va ben oltre qualsiasi contingenza locale”. Benché il film di Mitre si svolga interamente tra i corridoi e le aule della Facoltà di Scienze politiche, il suo non vuole essere un mero ritratto della militanza universitaria: al regista interessa osservare, all’interno del luogo prescelto, quei processi che sono costitutivi, ricorrenti e tipici di ogni livello della politica: alleanze, trasformismi, tradimenti. Non si tratta di un film ‘militante’: Mitre privilegia l’osservazione, una distaccata disanima dei meccanismi del potere, il suo sguardo ha un taglio quasi documentaristico. La metamorfosi del protagonista da studente insignificante a leader politico, viene tratteggiata secondo il topos narrativo del romanzo di formazione: l’eroe viene a definirsi, a maturare, a costruirsi in seno alla sua esperienza politica in università. Una sorta di “buon selvaggio”, essenzialmente onesto e sincero. La sua iniziazione alle miserie del potere non riesce a corrompere la sua buona indole ma – nel passaggio dall’ignoranza alla conoscenza – la riconquista e la conferma ad un livello di consapevolezza più alto. L’esperienza e la conoscenza maturate lo mettono in condizione di discernere e di dire no all’ennesimo tentativo di strumentalizzazione da parte dello stesso leader che lo aveva tradito. Il rifiuto di Roque, se ne sancisce l’integrità morale, segna anche la sua sconfitta politica. L’eroe di questo Bildungsroman non è più l’eroe romantico, che guida il popolo alla rivoluzione. Non è un martire della lotta politica. Sconfitto nella militanza, Roque ha trionfato in amore, conquistando la donna ambita anche dal leader del movimento che – probabilmente anche per questioni squisitamente private di gelosia – lo tradirà. Roque pertanto è “un tipico eroe postmoderno che, deluso dalla politica, si ritira nella vita borghese” (Luciana Caresani) e nella felicità domestica. Benché il succitato Leonardo d’Esposito lo definisca “miglior film argentino dell’anno” connotandolo come un film di portata storica, El estudiante è un film di una sbalorditiva povertà, sia nella narrazione che nei contenuti. La vantata disamina dei meccanismi del potere è una riproposizione trita, prevedibile, non meno ovvia di quel “i politici sono tutti uguali” affermato dal protagonista prima della sua stessa trasformazione in uomo politico. Ben lontano dal glamour americano del coevo Le idi di marzo (George Clooney, 2011), ne condivide il semplice schema contrabbandato per chissà quali rivelazioni illuminanti o svelamenti di giochi occulti. Gli unici momenti interessanti sono i frammenti di dibattiti che ascoltiamo nelle aule – momenti quindi del tutto marginali e inessenziali per quanto riguarda l’impianto narrativo del film – come quello su limiti e rischi della democrazia cui assistiamo all’inizio. La ‘volontà generale’, essenza stessa della democrazia e diretta antitesi dell’arbitrio totalitario del singolo, di regola – al contrario – “sceglie proprio i dittatori”, viene detto da uno degli studenti. La sovranità non può che appartenere al popolo, ma cosa avviene quando è il popolo stesso a svendere la propria sovranità al dittatore di turno? “Così mandi al potere un qualunque scemo”, come ancora sentiamo da uno studente. Un altro dibattito molto interessante riguarda l’essenza della guerra: se essa sia un dato del tutto naturale, inerente all’uomo, o se non sia anch’essa una sovrastruttura – secondo l’ortodossia marxista – generata da dinamiche di sfruttamento. A parte questi sporadici momenti in cui l’attenzione si ridesta, il film prosegue per due ore di tedioso dilettantismo, riscattato in parte soltanto dalla buona prova degli attori.