Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 SAGGI
- 3 INTERVISTA
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 5.1 UNA MOSTRA DI ALTO LIVELLO CON UN “LEONE D’ORO” CONDIVISO di Paolo Micalizzi
- 5.2 IL CINEMA DEL PASSATO E LA SUA ATTUALITA’: VENEZIA CLASSICI di Vittorio Boarini
- 5.3 I CORTI DI “CORTINAMETRAGGIO” IN TRASFERTA IN VERSILIA di Paolo Micalizzi
- 5.4 SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2017: NUMERI E CONTENUTI di Francesco Saverio Marzaduri
- 6 OCCHIO CRITICO a cura di Marco Incerti Zambelli
- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 8 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
- 9 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 10 AUTORI
- 11 CREDITS
ABSTRACT
SCERBANENCO SULLO SCHERMO di Mario Giunco
Il cinema e la tv hanno utilizzato in piccola parte la cospicua produzione narrativa di Giorgio Scerbanenco (1911 – 1969). Il suo nome è legato a quattro romanzi, aventi per protagonista Duca Lamberti, di cui tre (“I ragazzi del massacro”, “I milanesi ammazzano al sabato”, “Venere privata”) sono stati portati sullo schermo, con alterni risultati, dai registi Fernando Di Leo, Duccio Tessari e Yves Boisset. In essi compare la figura di un detective anomalo (Duca Lamberti), la cui complessità psicologica è colta solo in superficie. I film, tratti dai racconti, cedono ancora di più ad effetti di dozzina e indulgono a scene di violenza e di sesso, lontane dall’originale letterario.
SENZA PARADISO – MATERIALI PER UNA RIDEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRA CINEMA E LAVORO di Roberto Lasagna
Lo schermo del lavoro tra psicologia, storia del cinema e inquietudini collettive
ALLA RICERCA DELL’INNESTO PERDUTO: “BLADE RUNNER 2049” di Francesco Saverio Marzaduri
2049 Incaricato di recuperare un vecchio modello di replicante, l’ufficiale K, un “blade runner” appartenente alla polizia di Los Angeles, riporta in luce un segreto a lungo sepolto che ha il potenziale di far precipitare nel caos ciò ch’è rimasto della società. La scoperta lo porta a dover scovare Rick Deckard, un ex “blade runner” scomparso da trent’anni.
SULLE SPALLE DEL “GIGANTE”: CINEMA 3D E NUOVE FRONTIERE di Giorgia Pizzirani
Un gigante invisibile ma presente. Una famiglia barricata in una cantina in un paese non precisato degli Stati Uniti, in un’epoca che può essere molto vicina. Una storia che mamma e papà raccontano alla loro piccola per spiegare la situazione in cui si trovano, oscillando tra il presente disperato di una guerra e l’immaginario di un mondo dove il male è magicamente schermato da semplici trovate quotidiane. Cortometraggio diretto da Milica Zec e Winslow Porter III e presentato al Sundance Film Festival, “Giant” (6′) è una chicca del cinema 3D che tiene lo spettatore incollato alla sedia grazie all’originale connubio tra tecnologia e trama potente.
FILMMAKER ALLA RIBALTA: NICOLÒ ZACCARINI di Paolo Micalizzi
Ritratto di Nicolò Zaccarini, insegnante che dalla Sicilia si è trasferito a Savona dove ha realizzato insieme ai suoi studenti oltre venticinque cortometraggi. Un filmmaker attivo anche come Presidente del Circolo Savonese Cineamatori FEDIC, con cortometraggi ed iniziative culturali.
PREMIO CINECLUB FEDIC CAGLIARI ALLA QUINTA EDIZIONE DEL BABEL FILMFESTIVAL di Pio Bruno
Resoconto del Babel Film Festival 2017 dove il Cineclub FEDIC Cagliari ha attribuito un premio a “Spoon River a Lampedusa” di Rosario Santella.
UNA MOSTRA DI ALTO LIVELLO CON UN “LEONE D’ORO” CONDIVISO di Paolo Micalizzi
Una 74. Mostra di Venezia con un “Leone d’Oro” che ha convinto la critica e con tanti premi collaterali, espressione di appassionati di cinema e cinefili con scelte ben calibrate, che costituiscono un valore aggiunto alla manifestazione internazionale tra le più importanti del mondo. Presenza della FEDIC, da ventiquattro anni con un Premio al cinema italiano ed un Forum su “Il futuro del corto d’autore”.
IL CINEMA DEL PASSATO E LA SUA ATTUALITÀ: VENEZIA CLASSICI di Vittorio Boarini
Un excursus nella Venezia Classici, la sezione della Mostra Veneziana dedicata ai film restaurati e ai documentari sul cinema, per cogliere l’attualità delle opere del passato e sottolineare l’importanza decisiva dell’attività di restauro. Passando in rassegna i venti film presenti nella sezione, si è evidenziato, infatti, il valore storico-filologico delle complesse operazioni che li hanno riportati a nuova vita.
I CORTI DI “CORTINAMETRAGGIO” IN TRASFERTA IN VERSILIA di Paolo Micalizzi
Una nuova idea della vulcanica Maddalena Mayneri per valorizzare i nuovi talenti. Omaggio al regista Paolo Genovese
SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2017: NUMERI E CONTENUTI di Francesco Saverio Marzaduri
Panoramica sulla XVI edizione del Sedicicorto International Film Festival, tra appuntamenti e molteplici attività.
IL GRANDE ALTROVE di Marco Incerti Zambelli
Abstract: “Jim & Andy” e “Nico ’88”, biopics diversi per struttura e finalità, indagano sulle carriere e sulle vite di personaggi dello spettacolo accomunati da un’ambigua enigmaticità.
NON (SOLO) NEOREALISMO: “A CIAMBRA” E QUELLA SPORCA ULTIMA META: “DUNKIRK” di Francesco Saverio Marzaduri
Pio vive nella piccola comunità rom denominata “A Ciambra”, in Calabria. Raggiunti i quattordici anni, beve e fuma, ma è tra i pochissimi a entrare in relazione con tutte le realtà presenti nell’area: italiani, africani o rom come lui. Il ragazzino segue e ammira il fratello maggiore Cosimo, dal quale apprende quanto serve a sopravvivere per strada. Finché Cosimo e il padre non vengono arrestati, e tocca a Pio il difficile ruolo di precoce capofamiglia e il compito di provvedere al sostentamento del numeroso nucleo.
Una ricostruzione dei fatti della celebre evacuazione di Dunkirk, quando, agli inizi della Seconda guerra mondiale, decine di migliaia di uomini delle truppe britanniche e delle forze alleate si ritrovarono circondati dalle forze nemiche. Intrappolati sulla spiaggia, con le spalle al mare e i tedeschi che avanzavano, i soldati dovettero affrontare una situazione caotica ed estremamente difficile. L’operazione di salvataggio che fu messa in atto passò alla storia col nome altisonante di “miracolo di Dunkirk”.
HAPPY END e MONDO ZÀ di Tullio Masoni
Happy end
Lo spaccato di una famiglia “larga”, dominata dall’ipocrisia. La rivolta solitaria e sterile di un’adolescente. Un quadro sociale segnato dal cinismo speculativo e da un’avvelenata rassegnazione individuale.
Mondo Zà
Un documentario su Zavattini e, soprattutto, sul suo mondo nativo: la “Bassa” reggiana e mantovana: terra di naif, di immigrazione, e resistenza al degrado umano e ambientale.
“AGADAH” di Paolo Vecchi
Di “Manoscritto trovato a Saragozza” di Jan Potocki esiste una prima, splendida versione cinematografica firmata nel 1964 da Wojciech Jerzy Has, uno dei grandi del cinema polacco. Rondalli ambienta la sua, che intitola “Agadah”, nelle Murge, nella Bergamasca e nel Lazio, veste i suoi personaggi con gli sfarzosi costumi del repertorio Tirelli e gestisce in maniera disinvolta un racconto complesso fino alla frammentazione, illustrandone con eleganza l’onirica circolarità.
L’AMORE CORRE SULLA STRADA – “I’M IN LOVE WITH MY CAR” di Marcello Cella
“I’m in LOVE with MY CAR” dei giovani filmaker emiliani Marco Mellara e Alessandro Rossi racconta la storia dell’automobile, di come ha cambiato la nostra vita, le nostre città e i nostri cinque sensi, dandoci l’illusione di muoverci liberamente nel mondo da cui in realtà ci ha separato, e creando innumerevoli problemi sociali e sanitari.
I KENNEDY (la serie) Luisa Ceretto
Ideata da Joel Surnow, sceneggiatore che iniziò la sua carriera con Miami Vice, la serie dei Kennedy si cimenta in un’impresa ardua: portare sul piccolo schermo le vicende di una delle famiglie più importanti d’America e non solo…
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
Segnalazioni-recensioni di libri, recenti, dedicati al Documentario, a Cinecittà, alla sceneggiatura di “Ovosodo” e a Giuseppe Lanci.
SAGGI
SCERBANENCO SULLO SCHERMO
di Mario Giunco
“Con la massima stima di Scerbanenco, ogni volta che ho fatto un suo lavoro, il 90% è mio, il 10% suo”. Con queste parole il regista Fernando Di Leo dichiarava la quasi totale autonomia, rispetto a una delle sue fonti letterarie. Non è un caso unico. Tutti i registi che si sono accostati al romanziere, lo hanno “piegato” alle loro esigenze, modificando titoli, personaggi, avvenimenti , le stesse strutture della narrazione.
Non è agevole trasferire sullo schermo l’opera di Giorgio Scerbanenco (Kiev, 1911 – Milano, 1969). In pochi ci hanno provato, con risultati non certo convincenti. Lo si può invece “saccheggiare”, come spesso è accaduto. Il suo destino non è diverso da quello di Carlo Emilio Gadda. Il romanzo “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”, più che al cinema (“Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi, 1959) o in televisione (miniserie di Piero Schivazappa, 1983, con Flavio Bucci), è stato forse maggiormente più apprezzato a teatro, nell’allestimento di Luca Ronconi (1996), che ha lasciato leggere il testo direttamente agli attori, come se raccontassero le parti in terza persona. Scerbanenco renderebbe più a teatro? Forse solo così – oltre che sulla pagina, naturalmente – sarebbe possibile cogliere la ricchezza e l’originalità della sua lingua, letteraria e parlata a un tempo, la lunghezza “schubertiana” del suo periodare, che a volte sembra lottare e aggrovigliarsi su sé stesso, a volte toccare una epigrammatica concisione.
Nella sua copiosa produzione , Scerbanenco ha esplorato quasi tutti i generi e i sottogeneri letterari, compresi il western, il fantastico, l’umoristico, il sentimentale. E’ autore di almeno millequattrocento fra romanzi e racconti (secondo altri tremila, con più di trenta pseudonimi ) apparsi in settimanali, quotidiani, riviste di ogni genere, anche di cronaca rosa. Si racconta che la sua macchina da scrivere lo seguisse dovunque, perfino sotto l’ombrellone, quando era in vacanza a Lignano Sabbiadoro. Nell’autobiografia, pubblicata in appendice al romanzo Venere privata (1966), ricorda il suo esordio letterario: “Grazie alla raccomandazione di un amico, accettarono una mia novella alla Rizzoli. Zavattini che la pubblicava su ‘Piccola’ volle conoscermi. (…) Dopo qualche tempo fui assunto in redazione. Ero in un giornale, gli inizi erano finiti. Ma io, anche se allora non me ne rendevo conto, ero già abbrutito. Forse guastato dentro per sempre . Ero arrivato fin lì dopo troppa, troppa miseria. Veramente troppa. La miseria avvilisce, e chi scrive, invece, non deve aver timori, e deve vedere in grande. Ci vollero anni perché mi liberassi di quel complesso di inferiorità, e non me ne sono mai liberato del tutto. Per quanto in redazione mi seguissero con simpatia, m’incoraggiassero, non mi trovavo con loro. (…) Ero continuamente schiacciato da queste cose, e quello che era più triste, non me ne rendevo conto. Ma lo rivelavano le mie novelle, i miei romanzi, dove nessun protagonista era un ricco o un aristocratico, dove nessuno era superbo o grandioso nel vivere. Tutti i miei personaggi erano gente modesta, spesso anche umile, che pensava solo a vivere, oscuramente, e oscuramente soffriva o era felice”.
Insieme a questa concezione della vita, che non lo abbandonerà mai, si evidenzia nella sua narrativa un “background” giallo o noir (sotto forma di riconoscimento, rivelazione, sorpresa, scoperta spiazzante, colpo di scena) risalente all’antico “feuilleton”, in cui l’atroce procedeva di pari passo con il sublime.
Nel 1940 Scerbanenco esordisce ne “I libri gialli” di Mondadori (collana nata nel 1929, con una originalità esibita già nella copertina, essendo per secoli il giallo il colore della speranza) con il romanzo “Sei giorni di preavviso”, cui fanno seguito, fino al 1942 – anno di chiusura del periodico -, altri quattro titoli. Il protagonista è Arthur Jelling, archivista della Polizia di Boston, che non esce quasi mai dal suo ufficio (del resto l’autore ben poco conosceva della città americana, che rappresentava genericamente come piena di industrie, frenetica e malavitosa). ” Arthur Jelling era un uomo che aveva quarant’anni, aveva studiato medicina fino a ventiquattro anni, e altro non aveva fatto di più importante, se non scoprire la trama segreta di alcuni delitti famosi. Ma nella sua vita non era mai entrato il romanzo, se non di scorcio. Scoperto l’autore del celebre delitto, o archiviata la pratica dell’ultimo processo, egli tornava a casa, tra sua moglie e suo figlio, leggeva il giornale mangiando, leggeva un libro a letto, e la mattina era in ufficio, all’Archivio Criminale, come un qualunque impiegato, come il più oscuro degli impiegati, a catalogare interrogatori ed elenchi di referti, o stesure di alibi” (“Bambola cieca”, 1941). I modelli non sono gli investigatori d’oltreoceano (Philo Vance , Nero Wolfe, Ellery Queen) o il commissario italiano Carlo De Vincenzi, creato da Augusto De Angelis (1888 – 1944), sconsolato tutore della legge, lettore di Freud, dal carattere pessimista e malinconico.
Finita la guerra lo scrittore ritorna a Milano dalla Svizzera, dove si era rifugiato e riprende la sua attività instancabile, “lavorando quattordici, sedici ore al giorno, scrivendo quattro, cinque romanzi e centinaia di racconti all’anno”, che compaiono su quotidiani e riviste varie, da “Novella 2000” a “Annabella”, da “Stampa Sera” a “Sogno”, nella cui redazione lavorava anche Dario Argento (particolare non secondario).
Nasce il “mito” Scerbanenco – “Faccio fatica a scrivere solo quattro racconti su un tema, perché me ne vengono in mente dieci, venti, trenta, e devo eliminarli”. Dopo la morte prematura dell’autore, si pubblicano diverse antologie, edite da Garzanti (“Il Centodelitti”, “Racconti neri”), Frassinelli (“I cinquecento delitti” e “Millestorie”), Sellerio (“Nebbia sul Naviglio e altri racconti gialli e neri”). Ai testi contenuti in esse, oltre a quattro romanzi aventi per protagonista Duca Lamberti, si deve la fama dell’autore, considerato a ragione il capostipite e uno dei più ragguardevoli rappresentanti del “noir” italiano.
 Nel 1966 Scerbanenco pubblica presso Garzanti “Venere privata”. Seguono, sempre presso lo stesso editore, “Traditori di tutti” (1966) – vincitore, nel 1968, dell’importante “Grand prix de la littérature policière” – “I ragazzi del massacro” (1968) e “I milanesi ammazzano al sabato” (1969). Il protagonista della quadrilogia è Duca Lamberti, medico – come Arthur Jelling – radiato dall’Ordine e messo in carcere per aver praticato l’eutanasia su una paziente. Oppresso dai sensi di colpa (si ritiene responsabile anche della morte di crepacuore del padre che l’aveva fatto studiare con molti sacrifici), decide di collaborare con la Polizia ufficiale, il questore Carrua, amico di famiglia e Livia Ussaro, una donna, che ha un ruolo importante fin dalla sua prima avventura (“Venere privata”) e che nei film diventerà assistente sociale e moglie. Lamberti è un personaggio positivo, animato da senso di giustizia, ma in bilico fra illuminismo e pessimismo. Non ha paragoni con i detective della tradizione – e con lo stesso Maigret – ma apre la strada ai suoi “successori”, specie quelli tormentati, malaticci, introversi, combattuti da scrupoli morali, di moda oggi. Trasferito sullo schermo, perde ogni connotazione particolare. Ne “Il caso ‘Venere privata’” di Yves Boisset manca ogni riferimento alla vicenda privata di Duca e si modifica perfino l’identità dell’assassino. Le figure dei comprimari (Livia, diventata assistente sociale, il questore Carrua e l’agente Mascaranti) sbiadiscono.
Nel 1966 Scerbanenco pubblica presso Garzanti “Venere privata”. Seguono, sempre presso lo stesso editore, “Traditori di tutti” (1966) – vincitore, nel 1968, dell’importante “Grand prix de la littérature policière” – “I ragazzi del massacro” (1968) e “I milanesi ammazzano al sabato” (1969). Il protagonista della quadrilogia è Duca Lamberti, medico – come Arthur Jelling – radiato dall’Ordine e messo in carcere per aver praticato l’eutanasia su una paziente. Oppresso dai sensi di colpa (si ritiene responsabile anche della morte di crepacuore del padre che l’aveva fatto studiare con molti sacrifici), decide di collaborare con la Polizia ufficiale, il questore Carrua, amico di famiglia e Livia Ussaro, una donna, che ha un ruolo importante fin dalla sua prima avventura (“Venere privata”) e che nei film diventerà assistente sociale e moglie. Lamberti è un personaggio positivo, animato da senso di giustizia, ma in bilico fra illuminismo e pessimismo. Non ha paragoni con i detective della tradizione – e con lo stesso Maigret – ma apre la strada ai suoi “successori”, specie quelli tormentati, malaticci, introversi, combattuti da scrupoli morali, di moda oggi. Trasferito sullo schermo, perde ogni connotazione particolare. Ne “Il caso ‘Venere privata’” di Yves Boisset manca ogni riferimento alla vicenda privata di Duca e si modifica perfino l’identità dell’assassino. Le figure dei comprimari (Livia, diventata assistente sociale, il questore Carrua e l’agente Mascaranti) sbiadiscono.
Tre romanzi della quadrilogia, “Venere privata” (1966), “I ragazzi del massacro” (1968), “I milanesi ammazzano al sabato” (1969) – con l’esclusione del premiato e avvincente “Traditori di tutti” (1966) – gli altri due romanzi “Appuntamento a Trieste” (1953), “Al mare con la ragazza” (1965) e una decina di racconti assemblati sono il suo tributo all’ascesa e al declino del genere “poliziottesco”, cinematografico e televisivo (Sta a sé il romanzo “La ragazza dell’addio” (1956), che è una storia d’amore). Un tributo non propriamente fecondo, rimasto piuttosto in superficie, nonostante registi di culto (Fernando Di Leo, Duccio Tessari, Carlos Saura, Lamberto Bava), attori di richiamo ( Pier Paolo Capponi, Bruno Cremer, Mario Adorf, Frank Wolff, Raf Vallone, Henry Silva, Woody Strode, Adolfo Celi, Cyril Cusak, Antonio Banderas, Tomàs Miliàn, Diego Abatantuono, George Hilton, Ray Lovelock, Jacques Sernas, Tony Musante, Gianni Cavina, William Berger, Edmund Purdom, Giancarlo Dettori, Gene Gnocchi, Sylva Coscina, Femi Benussi, Martine Brochard, Eleonora Giorgi, Francesca Neri, Beryl Cunningham, Raffaella Carrà, Agostina Belli, Carol André, Daniela Poggi, Maddalena Crippa, Laura Troschel), colonne sonore a cura di Gianni Ferrio (Mina canta nei titoli di testa), Luis Bacalov, Armando Trovajoli, Gianfranco Plenizio, Enrico Pierannunzi).
Non sfugge la modestia complessiva di simili operazioni, che, specie dopo la morte dello scrittore – riesce a vedere solo “I ragazzi del massacro” di Di Leo, che lo aveva interpellato per la sceneggiatura – si riducono a mero pretesto e rappresentano spesso truculente storie di malavita. Scompaiono anche quegli aspetti di umana compassione o di sofferta moralità , che caratterizzavano la figura di Duca Lamberti. Secondo Di Leo, il “poliziottesco” si era affermato “con il bisogno di violenza del pubblico, come succedeva nelle partite di calcio, era un modo per scaricarsi”. Perciò i suoi personaggi – sosteneva il regista – risultavano più veri rispetto a quelli di Scerbanenco.
Filmografia:
1969 – I RAGAZZI DEL MASSACRO di Fernando Di Leo, tratto dal romanzo omonimo di G.S. (1968).
Sceneggiatura: Fernando Di Leo, Nino Latino, Andrea Maggiore. Fotografia: Franco Villa. Montaggio: Amedeo Giomini. Musiche: Silvano Spadaccino. Cast: Pier Paolo Capponi (Duca Lamberti), Susan Scott (Livia Ussaro), Renato Lupi (Mascaranti), Enzo Liberti (Carrua), Marzio Margine, Giuliano Manetti, Danika La Loggia, Jean Rougeul, Ettore Geri, Michel Bardinet.
In una scuola serale milanese alcuni ragazzi tra i tredici e i vent’anni, piccoli delinquenti di strada, seviziano e uccidono una maestra, senza motivo apparente. Duca Lamberti, incaricato dell’indagine, porterà allo scoperto un mondo di emarginazione e di miseria.
Rispetto al romanzo vi sono diverse differenze. Di Leo sottopose la sceneggiatura a Scerbanenco e cercò di minimizzare i contrasti con lui, che attribuiva a scelte estetiche e formali, non sostanziali. La scena della violenza alla maestra, girata con la macchina a mano, è di fortissimo impatto. Scerbanenco mostra invece una sorta di compassione e di comprensione per i ragazzi.
Il film, considerato uno dei meno riusciti di Di Leo, dopo un iniziale successo di pubblico sparisce dalle sale.
1970 – LA MORTE RISALE A IERI SERA di Duccio Tessari, tratto dal romanzo “I milanesi ammazzano al sabato” di G. S. (1969).
Aiuto regista: Lorella De Luca. Sceneggiatura: Artur Brauner, Biagio Proietti, Duccio Tessari. Fotografia: Lamberto Caimi. Musiche: Gianni Ferrio. Le canzoni “I giorni che ci appartengono” e “Incompatibile” sono cantate da Mina. Cast: Frank Wolff (commissario Duca Lamberti), Raf Vallone (Amanzio Berzaghi), Gill Bray (Donatella), Gabriele Tinti (Mascaranti), Eva Renzi (Livia, moglie di Duca Lamberti), Gigi Rizzi, Beryl Cunningham, Checco Rissone.
Donatella è una ragazza alta quasi due metri, figlia del ragioniere Amanzio Berzaghi, tenuta sotto stretta sorveglianza dal padre, perché è minorata psichica e si concede facilmente agli uomini. La ragazza sparisce di casa, rapita da malviventi, per essere avviata alla prostituzione. Berzaghi si rivolge al commissario Lamberti, che promette di aiutarlo. Il tempo passa e, non avendo più notizie, il padre comincia a indagare per conto suo. Anticipando la polizia, si fa giustizia da solo un sabato, perché in quella giornata i milanesi non lavorano.
Il film – con notevoli libertà rispetto al romanzo – si apprezza per la prova di Raf Vallone.
1970 – IL CASO “VENERE PRIVATA” di Yves Boisset, tratto dal romanzo “Venere privata” di G.S. (1966).
Sceneggiatura: Antoine Blondin, Francis Cosne, Yves Boisset. Fotografia: Jean-Marc Ripert. Montaggio: Paul Cayatte. Musica: Michel Magne. Cast: Bruno Cremer (Duca Lamberti), Marianne Comtell (Livia Ussaro), Claudio Gora (Carrua), Renaud Verley (Davide Auseri), Raffaella Carrà (Alberta Radelli), Mario Adorf (fotografo), Marina Berti (sorella di Alberta), Vanna Brosio, Agostina Belli.
Duca Lamberti cerca di assistere psicologicamente il giovane Davide Auseri, caduto in depressione, perché sconvolto per la morte di una sua amica occasionale, che, dopo una breve avventura, aveva abbandonato per strada. Davide non crede al suicidio della donna e si rifugia nell’alcol. Duca scopre che la ragazza aveva posato nuda per un misterioso fotografo, che si rivela essere un sadico criminale. Con l’aiuto di Livia, che si offre come esca, riesce a risolvere il caso.
1972 – MILANO CALIBRO 9 di Fernando Di Leo, tratto dai racconti “Stazione centrale ammazzare subito”, “Vietato essere felici”, “La vendetta è il miglior perdono” di G.S. Il titolo del film è preso dalla omonima antologia (1969).
Soggetto: Fernando Di Leo, Giorgio Scerbanenco. Sceneggiatura: Fernando Di Leo. Fotografia: Franco Villa. Montaggio: Amedeo Giomini. Musiche: Luis Enriquez Bacalov, Osanna. Cast: Gastone Moschin , Barbara Bouchet, Mario Adorf, Frank Wolff, Luigi Pistilli, Ivo Garrani, Philippe Leroy, Lionel Stander.
Accusato di tradimento, un malavitoso (Gastone Moschin) è costretto a uccidere. Un ragazzo si mette dalla sua parte e lo vendica, quando la sua donna lo tradisce e lo fa uccidere dal nuovo amante.
E’ considerato uno dei film migliori di Di Leo. Ottima direzione degli attori.
1972 – LA MALA ORDINA di Fernando Di Leo, tratto dal racconto “Milan by calibro 9” di G.S.
Soggetto: Fernando Di Leo. Sceneggiatura: Fernando Di Leo, Augusto Finocchi, Ingo Hermes. Fotografia: Franco Villa. Montaggio: Amedeo Giomini. Musiche: Armando Trovajoli. Cast: Mario Adorf, Henry Silva, Woody Strode, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Franco Fabrizi, Sylva Koscina, Francesca Romana Coluzzi, Femi Benussi, Peter Berling, Cyril Cusack, Gianni Macchia, Renato Zero.
Un piccolo sfruttatore di prostitute è accusato ingiustamente di aver sottratto a un trafficante di droga i suoi proventi. Due killer americani, giunti a Milano, si mettono sulle sue tracce e gli uccidono moglie e figlia. L’uomo si vendica sterminando tutti i componenti della banda. Famoso il finale in un cimitero di auto.
1975 – L’ASSASSINO E’ COSTRETTO A UCCIDERE ANCORA di Luigi Cozzi, tratto dal romanzo “Al mare con la ragazza” di G.S. (1965). Il film, realizzato nel 1973 con il titolo originale “Il ragno”, fu bocciato dalla censura per la violenza delle scene. Approdò sugli schermi due anni dopo, con l’attuale titolo.
Soggetto: Luigi Cozzi, Daniele Del Giudice. Sceneggiatura: Luigi Cozzi, Daniele Del Giudice. Fotografia: Riccardo Pallottini. Montaggio: Alberto Moro. Musiche: Nando De Luca. Cast: George Hilton, Antoine Saint-John, Femi Benussi, Cristina Galbò, Eduardo Fajardo, Tere Velàzques.
Un architetto indebitato e adultero decide di far uccidere da un sicario la ricca moglie, prefabbricandosi un alibi. Due giovani fidanzati si mettono inconsapevolmente di mezzo e l’assassino – che si vede in faccia fin dal primo fotogramma – sarà costretto a uccidere ancora.
1976 – LIBERI ARMATI PERICOLOSI di Romolo Guerrieri, tratto dal racconto “Bravi ragazzi bang bang” di G.S.
Soggetto: Fernando Di Leo, Giorgio Scerbanenco. Sceneggiatura: Fernando Di Leo, Nico Ducci. Fotografia: Erico Menczer. Montaggio: Antonio Siciliano. Musiche: Gianfranco Plenizio, Enrico Pierannunzi. Cast: Tomàs Miliàn, Max Delys, Eleonora Giorgi, Stefano Patrizi, Benjamin Lev, Diego Abatantuono (esordiente).
Tre amici, figli della buona borghesia milanese, per vincere la noia si danno a una serie di bravate sempre più pericolose, fino all’omicidio. La polizia li individua e li insegue per la campagna lombarda.
1979 – QUATTRO DELITTI. Sono quattro episodi della serie televisiva “Gli sceneggiati RAI, Giallo & Mistero”, tratti da “Il Centodelitti” di G.S.
Primo episodio: PER DUE TESTONI. Regia: Alberto Sironi (regista delle prime tre serie di Montalbano). Cast: Roberto Cenci, Renato Scarpa, Fiorenza Marchegiani, Alberto Cangemi.
Secondo episodio: PROFESSIONE FARABUTTO. Regia: Alberto Sironi. Cast: Bruno Pagni, Daniela Piperno, Valeria Falcinelli, Gianfranco Mauri, Umberto Verdoni, Roberto Paoletti, Massimo Sacilotto, Maurizio Donadoni.
Terzo episodio: WINCHESTER M2. Regia: Gian Pietro Calasso. Cast: Alfredo Pea, Evelina Vermigli Gori, Roberto Posse, Marilda Donà, Roger Browne, Zora Velkova, Tino Cimarosa, Mario Feliciani, Biagio Pelligra.
Quarto episodio: QUASI DUE METRI. Regia: Vittorio Melloni. Cast: Franco De Piccoli, Antonella Munari, Marisa Mantovani, Natalia Sattolo, Massimo Sacilotto, Pietro Pieraldini. Musiche: Giancarlo Chiaramello.
1984 – LA RAGAZZA DELL’ADDIO di Daniele D’Anza, tratto dal romanzo omonimo di G.S. (1956).
Sceneggiato RAI in quattro puntate, ultimo lavoro di Daniele D’Anza, che sposta l’ambientazione da Pavia e Milano a Torino e dalla Polinesia alla Germania. E’ una toccante storia d’amore, interpretata da Ray Lovelock, Carol André, Daniela Poggi, Giancarlo Dettori, Maddalena Crippa.
1989 – L’UOMO CHE NON VOLEVA MORIRE di Lamberto Bava, tratto dal racconto omonimo di G.S., contenuto ne “Il Centodelitti”. Come tutti i film della serie tv “Alta tensione” fu bloccato dalla censura per le scene di violenza. Inedito fino al 23 dicembre 2017, quando il canale satellitare Fantasy di Sky lo mise in palinsesto, con alcun repliche nei mesi successivi.
Soggetto: Giorgio Scerbanenco. Sceneggiatura: Gianfrano Clerici. Fotografia: Giancarlo Transunto. Montaggio: Daniele Alabiso. Musiche: Simon Boswell. Cast: Martine Brochard, Keith Van Hoven, Gino Concari, Lino Salemme, Igor Zalewsky, Jacques Sernas.
Una banda di ladri organizza un furto di quadri in una villa. Uno dei ladri violenta la proprietaria, ma è ferito dal guardiano. I complici, pensando che sia vicino a morire, lo abbandonano agonizzante nella boscaglia. Ma lui sopravvive e si vendica.
1989 – APPUNTAMENTO A TRIESTE di Bruno Mattei, tratto dal romanzo omonimo di G.S. (1953).
Sceneggiatura: Claudio Fragasso, Rossella Drudi, Silvio Maestranzi, Lucio Battistrada. Cast: Tony Musante, Cristina Borghi, Gianni Cavina, William Berger, Edmund Purdom, Jacques Sernas, Laura Troschel.
E’ una miniserie televisiva. Il regista modificò la sceneggiatura, dando più risalto alla storia d’amore tra i due protagonisti, con precisazioni e cambiamenti anche sulla ricostruzione storica.
1993 – SPARA CHE TI PASSA di Carlos Saura, tratto dal racconto omonimo di G.S., contenuto nella raccolta “Milano Calibro 9”.
Soggetto: Giorgio Scerbanenco. Sceneggiatura: Enzo Monteleone, Carlos Saura. Fotografia: Javier Aguirresarobe. Montaggio: Juan Ignacio San Mateo. Musiche: Alberto Iglesias. Cast: Francesca Neri, Antonio Banderas, Eulalia Ramòn, Walter Vidarte, Coque Malla.
Un giornalista conosce una giovane artista di circo, che, con la sua carabina, centra i bersagli su un cavallo al galoppo. Tre giovinastri violentano la donna, che si vendica uccidendoli. Braccata dalla polizia, si barrica in una casa colonica con una bambina, che la ospita e muore fra le braccia del giornalista.
E’ un film non particolarmente riuscito, nonostante la storia intensa e la buona prova dell’emergente Francesca Neri.
1995 – OCCHIO DI FALCO di Vittorio De Sisti, con Gene Gnocchi. Produzione televisiva travagliata (si succedono sette sceneggiatori), prevista nella programmazione estiva, ma subito soppressa. E’ una commedia, con vaghissimi riferimenti a Scerbanenco.
SENZA PARADISO – MATERIALI PER UNA RIDEFINIZIONE
DEL RAPPORTO TRA CINEMA E LAVORO
di Roberto Lasagna
Se i principi tayloristici messi in pratica dal fordismo apparivano alle aziende d’occidente come elementi che aumentavano la produttività delle aziende, ben presto divenne evidente che tali principi non erano necessariamente accompagnati a aumenti di produttività. Anzi, spesso erano associati ad atteggiamenti negativi verso l’azienda e a problemi di salute verso i dipendenti. Dopo “Tempi moderni” di Chaplin, che registrava gli effetti dell’automatizzazione sulla vita del singolo, importanti indagini condotte negli Stati Uniti tra operai impiegati nelle catene di montaggio di importanti aziende automobilistiche avrebbero confermato i problemi di salute fisica e mentale dovuti alla catena di montaggio (Chinoy, 1955; Kornhauser, 1965).
Conclusioni che sarebbero poi state confermate in Europa. Vale la pena rammentare qui almeno due significativi contributi allo sviluppo della psicologia del lavoro che avrebbero poi influenzato la concezione del benessere dei lavoratori. Abraham Maslow pubblicò, nell’ambito della psicologia della personalità e della psicologia clinica, la sua teoria dell’auto-realizzazione (1943) che applicò poi nel 1965 per il lavoro nelle organizzazioni; per Maslow solo le persone psicologicamente sane potrebbero essere motivate a lavorare, dando peso alla convinzione che gli ambienti repressivi, compresi quelli organizzati secondo il pensiero tayloristico, potrebbero inibire le persone dal raggiungere il loro pieno potenziale. In seguito, uno degli sviluppi più importanti è consistito nell’avvento delle teorie di progettazione dei posti di lavoro (Job Design), e, in particolar modo, il pensiero riguardante le condizioni di lavoro che influenzano le prestazioni e la salute mentale di lavoratori può essere dovuto a Frederick Herzberg (1966) che suggerì come la motivazione e la soddisfazione sul lavoro protrebbero essere migliorate agendo sul lavoro delle persone cioè sul miglioramento delle condizioni lavorative, arricchendone il lavoro attraverso la richiesta di un numero crescente di abilità, di complessità, e di riconoscimento. Sebbene alcune delle ricerche di Herzberg siano state in seguito criticate, alcuni dei suoi suggerimenti di base circa l’arricchimento della qualità lavorativa restano utili, e le sue considerazioni hanno stimolato una notevole quantità di ricerche sull’argomento, tanto che alcuni anni dopo Hackman e Oldham avrebbero elaborato un modello più specifico incentrato sulle “caratteristiche del lavoro”, apportando con esso nuovi stimoli e miglioramenti sul tema della progettazione del lavoro. Fu poi grazie all’università del Michigan, sin dal 1948, che vennero introdotti importanti contributi teorici allo sviluppo della psicologia della salute nei contesti lavorativi. L’influenza di Rensis Likert e dell’Istituto per la ricerca sociale (IRS) si sono estesi per lunghi anni. In due film paradigmatici sullo stress da lavoro come “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri e “A tempo pieno” di Laurent Cantet, è possibile rintracciare come la dimensione dello stress, studiata a Michigan nell’ambito lavorativo in tempi di molto precedenti alla realizzazione dei due film, sia sostanzialmente colta come una dimensione trascurata nei contesti storici di riferimento, i primi anni Settanta del film di Petri, il primo decennio del Ventunesimo secolo nel film del cineasta francese. Paradossalmente, due film così lontani nel tempo, ci raccontano il disagio psichico nei contesti di lavoro e ci segnalano cosa è cambiato e cosa è rimasto ancora da fare. La parola stress origina dal latino “stringere” ed è stata originariamente utilizzata in ingegneria e in fisica.
Secondo questo concetto, forze esterne (carico, o come tradotto dagli anglosassoni “load”) esercitano una pressione su un oggetto, producendo deformazione (“strain”). I fautori di questa visione affermano che possiamo misurare lo stress a cui un individuo è sottoposto, nello stesso posto in cui si può misurare lo sforzo fisico su una macchina (Hinkle, 1973). Questa prima concettualizzazione ha esaminato lo stress come uno stimolo esterno, tuttavia una seconda visione lo definisce come la risposta dell’individuo a una sollecitazione che può essere esterna o interna. Dapprima fu Cannon a studiare la resistenza agli effetti dello stress, e a lui si deve la concettualizzazione della risposta “fight or flight” (lotta o fuga). Attraverso questa reazione, le persone, così come gli animali, potranno scegliere se rimanere e combattere o tentare di fuggire quando ci si confronta con un pericolo estremo. Sia Petri che Cantet descrivono nei loro film dei lavoratori che scelgono di resistere, di lottare, di adattare il loro mondo interno trasformandolo per adattarsi all’ambiente esterno. Ciò, nei film dei due cineasti, si traduce in una salvaguardia del processo di sopravvivenza che assume echi differenti. Nel film di Petri si racconta per la prima volta la condizione operaia dopo le lotte del ’68 e soprattutto del ’69, finendo per destare, sin dall’uscita del film nelle sale, discussioni e boicottaggi, critiche feroci in particolar modo in seno alla sinistra; con il tempo, stemperatosi il furore ideologico, il film divenne un classico del cinema d’impegno, accordandosi naturalmente con gli altri due capitoli cinematografici di Petri sulla “trilogia della nevrosi” (“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” e “La proprietà non è più un furto”), e anticipando la svolta più pessimistica della commedia all’italiana che avrà in “Un borghese piccolo piccolo” e in “Brutti, sporchi e cattivi” i suoi titoli probabilmente più densi e paradigmatici. Le critiche che inizialmente vennero rivolte al film di Petri (tacciato di volta in volta di faciloneria, prospettiva piccolo-borghese, metafisica d’accatto, psicanalisi di quinta mano) erano le conseguenze di una focalizzazione sul suo solo aspetto politico ideologico-sindacale, focalizzazione che finì per ignorare sovente qualunque riflessione sul linguaggio e sulla struttura drammaturgica e, in definitiva, qualunque concreta e profonda valutazione della dimensione psicologico-organizzativa dei lavoratori raqppresentati dal film. L’operaio Lulu’ Massa poteva essere letto come una vittima non tanto dell’alienazione, su cui per sempre si puntò (e il cui cognome indicava persino ironicamente una simile lettura), ma della coazione a ripetere che faceva di lui un individuo simbolo e un sintomo per il quale, nello scenario espressivo sopra le righe e smisurato di Petri (e del suo splendido interprete protagonista, Gian Maria Volonté), la fabbrica diventa il luogo privilegiato dell’esistenza e divorante ogni dimensione dello sguardo; un luogo-ossessione in cui i fatti quotidiani accadono sotto gli occhi di tutti e al cospetto di spazi continuamente perlustrati dal controllo degli ingegneri; dimensione onnipervasiva che si espande dalla catena di montaggio alle abitazioni private, in un film votato all’eccesso di una rappresentazione che sconfina, detta il ritmo di una parossistica parabola in cui all’individuo non resta alcuna prospettiva differente all’assoggettamento, se non nella dimensione, beffardamente negata, di un possibile paradiso. In una prospettiva radicalmente critica della società industriale in cui Lulù è prigioniero come dentro un meccanismo crudele, i movimenti di camera e i meccanismi del montaggio restituiscono l’ossessività del lavoro e sanciscono come persino quel prodotto della civiltà industriale che è il cinema resti imbrigliato-imprigionato negli schemi che Godard, in quegli stessi anni, avrebbe sancito di poter far saltare con il suo cinema rivoluzionario e anticonvenzionale. La trappola che Petri individuava con il suo film era la condizione in cui è possibile modulare la concettualizzazione della risposta “fight or flight” (lotta o fuga) designata nella definizione di stress propria di Walter B. Cannon. Attraverso questa reazione, le persone possono scegliere se rimanere o combattere o cercare di fuggire quando ci si confronta con un pericolo estremo. Nella gabbia sperimentata da Lulu’ Massa, il pericolo estremo non è più avvertito come tale. Lulu’ anzi accentua il suo sforzo nell’impegno alla catena di montaggio, obbedisce alle richieste degli ispettori di produzione di accelerare il suo impegno (nella prospettiva dei migliori guadagni del lavoro a cottimo), e in ciò il film denuncia apertamente, tra le altre cose, la sconcertante mancanza di sicurezza della condizione del lavoratore operaio. Se la sopravvivenza dell’individuo, in particolar modo in contesti in cui lo stress è fortemente sollecitato, si esprime con l’impegno degli individui a ripristinare la cosiddetta “omeostasi” (vale a dire a regolare l’ambiente interno in risposta ai mutamenti dell’ambiente esterno), il film chiarisce come il suddetto processo di sopravvivenza è considerabile come l’esito dell’interazione tra l’ambiente esterno e i meccanismi biologici dell’organismo. Fu il medico di origini ungheresi Hans Seyle (1957) a sviluppare ulteriormente le concezioni originarie di Cannon sullo stress in un modello sistematico dello stress fisiologico in cui la risposta fisiologica specifica dell’individuo si articola in tre fasi che descrivono una “Sindrome Generale di Adattamento”: dapprima una reazione di allarme, dove l’organismo risponde agli agenti stressanti fisici, chimici, biologici e psicosociali attivandosi dal punto di vista fisiologico e producendo tanto una fase di controshock quanto una fase di ripresa; quindi una fase di adattamento e di possibile ripristino dell’equilibrio per l’individuo (se, tuttavia, gli agenti stressanti permangono o i meccanismi difensivi non funzionano, l’individuo proseguirà nella terza fase, non scontata); infine, l’esaurimento, la fase in cui i meccanismi adattivi dell’individuo cessano, e l’organismo non ha più la capacità di produrre ormoni adattivi, le scorte si esauriscono e gli agenti o l’agente stressogeno interno o esterno prevalgono sull’organismo. Fatte salve le numerose critiche che vennero rivolte allo schema di Sayle, gli studi successivi focalizzarono in parte l’attenzione sugli aspetti psicologici-valutativi del concetto di minaccia, poiché determinati stimoli, in virtù del loro significato specifico su determinati individui, possono essere percepiti come problemi solo da loro, mentre altri stimoli, in virtù del loro significato condiviso, possono rappresentare un problema per un numero di persone più consistente. Forti fattori cognitivi e situazionali entrano dunque nel processo globale di stress e negli anni Settanta le teorie social cognitiviste si soffermeranno sulla teoria transazionale tra individuo e ambiente, cioè sull’attenzione costantemente rivolta, come in Lazarus e nel suo modello transazionale, sugli aspetti sia cognitivi che emotivi dello stress, dove la condizione del disagio è còlta nella rappresentazione interiore di transazioni particolari e problematiche tra la persona e l’ambiente in cui è chiamata ad operare. E’ innegabile che un film come quello di Petri si situasse oltre i limiti della proposta di Sayle per portarsi verso una prospettiva che contemplasse, nelle sue sporgenze speculative, la prospettiva transazionale. In questa direzione, un film come “A tempo pieno” (2001) di Laurent Cantet, che si collega al cinema di Loach per descrivere la condizione di un disoccupato e possiede echi di un cinema europeo sempre più moderno ed inconsueto, ci conduce proprio dentro i rischi rappresentati dagli eventi ambientali portandoci in una dimensione in cui, dal cinema d’ìmpegno civile di Petri – teso a denunciare le condizioni rischiose della condizione lavorativa e l’allarmante dimensione sociale dell’industria italiana dopo le lotte politiche del ’68 e ’69 – si fa strada un cinema del disagio psichico più profondo e incomunicabile, in cui alla crisi della società industriale si accompagna un malessere strisciante a cui l’individuo non è preparato perché non trova modelli di reazione consolatori e validi per le nuove stagioni.
Nel film di Cantet, Vincent, non avendo il coraggio e la serenità interiore di rilevare alla famiglia e agli amici di aver perduto da ormai alcune settimane il suo lavoro di consulente, cerca di crearsi una vita professionale parallela fatta di riunioni di lavoro e di trasferte all’estero. Lazarus definì la valutazione come il processo che permette all’individuo sottoposto a stress di mediare e negoziare attivamente tra le richieste e le risorse dell’ambiente da un lato e la gerarchia e le credenze personali dell’individuo dall’altro. Il risultato del processo di valutazione sarà un tentativo di fronteggiamento (coping, dall’inglese to cope, fronteggiare). Secondo Lazarus il confronto con un evento stressante (qui segnatamente in ambito lavorativo) passa attraverso tre fasi: una valutazione primaria, cioè un evento in cui gli individui classificano un determinato evento come una minaccia per il proprio sé; una valutazione secondaria, in cui l’individuo elabora cognitivamente strategie per fronteggiare le richieste ambientali stressanti; un processo di fronteggiamento (coping), che riguarda la messa in atto di tali strategie. Il coping, in psicologia, è quindi comunemente concettualizzato come una risposta o reazione conscia a eventi stressanti e/o negativi la cui origine è esterna all’individuo. Nel film di Cantet, regista acuto e realistico osservatore di contesti contemporanei in cui l’individuo si confronta con il gruppo e con situazioni di separazione (illuminante il suo “La classe”), mentire diviene per Vincent un’occupazione a tempo pieno e una modalità che esprime una reazione disfunzionale a lungo sostenuta per la voglia di evitare lo sguardo della moglie Muriel e dei suoi tre figli. Una condizione che lo conduce a mentire a se stesso, come quando si immagina di poter trovare un posto di lavoro perdurando oltre il consentito nella sala attesa di un’azienda nell’attesa di un colloquio di lavoro risolutore per il quale non ha neppure un preliminare appuntamento. Il suo comportamento lo porta sempre più lontano dalla famiglia e da se stesso, alienandolo e svuotandolo, costringendolo al conflitto con quella visione del mondo che pur difende. Per mantenere il tenore di vita raggiunto in passato convince gli amici ad avventurarsi in investimenti senza speranza e l’angoscia crescente lo lascia senza via d’uscita. Anche in questo caso, come nel film di Petri, non c’è un paradiso che salvi dalla disperazione il lavoratore ma è piuttosto il benessere sociale a ritagliarsi l’immagine di un paradiso transitorio e di un obiettivo che si è soliti difendere a ogni costo, persino a danno dell’armonia interiore e dei valori fondamentali. Dalla rappresentazione di Petri – che mostra lo stordimento della vita di Lulu’ Massa e racconta, nella fissità delle scene casalinghe, la difficoltà dell’operaio di finalizzare il desiderio erotico a qualcosa che non sia il lavoro in fabbrica – a quella di Cantet, che mostra come i disagi si siano spostati e allargati, e come sempre di più, anche in anni di “flessibilità” e “globalizzazione”, dipendano dal contesto.
ALLA RICERCA DELL’INNESTO PERDUTO:
“BLADE RUNNER 2049”
di Francesco Saverio Marzaduri
“Perché realizzare un’opera quando è così bello sognarla soltanto?”
PIER PAOLO PASOLINI, Il Decameron
Non hanno ancora inventato una macchina capace di fissare il sogno prodotto dalla mente, e il giorno che succederà la fantascienza non avrà più significato. Quando il capolavoro di Ridley Scott uscì nel 1982, l’idea di un avvenire tetro come visto in quel film pareva non ammettere ricostruzioni altrettanto cupamente efficaci, e un eventuale sequel di “Blade Runner” avrebbe rischiato accuse di blasfemia. Sul punto, soprattutto, se il protagonista sia o meno un replicante. Stando alle scelte del regista Villeneuve, non pare giusto dissertare su un’opera che non è un vero sequel, né un calco del prototipo (del resto impossibile). E se nel precedente “Arrival” una linguista era reclutata dalle forze militari per scoprire se alcune navi aliene avessero o meno intenzioni pacifiche, qui l’autore prosegue il discorso spostando l’interrogativo di Philip K. Dick su cosa sia umano e cosa no.
Anche in questa rilettura (scritta da Michael Green e da quell’Hampton Fancher che già mise mano al primo episodio), i nodi di “Prisoners”, “Sicario” e del citato “Arrival” restano identici: la volontà di mantenere un ordine in un caos ingovernabile, l’incapacità di proteggere i figli da un’escalation frenetica che non fa sconti a nessuno, la progressiva de-umanizzazione di chi è deputato a far piazza pulita. E se la questione-Deckard, umano o no, condiziona pure questa ingigantita versione, Villeneuve opta per il contributo offerto da Fancher, seguendo una linea in cui il dubbio nasce dalla progressiva disumanizzazione di Deckard, e dal fatto che nel testo originale non vi è soluzione. Sicché la storyline si fa rettilinea, e la linea emozionale è quella di un reificato che recupera la propria umanità grazie all’antagonista.
In questo Capitolo Secondo, una macchina capace di elaborare sogni e rivelare la sincerità di un ricordo vissuto è presente nella scena-clou, in un film che non rinuncia all’atmosfera hard boiled dell’originale. Non c’è voce narrante a conferire patine noir: nondimeno, l’unilateralità espressiva e i gesti dell’agente K restituiscono la commistione di azione e disincanto in chi – finto umano in un mondo dove è sovversivo essere veri umani – cede a ossessioni e memorie moleste. Villeneuve ne segue l’indagine (individuare un figlio, pena la compromissione del mondo), che rivela un possibile ego interiore. Tale ricerca, a fronte di un antagonista che forse è il proprio padre spirituale, implica informazioni che riportano ai noti quesiti (“Chi sono? Da dove vengo? Quanto mi resta da vivere?”).
Il resto sta allo spettatore, specie se affezionato, scoprirlo: molti sono i pattern sparsi (gli origami, il pianoforte, le proteine genetiche, le aeromobili, l’immancabile babelica megalopoli), come i loro fantasmi e simulacri, a rammentare che “Blade Runner 2049” è un prodotto a sé stante. L’impressione della parodia è vanificata dalla riproposta, complice l’inversa prospettiva, di un discorso e un culto tanto maestosi che il continuum di figure e situazioni, entrato nell’immaginario collettivo, suonerebbe altrimenti scorretto. Se poi il futuro messo in scena trentacinque anni fa non fosse stato troppo dissimile dall’odierno presente, potrebbe da qui ripartire verso quello datato 2049, così lucido e scintillante, geometrico e astratto, per trasportarci in una rinascita (e in una catarsi) non difficile da immaginare. Consapevole di questo, Villeneuve gioca con le leggende cinematografiche costruite intorno al mito: lo testimonia la sterminata audio-video-biblioteca in cui Deckard si è rifugiato, mostrata con un’illuminazione che riecheggia l’Overlook Hotel (si ricordi la diceria, non infondata, sull’epilogo di “Blade Runner” montato con filmati scartati da Kubrick).
 Più che replicante, questo nuovo segmento è un nuovo innesto sul nostro ricordo, sul mito e su quanto credevamo di sapere, e in mezzo sta tutto il fantasy in celluloide di oltre un trentennio, da Cameron alla Bigelow, da Verhoeven a Niccol, sino ai Wachowski, per non parlare delle serie televisive. L’agente K gioca con simulacri femminili frutto di avanzate tecnologie (è una pendrive a procurare compagnie sentimentali) e, se il dilemma umano-replicante persevera, anche un “lavoro in pelle” chiede che il feticcio virtuale – già al centro di “S1m0ne” e del recente “Lei” – si amalgami col corpo di una prostituta, e abbia trasporti sessuali con entrambi i doppi. Il sesso è ridotto ad esotici ologrammi che riesumano l’onirismo felliniano nella sembianza più delirante, come a Deckard toccano i nostalgici replicanti-app delle icone che furono, da Liberace a Elvis, da Marilyn a Sinatra. La Los Angeles di Villeneuve eredita la post-Apocalisse di “Mad Max”, e in quell’acceso cromatismo rosso-fuoco del deserto, più che di Scott, è stretta parente del Tarkovskij di “Stalker” e di “Solaris”, mescolando Orwell e Gilliam. Apocalisse dove l’agente K si misura con un quid impensabile: la possibilità di un miracolo, che fa di “Blade Runner 2049” un hard boiled biblico. Miracolo che si origina ai piedi di un possibile albero della vita di stampo malickiano (e K è il Ryan Gosling di “Song to Song”), dal quale potrebbe dipendere la resurrezione dell’umanità.
Più che replicante, questo nuovo segmento è un nuovo innesto sul nostro ricordo, sul mito e su quanto credevamo di sapere, e in mezzo sta tutto il fantasy in celluloide di oltre un trentennio, da Cameron alla Bigelow, da Verhoeven a Niccol, sino ai Wachowski, per non parlare delle serie televisive. L’agente K gioca con simulacri femminili frutto di avanzate tecnologie (è una pendrive a procurare compagnie sentimentali) e, se il dilemma umano-replicante persevera, anche un “lavoro in pelle” chiede che il feticcio virtuale – già al centro di “S1m0ne” e del recente “Lei” – si amalgami col corpo di una prostituta, e abbia trasporti sessuali con entrambi i doppi. Il sesso è ridotto ad esotici ologrammi che riesumano l’onirismo felliniano nella sembianza più delirante, come a Deckard toccano i nostalgici replicanti-app delle icone che furono, da Liberace a Elvis, da Marilyn a Sinatra. La Los Angeles di Villeneuve eredita la post-Apocalisse di “Mad Max”, e in quell’acceso cromatismo rosso-fuoco del deserto, più che di Scott, è stretta parente del Tarkovskij di “Stalker” e di “Solaris”, mescolando Orwell e Gilliam. Apocalisse dove l’agente K si misura con un quid impensabile: la possibilità di un miracolo, che fa di “Blade Runner 2049” un hard boiled biblico. Miracolo che si origina ai piedi di un possibile albero della vita di stampo malickiano (e K è il Ryan Gosling di “Song to Song”), dal quale potrebbe dipendere la resurrezione dell’umanità.
 La memoria dello spettatore, cresciuto nel culto, non si arena alle rimembranze cinematografiche né agli onanismi intellettuali, e tuttavia, in un prodotto di oltre due ore e mezza, lampante è il ricupero di un certo immaginario narrativo dopo il disfacimento del pianeta. Gli strati in cui si smembra Los Angeles conducono alla sua estrema e altrettanto plausibile effige nell’area-discarica, in cui K si reca insieme al feticcio virtuale Joi alla ricerca del figlio (ossia dell’innesto) smarrito. Prima d’imbattersi in una fabbrica dove la manodopera grava sulle spalle di dozzine di fanciulli uniformi e calvi, schiavi agli ordini di uno sfruttatore rapper di colore. Forse, la stessa fabbrica in cui il protagonista crede di essersi trovato da ragazzino, inseguito e pestato da bambini senza capelli, per difendere – e all’occorrenza gettare nelle fiamme – una misteriosa statuetta a forma di cavallo, intagliata, chissà, dal citato albero della rinascita (che riporta inoltre al logo della Ladd Company, casa produttrice del primo episodio). Il resto è parente stretto di quel “1984” che è data topica per la narrativa di fantascienza, e dei mondi che si sono creati e qui disgregatisi dopo lunga lotta.
La memoria dello spettatore, cresciuto nel culto, non si arena alle rimembranze cinematografiche né agli onanismi intellettuali, e tuttavia, in un prodotto di oltre due ore e mezza, lampante è il ricupero di un certo immaginario narrativo dopo il disfacimento del pianeta. Gli strati in cui si smembra Los Angeles conducono alla sua estrema e altrettanto plausibile effige nell’area-discarica, in cui K si reca insieme al feticcio virtuale Joi alla ricerca del figlio (ossia dell’innesto) smarrito. Prima d’imbattersi in una fabbrica dove la manodopera grava sulle spalle di dozzine di fanciulli uniformi e calvi, schiavi agli ordini di uno sfruttatore rapper di colore. Forse, la stessa fabbrica in cui il protagonista crede di essersi trovato da ragazzino, inseguito e pestato da bambini senza capelli, per difendere – e all’occorrenza gettare nelle fiamme – una misteriosa statuetta a forma di cavallo, intagliata, chissà, dal citato albero della rinascita (che riporta inoltre al logo della Ladd Company, casa produttrice del primo episodio). Il resto è parente stretto di quel “1984” che è data topica per la narrativa di fantascienza, e dei mondi che si sono creati e qui disgregatisi dopo lunga lotta.
Pertanto “Blade Runner 2049” è anche un’opera-innesto sul nostro modo di assimilare-immaginare-giocare con la narrativa cartacea, e a buon bisogno reinterpretarla. L’incontro fra K e l’alter ego Deckard avviene giocoforza in un luogo di cultura semi-abbandonato tra i cromatismi rossastri di un Parnassus sperduto, di vago sapore lynchano: un dedalo deserto e coloratissimo, con un cane forse artificiale e potenziale Cerbero, custode dell’unico edificio presente di un tunnel in cui non è dato sapere dove termini l’Inferno e cominci il Paradiso. Più probabilmente un limbo, ove Deckard, l’immancabile pistola in pugno, sguscia dalla penombra come Kurtz, ponendo a K un quesito che rimanda a Stevenson, e che il secondo – “lavoro in pelle” acculturato come Roy Batty – prontamente indovina rivelando di nuovo una (sovra)umanità riposta. Ancora, la fantascienza di cui il film di Villeneuve è appropriato sunto, indispensabile per il nuovo millennio, non allontana la freddezza di un oggidì sinistro, ostile e inquietante, in cui impera ineluttabile il non-umano. Si prenda il timbro vocale automatico del test di riconoscimento cui ogni volta K è sottoposto, ridondante e opprimente, quintessenza non solo di un universo spia ma anche delle inquietudini à la Kafka (la scelta della lettera per il nome dell’agente certo non è casuale).
“La distinzione – osserva Alessandro Cappabianca – diventa sempre più difficile, con il cinema dell’era elettronica, che permette di giocare facilmente sull’ambiguità.” Ebbene: se “Blade Runner 2049” è operazione-innesto (o film-replicante, come ha scritto più d’uno), niente di più facile che, al pari del prototipo, il pattern della doppiezza, anch’esso di lontana derivazione letteraria, la faccia da padrone con un’evidenza così elementare da risultare ricercata a bella posta. La Wallace Industries rinasce dalle ceneri della Tyrell Corporation: ne è, anzi, l’aggiornamento riveduto e corretto in un progresso dall’esito ancor più stupefacente (e provvisto di etica anche più delirante), così come il suo proprietario-Onnipotente, generatore di angeli e corpi sintetici, è un continuum addirittura più cinico e spaventevole. Segue la dicotomia tra Los Angeles e le colonie Extramondo, e tra K e Deckard, l’uno alter ego (quindi doppio) dell’altro, anche se fare il lavoro del secondo “un tempo era più facile”. E tra i personaggi, come tra le scenografie, i risvolti e le sfumature inerenti alla trama, il gioco potrebbe continuare all’infinito: del capolavoro di Scott, tra l’altro, fa capolino un estratto in forma di traccia-audio, del dialogo-test cui Deckard sottoponeva Rachael per stabilire se fosse una replicante, che K ascolta insieme a Luv, la replicante tirapiedi di Wallace. Come già per il primo episodio, anche in Villeneuve lo scarto tra la norma e la sua interpretazione, tra il reale e l’artificiale, tra il vero e il presunto (e tra il ricordo e l’innesto) è la regola prima, senza che il didascalismo tradisca lo spirito prevalendo sull’enigmaticità, ancora una volta suadente, dell’immaginario esposto.
 Pure, nella missione noir di K, la doppiezza collima con la sessualità del misterioso figlio perduto, e s’insinua il sospetto che la replicante defunta abbia concepito due gemelli col medesimo DNA: a un certo punto, K non supera il consueto test d’accesso sulla propria natura replicante, e ragioni da non proferire abbracciano l’ipotesi di una sua presunta umanità alimentando la contrapposizione umano-replicante (e il ricordo su cui ruota l’indagine potrebbe sul serio appartenergli). Nella demarcazione Ieri-Oggi non mancano le caratterizzazioni femminili, l’una il riverbero dell’altra perfino nel cuore della vicenda: inevitabile il duello tra Luv e Joshi, il biondo capo di K, in parti uguali interessate alla missione di K secondo una discrepante scelta di campo, e tuttavia la prima è una Rachael anche più glaciale, priva di sentimenti e fragilità. E l’ologramma Joi si contrappone a tali ciniche bellezze, costituendo un doppio con Mariette, la bionda prostituta cui K decide di concedersi: a tratti simile all’acrobatica Pris, invero una figura-chiave come l’enigmatico Nexus 8 dell’incipit che l’agente è costretto a “ritirare”, entrambi facenti parte di quell’Esercito della Salvezza che aiuta il replicante a scampare alla morte permettendo di far luce sull’arcano. Creatura evanescente, Joi si materializza “possedendo” il corpo e il volto (cibernetici) di Mariette, facendo del proprio simulacro un tutt’uno con una tangibilità che non è più (solo) innesto o artificio, bensì carne e materia (sia pur virtuali). Quando la prostituta trova la statuina di legno – altro punto nodale – e Joi l’ammonisce che il suo compito è terminato, lei dice “Sono stata dentro di te: c’è meno di quel che pensi”. Poco dopo l’ologramma convince K a portarlo con sé, sapendo di essere sacrificato: il limite suggerito da Mariette, prima che la si ritrovi nell’Esercito della Salvezza, risiede nel non (voler) consentire che la verità venga a galla. E Joi è un prodotto della Wallace. La conferma si ha quando il presidente di essa ipotizza che l’amore tra Deckard e Rachael, e la loro creazione, sia un esperimento della Tyrell per testare l’eventuale capacità dei Nexus di riprodursi. “L’umanità – dice Wallace – non può sopravvivere. I replicanti sono il futuro della specie. Ma non posso crearne di più.” “Io so cosa è reale”, controbatte un Deckard in lacrime: sicché la presenza di una Rachael clonata, di cui Joi è il corrispettivo speculare, restituita all’ex cacciatore di androidi come un impressionante calco dell’originale, è neutralizzata prima ancora che se ne accerti la concretezza, smentita dallo stesso Deckard (“Aveva gli occhi verdi”) un istante prima che Luv si sbarazzi del clone.
Pure, nella missione noir di K, la doppiezza collima con la sessualità del misterioso figlio perduto, e s’insinua il sospetto che la replicante defunta abbia concepito due gemelli col medesimo DNA: a un certo punto, K non supera il consueto test d’accesso sulla propria natura replicante, e ragioni da non proferire abbracciano l’ipotesi di una sua presunta umanità alimentando la contrapposizione umano-replicante (e il ricordo su cui ruota l’indagine potrebbe sul serio appartenergli). Nella demarcazione Ieri-Oggi non mancano le caratterizzazioni femminili, l’una il riverbero dell’altra perfino nel cuore della vicenda: inevitabile il duello tra Luv e Joshi, il biondo capo di K, in parti uguali interessate alla missione di K secondo una discrepante scelta di campo, e tuttavia la prima è una Rachael anche più glaciale, priva di sentimenti e fragilità. E l’ologramma Joi si contrappone a tali ciniche bellezze, costituendo un doppio con Mariette, la bionda prostituta cui K decide di concedersi: a tratti simile all’acrobatica Pris, invero una figura-chiave come l’enigmatico Nexus 8 dell’incipit che l’agente è costretto a “ritirare”, entrambi facenti parte di quell’Esercito della Salvezza che aiuta il replicante a scampare alla morte permettendo di far luce sull’arcano. Creatura evanescente, Joi si materializza “possedendo” il corpo e il volto (cibernetici) di Mariette, facendo del proprio simulacro un tutt’uno con una tangibilità che non è più (solo) innesto o artificio, bensì carne e materia (sia pur virtuali). Quando la prostituta trova la statuina di legno – altro punto nodale – e Joi l’ammonisce che il suo compito è terminato, lei dice “Sono stata dentro di te: c’è meno di quel che pensi”. Poco dopo l’ologramma convince K a portarlo con sé, sapendo di essere sacrificato: il limite suggerito da Mariette, prima che la si ritrovi nell’Esercito della Salvezza, risiede nel non (voler) consentire che la verità venga a galla. E Joi è un prodotto della Wallace. La conferma si ha quando il presidente di essa ipotizza che l’amore tra Deckard e Rachael, e la loro creazione, sia un esperimento della Tyrell per testare l’eventuale capacità dei Nexus di riprodursi. “L’umanità – dice Wallace – non può sopravvivere. I replicanti sono il futuro della specie. Ma non posso crearne di più.” “Io so cosa è reale”, controbatte un Deckard in lacrime: sicché la presenza di una Rachael clonata, di cui Joi è il corrispettivo speculare, restituita all’ex cacciatore di androidi come un impressionante calco dell’originale, è neutralizzata prima ancora che se ne accerti la concretezza, smentita dallo stesso Deckard (“Aveva gli occhi verdi”) un istante prima che Luv si sbarazzi del clone.
Trenta(cinque) anni di mitologia e passato, di ricordi e/o innesti, non si cancellano facilmente. E nell’epilogo a spirare – almeno a livello spirituale – è il fantasma dell’estraneo che tale ha scelto di essere per amore. Chi si ha di fronte è la sua parte ritrovata di umano. La medesima che il suo alter ego, nelle spoglie di un “lavoro in pelle”, sembra consegnare in un estremo gesto di redenzione. Il tutto sotto l’egida di un bulbo oculare che introduce alla narrazione e, specchio di quello della prima puntata che offriva una “Metropolis” ruvida e oscura, ne avvia una post-industriale e risplendente. Qui le colture sintetiche, necessarie per la sopravvivenza della specie umana, contrastano col più volte citato albero naturale, da cui sarà forse possibile ripartire. E un umanoide, proprio perché ancora più umano, rivelarsi della sostanza di cui sono fatti i sogni (i ricordi felici). Da fatiscente e sporca, piovosa e multietnica, la metropoli potrebbe farsi sommergere da un alluvione che spazzi via il disfacimento del sogno-incubo tecnologico, e la natura (non la sua memoria-innesto) riprendere possesso dalle ceneri del suo inquinamento. Prima che di nuovo sia tutto fango occorre approfittare della neve, a mo’ di estrema purificazione, e qui espiare e attendere la morte, rivelando di avere un’umanità riposta. Mentre la gigantesca ampolla che cinge il personaggio-chiave reca una neve artefatta che si concilia con quella del mondo esterno. L’innesto si fa ricordo di un’epoca e di un cinema lontani, non solo di un’infanzia sottratta: la boccia vitrea che Kane-Welles teneva nella mano prima di lasciarla cadere a terra, risorge indistruttibile.
Parafrasando Leonardo Gandini, il cinema non è un farmaco, ma, se ci si crede, può essere una radiografia. Sotto questo profilo, “Blade Runner 2049” è una lastra nitidissima che riflette al meglio sull’evanescenza e la labilità dell’era digitale. Un aggiornamento capace, questo, di quadrare i conti con il suo e il nostro tempo. È il cinema del nuovo millennio a consentire questa risurrezione: ecco il vero “miracolo” di cui anche un replicante può rendersi capace. La dimensione oltre della nuova possibile realtà, e del cinema da questa concepito.
INTERVISTA
 SULLE SPALLE DEL GIGANTE:
SULLE SPALLE DEL GIGANTE:
CINEMA 3D E NUOVE FRONTIERE
di Giorgia Pizzirani e Federico Felloni
Un piccolo caseggiato bianco, tre sedie complete di visori e piastra agganciata allo schienale a simulare non solo la visione tridimensionale ma ogni tipo di sensazione percettiva, esperienziale, materiale della storia che si guarda. La trama asciutta e potente – una famiglia composta di padre, madre e una bambina che, in un futuro imprecisato, si barricano in una cantina per sfuggire ai bombardamenti durante una guerra – ricorda senza difficoltà trame del miglior cinema quale La vita è bella, dove l’adulto si ingegnava nel lo spiegare, con la leggerezza della disperazione, un avvenimento devastante come la deportazione nazista.
Anteprima italiana e novità assoluta, il cortometraggio 3D “Giant” è stato presentato nella tre giorni di Internazionale a Ferrara 2017 alla presenza degli ideatori, la regista serba americana di adozione Milica Zec e il regista newyorchese Winslow Porter III.
“Il gigante – spiega Milica – è un pretesto, un simbolo che potesse stagliarsi e riconoscersi in quanto causa di ciò che avviene nel setting della trama. Il gigante è la personificazione della guerra, il pretesto con il quale i genitori giustificano alla figlia lo stare nascosti, al buio, dal mondo fuori: quasi un modo per edulcorare une realtà devastante e renderla più accettabile. È un gigante che si approccia alla casa in modo maldestro, che con il suo incedere lento e goffo irrompe nella vita della famiglia perfetta: dapprima attraverso ombre proiettate sul muro dai due genitori per preparare la piccola Rose al suo arrivo; poi con fragore, crolli di mensole e polvere, cadute di travi del soffitto, luce che salta. In tutto questo escogitano passatempi per alleviare il dolore di una esperienza devastante tanto per un adulto quanto, e soprattutto, per un bambino”.
E come la spieghi la guerra a un bambino?
“Ho 35 anni, ero piccola quando vissi in prima persona il fragore delle bombe durante il conflitto in Kosovo negli anni Novanta. Scrivendo questo soggetto cercavo un modo per raccontare la mia esperienza e nel contempo porre un monito a chi osserva e ascolta, sul fatto che la guerra può accadere ovunque, può riguardare ognuno di noi. Ecco perché ‘Giant’ è ambientato in un futuro imprecisato in un luogo altrettanto imprecisato degli Stati Uniti (dove Milica vive ora, ndr).
Non è distopico, non è lontano; e questa la realtà su cui riflettere”.
Il piano sequenza continuato a cui lo spettatore assiste, grazie alla tecnologia di visione a 360º, consente di vedere il coniglietto che la bimba addita felice, risultato del gioco dell’iniziale, che è esattamente ai piedi dello spettatore; e di guardarsi intorno facendo un giro sulla sedia, osservando ogni minimo e pianificato dettaglio del disegno originale, come era intenzione del progetto.
A complemento della storia breve e intensa c’è infatti un supporto tecnologico totalmente spiazzante, appannaggio del cinema 3D.
“ ‘Giant’ è il primo short movie di una trilogia che parla del male. Il 3D è una esperienza particolare, che rende possibile per gli spettatori calarsi completamente nella realtà che vedono sullo schermo – racconta Porter, creativo e produttore – grazie a una piastra sistemata sullo schienale della sedia e al visore che isola orecchie e occhi, canalizzando i sensi in un unico verso e nel contempo fondendoli. È una colonna portante dell’industria LBE (Location Based Entertainement, inteso sia come media il cui principio di base è correlato alla realtà virtuale, sia come modalità di interazione sociale tra luogo e tecnologia), ciò che di fatto avviene quando proiettiamo un film come questo”.
E, se tuttavia non è da confondere con la realtà virtuale, la sensazione che se ne ricava già dopo qualche secondo è spiazzate, tanto da rendere utili le raccomandazioni dei volontari della rassegna di non alzarsi per nessun motivo dalla sedia, e di non lasciarsi condizionare perché ciò che si vede è finzione. Un cinema insomma che, ci tiene a precisare Porter, non è interattivo bensì virtuale, ovvero simula ogni piccolo effetto che racconta lo schermo 2D.
“Se già questo è innovativo e connotato da una forte esperienza sensoriale – ci anticipa ancora – attendo al varco chi vivrà il capitolo numero 2, dal titolo Tree, incentrato sul tema del cambiamento climatico. Come suggerisce il titolo, il soggetto sarà un albero, ma… attenzione: chi parteciperà alla visione sarà egli stesso immerso nel processo di crescita del fusto, dei rami e delle fronde la cui commistione con la fisicità umana sarà sorprendente. Come se l’albero fosse lo spettatore.”
Il cortometraggio, la cui lavorazione è durata 4 mesi, è stato co-finanziato da Fondazione Pianoterra, associazione onlus nata a Roma, incubatrice di progetti che utilizzano la cultura in ogni sua forma come strumento di emancipazione e sviluppo delle potenzialità di chi vive in contesti disagiati che ha co-prodotto anche “Tree”, il secondo capitolo della trilogia. Al momento – racconta Giusy Muzzopappa di Fondazione Pianoterra – non ci sono rientri economici ma solo proiezioni in giro per il mondo e riconoscimenti, che non sono cosa da poco: Sundance Film Festival e Internazionale a Ferrara, fino al Maxxi di Roma. L’aspetto economico è senza dubbio parte importante da affrontare poiché ogni spettatore necessita di una postazione con supporti tecnici delicati e costosi. Anche se si tratta di una esperienza unica, che consente allo spettatore quasi un isolamento tra sé e il film; un contesto intimista e coinvolgente, che attende solo di essere finanziato per intraprendere nuovi progetti artistici, magari socialmente e universalmente utili.”
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
FILMMAKER ALLA RIBALTA: NICOLO’ ZACCARINI
di Paolo Micalizzi
La passione per il cinema per Nicolò Zaccarini nasce a 5 anni quando insieme al fratello proiettava, aiutato da una scatola di scarpe e una candela, le strisce dei fumetti di Capitan Miki e Bleck Macigno, due personaggi immaginari creati negli anni Cinquanta. Ma i film, dichiara, iniziò a realizzarli quando incominciò ad insegnare Educazione Tecnica in una Scuola Media di Savona. Gli fu possibile grazie ai mezzi messi a disposizione da un alunno. Il primo corto lo realizzò alla Scuola Media “Chiabrera” di Savona nell’anno scolastico 1975/76. S’intitola “La merenda di Rossi” ed è incentrato su un ragazzo emarginato dagli altri perché proveniente dalla campagna. Ma quando arrivava in classe con la merenda riceveva invece una buona accoglienza. Il secondo corto, “Il sogno di Paciullo” lo realizza nell’anno scolastico successivo nella Scuola Media “Ramella” di Loano. Protagonista un ragazzo povero che sogna di diventare ricco: una volta acquistato un cappotto elegante egli sarà conteso dagli altri. A partire dall’anno scolastico 1977/78 Nicolò Zaccarini insegna Alla Scuola Media “Angelo Barile” di Albissola Marina. Lo farà per 28 anni. In occasione del decimo anno(1977/1987) nello “Spazio giovani” del periodico “Liguria” appare un articolo, a cura di Emilio Sidoti, in cui se ne riassume l’attività in cui viene sottolineato che “perno e animatore di quest’attività è il professore Nicolò Zaccarini, un insegnante che dimostra non solo di credere al valore formativo delle immagini in movimento, ma anche di possedere realmente la tecnica cinematografica”.
Aggiunge subito che ciò che gli mancano sovente, come avviene nella Scuola italiana, sono i mezzi finanziari, ma che Nicolò Zaccarini non si perde d’animo e cerca sponsor. “ Cosi, ora con l’aiuto della Cassa di Risparmio ora con l’appoggio della 3M è riuscito a produrre con i suoi allievi, anno dopo anno, una decina di film in Superotto”. Un cinema con i ragazzi e non dei ragazzi, sottolinea Emilio Sidoti, realizzato nel modo seguente:” L’insegnante propone un soggetto e usando gli strumenti lo realizza insieme agli alunni. Ogni allievo ha cosi modo d’imparare in pratica la morfologia, la sintassi e gli effetti più stupefacenti del linguaggio filmico”: Nascono cosi opere, tanto per citarne alcune, come “Il dizionario” dove un gruppo di alunni di una Scuola Media prende spunto da un dizionario per mettere in scena alcuni vocaboli significativi dei vari aspetti della nostra vita quotidiana. Nel successivo “Il film” l’autore cerca di dare al pubblico delle sensazioni di terrore, paura e di fenomeni paranormali per insegnare alle nuove generazioni cosa c’è dietro l’affascinante mondo del cinema con i suoi effetti speciali, i segreti e le tecniche di montaggio, l’importanza della sonorizzazione.
Un’opera didattica in nove episodi individuali che insieme costituiscono l’arte di fare del cinema, naturalmente fatto da ragazzi e per ragazzi. L’iter per la realizzazione di un film, viene poi affrontato in “Dall’idea all’immagine sullo schermo” attraverso il racconto di uno scrittore che inventa una storia ,passando poi per un produttore ed un regista.
Ancora film con la scuola “Angelo Barile” negli anni scolastici successivi. Nel 1989/90 “Aria pulita” in cui viene proposta come alternativa ad una società impostata su consumi falsi e negativi(alimentazione sbagliata, fumo, rumore assordante) soluzioni positive legati ad aria pulita: sport, aria non inquinata, dinamismo; nel 1990/91 ”L’allegra farfallina”, in cui gli alunni affrontano la realizzazione di un cartone animato. Dall’insegnamento delle tecniche da adoperare fino alle riprese ne scaturisce un film ecologico in cui viene sottolineato come la natura e l’ambiente sono sempre minacciati dagli uomini. Nel 1993/94 è la volta di “Ragazzi all’opera” e ne è protagonista un piccolo genio dell’arte che svegliatosi da un lungo sonno è affascinato dalla musica lirica: vorrebbe conoscere lo spirito che è dotato di tale potere magico e quando lo trova i due si divertono a creare musica e paesaggio. Il cortometraggio nasce sotto l’egida del Circolo Savonese Cineamatori Fedic, che dà vita ad altre opere. Con il Liceo Classico “ Gabriello Chiabrera” Nicolò Zaccarini realizza “Tre personaggi in cerca d’amore” dove viene raccontato che Ugo è follemente innamorato di Silvia che le appare nei suoi sogni mentre studia a casa o che lo induce a trascurare la spiegazione dell’insegnante per ammirarla, prendendo dei rimproveri. Ma quando pensa ,durante la ricreazione, di poterle dichiarare il proprio amore, Silvia rimarrà attratta, come altre ragazze, da Mimmo, un ragazzo alto e bello è affascinante. Il finale sarà a sorpresa. Con gli alunni della 2B delle scuole medie ”Angelo Barile” realizza invece “L’amicizia è in pericolo” . Protagonista una strega malvagia che mette in pericolo l’amicizia tra alcuni compagni di scuola. Sarà debellata dall’intervento di due maghi e il coraggio di alcuni ragazzi che vogliono far valere il valore dell’amicizia. Nel 2002 con “Diamoci un taglio”, Nicolò Zaccarini passa al digitale. Il tema del cortometraggio è quello dei rifiuti urbani ed è incentrato su una lezione, su invito della maestra, a degli studenti di scuola elementare del Direttore dell’Azienda locale “tutela ambente”: un’opera tra il documentario e la fiction. Il mondo delle scommesse viene affrontato in “Un giorno da campioni”(2004) dove per vincere si ricorre alle minacce. Del 2008 è “Il testamento”, un racconto ad ampio respiro con protagonista un giovane che rimane escluso dal testamento della zia e fa di tutto per screditare la sorella, che dovrebbe ricevere l’eredità, e architettare l’omicidio della ricca zia.
Con questo cortometraggio Nicolò Zaccarini imbocca la strada del poliziesco, con un occhio al noir americano come si deduce dai nomi dei protagonisti. In “Scommessa con la morte”(2009) protagonista è un dipendente di un’azienda chimica che denuncia per screditarlo il suo datore di lavoro, spregiudicato imprenditore, accusandolo di imbrogliare i clienti con prodotti pericolosi per la loro salute. Da qui la scommessa dell’imprenditore di ucciderlo senza andare in galera con la promessa che, se sarebbe riuscito a salvarsi, il dipendente avrebbe ereditato l’azienda. Sul tema dell’omicidio anche “Che cosa hai in testa?” (2010) dove un medico e la sua amante architettano l’omicidio della moglie.
Quando credono di averlo compiuto, accade un colpo di scena grazie all’Ispettore Maffei. Quest’ultimo è anche il protagonista di “Delitto passional”(2013) in cui un omicidio in una rappresentazione teatrale si rivela veramente accaduto. Anche qui un colpo di scena finale svelerà l’assassino e il suo movente. Cambio di registro in “(Al) Fred”(2015) in cui il protagonista ha la passione dei film musicali con Fred Astaire e Ginger Rogers, al punto che gli amici lo chiamano, appunto, Fred, come il suo idolo.
Ma la passione si scontra con la realtà quotidiana. La filmografia di Nicolò Zaccarini tende ad ampliarsi perché il “nostro” è già alle prese di un nuovo cortometraggio. Il suo titolo è “ Il contratto”.
Dal 1994 Nicolò Zaccarini è Presidente del Circolo Savonese Cineamatori e tante sono le iniziative intraprese per dare vitalità a questo Cineclub FEDIC.
Tra esse, importante è la “Festa dell’Immagine”, una Mostra Concorso Nazionale ,a premi, di Foto, Disegni, Slideshow, Video e Web Serie, il cui scopo è di diffondere la passione per il cinema e la fotografia e portare alla realizzazione di film non professionali. Nel 2016 si è svolta la quattordicesima edizione , con la tradizionale compartecipazione ed il patrocinio del Comune di Savona che ha offerto gli spazi e quanto necessario per la buona riuscita della manifestazione. Nata da un’idea di Nicolò Zaccarini e di Roberto Usida, vice presidente del Circolo, ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico le opere di autori italiani dando modo a loro di esprimere il proprio talento ad un’ampia platea. L’obiettivo è di dare un piccolo contributo alla cultura nazionale, anche con opere legate a Savona. Un ulteriore segno del suo legame affettivo con la città nella quale si è trasferito da 47 anni da Mazara del Vallo dove è nato il 6 novembre 1946.
Filmografia
- LA MERENDA DI ROSSI 1975/76 Scuola Media “Chiabrera” di Savona
- IL SOGNO DI PACIULLO 1976/77 Scuola Media “Ramella “ di Loano
- HO TROVATO UN AMICO 1977/78 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- UFO? 1978/79 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- E ALLORA QUESTO FILM SI FARA’ O…NON SI FARA’? 1979/80 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- UN’ORA DI GINNASTICA 1980/81 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- ANIMAZIONE 1980/81 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- PAPA’ PERCHE’ FUMI ? 1981/82 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- LA FIGLIA DEL RE 1982/83 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- IL DIZIONARIO 1983/84 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- IL FILM 1985/86 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- SOAP 1985 – Circolo Savonese Cineamatori – Fedic
- DALL’IDEA ALL’IMMAGINE SULLO SCHERMO 1987/88 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- ARIA PULITA 1989/90 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- L’ALLEGRA FARFALLINA 1990/91 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- SCACCO MATTO 1991/92 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- FINALMENTE POSSO ESSERE 1991/92 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- RAGAZZI ALL’OPERA 1993/94 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- SPOT 1994/95 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- TRE PERSONAGGI IN CERCA D’AMORE 1994/95 Liceo Classico “Gabriello Chiabrera” Savona
- RAGAZZI TRA LE LETTERE 1994/95 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- ARDESIA 1995/96 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- L’AMICIZIA E’ IN PERICOLO ? 1997/98 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- DIAMOCI UN TAGLIO 2001/2002 Scuola Elementare “Cristoforo Colombo” Savona
- IN CERCA DI UN’IDEA PER UN FILM 2002/2003 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- LO SPOT CHE FA BENE 2003/2004 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- UN GIORNO DA CAMPIONE 2003/2004 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina
- SAVONA CITTA’ DA SCOPRIRE 1994 UNI tre Savona
- UNO SPORT PER TUTTI 2006/2007 Circolo Savonese Cineamatori – Fedic
- PIACIONE & PIACIONA Lui e Lei 2006 Circolo Savonese Cineamatori – Fedic
- PIACIONE & PIACIONA La Verità 2007 Circolo Savonese Cineamatori – Fedic
- IL TESTAMENTO 2008 Circolo Savonese Cineamatori – Fedic
- SCOMMESSA CON LA MORTE 2009 Circolo Savonese Cineamatori – Fedic
- CHE COSA HAI IN TESTA ? 2010 Circolo Savonese Cineamatori – Fedic
- DELITTO PASSIONAL 2012/2013 Circolo Savonese Cineamatori – Fedic
- (AL) FRED 2016 Circolo Savonese Cineamatori – Fedic
PREMIO CINECLUB FEDIC CAGLIARI
ALLA QUINTA EDIZIONE DEL BABEL FILMFESTIVAL
di Pio Bruno
Dal 4 al 9 dicembre 2017 si è svolto a Cagliari il BABEL Film Festival, il concorso internazionale per il cinema in lingua minoritaria, una vera e propria festa biennale del cinema delle minoranze linguistiche portato avanti dalla Cineteca Sarda – Società Umanitaria di Cagliari, ideato dal suo direttore, Antonello Zanda, assieme ai due autori Paolo Carboni e Tore Cubeddu. E per la seconda volta, la prima durante la scorsa edizione del 2015, il Cineclub FEDIC Cagliari è partner del Festival partecipandovi con un suo premio, un riconoscimento importante per questa associazione culturale cagliaritana, nata nel 1953, che dagli anni ’60 collabora attivamente con la Cineteca Sarda e che negli ultimi anni ha cercato di ampliare e diversificare la propria attività abitualmente volta a valorizzare le opere di autori indipendenti ed a sensibilizzare i giovani all’espressione personale attraverso il linguaggio cinematografico. Quest’anno il Babel Film Festival, alla sua quinta edizione, segna un punto di svolta importante avendo ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa e dell’Unesco, oltre a quello delle massime istituzioni italiane, riconoscimenti che sanciscono la rilevanza sul piano culturale e sociale di questa manifestazione che oggi vanta un archivio di oltre 600 film parlati in lingue minoritarie tra le più disparate del mondo. Una novità: finalmente la RAI ha iniziato ad interessarsi al Festival e per quattro settimane, dal 25 novembre al 16 dicembre, in collaborazione con la Cineteca Sarda, ha trasmesso in orario mattutino su RAI3 una selezione dei cortometraggi in sardo delle cinque edizioni del Babel, all’interno di un programma, Kentzeboghes (Senza voci) per la regia di Serena Schiffini, con Davide Zucca e Pierfrancesco Cadeddu. Il Festival, articolato su diversi eventi, ha permesso la visione di decine di corti selezionati da una giuria formata da registi, giornalisti e personaggi della cultura internazionale (Laura del Colli, Peter Forgacs, Marcello Martinessi, Abeer Nehme, Sergio Naitza, Gary Funck, Vincenzo Santoro), ha visto la partecipazione di registi internazionali (Incontro con il cinema basco) e offerto un concerto (con canzoni in lingue minoritarie, ça va de soi) che ha deliziato il pubblico accorso numeroso al Piccolo Auditorium, spazio dove si è svolta anche la serata conclusiva del festival, il 9 dicembre scorso, presentata dall’attore Simeone Latini. Il primo premio della giuria del Babel se l’è aggiudicato il lungometraggio del regista basco Asier Altuna “Amama“, ma non meno inrteressanti sono stati i lavori premiati dalle altre giurie (formate da diverse associazioni culturali, quella degli studenti dei licei cagliaritani, la FICC, la rivista Diari dei Cineclub). Per quanto riguarda il Cineclub Cagliari, la giuria, formata dai soci, si è riunita qualche giorno prima dell’inizio del BABEL per visionare 7 cortometraggi, in lingua sarda, veneta, siciliana, e altri idiomi, e a fine serata li ha votati. Quest’anno il premio del Cineclub FEDIC se l’è aggiudicato il corto siciliano “Spoon River a Lampedusa” di Rosario Santella, con la seguente motivazione:” Un film emozionante che con stile personale ha rappresentato il drammatico incontro di due mondi, riuscendo a far convivere idiomi diversi, italiano, francese, inglese, siciliano e wolof, nello spazio ristretto di un tratto di mare che si frange sulle spiagge della Sicilia, dimensione spazio/temporale nella quale i suoni e le immagini assurgono a messaggio universale.” Nell’attesa della prossima edizione del BABEL, nel 2019, con il 3° premio del Cineclub FEDIC Cagliari, continueremo a riunirci assieme ai nostri soci per proiettare cortometraggi d’autore e, perché no, proporne la realizzazione, magari nelle scuole, per divulgare questa arte tra i giovani.
Il Palmares del Babel Film Festival:
– Premio “Maestrale” Miglior Lungometraggio:
AMAMA – Asier Altuna (España, 2015, o.l: euskara, subt.: eng., 102′)
– Menzione Speciale Lungometraggio:
LA GUERRA DEI CAFONI – Davide Barletti | Lorenzo Conte (Italia, 2017, o.l.: italiano/griko bizantino/dialetti pugliesi, subt.: eng., 97′)
– Premio “Maestrale” Miglior Documentario:
NUJÎN – Veysi Altay (Türkiye, 2016, o.l.: kurdî, subt.: ita., 50’)
– Menzione Speciale Documentario:
INNER ME – Antonio Spanò (Italia, 2016, o.l.: kiswahili/lingua dei segni, subt.: ita., 22’)
– Premio “Maestrale” Miglior Cortometraggio:
IL SILENZIO – Farnoosh Samadi | Ali Asgari (Italia, 2016, o.l.: english/kurdî, subt.: ita., 14’35”)
– Premio Unica:
BINXÊT / Sotto il confine – Luigi D’Alife (Italia, 2017, o.l.: kurdî/arabo/english/italiano), subt.: ita., 94’)
– Menzione Speciale Unica:
COLOURS OF THE ALPHABET – Alastair Cole (Scotland, 2016, o.l.: soli, nyanja, bemba, english, subt.: srd., 80’)
– Premio Diritto di Parola:
FUTURO PROSSIMO – Salvatore Mereu (Italia, 2017, o.l. subt.:, 18’)
– Premio Italymbas:
OSTANA VIVA, VIVA OSTANA – Elisa Nicoli (Italia, 2017, o.l.: italiano / piemontese / occitano / inglese, subt.: ita., 36’)
– Premio One Wor(l)d:
HALABJA THE LOST CHILDREN – Ekrem Heydo (Deutschland, 2011, o.l.: kurdî, subt.: eng., 72’)
– Premio FICC:
EADRAINN FÉIN [Between us] – Daithí O Cinnéide (Ireland, 2016, o.l.: irish, subt.: eng., 11’11”)
– Premio AAMOD:
IL CLUB DEI CENTENARI – Pietro Mereu (Italia, 2016, o.l.: italiano/sardo, subt.: eng., 32’)
– PREMIO L’AURA:
SU BATTILEDDU – Cinzia Puggioni (Italia, 2014, o.l.: italiano/sardo, subt.: ita., 27’)
– Premio Cineclub FEDIC Cagliari:
SPOON RIVER A LAMPEDUSA – Rosario Santella (Italia, 2017, o.l.: francese/arabo/inglese/dialetto siciliano, subt.: ita., 15’)
– Premio Diari di Cineclub:
BÎRA MI’ TÊTIN – Selim Yıldız (Turkiye, 2016, o.l.: kürtçe, subt.: eng., 38’)
RITORNO IN ATTIVITÀ DEL CINECLUB FEDIC FERRARA
di Giorgia Pizzirani
Dopo una pausa forzata di 8 anni ha ripreso, nel 2017, la propria attività il Cineclub FEDIC Ferrara.
Attivo già dal 1953, con la Presidenza di Giorgio Piacentini e successivamente di Fabio Medini, il Cineclub ha vissuto con la guida di Anna Quarzi prima e poi Marco Felloni fino al 2010 trenta anni di soddisfazioni e riconoscimenti, come i due premi consecutivi come miglior Cineclub nel 1981 e 1982; ma a dire il vero lo aveva già conquistato nel 1956 agli albori della Federazione.
Sono decine gli autori premiati che hanno militato nel Cineclub, senza far torto a nessuno ricordiamo Massimo Sani, Ezio Pecora, Renzo Ragazzi, Antonio Bonetti, Giuseppe Gandini, anche due volte Nastro d’Argento, Roberto Fontanelli, Carlo Magri, Valerio Vicentini e Andrea Barra.
Un mancato ricambio generazionale unito a una repentina evoluzione delle tecnologie ha portato un prima a un lento declino e poi a una chiusura dei battenti nel 2010, in concomitanza con la scomparsa di Marco Felloni, presidente ma anche autore di innumerevoli corti e lungometraggi.
Dal forte impulso di soci storici e pilastri della FEDIC in ambito nazionale come Paolo Micalizzi (che ha assunto anche la carica di Presidente Onorario) , Carlo Magri e Roberto Fontanelli è nata l’idea, poi realizzata, di riformare il Cineclub offrendo la carica di Presidente in un simbolico passaggio di testimone a Federico Felloni, grande appassionato di cinema che non poteva esimersi da un incarico portato avanti per decenni da suo padre.
Il Cineclub ha scelto simbolicamente(g.c.) il Circolo Negozianti di Ferrara, sede storica già nel lontano 1954, come location del primo evento a sigla della ripresa della attività. Nel dicembre 2016 si è organizzato a latere della presentazione del volume di Paolo Micalizzi L’Orlando Furioso e il suo mondo nel cinema italiano una proiezione di spezzoni d’epoca del mondo ariostesco nel cinema italiano. Omaggio all’Ariosto per i 500 anni della creazione del suo capolavoro ambientato proprio a Ferrara.
Nei mesi a seguire, oltre a un progetto editoriale curato sempre da Paolo Micalizzi, Autori FEDIC alla ribalta, presentato a marzo nel corso dell’assemblea nazionale FEDIC a Montecatini e successivamente al Forum Fedic di Venezia, si è proposto una serie di proiezioni di autori FEDIC come Franco Piavoli, Piero Livi e Francesco Giusiani che hanno coinvolto un discreto numero di spettatori appassionati.
La conclusione di questo primo anno di rilancio è stata una personale di Nedo Zanotti, ferrarese di origine e maestro del cinema di animazione, autore di sigle RAI e illustratore che ha presentato una serie di suoi cortometraggi di animazione. Nel corso dell’incontro l’assessore alla Cultura e vice sindaco del Comune di Ferrara, Massimo Maisto, ha consegnato un riconoscimento a Nedo per il lustro dato negli anni alla città di Ferrara in Italia e nel mondo, rimarcando la soddisfazione anche a livello istituzionale per la rinascita e ripresa in città delle attività dello storico Cineclub.
Tra grosse difficoltà, in primis nel sensibilizzare appassionati a nuovi tesseramenti e in particolare nel creare una nuova leva di autori che sappiano destreggiarsi con le nuove tecnologie aggirando però le insidie della facile visibilità on line, il Cineclub sta organizzando per il 2018 un Festival delle colonne sonore, unico nel suo genere in Italia che si auspica entri fra gli eventi principi della Federazione.
Brindiamo al futuro del rinato Cineclub FEDIC Ferrara.
FESTIVAL ED EVENTI
UNA MOSTRA DI ALTO LIVELLO CON UN “LEONE D’ORO” CONDIVISO
di Paolo Micalizzi
Mostra bagnata, Mostra fortunata, parafrasando il vecchio detto “Sposa bagnata, sposa fortunata”. La pre-inaugurazione all’Arsenale con “Dunkirk” è stata infatti contrassegnata da una pioggia battente, quasi un diluvio, che ha un po’ rovinato la visione di un film spettacolare come quello diretto da Christopher Nolan. Un film che racconta la battaglia di Dunkerque, l’evacuazione di 400.000 soldati britannici schiacciati dall’offensiva tedesca sulle spiagge di fronte alla Manica. Ciò avvenne grazie a centinaia di imbarcazioni civili, a rischio della vita, che riuscirono a portare a casa oltre 300.000 uomini. Non una riflessione su quell’evento della Seconda guerra mondiale, ma un film all’insegna di quel realismo spettacolare cui siamo abituati dai “War-movies” alla “Salvate il soldato Ryan”. Una scelta indovinata, come indovinata è stata l’idea del padrino Alessandro Borghi, attore rivelatosi con ”Non essere cattivo” di Claudio Caligari, ed interprete di film con registi di nuova generazione. Una presenza, la sua, sia nella cerimonia di inaugurazione che in quella di chiusura, sobria e misurata imperniata sul suo amore per il cinema.
Verdetto per il “Leone d’Oro” che ha soddisfatto anche la critica quello attribuito al film “The shape of water” (La forma dell’acqua) alla 74.Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film di Guillermo Del Toro è stato proiettato nei primi giorni della prestigiosa Kermesse veneziana e man mano che si procedeva nelle proiezioni era nostro convincimento che a trionfare nel massimo premio sarebbe stato il film del regista messicano, anche se la graduatoria stilata nei giorni successivi dal daily “Ciak in Mostra” ,che segnalava le preferenze dei critici italiani, indicava che poteva essere contrastato da “Three Billboards outside Ebbing, Missouri” (Tre manifesti a Ebbing, Missouri) di Martin McDonagh a cui alla fine la Giuria ha attribuito il premio per la migliore sceneggiatura. La nostra preferenza al film di Guillermo Del Toro scaturiva dal fatto che trattavasi di un film che affrontava un tema politico, la guerra fredda, attraverso un fantasy romantico, coinvolgendoti appieno nella storia ambientata in un laboratorio segreto dove la muta e mite Sally entra in contatto, innamorandosene, con una creatura misteriosa, un mostro della laguna con emozioni umane.
Anche se il thriller intriso di humour nero di Martin McDonagh intriga in maniera in maniera notevole. Un film incentrato su una donna che dopo mesi trascorsi, senza riuscirci, a trovare il colpevole dell’omicidio della figlia, noleggia tre cartelloni pubblicitari sui quali con un chiaro messaggio sfida lo stimato capo della polizia locale. Nel caso viene poi coinvolto anche il suo vice, uomo dal temperamento violento e aggressivo e lo scontro con le forze di polizia diventa più duro. Film che appassiona poiché immerge lo spettatore nelle zone oscure della condizione umana. Poteva ottenere, in effetti, almeno il “Leone d’Argento” per la migliore regia attribuito invece al regista francese Xavier Legrand per il film “Jusqù’à la garde”( Fino alla custodia)che come esordiente ha vinto anche il premio “De Laurentiis” per l’opera prima: un film sulla violenza sulle donne premiato più per la tematica attuale trattata che per la sua realizzazione. La vicenda si svolge attorno al tema dell’affido. Myriam e Antoine hanno divorziato e la donna cerca di ottenere l’affido del figlio per proteggerlo da un padre che ritiene violento. Ma Antoine protesta e il giudice decide per l’affido congiunto. Ma il figlio non è d’accordo poiché diventa giocoforza il testimone sensibile di un matrimonio fallito che si contende la sua felicità. Una realizzazione che lascia un po’ perplessi. Meritato il premio a Charlotte Rampling per il film di Andrea Pallaoro “Hannah” , un’opera pensata dal regista sul talento dell’attrice che qui interpreta il ruolo di una donna, governante nella casa di una ricca signora, il cui figlio piccolo è non vedente condividendone la quotidianità con il marito.
Ma quando il coniuge finisce in prigione, le cose cambiano e lei è messa al bando dalla collettività. Il regista ne esplora la sua identità frantumata e la sua perdita di autocontrollo compiendo un viaggio nel dolore interiore. Premio per il miglior attore a Kamel El Basha, interprete del film “The insult” di Ziad Doueiri che affronta un tema forte, le fratture sociali in Libano. L’insulto è quello che vola fra un libanese cristiano e un rifugiato palestinese, che farà scaturire un processo che scoperchia pregiudizi e ipocrisie. Il premio per il miglior attore/trice emergente è andato invece a Charlie Plummer interprete del film “Lean on Pete” di Anderew Hiagh, con protagonista un quindicenne che grazie alla simpatia e amicizia con un vecchio cavallo trova il coraggio di vivere nella dura realtà famigliare. Tra in film visti mi piace segnalare quelli di due grandi maestri del cinema. “Human flow” del cinese Aio Weiwei , è un’opera che dà valore ai diritti umani attraverso un viaggio nella migrazione di massa odierna, testimoniata da situazioni colte in ventitré Paesi che mettono in luce tante storie disperate alla ricerca di salvezza, rifugio e giustizia ponendosi la domanda se la società globale d’oggi riuscirà ad avere rispetto per l’umanità con un percorso d’apertura e di libertà. Peccato che sia un po’ dispersivo perdendosi anche nell’estetismo, non facendo arrivare il messaggio con incisività. In “Ex libris”, Frederick Wiseman va dietro le quinte della “The New York Public Library”, una delle più grandi istituzioni del sapere del mondo, mostrandola come un luogo di accoglienza, scambio culturale e apprendimento per diciotto milioni di utenti e trentadue milioni di visitatori online all’anno. Partecipano alla sua vita attiva e al suo funzionamento persone di tutte le razze, classi sociali ed etnie. Una grande lezione di democrazie alla cui scoperta ci porta lo sguardo di Wiseman continuamente stimolato ad esplorarla.
Non si può poi non segnalare la delusione di un film come “mother!” di Darren Arofonofsky nella cui carriera vi sono opere di un certo interesse. Il regista nel mostrare lo scompiglio in cui una coppia si trova per l’arrivo di alcuni ospiti inattesi si lascia prendere la mano da ogni tipo di violenza, onde sottolineare, nel suo intento, la follia di chi domina il mondo moderno. Una visione, all’insegna degli eccessi, non accettabile. Ben diversi, e più convincenti, i toni del film “La villa” di Robert Guédiguian, incentrato anch’esso su uno scompiglio che si verifica in una famiglia al capezzale dell’anziano genitore giunto ai suoi ultimi giorni di vita. La riflessione sul bilancio dei loro ideali e dello spirito comunitario che il padre aveva creato viene messa in crisi dall’arrivo nell’insenatura della villa di un gruppo di profughi, una famiglia che darà nuova vita a quel luogo ormai statico, pieno di malinconia. L’America degli anni Cinquanta, razzista e ipocrita è in “Suburbicon” di George Clooney, dietro e dentro la macchina da presa. Una commedia noir che richiama il presente. Un’opera che convince, cosi come “Downsizing” ( Riduzione) di Alexander Payne, incentrata sul problema della sovrappopolazione.
Un problema che alcuni scienziati norvegesi propongono di risolvere , nel giro di duecento anni, rimpicciolendo le persone a una decina di centimetri con la promessa di una vita migliore, grazie ai vantaggi economici di un mondo in miniatura. Due coniugi (Matt Damon e Kristen Wiig) decidono di aderire alla proposta per abbandonare la loro stressante esistenza a Omaha facendosi rimpicciolire e trasferirsi in una nuova comunità in miniatura. Ma lei , all’ultimo momento, si ritirerà da quella che poi si rivelerà un’avventura che cambia la vita per sempre.
Significativi anche i premi attribuiti nelle altre sezioni della Mostra. In “Orizzonti” ha vinto “Nico,1988” di Susanna Nicchiarelli, biopic che guarda alla parabola esistenziale di Christa Paffgen, nota ai più come Nico. La regista segue gli ultimi due anni di vita (1987-1988) della musicista tedesca (interpretata dalla danese Trine Dyrholm) che cantò con i “Velvet underground”. Un film che ha dato gloria all’Italia, che quest’anno alla Mostra ha ben figurato. Avrebbe potuto benissimo figurare in Concorso, cosi come “La vita in comune” di Edoardo Winspeare che non ha ottenuto premi al Concorso ma che ne ha avuto Collaterali come il “Premio Fedic” attribuitogli “perché nel racconto delle vicende del paesino di Disperata riesce a trasformare situazioni drammatiche in commedia di valore universale”. L’inventato paesino del Sud Disperata è il luogo in cui vivono persone che l’arte riuscirà a cambiare nella loro identità: il Sindaco Filippo che insegna in un carcere dove conosce Pati, ed il fratello di quest’ultimo Angiolino. I due fratelli subiranno una vera e propria conversione alla poesia e alla bellezza del creato. Il cambiamento dei tre segnerà la rinascita civile di tutta la comunità.
E la comparsa della foca monaca ne sarà un chiaro segnale. Ha avuto premi (miglior regia) , invece, il film dell’iraniano Vahid Jalilvand “ Senza data, senza firma” che pone al protagonista, un anatomo-patologo, un caso di coscienza: il bambino di 8 anni è morto dopo un incidente per causa sua o per avvelenamento da cibo come sostiene la diagnosi di altri medici? Nella Sezione “Orizzonti” figurava quest’anno anche il Concorso Cortometraggi. Tra le 12 opere presentate la preferenza della Giuria è andata al cortometraggio d’animazione “Gros Chagrin”(Grande dolore) della francese Cèline Devaux incentrato sul flusso di coscienza di una persona che riflette sulla recente rottura di una relazione. Il cortometraggio ha anche ricevuto il “Venice Short Film Nomination for the European Awards 2017”. Nella SIC@SIC della Settimana Internazionale della Critica, giunta alla 32. Edizione, la vittoria ( Premio del pubblico che ha votato con apposite schede) è andata al film “Temporada” de Caza” di Natalia Gargiola, film intimista incentrato su una relazione impossibile fra padre e figlio. Nell’altra sezione autonoma e parallela, “Le Giornate degli Autori” la Giuria, presieduta dalla regista iraniana Samira Makhmalbaf, ha premiato il film ”Candelaira” del colombiano Johnny Hendrix Hinestroza, opera drammatica su una coppia di sessantenni ,in una Cuba dove si annega nel rum e si soffoca tra fame e sigari, la cui vita cambia dopo il ritrovamento da parte di lei di una telecamera analogica HB che nel consentire una reciproca osservazione fa sbocciare di nuovo l’amore. Ma la felicità non sarà come pensavano.
La novità di quest’anno alla Mostra di Venezia è stata la Sezione competitiva “ Venice Virtual Reality”. Una realtà molto viva, come affermato in Conferenza Stampa” a Roma dal Direttore Artistico Alberto Barbera che si è dichiarato stupito di aver ricevuto più di 100 proposte di cortometraggi, lungometraggi e installazioni(interattive e non) tra i quali scegliere i 22 titoli da sottoporre al giudizio di una Giuria internazionale e degli spettatori che avrebbero frequentato il nuovo spazio appositamente allestito sull’isola del Lazzaretto Vecchio di fronte al Lido di Venezia, nelle vicinanze del Palazzo del Cinema. Un recupero che fa parte del progetto di rinascita della Cittadella del Cinema al Lido, fortemente voluta dal Presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta.
La Giuria internazionale del “Venice Virtual Reality”, presieduta dal prestigioso regista John Landis, ha premiato “Arden’s wake”(L’attesa di Arden) di Eugene Yk Chung, un’opera che in 16 minuti racconta di una giovane donna e del padre che vivono in un faro arroccato dove domina un mare sconfinato: una rappresentazione da mondo apocalittico. Una sezione,“Venice Virtual Reality, che è un chiaro segnale che la Mostra di Venezia guarda al futuro. Lo testimonia anche il fatto di attribuire al vincitore un Leone d’Oro.
Da evidenziare alla Mostra un’ampia presenza del cinema italiano, che ha ben figurato anche nel cortometraggio e nel documentario, dove in particolare, tra le opere viste, abbiamo apprezzato il corto ”Casa d’altri” di Gianni Amelio sul dramma della popolazione di Amatrice che oggi pensa alla ricostruzione; il documentario di Wilma Labate “Raccontare Venezia”( Giornate degli Autori), liberamente tratto dal libro “Storie di cinema a Venezia” di Irene Bignardi. In esso la giovane attrice Silvia D’Amico accompagna lo spettatore per calli, campi, fondamenta, ponti, chiese, luoghi più o meno conosciuti della città compreso il “bacaro” a mangiar “cichetti” o bere “un’ombra”. Ma anche “ La lucida follia di Marco Ferreri” in cui ci s’immerge in un universo creativo tanto originale e violento nella sua verità, quanto potente. E’ stato presentato nella Sezione “Classici” su cui si sofferma ampiamente, in questo stesso numero, Vittorio Boarini. Oltre 20 i lungometraggi . La Giuria di “Venezia 74”, Sezione principale della Mostra ha premiato soltanto l’interpretazione di Charlotte Rampling per il film “Hannah” di Andrea Pallaoro attribuendole la Coppa Volpi e la Sezione “Orizzonti” ha assegnato il premio per il Miglior film a “Nico, 1988” di Susanna Nicchiarelli, ma altre le opere del cinema italiano premiate dalle Giurie dei Premi Collaterali. “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini ha avuto ben quattro riconoscimenti, mentre il film d’animazione “Gatta Cenerentola” di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone ne ha portati a casa tre. Due premi per “L’equilibrio” di Vincenzo Marra che si è aggiudicato anche il Premio Imaie per l’interpretazione dell’esordiente Mimmo Borrelli mentre quella per l’interpretazione femminile è andata a Federica Rosellini per “Dove cadono le ombre”, due premi per “Ammore e malavita” dei Manetti Bros ed uno per “Brutti e cattivi” di Cosimo Gomez. Particolarmente importante, perché attribuito dai giovani giurati, è il “Leoncino d’Oro” al film di Paolo Virzi “ The Leisure Seeker”, film che affronta il tema dell’eutanasia sullo spunto dell’omonimo romanzo di Michel Zaoodorian. Un film commovente nella semplicità con cui narra una storia d’amore intrisa di vecchie gelosie e rancori ma piena di passione e devozione. Un film che mescola umanità, commedia e tragedia, in chiave road- movie , sulla libertà di scegliere ogni istante della propria vita, contro pareri contrastanti. Un film in cui Virzì si misura per la prima volta con attori e storie made in USA, dimostrandosi all’altezza della situazione per la maniera in cui volge lo sguardo alla realtà americana. Lo interpretano due grandi attori, Helen Mirren e Donald Sutherland, ovvero Ella e John nel titolo italiano.
Sono premi da prendere in seria considerazione perché espressi da appassionati di cinema e cinefili le cui scelte sono ben calibrate. E costituiscono un valore aggiunto ad una Mostra. Ma la ciliegina sulla torta di “Venezia 74” che, per ampio giudizio, è stata di grande livello era rappresentata dal “Leone d’Oro” alla carriera a Jane Fonda e Robert Redford, due Mostri sacri del cinema, che hanno fatto commuovere e divertire gli spettatori di tutto il mondo. Un’esistenza, la loro, all’insegna della libertà e scevra da ogni forma di conformismo.
Per il 24° anno la FEDIC è stata presente alla Mostra di Venezia con il Premio ed il Forum Fedic, giunto alla 22.a edizione. Come detto il Premio è stato attribuito al film di Edoardo Winspeare “La vita in comune” . La Giuria, presieduta da Ugo Baistrocchi, ha voluto poi premiare con una Menzione speciale il film di Susanna Nicchiarelli “Nico, 1988” con la seguente motivazione: ”Perché racconta senza indulgenza, con un’analisi dolente e partecipata la parabola esistenziale di Christa Paffgen, nota ai più come Nico, una donna di mezza età che rifiuta la vita normale ed è rifiutata dai conformisti, ma in un momento di riscoperta e di rilancio internazionale viene stroncata da una improvvisa e prematura morte”. Per il quarto anno poi è stata assegnata una Menzione FEDIC- Il Giornale del Cibo “ destinata all’opera che propone la scena più significativa legata al cibo e alla alimentazione al cortometraggio “Le visite” di Elio Di Pace( “Settimana della Critica –SIC@SIC”) “ perché il cibo, la sua preparazione, sono parte integrante del cortometraggio che è ambientato in una cucina dove una madre e una zia preparano pasta al forno e pacchi di caffè da portare al figlio e nipote detenuto a Poggioreale”. E sottolineando anche che “l’abilità tecnica del regista fonde la raffinata immagine retrò utilizzata e rende drammatica una preparazione culinaria che ha n tragico epilogo fuori campo”.
Il Forum Fedic, giunto alla ventiduesima edizione, era incentrato sul tema “Autori Fedic alla ribalta e in Cineteca”, in riferimento alla pubblicazione del volume di chi scrive “Autori Fedic alla ribalta” che sottolinea l’attività di alcuni Autori che hanno realizzato film nell’ambito della Federazione Italiana dei Cineclub, e al trasferimento della Cineteca FEDIC nell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea. Un Forum, aperto anche quest’anno con la prestigiosa presenza di Luigi Cuciniello (Direttore Organizzativo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia) che, portando il saluto della Mostra, ha sottolineato l’importanza del lavoro della FEDIC nel promuovere la produzione di opere non omologate alla produzione e alla distribuzione delle grandi case internazionali. Aggiungendo che la valorizzazione di questo tipo di attività è un impegno permanente della Mostra di Venezia. Che la FEDIC sia una Federazione attiva nella cultura e nella produzione è stato ribadito nella relazione del Presidente Lorenzo Caravello, che ha evidenziato come il suo obiettivo principale sia la promozione e la divulgazione della cultura cinematografica con produzione e distribuzione di film. Ha inoltre sottolineato che la FEDIC ha due organi ufficiali di stampa: Carte di Cinema online, diretto dal 2015 da Paolo Micalizzi, che si avvale della collaborazione di importanti nomi della critica italiana e di giovani studiosi di cinema che nel 2016 ha ricevuto il prestigioso premio “Domenico Meccoli”-Scrivere di Cinema” con la seguente motivazione: “Per uno stile chiaro e rigoroso con il quale riesce a stabilire un dialogo proficuo con un pubblico vario ed eterogeneo quale quello dl web”; “nuovo FEDIC Notizie”, un notiziario, che è un altro importante strumento di informazione e formazione, a cura di Giorgio Sabbatini, che raccoglie e coordina notizie provenienti dai vari Cineclub FEDIC. Ha anche evidenziato la divulgazione e l’insegnamento del linguaggio cinematografico in ambito scolastico attraverso FEDIC Scuola di cui è responsabile nazionale, dal 2013, Laura Biggi. Tra le iniziative di rilievo organizzate periodicamente, Rassegne, Laboratori di Cinema , Festival di rilevanza nazionale ed internazionale e, la grande innovazione del Campus residenziale per ragazzi “Naturalmentecinema”, giunto al quarto anno. Su “ La Cineteca FEDIC all’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea” ha riferito il suo direttore Sergio Toffetti che ha evidenziato come quella struttura negli anni ha visto crescere esponenzialmente le sue collezioni grazie a convenzioni di deposito stipulate con altri archivi e con privati per la conservazione del patrimonio filmico. L’accordo con la FEDIC si colloca in quest’ambito e porterà , la digitalizzazione è già in atto, a conservare opere di decenni passati( pellicole in 8, Super8 e 16mm., VHS, DVD). In questo modo è possibile mettere tutto questo materiale a disposizione di quanti sono interessati a consultarlo, in formati utilizzabili dalle tecniche odierne di visione. Dopo l’intervento di chi scrive che ha evidenziato come “Autori FEDIC alla ribalta” sia il primo volume di un progetto, a sua cura , volto ad elaborare un Storia della FEDIC attraverso i suoi Autori e i suoi Cineclub, sono stati proiettati alcuni cortometraggi di autori FEDIC.

Il tavolo dei relatori al Forum FEDIC: da sin. Luigi Cuciniello, Sergio Toffetti, Lorenzo Caravello, Paolo Micalizzi (Foto, Laura Biggi)
A presentare “ ‘A livella’ di Beppe Rizzo e “Tre fogli” di Giorgio Sabbatini ha provveduto Paolo Micalizzi con la lettura di testi dei due autori assenti, mentre gli altri sono stati introdotti dai rispettivi realizzatori: Laura Biggi, “Un’avventura mostruosa” di Laura Biggi- Lorenzo Caravello; Ettore Di Gennaro,”Polvergeist”; Giorgio Ricci, “Ladro di biscotti”; Nedo Zanotti, “African patchwork”. “L’affondamento del Giudecca” di Enrico Mengotti ha avuto anche la testimonianza di alcuni parenti degli scomparsi.
Una Mostra in cui anche questa volta sono emerse tematiche più ricorrenti delle società odierne, la famiglia, l’emigrazione, la sovrappopolazione, la guerra, la vecchiaia, il mondo della droga, il razzismo , la violenza alle donne.
Un Festival che ha tenuto presente la critica, ma anche il pubblico che non è più composto solo di addetti ai lavori. E la costante presenza di giovani sin dal mattino sul Red Carpet che poi nelle ore di punta della “sfilata” s’infoltisce di persone di ogni età , è significativa di un interesse non solo verso i Divi ma per il cinema in generale che anche la Mostra di Venezia consente loro di soddisfare. E non è cosa da poco tenere presente anche questo aspetto nelle scelte da portare avanti.
IL CINEMA DEL PASSATO E LA SUA ATTUALITA’: VENEZIA CLASSICI
di Vittorio Boarini
La 74. Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica ci ha consentito, con la ormai consolidata sezione Venezia Classici (una rassegna, istituita nel 2012, di film restaurati e documentari sul cinema), di rivolgere uno sguardo critico all’universo cinematografico attraverso le opere che richiamano il suo passato e ne mostrano l’attualità. Abbiamo avvertito, già la sera della pre-apertura, come perfino le pellicole mute, pur mantenendo il loro spessore storico, possano essere perfettamente inserite nel quadro del cinema contemporaneo. La pre-apertura, infatti, ha coinciso con l’anteprima inaugurale di Venezia Classici avvenuta con la proiezione di “Rosita”, il primo film americano di Ernst Lubitsch, girato nel 1923 e, fino agli anni sessanta, ritenuto perduto. Un’anteprima eccezionale, sottolineata dall’accompagnamento musicale effettuato dalla Mitteleuropa orchestra del Friuli sotto la esemplare direzione di Gillian Anderson, una musicologa di riconosciuto talento, che ha ricostruito filologicamente la partitura originale conservata presso la Library of Congress di Washington. Ma eccezionale anche per averci fatto vedere, dopo quasi un secolo dalla prima americana, il film che segna una svolta nella carriera di Lubitsch, noto fino ad allora per i suoi kolossal di carattere storico girati in Germania, e il definitivo decollo di Mary Pickford. Chiamato a Hollywood dalla stessa Pickford, che desiderava interpretare un dramma elisabettiano sotto la direzione di un affermato regista europeo, Lubitsch, che per lei aveva in mente il Faust di Goethe, è costretto a una defatigante trattativa finita nel compromesso di “Rosita”, tratto da Don César de Bazan, una commedia del 1844 di Adolphe d’Ennery e Philippe François Pinel detto Dumanoir.
Nonostante il successo pieno del film e gli elogi che il regista e la diva si scambiarono pubblicamente durante e dopo la sua lavorazione, i due non collaborarono mai più e la loro unica pellicola andò perduta, quasi certamente con la complicità della Pickford, che ne conservò per sé solo la quarta bobina. Fortunatamente e fortunosamente ne venne ritrovata una lacunosa copia nitrato negli archivi sovietici, copia consegnata al MoMA di New York, che, dopo anni di ricerche storico-filologiche, ha potuto restaurarla ricavandone una copia numerica molto simile all’originale. Bisogna notare che il personaggio, da cui deriva il titolo della commedia francese ambientata in Spagna, lo troviamo già nel famoso lavoro teatrale Ruy Blas (1838) di Victor Hugo, mentre, fatto ancor più singolare, sempre quel personaggio dà il titolo al film d’esordio di Riccardo Freda, uscito nel 1942, con la sceneggiatura di Zavattini e Brancati, esibendo un cast con Gino Cervi e Paolo Stoppa. Ma le sorprendenti coincidenze non sono finite: il protagonista maschile di “Rosita”, interpretato dall’avvenente fratello di Raul Walsh, è condannato alla fucilazione dal re libertino di un reame spagnolesco d’epoca imprecisata.
Per amore di Rosita, cantante di strada, il re promette che le armi del plotone d’esecuzione saranno caricate a salve, ma non ha alcuna intenzione di mantenere la promessa. Richiamo l’attenzione sulla curiosa analogia con Mario Cavaradossi, del quale il capo della polizia pontificia promette a Tosca la salvezza con identico stratagemma, promessa che, come sappiamo bene, non manterrà. “Illica e Giacosa, librettisti della Tosca (1900) di Puccini, avevano preso quell’idea, ovviamente, da Victorien Sardou (La Tosca, 1887), ma questi, a sua volta, come l’aveva avuta?”. Non lo sappiamo, ma sappiamo che nel nostro film, grazie all’intervento di una regina intelligente, l’esecuzione sarà veramente finta e il lieto fine assicurato. Da un folclore sapientemente inventato con canti, giochi amorosi e gesta avventurose traspare la struttura della commedia sofisticata che renderà famoso Lubitsch e il suo “tocco”, già perfettamente percepibile.
Dopo l’inaugurazione dobbiamo soffermarci su un altro evento di grande impatto, il restauro di “Novecento”, capolavoro di Bernardo Bertolucci del 1976, realizzato dalla Cineteca di Bologna nel proprio laboratorio con l’attiva partecipazione di Bertolucci stesso. Tutti conoscono le avventure produttive e distributive di questo film, che ha sempre circolato diviso in due atti, ma non tutti sanno che l’opera, come ci ha confermato il regista parlandoci dallo schermo perché un’indisposizione gli ha impedito di essere a Venezia personalmente, presentava ben settecento tagli, molti dei quali andati perduti e ricostruiti digitalmente. Un’impresa titanica, durata diversi anni, che ci ha restituito integralmente le cinque ore e venti del metraggio originalmente voluto da Bertolucci. L’affascinante sventolio di bandiere rosse, anche il restauro del colore ha un ruolo fondamentale, contribuisce a restituirci la forza espressiva di questo affresco, che evidenzia drammaticamente un aspetto distintivo del Novecento: l’affacciarsi del proletariato alla ribalta della storia come protagonista. Una realtà resa in forma artistica anche da Pelizza Da Volpedo nella famosa tela Il quarto stato, ma che sullo schermo Bertolucci, con l’uso sapiente del linguaggio cinematografico, ha arricchito di tutte le sue determinazioni inserendola nel “naturale” contesto della lotta di classe. I braccianti e i contadini poveri dell’Emilia, in realtà del mondo, diventano proletari, classe antagonista, assumendo un ruolo storico che si riflette in tutta la loro vita, anche in quella più intima degli affetti, dell’amicizia e dell’amore. Nella sua seconda vita, il film ha intensificato la forza emotiva con cui cattura lo spettatore e lo costringe a pensare la realtà del mondo, anche di quello presente. Non possiamo concludere su questo punto senza citare un documentario della rassegna,” Evviva Giuseppe”, dedicato al fratello di Bernardo, morto nel 2012. Il bellissimo filmato di Stefano Consiglio, infatti, nel mettere in piena luce le qualità artistiche, culturali e umane di Giuseppe, lo mostra, assieme al fratello e a Kim Arcalli, mentre partecipa alla elaborazione della sceneggiatura di “Novecento”.
 Bernardo, poi, evidenzia, con accenti di autentica commozione, la qualità del suo contributo e non soltanto per quanto riguarda “Novecento”. Aggiungiamo che questo non è il solo dei documentari presentati ad avere attinenza con i classici restaurati, ma prima di aprire questo discorso passiamo agli altri tre film italiani compresi nella rassegna, tutti di grande rilievo.
Bernardo, poi, evidenzia, con accenti di autentica commozione, la qualità del suo contributo e non soltanto per quanto riguarda “Novecento”. Aggiungiamo che questo non è il solo dei documentari presentati ad avere attinenza con i classici restaurati, ma prima di aprire questo discorso passiamo agli altri tre film italiani compresi nella rassegna, tutti di grande rilievo.
Cominciamo con “Il deserto rosso” (1964) di Michelangelo Antonioni, rilevando, in primo luogo, che anche in questo caso il restauro del colore ha richiesto un particolare impegno data l’importanza che, come più volte ha dichiarato Antonioni stesso, hanno i cromatismi di ogni singola scena per l’armonia narrativa dell’intera opera. Giustamente il CSC-Cineteca Nazionale, che, in collaborazione con Istituto Luce e Cinecittà, ha curato l’operazione, ha chiesto la supervisione di Luciano Tovoli per restituire al film il tono fotografico voluto dal regista e dal suo direttore della fotografia Carlo Di Palma (al quale Fariborz Kamkari ha dedicato un puntualissimo documentario, “Acqua e zucchero-Carlo Di Palma: i colori di una vita”, visto l’anno scorso proprio in Venezia Classici). Il colore, infatti, per Antonioni non ha una funzione mimetica, ma, analogamente a quanto succedeva per il cinema muto, espressiva, come risulta chiaramente anche dal contrasto tra le sequenze luminose (ad esempio la spiaggia sarda di Budelli) e quelle nebbiose del grigio petrolchimico di Ravenna, contrasto che rivela anche le contraddizioni del moderno, della società contemporanea nei suoi molteplici aspetti.
Un altro impatto emotivo ci ha riservato “La donna scimmia”, un film di Marco Ferreri restaurato dalla Cineteca bolognese. Per la prima volta, infatti, abbiamo visto i tre finali dell’opera, una favola grottescamente buffa, ma profondamente amara. Il finale voluto dal produttore Ponti quando il film uscì nel 1966 (la donna pelosa, Annie Girardot, muore di parto e il neonato non le sopravvive); quello voluto dal regista quando la pellicola fu riedita (il marito, Ugo Tognazzi, imbalsama i due cadaveri e li esibisce a pagamento in un baraccone); quello a lieto fine per il distributore francese (la moglie partorendo perde i peli, il bambino è normale e il marito trova lavoro come portuale). Il sorriso che suscita la vicenda, nella quale si avverte una eco bunueliana, si raggela di fronte alla tragica realtà di un contesto sociale in cui anche i “cari estinti” vengono portati al mercato per ricavarne denaro. Anche “La donna scimmia” è stato contrappuntato da un intelligente documentario, “La lucida follia di Marco Ferreri”, realizzato da Anselma Dell’Olio, che ripercorrendo la vicenda creativa del regista ci invita, con irresistibile insistenza, a riscoprire il suo cinema. Infine, per concludere sulla presenza dell’Italia nella rassegna, “Non c’è pace fra gli ulivi”, un’opera di Giuseppe De Santis del 1950, dalla quale non si può prescindere se si rivolge retrospettivamente lo sguardo alla grande stagione del neorealismo. Interpretato da Raf Vallone e dall’esordiente Lucia Bosè, il film, ottimamente restaurato dal CSC-Cineteca Nazionale, costituisce un esempio alto, forse ancor più del precedente “Riso amaro”, della particolare versione nazional-popolare che del neorealismo ha dato De Santis. Versione nazional-popolare non contraddetta, in questo caso, da una vena brechtiana che fa crescere lo spessore culturale di questo romanzo corale dei pastori ciociari in lotta per la giustizia.
Non per spirito di parte degli organizzatori l’Italia era presente con quattro opere, gli Stati uniti, infatti, lo erano con cinque, come la Francia, considerando anche il corto di Jean Rouch e una coproduzione. Di “Rosita” abbiamo detto, degli altri film USA, comprendenti opere come “Incontri ravvicinati del terzo tipo” (1977), di Steven Spielberg, un punto di riferimento per quel cinema di fantascienza che, per forza critica, va al di là del genere stesso, riteniamo di doverci soffermare su “Il castello maledetto” (“The Old Dark House”, 1932), un horror di James Whale, l’autore di “Frankenstein” (1931) e “L’uomo invisibile” (1933). Si tratta, infatti, di un’opera esemplare, nel suo genere, perché fonte di ispirazione di molte altre, ma anche particolare per l’abilità con cui l’autore intreccia suspence e humor fino a delineare una satira di costume. Non casualmente Bernard Tavernier lo ha definito “una commedia macabra”. Ciò non significa che il divertente “Into the night” (“Tutto in una notte”, 1985) di John Landis, presente alla proiezione, e la vicenda spregiudicata di “Femmina ribelle” ( “The Revolt of Mamie Stover”, 1956), del prestigioso Raul Walsh, non abbiano ben figurato nella rassegna, ma riteniamo sufficiente segnalarle ai lettori perché non le perdano quando verranno rimesse in circolazione.
Abbiamo accennato alla rilevante presenza di film francesi, dei quali va subito indicato “Due o tre cose che so di lei” (“Deux ou trois choses que je sais d’elle”,1966), una delle pellicole più significative di quel grande innovatore che, soprattutto negli anni sessanta, è stato Jean-Luc Godard (“Il mio Godard”, recente opera del pur bravo Michel Hazanavicius, non gli rende, a mio avviso, del tutto giustizia). Dal suo distacco dalla Nouvelle vague, della quale era stato uno dei fondatori, all’impegno politico (“fare politicamente un film”), quando si fonde nel gruppo Dzigz Vertov , Godard gira alcune opere nelle quali la ricerca linguistica diviene un’acuta e penetrante critica sociale. L’opera in questione, interpretata magistralmente da Marina Vlady, ne è un esempio straordinario, dove la lei di cui il regista sa due o tre cose è, alla fine, la società, una tragica realtà della quale il film è il modello teorico. Anche “L’occhio del maligno” (“L’oeil du malin” ) è opera di un fondatore della Nouvelle vague, Claude Chabrol, noto anche in Italia fin dai suoi esordi, un autore molto considerato, al di là della sua prolificità (una cinquantina di film), per le perfide analisi psicologiche in funzione antiborghese. Bene ha fatto lo Studio Canal a restaurare questo film del 1961 per la Mostra, fra l’altro molti di coloro che seguono Venezia Classici non l’avevano mai visto. Degno di nota per almeno tre motivi è anche “Daïnah la métisse”, di Jean Gremillon: l’ottimo restauro che la Gaumont ha realizzato nel Laboratorio L’immagine Ritrovata; il film, del 1931, non è mai uscito in Italia; la storia, iniziata come un esotico viaggio su un piroscafo di lusso, finisce in tragedia rivelando, con appropriato taglio espressivo, le profonde disuguaglianze che stanno alla base dei conflitti sociali, razziali e personali.
Infine un regalo prezioso, in occasione del centenario della nascita di Rouch, ci è stato fatto con la proiezione in anteprima mondiale di un inedito del grande regista ed etnologo, “Cousin, cousine” (“Cugino, cugina”, 31’, colore), girato a Venezia nel 1985 e completato sul fiume Niger due anni dopo. L’attore nigeriano Demouré Zika e la regista sua connazionale Marianna Hima percorrono in gondola il Canal Grande nelle vesti di due cugini venuti a Venezia per ritrovare un’antica reliquia perduta (l’ispirazione è presa da un dipinto di Gentile Bellini). La conversazione fra i due è interessante quanto i luoghi veneziani che la gondola incontra (fra i quali uno squero dove si fabbricano gondole) e il viaggio termina. . . sul Niger, dove, dalla piroga che li trasporta, i due cugini trovano la reliquia: un’ascia rituale del genio del tuono. Questa fantasia deliziosa, restaurata con cura dal CNC francese, era preceduta da “L’enigma di Jean Rouch a Torino–cronaca di un film raté”, cioè, come dice il titolo, la cronaca di un film che non si è mai fatto, realizzato da Marco di Castri, Paolo Favaro e Daniele Pianciola. Il cineasta vicino alla Nouvelle vague e inventore del cinema verité, all’inizio degli anni ottanta, viene convinto dai tre giovani autori a girare un film a Torino. Il materiale girato, oltre venti ore, non diverà mai un film, ma costituisce una documentazione straordinaria di come Rouch lavorava, la memoria di una sua impresa finora sconosciuta. Resta la coproduzione franco-tunisina +del 1984, in realtà un’opera del regista tunisino Nacer Khemir, distribuita dalla Cineteca belga, che ne ha curato il restauro. “El-haimonne”, titolo arabo che potrebbe essere tradotto “I figli delle mille e una notte”, è un’opera prima che fa di una leggenda tramandata oralmente un poetico omaggio alla miglior tradizione della cultura araba.
Veniamo ora a un altro punto di eccellenza della rassegna, i tre capolavori giapponesi degli anni Cinquanta, tutti splendidamente ricostruiti, che hanno reso felici gli spettatori. Due di essi, entrambi datati 1954, dovuti al maestro Mizoguchi e il terzo (1952) a un altro padre nobile del cinematografia nipponica, il grande, ma meno conosciuto in Italia, Yasujiro Ozu. “Gli amanti crocefissi” e “L’intendente Sanshô” ci sono parsi, se possibile, più convincenti di come li ricordavamo, più calibrati nella narrazione tesa, in ciascuno di essi, ad affermare e a ribadire i grandi temi che caratterizzano il cinema di questo autore; la maledizione del denaro che spinge gli uomini alla rovina e, complementare a questo, la necessità di lottare contro lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo fonte di tutte le ingiustizie. Il film di Ozu, “Ochazuke no Aji”, mai distribuito nel nostro paese, potremmo intitolarlo “Il sapore del riso al te verde”, perché questo piatto povero assume grande rilievo nella vicenda di una coppia borghese in crisi. Attraverso i conflitti vissuti da questa coppia, Ozu conferma la sua eccezionale capacità di analizzare intensamente situazioni quotidiane cogliendone le sfumature psicologiche che rendono l’esperienza minimale un modello esemplare.
Alle grandi cinematografie, delle quali finora abbiamo parlato, dobbiamo aggiungere quella dell’Unione sovietica, che ci ha dato storicamente una produzione fondamentale per la Settima arte. All’Unione sovietica appartiene, infatti, il film di Elem Klimov “Vai e vedi” (“Idi i smotri”, 1985), premiato per il miglior restauro dalla consueta giuria di studenti coordinati, questa volta, dal regista Giuseppe Piccioni. Oltre al meritato riconoscimento –il restauro è stato effettuato dal Mosfilm Cinema Concern- l’opera si segnala per il linguaggio attualissimo con cui il regista, consapevole della spietata aggressione che le immagini effettuano sullo spettatore, denuncia gli orrori della guerra, storicamente le truci imprese dei nazisti in Bielorussia, intesi come il limite estremo oltre il quale l’umanità stessa potrebbe non esistere più. Una realtà storica spinta verso momenti metafisici.
A proposito dell’ex Unione sovietica, nell’anno centenario della rivoluzione d’ottobre, dobbiamo citare il documentario “L’utopie des images de la revolution russe”, del giustamente noto Emmanuel Hamon, per la eccezionale efficacia con cui fa rivivere sullo schermo la grande stagione dell’avanguardia russa (1917- 1934, secondo l’autore). Cineasti, tecnici e poeti pensarono e operarono per alcuni anni come se il cinema e la rivoluzione insieme stessero costruendo una nuova società. Purtroppo questa “utopia” fu presto schiacciata dal potere staliniano.
Ci soffermiamo ancora sui documentari poiché non possiamo non segnalare quello che è stato giudicato il migliore dalla giuria di studenti. “Il principe e il Dibbuk”, dei polacchi Elwira Niewiera e Piotr Rosolowski è centrato sul mitico produttore hollywoodiano e sedicente nobile polacco, in realtà un ebreo ucraino di umili origini, Michael Waszynski. Fra i cinquanta e più film ai quali ha lavorato, uno lo ha ossessionato per tutta la vita. Si tratta di “Der Dybbuk” (“Il Dibbuk”, ovvero tra due mondi), un film Yiddish girato poco prima della seconda guerra mondiale, perduto e mai più ritrovato. Infine, accenniamo anche a “La voce di Fantozzi”, dove Mario Sesti affronta un’altra delle sue imprese volte a tradurre in immagini la voce di una personalità. Anche questa volta il risultato è esemplare.
Terminiamo questo excursus nella Venezia Classici con un interessante film filippino e un’opera cecoslovacca d’avanguardia divenuta veramente un “classico”. L’Asian Film Archive ha avuto l’ottima idea di rimettere in circolazione “Batch ’81” (“Gruppo ’81”), un film girato da Mike De Leon nel 1982, affidandone il restauro a L’Immagine Ritrovata. Ottima idea perché, oltre la buona qualità dell’opera, De Leon ci mostra con convincente realismo il formarsi della mentalità autoritaria parafascista nelle confraternite studentesche dell’Università di Manila. Purtroppo l’attualità ci dice che non si tratta solo delle Filippine.
Abbiamo lasciato per ultimo, ma non lo è certamente per importanza, ”L’asso di picche” (“Cerni Petr”, 1963), opera prima di Milos Forman, uno dei film più rappresentativi del Nuovo cinema cecoslovacco. Ancora oggi il film s’impone allo spettatore per quel taglio linguistico innovativo che rende realisticamente le inquietudini profonde della gioventù dell’Europa orientale, inquietudini che, nel caso specifico, si riveleranno i prodromi della primavera di Praga.
I CORTI DI “CORTINAMETRAGGIO” IN TRASFERTA IN VERSILIA
di Paolo Micalizzi
“Cortinametraggio” ha portato il pesciolino rosso, simbolo dell’evento più prestigioso della Conca ampezzana, in Versilia, iniziando cosi un viaggio itinerante in Italia con l’obiettivo di arrivare anche all’estero. E’ una nuova idea di Maddalena Mayneri, la vulcanica Presidente del Festival che da dodici anni si svolge a Cortina , Perla delle Dolomiti. I primi passi di questa nuova iniziativa sono stati posti nel marzo 2017 quando alla dodicesima edizione di “Cortinametraggio” il Sindaco di Pietrasanta aveva premiato il cortometraggio “La notte del professore” di Giovanni Battista Origo che aveva conquistato il Premio come miglior regia. L’autore, in quella occasione, non aveva potuto essere presente ed il premio lo ha ritirato appunto a Pietrasanta. Il cortometraggio si svolge in un condominio mostrandoci personaggi alquanto bislacchi che fanno scaturire tanta ilarità. A Pietrasanta è stato presentato il meglio di Cortinametraggio 2017 e reso omaggio, nella serata conclusiva, al regista Paolo Genovese, vincitore di due David di Donatello per il film “Perfetti sconosciuti”, anche grande successo al Box Office. Tanti altri nuovi talenti , quelli presentati nei due giorni di “Cortinametraggio in viaggio”.
Di Alessandro Sanpaoli “Al posto suo”, una cortycomedy che racconta come ci si può salvare da una situazione disperata. Che è quella di Leone il quale riceve la visita della madre, arrivata appositamente per conoscere la fidanzata del figlio, proprio nel momento in cui, dopo un ennesimo litigio, lei lo lascia. Leone risolve il problema chiedendo alla domestica Svetlana di fingere di essere la sua ragazza, pagandola profumatamente. “Amira” è poi un cortometraggio di Luca Lepone con al centro del racconto una giovane donna che esprime la sua libertà danzando freneticamente e felicemente in mezzo alla folla, che però la ritiene folle. “Angel” di Federica Belletti è una storia fantastica in cui una giovane ragazza rientrando a casa viene vista dal padre come un angelo, e ciò cambia il loro rapporto. Una parodia sul potere in “Buffet” di Santa de Santis e Alessandro D’Ambrosi in cui un raffinato vernissage si trasforma in un grottesco ed esilarante assalto al buffet. Iniziato come una sorta di thriller il cortometraggio, che ha vinto a “Cortinametraggio 2017” il premio come miglior corto in assoluto, si sviluppa in un racconto in cui emergono ipocrisia, avidità e individualismo, aspetti deteriori del potere d’oggi che portano il paese alla rovina. Tra le iniziative svoltesi a Pietrasanta, di particolare valore l’incontro del giornalista Lorenzo di Las Plassas con gli studenti del Don Lazzeri di Pietrasanta. In una masterclass si è soffermato sul giornalismo cinematografico raccontando la propria esperienza di frequentatore di Festival e di eventi cinematografici da trasmettere poi agli spettatori televisivi. Un incontro utile ad arricchire la conoscenza del cinema da parte delle nuove generazioni. Per l’ omaggio al regista Paolo Genovese sono stati proiettate alcune sue opere. Oltre al film d’esordio, co-diretto con Luca Miniero, “Incantesimo napoletano” e “Una famiglia perfetta”, il cortometraggio “Piccole Cose di Valore non quantificabile”. Al centro del racconto la deposizione di una ragazza che andava dai carabinieri a dire che le avevano rubato i sogni. In realtà, a poco a poco, si capiva che aveva subito uno stupro. Ma anche Il corto più recente, “Per sempre”, in cui affronta il tema dell’affido attraverso un racconto ambientato nell’affascinante mondo della moda per far corrispondere l’opera alla volontà del committente inserendo però la tematica che più gli stava a cuore. Un omaggio che ha consentito di inquadrare la personalità autoriale del regista.

Consegna del Premio Paul Picot al regista Paolo Genovese: da sin. Maddalena Mayneri, il vicesindaco Daniele Mazzoni, Paolo Genovese e Elettra Mallabry.
Nell’occasione ha ricevuto, alla presenza del Vicesindaco Daniele Mazzoni e di Maddalena Mayneri, il Premio Paul Picot consegnatogli dall’attrice Elettra Mallabry, un’attrice che si è distinta come nuovo talento nel film fantascientifico “Andron. The black Labyrint” diretto da Francesco Cinquemani. Un giusto riconoscimento ad un regista,Paolo Genovese appunto, che, si può dire, è stato il protagonista di questa prima edizione di “Cortinametraggio in viaggio”.
SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2017:
NUMERI E CONTENUTI
di Francesco Saverio Marzaduri
Si è conclusa il 15 ottobre la XIV edizione del Sedicicorto International Film Festival, particolarmente densa di appuntamenti. Ben 48 i programmi, suddivisi in 17 sezioni, sei delle quali competitive: “Movie”, “Animalab”, “Cortitalia”, “Animare”, “CortoinLoco”, “NO+D2”. Undici le sezioni fuori concorso: “Bebisciort”, “Light” ed “Experia”, tre focus dedicati a Bulgaria, Slovacchia e Macedonia. E ancora “Euroshort”, “Atrium”, “Migrò”, “Water”, il programma S.E.I. (Scuola-Educazione-Immagine), e numerosi altri eventi collaterali. In cifre, il comitato di valutazione ha visionato 4.278 lavori provenienti da 116 paesi, selezionandone 270 in rappresentanza di 53. Nove le anteprime mondiali, cinque quelle europee, trentuno le nazionali e sessantaquattro quelle regionali. Anteprima assoluta anche per “Ancora preti”, seconda parte della fortunata serie web “Preti”, che ha superato i tre milioni di visualizzazioni su YouTube. Ventiquattro mini-episodi sulfurei con protagonisti due sacerdoti, alle prese con vecchie e nuove problematiche sociali e religiose e relative, estrose soluzioni per svecchiare la Chiesa. In programma, inoltre, la visione di opere vincitrici di premi prestigiosi come l’Oscar, il Festival di Cannes, il Festival di Los Angeles, il David di Donatello, il Nastro d’Argento.
Il tema del festival, “Migrazioni e integrazioni tra popoli”, è stato protagonista della sezione “Migrò” costituita da dodici shorts. Le altre sezioni tematiche sono state “Ecofilm”, con una sezione inerente il tema dell’acqua in collaborazione con Romagna Acque, e i focus geografici dedicati a Bulgaria, Slovacchia, Repubblica di Macedonia. In collaborazione col Palace International Short Film Festival, il principale festival bulgaro di cortometraggi, il focus sui film d’animazione slovacca è stato realizzato in collaborazione col “Fest Anča International Animation Festival”, che si è concentrato sulle nuove tendenze dell’animazione (1999-2016), e col “Winter Apricots: Prilep International Film Festival” di Macedonia.
Non sono mancati consueti appuntamenti come il progetto S.E.I., che ha coinvolto bambini e ragazzi dalla scuola materna a quella superiore, oltre a centri educativi con attività annuali quali laboratori, cineforum, concorsi di disegno e scrittura. Il programma del S.E.I. ha contato tredici corti, due dei quali di animazione, realizzati da alunni di una scuola elementare di Forlì e una di Sassuolo, nell’ambito del laboratorio di animazione in stop-motion “Piccoli registi crescono”, organizzato dal Sedicicorto e condotto dall’Atelier del Cartone animato. Inoltre sono stati proiettati quattro lavori realizzati da bambini belgi, risultato dei laboratori della scuola belga Camera Etc. A completare la kermesse, la presentazione di sette lavori appartenenti al progetto della scuola di effetti speciali francese ArtFX.
La sezione “NO+D2”, dedicata a prodotti con una durata non superiore a due minuti, ha visto ragazzi delle scuole forlivesi, oltre a 800 studenti di scuola media e superiore, partecipare a proiezioni mattutine con relativo dibattito e a due concorsi di scrittura critica indetti dal Sedicicorto e dal Resto del Carlino (redazione di Forlì). Dedicate ai più piccoli, le due sezioni di cinema di animazione “Bebisciort” e “Animare”. Sempre attesa dal pubblico, la sezione “CortoinLoco”, dedicata agli autori dell’Emilia-Romagna, ha visto in gara 18 titoli, otto dei quali realizzati da forlivesi. Ancora, in collaborazione col Comune di Forlì, il progetto cinematografico “Atrium”, rotta culturale del Consiglio d’Europa, ha promosso uno sguardo critico-storico sull’architettura dei regimi del XX secolo, con lavori provenienti da Germania, Estonia, Croazia, Russia e Corea. E, per la categoria “Caratteri d’autore”, le tradizionali masterclass, condotte quest’anno da Valerio Aprea e da Mattia Torre, in collaborazione con ArchiMedia, per i dieci anni dalla realizzazione della fortunata serie televisiva “Boris”. A Luca Miniero la conduzione di “Migrazioni nel cinema”, e a Sergio Basso quella di “Integrazioni nella Chinatown di Milano”.
Oltre ai consueti incontri con gli autori in gara, non è mancato un approfondimento sul tema della distribuzione del corto, e sulle dinamiche che ne caratterizzano l’attività, con la partecipazione di Giulio Mastromauro di Zen Movie Distribuzione (Italia), Adam Selo di Elenfant Film (Italia), Wouter Jansen di Some Shorts (Paesi Bassi), Aitor Arenas Suso di Banatu Filmak (Spagna), Luce Grosjean di Sève Films (Francia).
168 i professionisti accreditati, più di 8.000 gli spettatori. Tra loro, a sorpresa, è arrivato Agur Schiff, apprezzato regista e scrittore nato a Tel Aviv nel 1955, laureatosi alla Scuola d’Arte di Saint Martins a Londra, dove si è specializzato in animazione, e all’Accademia di Arte Rijks di Amsterdam. Professore all’Accademia di Design e Arti di Bezalel a Gerusalemme, insegna scrittura creativa, sceneggiatura e filmologia. Da tale incontro è nato un progetto di collaborazione tra il Sedicicorto e l’Accademia di Design e Arti. Le grate visite a sorpresa non sono cessate nemmeno l’ultimo giorno, quando sono arrivati i ragazzi della “Gang del bosco” – accompagnati dal professor Ian Giovanni Soscara, della scuola “Salesiani” di Forlì – che hanno presentato il rap-clip “Datemi un martello”, pieno di energia, ironia, voglia di futuro e integrazione.
Relativamente ai vincitori in gara, per la categoria “Movie”, inerente le opere internazionali, il premio è stato assegnato al corto francese “Chasse Royale”, opera d’esordio di Lise Akoka e Romane Guéret. La tredicenne Angelique è la più grande dei suoi numerosi fratelli, e vive nel sobborgo di Valenciennes. Un giorno le viene proposto di sottoporsi a un provino per un film: dopo molte esitazioni, Angelique decide di partecipare, e uno dei suoi fratellini spera di vederla andare a Parigi. Nonostante la scorza dura e l’atteggiamento ribelle, la paura del fallimento prende presto il sopravvento su di lei… A decretare il successo del film, la creatività, il rigore stilistico, le emozioni interpretate da giovani attori naturali e selvaggi, feroci e veri, la forza dei dialoghi, gli inserti musicali, un bell’epilogo. Esempio di un cinema vitale, realistico e sociale, tributo a una gioventù cruda e ruvida, al contempo vulnerabile e sensibile.
La menzione speciale è andata all’olandese “In Kropsdam is iedereen gelukkig” di Joren Molter. A Kropsdam, un piccolo villaggio nell’est di Groninga, vive Lammert, un amichevole agricoltore. La vita tranquilla si guasta quando l’uomo è sospettato di aver stretto un accordo con la società di energia Green Now. Lammert non vuole aver nulla a che fare con le turbine eoliche, eppure il villaggio inizia a trattarlo diversamente, giacché tutti a Kropsdam sospettano di lui. Lammert non ha colpe, ma diventa vittima del potere soffocante di una comunità che ha scelto il proprio capro espiatorio. Il film di Molter è una commedia nera che analizza il feroce effetto delle calunnie su un paesino, e il potere incontrollabile di un gruppo industriale sulla vita di un uomo. Quel che affascina maggiormente il regista è l’accusa reciproca fra persone tranquille che improvvisamente sviluppano un odio feroce: anziché da fatti, però, la rabbia scaturisce da un singolo pettegolezzo.
Il premio del pubblico è stato assegnato all’ungherese “Mindenki” di Kristóf Deák, uno tra i pochi film magiari ad aver vinto un Oscar. Basato su una storia realmente accaduta, il film è un dramma infantile dove la musica ricopre un ruolo fondamentale. Ambientato negli anni Novanta a Budapest, narra le difficoltà di Zsofi, una bambina di dieci anni che si trasferisce in una nuova scuola elementare e diventa membro del pluripremiato coro. La cui direttrice, però, non è l’insegnante che tutti pensano essere… La piccola protagonista dovrà affrontare una scelta difficile: piegarsi a un sistema corrotto o adattarsi tranquillamente ad esso. Alla fine sarà Zsofi, insieme alla sua amica Liza e al coro, a dare una lezione all’insegnante.
Per la sezione “Animalab”, dedicata all’animazione, ha vinto lo svizzero “Analysis Paralysis” di Anete Melece. Nel parco Anton cerca qualcuno per giocare a scacchi, o che almeno giochi meglio del proprio cane. La giardiniera sta cercando il misterioso vandalo che ha distrutto le sue aiuole e ha perduto uno stivale giallo. In realtà, entrambi stanno cercando la stessa cosa: sfuggire alla solitudine. Menzione speciale e premio del pubblico sono andati rispettivamente all’estone “Penelope” di Heta Jäälinoja e al romeno “Cel mai bun client” di Serghei Chiviriga. Nel primo, operina di laurea presso l’Accademia delle Arti estone, un campanello squilla: ma la casa della protagonista Penelope è terribilmente sottosopra, e lei ancora dorme. Riuscirà in una manciata scarsa di minuti a renderla presentabile? Mai sottovalutare l’ingegno femminile! Nel secondo, la famiglia Kruchowski possiede un salone funebre. Un giorno, un vecchio ordina dodici corone funerarie con messaggi di cordoglio di parenti e amici. I coniugi Kruchowski diventano sospettosi e iniziano a indagare su quello che ritengono un potenziale assassino… Scritto e diretto da Serghei Chiviriga, il corto s’ispira a un testo di Henri Troyat. 150 giorni di riprese per 10 minuti di animazione, un piccolo e appassionato team alle prese con un soggetto universale: per far fronte alla solitudine, un anziano gravemente malato s’inventa una famiglia immaginaria che troverà, però, nei signori Kruchowski.
La sezione “Animare” se l’è aggiudicata il francese Hugo Favre con “Jamais sans mon dentier”, scelto da una giuria composta da 120 ragazzi di età compresa tra i 4 e i 13 anni. Quattro pensionati in una casa di di riposo stanno per guardare in televisione il loro programma preferito, quando una perfida infermiera confisca loro il telecomando. Gli intraprendenti anziani decidono di recuperarlo, e nell’epilogo l’infermiera è sistemata. I quattro compiono il recupero in stile “Mission: Impossible”: l’operazione riesce, ma il telecomando è quello per azionare le tapparelle. La sezione “Cortitalia” è stata vinta da Mario Piredda con “A casa mia”, che ha conseguito anche il premio “CortoinLoco”, riservato ai titoli girati in Emilia-Romagna. Omaggio alla Sardegna, terra natia del regista, e alla lingua sarda, l’opera narra di un’anziana vedova (la Giusi Merli vista ne “La grande bellezza”) e di un amico pescatore (Giulio Pau, zio dell’autore), rimasti i soli abitanti di un borgo di pescatori sul mare che si ripopola solo d’estate, i quali vivono nella speranza che l’inverno non termini. Piredda dirige in modo magistrale due volti che incarnano la ruvidezza e la profondità dell’isola, oltre a ribadire temi importanti come lo spopolamento e la perdita di autenticità del territorio sardo e delle sue tradizioni, la solitudine degli anziani, il disagio delle nuove generazioni. Il tutto trasposto in un paesaggio invernale struggente, assai distante da immagini e contenuti patinati dei tabloid estivi e dei depliant turistici.
Menzione speciale e premio della critica di “Cortitalia” sono stati assegnati al film d’animazione “Confino” di Nico Bonomolo e a “Mostri” di Adriano Giotti. Il primo, la storia di un artista di ombre cinesi costretto all’esilio per aver osato prendersi gioco di Mussolini, ribadisce la dignità di ogni individuo davanti ai meccanismi di potere. Proprio l’arte porta via il protagonista da quel luogo di solitudine e di abbandono, regalandogli un altro luogo e un altro tempo per il proprio splendido gioco d’illusione. Lo short è sostenuto da una forte ispirazione e da un perfetto equilibrio tra musica e immagini: il cinema spezza le catene del confino e offre uno sguardo libero verso le stelle. In “Mostri”, Alex ha quasi quarant’anni, da tempo si è disintossicato dalla droga, ma il padre, che gli è rimasto sempre accanto, teme che il figlio possa ricaderci. Soprattutto ora che deve dare l’addio al cane: la sola cosa cui Alex tenga davvero… Già in altre occasioni il regista ha narrato con fervore esistenze borderline, ma qui il disagio è palpabile da subito. E ogni dettaglio va a comporre un mosaico coerente nel suo essere disturbante in modo secco. Un inatteso detour conduce i protagonisti in luoghi ancora più degradati, laddove l’epifania conclusiva, in apparenza fuori luogo (l’apparizione iconica di canini da vampiro), rafforza icasticamente una diversità molto concreta, sul piano di un grave disagio sociale e di un rifiuto. I mostri risultano credibili, sia per lo sguardo tagliente sul quotidiano, sia per la sensibilità espressa dai volti dei protagonisti, il giovane Federico Rosati e il maturo Alessandro Benvenuti, qui chiamato a cesellare un ritratto umano dolente, intimista e sommesso.
Per quanto concerne menzione speciale e premio del pubblico per la categoria “CortoinLoco”, vincitori sono stati “Ancora” di Lu Pulici (che ha ottenuto anche il premio FEDIC) e “La procedura” di Alessandro Valbonesi. Nel primo, una ragazza affronta il viaggio per tornare dall’uomo che ama: ma la loro relazione non è facile. Due mondi diversi e contrastanti si riuniscono e danno vita a un amore appassionato e tormentato, testato dalla realtà che li circonda. Nel secondo, invece, un normale controllo di documenti si trasla in un incubo kafkiano, nell’epoca in cui l’identità di un uomo sembra dipendere solo dalla sua esistenza online. In pochi minuti, “La procedura” racconta come la contaminazione dei social prenda il sopravvento sulle normali procedure del controllo d’identità: una boutade su un futuro sempre meno lontano.
Per la sezione “NO+D2” il vincitore è stato il tedesco “The Culprit” di Michael Rittmannsberger, commissionato dalla sede tedesca di Amnesty International, storia di un giovane accusato di un grave delitto e condannato a morte. L’uomo ammette tutto senza mostrare traccia di rimorso, dando, anzi, l’impressione di aver commesso il crimine con la massima convinzione. Nel finale, diventa chiaro quale sia il suo delitto: l’amore, ricambiato, per un altro uomo. La menzione speciale è andata a “Not Acceptable” dell’iraniano Saman Haghighivand. Autore di cortometraggi, documentari, video art e spot pubblicitari, focalizzato sull’alienazione, la differenza, il trauma e i rifugiati, qui Haghighivand si concentra sul desiderio di un giovane di diventare donna, e sul rifiuto dell’oppressivo nucleo familiare nell’apprendere la notizia. Una didascalia sui titoli di coda informa di suicidi di omosessuali e trans e di ripudi da parte di famiglie, in Iran e un po’ in tutto il Medio Oriente.
Il premio “Euroshort” è stato assegnato a “Piove” di Ciro D’Emilio: delicatezza e profondità sono impiegate per un aneddoto su giovani prostitute africane, costrette a vivere giorni di dolore e sfruttamento in attesa di una pioggia catartica. Il premio per il miglior documentario è andato a “Rejetés” di Antonio Guadalupi: molto più che una testimonianza sugli afflitti da problemi psichici in Africa, è una disperata denuncia e un tentativo di sollecitare aiuti concreti per quanti, costretti dalla fame e dalla miseria, cercano nell’emigrazione l’estrema soluzione. Perché la migrazione è la fuga dal destino delle catene. Il premio “Corte Tripoli” se l’è aggiudicato “Gionatan con la G”, firmato da Gianluca Santoni. Il Gionatan del titolo ha nove anni e gli occhi di un adulto. Nella sala d’aspetto del pronto soccorso attende che la madre si faccia medicare: di nascosto, la sente mentire sul modo in cui si è procurata alcune ferite al volto. Con un po’ di caramelle in mano e una terribile idea in testa (uccidere il padre), Gionatan decide di fuggire.
Premio “Migrò”, infine, a “Penalty” di Aldo Iuliano, che trae ispirazione da un’inchiesta giornalistica sui lager libici di Gheddafi: un’opera sorprendente, in cui una partita di calcio si fa emblematica metafora di una spietata lotta per la sopravvivenza, e l’immigrazione è riflessione sulla condizione umana osservata da chi parte. Sceneggiato da Severino Iuliano (fratello del regista) e Alessandro Giulietti, e col montaggio di Marco Spoletini, abituale collaboratore di Garrone, lo short si avvale di un cast di interpreti non professionisti, illuminato dalla superba fotografia, al contempo oscura e raggiante, di Daniele Ciprì.
In chiusura del presente, chi scrive vuole dedicare queste righe al regista Umberto Lenzi, scomparso pochi giorni dopo la fine della rassegna, che già lo vide membro di giuria nell’edizione del 2010.
OCCHIO CRITICO
a cura di Marco Incerti Zambelli
IL GRANDE ALTROVE : “JIM & ANDY” E “NICO 88”
di Marco Incerti Zambelli
“Jim & Andy” e “Nico 88”, opere diverse per stile e costruzione, sono accomunate dalla ricerca di uno sguardo coinvolto sulle vicende umane e professionali di miti dello spettacolo dalla enigmatica, discussa carriera.
Utile, non necessario, (ma certamente piacevole ed occasione per ripensarne la qualità, forse non sufficientemente apprezzata all’epoca della sua uscita) rivedere “Man on the moon”, il film di Milos Forman, per meglio apprezzare “Jim e Andy” di Chris Smith, autore di notevoli documentari e di un paio di pregevoli film narrativi, purtroppo mai arrivati sugli schermi italici; ed anche quest’opera, in fondo, è disponibile solo su Netlix.
Prodotto da Spike Jonz, marito di Sofia Coppola ed autore di “Essere John Malkovich” e di “Her”, a partire da materiali di archivio sul backstage della realizzazione del film del 1999, l’autore costruisce un complesso intrecciarsi di racconti che è ad un tempo rivelatore dei caratteri, a tratti sovrapponibili, dei due protagonisti, ma anche ritratto dell’impervio, a volte pericoloso, mestiere dell’attore. Diverse le suggestioni suggerite dalla visione. A partire dal titolo completo “Jim and Andy. The great beyond. Featuring a very special contractually obligated mention of Tony Clifton”. Jim è Jim Carrey, all’epoca nel punto più alto della sua carriera, dopo la trilogia demenziale di “Ace Ventura”, “Scemo & più scemo”, “The Mask” ma anche la toccante interpretazione di “The Truman Show”, Andy è Andy Kaufman, comico a dir poco irriverente, morto a soli trentacinque anni, che Carey interpreta nel film di Forman. ‘The Great Beyond’ (“Il grande altrove”) è una canzone dei Rem, dal testo al solito criptico, composta per “The Man On The Moon”, che, a sua volta, deriva il titolo da un‘altra canzone precedente sempre dei Rem, a Kuafman dedicata. Tony Clifton è un alter ego, cantante grottesco e insolente, interpretato da Andy, ma anche dal suo coautore Bob Zmuda.
Analoga poliedrica struttura innerva la narrazione, che articola una recente lunga intervista a Carey, barbuto, sereno ma con vena di tristezza nel ricordare, con le straordinarie riprese sul set del film di Forman, rimaste in archivio per 20 anni su precisa richiesta dell’Universal, dalle quali emerge la inquietante totale identificazione dell’attore con Kaufman, di cui vengono proposti ampi spezzoni di performances ed interviste. Se si aggiunge che molti dei personaggi narrati in “The Man Of The Moon” sono anche protagonisti nella parte di se stessi, il corto circuito realtà/finzione che si innesta conferisce al lavoro di Smith un fascino a tratti stordente. Il risultato è ad un tempo divertente e commovente, lirico e sarcastico, un prezioso dietro le quinte e dentro gli artisti.
Nico: e viene in mente la banana di Warhol sulla copertina di ‘Velvet Undergound &Nico’, (nel quale in realtà lei canta solo tre pezzi e mezzo), la fellatio a Jim Morrison in ascensore nel film di Oliver Stone, per i più cinefili la deliziosa fanciulla che incontra Mastroianni ne “La dolce vita”.
Il film che Susanna Nichiarelli le dedica, vincitore della sezione ‘Orizzonti’ all’ultima Mostra del cinema di Venezia, nulla racconta di quella Nico, se non per qualche fugace, sgranato estratto da opere di John Mekas, concentrandosi sull’ultimo anno di vita della cantante, con qualche efficace richiamo alla sua infanzia nella Berlino bombardata degli anni ‘40.
La bionda, statuaria icona degli anni ’60 è diventata una corpulenta cinquantenne che gira l’Europa con uno vecchio furgone insieme ai componenti della band e che si è lasciata alle spalle il glamour del passato, proponendo in piccoli club le sue fosche e ombrose composizioni. Fortemente dipendente dall’eroina, tenacemente affezionata al problematico figlio abbandonato da bambino, avuto da Alain Delon e da lui mai riconosciuto, Nico, tornata Christa Paffgen (il suo vero nome), insegue la ricerca di se stessa come donna ed artista, percorso impervio ma sincero: un convinto abbandono del “glorioso” passato, una caparbia affermazione del suo presente, un’incompiuta risalita verso la rinascita. L’opera della Nichiarelli è anche un film sull’Europa alle soglie dell’epocale crollo del Muro di Berlino, tra le atmosfere fuori stagione del litorale romano e le magiche ombre dei cortili di Praga, ancora per poco sotto il tallone dei sovietici e teatro della più esaltante delle performances, passando da Manchester a Parigi, da Norimberga alla campagna polacca.
L’autrice confeziona con cura, a partire dal formato paratelevisivo 4/3 delle immagini ribadito dall’attenzione ai colori complementari della efficace fotografia di Crystel Fournier, ed ha il suo punto di forza nella magistrale interpretazione di Trine Dyrholm, vincitrice dell’Orso d’Argento a Berlino per la “La comune” di Thomas Vinterberg. L’attrice danese è superba nel rendere coinvolgente la figura della chanteuse, puntando più alla messa in scena dei sentimenti, delle emozioni che alla mimesi, arrivando ad utilizzare la propria voce voce nell’interpretarne le severe ballate.
NON (SOLO) NEOREALISMO: “A CIAMBRA”
E QUELLA SPORCA ULTIMA META: “DUNKIRK”
di Francesco Saverio Marzaduri
Non (solo) Neorealismo: A Ciambra
Quando “A Ciambra” fu presentato al “Sedicicorto Film Festival” di due anni fa, trovammo che quanto ci mostrava, il percorso d’iniziazione forzata di un ragazzino rom, ricordava certo Visconti e pure gli olvidados di Buñuel, una poetica dell’infanzia cara a Truffaut su uno sfondo di delinquenza alla “Gomorra”. Nell’arco d’una mezz’oretta, l’italo-americano Jonas Carpignano condensava la vicenda del piccolo Pio Amato in una struttura a blocchi, dove a una prima parte notturna e concitata ne seguiva una seconda più dilatata. L’alienante violenza, strumento necessario a Pio per sopravvivere nel degrado, lasciava il posto a un’introspezione psicologica accentuata da un frequente impiego di primi piani. Identico stile si ritrova nel suo secondo lungometraggio, premiato alla Croisette come miglior film europeo alla “Quinzaine des Réalizateurs”, che consente al giovane autore di tornare nella stessa zona calabrese di Gioia Tauro – in gergo, appunto, “A Ciambra”. Più che un ampliamento, un sequel di due ore di quello short. Raggiunti i quattordici anni, Pio beve e fuma, ma è tra i pochissimi a entrare in relazione con tutte le realtà presenti nell’area: italiani, africani o rom come lui. Il ragazzino segue e ammira il fratello maggiore Cosimo, dal quale apprende quanto serve a sopravvivere per strada. Finché Cosimo e il padre non vengono arrestati, e tocca a Pio il difficile ruolo di precoce capofamiglia e il compito di provvedere al sostentamento del numeroso nucleo, per assolvere il quale conosce, manco a dirlo, un solo modus operandi: il furto. In un’area dominata dalla ’Ndrangheta, dove si ruba pure l’elettricità per non pagare le bollette (ma una, salatissima, arriverà), la maniera più redditizia e meno rischiosa per farlo è salire sui treni per scenderne coi bagagli dei passeggeri. A piazzare il bottino ci pensa un immigrato del Burkina Faso (e Koudous Seihun reinterpreta qui lo stesso personaggio di “Mediterranea”, lungometraggio d’esordio di Carpignano), col quale Pio costruisce un rapporto d’amicizia che gli permette di frequentare la locale comunità africana. Di fronte al bivio se tradire o meno quest’amicizia, l’itinerario di Pio verso l’età adulta imboccherà la svolta definitiva. “Ero entrato alla Ciambra con una vaga storia in mente – racconta il regista – poi ho conosciuto Pio e ho adattato la sceneggiatura per inserire elementi biografici della sua famiglia”. E come per “Mediterranea”, “il film è stato adattato alla vita reale, pur mantenendo la struttura drammatica del racconto.” Non sorprende che la lavorazione di “A Ciambra” abbia richiesto tre mesi, trattandosi di un luogo imprevedibile e ingovernabile dove, parafrasando Carpignano, tutto ciò che può succedere si verifica dieci o quindici volte al giorno. Ciò non toglie al film la patina di un insolito romanzo di formazione, che attraverso l’escamotage della finzione fa emergere una verità cruda e sgradevole (l’educazione sentimentale, qui, è anche un’educazione al furto). Perfettamente orizzontale, lo sguardo dell’autore non esalta né denigra. La macchina da presa non si frappone ma si fa corpo unico della narrazione, la presa di posizione è aprioristica e figlia d’una necessità vitale: quella di non (voler) chiedere allo spettatore di modificare un pregiudizio, che pure traspare, non facile da rimuovere. Eppure, l’occhio di Carpignano non chiede compassione e non parteggia: limitandosi alla descrizione, la vicenda non rilascia giudizi. “A Ciambra” è il prodotto di un’immersione totale nei luoghi e nelle dinamiche quotidiane della famiglia Amato: l’autore li conosce da sei anni, sin da quando dovette attendere la fine dei funerali del capofamiglia per poter concordare il prezzo con cui “riscattare” l’auto che gli avevano rubato. Giacché qualcosa di analogo si ritrova nel film, lo stile sembra coniugare la lezione di Pasolini e di Cassavetes, soprattutto nella registrazione d’una realtà carpita all’interno del nucleo familiare, senza trascurare il documentario antropologico più classico, avendo la pretesa di fargli il verso o di riproporlo tale e quale. In tal senso, l’opera non si contenta di mostrare, ma tende a (far) vivere quello cui si assiste. Pazienza per qualche inserto onirico che, inevitabile, accosta il risultato al Neorealismo (il cavallo agognato da Pio, che ricorre in numerosi passaggi). Non c’è redenzione, la vita resta quella di ogni giorno. “Siamo noi contro il mondo”, chiosa il nonno del protagonista: il mondo esterno, a un passo da Gioia Tauro, è sempre solcato da una distanza incolmabile. Da prodotto indipendente qual è, “A Ciambra” esibisce il piglio nostrano e passionale della tradizione popolare; e chi accosterà il sentimento di stima (non ripagato) di Pio verso il fratello a quello del coppoliano “Rusty il selvaggio”, dovrà ricordare che a finanziare il progetto ha contribuito Martin Scorsese.
Quella sporca ultima meta: Dunkirk
I tamtam mediatici sono duri a morire. A testimoniarlo, negli ultimi tempi, il dubbio se l’ultimo film di Sofia Coppola sia degno o meno del suo tentativo di rifare Don Siegel o, cosa più probabile, di prenderlo solo in prestito per proseguire un discorso personale. E più intenso è il coro di voci per il sequel di “Blade Runner”: quanto e se fedele allo spirito, solo il tempo lo dirà. A più di un mese di distanza dalla sua uscita, è il momento di un primo bilancio sul caso cinematografico d’inizio stagione: decimo lungometraggio dell’inglese Christopher Nolan, sull’epica evacuazione militare dell’ultimo conflitto mondiale, “Dunkirk” è un magniloquente spettacolo, almeno se lo si guarda come puro intrattenimento. Dopodiché, si può condividere l’opinione di chi afferma che l’autore di “Inception” e di “Interstellar” abbia dato il suo meglio in precedenti occasioni, e in quest’ultimo lavoro si sceglie un paradigma narrativo che, nell’ambito della ricostruzione storica, non si discosta dai noti cliché di genere bellico. Né qualche voce illustre della critica, da par suo, ha perso occasione per l’ennesimo parere dissonante, asserendo che la messinscena di topoi già visti in pellicole dimenticate, meno note e più sincere, si coniuga all’errore dell’ambizione, e sconfini in quella tracotanza insita già nell’anglofona storpiatura della spiaggia che intitola il film. Lungi dal fomentare la polemica: ne risentirebbe lo scopo all’origine, stritolato dall’ineffabile macchina pubblicitaria.
“Dunkirk” è apparso a chi scrive un match agonistico vestito da prodotto di genere, con tutti i crismi, pregi, limiti che i film di guerra restituiscono in stile patriottico. Lo comprova la figura di un uomo di mezz’età al timone di un’imbarcazione da diporto, atta a soccorrere le migliaia di ragazzi allo sbaraglio; aiutato dal figlio e da un amico di questi in cerca dell’atto eroico di una vita irriconoscente, l’uomo non arretra a fronte di un gesto da cui dipende l’esistenza di qualcuno. Si può convenire con gli aficionados di Nolan nell’affermare che altrove il suo talento si mostra con maggior incisività. Ma non si può negare che il mix di ingredienti arrivi allo scopo, meticolosamente studiato secondo unità narrative che s’intersecano, seguendo uno sviluppo volutamente non lineare, si tratti di una colonna musicale roboante o di una temporalità scandita dalle didascalie a inizio film, ch’è la bussola d’orientamento per un’estenuante posta in gioco. Dalla vasta spiaggia francese al lungo molo nell’oceano, terra, mare e cielo fungono da location complementari e convergenti: stratificazioni di una gigantesca scacchiera volta a permettere, a chi vi si trova invischiato, di resistere a un nemico invisibile ma presente. Un’ora è il tempo di volo dei caccia inglesi che devono arrivare sul posto, sperando che il poco carburante a disposizione lo renda possibile; una giornata è l’arco in cui la barca compie il suo tragitto, e una settimana la durata storica dell’evento. Al centro si distingue la figura di un soldatino, Tommy, una faccia che ricorda quella di un giovane Tom Courtenay, la cui funzione è quasi sempre di spartiacque teso a sedare l’incessante climax di paranoia insinuatosi tra i compagni (nello scafo che li raduna, prima di esser mitragliato da colpi che rischiano di affondarlo, s’insinua il sospetto che un soldato taciturno sia tedesco, e nell’incipit Tommy cerca di farsi riconoscere come inglese e alleato da sospettosi soldati francesi). Primi passi scomposti nelle strade della città sotto il mirino del fuoco, poi in corsa verso la spiaggia, Tommy è una minuscola figura di cui, al pari degli altri, si percepisce appena il nome, mentre i dialoghi malapena si comprendono in un fracasso di bombe e aerei che fomenta la tensione. Chiunque è visto con ostilità, la fobia fa compiere gesti involontari che trasformano la morte in un ennesimo sacrificio destinato alla gloria. Totali e campi smisuratamente lunghi si alternano a segmenti in cui spazi ristretti restituiscono l’idea del claustrofobico e dell’oppressivo, comprimendo l’istante, dilatando l’inquietudine, rimescolando le carte ogni volta. Montaggio e suono, per i quali “Dunkirk” potrebbe concorrere ai prossimi Oscar, sono i reali protagonisti di un’opera incentrata su un senso dell’attesa di volta in volta crescente, sul tentativo di scampare alla tragedia, reso impervio in qualunque momento da incalcolabili imprevisti (quell’asse di legno tra due imbarcazioni a rischio di spezzarsi, da cui giocoforza transitare per il trasporto di un ferito). E sull’ottimismo non meno ineludibile di chi, attendendo l’arrivo di navi e aerei britannici che sottraggano i superstiti al fuoco tedesco, sino all’ultimo spera che abbia luogo il touchdown: uscire dall’inferno ed essere ricondotti a un’eguale libertà. Non si contano i segmenti da cardiopalma, in un action movie sobrio dove non si può non palpitare per un aviatore precipitato in mare col velivolo, che disperatamente tenta di rompere il vetro per non annegare. Il coming home di chi sopravvive dipende dal sacrificio di altri, e se il nemico è reso udibile da colpi incessanti, eccolo appostarsi, sfocato, nei fotogrammi conclusivi, dietro uno degli aviatori inglesi di fronte al motore da lui dato alle fiamme. Al rimpatrio il compito di sancire la temporanea ritirata, salutata da cori di festa, che presto farà degli scampati volti nella folla che la guerra renderà di nuovo indistinguibili. Come Nolan fa coi pochi nomi illustri nel cast, da Kenneth Branagh a Tom Hardy.
HAPPY END e MONDO ZÀ
di Tullio Masoni
HAPPY END di Michael Haneke
Ho spesso ammirato il regista austriaco, in particolare per “Benny’s video” del 1992 (uno dei film più duri e giusti sull’adolescenza degli ultimi vent’anni, ancora inedito in Italia credo) “Funny Games” del 1997, e la sua replica “a specchio” di dieci anni dopo, “Il nastro bianco” del 2009, e “Amour” del 2012. Un autore calato nelle brutalità soprattutto private dell’occidente odierno (e delle sue radici) e in un pessimismo che, al di là di qualche compiacenza forse inevitabile, è difficile contestare. Almeno da chi abbia un minimo di coscienza delle istigazioni che una società prigioniera di rapporti febbrilmente veicolati dalla tecnologia compie sul “male di vivere” di grandi masse.
In “Happy End”, un titolo a dir poco sarcastico, Haneke ricorre alla frantumazione narrativa già collaudata – cioè a un calibrato straniamento fenomenologico – per operare su due piani: da una parte lo spaccato socio-famigliare nel quale ancora una adolescente fa saltare il meccanismo con la complicità più o meno esplicita del nonno, dall’altra l’autocoscienza sul mezzo-cinema. Il regista prende atto di un fenomeno in espansione irresistibile, ossia della moltiplicazione di schermi e formati che raccontano la vita delle persone spiandola: il cellulare nei titoli di testa, poi i computer mediante i quali, paradossalmente, la parola sostituisce l’immagine per scambi erotici segreti e compulsivi…Tutto questo, e altro, nell’involucro dello schermo cinematografico di sala che, in ultima istanza, viene “destituito”, cioè fatalmente corroso. La crisi come l’aveva definita Godard, ammettendo che il cinema non è più uno e diventa un audiovisivo fra gli altri, si compie dopo una lunga e pur rapida incubazione.
 Sull’altro piano, cioè quello della storia socio-famigliare, Haneke recupera e parzialmente dà seguito ad “Amour” attraverso l’inimitabile Trintignant. Ma la bravura dell’attore, e la verità che in quanto tale comunica, non bastano a salvare il film dal suo eccesso. Intendo dire che è difficile esercitare la crudeltà – quando la si ritiene espressivamente necessaria – senza un adeguato equilibrio. In altri termini non vale, neanche artisticamente, che in un’ora e mezza si concentrino incidenti, disgrazie familiari, fallimenti d’impresa, morti sul lavoro a causa della speculazione, suicidi compiuti o tentati, in un numero così elevato da far perdere il conto. Un eccesso che, a mio avviso, compromette ogni pessimistica necessità; una materia che impazzisce fino a indurre il sospetto di falso.
Sull’altro piano, cioè quello della storia socio-famigliare, Haneke recupera e parzialmente dà seguito ad “Amour” attraverso l’inimitabile Trintignant. Ma la bravura dell’attore, e la verità che in quanto tale comunica, non bastano a salvare il film dal suo eccesso. Intendo dire che è difficile esercitare la crudeltà – quando la si ritiene espressivamente necessaria – senza un adeguato equilibrio. In altri termini non vale, neanche artisticamente, che in un’ora e mezza si concentrino incidenti, disgrazie familiari, fallimenti d’impresa, morti sul lavoro a causa della speculazione, suicidi compiuti o tentati, in un numero così elevato da far perdere il conto. Un eccesso che, a mio avviso, compromette ogni pessimistica necessità; una materia che impazzisce fino a indurre il sospetto di falso.
MONDO ZA’ di Gianfranco Pannone
La golena è allagata: acqua piatta come un vetro. Dal fascio dei pioppi immobili e riflessi, cadono ogni tanto foglie gialle, le ultime d’autunno. Così si apre il film di Gianfranco Pannone: una lunga inquadratura nella luce slavata; la luce del luogo, della Bassa. Per tutto il film questa luce dominerà, assorbendo le nebbie, la polvere del secco estivo e i vapori.
“Mondo Zà”: che significa? Un nuovo ritratto del grande luzzarese? No, non proprio. Con la collaborazione di Nico Cerrato e Primo Giroldini – e la produzione di Effettonotte con Poligraphic – Pannone mette assieme il lavoro di tre anni, sceglie i testimoni per farne personaggi: un pittore naif, un fotografo, alcuni militanti del Partito Comunista, massaie di talento anche nella vita sociale… e, inseguendo la memoria di Zavattini, si lascia conquistare da una regione nella regione – meglio sarebbe usare il plurale: Emilia e Lombardia di confine – cioè da “un mondo nel mondo”. Il segno di Zavattini è ovviamente forte, la sua voce funge talvolta da commento fuori campo, il suo busto campeggia nella sede della Fondazione a lui dedicata a Luzzara, mentre brani di documentari d’epoca (sia in bn che a colori) lo rendono vivo e presente. Ma, dicevo, ciò che interessa di più al regista e ai suoi collaboratori è la vita di resistenza che anima le sponde del Po e gli immediati retroterra. Resistenza in che senso? In quello proprio e ufficiale, perché nella memoria dei personaggi/testimoni ci sono partigiani e caduti, e in quello che vede ostinarsi presso il fiume violentato persone che si aggirano attorno a relitti, a costruzioni diroccate, a precari luoghi di ritrovo da essi stessi creati (quasi a riscattare il detrito portato dalla corrente e guardare in faccia la rovina) per tornare con la memoria al “passato recente”. Dove fra gli altri si incontra Ligabue, la cui pittura il fotografo spiega con sintesi perfetta: «…le belve erano la sua rabbia…se lo prendevano in giro, lui si arrabbiava e dipingeva le belve…».
 Secondo Prince, un bel giovane immigrato dal Ghana che visita regolarmente la “Fondazione un Paese” coordinata da Simone Terzi, e trae dallo scrittore-sceneggiatore (e tanto altro) motivi per il suo rap morbido e canzoni di suggestiva melodia, Ligabue è un visionario che nell’aspro paesaggio della Bassa indovinò l’Africa.
Secondo Prince, un bel giovane immigrato dal Ghana che visita regolarmente la “Fondazione un Paese” coordinata da Simone Terzi, e trae dallo scrittore-sceneggiatore (e tanto altro) motivi per il suo rap morbido e canzoni di suggestiva melodia, Ligabue è un visionario che nell’aspro paesaggio della Bassa indovinò l’Africa.
La Bassa di cui Pannone si è innamorato, lascia intravedere nella polvere i colorati turbanti degli indiani, famosi da tempo come ottimi bovari; evoca un mondo lavorativo distrutto dall’anarchia industriale e dalle multinazionali, riascolta i suoni della più complessa (cioè semplice) tradizione.
E c’è il Po, che da anni e anni si vorrebbe bonificato – qualcuno parlò di massima risorsa nazionale – e invece soffre di essere quasi ridotto a cloaca, a innaturale habitat del pesce siluro e di chi, arrivando nottetempo coi tir frigoriferi, ne organizza lo smercio nelle zone più buie d’Europa.
Ma anch’esso resiste. Come i pochi – ma ostinati, dicevo, e immortali – che non si rassegnano ad abbandonare le sue acque e le sue rive.
“AGADAH”
di Paolo Vecchi
Di nobile famiglia polacca, diplomatico, consigliere privato dello Zar Alessandro 1°, cosmopolita di formazione illuminista, dapprima vicino ai giacobini, poi loro puntuto critico, fondatore dell’archeologia slava e instancabile voyageur, Jan Potocki tra il 1803 e il 1815 scrive “Manoscritto trovato a Saragozza”. Lo scrive in francese, così come nella lingua di Molière qualche anno prima William Beckford, eccentrico e dissoluto gentiluomo inglese, aveva scritto “Vathek”. Rispetto a quest’altro classico della letteratura fantastica, citato da Poe e amato da Borges, esibisce una sostanziale novità, che risiede nell’organizzazione di tutti gli elementi del racconto in una struttura circolare, ripetitiva, e nella costruzione a scatole cinesi delle vicende, che si inseriscono l’una nell’altra accumulando molteplici livelli narrativi. Come afferma il massimo esegeta di Potocki, Roger Caillois, la storia, pur variata nei particolari, è sempre quella degli amori di un viaggiatore con due sorelle, che lo attirano nel loro letto talvolta sole, talaltra con la madre, con il contrappunto delle apparizioni fantasmatiche, degli scheletri, dei castighi soprannaturali. Questa circolarità, in cui vengono a confrontarsi culture e religioni diverse, potrebbe essere letta, ci pare non senza fondamento, come volontà di giustapporre cristianesimo, ebraismo e islamismo visti dall’alto dell’ironìa paradossale di un laico figlio del “secolo dei lumi”.
Di “Manoscritto trovato a Saragozza” esiste una prima versione cinematografica, diretta nel 1964 da Wojciek Jerzy Has. Nato a Cracovia nel 1925, morto a Lodz nel 2000, il regista é a giusto titolo considerato il terzo grande della sua generazione, insieme ai due Andrzej, il monumentale Wajda e il geniale e sfortunato Munk. A parte il “Manoscritto”, l’unico suo film distribuito nel nostro essai è stato lo straordinario “La clessidra” (1973), tratto da “Le botteghe color cannella” del grande e misconosciuto Bruno Schultz, a conferma dunque dell’interesse per le eccellenze letterarie del suo Paese. Ricomponendo a suo modo il rompicapo di Potocki, Has ha messo in evidenza quanto di più straordinariamente moderno c’è nel romanzo: la magia, la finzione, l’illusione, la realtà e il sogno, in un continuo alternarsi e rincorrersi, con un linguaggio la cui sontuosa classicità può farsi forte, anche, di un notevole budget che ha permesso, ad esempio, di avere come protagonista Zbigniew Cybulski, il cosiddetto James Dean polacco,mitico interprete di “Cenere e diamanti” di Wajda, e di affidare la colonna sonora a Krzysztof Penderecki, cioé uno dei più importanti musicisti tuttora in attività.
“Agadah” è un termine cabalistico che significa narrare. Nell’esergo del suo film Alberto Rondalli cita poi il “Don Chisciotte”: non solo, certo, per Sancho che dismaga in mulini a vento i giganti fantasticati nel delirio del suo padrone, ma anche, ci sembra, con riferimento alla struttura en abyme del capolavoro di Cervantes, dalla quale Potocki stesso ha con ogni probabilità preso spunto. Metalinguismo letterario, dunque, del tutto appropriato visto il testo di partenza.
Meno convincente – ammesso e non concesso che abbia importanza – il rapporto con la versione Has, della quale, pur differenziandosi ovviamente per modalità di messa in scena oltre che per valore del risultato, sposa l’idea di mettere il racconto tra parentesi: la scoperta – di fantasia – del manoscritto da parte di Potocki durante l’assedio di Saragozza diventa infatti la preparazione – reale – del suicidio dello stesso, tramite la pallottola ricavata da una teiera d’argento e fatta benedire prima dell’introduzione nella canna della pistola. Rondalli sposta l’azione dalla Spagna alla Puglia, nei giorni che seguono la battaglia di Bitonto del 1734. Questo gli ha consentito di girare in ambienti naturali di notevole suggestione: le Murge, Ginosa e le Grotte di Castellaneta, ma anche, nella Bergamasca, Santa Maria Maggiore, Almenno, i castelli di Pagazzano e Camozzi Vertova, villa Zanchi di Stezzano, e nel Lazio, la riserva naturale di Monterano, il bosco di Manziana e le cascate di Monte Gelato. Insieme a queste locations tutto sommato abbastanza a portata di mano, accedere al repertorio Tirelli ha poi significato disporre di magnifici costumi, offrendo uno spettacolo di grande eleganza a costi, immaginiamo, tutto sommato ragionevoli. A ulteriore merito di Rondalli, anche sceneggiatore e montatore, quindi autore in toto, l’aver saputo gestire con disinvoltura un racconto complesso fino alla frammentazione. Al quale manca forse solo un filo conduttore, diciamo più convintamente filosofico, che lo sottragga alle insidie dell’illustrazione. Un cast internazionale (l’argentino Pérez Biscayart, gli spagnoli Mollà e Lopez de Ayala) che recita in tre lingue, é irrobustito da alcuni bravi caratteristi italiani (Bucci, Haber) tra i quali spicca Umberto Orsini che, nel ruolo, luciferino in senso stretto, di Belial de Gehenna, pronuncia la battuta, sulla relatività del giusto e dell’ingiusto, che forse più di ogni altra dà il senso del romanzo e di entrambi i film: Due piccolissimi insetti si arrampicavano sulla cima di alcune erbe alte. Uno di loro disse agli altri: ”Vedete quella tigre sdraiata vicino a noi? E’ il più mite degli animali, non ci fa mai del male. La pecora invece é un animale feroce: se ne arrivasse una, ci divorerebbe insieme all’erba che ci serve da asilo. Ma la tigre é giusta, ci vendicherebbe!”.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
L’AMORE CORRE SULLA STRADA –
“I’M IN LOVE WITH MY CAR”
di Marcello Cella
C’è stato un tempo in cui l’automobile era la materializzazione di un sogno di libertà e di fuga da una vita grigia e senza sbocchi, lo strumento per evadere da un mondo chiuso nella ripetizione di stili di vita e modalità di pensiero sempre uguali, spesso legati ad un passato che pesava come un macigno sulla/nella testa di chi faceva del movimento fisico e mentale verso un altrove la propria ragione di vita. Era il tempo del sogno americano che sembrava a portata di mano per chi aveva le chiavi di un’automobile. Era il tempo in cui Bruce Springsteen, nella sua epica canzone “Born to run” del 1975, cantava versi come questi: “Di giorno teniamo duro nelle strade/ di uno sfrenato sogno americano/ Di notte sfrecciamo fra case signorili/ su macchine da suicidio/ Usciti dalle bare di cemento verso l’autostrada 9/ su ruote cromate, motori a iniezione/ correndo sulla linea bianca/ Piccola, questa città ti strappa le ossa dalla schiena/ E’ una trappola mortale, un invito al suicidio/ Dobbiamo fuggire finché siamo giovani/ Perché vagabondi come noi, tesoro,/ sono nati per correre”. Poi il sogno americano si è fermato e si è trasformato in un incubo. Le automobili si sono moltiplicate sempre più fino a intasare quelle grandi strade, le vie di fuga verso quell’ignoto carico di promesse e speranze sempre più irraggiungibili. Il nostro paesaggio urbano si è trasformato in una immensa autostrada sempre piena di automobili ferme in qualche ingorgo o in qualche parcheggio (la nostra automobile passa il 95% della sua vita attiva ferma in un parcheggio). E quello che sembrava il mezzo per fuggire si è trasformato in una gabbia a misura umana che ci impedisce di andare da qualsiasi parte. Un oggetto ingombrante e forse destinato ad una progressiva estinzione.
 Il documentario “I’m in love with my car” dei due giovani cineasti emiliani Michele Mellara e Alessandro Rossi, già ricchi di esperienze creative nel documentario come nel cinema, nella televisione e in teatro, racconta o suggerisce tutto questo. L’opera dei due documentaristi è la storia dell’automobile, di come questo strumento ha cambiato la nostra vita e le nostre città, sempre più città a misura di automobile e non di noi umani, il nostro modo di muoverci e perfino i nostri sensi. In effetti il film, dopo un prologo esilarante, ma anche a suo modo significativo, girato in una classe di una scuola elementare di Bologna in cui i bambini hanno disegnato la loro idea di automobile e la spiegano ai compagni, si divide in cinque parti, ognuna delle quali è dedicata ad uno dei nostri cinque sensi, vista, udito, olfatto, tatto e gusto, e incentrata sul modo in cui l’automobile li ha progressivamente cambiati. Utilizzando filmati pubblicitari d’epoca e interviste a persone che hanno dedicato la vita all’automobile come il pilota Dindo Capello, tre ricercatori dell’ISFTTAR (Michel Berengier, Judicael Picaut, Arnaud Caen) che indagano su nuovi modelli di città e di sostenibilità dell’auto, un designer di automobili di fama internazionale come Chris Bangle e l’antropologo Franco La Cecla, i due filmaker raccontano l’epopea dell’automobile e le trasformazioni psicologiche, antropologiche, culturali e sociali da essa indotte.
Il documentario “I’m in love with my car” dei due giovani cineasti emiliani Michele Mellara e Alessandro Rossi, già ricchi di esperienze creative nel documentario come nel cinema, nella televisione e in teatro, racconta o suggerisce tutto questo. L’opera dei due documentaristi è la storia dell’automobile, di come questo strumento ha cambiato la nostra vita e le nostre città, sempre più città a misura di automobile e non di noi umani, il nostro modo di muoverci e perfino i nostri sensi. In effetti il film, dopo un prologo esilarante, ma anche a suo modo significativo, girato in una classe di una scuola elementare di Bologna in cui i bambini hanno disegnato la loro idea di automobile e la spiegano ai compagni, si divide in cinque parti, ognuna delle quali è dedicata ad uno dei nostri cinque sensi, vista, udito, olfatto, tatto e gusto, e incentrata sul modo in cui l’automobile li ha progressivamente cambiati. Utilizzando filmati pubblicitari d’epoca e interviste a persone che hanno dedicato la vita all’automobile come il pilota Dindo Capello, tre ricercatori dell’ISFTTAR (Michel Berengier, Judicael Picaut, Arnaud Caen) che indagano su nuovi modelli di città e di sostenibilità dell’auto, un designer di automobili di fama internazionale come Chris Bangle e l’antropologo Franco La Cecla, i due filmaker raccontano l’epopea dell’automobile e le trasformazioni psicologiche, antropologiche, culturali e sociali da essa indotte.
Come raccontano nel book di presentazione del film, “la nostra VISTA è occupata da automobili parcheggiate, svincoli autostradali, code di auto in tangenziali o nei boulevard delle periferie. Il nostro GUSTO è cambiato: il rituale quotidiano dei fast-food e dei drive-through ha modificato il nostro rapporto col cibo che sempre più spesso consumiamo sui sedili dell’auto. Quasi non facciamo più caso all’ODORE dei fumi di combustione nelle nostre città, ma sempre più persone sono malate a causa dell’inquinamento atmosferico. Sia che UDIAMO il rumore del traffico dalla nostra macchina, sia che ci lasciamo trasportare dal l’ipnotico rombo dei motori in una gara automobilistica, il suono che produce l’automobile è diventato una fonte di inquinamento acustico. La richiesta di perfezione nello stile e nella forma spinge i designer automobilistici ad innovare costantemente le forme, cercando di creare una speciale connessione tra l’uomo e la macchina. In questo rapporto entra in gioco il TATTO e l’auto diventa un corpo che ci seduce e ci ammalia”.
L’automobile ci ha avvinto in un rapporto talmente stretto da costituire una sorta di “sesto senso”, una specie di facoltà umana aggiunta inconsapevolmente alla nostra natura originaria. “L’automobile” – afferma l’antropologo La Cecla – “fa parte di quel saper fare che costituisce tutti quei meccanismi automatici che noi impariamo e poi dimentichiamo. Camminare fa parte di uno di questi automatismi, di queste tecniche del corpo: come gesticolare, come dormire, come buona parte delle facoltà umane. Allora la cosa impressionante è che guidare è diventata una facoltà, cioè proprio al pari del parlare, del camminare, è diventato una facoltà umana”. Una facoltà/strumento che ci ha permesso di andare ovunque nel mondo, di raggiungere e conoscere i luoghi più lontani e nascosti, di avvicinarci agli altri, di accorciare le distanze fra le nostre diversità o, forse, come suggerisce sempre La Cecla, ci ha fornito solo l’illusione di questo rapporto ravvicinato con il mondo e con gli altri. L’automobile è un oggetto che ha completamente colonizzato anche il nostro immaginario come testimoniano le migliaia di canzoni dedicate ad essa. Per non parlare dei film e di quel ricchissimo genere cinematografico, il road movie, che tanto ci ha fatto sognare mondi lontani, accompagnando le nostre più ingenue utopie di cambiamento e dandoci quell’illusione, così necessaria a noi umani, che tutto sia sempre possibile, che sia possibile fuggire dalla prigione della casa e al tempo stesso portarsela appresso, per poi magari farvi ritorno completamente trasformati.
“L’automobile” – continua La Cecla – “è una casa, però è molto di più di una casa, penso che in qualche modo ti libera dalla casa, è una casa le cui finestre sono aperte al mondo. La cosa che impressiona è che il mondo diventa tutto un paesaggio percorribile, tu vedi le cose, sei in mezzo alle cose, ma comunque le vedi attraverso una finestra. L’automobile da questo punto di vista è anche la mamma della televisione. Perché il parabrezza è una finestra sul mondo. (…) L’automobilista è un flaneur, è qualcuno che ha un rapporto col mondo da fruizione disincantata e distaccata, che ha un rapporto con gli altri nel traffico, che non è un rapporto vero, nel senso che poi le persone le vedi attraverso i vetri, ma non è che hai un rapporto umano, diretto. Tutto questo fa parte anche della costruzione dell’indifferenza, che è anche una delle cifre della modernità, cioè tu sei nel mondo, ma sei indifferente al mondo, e agli altri”. Un’ipotesi inquietante che spiegherebbe molte delle contraddizioni tipiche della nostra epoca, quel senso ambiguo di essere dentro la realtà, ma nel contempo di non riuscire a comprenderla appieno, la contemporaneità di presenza ed estraneità dentro noi stessi, dentro i luoghi in cui viviamo e che percorriamo ogni giorno, dentro il nostro mondo perennemente “visibile”, illuminato a giorno e senza ombre apparenti, ma il cui significato continua a sfuggirci. E forse si spiega anche quel vago senso di nostalgia, come di qualcosa che sta finendo, che pervade sottilmente “I’m in love with my car”. Forse l’automobile con le sue emozioni artificiali, i suoi sogni perduti e i suoi reali incubi sociali, sanitari, economici e culturali è già uno oggetto del passato, qualcosa da consegnare alla storia, mentre i giovani umani che vivono e attraversano oggi le nostre città accarezzano sogni di fuga e di cambiamento completamente diversi, realizzabili con strumenti più maneggevoli come uno smartphone. Anche se ugualmente illusori nell’idea di colmare distanze e coltivare rapporti nuovi e più ricchi di significato. Forse solo nuovi strumenti per coltivare l’umana indifferenza al mondo e sfamare nuovi incubi, in fondo così simili a quelli prefigurati in un’altra famosa canzone “automobilistica” del 1979, “Highway to hell”, della band americana AC DC: “Vivo tranquillamente, amo liberamente/ abbonato per una corsa di sola andata/ (…) Non ci sono segnali di stop o limiti di velocità/ nessuno riuscirà a farmi rallentare/ (…) Hey mamma, guardami,/ sono sulla mia strada per la terra promessa/ Sono sull’autostrada per l’inferno”.
 I’m in love with my car
I’m in love with my car
Regia, soggetto e sceneggiatura: Michele Mellara, Alessandro Rossi
Fotografia: Michele Mellara
Montaggio: Marco Duretti, Michele Mellara, Alessandro Rossi
Musica originale: Nicola Bagnoli
Suono: Alessandro Rossi
Operatori: Michele Mellara, Francesco Merini, Umberto Romagnoli, Marco Cavalli
Produttore: Ilaria Malagutti
Produzione: Mammut Film srl con il supporto di programma Media della Comunità Europea, il contributo del Fondo Audiovisivo della Regione Emilia Romagna ed il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e della Regione Piemonte
Nazionalità: Italia
Anno: 2017
Durata: 72 minuti
QUALITA’ IN SERIE
a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
I KENNEDY (la serie)
di Luisa Ceretto
Da un’idea di: Stephen Kronish e Joel Surnow
Titolo originale: The Kennedys
Regia: Jon Casar
Sceneggiatore: Stephen Kronish
Interpreti: Greg Kinnear (John Fitzgerald Kennedy), Katie Holmes (Jackie Kennedy), Barry Pepper (Robert Kennedy), Kristin Booth (Eithel K.), Diana Hardcastle (Rose Kennedy, la madre), Tom Wilkinson (Joseph Kennedy, il patriarca)
Fotografia: David Moxness
Montaggio: David B. Thompson, Don Cassidy
Scenografia: Rocco Matteo
Origine: Stati Uniti, Canada, 2011
1° puntata: Le grandi aspettative di un padre
2° puntata: Vittorie condivise, lotte intestine
3° puntata: Invasioni fallite, promesse mancate
4° puntata: Promesse infrante e barriere letali
5° puntata: Questioni morali e fermenti interni
6° puntata: Sull’orlo della guerra
7° puntata: L’inevitabile si avvicina
8° puntata: L’epilogo
I mille giorni di presidenza di JFK in epoca di Guerra Fredda sono stati segnati da eventi che costituiscono pagine importanti della Storia: lo sbarco nella Baia dei Porci, la crisi missilistica a Cuba, la costruzione del Muro di Berlino, la conquista dello spazio, l’inizio della Guerra del Vietnam e l’affermarsi del movimento per i diritti civili degli Afroamericani, fino al tragico epilogo, l’assassinio a Dallas. La serie ha inizio con l’ultimo giorno delle elezioni, prima della nomina di JFK a presidente degli Stati Uniti. La narrazione va indietro nel tempo, a quando il giovane John Fitzgerald è dato per disperso, nel corso del conflitto bellico. Il fratello maggiore, Joseph, è nell’aviazione, è lui che dovrà, secondo il volere del padre, candidarsi a presidente degli Stati Uniti, una volta terminata la guerra; purtroppo, il suo aereo viene abbattuto nel 1944. Toccherà quindi a John Fitzgerald dare inizio alla scalata al potere…
Presentata di recente sugli schermi di Sky, gli otto episodi della miniserie, “I Kennedy”, costituiscono un’ulteriore conferma della crescente attenzione da parte del mondo della settima arte verso il piccolo schermo. Ma soprattutto di quanto la Storia e le sue molteplici pagine, più o meno note, rappresentano una forte inesauribile di ispirazione, tanto più quando si intrecciano coi percorsi personali, con le biografie di figure carismatiche come la famiglia Kennedy, per lo spirito liberal che ha segnato fortemente il governo di JFK nei primissimi anni sessanta.
I Kennedy costituiscono ancora oggi un mito, un punto di riferimento per più generazioni, sono ricordati per eleganza, stile, determinazione, lealtà, ma anche per i tradimenti, le tragedie e i dolori che ne hanno contraddistinto il cammino.
Sono numerosi gli attori e le attrici che hanno calzato i panni di JFK e di Jacqueline Kennedy, così come i registi che si sono cimentati nel raccontare l’ascesa del trentacinquesimo presidente americano. Pellicole di finzione, così come documentari che ne ripercorrono anche solo l’ultimo tragico giorno, la parata per le vie di Dallas: tra le più recenti versioni per il grande schermo, la rilettura di Pablo Larraìn in “Jackie” è sicuramente tra le più interessanti e inedite. Nel film, difatti, l’asse della narrazione è spostato, la vicenda è raccontata dal punto di vista della first lady, testimone, suo malgrado, di quell’assassinio.
 Dopo la presentazione in chiaro nel 2011 su La7, ritorna la serie dei “Kennedy”, sugli schermi, come dicevamo, di Sky. Firmata da Jon Casar, la serie televisiva, pur riprendendo i fatti salienti che hanno costituito la presidenza di JFK, si sofferma sulla vita privata dei singoli componenti familiari. Il racconto ripercorre le prime tappe della carriera politica di John Fitzgerald, del suo incontro con Jackie, così pure della sua chiacchierata infedeltà. Per poi tratteggiare con una certa accuratezza le relazioni con gli altri fratelli e in particolare con la figura paterna, influente e carismatica. Commissionata e poi rifiutata da History Channel, l’uscita della serie è stata preceduta da un anno di polemiche, accese critiche da parte di storici, del resto pensare di realizzare una fiction storica, di portare sul piccolo schermo un docu-drama sui Kennedy era di per sé un azzardo. Eppure un’impresa che sul piano filmico sembra comunque riuscita, a partire dalla scelta dei protagonisti, Greg Kinnear e Katie Holmes sono perfetti nei panni di JFK e di Jackie ma più in generale dell’intero cast. Girata a Toronto tra il giugno e il settembre 2010, tra i pregi della serie va sicuramente segnalata l’accuratezza nella ricostruzione degli anni ’60 nei minimi dettagli, che ha impegnato centinaia di professionisti per diversi mesi di lavoro, dal design delle case, alla scelta delle auto, al trucco dei personaggi.
Dopo la presentazione in chiaro nel 2011 su La7, ritorna la serie dei “Kennedy”, sugli schermi, come dicevamo, di Sky. Firmata da Jon Casar, la serie televisiva, pur riprendendo i fatti salienti che hanno costituito la presidenza di JFK, si sofferma sulla vita privata dei singoli componenti familiari. Il racconto ripercorre le prime tappe della carriera politica di John Fitzgerald, del suo incontro con Jackie, così pure della sua chiacchierata infedeltà. Per poi tratteggiare con una certa accuratezza le relazioni con gli altri fratelli e in particolare con la figura paterna, influente e carismatica. Commissionata e poi rifiutata da History Channel, l’uscita della serie è stata preceduta da un anno di polemiche, accese critiche da parte di storici, del resto pensare di realizzare una fiction storica, di portare sul piccolo schermo un docu-drama sui Kennedy era di per sé un azzardo. Eppure un’impresa che sul piano filmico sembra comunque riuscita, a partire dalla scelta dei protagonisti, Greg Kinnear e Katie Holmes sono perfetti nei panni di JFK e di Jackie ma più in generale dell’intero cast. Girata a Toronto tra il giugno e il settembre 2010, tra i pregi della serie va sicuramente segnalata l’accuratezza nella ricostruzione degli anni ’60 nei minimi dettagli, che ha impegnato centinaia di professionisti per diversi mesi di lavoro, dal design delle case, alla scelta delle auto, al trucco dei personaggi.
Tra i difensori della serie, ricordiamo Oliver Stone, autore di film dedicati a tre presidenti americani, a JFK, a Nixon e a Bush: “A un certo punto – ha dichiarato Stone – devi lasciarti dietro le spalle il materiale storico ed entrare nel mondo della creatività drammatica, usare l’intuizione per riempire i vuoti di conoscenza, immaginare ciò che fu detto nei momenti in cui non c’era nessuno per documentare gli eventi”.
PANORAMA LIBRI
a cura di Paolo Micalizzi
 BREVE MA VERIDICA STORIA DEL DOCUMENTARIO
BREVE MA VERIDICA STORIA DEL DOCUMENTARIO
di Adriano Aprà
“Falsopiano editore”, 2017
pagg. 284, Euro 18
Raccoglie, con il sottotitolo di “Dal cinema del reale alla nonfiction”, una serie di saggi sul documentario, scritti in varie circostanze, che riguardano l’Italia e l’Estero. E in questa occasione, Adrano Aprà, riflette sul termine documentario che secondo lui oggi bisognerebbe definirlo nonfiction perché il documentario più innovativo, almeno negli anni Novanta se non da prima, si allontana sempre più dal cinema del reale e il documentario da oggettivo si fa soggettivo e all’autore che guarda si sostituisce l’autore che si guarda. Cosi il film-saggio, il film autobiografico, la riflessione sul found footage e sul materiale d’archivio diventano la nuova forma del documentario. E tutto ciò, precisa l’autore, non per perdita di fiducia nella realtà ma, forse, per presa di coscienza che il cinema non riflette la realtà ma la media attraverso uno sguardo che sempre più si fa carico delle proprie responsabilità nei confronti dello spettatore. Per giungere a concludere che il nuovo del documentario , o meglio della nonfiction, è il campo d’esplorazione del cinema del nuovo millennio. E’ interessante quindi leggere questo volume alla luce delle considerazioni fatte dall’autore, per inquadrane meglio la validità nell’ambito della Storia del Cinema. Il volume esce per iniziativa di “Cinemazero” che lo ha pubblicato, a cura di Fabio Francione, in occasione di “Le voci dell’inchiesta” 2017.
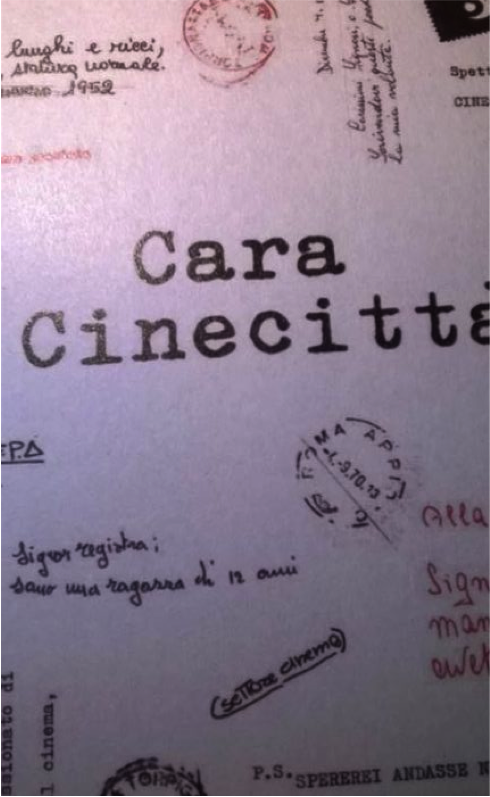 CARA CINECITTA’
CARA CINECITTA’
a cura di Giancarlo Di Gregorio
Pagg.96,s.i.p
E’ un supplemento al n.34 di 8 1/2., relativo a “Numeri, visioni e prospettive del cinema italiano”. Un volume pubblicato in occasione dell’ottantesimo compleanno di Cinecittà che, come sottolinea Giancarlo Di Gregorio nella sua presentazione, contiene un centinaio di lettere di gente comune indirizzate agli studios di Cinecittà. Un “piccolo tesoro”, come lo definisce, che ha scoperto un giorno in un scatolone, guardato per curiosità, che giaceva nell’ex ufficio di Franco Mariotti, allora addetto stampa di quell’Ente. Cinecittà, appunto, dove tutti, come afferma Nicola Guaglianone, possono essere cittadini senza bisogno di passaporti o permessi di soggiorno perché il cinema cancella i confini e le frontiere e rende tutti uguali, accomunati dal desiderio di realizzare lo stesso sogno. Come è successo a lui che è entrato da comparsa ed è diventato poi sceneggiatore, ma ha vissuto sul set per anni come tanti, ed era l’unico posto in cui volevano stare e non lo avrebbero barattato per nessuna cosa al mondo e per il quale farebbero, come per un amante qualsiasi pazzia pur di poter dire “Ho fatto un film”. Scorrendo le lettere pubblicate nel volume si possono cogliere i sogni di tanti ragazzi che inviavano le proprie foto perché volevano fare western o, perché i propri compagni dicevano che sapevano far ridere, e ragazze perché dicevano di somigliare a Romina Power o ammiravano Sofia Loren. O, ancora perché avevano già fatto i generici oppure volevano far pervenire un loro manoscritto a Vittorio De Sica. Tante le motivazioni che li inducevano a scrivere a Cinecittà. Soprattutto, gente del Sud. Ed in tutti c’era la speranza di potercela fare.
 OVOSODO.LA SCENEGGIATURA DI VIRZI’, BRUNI E SCARPELLI
OVOSODO.LA SCENEGGIATURA DI VIRZI’, BRUNI E SCARPELLI
di Massimo Ghirlanda – Federico Govoni
Edizioni Erasmo,2017
Pagg. 406, Euro 20
E’ un volume della Collana “I quaderni di Storia del cinema” del Centro Studi Commedia all’Italiana che è stato pubblicato in occasione del ventennale del film di Paolo Virzì. Contiene uno studio dei due autori sulla genesi della sceneggiatura finale del film. Un’analisi puntuale del testo in cui emerge l’universo artistico di Furio Scarpelli, maestro di Virzì e Bruni, ma al tempo stesso un omaggio all’eredità della commedia all’italiana, l’uso dell’ironia e del sottotesto politico, il confronto con i grandi modelli del romanzo di formazione, partendo da Dickens. Oltre alla pubblicazione della sceneggiatura, il volume comprende degli approfondimenti, tra cui quello di Marco Sisi che sottolinea il rapporto con l’ambientazione livornese e la sua livornesità. Lo completano una biografia di Paolo Virzì, la scheda dl film con i premi ricevuti, ed un’essenziale bibliografia.
.
.
 LA LUCE COME EMOZIONE. CONVERSAZIONE CON GIUSEPPE LANCI
LA LUCE COME EMOZIONE. CONVERSAZIONE CON GIUSEPPE LANCI
di Monica Pollini
Artdigiland, 2017
Pagg. 262, Euro 20,80
Una conversazione , quella della studiosa Monica Pollini con Beppe lanci, un direttore della fotografia dalla pluriennale carriera che, come sottolinea Laura Delli Colli, è erede, secondo il biografo ufficiale dei “ cinematographers” Stefano Masi, di quell’aristocrazia artigianale che discende dal capostipite Tonino Delli Colli, suo zio, alla cui scuola si è formato anche il padre Franco, “ storie della luce che hanno radici ‘antiche’ in quel meraviglioso saper fare che nasceva dalla capacità allora davvero tutta artigianale di costruire sull’intuizione e sul talento”. E Beppe Lanci l’intuizione l’ebbe un pomeriggio ,alla sala Trianon di Roma, di fronte alle immagini di “Rashomon”. Ed oggi, appartiene a quella generazione preziosa che ha unito artigiani e artisti. L’intervista fa piena luce su uno di questi artigiani che attraversa nel vivo del set oltre cinquant’anni del migliore cinema italiano, e non solo, arrivando a soffermarsi sul suo insegnamento e lo scambio con i giovani al Centro Sperimentale. Arricchiscono il volume testimonianze d registi come Marco Bellocchio, con il quale Beppe Lanci ha avuto un importante sodalizio e colleghi d’oggi, suoi allievi al CSC ma anche un maestro del montaggio come Roberto Perpignani che afferma che “ nella fotografia di Lanci vedo la cultura, la cultura visiva” e la scrittrice Susanna Tamaro con la quale ha realizzato il film “Nel mio amore”. Importante anche la filmografia e l’elenco dei premi e riconoscimenti ricevuti.
AUTORI
CREDITS
Carte di Cinema 15
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com )
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 15 della rivista online: Vittorio Boarini, Pio Bruno, Marcello Cella, Luisa Ceretto, Federico Felloni, Mario Giunco, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Giorgia Pizzirani, Paolo Vecchi, Marco I. Zambelli, Giancarlo Zappoli.




















































