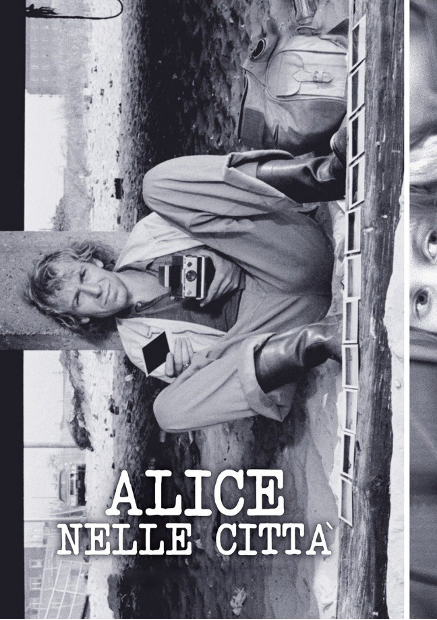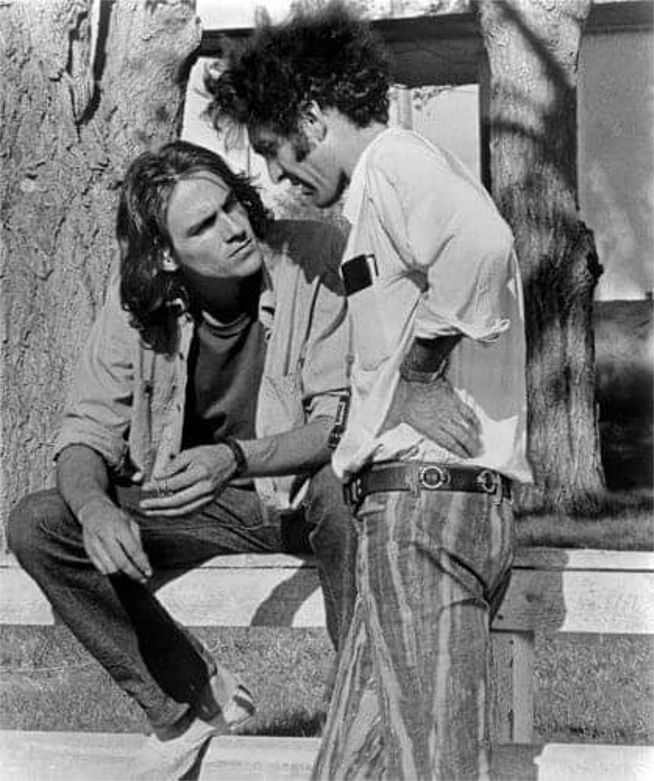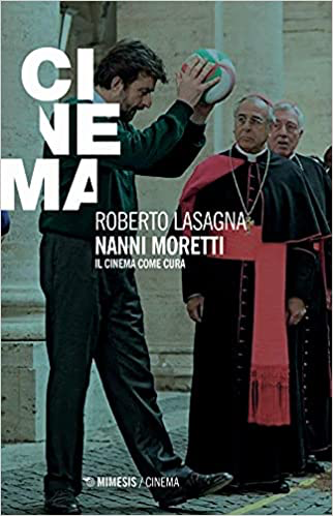Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 3.1 I FILM COMPILATION (O FILM DI MONTAGGIO), TRA PRODOTTI COMMERCIALI E OPERE ARTISTICHE di Roberto Baldassarre
- 3.2 PETER DEL MONTE: LETTERA CONTROVENTO di Francesco Saverio Marzaduri
- 3.3 ELOGIO DELL’UOMO LAICO “L’ora di religione” di Marco Bellocchio di Danilo Amione
- 3.4 VAMPIRI, POETI E ZOMBIE NEL NUOVO CINEMA DI JIM JARMUSCH di Roberto Lasagna
- 3.5 L’AMERICA NEL CINEMA POLIZIESCO DI GUGLIELMO GIANNINI di Mario Galeotti
- 3.6 PANDEMIA E OLTRE: STATICITÀ E MOVIMENTO NELLE USCITE CINEMATOGRAFICHE POST LOCKDOWN di Paola Brunetta
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 6 OCCHIO CRITICO
- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 8 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 9 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
IL NUOVO CINEMA TEDESCO di Marino Demata
Il saggio esamina la genesi e lo sviluppo di quel fenomeno cinematografico chiamato “il nuovo cinema tedesco”, innanzitutto nei suoi aspetti più che di unicità che di originalità. Infatti, rispetto al rinnovamento del cinema francese con la Nouvelle Vague, e di quello inglese con il “Free cinema” e del Nuovo cinema americano di New York, per il cinema tedesco si è trattato di una vera e propria rifondazione o rinascita in Paese dove, per gli Autori, si trattava di “creare” dal nulla. Lì “il cinema non esiste”, come affermò uno dei fondatori del movimento, Volker Schlondorff.
Il saggio ripercorre le tappe salienti di questa vera e propria (ri)nascita del cinema in Germania, partendo dall’evento cruciale del Festival dei film corti di Oberahusen del 1962, dove un gruppo di cineasti pubblicò un manifesto-appello per la rinascita del cinema in Germania.
Il saggio ripercorre le faticose tappe di questa rinascita, le lotte nei confronti di un governo prono solo alle richieste delle società importatrici del cinema americano.
Una volta affermatosi il nuovo gruppo di cineasti, molto variegato e con grandi individualità e molto numeroso, resta solo l’imbarazzo della scelta per chi, come noi, vuole tratteggiare i caratteri salienti del movimento. Pertanto, il saggio si sviluppa partendo dalla scelta di alcune grandi personalità che diedero lustro al movimento con i loro film: lo stesso Volker Schlondorff. Herzog, Wenders (di cui si esamina analiticamente la filmografia fino a Paris Texas), Fassbinder (il più amato dai tedeschi), le cineaste come Helke Sander e la Von Trotta. Il saggio si chiude con la riscoperta di un Autore troppo presto dimenticato e accantonato, come il brillante ed eclettico Roland Klick.
MONTE HELLMAN: CINEMA A DOPPIA CORSIA di Francesco Saverio Marzaduri
Ritratto di un maestro della produzione indipendente, entrato nella storia del cinema dalla porta di servizio, rivelando un talento originale ancora misconosciuto in lavori di basso costo e antispettacolari improntati a un grande rigore espressivo.
SAGGI
I FILM COMPILATION (O FILM DI MONTAGGIO), TRA PRODOTTI COMMERCIALI E OPERE ARTISTICHE di Roberto Baldassarre
Excursus sul concetto di “film compilation” (o “film di montaggio”), che si distinguono nettamente da “film episodici”, sebbene siano strutturati in modo simile. Usualmente le “compilation filmiche” possono essere prodotti di consumo commerciale, ma ci sono anche alcune opere artistiche che hanno sfruttato questa tipologia di montaggio.
PETER DEL MONTE: LETTERA CONTROVENTO di Francesco Saverio Marzaduri
Un ricordo di Peter Del Monte che ripercorre, in forma di missiva, temi e spunti della sua filmografia.
ELOGIO DELL’UOMO LAICO di Danilo Amione
I temi della famiglia, della laicità, della cultura borghese e della libertà individuale e
collettiva sono da sempre i punti cardini del cinema di Marco Bellocchio. La vicenda
di Ernesto Picciafuoco, un coinvolgente Sergio Castellitto, diventa sintesi di una
visione del mondo improntata sul primato della libera scelta dinnanzi agli “obblighi”
che la società organizzata ci riserva. La fantasia del suo lavoro (è un illustratore di
favole per bambini), insieme simbolo e metafora, ci indica il protagonista come un
antagonista e un non riconciliato all’interno di un nucleo borghese stretto in un
cerchio soffocante e inevitabilmente chiuso a ogni cambiamento. Il finale, sofferto e
travagliato, guida lo spettatore in una prospettiva che è insieme umana e “politica”.
VAMPIRI, POETI E ZOMBIE NEL NUOVO CINEMA DI JIM JARMUSCH di Roberto Lasagna
L’ultimo cinema di Jim Jarmusch è un viaggio tra non-morti e poeti-fantasma: vampiri e zombi partecipano alla riflessione sugli ideali di bellezza e sull’interiorità messa sotto scacco dalla decadenza del mondo.
L’AMERICA NEL CINEMA POLIZIESCO DI GUGLIELMO GIANNINI di Mario Galeotti
Guglielmo Giannini, nato a Pozzuoli nel 1891 e scomparso a Roma nel 1960, è stato senza dubbio una figura eclettica nel panorama culturale e mediatico italiano, dagli anni Venti al secondo dopoguerra: giornalista, drammaturgo, sceneggiatore, regista teatrale, regista cinematografico e alla fine della seconda guerra mondiale anche uomo politico. In particolare Giannini è conosciuto soprattutto come rappresentante di un genere poliziesco importato dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Esaminando alcuni film di cui Giannini ha curato la regia e la sceneggiatura tra gli anni Trenta e Quaranta (“Grattacieli”, “L’anonima Roylott”, “Joe il rosso”) vedremo come queste pellicole abbiano avuto un ruolo non secondario in quel gioco altalenante tra demolizione del mito americano e irresistibile attrazione per alcune delle moderne forme dello stesso mito nell’Italia del ventennio fascista, inserendosi non solo nel panorama del film poliziesco italiano di quegli anni ma almeno in parte anche in quella galleria di bizzarre rappresentazioni di vita americana che, soprattutto in tono di commedia, hanno occupato uno spazio non trascurabile all’interno della produzione cinematografica dell’epoca. Si tratta, come avremo modo di dimostrare, di un piccolo ma significativo tassello nella storia culturale delle relazioni euro-atlantiche e, nello specifico, nella storia alquanto contraddittoria dell’immagine dell’America divulgata durante il fascismo.
PANDEMIA E OLTRE: STATICITÀ E MOVIMENTO NELLE USCITE CINEMATOGRAFICHE POST LOCKDOWN di Paola Brunetta
Il 26 aprile hanno riaperto le sale cinematografiche in Italia dopo un periodo in cui tutto è stato fermo, piattaforme digitali a parte; naturale quindi, dovendo isolare un tema, concentrarsi sul rapporto tra staticità e movimento, riflessione ed energia pulsante, a partire dall’immobilità che noi tutti, e anche il cinema nei suoi vari aspetti, abbiamo subito in questa seconda fase di chiusura delle sale.
Il presente saggio andrà a considerare, in termini impressionistici piuttosto che “razionali”, alcuni film che, tra quelli usciti dal 26 aprile ad oggi (giugno 2021), meglio rappresentano l’energia e il movimento del corpo, quindi anche dell’anima, e altri che rappresentano invece l’immobilità collegata, o collegabile, al tempo di pandemia che stiamo vivendo. Film che veicolano gioia, energia, passione… fisicità, sensualità… film da gustare, appunto, con i sensi aperti piuttosto che intellettualmente, anche per le atmosfere che creano, per i “mondi” in cui fanno entrare; e film che, al contrario, rappresentano la staticità, il silenzio, la chiusura anche solo per una scena, un aspetto, un elemento.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
INIZIATIVE IMPORTANTI AL 71. ITALIA FILM FEDIC di Paolo Micalizzi
Autori ed ospiti importanti al Festival di Montecatini Terme, manifestazione storica della Federazione Italiana dei Cineclub sin dal 1950 che da due anni la Fedic gestisce direttamente con il coinvolgimento di tutti i Cineclub Associati. Cortometraggi e lungometraggi ma anche presentazione di libri, un Focus sulla Cineteca Fedic, un Incontro con il più importante “cartoonist” italiano, Bruno Bozzetto a cui è stato conferito il Premio FEDIC alla carriera ed un Omaggio a Dante.
FESTIVAL ED EVENTI
PESARO 2021 di Paolo Vecchi
Nell’ambito del concorso della 57a Mostra di Pesaro si è scelto di attribuire pari dignità a corti e lungometraggi. La giuria ha scelto i dieci minuti del grazioso e spiritoso “Un bananero no es casualidid” dell’argentina Luiza Gonçalves. Ma il giudizio fa torto a “What Do We See When We Look at the Sky”, opera seconda del georgiano Alexandre Koberidze, solo segnalata, poema sinfonico sulla città di Kutaisi la cui dimensione poetico-fantastica rimanda alla grande tradizione dei vari Iosseliani, Abuladze, Shengelaja e Gogoberidze.
IL SATURNIA FILM FESTIVAL HA ANCHE PREMIATO MILENA VUKOTIC E LE DONNE REGISTE di Paolo Micalizzi
Premi e riconoscimenti di un Festival che quest’anno si è articolato in più appuntamenti in alcuni Borghi della Maremma, dove protagonisti sono stati l’attrice Milena Vukotic, le “Mujerese del Cinema” e gli autori della Quarta edizione del “Saturnia Film Festival, presieduto da Antonella Santarelli, di cui vengono segnalati i vincitori.
ALCUNE NOTE SU “IL CINEMA RITROVATO” di Paolo Micalizzi
Un ricchissimo programma di cui l’autore ha seguito, in due giorni, alcuni momenti importanti che qui riferisce. Tra essi, la presentazione del film “Harlem” di Carmine Gallone , di “Giochi di notte” di May Zetterling e di “Gli amori di una spia” con Mirna Loy. Ma anche “La cosa” di Nanni Moretti.
OCCHIO CRITICO
“NONOSTANTE LA NEBBIA” DI GORAN PASKALJEEVC di Tullio Masoni
Un bambino siriano di 8 anni, Mohammed, viene abbandonato sulla strada da un amico più grande. E’ raccolto da Paolo, che se lo porta a casa. Paolo e la moglie Valentina hanno da poco perso un figlio; Mohammed potrebbe sostituirlo, ma ci sono troppe, prevedibili difficoltà.
DUE OSCAR: “UN ALTRO GIRO” DI THOMAS VINTERBERG; “MINARI” DI LEE ISAC CHUNG di Paolo Vecchi
Rispetto ai numerosi film sull’etilismo,l’originalità di “Un altro giro” di Thomas Vinterberg consiste nel fatto che l’alcol apre davvero una fase tutto sommato positiva nella vita dei protagonisti. Oscar per il miglior film straniero, è una commedia che possiede un sicuro equilibrio fra tonalità amare e soprassalti comici, momenti convulsi e un tempo che si sospende sulle note della “Fantasia D. 940” di Schubert, un capolavoro che impone fatalmente la propria temperatura emotiva alla narrazione.
Lee Isac Chung è nato a Denver, ma immaginiamo che in “Minari” ci sia più di un elemento autobiografico, vista la sua condizione di immigrato della seconda generazione. Anche per chi è approdato in America negli anni della presidenza Reagan il sogno è quello, eterno quanto troppo spesso illusorio, dell’ascensore sociale. In un film che con il pudore dell’ellissi insiste su elementi simbolici crudeli, Soon-ja, la vecchia nonna, rappresenta l’elemento di giuntura tra situazioni così distanti, oltre che custode di una memoria che solo la pratica della tradizione è destinata a preservare.
THE BOYS: IT’S ONLY ROCK AND ROLL BUT I LIKE IT di Marco Incerti Zambelli
Davide Ferrario confeziona, per il suo ritorno alla fiction, una godibile commedia agrodolce a tempo di rock tra nostalgia ed ironia.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
VIAGGIATORI INVISIBILI. NO BORDERS. FLUSSO DI COSCIENZA DI MAURO CAPUTO di Marcello Cella
Il documentario del cineasta friulano racconta, aggirandosi lungo i sentieri sul confine tra Italia e Slovenia, il dramma dei migranti che entrano in Europa attraverso la rotta balcanica.
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
Segnalazione – recensione di volumi su “Harlem” di Carmine Gallone, Chaplin, Nanni Moretti e Lino Banfi.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
IL NUOVO CINEMA TEDESCO
di Marino Demata
“Andrò a fare cinema nel mio Paese, dove non esiste”.
1961. Chi pronuncia queste parole è un promettente aiuto regista tedesco, Volker Schlondorff. Siamo a Parigi e il giovane Volker è entusiasta di lavorare con grandi Autori della Nouvelle Vague del calibro di Luis Malle e Alain Resnais. Ma esprime queste amare parole nel corso di un’intervista rilasciata al redattore di una grande istituzione parigina, Les cahiers du cinema, vera e propria sede di apprendistato di tutti i giovani talenti della Nouvelle Vague. Essi sono passati attraverso l’esperienza critica, e, in certo senso, didattica della rivista in sé, ma soprattutto dell’ambiente che gravitava attorno ad essa e attorno al suo leader indiscusso Andrè Bazin.
Un articolo di Bazin sui Cahiers, oppure una discussione con lui, valeva di più della lettura di cinquanta saggi cinematografici. Si discuteva delle strade che stava imboccando il cinema innovativo e spesso alternativo che si sviluppava in Francia e c’era la consapevolezza che una nuova epoca era già nata e che gli ulteriori sviluppi sarebbero stati grandi ed impensabili. Il tema non era solo il cinema francese. Si discuteva anche di altre cinematografie e in particolare del cinema americano e degli errori della critica di quel Paese, che ha portato alla sopravvalutazione di un tipo di cinema mediocre e, ad esempio, alla bocciatura di un grande regista come Alfred Hitchcock. Questi era generalmente considerato in America come un semplice creatore di film gialli, come ce ne sono tanti. Uno dei tanti meriti dei giovani di Cahiers du cinema è stato quello di aver scoperto la grandezza, spesso del tutto ignota in America, di questo regista. E tanti altri ancora.
Abbiamo citato questo caso a mo’ di esempio. Ma, più in generale, non la cultura francese, ma quella su scala mondiale, è debitrice di tanto ai Cahiers e alla Nouvelle Vague.
Al centro di questo fervore immaginiamo come doveva sentirsi il nostro giovane aiuto regista tedesco. Convivevano in lui due sentimenti: l’eccitazione per un movimento che aveva fatto dell’innovazione il suo cavallo di battaglia, e del quale si sentiva in qualche modo partecipe. E, contemporaneamente, il rammarico e il senso di frustrazione che lo coglievano quando pensava al vuoto assoluto che aveva lasciato nel suo Paese.
Per questo possiamo comprendere l’amarezza della sua risposta, alla domanda del redattore dei Cahiers du cinema. Il Paese dove il cinema non esiste, ovviamente, è la Germania. Dopo aver conosciuto il grande cinema dell’impressionismo e dei grandi autori storici come Fritz Lang, la Germania ha visto ridursi il cinema a strumento del regime nazista e assistito alla fuga dei grandi Autori soprattutto verso l’America.
Tuttavia, se analizziamo bene l’affermazione di Schlondorff, non possiamo non notare che in essa non c’è solo lo sconforto di una realtà che, culturalmente, è come rasa al suolo. In quel verbo iniziale, “Je retournerai…” c’è la ferma determinazione di fare qualcosa in Germania, di dare il proprio contributo di intellettuale e di artista affinché la situazione cambi.
Certo non era facile. Gli ostacoli erano molti. I distributori tedeschi ormai lavoravano con i film americani, e nelle sale delle città tedesche era difficile trovare qualcosa di diverso. I pochi contributi statali andavano a ripianare i deficit di entrambi, distributori e sale. Non erano proprio previsti contributi ad autori tedeschi. Merce diventata sempre più rara col passare del tempo. La critica cinematografica, che a Parigi aveva dato molta soddisfazione a Schlondorff, era quasi inesistente, Per ripartire, il cinema tedesco aveva bisogno del verificarsi di molte circostanze, che non sembravano essere all’orizzonte.
Oberhausen
Oberhausen è una piccola città tedesca di poco più di 200.00 abitanti, situata in una delle zone più densamente popolate d’Europa, a soli 30 km da Düsseldorf. Sembrerà strano, ma lì ogni anno, dal 1954, si celebra il più importante Festival internazionale di film corti di tutta la Germania. Effetto di strane congiunture, le stesse che in certo senso hanno fatto di Clermont-Ferrand il più importante Festiva di corti della Francia e che hanno determinato che, nel piccolo villaggio di Giffoni Valle Piana, a mezz’ora da Salerno, si celebri da 51 anni il più importante Festival di film corti d’Italia.
Ma Oberhausen è importante non solo per la sua meritata fama di principale festival internazionale di corti in Germania, ma anche perché, nel 1962 successe qualcosa di importante e di inaspettato. Qualcosa che, in qualche modo, e se ce ne fosse bisogno, testimonia, ancora una volta la vitalità di quel mondo semi-sotterraneo costituito dai film corti.
Siamo al 28 febbraio e un gruppo di 22 giovani e giovanissimi autori dei film corti in concorso, senza alcun preavviso, legge alla platea un programma-manifesto che ha come proprio focus la rinascita del cinema in Germania! Non si può negare il grande valore di questo avvenimento, che non può essere considerato semplicemente il gettare una pietra in uno stagno, ma, piuttosto, il vedere da lontano un fulmine che preannunzia l’arrivo di un temporale.
Sì, è vero, c’è del velleitarismo e del dilettantismo in quel manifesto. È vero che gran parte dei giovani estensori si dispersero. Non li ritroveremo mai più nelle pagine della storia del Nuovo Cinema Tedesco (che chiameremo d’ora in poi NCT). È anche vero che sono pochi gli Autori che si faranno strada nel nuovo corso. Ma non insignificanti. Tra i firmatari ci sono due futuri mostri sacri del NCT, Alexander Kluge e Edgard Reitz. E’ anche vero che i firmatari non formarono mai un vero e proprio gruppo. Né di gruppo si può parlare a proposito degli anni successivi. Se una delle fonti di ispirazione più evidente dei cineasti del NCT è la Nouvelle Vague, è indubbio che in quest’ultima l’idea di gruppo esiste, eccome! Esiste in Francia l’idea di avere una comune matrice, individuabile soprattutto ne Les cahiers du cinema e perfino fisicamente localizzabile nei locali della Cinemateque, vero tempio del nuovo cinema.
Eppure, anche se sono vere tutte queste osservazioni, sono personalmente in disaccordo con la generica svalutazione del lavoro dei redattori del manifesto di Oberhausen. A me sembra abbastanza chiaro il motivo: la situazione del cinema e, più in generale, della cultura in Germania era così arretrata, come annichilita durante e dopo gli anni del nazismo, che Oberhausen operò come una sorta di sussulto, di risveglio improvviso. Se ne accorsero soprattutto gli avversari, i tradizionalisti, il ceto affarista che prosperava sulla assenza di un cinema tedesco per continuare ad inondare il Paese di pellicole americane il più delle volte scadenti, o di puro intrattenimento. Non a caso gli anni successivi al 1962 sono caratterizzati dai tentativi di bloccare sul nascere ogni forma di rinnovamento e di ogni provvedimento che andasse incontro al “nuovo”, anche se disperatamente invocato.
E non si può neppure negare che, proprio dopo Oberhausen cominciò un dibattito a distanza tra molti autori del NCT. In questo dibattito trovava posto anche la questione delle differenze con la Nouvelle Vague, e cioè il non riuscire, da parte del NCT a promuovere, al di là delle emergenti creatività individuali, una creatività di gruppo.
In questo senso, uno dei primi tentativi fu palesemente sbagliato. Mi riferisco al voler fare gruppo individuando un minimo comun denominatore nella matrice del cinema espressionista tedesco e “inventandosi” una sorta di comune richiamo di tutti gli Autori al proseguimento di quell’esperienza. In un’intervista del 1978 Herzog afferma: “Molti pensano che noi abbiamo un rapporto, legami storici e stilistici con i grandi registi degli anni Trenta, con gli espressionisti. Non è così. La continuità è stata interrotta per trent’anni dopo la Seconda guerra mondiale”. (1)
L’errore di coloro che hanno semplicisticamente formulato tale ipotesi è poi diventato anche un errore di una parte della critica successiva, alla ricerca di forzate generalizzazioni. Quelli di Oberhausen si erano uniti per contare di più. Ciascuno di loro, ma non come gruppo. Ciò non sminuisce la portata storica del manifesto e del dibattito che ne seguì. Un dibattito entro il quale cominciarono presto a trovare posto fermenti sociali e politici e l’appello ad una presa di coscienza, sottolineata soprattutto da Kluge.
Viene respinta dagli Autori la tesi di un collegamento tra il NCT e il vecchio espressionismo cinematografico. Invece io credo che, come motivo unificante, che la scoperta di un comune sentire da parte degli autori vada individuata nel cinema americano autoriale – pur con i suoi limiti – assai diverso da quello che era stato fatto circolare in Germania dalla fine della guerra in poi. Gli Autori del NCT cominciarono a familiarizzare con i grandi film, di cui non c’era traccia nelle mediocrità che i distributori tedeschi propinavano per fare cassetta. E se la “scoperta della vera America cinematografica” diventerà un motivo idealmente unificante di molti nuovi registi tedeschi, esso sarà contemporaneamente anche un motivo che li collegherà agli Autori della Nouvelle Vague. I quali già da molti anni avevano aperto un fronte di discussione anche con i critici americani sulla svalutazione di grandi Autori. Clamoroso l’esempio di Hitchcock, di cui abbiamo parlato, e che veniva invece giustamente idolatrato da Chabrol e da Truffaut.
E proprio su queste basi nasce anche una forte solidarietà tra le così diverse esperienze degli Autori del NCT. Lo affermerà un Autore così atipico e “diverso dagli altri”, Wim Wenders: “Fin dall’inizio c’è stata una sorprendente solidarietà fra noi…Credo che nessuno di noi avrebbe potuto sopravvivere né arrivare dove siamo arrivati senza questa solidarietà, anche nella produzione e nella distribuzione.” (2)
Oberhausen 2
Dunque il manifesto di Oberhausen non è stata cosa inutile e lo hanno ben capito soprattutto gli avversari, i conservatori, le burocrazie governative, i nemici di ogni voce innovativa, che, secondo loro, doveva essere del tutto soffocata. E allora alcuni dei nuovi registi cominciano ad aprire gli occhi e a pensare che, dopo tutto, Kluge nel ’62 aveva avuto ragione. La sua lungimiranza lo aveva portato ad affermare che senza una lotta politica e sociale non si sarebbe andati da nessuna parte.
Alla metà degli anni ’60 molti giovani registi cominciano a capire chi è il nemico e dove si trova. Cominciano a comprendere che per andare avanti non basta fare un bel film, ma occorre anche sporcarsi le mani con i fattori economici e politici e verificare chi è che controlla la distribuzione e il mercato. A che serve fare un bel film se non viene distribuito? Se le leggi non incoraggiano le nuove voci innovative del cinema?
Dalla piena comprensione della situazione nascono lotte e petizioni che finalmente obbligano il Governo a dare vita a un “Consiglio del giovane cinema tedesco” (Kuratorium Junger Deutscher Film), per cui vengono stanziati cinque milioni di marchi destinati a finanziare le opere di giovani esordienti, purché provvisti di un soggetto, di un produttore e di un piano di lavorazione.
La legge suscita le proteste dei conservatori. Ed ecco che il Governo, vara, in maniera molto subdola, una nuova legge, che, col pretesto di aiutare il nuovo cinema, in realtà ne soffoca sul nascere le nuove istanze rinnovatrici. La nuova legge, infatti, stabilisce una tassa sui biglietti di ingresso, dai cui proventi si dovrebbero ammodernare le sale. Ma poiché l’80% delle sale appartiene alle major americane, ecco che tale operazione si rivela un’altra beffa per gli innovatori e un poderoso aiuto per i soliti conservatori.
Ma la miccia è ormai accesa e non potrà essere più spenta. Nel 1965, l’annuale kermesse ad Oberhausen diventa il teatro di proteste contro i conservatori, anche se, ancora una volta, i nuovi registi si presentano non solo in ordine sparso, ma anche con laceranti divisioni al loro interno. Un gruppo di giovani autori di cortometraggi stila addirittura un contro – manifesto che definisce i “ribelli di Oberhausen matusa, parrucconi, e autori di opere che falsificano la realtà”. Costoro sono del tutto fuori tempo e non si sono accorti che intanto si faceva avanti un nuovo gruppo di registi i cui nomi diventeranno presto molto familiari in Germania. Si chiamano Fassbinder, Herzog, Schroeter, i quali fonderanno una casa di produzione, la “Filmverlag der Autoren” nel 1971. E non si sono resi conto che è uscito intanto il primo capolavoro del NCT, “I turbamenti del giovane Torless” di quel Volker Schlondorff, che, ritornato “dove il cinema non c’è”, ha dato prova che il cinema in Germania può esserci. Eccome!
“I turbamenti del giovane Torless”
Il film ci porta all’inizio del secolo, all’interno dell’impero austro-ungarico. Torless, per decisione della famiglia, viene portato in un collegio asburgico per completare la sua fase educativa. Fa amicizia con due coetanei, Reiting e Beimberg. Una notte l’allievo Basini, per poter pagare un debito di gioco nei confronti di Reiting ruba dei soldi nell’armadietto di Beimberg. Una volta scoperto, implora di non essere denunciato ai superiori.
La moneta di scambio per questo favore sarà però molto pesante: dovrà sottomettersi completamente ai voleri di Reiting e Beimberg, ai quali si affianca anche Torless, più che altro per curiosità e per vedere come andranno a finire le cose. Anche se, in un primo momento, avrebbe voluto che Basini fosse denunciato alle autorità del collegio.
Da questo momento in poi, però, l’atteggiamento di Torless sarà quello di osservare lo svolgimento degli eventi e ricavare alcuni principi da tale esperienza. In altri termini, pur non condividendo le violenze fisiche e psicologiche che si scatenano sul povero Basini, Torless è pienamente consapevole di poter trarre alcuni utili insegnamenti e principi.
La figura più complessa e proprio quella di Torless, perché la sua ripulsa per le violenze che un giovane studente come lui è costretto a subire, viene smorzata dall’interesse verso lo sviluppo che potrà avere la storia alla quale assiste. È uno scenario nuovo e inconsueto: verificare cosa può portare un uomo a rendersi completamente schiavo di altri. E soprattutto, davanti agli insegnanti, Torless cerca di spiegare cosa gli è rimasto di quella storia di degrado e di violenza: “L’uomo non viene creato una volta per tutte buono o cattivo, ma cambia continuamente. Ma se indifferentemente ci è dato essere carnefici o vittime, tutto è possibile allora. Non esiste un muro tra un mondo buono e uno cattivo…Anche persone normali possono fare cose orribili… Ciò che sembra terribile e così inconcepibile, succede e basta.”
Quest’ultima frase, che abbiamo citato integralmente è una chiara allusione al fenomeno del nazismo e come esso sia stato tollerato, se non esaltato, in una ampia parte della popolazione in Germania. Questo fa del film una sorta di pamphlet retrospettivo, con una spiegazione socio-filosofica che l’Autore fornisce per bocca di Torless.
Tutto questo basta per fare de “I turbamenti del giovane Torless” un film completamente diverso da qualsiasi altro film mai uscito in Germania, almeno da oltre 30 anni. Un film tratto da una storia scarna e semplice (dal romanzo di Musil), che sollecita però alla riflessione ed anche ad una certa dose di angoscia nello spettatore.
Siamo già nel cuore del Nuovo Cinema Tedesco.
La definitiva affermazione negli anni ’70.
All’inizio degli anni ’70 proseguono i riconoscimenti e i premi ai nuovi Autori tedeschi. Ma quasi sempre premi ed elogi vengono raccolti all’estero e mai in patria, dove gli ostacoli al nuovo continuano ad essere troppi. Pochissimi film riescono ad ottenere in Germania una regolare distribuzione. La verità è che all’estero il NCT viene considerato ormai un fenomeno importante come lo è stato la Nouvelle Vague. Una strada che molti autori percorrono per aggirare gli ostacoli incontrati in Germania è quella delle cooperazioni internazionali. Le quali presentano molti vantaggi, anche se talvolta costringono a compromessi di carattere commerciale. Inoltre, il trovare ciascun Autore la strada di una cooperazione internazionale in Paesi diversi accentua l’individualismo del gruppo.
Saranno, invece, i fatti ad assemblare, in certo modo, il gruppo. Ci avviciniamo a sempre più accentuate inquietudini della società e ai cosiddetti “anni di piombo”. Le proteste, i fatti e la storia forniscono nuovi importanti soggetti e progetti. Si arriva addirittura ai film collettivi, dei quali i più significativi saranno “Germania in autunno” e “Der kandidat”. L’impegno civile di fatto si fa strada nei soggetti utilizzati dal NCT. In questo quadro come non ricordare film come “Il coltello nella testa” e “Anni di piombo”?
Alla fine degli anni ’70 il NCT è diventato famoso in tutto il mondo. “Il tamburo di latta” di Schlondorff vince la Palma d’oro al Festival di Cannes. Un riconoscimento impensabile fino a qualche anno prima. E che dire di opere come “Il matrimonio di Maria Braun” di Rainer Werner Fassbinder, amatissimo in America e in tante altre parti del mondo? Hanna Shygulla, Bruno Ganz, Rudiger Voger diventano attori sulla bocca di tutti. E registi come Wim Wenders ed Herzog e Fassbinder sono ovunque seguitissimi.
Cresce dunque il filone legato ai problemi della società e, accanto ad esso, proprio come in Inghilterra a proposito del Free cinema inglese, nasce anche un nuovo rapporto fra letteratura e cinema, che produrrà effetti positivi insperati.
GLI AUTORI
Werner Herzog.
L’enorme quantità degli Autori e il loro rilievo qualitativo, sono due ostacoli insormontabili per chi, come noi, voglia tracciare una rapida sintesi del fenomeno del NCT. Gli Autori di valore sono tanti ed ognuno di loro meriterebbe un capitolo o un’analisi almeno delle proprie opere più significative. All’estensore di queste note non resta altro che dare successivi appuntamenti per continuare questo entusiasmante lavoro. Per il momento ci limitiamo ad alcuni Autori e ad alcune loro opere, pur pienamente consapevoli che ogni scelta potrà essere considerata arbitraria e parziale.
Tra i motivi che accomunano alcuni degli Autori troviamo il tema del viaggio, che, a volte, si coniuga con quello dell’avventura e della fantasia. È il caso di Werner Herzog e del suo “Fitzcarraldo”.
Ci sono molti film di Herzog migliori e di fattura superiore rispetto a “Fitzcaraldo”. Noi abbiamo scelto questo film per esemplificare l’opera di Herzog, perché si tratta, in ogni caso, di un film unico e di una singolare realizzazione della fantasia (o, se volete) della pazzia di un visionario. E qui si lascia volutamente nell’ambiguità, di cui il cinema in generale è pieno, il problema e la domanda se la pazzia è quella del personaggio, Brian Sweeney Fitzgerald, ovvero “Fitzcarraldo” per gli indiani e gli spagnoli che abitano il suo angolo dimenticato dal Sud America, o la pazzia è del regista.
Vediamo prima la follia del personaggio, magistralmente interpretato da Klaus Kinski, che, a sua volta, aggiunge la propria follia al personaggio. Fitzcarraldo è appassionato per l’opera e la voce di Enrico Caruso. Lavora in una fabbrica di ghiaccio e sogna. Sogna di costruire un teatro dell’opera nella Giungla e di far venire Enrico Caruso a cantare lì. È un piano folle. Ma forse più folle ancora è il modo da lui concepito per realizzarlo. Un fiume non lontano da quello sul quale vive Fitzacarraldo, offrirebbe la possibilità di raggiungere migliaia di potenziali clienti. Il problema è uno solo: occorrerebbe spostare la nave che si trova attualmente sul fiume dove Fitzcarraldo risiede, all’altro sistema fluviale. E quale è il modo migliore per effettuare questo spostamento? Tirare, con l’aiuto di ingegnosi rulli e funi e con la mano d’opera degli indigeni, la nave da un fiume all’altro superando le montagne che si trovano in mezzo.
È il sogno di una soluzione folle alla quale Fitzcarraldo crede. Ma – e qui sta la seconda e più grande follia – ci crede anche Werner Herzog. Se il suo personaggio non ce l’ha fatta, Herzog nella realtà vera e senza alcun trucco cinematografico, intende spostare la nave, farle scalare le montagne e portarla nel bacino dell’altro fiume. E, naturalmente filmare con totale realismo, questo strano e assurdo viaggio. Nel film non ci sono trucchi o effetti speciali, non ci sono, naturalmente, scene girate al computer o altro del genere. Ci sono ingegneri pagati dalla produzione che hanno ideato il sistema per la scalata e centinaia di indios che tirano la nave sulla montagna.
C’è da aggiungere che il film non è solo follia del personaggio e follia del regista, ma è anche un film spettacolare e pieno di vedute maestose e meravigliose. Il viaggio che compie Herzog è innanzitutto un viaggio sognato fin nei suoi dettagli. È il sogno di un visionario che vuole concretamente realizzare l’audace e impossibile progetto che il suo personaggio ha immaginato, dandogli immagini, pellicola e autenticità.
Wim Wenders
Due parole chiave potrebbero riassumere il mondo cinematografico di Wim Wenders: l’America e il viaggio. Due parole e due concetti che frequentemente si intersecano, si accavallano. Il cinema americano e, più in generale, l’America, sono il vero punto di partenza del cinema di Wenders. Un punto di partenza, ma non di arrivo.
La cultura cinematografica americana – e l’America in generale – non è mai idolatrata. Piuttosto appare allo spettatore attento, come una sorta di guado da attraversare necessariamente. Per Wenders non si può fare a meno del cinema americano, se si vuole portare avanti un progetto nuovo, originale.
“Il cinema americano – afferma Filippo D’Angelo nel suo celebrato saggio su Wenders – viene assunto col valore di una norma da infrangere, di un modello non da imitare ma da riattraversare interamente per negarlo e liberarsene. Facendo ricorso ad una tematica fondamentale della sua poetica, si può dire che Wenders , attraverso i suoi personaggi, compie un lungo viaggio di liberazione e di ricerca nelle pieghe del cinema del passato, di volta in volta schizofrenico e disancorato in “La paura del portiere prima del calcio di rigore” del 1972, disilluso e disponibile in “Alice nelle città” (1973), lucido e disperato in “Falso movimento” (1975), desideroso di un cambiamento in “Nel corso del tempo” (1976), maturo e consapevole in “L’amico americano” (1977)” (3).
E, accanto all’America, c’è il tema del viaggio. Che per Wenders sia un punto fondamentale ed una vera e propria parola chiave della sua filmografia è dimostrato anche dai titoli dei suoi film, che fanno quasi sempre riferimento a luoghi specifici, oppure al viaggio verso determinati luoghi: da “Alice nelle città” a “Falso movimento”, a “Paris, Texas” a “Lisbon story”, a “Il cielo sopra Berlino”, per non parlare poi di “Fino alla fine del mondo”, che rappresenta forse la summa dei concetto di viaggio in Wenders.
Ci fermeremo solo sui film che giudichiamo più significativi in rapporto ai due concetti centrali che abbiam individuato nel regista, l’America e il cinema americano da un lato, e il viaggio dall’altro lato. Che sono poi i film del primo periodo: un viaggio cinematografico che parte dall’America sulle coste della Virginia in “Alice nelle città”, e si conclude sempre in America, nel Texas di “Paris, Texas” e nell’incontro col grande Sam Shepard.
“Alice nelle città” (1974)
L’inizio è America. Il giornalista di Monaco Felix Winter (Rudiger Vogler) scatta alcune foto su una spiaggia della Virginia con la sua Polaroid. Arriva a New York in auto e litiga col suo agente per non aver svolto il compito assegnatogli, cioè fare un servizio sul paesaggio americano. Felix nemmeno risponde. Vuole andare via. Ritornare in Germania. All’aeroporto viene a sapere di uno sciopero che blocca tutti i voli per la Germania Ovest e riesce a trovare un biglietto per Amsterdam. All’aeroporto Felix conosce la tedesca Lisa e sua figlia Alice. I tre restano insieme fino al mattino seguente, allorchè Lisa comunica a Felix di non poter più partire e gli affida Lisa, dandogli un appuntamento dopo due giorni ad Amsterdam, che non rispetterà.
Questa è la premessa che fa scattare due elementi: la formazione della strana coppia formata da Felix e Alice, e il viaggio, prima in aereo, ma poi soprattutto in treno lungo varie destinazioni della Germania alla ricerca del luogo di residenza di Alice. In questa ricerca Felix si deve necessariamente affidare ai ricordi visivi di Alice. Da notare che, quasi simbolicamente, “Alice nelle città”, e con esso tutta la cosiddetta trilogia del viaggio, nasce in America, da dove Felix vuole precipitosamente andare via. Diciamo simbolicamente perché l’esigenza del viaggio nasce proprio in una realtà, gli Stati Uniti, dove i viaggi e gli spostamenti sono la regola e dove esiste un patrimonio letterario di romanzi basati sui viaggi, da Marc Twain fino a Keruac e alla Beat generation. Per non parlare poi di un vero e proprio genere cinematografico nato in America, il road movie. D’altra parte, anche la Germania è la patria di grandi viaggi reali e a un tempo letterari. Basta pensare a Goethe e al suo Wilhelm Meister, che ispirerà Wenders e il suo sceneggiatore Handke al secondo film della trilogia del viaggio “Falso movimento”.
Dunque il destino (il caso?) che fa incontrare all’aeroporto Felix con Lisa e Alice, crea il vero stacco narrativo del film. Inizia una nuova storia che non finirà più e si nutrirà dell’attraversamento delle tante città tedesche di cui parla il titolo del film. E, nello stesso tempo, il rapporto che pian piano diventa complicità tra Felix e Alice, restituisce a Felix una dimensione più umana, nutrita di quella spontaneità che solo il mondo infantile sa promettere e procurare.
È stato detto che Alice è la metafora del cinema. Come non essere d’accordo? Questo significa che Wenders sente l’esigenza che il cinema riconquisti la sua originaria purezza descrittiva, proprio come Felix si è riconciliato con la sua stessa vita dopo aver trascorso alcune giornate “di viaggio”(!) con Alice: grazie ad Alice, Felix ritrova la possibilità di una diversa e rinnovata visione delle cose e del mondo.
In tutto questo c’è però un elemento disturbante: la televisione che assale i protagonisti ovunque, nella sala di attesa dell’aeroporto, in albergo, nelle varie realtà della Germania che attraversa. Fino alla simbolica distruzione di un televisore nella stanza del motel.
Per tornare al nostro tema principale, non si può non affermare che Alice nelle città è stato quello che oggi chiameremmo uno spot straordinario per il NCT. Il film avrà un successo strabiliante. Il NCT c’è ed è vivo. Ha molto da raccontare ed ha tanti protagonisti, tra i quali Wenders ha un ruolo di primissimo piano.
“Falso movimento” (1975)
Con “Alice nelle città” abbiamo visto come il cinema di Wenders riproduce continuamente il senso del movimento e del viaggio. Dai soggiorni americani Wenders porterà con sé un’idea di cinema, che non abbandonerà mai. Il cinema come descrizione del movimento e movimento in sé stesso. D’altra parte, il Road movie è un genere che ha prosperato in America regalando grandi capolavori. E in questo “movimento” del cinema americano c’è la riproduzione di una nazione che è nata attraverso il continuo progressivo movimento verso Ovest: il mito del West da raggiungere e una frontiera che si sposta continuamente come un elastico, nella misura in cui nuovi territori vengono annessi. Nella consapevolezza che solo il mare della California potrà fermare questo movimento.
Ma il road movie di Wenders è decisamente diverso da quello americano: esso più che nutrirsi di fatti e di eventi, si nutre di idee e di emozioni e, in una parola, di psicologia. Siamo infatti, non dimentichiamolo mai, all’interno di un grande movimento cinematografico, cui Wenders ha dato un grande contributo, che è il NCT. Un movimento nel quale il cinema, a trent’anni dal disastro della guerra mondiale, si interroga su cosa sia la Germania, come possa superare il proprio passato e cosa vorrebbe diventare.
Tutto questo è leggibile in “Falso movimento”. È un film che, programmaticamente, vuole essere un’opera di formazione, data la sua matrice letteraria, il “Wilhelm Meister” di Goethe, rivisitato a quattro dalla sceneggiatura dello stesso Wenders e dell’amico scrittore Peter Handke.
Wilhelm (Rüdiger Vogler) sente dentro di sé l’aspirazione a scrivere, ma sente anche l’angustia del piccolo paese del nord della Germania nel quale si trova e la pressione di una madre possessiva. Fino a che quest’ultima comprende che il figlio ha bisogno di mettersi in movimento per conoscere nuove realtà. Gli mette in mano un biglietto ferroviario per Bonn, ma in realtà il viaggio di Wilhelm si concluderà molto più a sud, ai confini con l’Austria.
Nel corso del viaggio, in treno, fa la conoscenza di un anziano affetto continuamente da epitassi nasale, Laerte (Hans Christian Blech), che si rivelerà un ex nazista (“qualche volta ho anche aiutato degli ebrei”) e da sua figlia Mignon (Nastassja Kinski), un tipo strano, muta, impegnata soprattutto in giochi da illusionista.
Alla piccola compagnia si aggregheranno presto un’attrice, Therese (Hanna Schygulla) e poi un aspirante poeta austriaco. Wilheilm sembra trarre profitto da una compagnia così variegata, per ricavare ispirazione dalle loro vite e dai loro pensieri, come materia per un romanzo. Ma è soprattutto la sosta presso la casa di un industriale (Ivan Desny), dove l’intera compagnia trascorrerà la notte, che gli offre molti spunti positivi.
L’industriale, infatti, che da poco ha perso la moglie e che medita di suicidarsi, accortosi dell’interesse di Wilhelm per la sua storia, si lascia andare ad una serie di considerazioni sulla mentalità dei tedeschi in quel momento che considera il crocevia della storia. Il colloquio tra l’industriale e Wilheilm è uno dei momenti chiave del film. L’industriale è la coscienza di tutto quanto di negativo è presente nella Germania, dove le persone vengono da lui definite “anime morte che errano per i supermercati”. Eppure, il “movimento” di tutti i personaggi di quella strana compagnia si rivela il primo dei falsi movimenti di cui ci parla il titolo del film.
“Falso movimento” è un film incredibile: la storia di un gruppo di persone che viaggiano attraverso la Germania senza riuscire a conoscersi reciprocamente, ma senza neppure riuscire pienamente a conoscere sé stessi. L’allontanamento di Wilheilm dalle altre persone è un allontanamento da persone a cui non si è mai avvicinato.
Dunque, siamo al secondo film sul movimento e sul viaggio. Ma c’è un aspetto che va sottolineato e che è fornito dall’aggettivo “falso”, che per la prima volta Wenders abbina alla sua parola chiave “movimento”:
c’è in realtà una falsificazione che corre lungo tutto l’arco della storia del film e che coinvolge tutti i personaggi. Smascherare questa falsificazione, andare a fondo nei personaggi, sarebbe stato il compito dell’aspirante scrittore, che, in questo, miseramente fallisce.
“Nel corso del tempo”
Purtroppo il corso del tempo è tiranno e ci impedisce di soffermarci su tutti i film di questa grandiosa e irripetibile stagione di Wim Wenders e del suo eccezionale contributo dato al NCT.
Ci soffermiamo brevemente su questo film bellissimo, un bianco e nero in stile documentaristico, che tratta della nascita di una sincera amicizia tra due uomini e della assenza e mancanza di una donna nelle loro rispettive storie. Ma tratta anche del cinema. È metaforicamente e realmente un film sul cinema. Uno degli amici, infatti, fa di mestiere il riparatore di macchine per la riproduzione dei film e l’altro si appassiona a tale lavoro. Dunque, come sempre, emerge l’amore di Wenders per il cinema, inteso nella sua genuinità, nella sua naturalezza. Del cinema della spontaneità inventiva ne fornisce lui stesso l’esempio per il modo col quale sta creando e sviluppando il film “nel corso del tempo”. Infatti, Wenders non ha una sceneggiatura già preordinata. Il film che sta girando è un work in progress. Egli racconterà: “Ho deciso di realizzare un film di viaggio in cu potessi inserire a mia completa discrezione ciò che via via mi veniva in mente e in cui avessi la libertà di inventare la storia man mano che avvenivano le riprese. Un film che, girata la prima metà, potesse diventare ancora del tutto diverso.”
È già chiaro da queste brevi notazioni, che moltissimi sono i motivi e i temi rintracciabili in questo ennesimo capolavoro. Ma poiché ci siamo lasciati guidare, finora, dal tema del “movimento”, del viaggio, soffermiamoci solo per un attimo su quello che è il movimento in questo film. I due amici girano per molte città dove c’è da riparare qualche proiettore o cambiare le lenti ai vari strumenti per far funzionare lo spettacolo e consentire il punto tanto atteso e desiderato nei vari paesini, la proiezione de film.
Ma in questo girare in auto in varie realtà, i due amici si trovano a “circumnavigare”, per così dire, i confini della Germania Ovest con la Repubblica Democratica Tedesca. Non è mai esplicitato uno sguardo doloroso ai punti di confine tra le due Germanie. Non è necessario perché esso è nelle cose in sé. Dovremo attendere “il cielo sopra Berlino”, perché venga in qualche modo esplicitata e “lamentata” la condizione di separatezza delle due Germanie, delle due Berlino. È però significativo questo ritorno frequente al tema del confine, della terra e della strada che finiscono con delle barriere che non ti permettono di andare al di là. Né di vedere se non pochi metri di “terra di nessuno”.
È significativo che “Falso movimento” finisca proprio al confine tra Germania e Austria, allorché Wilhelm si reca sulla vetta più alta della Germania. È come se sempre, se si sceglie il viaggio come modalità di vita e di ricerca dell’arte e di se stessi, si debba avere a che fare con la frontiera. Che è una sorta di entità con la quale i due amici devono fare i conti. La frontiera è l’altrove che per il momento non è possibile raggiungere, ma che esiste comunque. È l’Altro da noi, che non è disperazione. Al contrario è speranza, è utopia e garanzia di un diverso al quale noi stessi possiamo attingere. Se ha tutti questi significati è chiaro che la frontiera diventa un luogo misterioso e magico ad un tempo. Un luogo a volte evocatore di dolore. Ma anche un luogo dotato di un grande fascino.
L’America arriva in Germania: “L’amico americano” (1977)
Con “L’amico americano”, che ha come scenario Amburgo e la sua periferia, Wenders prende il mondo americano, rappresentato da Dennis Hopper, e lo porta in Germania. Qui ci descrive di nuovo una storia di amicizia al maschile, che sembra il prolungamento e l’approfondimento di “Nel corso del tempo”.
Lo spunto gli viene da una fonte letteraria, il romanzo della grande scrittrice Patricia Highsmith “Ripley’s game”, che aveva già ispirato Hitchcock con “Delitto per delitto” e Renè Clement con “Delitto in pieno sole” con Alain Delon.
Ci saranno in seguito altre versioni tratte dal medesimo romanzo, che ha dunque affascinato molti registi e produttori, ma questa di Wim Wenders è unica ed è una delle grandi opere del NCT in generale. Un film che ha un’originalità e un registro tutti wendersiani. La prima originalità di fondo consiste nel collocare i due protagonisti in due mondi assolutamente diversi, quello classico tedesco, compassato, pieno di regole e tradizioni, e quello americano, spregiudicato, sregolato, aperto al nuovo e al rischio. Due mondi interpretati dai due protagonisti dai quali non è certo impossibile intravedere la metafora di due differenti cinematografie alle quali Wim Wenders è costantemente attratto, come tra due poli.
Alle prese però col genere noir, che in America ha profonde radici, Wenders come si comporta? Il regista tedesco non ci pensa due volte a ribaltare e rovesciare i segni e le funzioni degli stereotipi narrativi del genere poliziesco: “I luoghi e le figure del cinema classico (i gangster, le pistole, gli omicidi, i frequenti cambiamenti di ambientazione) sono puri segni convenzionali, espedienti retorici che perdono il loro fascino perché raffreddati dal distanziamento della rivisitazione intellettuale” (4)
Le modalità stesse dell’omicidio, che ritorna per ben tre volte nel film, sono spiazzanti e assolutamente non in sintonia col genere classico, dal quale Wenders prende apertamente, e con abbondanti dosi di ironia, le distanze.
Jacques Fresnais sostiene che “L’amico americano” è un intrico di indizi e di tracce, come amano scoprirne i criminologi, ma che moltiplicano all’infinito le piste possibili”. E la prima pista è offerta dal titolo stesso del film, un titolo che può essere letto, come suggerisce lo stesso regista, anche in senso ironico: cioè l’improvvisa ed inaspettata amicizia tra due esseri assolutamente eterogenei e distanti, abitanti di due mondi e addirittura due continenti diversi, eppure attratti l’uno all’altro dalla comune segreta paura della morte, che è anche angoscia dello stare al mondo. Jonathan (Bruno Ganz), il modesto corniciaio di Amburgo, che ha avuto dal destino una grave malattia, i cui contorni vengono artatamente aggravati da Ripley (Dennis Hopper) non accetta del tutto la sua condanna a morte lenta. Vede in Ripley quello che manca a lui: la spregiudicatezza e l’intraprendenza, mentre Ripley sembra attratto dalla tranquillità familiare che caratterizza la vita del corniciaio. Logico che tra i due si instauri un rapporto a filo doppio, e il sottile filo conduttore di questo rapporto rappresenta sicuramente una delle novità più piacevoli di questa edizione del romanzo della Highsmith, che si sostanzia in scene bellissime ove emerge “l’ambigua complicità – fatta di silenzi, sguardi, emozioni più che di parole o gesti di affetto – che lega i due nella lotta contro il comune nemico interiore.”
L’altra protagonista del film è la morte, “la regola senza eccezioni”, che è il primo titolo che Wenders avrebbe voluto dare al film, prima di pervenire al titolo definitivo, che sottolinea invece l’aspetto dell’amicizia. L’idea della morte scuote Jonathan come una “sciabolata che prima lo annichilisce, poi lo scuote da cima a fondo”. Ma anche lo spregiudicato “amico americano”, il cinico Ripley, che sembra da solo dettare le regole del suo “gioco”, in realtà è in balia della morte. Quando la missione sarà stata compiuta, i gangster saranno stati eliminati e lo stesso Jonathan sarà andato incontro al suo destino, si abbatte su Ripley un senso di vuoto e di morte che è anche smarrimento definitivo della propria identità. Non a caso Ripley dirà al proprio inseparabile registratore: “So sempre di meno chi sono io e chi sono gli altri”.
“Paris, Texas”. Di nuovo l‘America per concludere un ciclo.
A vedere (o rivedere) l ‘inizio di “Paris, Texas”, diciamo i primi cinque minuti, rimani come folgorato, annichilito. Il deserto della parte sud degli Stati Uniti: la scena è fatta di spazi infiniti, ma non del tutto piatti. Piuttosto costellata da picchi, sbalzi improvvisi del terreno sempre arido. Un contesto pesantemente battuto da un sole accecante che aggiunge colori vividi. Un uomo magro e tutto impolverato, con un cappello rosso da baseball, una giacca grigia e trasandata e una cravatta sbilenca. Dallo sguardo assente si coglie tutto lo spaesamento e il vuoto confusionale che si agitano nel suo animo e nella sua testa. In mano ha una piccola tanica di plastica nella quale è rimasta pochissima acqua, da non poter certo placare la sua sete.
L’uomo non parla. D’altra parte, non avrebbe in tale contesto nessuno con cui parlare. Lo spettatore però capirà presto che l’uomo non parla comunque. La sua comunicazione col mondo e con le persone si è interrotta. Sicchè, oltre che vedere le meravigliose immagini iniziali, il deserto e il volto stralunato dato in prestito al personaggio di Travis da un immenso (e forse inaspettato) Harry Dean Stanton, lo spettatore coglie il silenzio del deserto non soffocato, ma sottolineato e esaltato dalle incredibili note di Ry Cooder, che accompagneranno molte parti del film.
I soccorritori di Travis trovano nel suo portafoglio un numero di telefono, quello di suo fratello Walt (Dean Stockwell), attraverso il quale quest’ultimo può soccorrerlo dopo una silente assenza di ben quattro anni trascorsi girando nel deserto. Walt lo riconduce alla propria casa, ove Travis rivede il figlio Alex. Il viaggio in auto con Walt è un viaggio silenzioso. Ma con Alex è diverso: ben presto si ricompone l’affetto e la complicità. Padre e figlio decidono insieme di mettersi in viaggio per Houston perché hanno saputo che lì si trova Jane (Nastassja Kinski), la moglie di Travis, fuggita dopo la nascita di Alex da un matrimonio che lui ha gradatamente trasformato in una prigione.
Travis ritroverà Jane: lavora in un Peep show. Ci saranno fra loro due lunghi colloqui. Separati da un vetro, secondo le regole di questi locali creati per chi ama guardare una donna spogliarsi senza essere visto, e parlarle con voce distorta dall’interfonico, perché non possa in alcun caso essere riconosciuto. Un po’ metafora del cinema che è il regno del voyerismo assoluto, dell’occhio della camera e dell’occhio dello spettatore. Due colloqui intercorrono tra Travis e Jane. Nel corso del secondo colloquio lui descrive l’afflizione del proprio matrimonio, i suoi errori e il suo amore per lei, fermandosi su una serie di circostanze che lo rivelano. Jane ha capito e si commuove. Lui è lì per restituirle il figlio. Le ultime parole di Travis sono un indirizzo e il numero di una stanza, ove Jane potrà riabbracciare Alex.
Film-capolavoro e vera conquista dell’America da parte di Wenders dopo una serie di tentativi che lo avevano lasciato insoddisfatto e deluso. L’idea di un film del genere era nata dalla lettura di alcuni lavori del suo fido sceneggiatore tedesco Handke. Ma la svolta alla realizzazione del film gli è offerta dalla conoscenza e poi collaborazione con Sam Shepard, già all’apice della sua bravura come scrittore teatrale e sceneggiatore, che ha girato le spalle al sogno americano e al mondo degli eroi. I suoi personaggi sono infatti sempre problematici, rapporti umani difficoltosi e dolorosi, i rapporti con le cose e con i luoghi mai conciliativi. In genere i luoghi sono fatti per andare via e non per stare.
Riconosciamo Shepard nei due colloqui tra Travis e Jane, separati dal vetro e dalle regole del Peep show. Ritroviamo in quei due colloqui la grande capacità del drammaturgo di cadenzare di volta in volta, attraverso le battute, la curiosità, e poi la meraviglia e lo stupore e poi la commozione di Jane, mentre Travis, con voce rotta dall’emozione, porta avanti con meticolosa calma la sua storia, che è poi è la loro storia. Storia di fallimenti, di dolori e di solitudini.
La grande fortuna di Wenders con “Paris, Texas” si identifica con la sua capacità di unire la propria bravura e ispirazione registica con la genialità e la pulizia dei dialoghi di Sam Shepard, col languore della musica di Ry Cooder, con gli splendidi colori di Robby Muller, in un mix talmente straordinario, che non riusciamo ad immaginare il film senza uno di questi collaboratori.
Con “Paris,Texas” Wenders ripercorre anche la tematica del viaggio. Quanti viaggi ci sono nel film? C’è il viaggio senza meta, e che è un vagabondare, di Travis nel deserto, c’è il viaggio col fratello che lo ha ritrovato e lo porta a casa del suo bambino. E c’è il viaggio verso la donna, che Wenders qui finalmente pone al centro dell’attenzione. E i due colloqui tra Travis e lei costituiscono un profondo viaggio nella memoria della loro storia.
Con “Paris, Texas” finalmente Wenders ha chiuso i conti con l’America. Dopo ritornerà in Europa come dopo il compimento di una missione. Si è chiuso un ciclo che è iniziato sulle spiagge della Virginia in “Alice nelle città” e che termina nel profondo Texas. E si è chiuso il ciclo più denso di significati e di sorprese di questo straordinario regista e forse dell’intero NCT.
Il NCT e la politica: Fassbinder
Fassbinder è stato il più prolifico dei registi tedeschi ed uno dei più prolifici di tutti i tempi. In un lasso di tempo relativamente breve, visto che la morte improvvisa per una mortale overdose lo ha stroncato al solo tredicesimo anno di attività artistica, ha girato 30 film, 3 cortometraggi, film televisivi e due serial, tra i quali il famoso “Berliner Alexanderplaz”. Ha trattato, nella sua filmografia, molti temi e, attraverso di essi, è riuscito ad incarnare per molti versi, lo spirito tedesco della sua epoca, tanto da diventare ben presto il più amato in patria dei registi del NCT, e forse il regista della Germania Ovest più apprezzato e amato all’interno della cultura della Germania est. Al contrario degli altri, che il loro successo, da Herzog a Wenders, lo hanno piuttosto costruito al di là dei famosi “confini” sui quali si sofferma spesso lo stesso Wenders.
Non mancherà in lui una analisi, individuale e collettiva, sugli “anni di piombo”. Gli eventi tragici di quegli anni, culminati con la morte in carcere di Bader, Raspe e la Enslin, con tutta la sua scia di misteri e di interrogativi che si è portato dietro. Quella che spinse Theo Hinz, uno dei membri della Filmverlag der Autoren a promuovere l’iniziativa di un’opera a più mani, “Germania in autunno”, realizzato nel 1978. . Dieci sono i registi impegnati, tra i quali, oltre a Fassbinder spiccano i nomi di Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Bernhard Sinkel, Edgar Reitz. In quest’opera emerge, da parte degli Autori, la volontà di interrogarsi e di discutere sul difficile versante che sta attraversando la Germania. Discutere non significa, naturalmente, tracciare la linea della verità e individuare tutte le responsabilità. Sotto questo aspetto il film è una risposta polemica ai troppi silenzi e alle troppe omissioni da parte delle autorità. Ma non vuole essere a sua volta, il ritrovamento della verità!
Ma, al di là dell’opera collettiva, che rappresenta sempre un fatto positivo nell’universo tendenzialmente individualistico del NCT, alcuni degli autori si cimentano anche da soli, per avere più libertà di esporre le proprie idee sul difficile momento attraversato e neanche del tutto compiuto ancora. Sotto questo angolo visuale vanno interpretati film come “Il coltello in testa” di Reinhard Hauff, interpretato da una coppia d’attori straordinari come Bruno Ganz e Angela Winker, “Anni di Piombo” di Margarethe Von Trotta e “La terza generazione” dello stesso Fassbinder.
I dubbi e la critica di Fassbinder non riguardano solo gli anni di piombo e il mistero di tante morti sospette – specialmente quelle in carcere – ma diventano critica globale e generale alle modalità con le quali si era sviluppato il modello tedesco negli anni della ricostruzione. Sembrava, infatti, che l’interesse fondamentale fosse soprattutto la sua ricostruzione materiale, mentre veniva del tutto trascurata la ricostruzione di un tessuto connettivo, ideale e morale in una Germania, dove l’individualismo e gli interessi personali avevano la prevalenza su tutto o quasi.
Il suo cinema ha trattato i problemi della Germania attraverso le storie che ci ha presentato e quindi solo a volte direttamente, ma il più delle volte affidandosi alla metafora che lasciava trasparire in situazioni e personaggi particolari la realtà problematica dell’intero Paese.
“Lola” è uno degli ultimi film di Fassbinder ed è, come genere, un melodramma nel quale l’Autore si concede momenti di paradosso e di ironia, strappando anche sorrisi compiaciuti allo spettatore. Il film si svolge nella cittadina di Coburg nel 1957, dove il tran-tran quotidiano, che vede al centro dell’attenzione, nel corso della giornata, le attività del Comune e, la sera, i divertimenti – soprattutto il bordello di Villa Fink – viene scosso dall’arrivo di un nuovo assessore all’urbanistica: si tratta dell’integerrimo Von Bohm (Armin Muller-Sthal).
Quest’ultimo rischia di mandare all’aria il connubio tra politica e affarismo che è alla base di tutte le scelte comunali più importanti. Il sindaco infatti appare come un fantoccio nelle mani del potente imprenditore Schuckert (Mario Adorf), che sta per avvantaggiarsi di una nuova grande scelta edilizia del Comune, in assenza di ogni piano urbanistico. Ovvero: le scelte pubbliche sono smaccatamente piegate al servizio degli interessi privati. Questa volta la speculazione edilizia a vantaggio di Schuckert sembra in serio pericolo per l’operato del nuovo assessore, che in ogni caso non si fa portatore di nessuna forza politica di opposizione, ma di istanze meramente morali.
La chiave del film è una donna, Lola (Barbara Sokowa), la reginetta del bordello di Villa Frank, nella quale canta divinamente prima di intrattenere i clienti, a partire naturalmente da Schuckert, padrone della vita pubblica e privata del luogo. Il nuovo cittadino di Coburg, l’assessore Von Bohm, senza ancora conoscere la reale attività di Lola, se ne innamora perdutamente. In tal modo il furbo Schuckert saprà sfruttare a suo vantaggio questa imprevedibile situazione.
“Lola” è la riflessione sui troppi aspetti marci della vita della Germania Ovest negli anni ’50, nella quale viene implacabilmente evidenziato, con una lettura drammatica, ma anche umoristica, il binomio sesso e denaro, che rappresenterebbe il vero motore di una società più che mai in mano a Schuckert, metafora del ceto dei potentati economici dell’epoca.
E, come sempre in Fassbinder, una realtà particolare – in questo caso Coblenza negli anni ’50 – diventa spaccato e metafora delle problematiche dell’intera Germania. In questo film, come in tutto il cinema di Fassbinder, il pubblico si riconosceva, ovvero riconosceva i problemi tedeschi raccontati da un tedesco.
Radicalità politica e sociale nel NCT: Helke Sander
Se Fassbinder è stata la coscienza critica della Germania, nella quale tanti tedeschi, dell’ovest e dell’est, si sono riconosciuti, alla sua sinistra si va presto formando un movimento che pone al centro dell’attenzione le più forti tematiche sociali e politiche. La parte più radicale di questo movimento cinematografico e culturale viene espressa dall’universo femminile e si intinge di femminismo. In quest’ambito Helke Sander rappresenta una posizione particolare nel NCT, collegandosi, col suo cinema di denuncia, al vasto universo femminile delle registe, sceneggiatrici e attrici che il movimento indusse ad esprimersi e ad essere protagoniste. La sua propensione per il documentario è una scelta ideologica. La regista infatti, attraverso questo mezzo, riesce ad essere diretta e a trasmettere, quasi esclusivamente attraverso le immagini, il suo messaggio. Così come ideologica è anche la preferenza, quando si tratta di lanciare un messaggio immediato e trascinante, per il film corto in stile documentaristico.
Il film corto dal titolo strano, “Dai rapporti di guardie di sicurezza & patrol services n.1” è forse il più famoso ed è valso alla regista un riconoscimento molto significativo: l’Orso d’oro al miglior cortometraggio al Festival di Berlino.
La regista Helke Sander si affida esclusivamente alle immagini e ai suoni dell’ambiente circostante e ai lamenti del bambino piccolo che la madre porta legato al petto. L’inizio del film ci mostra i tre personaggi, la madre e i due bambini, di cui il più grande cammina tenendole la mano, in una atmosfera di totale tranquillità. Sono in prossimità della stazione, sorridono. Una donna attirata da quel bel terzetto, si ferma a scattare delle foto. Nulla sembra lasciar presagire quello che starà per accadere.
Dirigendosi in un luogo già prestabilito, la mamma solleva un palo ed entra in un cantiere con i suoi figli. Arrivata alla base di un’altissima gru, tira fuori dalla borsa un considerevole numero di copie di un messaggio scritto a pennarello sopra la pagina di un giornale. Solo il messaggio dice: “Ultimo tentativo. Se non avremo un conveniente luogo per vivere per questa sera, allora noi salteremo giù.” La donna affigge alcune di quelle copie, altre le lancerà giù durante la scalata verso la cima della gru. Prima di intraprendere la salita attraverso la scaletta di ferro, la donna assicura meglio a sé i tiranti del marsupio contenente il bambino più piccolo. L’altro bambino precede di qualche gradino la mamma, in modo che questa possa osservarlo con attenzione. Iniziano i pochi lunghissimi minuti che ci portano, passo dopo passo, ad accompagnare i tre personaggi in uno straziante pellegrinaggio col silenzio interrotto solo dagli sporadici lamenti del bimbo più piccolo e dai suoni sempre più lontani e indistinti, della città, situata ormai ai loro piedi. Ancora un attimo di sosta per lanciare gli ultimi volantini.
Le immagini parlano di storie che sono , purtroppo, comuni, e piene di grande gravità e tragicità. Ogni immagine ha una sua potenza visiva straordinaria. È cinema di protesta. È cinema militante. All’inizio del movimento non avresti mai immaginato che il NCT arrivasse a tanto.
Margarethe Von Trotta
Abbiamo dunque citato un esempio abbastanza eclatante di militanza femminile e femminista all’interno del NCT. In questo quadro, non possiamo non menzionare, sia pure brevemente, il grande talento di Margarethe Von Trotta, messo quasi interamente al servizio di cause democratiche e control e ingiustizie e iniquità della storia. Ci piace ricordare innanzitutto “Rosa L.” ritratto impeccabile di una delle grandi figure femminili del movimento socialista tedesco, Rosa Luxemburg. Altri film di grande rilievo sono “Il caso Katharina Blumm”, “Gli anni di piombo”, “Rosenstrasse”, sulla coraggiosa protesta avvenuta nella strada di Berlino che dà il titolo al film. La protesta è quella del 1943, allorchè centinaia di cittadine ariane inscenarono una protesta contro la deportazione dei loro mariti ebrei. Un episodio reale, che si concluse col successo delle donne, che riuscirono a far liberare i loro mariti.
Una tardiva riscoperta: Roland Klick
Oggi si tende a rivalutare la figura e l’opera di un autore del NCT sempre poco considerato. I suoi film sono stato addirittura etichettati come i B-Movies del NCT. La rivalutazione, anzi la vera e propria riscoperta, si deve alla ricca e intelligente piattaforma di MUBI, che riesce a presentare in esclusiva film che, probabilmente, non riusciremo a vedere o rivedere mai.
Già schiacciato dalla statura di altri Autori del Nuovo Cinema Tedesco, come Wim Wenders, Werner Herzog, Volker Schlondorff, Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge e tanti altri ancora, Klick non è riuscito a ritagliarsi uno spazio proprio nella considerazione della critica, cadendo presto, e ingiustamente, nel dimenticatoio. A tutto questo va aggiunto che Klick ha subito, nel suo percorso artistico, vari incidenti, che hanno resa più amara, accidentata e complicata la sua carriera. Uno di questi riguarda il film “Deadlock” del 1970, un’opera sulla quale il regista e il suo entourage avevano puntato molto. E’ un film genere “spaghetti western” con un’ottima interpretazione di uno dei mostri sacri del NCT, Mario Adorf.
Il caso di Roland Klick è veramente singolare: è un caso cinematografico forse unico nel suo genere.
“Deadlock” fu invitato al Festival di Cannes del 1970 tra i film in concorso. Come talvolta accade in questo Festival (e in altri) la scelta non era passata attraverso i canali ufficiali, ma dall’interno del Festival stesso. Quella scelta suscitò proteste e riprovazioni da parte di chi affermava di avere i titoli per rappresentare il Nuovo Cinema Tedesco. La cosa grave è che il Festival, supinamente accolse tale protesta e revocò l’invito che era stato già recapitato a Klick. Al posto di “Deadlock” fu invitato “Malatesta”, storia dell’anarchico italiano per la regia di Peter Lilienthal.
Per giustificare la sostituzione del film di Klick, fu scomodato il carattere eccessivamente popolare di “Deadlock” e i suoi chiari riferimenti al filone italiano degli “spaghetti western”. E dunque tutti coloro che, con somma autoreferenzialità, si erano proclamati rappresentanti del nuovo cinema d’arte tedesco, trovarono pretestuosi, ma sufficienti argomenti, per farlo eliminare. Riassumendo: troppo popolare, poco tedesco, poco artistico.
Il film viene oggi giustamente rivalutato: il film ha dalla sua splendide interpretazioni dei tre personaggi principali: un grandissimo Mario Adorf, in un ruolo decisamente insolito di ex cercatore d’oro e attuale cercatore comunque di danaro, Anthony Dawson e Marqaund Bohm. Si avvale inoltre della fotografia di un notevole Direttore come Robert Van Ackeren. E infine, come sostiene il critico cinematografico di Die Welt, Friedrich Luft, nel film traspare una “poesia delle cose perdute che non sempre hanno i western classici. E Klick sa creare la tensione…conosce l’ironia , l’umorismo e perfino una certa poesia del male”.
il film successivo, “Supermarket” del 1984, esalta ancora di più le caratteristiche del regista ed ha nell’azione, spesso frenetica e irrefrenabile, la sua costante e il suo elemento chiave. Un film di azione dunque ispirato alla tradizione dei film polizieschi e noir, con grande ricerca di originalità, rispetto alla ricerca di autorialità che caratterizza gran parte del NCT. Klick volutamente non segue la tentazione del film di autore che caratterizza e in certo senso unifica tutta la prima linea del NCT. Klick si colloca spontaneamente in una seconda linea, dove si sente evidentemente più ispirato e al sicuro, e gira il “suo” cinema. Non disdegnando di sporcarsi le mani negli ambienti più luridi di una città, Amburgo, mai apparsa così sporca ed esclusivamente ritratta nei suoi quartieri a luci rosse o nelle sue realtà più infime. Il giovane Willy (Charly Wierzejewski) trascorre la sua vita alla giornata, tra piccoli furti, imbrogli e accattonaggio quando possibile.
Willy, quasi come per principio, quando vede la polizia fugge. Il che significa che noi lo vediamo in fuga nei due terzi del film. Perché fugge anche se in quel momento magari non ha fatto proprio nulla di strano? Perché ci può essere sempre un motivo per il quale la polizia lo possa ricercare e casomai incarcerare. E in effetti Willy ha ragione. Ma, sembra chiedere il regista, si può vivere in questo modo? Che vita è questa? Ma, come succede per tutti i gangster o per tutti i fuorilegge che siano, a sorreggere la vita c’è sempre la speranza riposta in un piano decisivo capace di cambiarti la vita definitivamente. Ed è proprio questo che sorregge Willy nelle sue scorribande notturne, spesso perfino alla ricerca di un posto dove dormire, che non è mai garantito dalla sua non fissa dimora. Il piano alla fine riesce ad organizzarlo. E trova anche una partner, Monika (Eva Mattes), con la quale si crea un rapporto di affetto profondo, che coinvolge anche il figlio della ragazza. E’ la speranza di un futuro insieme.
Aggiungiamo a tutto il positivo che abbiamo trovato in questo film, la sua abilità a coniugare le atmosfere e le immagini raccapriccianti con una scelta di brani musicali assolutamente perfetta di un rock che si impone con una forza acustica che, ascoltata in modo a sé stante, sarebbe eccessiva. Ma qui non lo è. Anzi le note fortissime hanno, per il pubblico, un effetto catartico e liberatorio per scelta deliberate del regista. Le note violente di Celebration, cantate da Marius Westernhagen, un autore rock amatissimo in quei tempi in tutta la Germania, aggiungono atmosfera ad atmosfera e stanno a testimoniare l’abilità del regista a curare tutti gli aspetti di questo film che è, a nostro giudizio, decisamente superiore alla media.
Conclusioni
Nel corso della trattazione di questo lavoro, abbiano fatto spesso riferimento alle possibili critiche di parzialità nella scelta degli autori e di incompletezza nella citazione dei film. Tutto vero.
A sola parziale scusante di tale critica sta la enorme, estrema complessità e varietà del NCT e il fatto che abbiamo più volte fatto riferimento agli estremi individualismi presenti e alla mancata o debole propensione a “fare gruppo” da parte degli Autori. Questo ci avrebbe obbligato a creare un capitolo per ognuno di essi e a moltiplicare il numero dei film citati e, in qualche caso, parzialmente recensiti. E non è esagerato affermare che per i primi parliamo di alcune decine e per i secondi di alcune centinaia. Ci riferiamo, ovviamente, agli autori e ai film per quali varrebbe veramente la pena soffermarsi e non a tutti quelli esistiti. La logica conclusione è una sola: il lavoro andrebbe continuato e, possibilmente, completato.
Note:
(1) M. Fontana: Intervista a Herzog, in Film und Drang, Firenze, Vallecchi, 1978, pag. 69. Citato in “Wim Wenders” di Filippo D’Angelo, Il Castoro, pag. 13.
(2) M. Fontana – cit. pag 165
(3) Filippo D’Angelo: Wim Wenders, ed. Il Castoro, pag. 17.
(4) F. D’Angelo, Wim Wenders – cit. Pag. 87
MONTE HELLMAN: CINEMA A DOPPIA CORSIA
di Francesco Saverio Marzaduri
Rivisto in televisione, “L’uomo di Laramie” di Anthony Mann suscita domande circa la traccia lasciata da ineccepibili artigiani del genere, la cui rilevanza è fuori discussione ma, ai giorni nostri, non più ricordati quanto certi eponimi maestri; ciò, forse, anche a causa di “topoi” come il registro sentimentale, i quali – benché richiesti dall’assunto – ne ammorbidiscono le opere apparentandole a più modesti prodotti. Nel caso di Monte Hellman, scomparso il 20 aprile, la critica deve far i conti con un aspetto insolito, inedito alla sua apparizione: lo scardinamento dell’unità narrativa spazio-temporale, assorbita in un “unicum” che è cerchio dall’inizio alla fine. Non occorre altro. Ciò cui s’assiste è un congegnato “frame” narrativo che non necessita di artificiosi stratagemmi o roboanti orpelli da decadente confezione “studio system”. Un’icasticità che nell’industria di serie B, perlopiù snobbata e altresì garanzia di cinema fatto con intelligenza e passione (scarno “budget”, rapidità d’esecuzione, totale sfruttamento del materiale di lavorazione), trova un comodo posto, cui s’acclude un ulteriore elemento di sorpresa: il paradigma teatrale, che insinua gli ipertestuali Camus e Sartre, soprattutto il Beckett di “Aspettando Godot”, all’interno d’un contesto scenico costantemente pervaso dalla morte – presenza (extra)diegetica aleggiante e inevitabile – in cui le figure al centro, anime agonizzanti che nulla possono contro il Fato pur cercando di resistergli, procedono come criceti in una ruota. Senza senso, identità o nome, consapevoli d’un destino che incarnano senza (domandarsi) un perché.
In tale anonimia il campionario umano e paesaggistico, non insensibile alla componente figurativa dell’iperrealismo, si esprime in una sorta di spettacolo esistenzialista, per alcuni versi preludendo il “milieu” della New Hollywood che dagli hippy in “chopper” alla vana ricerca dell’America, sino ai “dropout” in impossibile fuga da tutto (e “in primis” da sé stessi), funge da vivaio per un collettivo ritratto generazionale: si prenda “Cinque pezzi facili”, la cui sceneggiatura è firmata da Adrien Joyce (al secolo Carol Eastman), già autrice del copione de “La sparatoria”, e il cui protagonista – “outsider” senza meta per scelta, condannato a peregrinare come in un limbo – è il Jack Nicholson destinato di lì a poco a farsi volto iconico del Nuovo Cinema Americano. Il Jack Nicholson che, insieme al trentasettenne Hellman, fonda l’indipendente Proteus, con la quale il cineasta newyorchese gira il noto dittico western composto dal già citato “La sparatoria” e da “Le colline blu”, del quale Jack scrive il soggetto, negli stessi luoghi e nello stesso momento, la mattina uno e il pomeriggio l’altro, con un costo minimo e identiche maestranze. In maniera esemplare, dopo un lungo apprendistato da fotografo, montatore e autore radiofonico, Hellman ostenta la lezione del mentore Roger Corman (che gli consente di esordire alla regia con l’horror “Beast from Haunted Cave”, e perfino co-dirigere alcune scene de “La vergine di cera”), al quale non poco si deve la rinascita della cinematografia a stelle e strisce, e che non s’arena alla tecnica registico-produttiva ma abbraccia quella rivisitazione dei generi da cui sarà impossibile uscire.
Se il crepuscolo della Grande Frontiera trova il proprio vate stanco e disilluso nell’anarchico Peckinpah (e proprio lui impersona il “novelist” Wilbur Olsen del tardivo “Amore, piombo e furore”), è d’uopo rammentare che in Hellman il genere, rifuggendo una facile effettistica, conduce a una meditazione filosofico-esistenziale svelata da un impiego di tempi lentissimi, una linearità nello stile, un’acuta osservazione della dilatazione spaziale tipica del western (e qualche vaga eco s’individua nel recente “I fratelli Sisters” di Jacques Audiard). In ambo i casi si tratta di restituzione pessimistica, tuttavia la visione esistenzialista che il regista immette, senza curarsi troppo della ristrutturazione del cinema, avvia a un crepuscolarismo antispettacolare e antieroico, ribadito pure da scelte fisionomiche: a parte Nicholson, il Warren Oates feticcio di Peckinpah, che Hellman considera un ideale “alter ego” tanto da utilizzarlo in quattro occasioni preferendolo a Sterling Hayden (in “Cockfighter” è un taciturno allevatore di polli da combattimento), e alla cui memoria dedica l’avventuroso thriller “Iguana”. E un inedito Oates affianca i musicisti James Taylor e Dennis Wilson in quell’anti-“Easy Rider” ch’è lo sfortunato “Strada a doppia corsia”, il cui maggior pregio, a dispetto del film di Hopper, è una distanza da costumi e spiriti dell’epoca eletta a denudante spaccato, i cui caratteri, poco più che figuranti, si rivelano creature solitarie cui non importa molto della sfida lanciata al volante dei rispettivi bolidi (il loro unico documento d’identità): mitomania e ciarliera spavalderia bruciano rapide sulla pista, e ogni attante offre di sé una versione discrepante della propria esistenza; tutti però, girovagando lungo il sudovest americano, paiono consci del personale fallimento e ci convivono senza (voler) apporvi rimedio. Non sorprende come il miglior lavoro di Hellman, nonché uno tra i “road movies” più rappresentativi del decennio, acquisti la patina di “cult”: come nei citati western – implicite letture dell’omicidio Kennedy e dei conseguenti, paranoici effetti – i personaggi sono in movimento laddove l’azione si riduce a un quadro desolato, apparentemente statico, che sembra non mutare. Non meno inerte è il tempo, l’imminente resta tale, l’accadimento non accade mai, né i protagonisti fanno qualcosa affinché l’evento si compia. Ripetitivi i micro-eventi, eppure tutto scorre in uno spoglio vortice senza strilli, lento e inarrestabile, riverbero d’un “climax” socioculturale a un passo dalla crisi.

Come le rockstar denudate dell’abituale contesto in uno strano gioco meta-testuale, che non solo non cantano ma che quasi non parlano, Hellman si trasla in personaggio “prigioniero” della propria “politique”, che in un cinema e in un’epoca in moto frenetico si smarrisce, senza sapere né volere leggere la staticità del suo periodo. E al pari di Corman, il suo posto è ampiamente occupato se non surclassato da autori nuovi, debitori di un’erudizione imprescindibile nella confezione “indie”, in barba a “majors” e “System”, che la produzione postmoderna ampiamente dimostrerà: a tagliar la testa al toro è il ruolo del Nostro come produttore esecutivo per l’esordio registico del giovane Tarantino (quel “Le iene” che in un primo momento Hellman vorrebbe dirigere, nei cui disseminati indizi si può individuare la filigrana, dai gangster senza nome all’azione concentrata in un magazzino), che, da grande ammiratore, sovente lo menzionerà, come testimonia il motore truccato di Stuntman Mike. E se “Amore, piombo e furore”, girato in Spagna e in Italia, benché nel solco dello spaghetti-western è un’anomala incursione in un tempo frattanto rinnovatosi, l’antifona rimane quella d’un cineasta poco prolifico verso un mondo che non può cambiare, dove (soprav)vivere fa parte d’un cerchio – il mondo, appunto – da prendersi com’è.
Quasi fosse un ulteriore capriccio del destino, Hellman scompare il giorno prima che l’amico Nicholson raggiunga gli 84 calendari, e c’è chi, per ricordarne il culto, si sperpera tra messaggi di commiato e disperate ricerche cinefile: citata anche da Roberto Silvestri, una squisita curiosità concerne una sequenza introduttiva di “Per un pugno di dollari”, girata da Hellman per un’edizione irta di tagli, totalmente estranea all’originale, e visibile solo alla tv americana. “Road to Nowhere” è l’ultimo lungometraggio del settantottenne autore, realizzato in parte in Italia e mai distribuito, che ne segna il ritorno al cinema dopo ventun anni d’assenza: uno strano esperimento, ammaliante e “démodé”, sul cinema e sull’usuale rimescolio realtà-finzione. Una “strada verso il nulla”, appunto, come un “freeze” conclusivo in cui la pellicola si liquefà sullo schermo, in completo mutismo: oltre il cerchio non c’è altro. Nel cinema come nella vita.
SAGGI
I FILM COMPILATION (O FILM DI MONTAGGIO), TRA PRODOTTI COMMERCIALI E OPERE ARTISTICHE
di Roberto Baldassarre
COMPILATION IN AMBITO MUSICALE
Usualmente il termine “Compilation” è utilizzato nell’industria musicale, ed è usato come sinonimo di “Anthology”, “The essential”, “The Best” o “Greatest Hits”. Confrontando il termine “Compilation” con queste altre quattro espressioni, sicuramente la più affine è “antologia”, mentre le altre tre evidenziano nettamente lo specifico del loro contenuto, ossia l’essenziale, il meglio o i maggiori successi di un artista o più artisti, mentre la “compilation”, sovente effettuata dalla casa discografica senza chiedere opinioni agli artisti (se non pagargli le dovute royalties), assomma differenti brani inerenti a una determinata decade o a uno specifico genere musicale. A livello di audience le “compilation” musicali hanno sempre avuto ottimi riscontri di vendite, perché in un solo disco sono raccolte differenti canzoni che riescono, attraverso un assaggio, a dare fisionomia al decennio preso in esame oppure fornire alcuni spunti inerenti al genere musicale trattato. Utilizzando un tecnicismo cinematografico, si potrebbero definire le “Compilation” come delle carrellate laterali, che ci presentano l’argomento in questione. Ad esempio, quando esplose il revival della musica degli anni Ottanta, ossia dalla seconda metà degli anni Novanta, grande esito ebbe l’enorme serie, prodotta dalla Universal Music e composta da ben 20 Cd (1998-2009), One Shot ’80, che compilava una sfilza di canzonette che avevano infiorettato le classifiche di quel decennio. Per precisare, in ambito musicale “One Shot” significa meteora, ovvero artisti o canzoni che hanno fatto centro in classifica una sola volta. Una “Compilation” ponte tra musica e cinema si ravvisa in una lontana iniziativa editoriale proposta da “L’Unità” durante il 1996, quando il periodico era diretto dal cinefilo Walter Veltroni e il centenario del cinema era stato da poco onorato. “L’Unità” pubblicò la serie “Cinema & Musica”, 6 compilazioni che raccoglievano, suddivise per argomenti, un determinato tipo di musica da film: Classica, Hollywood, Il grande freddo, Rock, Pop, Jazz. Tra questi Cd il più gettonato fu quello dedicato alla pellicola “Il grande freddo” (The Big Chill, 1983) di Lawrence Kasdan, che a ben guardare è più una colonna sonora che una “Compilation”.
In ogni modo una iniziativa simile era stata anche proposta, sebbene con meno successo, dalla rivista “Panorama” nel 1994, poiché allegava settimanalmente al magazine una musicassetta con brani noti legati a pellicole famose. Il titolo di questa serie era “Indimenticabili”. Un altro legame tra cinema e musica si è creato anche con quelle VHS o DVD “Compilation” che contengono i videoclip musicali. Sovente sono raggruppamenti di video di uno stesso artista, ma a volte anche di musicisti differenti, per andare a creare una panoramica su una decade oppure per mostrare i migliori videoclip della storia musicale. Queste raccolte, che di solito sono solo per aficionados di quel musicista o di quel gruppo, divengono fondamentali per valutare il percorso evolutivo sia della tecnica video e sia per comprendere come gli artisti abbiano sempre maggiormente puntato su questo formato tanto artistico quanto pubblicitario, in particolare con l’avvento del canale MTV. Per fare qualche esempio, fondamentali sono le “Compilation” “Queen Greatest Flix II” (1991), che raggruppa i migliori videoclip degli anni Ottanta del gruppo inglese, oppure i due “The Best of 1980-1990” (1998) e “The Best of 1990-2000” degli U2, che mostrano come il gruppo irlandese con il passare degli anni si sia affinato – investendo anche maggior denaro – nei videoclip.
I FILM COMPILATION
Si può applicare il termine “compilation” direttamente al cinema? Una pellicola costruita con più brani assemblati assieme viene definito film a episodi o film episodico. Usualmente è un tipo di realizzazione più di tipo produttivo che di valenza artistica, che nelle sue varie tipologie si è rivelato molto redditizio, essendo stato in passato una prassi consolidata nel cinema italiano. Sondando solo la cinematografia italiana, si può facilmente riscontrare che sono stati realizzati tantissimi film episodici – principalmente commedie – che sebbene adottassero sempre differenti escamotage produttivi, avevano come forza di richiamo per il pubblico l’attore o gli attori coinvolti. Questi film episodici potevano essere strutturati narrativamente in differenti modi, avere come realizzatori uno o più registi, essere costruiti su due o più storie, avere un filo conduttore oppure un’argomentazione libera.
Raramente un film episodico è nato da un intento autoriale, e come nobili esempi si potrebbero citare lo sfortunato “Ro.Go.Pa.G. – Laviamoci il cervello” (1963), compilazione erudita sulle manie e le paura della gente nel pieno boom economico, antologia coraggiosamente portata a compimento dal produttore Alfredo Bini; oppure il melomane “Aria” (1987), nel quale 10 registi realizzano il proprio segmento mettendo in immagini l’aria lirica prescelta. Il termine “Compilation”, però, si potrebbe utilizzare benissimo per alcuni film di montaggio, cioè quelle opere che assemblano brani filmici già esistenti e che sono (ri)montati assieme per creare un’opera a sé stante.
Restando nell’ambito della commedia italiana, il programma televisivo “Storia di un italiano” (1979-1986), ideato e condotto da Alberto Sordi, è un mastodontico “documentario” compilativo che ripercorre la storia degli usi e costumi dell’Italia del Novecento attraverso brani estratti da molte pellicole interpretate dell’Albertone nazionale. Precedentemente ci sono stati anche due film di montaggio nodali, e in un certo qual modo similari al monumento compilativo auto-celebrativo ad Alberto Sordi, dedicati a Totò (1898-1967): la frettolosa antologia ossequiosa “Totò story” (1968), che assembla spezzoni comici desunti da: “Totò sceicco” (1950) di Mario Mattoli, “La banda degli onesti” (1956) di Camillo Mastrocinque, “Totò, Peppino e la… malafemmina” (1956) di Camillo Mastrocinque; “Signori si nasce” (1960) di Mario Mattoli, “Totò, Peppino e i fuorilegge” (1956) di Camillo Mastrocinque, “Totòtruffa ‘62” (1962) di Camillo Mastrocinque, “Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi (1960) di Mario Mattoli; oppure la più accorta “Antologia di Totò” (Totò, une anthologie, 1978) curato dallo storico francese Jean-Louis Comolli e con Dario Fo come commentatore. Questa compilazione, che cerca di essere più esaustiva e filologica, ripesca anch’essa le migliori scenette aventi protagonista il Principe De Curtis, ma recupera gags anche dal primo film “Fermo con le mani” (1937) di Gero Zambuto oppure dallo sfortunato “Risate di gioia” (1960) di Mario Monicelli. Gli spezzoni della “compilation” creata da Comolli sono tratti da ben 17 pellicole.
Operazioni simili a “Totò story” sono i due film collage che hanno come protagonisti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Sono due intenti prettamente commerciali che cercano di spacciare come nuovi film vecchi brani comici del redditizio duo, che in quel momento si era sciolto (torneranno a recitare assieme soltanto nel 1981). Il prodotto “Franco e Ciccio Superstar” (1974), assemblato da Giorgio Agliani, è una compilazione fatta mettendo insieme quattro brani desunti da: “Continuavano a chiamarli… er più e er meno” (1972) di Giuseppe Orlandini; “Il clan dei due Borsalini” (1971) di Giuseppe Orlandini; “Il lungo, il corto, il gatto” (1967) di Lucio Fulci; “Come svaligiammo la banca d’Italia” (1966) di Lucio Fulci. Mentre “Amici più di prima” (1976), invece, infila ben 9 spezzoni: “I due mafiosi” (1963) di Giorgio Simonelli; “Due mafiosi nel Far West” (1964) di Giorgio Simonelli; “Due mafiosi contro Goldginger” (1965) di Giorgio Simonelli; “Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione” (1970) di Marino Girolami; “2 mafiosi contro Al Capone” (1966) di Giorgio Simonelli; “I due deputati” (1968) di Gianni Grimaldi. Le antologie comiche sono state anche create per mettere insieme scenette di noti e amati comici stranieri, come attestano ad esempio: “La bomba comica” (1958) film di montaggio che mette insieme vecchissimi filmati diretti da Mack Sennett che vedono come protagonisti – separatamente – Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton e Stan Laurel e Oliver Hardy; oppure la “Compilation”, con un titolo assurdo dato dalla distribuzione italiana, “Al Cafone e compagni” (1959), film di montaggio che contiene diverse gag mute di un giovanissimo Charlie Chaplin.
Più interessante, e probabilmente più facilmente definibile come “film Compilation” è l’antologia “Super vacanze di Natale” (2017) curata da Paolo Ruffini, che vuole omaggiare i famigerati cinepanettoni. L’atto di ossequio di Ruffini consiste nel cogliere lacerti comici da tutti i cinepanettoni realizzati dal 1983 (anno del primo “Vacanze di Natale” di Carlo Vanzina) fino al 2016 (“Natale a Londra – Dio salvi la regina” di Volfango de Biasi). Anche questa operazione nostalgica, poco fruttuosa al botteghino, ha avuto un importante antenato, ossia il compilativo “Un sorriso, uno schiaffo, un bacio in bocca” (1976) di Mario Mora, che riunisce frammenti filmici di molte pellicole prodotte dalla Titanus tra il 1947 e il 1962 inframmezzati da sketch comici di Renato Pozzetto, in quel momento uno dei comici cinematografici di maggior richiamo. Questo collage elegiaco ebbe inaspettatamente grande successo, e tutto era partito dall’idea del Press Agent Enrico Lucherini. Idea dimostratasi vincente, ma certamente Lucherini ha preso spunto da il coevo “C’era una volta… Hollywood” (That’s Entertainment!, 1974) di Jack Haley Jr., un film di montaggio celebrativo per i 50 anni della MGM, che compila in più di due ore molti spezzoni prodotti dalla casa del leone ruggente, in particolar modo utilizzando i musical. Questa “Compilation” cinefila ebbe tanto successo che vennero poi realizzati: “Hollywood… Hollywood” (That’s Entertainment! II, 1976) di Gene Kelly e “That’s Entertainment! III” (1994) di Bud Friedgen e Michael J. Sheridan. Tra il secondo e il terzo capitolo fu anche prodotto “That’s Dancing” (1985) realizzato da Jack Haley Jr., un mishmash musicale che assembla diverse pellicole musicali non solamente di derivazione MGM. Infine, una particolare compilation.
LE VHS COMPILATION
In questo excursus, da mettere in evidenza anche alcune VHS compilation prodotte a metà degli anni Novanta, che valicano l’aspetto commerciale e si posizionano più nell’ambito divulgativo. Sono tre VHS antologiche distribuite dalla Mondadori Video, poco prima del centenario del cinematografo. “Antologia surrealista 1” (1993) raccoglie tre cortometraggi surrealisti: “La coquille et le Clergyman” (1928) di Germain Dulac, “Un chien andalou – Un cane andaluso” (Un chien andalou, 1929) di Louis Buñuel ed “Entr’acte” (1924) di René Clair. “Antologia surrealista 2” (1993) contiene: “Le retour à la raison” (1923) di Man Ray, “Ballet mecanique” (1924) di Fernand Léger, “Anémic Cinéma” (1926) di Marcel Duchamp, “Emak-Bakia” (1926) di Man Ray, “L’etoile de mer” (1928) di Man Ray. “Antologia delle origini” (1994), curata dallo storico Antonio Costa, riunisce alcuni fondamentali filmati dei primordi del cinema dal 1891 (i primi tentativi di pre-cinema) fino al 1907 (periodo in cui il cinema entrava nella consapevolezza tecnico-produttiva). I filmati scelti per fare una panoramica sugli albori del cinema sono tratti dall’opera di August (1862-1954) e Louis (1864-1948) Lumiére, da Thomas Alva Edison (1847-1931), da Étienne-Jules Marey (1830-1904), da Charles-Émile Reynaud (1844-1918) e da Edwin Porter (1870-1941).
Sono state tre VHS fondamentali, distribuite in un periodo in cui internet in pratica non esisteva e il materiale proposto era “chimerico”, e per tanto andavano a creare un ideale ponte conoscitivo tra questi lontani esperimenti cinematografici “strani” e il pubblico contemporaneo. Altra VHS compilation di un certo interesse è “Jess Franco Movie Trailers 1961 to 1999”, antologia uscita nel nuovo millennio e contenente ben 17 prossimamente di film diretti da Jesús Franco (1930-2013). Certamente poco nota e già finita nel dimenticatoio, ma vantaggiosa per comprendere la realizzazione di un trailer per una pellicola di basso rango, e fare un raffronto con i filologici Fake Trailer inseriti a metà nel Double Feature “Grindhouse” (2007) di Robert Rodriguez e Quentin Tarantino. Infine una VHS compilation che si riallaccia alle antologie monografiche su Totò e Franco e Ciccio, ovvero “Pillole, capsule & supposte” (1999) di Carlo Verdone. È un video antologico nel quale l’autore romano mette insieme quelli che lui ritiene i suoi migliori sketch comici, e vi aggiunge, nel girato ex novo, anche dei nuovi personaggi.
COMPILATION AUTORIALI
I “film compilation” non nascono solamente per meri profitti commerciali, come si è visto in precedenza, ma a volte ci sono anche opere che usano questo tipo di struttura in modo autoriale. L’imponente compilazione antologica che Jean-Luc Godard fa con “Histoire(s) du cinéma” (1988-1998), vuole ri-raccontare la storia del cinema sommando e mischiando materiali di differente provenienza (cinema, letteratura, musica). È una “Compilation” cinefilo-didattica-teorica scaturita dalla personale visione iconoclasta di Godard, e per tanto si può accettare o dissentire. L’opera è composta da 8 capitoli, e in un certo qual modo ogni capitolo è come se fosse paragonabile a un album musicale, essendo composto da un lato A e un lato B. I capitoli sono: 1 (a) Toutes les histoires; 1 (b) Une histoire seule; 2 (a) Seul le cinéma; 2 (b) Fatale beauté; 3 (a) La monnaie e l’absolu; 3 (b) Une vague Nouvelle; 4 (a) Le contrôle de l’univers; 4 (b) Les signes parmi nous.
Altra stimolante “Compilation” autoriale è “Scandalosi vecchi tempi” (Polisons et galipettes, 2002) di Michel Reilhac. Questo documentario compilativo è la somma di oltre 300 filmati pornografici muti che furono realizzati per essere proiettati nei bordelli, e databili tra il 1905 e il 1930. L’opera di Reilhac non è solamente una birichina operazione ironicamente nostalgica, come sponsorizza la distribuzione italiana, ma diviene una carrellata laterale su quel modo di realizzare porno e la fruizione per cui erano realizzati.
Quest’ultimo film compilativo, che attinge dal found footage, fa pensare anche alle opere create dalla coppia registica Angela Ricci Lucchi (1942-2018) e Yervant Gianikian (1942). Le loro pellicole non sono proprio definibili come “Compilation”, perché è vero che assommano materiale d’archivio, ma lo assemblano secondo un proprio gusto personale artistico che trasforma quegli spezzoni in un unico viaggio nelle immagini. Detto ciò, comunque, va citato almeno il loro “Dal polo all’equatore” (1986), che mette insieme molto materiale filmico realizzato da Luca Comerio (1878-1940), divenendo un sentito omaggio al dimenticato Comerio, uno dei primi operatori che ha raccolto materiale intorno al mondo.
PETER DEL MONTE: LETTERA CONTROVENTO
di Francesco Saverio Marzaduri
Caro Peter Del Monte, chi scrive confessa di non essere mai stato troppo ferrato sulla tua opera, e dunque di non esser mai stato un tuo grande ammiratore: il che, per un cultore della Settima Arte, costituisce certo un punto debole. Ciò, per inciso, non per snobismo o preferenze che la vincano sulle differenze, ma solo perché la tua filmografia – che conta poco più d’una quindicina di titoli in quasi mezzo secolo, considerando pure i lavori per il piccolo schermo – ha sempre dovuto far i conti con circuiti di preferenza commerciali in cui il labile margine per firme minimaliste, più sensibili di altre ai piccoli problemi (meglio, ai “piccoli fuochi”) della quotidianità, sarebbe andato via via scemando. Come una traccia di vita amorosa, irta di brevi ritagli esistenziali, ridotta a sperduta oasi nel mare magno di produzioni che non sa più che farsene di apologhi a basso costo, concepiti nel segno d’una semplicità la cui filigrana si rivela tutt’altro che elementare, oggetto di dissertazioni riverberanti un personalissimo sguardo sul mondo. Lo stesso tuo primo lavoro a uscire nelle sale italiane era in realtà il tuo secondo film, laddove l’esordio, dall’esplicativo titolo “Fuori campo” e col quale ti saresti diplomato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, recava il segno d’un mutamento di tempi e gusti; la stessa egida di quel Rossellini che nei primi anni Settanta avrebbe accantonato il grande schermo, approntando nuovi linguaggi per la narrazione televisiva, mostrò come il coraggio del cambiamento si conciliasse con una rivoluzionaria boccata d’aria, attraversando un ampio solco che non s’arenava giocoforza al registro politico. Erano gli anni di autori giovani e freschi, ognuno con la rispettiva “politique”, chi più chi meno destinati a lasciare l’impronta anche nei decenni successivi: il periodo dei fratelli Bertolucci, di Faenza e Giordana, di Piscicelli e Amelio, e del primo Moretti. Se purtroppo, causa i citati motivi, il tuo nome non ha lasciato gran spazio nella produzione dell’ultimo ventennio, questo non costituisce necessariamente una colpa, né un demerito: il carattere riservato ma disponibile, umile e garbato, testimoniato da chi ti conosceva, era deittico marcatore d’una cifra stilistica disinteressata alla volontà di apparire; sicché la tua filmografia si spiega col desiderio d’illustrare il proprio discorso senza forzature o condizionamenti altrui. Prima che una sorta d’originale vagabondaggio, in cui nessuno pettina bene come il vento, un “invito al viaggio”, meglio se in compagnia: questo il piccolo, spirituale monito di volta in volta riproposto in varie forme, dove un pellegrinaggio a Milano condotto da un ragazzo padre appena tredicenne si trasla nell’onirica allucinazione di un bambino di sei anni, benché il violento Edipo che ne scaturisce non impedisca fantasticherie tipiche dell’immaginazione infantile. Nel maggiore dei casi l’infanzia riveste un ruolo determinante, nella misura in cui gli assunti da te firmati suonano quali favole metropolitane debitrici del neorealismo alla Zavattini, ove il Sessantotto, iniziato e concluso in un celere istante, è testimone di consegna nelle mani di figurine alle prese con temporalità più grandi di loro, ben lontani da sogni, speranze, illusioni di chi ingenuamente li ha messi al mondo. Tanto la fantasia è univoco strumento per controbattere gli egoismi adulti, quanto l’itinerario – insegna la letteratura classica – è una lunga ricerca del tempo perduto in cui radunare i cocci dell’esistenza, annoverante delicati sdoppiamenti tra immaginazione e realtà – ciò che potrebbe essere e di fatto è – e non sempre destinata a siglarsi in modo idilliaco. Le sorprese del Fato son sempre dietro l’angolo e “nelle tue mani”, forse, qui risiede il gusto d’una sorpresa, positiva o negativa, tra risvolti insospettati e impreviste affinità che sfociano in inattesi recuperi. Probabilmente è questa, la magica chiave del tuo cinema: un’immaginifica terapia, che alterna Freud e pedagogia, volta all’introspezione nella stentata (ancorché non vana) possibilità d’una cura; come fa “l’altra donna” della tua non prolifica opera: una signora sposata, infelice e tradita dal coniuge, in cui uno dei pochi sostegni, una colf di colore, inaspettatamente scompare spingendo la protagonista, sola e sperduta, al suo ritrovamento. Oltre il fantastico, la scelta di raccontare il sentimento della vita in pieghe riposte e sottili conciliava con la scommessa d’una sperimentazione ereditata dai maestri, che non abbracciava solo generi e ipertesti (talora strizzando l’occhio al gotico macabro circa ambientazioni e scenografie): lo riprovano le riprese di “Giulia e Giulia”, prima fiction realizzata con un sistema analogico “ante litteram” ad alta definizione. Al pari di altri talentuosi “film maker” fuori dagli sche(r)mi di quel periodo, ormai misconosciuti, tu pure saresti tornato oggetto di culto e rivalutazione grazie alle ospitate di festival e “kermesse” (come la partecipazione a Napoli, nel luglio di tredici anni fa) e alle monografiche retrospettive che t’avrebbero dedicato; non è mai abbastanza, eppure giurerei di carpire la tua lezione in altri cineasti, da Gianni Zanasi a Ivano De Matteo, dall’orma altrettanto originale e anch’essi ai margini del grande circuito. L’improvvisa scomparsa, lo stesso 31 maggio in cui il vegliardo Clint Eastwood aggiungeva una candelina ai propri novanta calendari, non è avvenuta in punta di piedi come forse il tuo animo gentile pensava, salutata da tornate di commossi commiati tra carta stampata, “social network” e “blog”; segno che il cinema nostrano, sospeso tra poesia e surreale, probabilmente ancora necessita di qualche scossa “controvento” di romantica indecifrabilità: la medesima, libera e selvaggia di cui l’odierna cultura – e il Paese tutto – sentono il bisogno senza necessariamente esplicitarlo.
ELOGIO DELL’UOMO LAICO “L’ora di religione” di Marco Bellocchio
di Danilo Amione
Bellocchio e il mondo senza più ideali: politici, sociali, di cambiamento.
Caduti tutti i muri, ad Ernesto, affermato e schivo pittore, non resta che vivere il suo ateo presente nel ripetersi di un quotidiano fatto solo di sopravvivenza. Separato dalla moglie Irene ed attento alla crescita equilibrata del piccolo figlio Leonardo, egli apprende improvvisamente della ferma volontà del Vaticano di beatificare la madre, uccisa anni prima da un altro figlio, Egidio.
Da questo momento ha inizio per Ernesto, e per lo spettatore che sapientemente il regista piacentino coinvolge nella vicenda attraverso uno stile asciutto, essenziale, anche grazie alla bella fotografia “in nero” di Pasquale Mari, un viaggio nella vertigine. Tutto quello che si muove attorno al protagonista si rivela frutto di una macchinazione ordita dalla famiglia per costringerlo ad accettare l’inaccettabile. Che non è certo la beatificazione di per sé (come frainteso dalla CEI che ha duramente attaccato il film), ma ciò che ad essa sta dietro. Da un lato, le convenienze della Chiesa, pronta a sacrificare sull’altare della santità le ragioni che hanno portato il disturbo psichico di un figlio all’uccisione della madre (e qui ritorna il tema di fondo di tutto il cinema di Bellocchio, il disagio familiare borghese, dal magnifico debutto de “I pugni in tasca” (1965), a “Nel nome del padre” (1972), da “Salto nel vuoto” (1979), allo splendido “Gli occhi, la bocca” (1983), a “Il sogno della farfalla” (1994), fino a “La balia” (1999), a “Vincere” (2009), e ai più recenti “Bella addormentata” (2012), e “Fai bei sogni” (2016), “Marx può aspettare” (2021), solo per citare alcuni dei titoli emblematici della sua filmografia).
Dall’altro, le esigenze di una famiglia il cui unico obiettivo è quello di assicurarsi un futuro di notorietà e dunque di sicurezza economica, che compenserebbe tutti i fallimenti esistenziali a cui i suoi componenti sono incorsi (un altro fratello è un ex terrorista che si ribella ad un presente da sopravvissuto). Il tutto è riassunto nell’illuminante e spietato dialogo fra Ernesto e la cinica zia Maria (una inarrivabile Piera Degli Esposti), atea anche lei, che invita il nipote a riflettere su che cosa abbia significato la coerenza nella sua vita ed in quella dei suoi fratelli, nel caso volesse immolare ad essa anche il futuro del figlio Leonardo. Il coraggio di Bellocchio è stato quello di analizzare il mondo che lo circonda, traendone cinema, con lo stesso candore rivoluzionario dei suoi primi film. Lì ogni contenuto veniva giustificato da un clima, quello degli anni ’60 e ’70, favorevole ad accogliere parabole ribelli. Nel 2002, l’esprimersi della follia di Eugenio, “torturato” dalle domande degli emissari del Papa, attraverso la bestemmia gridata fino alla saturazione, o il franco affermare di Ernesto che la madre era soltanto una “cretina insensibile” hanno riaperto in maniera sanamente provocatoria un contenzioso che la cinematografia italiana aveva purtroppo chiuso con la società già all’inizio degli anni ’80. Ed il fatto che il film abbia ottenuto numerosi riconoscimenti prestigiosi e sia stato ai vertici degli incassi stagionali, nonostante le importanti avversioni di cui sopra, sta a dimostrare che un artista non può che diventare “visibile” anche quando si tenta di cancellarlo. Lo sguardo di Bellocchio si muove in maniera così avvertita da lasciare un segno indelebile nell’occhio dello spettatore, anche quando l’elemento narrativo lascia il passo ad immagini bressonianamente sospese e per questo foriere di un coinvolgimento nei confronti di chi si presta ad interpretare ogni singola inquadratura come un tassello di un enorme puzzle emotivo. Il senso di religiosità laica che promana dal film è direttamente proporzionale ad un’etica della spiritualità vissuta nel rispetto delle scelte così come la coscienza umana può concepirle e dettarle al proprio essere.
La rivendicazione del protagonista, un sorprendente Sergio Castellitto, dell’innamoramento come unico traguardo cui tendere per dare valore alla propria esistenza, riempie la vicenda di una pienezza terrena che fa da contraltare all’ipocrisia di chi cerca nella religione una sorta di assicurazione per l’eternità. Speculazione sul dubbio contro verità umana, questa la motivazione insieme forte e dolorosa di un’opera che costringe lo spettatore a fare i conti con la propria coscienza, laica o religiosa che sia. Già nei due titoli del film sta l’assunto dello stesso. “L’ora di religione” è quella a cui il figlio di Ernesto viene iscritto a scuola dalla madre, soltanto perché opportuno e conveniente relativamente alla vicenda che riguarda la nonna, nonostante non sia battezzato e il padre sia contrario. “Il sorriso di mia madre” indica l’ambiguità del rapporto madre-figlio che informa tutto il film, dalla vicenda succitata, all’esperienza matricida, fino alla figura materna della Chiesa che tutto tende a fagocitare. La necessaria “liberazione” dalla madre è avvertita dallo spettatore quando questa diventa complice dei parenti nel gran gioco della santificazione, sacrificando “ a fin di bene” il figlio, sottratto alla libera scelta cui il padre lo aveva laicamente destinato. E’ proprio la figura paterna che si impone, dunque, come elemento di rottura di una spirale perversa che tende all’abbraccio soffocante. Nel film d’esordio del regista lombardo, “I pugni in tasca”, il padre era assente (perché morto e non solo freudianamente) e la ribellione del figlio si rivolgeva contro la madre significativamente cieca. Oggi Bellocchio fa un passo avanti e teorizza il padre come indispensabile via di fuga. La gigantografia sfumata di una icona della madre, su cui Ernesto pone una mano quasi a volerne scrutare il valore affettivo, appare come l’immagine emblematica e metaforica di un rapporto irrisolto che resterà sempre tale. La figura paterna che ai tempi del primo “rivoluzionario” Bellocchio rappresentava l’incarnazione del potere, oggi al Bellocchio passato attraverso l’esperienza psicanalitica, riversata in opere quali “Diavolo in corpo” (1986), “La visione del Sabba” (1987), “La condanna” (1991), si appalesa come componente essenziale del rapporto genitori-figli, al di là di qualsiasi tipologia familiare. La maestria del regista si dipana su livelli motivazionali che toccano vertici da tempo sconosciuti al nostro cinema, come quando il protagonista recita la poesia di Tarkovskij padre “Tutto questo non basta”, o, nel finale, guarda felice il figlio, che ha sottratto ad ogni macchinazione, entrare a scuola e sembra invidiarne l’entusiasmo ancora intatto. Il quotidiano diventa così paradigma di scelte che affondano le loro radici nel tempo, con un presente comunque e inevitabilmente funzione di momenti che diventano storia, personale e collettiva. Un film, dunque, decisamente in anticipo sui tempi, e che conferma in pieno la vena libertaria e dissacratoria di un cineasta che come pochi altri, vedi Ferreri o Pasolini, ha saputo indirizzare modi e contenuti verso mete che altrimenti sarebbero rimaste tabù inesplorati.
VAMPIRI, POETI E ZOMBIE NEL NUOVO CINEMA DI JIM JARMUSCH
di Roberto Lasagna

Tutto il cinema di Jarmusch è un viaggio nella notte della coscienza, sia negli esordi dell’autore di Akron, sia nelle opere più recenti, dove troviamo nuovi personaggi al confine con la morte e la sopravvivenza degli ideali di bellezza. Il viaggio nella coscienza di un film inedito in Italia come “The Limits of control” (2009) prelude alla profondità metaforica del successivo film di Jarmusch, “Solo gli amanti sopravvivono” (2013), che fa conoscere alle nuove generazioni il regista di “Stranger than paradise” (1984) e reca nel pantheon jarmuschano i vampiri Adam e Eve.
Costoro sono amanti dell’arte, dell’estetica, della letteratura e della musica underground, e si muovono su voli di prima classe o in auto, di notte, per ritrovare fantasmi della cultura che fu. Da una parte loro, i vampiri, emaciati ma dignitosi, dall’altra gli esseri umani, che loro chiamano zombie perché hanno contribuito alle guerre e alla loro autodistruzione. Gli zombie torneranno nel successivo “I morti non muoiono” (2019) e saranno strane creature alla ricerca, esattamente come i vampiri di “Solo gli amanti sopravvivono”, di quel sentimento che un luogo è in grado di ridestare naturalmente.
Presentato in concorso al Festival di Cannes 2013, “Solo gli amanti sopravvivono” è la vicenda romantica di Adam (Tom Hiddleston) e Eve (Tilda Swinton), uniti da secoli, i quali vivono separati, l’uno a Detroit e l’altra a Tangeri, sopravvivendo in pace attraverso il sangue umano pulito fornito loro da medici collaborativi. Adam è depresso perché il mondo circostante cade a pezzi, con gli umani incapaci di preservare la bellezza del mondo. Un universo che si sfalda, mentre soltanto il legame degli amanti conserva in loro il filo della perseveranza, la capacità di assaporare i piccoli piaceri dell’esistenza, di apprezzare la natura e i rapporti con gli altri, sia i propri simili sia gli umani.
Soggiogati dalla superficialità umana nonostante la loro romantica e coraggiosa resistenza, Adam e Eve sono sottratti alla loro condizione di cultori contemplativi e ricacciati nella dimensione del bisogno, per adattarsi alle circostanze e diventare uguali agli “zombie” che hanno disprezzato anche se loro due, per lo meno, sono stati in grado di avvertire quella consapevolezza che agli altri sembra non appartenere ormai da molto tempo. Adam e Eve paiono come vette di quello che gli esseri umani sono stati in grado di creare prima della decadenza, mentre nel film domina l’immagine post-industriale dei dintorni di Detroit e il celebre Teatro Michigan, costruito negli anni Venti con i suoi quattro mila posti e ora divenuto un parcheggio.
Stile e ironia non difettano al film, per questi vampiri umanistici che si consolano e si rinfrescano con i ghiaccioli di sangue e i personaggi a ripercorrere quotidianamente le stesse abitudini come fa l’autista Paterson nell’omonimo film di Jarmusch che segue: un muoversi in circolo come quel giradischi degli amanti vampiri. Un girare in tondo che non nasconde la tristezza del personaggio del lungometraggio del 2016, che il volto di Adam Driver e la musica degli Sqürl, il gruppo di Jarmusch e Carter Logan, sono pronti a caricare di composto straniamento. Paterson è un umano che sopravvive, come i vampiri, difendendo la solitudine del suo spazio interiore, in quell’inconscio che sembra avere regole minime, come il racconto di Jarmusch fatto di campi e controcampi, interno ed esterno. Con un colore deprivato di tinte forti, dove però il vuoto diviene fonte di bellezza esattamente come in un pensiero zen. Quel vuoto che rimane e resiste come volontà interiore, restituisce forma al reale, disposto come una pagina bianca su cui sia possibile disporre i segni di una poesia minimale che riordina i motivi della quotidianità vissuta dal personaggio. Il quale vive nella tranquilla cittadina del New Jersey, conosciuta per aver dato i natali al poeta e medico William Carlos Williams che alla città dedicò il poema del titolo. E Paterson-Adam Driver si alza ogni mattina tra le sei e le sei e un quarto senza bisogno di alcuna sveglia, si gira nel letto dalla parte della moglie e lei gli racconta il suo sogno, regolarmente, così che lui può andare a fare colazione, per poi dirigersi al lavoro e da solo, in silenzio, scrivere quelle poesie che nessuno, tranne la moglie, leggerà.
Scrive per se stesso e trascrive le osservazioni dei bambini che ricordano il pugile “Hurricane” Rubin Carter, o quelle di operai che raccontano di una ragazza smaniosa, o di studenti pronti a ricordare l’anarchico Gaetano Bresci che viveva a Paterson prima di morire in Italia dopo aver assassinato Re Umberto I. I microscopici avvenimenti che filtrano attraverso lo sguardo riordinante della scrittura e dei silenzi dell’autista-poeta, diventano trame combinatorie che si distendono su un telo di immagini e suoni mentre ricamano impercettibili variazioni della quotidianità fatta di pochi picchi emotivi e tanta routine. Le soste del personaggio, come il pranzo in un punto panoramico del Parco nazionale che dà sulle grandi cascate del fiume Passaic, ispirano una scrittura in cui la fissità delle inquadrature e la recitazione straniata confluiscono nel disegno sorprendente di una visione onirica del luogo. La ripetitività convive con un’attitudine a ripercorrere le stesse situazioni, ottenendo con l’immobilità del personaggio una sottile comicità mista a sorpresa per il comportamento del protagonista, impassibile nel rientrare a casa dal lavoro, nell’aggiustare la cassetta delle lettere sempre inclinata, nell’accogliere con sorpresa le intenzioni creative della sua compagna, mangiare e portare fuori il loro bulldog inglese che si chiama Marvin. Una reiterazione che si srotola lungo gli stessi gesti, con la sosta immancabile al bar per una birra e due chiacchiere con Doc, il padrone. Eppure, tra le battute uguali che passano di voce in voce dei vari personaggi, si colgono gli scarti, le differenze. Come il guasto dall’autobus di Paterson e il personaggio di Everett, il quale intende uccidere l’amata che l’ha lasciato e a sua volta uccidersi, ma viene fermato proprio da Paterson, inaspettato in ruolo tanto “attivo” (e nonostante si venga poi a sapere che la pistola di Everett era caricata soltanto di pallini di polistirolo). In questa astrazione che tinge di poeticità allusiva le immagini, ritroviamo anche la figura del doppio, come i gemelli che la moglie Laura sogna e che puntualmente il marito vede sul proprio autobus o per strada. Un reale perturbante eppure anche normalizzato, fatto dalla coppia di bambine, di anziane, o di giocatori al biliardo, che Paterson tiene a bada attraverso una scrittura che lascia segni visivi sulla tavolozza delle inquadrature. Una dimensione della psiche che il vuoto contiene e mette in luce facendo della città l’estensione spaziale e visiva della sua anima. Paterson si chiama esattamente come la città e il poeta. É lui stesso quel mondo, è lui quel poeta che William Blake/Dead man non era e non poteva essere. É lui che con il suo viaggio quotidiano nella città ci ricorda come i bambini scoprano con stupore la dimensione del tempo, che in sua presenza o in sua assenza diventa il vero tema del film, dove ogni quadro si chiude in dissolvenza, non confluisce in quello successivo, perché con Paterson, in definitiva, il grande omaggiato è Yasujiro Ozu. Questi, tra i cineasti prediletti da Jarmusch, ha fatto dell’haiku una pratica cinematografica grazie a cui le simmetrie, le ripetizioni inquadrate con rituale fissità, evocano una vita di bellezza e felicità in impercettibili variazioni cromatiche che, metabolizzate da Jarmusch, ritroviamo nel suo cinema e nelle sue dissolvenze, al seguito di una forma quasi trascendentale. La quotidianità di Paterson è un percorso di ascesi, che nel film ottiene una celebrazione nell’incontro con il giapponese il quale, al contrario del protagonista, non ha timore di definirsi poeta, e dinanzi alla cascata tanto amata, regala al personaggio un taccuino pieno di pagine bianche grazie a cui sentirsi autorizzato ancor di più a vivere su carta i momenti di un’esperienza che rivive ogni giorno. Una rinascita che suona come quell’incoraggiamento morale e spirituale di cui il personaggio ha bisogno. E di cui con buona probabilità avrebbe bisogno anche Centerville, il paese in cui i morti escono dalle tombe perché la terrà è fuoriuscita dal suo asse ne I morti non muoiono (2019), un film ultimo-non ultimo dove Jarmusch, dilettandosi con l’horror romeriano, ritrova la sua ironia profonda e un mondo alla malora in cui i morti che ritornano sognano anche loro di ritrovare il sentimento di un luogo, psicofarmaci e connessioni wireless, verso quel desiderio di sorpresa che unisce fatalmente i vivi ai non morti.

L’AMERICA NEL CINEMA POLIZIESCO DI GUGLIELMO GIANNINI
di Mario Galeotti
Guglielmo Giannini, nato a Pozzuoli nel 1891 e scomparso a Roma nel 1960, di origini inglesi da parte di madre, è stato senza dubbio una figura eclettica nel panorama culturale e mediatico italiano, dagli anni Venti al secondo dopoguerra: giornalista, drammaturgo, sceneggiatore, regista teatrale, regista cinematografico (sui film di Giannini si veda: E. Mosconi, L’altra scena. Il cinema di Guglielmo Giannini, in Guglielmo Giannini. Uomo di spettacolo, Edizioni Di Pagina, Bari 2021) e alla fine della seconda guerra mondiale anche uomo politico, fondatore del movimento «L’uomo qualunque» che con le elezioni del 1946 lo portò a diventare membro dell’Assemblea Costituente.
Giannini è conosciuto soprattutto come autore di commedie teatrali, prevalentemente nel genere poliziesco importato dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Estimatore degli americani, una volta, di ritorno da un viaggio a New York, Giannini si era confidato con l’amico Lucio Ridenti dicendo che dopo aver visto come facevano teatro nelle metropoli americane era stanco di lavorare in patria (F. Perrelli, Tre carteggi con Lucio Ridenti: Anton Giulio Bragaglia, Guglielmo Giannini, Tatiana Pavlova, Edizioni Di Pagina, Bari 2018, p. 134). Lo stesso Giannini, però, con la commedia Grattacieli, storia poliziesca di ambientazione newyorchese poi diventata anche un film, si era preso gioco di quella giovane America di cui lui ammirava l’indiscutibile bravura nel saper fare spettacolo. Più esattamente, si burlò di una certa idea di America, con quelle sue espressioni di vita più appariscenti che all’occhio del vecchio europeo dovevano sembrare tanto inconsuete, descrivendo New York come una Babilonia moderna e viziosa.
Grattacieli è il primo di una lunga serie di drammi polizieschi scritti da Giannini tra la fine degli anni Venti e il 1960 (ricordiamo almeno La donna rossa, La sera del sabato, I rapaci, L’angelo nero, Supergiallo, Il tredicesimo furfante) e debuttò al Teatro Orfeo a Roma, con l’applauditissima compagnia Lombardi – Glori – Rovena, il 21 gennaio del 1930. Adattata per il grande schermo nel 1943 dallo stesso Giannini, la commedia Grattacieli si colloca a tutti gli effetti nei processi di elaborazione del mito americano in Italia negli anni tra le due guerre, tra curiose descrizioni di vita a stelle e strisce da una parte e un’esplicita assunzione di modelli culturali anglosassoni e americani dall’altra.
Strutturato nella classica tripartizione antefatto delittuoso – detection – catarsi, il testo di Giannini è uno dei cinque drammi polizieschi italiani che, rappresentati per radio e a teatro tra il 1927 e il 1930 (gli altri testi furono Venerdì 13 di Gigi Michelotti, La casa del parco di Giuseppe Romualdi, L’anello di Teodosio di Luigi Chiarelli e Il tappeto verde di Alessandro Varaldo), hanno anticipato la pubblicazione nel 1931 del primo romanzo giallo scritto in Italia e ambientato a Roma, Il sette bello di Alessandro Varaldo, edito da Mondadori nella collana de “I libri gialli” inaugurata due anni prima con la traduzione di un romanzo dello statunitense S. S. Van Dine. Grattacieli, dunque, contribuì a formare il terreno preparatorio per un genere poliziesco casereccio che faceva il verso agli inglesi e agli americani, destinato a un pubblico di massa e sviluppatosi nel corso degli anni Trenta in campo teatrale, letterario e, in misura più limitata, anche cinematografico. Se nel 1941, in un clima di politica autarchica sempre più acceso, il regime ordinò il sequestro di tutti i romanzi gialli stranieri presenti sul mercato italiano e la cessazione della collana “I libri gialli” Mondadori, perché il genere era ritenuto diseducativo e deteriore, le commedie poliziesche italiane continuarono ad essere rappresentate a teatro perché, pur rifacendosi (con caratteristiche proprie) a quegli stessi modelli banditi dal fascismo, riscuotevano un grosso successo di pubblico. “La folla si getta sempre su questi drammi polizieschi con una passione che sbalordisce”, aveva detto il responsabile della censura Leopoldo Zurlo (F. Perrelli, Tre carteggi con Lucio Ridenti, cit., p. 110). E’ dunque per questo motivo che ancora nel 1943, in pieno conflitto mondiale, fu possibile realizzare un film tratto proprio dal dramma poliziesco di Giannini “Grattacieli”, diretto dallo stesso autore (che in quell’anno curò anche la regia e la sceneggiatura di un altro film giallo, “Il nemico”), confermando la persistente ambivalenza della politica fascista in campo culturale e cinematografico perfino quando l’Italia era in guerra contro gli Stati Uniti. Ma se quello americano era in ogni modo il modello vincente, con “Grattacieli” Giannini si divertì anche a mettere in ridicolo e condannare moralmente quella stessa America che, con la letteratura e la macchina dei sogni hollywoodiana, aveva mostrato la via per la nascita del poliziesco italiano.
In parte perché, mancando ancora una vera tradizione di questo genere in Italia, gli ambienti nostrani rischiavano di apparire poco credibili, in parte per le restrizioni imposte dal fascismo che proibiva ad esempio che gli assassini fossero di nazionalità italiana, le storie dei polizieschi italiani si svolgevano quasi sempre all’estero. Nel caso di “Grattacieli” ci troviamo in una New York dell’alta società, che fornisce il pretesto per una raffigurazione dei mali moderni. L’azione si svolge nell’arco di poche ore in una notte d’autunno e l’ambientazione è quella altolocata tipica delle commedie sofisticate americane, che si ritrova anche nel cinema italiano cosiddetto dei ‘telefoni bianchi’ che tra gli anni Trenta e i primi anni Quaranta prendeva spunto soprattutto da commedie ungheresi. Protagonista è un gruppo di ricchi sfaccendati e ragazze sprovvedute che si riuniscono allegramente nell’attico di Jim Mayer Flynn. Il padrone di casa è uno scapolo quarantenne che vive nel lusso e che passa da un’avventura sentimentale all’altra, senza farsi scrupolo di spezzare il cuore alle giovani e ingenue fanciulle che di volta in volta si innamorano di lui. Ad un certo punto uno degli ospiti precipita dal terrazzo e muore. Quando interviene la polizia, si scoprirà che non è stato un semplice incidente ma che, prima di cadere, la vittima ha ricevuto un colpo in testa e che dunque si tratta di omicidio. In un finale che anticipa le innovative soluzioni di Agatha Christie in “Murder On the Orient Express” (pubblicato per la prima volta in Italia nel 1935, quindi cinque anni dopo la prima rappresentazione della commedia di Giannini), anche il colpevole, ovvero il padrone di casa, viene accidentalmente assassinato nel mezzo di una violenta discussione, ma nessuno pagherà perché, considerando che giustizia è stata fatta e che un torvo individuo ha avuto quel che meritava, l’ispettore convalida la versione dei presenti e, in un tacito compromesso, archivia il secondo caso come suicidio.
Nella commedia teatrale e nella sua trasposizione per il grande schermo, lo abbiamo già detto, il racconto poliziesco è anche il pretesto per una critica sottile, ironica a taluni aspetti della vita americana, che si regge su una visione stereotipata o quanto meno incompleta dell’American Way of Life. Sotto accusa, qui, è la metropoli “tentacolare” dei grattacieli, abitata da “eleganti scioperati”, “gaudenti dei grattacieliche, non avendo niente da fare, hanno tutto il tempo per le più difficili conquiste”. Questo spaccato di vita dei ricchi americani viene descritto nel testo originale della commedia con notazioni e frasi che in tal senso risultano molto efficaci, poi tradotte visivamente anche nell’impianto scenico del film. Visualizzando a parole l’arredamento dell’appartamento di Jim, all’ultimo piano di un grattacielo, si precisa che ci sono “dietro ogni quadro, sotto ogni statuetta, dei nascondigli per liquori e sigarette”. Per sottolineare l’atmosfera lasciva della garçonnière, Giannini continua dicendo che “tutto, dai quadri ai divani bassi e soffici, dai finissimi bicchieri alla bambola telefonica, dalle profonde poltrone alla disposizione delle luci, traspira la sensualità di chi ha presieduto all’arredamento”. Il cinico padrone di casa, lussurioso ed egocentrico, pronuncia frasi del tipo: “ora ci vuole un cocktail semplicemente infernale”, “la felicità è nella solitudine”, “al ventesimo piano non giungono i rumori della miserabile folla che s’affatica senza un perché”, frasi che si ritrovano con parole simile anche nel film. Sempre nel testo della commedia, su cui la caratterizzazione dei personaggi nel film è ricalcata fedelmente, con evidente piglio ironico Giannini fa dire alla sedicenne Evelyn Maloney, perdutamente innamorata di Jim, rivolgendosi con orgoglio all’amica Elga Manners: “Vedi? Questa è una delle mille cose nuove per me. Non sapevo fumare, non avevo mai provato… In quindici giorni, da quando m’offrì la prima sigaretta, sono diventata una fumatrice!”. Stupidamente la ragazza sembra considerare il vizio del fumo come uno dei possibili pregi nel frequentare un uomo di quella levatura.
Rispetto alla commedia, nella versione cinematografica la macchina da presa offre ovviamente una maggiore mobilità dei personaggi e una prospettiva più ampia, anche se in misura comunque limitata, perché permane un’impostazione prevalentemente teatrale e l’intera storia è ambientata anche nel film nello stesso appartamento nell’arco di poche ore. Il primo schema di soggetto cinematografico, indirizzato da Giannini al produttore napoletano Giuseppe Amato nel giugno del 1939, introduceva alcune soluzioni narrative originali che, ispirandosi anche all’andamento dei gangster movie hollywoodiani, avrebbero conferito un ritmo più incalzante al film, differenziandolo dalle altre pellicole poliziesche realizzate in Italia negli anni del fascismo nelle quali prevalevano il dialogo, la staticità, gli spazi chiusi. Ma a distanza di circa quattro anni, nel momento dell’effettiva realizzazione di “Grattacieli” per il grande schermo con la Cines-Juventus Film, il progetto fu ridimensionato con molta probabilità per problemi legati al budget. Infatti, il film uscì nella sale nel giugno del 1943, in un momento critico per l’Italia, quando lo stremo della guerra non solo inaspriva i toni di una propaganda volta sempre più a demolire anche sul piano culturale il nemico, ma aveva inevitabili ripercussioni sull’economia e, di conseguenza, anche sull’industria cinematografica italiana, imponendo verosimilmente tagli alla spesa. Eliminate le varianti previste nello schema del 1939, dunque, restavano solo la vista sulle sagome dei grattacieli e i pochissimi stacchi esterni a comporre un’America che il settimanale «Film» aveva definito con disprezzo “da Upim nettamente rionale” (Recensione di “Grattacieli”, in «Film», n. 45, 6 novembre 1943).
All’inizio del film l’abitazione di Jim (impersonato da Renato Cialente), con l’ampio terrazzo dove si consumerà il delitto, ci viene mostrata dall’esterno. Dalla torre di un altro grattacielo, quello di Lambert, una donna spia con il binocolo l’appartamento e dice che le sembra di essere ancora innamorata di Jim. L’interlocutore ha una reazione meravigliata: “mi pareva che foste innamorata di Gilbert, almeno avete detto così un quarto d’ora fa!”. Pronta la risposta della donna, sintomatica di un universo femminile alquanto volubile: “in un quarto d’ora una donna può cambiare opinione quindici volte”. È una scena che non troviamo nella commedia e che aggiunge una nota ironica di critica di costume in funzione antiamericana. Poi vediamo il servitore orientale di Jim che sui pattini scivola agilmente da una parte all’altra e annaffia i fiori sulla terrazza. Nella commedia, invece, nel suo primo ingresso in scena il servitore rincasava dopo essere uscito a comprare lo zucchero e quando, successivamente, lo avevamo visto annaffiare le piante sulla terrazza, non si faceva menzione dei pattini. Il dettaglio dei pattini introduce un altro dei motivi ricorrenti nelle rappresentazioni di vita americana: le usanze stravaganti e l’eccesso. Quando Elga (Luisa Garella) e Evelyn (Elena Maltzeff) parlano dell’eventualità di cenare a casa, anziché uscire, Jim ci tiene a puntualizzare che le uniche provviste a disposizione in quel momento sono cibi freddi in scatola, e quello del cibo è sempre stato un altro terreno fertile per una polemica antiamericana: “non hai visto come si sono subito attaccate perfino alla roba fredda e in scatola?”, dice in disparte Jim all’amico da poco sopraggiunto, Roberto Wingham (Guido Notari). Facoltoso ma onesto agricoltore, unico personaggio positivo in mezzo alla combriccola di quei ricchi oziosi, Roberto (nel testo originale della commedia Robert) è inevitabilmente colpito dalla bellezza di Evelyn (la cui età, nel film, viene comprensibilmente innalzata a diciotto anni) e Jim, con cinismo e noncuranza, lo esorta a provarci: “una prova non costa nulla, come dice la fabbrica per il lucido di scarpe”, dice Jim all’amico, prendendo a prestito uno slogan pubblicitario, quasi a voler mettere sullo stesso piano le relazioni umane e la logica consumistica del capitalismo americano. È interessante notare che nella commedia, che ricordiamo aveva debuttato nel 1930, non si usa la parola «fabbrica» ma «réclame» e invece, nel film, il francesismo è stato eliminato, evidentemente in conseguenza del fatto che nei primi anni Quaranta si era intensificata la stretta autarchica del regime anche sul piano linguistico. Sempre in sintonia con una battaglia in difesa della lingua italiana, non è un caso che il nome di battesimo di Wingham nel film sia stato italianizzato, come anche l’altro personaggio positivo, l’ispettore Pietro Stoll (Luigi Pavese), che nella commedia si chiamava Dick Mason. Roberto, a differenza degli altri, non è un edonista e dimostra un attaccamento ai valori importanti della vita. Anche lui è ricco, ma è un faticatore e proviene dalla campagna (sono anni in cui, non dimentichiamolo, l’economia italiana era ancora prevalentemente rurale), crede in Dio, nella famiglia, nell’integrità morale, nell’etica del lavoro. Anche se per una volta all’anno, per svagarsi, arriva a New York e, come dice lui stesso nel testo della commedia, “depongo i miei pantaloni di pelle e indosso la livrea della deboscia”, in fondo non condivide la vita di quei “signori dei grattacieli” che non fanno nulla di utile e costruttivo, “scioperati che colgono i frutti maturati dalle nostre fatiche”, “bei signori che vivono solo per divertirsi” e i cui nomi (fatta eccezione per Elga, nome usato anche nel testo originale), anziché essere italianizzati, sono inequivocabilmente americani proprio perché si tratta di personaggi negativi. Come il ripugnante Frank Millstone, impersonato da Paolo Stoppa, l’uomo che precipita dal balcone: ubriaco, borioso, prepotente, “aspro e volgare”, “scioperato, vitaiolo, cacciatore di donne”.
Quella di “Grattacieli” è, in generale, un’America che svela il lato peggiore di sé: una società arrogante e corruttibile, materialista, dominata dalla logica del denaro, in linea con le rappresentazioni che ritroviamo, anche in toni da commedia, in molti altri film del ventennio: “Cose dell’altro mondo” e “Dopo divorzieremo”,diretti da Nunzio Malasomma rispettivamente nel 1939 e nel 1940, “Centomila dollari” di Mario Camerini (1940), “Harlem” di Carmine Gallone (1943). Ma, riproponendo aspetti dello sfaccettato dibattito tra americanismo e antiamericanismo nell’Italia fascista, la descrizione ironica di uno spocchioso microcosmo di opulenza yankee e delle storture del sistema americano convive, lo ripetiamo, con l’emulante riproposizione di modelli culturali principalmente americani, verso i quali Giannini ha sempre nutrito ammirazione: non solo la tradizione poliziesca e la commedia sofisticata, ma anche il musical hollywoodiano, un genere che viene riproposto brevemente nella sequenza in cui alcuni degli ospiti di Jim improvvisano un numero di danza a tre (“virtuosismi tersicorei” è l’espressione usata nel testo teatrale), versione impoverita ma gradevole di una delle tante coreografie che lo spettatore italiano aveva potuto ammirare in abbondanza nei film musicali provenienti da oltreoceano.
Di ambientazione americana è un altro film tratto da un omonimo dramma poliziesco di Guglielmo Giannini, “L’anonima Roylott” (1936), diretto questa volta da Raffaello Matarazzo ma su sceneggiatura dello stesso Giannini e prodotto da una società di nome Fiorda & C. La storia ruota attorno a una azienda chimica di proprietà di due fratelli, Joe e Eric Roylott (interpretati rispettivamente da Italo Pirani e Carlo Lombardi), che, spalleggiati da uno scaltro avvocato (Camillo Pilotto), mettono sotto contratto giovani e intraprendenti ricercatori chimici per servirsi delle loro competenze e al momento giusto impossessarsi dei loro brevetti, negando qualsiasi diritto economico di sfruttamento. Incarnazioni di un torbido mondo capitalista e di un moderno sistema di schiavitù legalizzata (“delinquenza legale” è l’espressione utilizzata nel dialogo) che nega ogni pretesa di egualitarismo, “pirati della finanza”, i fratelli Roylott vengono assassinati a breve distanza l’uno dall’altro. Non è un evento del tutto inaspettato, dal momento che a causa delle disoneste attitudini si erano fatti molti nemici. Le autorità seguono diverse piste. Il capo della polizia, Stark, è interpretato da Mario Ferrari, uno dei volti più amati del cinema del ventennio, mentre l’ispettore MacKay è impersonato da Romano Calò, l’attore e regista che nel 1932 aveva fondato l’omonima compagnia teatrale di spettacoli gialli. Gli investigatori giungono alla conclusione che il colpevole del duplice omicidio è il fido avvocato, perché l’arma del delitto è stata ritrovata nel suo cappotto. Condannato alla sedia elettrica, si scopre che in realtà ad assassinare i due imprenditori è stato uno dei ricercatori raggirati. Per far uscire allo scoperto il reo, l’ispettore decide di inscenare una finta esecuzione capitale.
Gli ambienti e i personaggi del film “L’anonima Roylott”, così come quelli della commedia, ritraggono con toni molto cupi un’America affarista e spietata, tanto che all’inizio si pensò di intitolare la pellicola “Gli avvoltoi della metropoli”. La critica all’epoca si divise tra stroncature e giudizi favorevoli. Raffaele Patuelli ad esempio, sulla rivista mensile «Lo schermo», disapprovò in particolare l’ambientazione americana, giudicandola in controtendenza con le linee del nuovo cinema italiano, ignorando però il fatto che, come abbiamo già accennato, trasferire le storie all’estero era anche una necessità dettata dai limiti che il regime aveva imposto alla struttura del genere poliziesco. Patuelli inveì contro “i gangster nazionali, interamente fabbricati in Italia con materiale italiano”, contro “i tabarin, i frac, le bionde platino ed i giovinotti galanti” dichiarando che “il cinema italiano di oggi non ha nulla a che fare col cinema degli americani” (R. Patuelli, recensione di “L’anonima Roylott”, in «Lo schermo», n. 10, ottobre 1936). In realtà, come ha ben evidenziato Elena Mosconi in un saggio dedicato a “La anonima Roylott”, il punto di forza del film stava proprio in alcune soluzioni tecniche mutuate dal cinema hollywoodiano, cinema che Giannini conosceva bene grazie alla sua esperienza di curatore delle edizioni italiane di film americani negli anni del muto (E. Mosconi, “La anonima Roylott” e la fabbrica del giallo, in «Bianco e nero», n. 587, gennaio – aprile 2017).
Nel frequente gioco di sovrapposizioni di americanismo e antiamericanismo, ricordiamo anche lo scoppiettante film giallo diretto da Matarazzo e prodotto dalla S.A. Lupa Film, “Joe il rosso” (1936), tratto dall’omonima commedia di Dino Falconi e basato su una sceneggiatura di Guglielmo Giannini. Questo film forniva un’immagine dell’America molto più conciliatoria rispetto agli avidi capitalisti senza scrupoli di “L’anonima Roylott”: una “parodia di film più o meno poliziesco punteggiato da alcune colorite macchiette”, scrisse Mario Gromo (M. Gromo, recensione di “Joe il rosso”, in «La Stampa», 8 dicembre 1936). Girato in interni negli stabilimenti Cines e in esterni a Quercianella, sulla costa livornese, il film ha come protagonista un simpatico contrabbandiere americano, Joe Mark detto “Joe il Rosso”, impersonato da Armando Falconi, padre di Dino, e ispirato a una figura di gangster buono realmente esistito conosciuto di persona dall’autore del testo teatrale.
Eccone brevemente la trama. Stefano (Luigi Pavese), rampollo dell’aristocratica famiglia francese dei Sandelle-Lafitte, ha conosciuto durante un viaggio in America la giovane orfana Marta (Luisa Garella) e l’ha sposata, venendo poi a sapere che l’unico parente della ragazza è lo zio Joe, che ha fama di essere coinvolto in affari loschi. Quando i due novelli sposi tornano nella sontuosa villa di famiglia in Costa Azzurra, a causa delle sue modeste origini Marta viene accolta con freddezza dalla madre di Stefano, la duchessa Sofia di Sandelle-Lafitte (Ada Dondini). Poco tempo dopo, nella villa viene rubato un prezioso dipinto del pittore spagnolo Murillo, che la famiglia era in procinto di vendere alle Belle Arti. Marta chiede aiuto allo zio Joe, il quale raccoglie l’invito con molto piacere perché ciò gli consente di stare lontano per un po’ di tempo dal suo paese e sottrarsi così a una violenta guerra tra bande rivali. All’arrivo del bizzarro ospite, Stefano, imbarazzato, lo presenta alla famiglia come un poliziotto americano (“in America i poliziotti sono molto rispettati”). “Come parente potrebbe essere nostro ospite, ma come americano…”, dice perplessa la madre di Stefano, ma un cugino la rassicura dicendole: “io credo che al giorno d’oggi gli americani possono entrare nelle migliori famiglie!”. Coi suoi metodi d’indagine sbrigativi e alquanto rozzi, ma efficaci, Joe il Rosso viene a conoscenza di tutta una serie di scandali e magagne che riguardano i membri della famiglia ed anche la servitù. Alla fine riesce a recuperare il quadro rubato e a identificare l’autore del furto, ma scopre che si tratta di un falso. In un doppio colpo di scena, Joe ricostruisce il caso: il vero quadro era già stato venduto quarant’anni prima dall’anziano duca Gontrano di Sandelle-Lafitte (Aristide Baghetti), il nonno di Stefano, per ripagare i debiti contratti in gioventù a causa della sua vita dissoluta. Il buon Joe promette di recuperare la preziosa opera d’arte.
L’uso di parole straniere in “Joe il rosso”, che nel testo della commedia era più frequente, nella versione cinematografica viene ridimensionato per ovvie questioni di censura. Inglese è la canzoncina che Joe canta a bordo del velivolo che, dopo essere scampato alle ritorsioni della banda avversaria in un rocambolesco inseguimento automobilistico, da San Francisco lo sta portando sano e salvo a Québec per imbarcarsi su una nave con destinazione l’Europa: “Red Joe is flying… Red Joe is going”. Inframmezza la sua parlata (italiana perché il film è italiano, ma ricordiamoci che la storia è ambientata in Francia) con poche espressioni inglesi del tipo “now listen!”, “you see”, “how do you do”, “stop”, “yes”, “my baby”, “good”, “you are fool”, “excuse me”, espressioni che non sovrastano mai il dialogo e servono solo a mettere in risalto l’origine del personaggio, soprattutto nella prima parte del film. L’americano Joe il Rosso, che a dispetto delle sue attività criminose si dimostra schietto e generoso, assume una connotazione decisamente positiva (ma ricordiamoci che questo film è del 1936, prima che si delineasse lo scacchiere internazionale in vista della guerra) e si contrappone ai falsi valori di un’aristocrazia europea (francese per la precisione, non certo italiana) ipocrita che, dietro alla facciata di perbenismo (“in casa dei Sandelle-Lafitte non vi sono che persone insospettabili”, aveva detto la duchessa all’ispettore delle belle arti), cela inganni e menzogne. Le maniere spicce e borghesi di Joe il Rosso risultano molto più autentiche degli inutili rituali di una nobiltà vecchia e decrepita che vive di rapporti sociali fasulli. Attraverso il protagonista, l’America è portatrice di nuove energie e di giustizia nella stagnante realtà di una élite sociale moralista, altezzosa e per di più disonesta. Nell’incontro – scontro tra Vecchia Europa (dove però, lo sottolineiamo ancora, non ci sono italiani) e Nuovo Mondo, in questo caso è chiaro come sia l’America a uscirne vincente. Del resto, pur tra tante contraddizioni, fin dalla salita al potere di Mussolini non sono state poche le manifestazioni di stima del regime nei confronti dell’intraprendente e giovanile società americana.
In conclusione, possiamo dire che film come “Grattacieli”, “L’anonima Roylott” e “Joe il rosso” hanno avuto un ruolo non secondario in quel gioco altalenante tra demolizione del mito americano e irresistibile attrazione per alcune delle moderne forme dello stesso mito nell’Italia del ventennio fascista. Questi titoli si inseriscono non solo nel panorama del film poliziesco italiano di quegli anni, che si rifaceva inevitabilmente al modello hollywoodiano pur non riuscendo a competere con il dinamismo dei film americani, ma almeno in parte anche in quella galleria di bizzarre rappresentazioni di vita americana che, soprattutto in tono di commedia, hanno occupato uno spazio non trascurabile all’interno della produzione cinematografica degli anni Trenta e primi anni Quaranta.Anche l’opera del poliedrico Guglielmo Giannini, in veste di commediografo, regista e sceneggiatore, rappresenta dunque un piccolo ma significativo tassello nella storia culturale delle relazioni euro-atlantiche e, nello specifico, nella storia alquanto contraddittoria dell’immagine dell’America divulgata durante il fascismo: immagine sempre in bilico tra fascinazione e animosità.
PANDEMIA E OLTRE: STATICITÀ E MOVIMENTO NELLE USCITE CINEMATOGRAFICHE POST LOCKDOWN
di Paola Brunetta
Il 26 aprile hanno riaperto le sale cinematografiche in Italia dopo un periodo in cui tutto è stato fermo, piattaforme digitali a parte; naturale quindi, dovendo isolare un tema, concentrarsi sul rapporto tra staticità e movimento, riflessione ed energia pulsante, a partire dall’immobilità che noi tutti, e anche il cinema nei suoi vari aspetti, abbiamo subito in questa seconda fase di chiusura delle sale.
E i film che sono usciti in questo periodo ce ne danno motivo: in alcuni prevale decisamente il movimento per non dire il caos, il desiderio, la pulsione di vita, altri hanno un andamento più meditativo o comunque lento, riflessivo, “interiore”. Ce n’è uno, in particolare, che sintetizza questa dicotomia: “Kufid” di Elia Moutamid, che partendo dall’esplorazione di quelli che avrebbero dovuto essere i luoghi del suo nuovo film, la medina gentrificata di Fes, diventa improvvisamente un film sul (primo) lockdown nel bresciano, comprimendo per cause di forza maggiore quell’istinto al movimento e al viaggio che avrebbe caratterizzato la pellicola che il regista, italiano di origine marocchina, non ha potuto realizzare.
Ma altre opere si muovono su questo crinale: dal movimento lento di “Nomadland di Chloé Zhao all’energia pulsante di Estate ’85 di François Ozon, dal movimento a vuoto di “The Father – Nulla è come sembra” di Florian Zeller alla direzione precisa che prende invece quello di Cassie, la protagonista di Una donna promettente di Emerald Fennell.
Il presente saggio andrà quindi a considerare, in termini impressionistici piuttosto che “razionali”, alcuni film che, tra quelli usciti dal 26 aprile ad oggi (giugno 2021), meglio rappresentano l’energia e il movimento del corpo, quindi anche dell’anima, e altri che rappresentano invece l’immobilità collegata, o collegabile, al tempo di pandemia che stiamo vivendo. Film che veicolano gioia, energia, passione… fisicità, sensualità… film da gustare, appunto, con i sensi aperti piuttosto che intellettualmente, anche per le atmosfere che creano, per i “mondi” in cui fanno entrare; e film che, al contrario, rappresentano la staticità, il silenzio, la chiusura anche solo per una scena, un aspetto, un elemento…
Cominciamo, quindi. Non da “Kufid”, che ci ha fornito comunque lo spunto iniziale, ma da “Voyagers” di Neil Burger, film distopico un po’ troppo didascalico che però, rifacendosi a Il mondo nuovo di Huxley e all’ultimo film di Clooney, il disconosciuto “The Midnight Sky”, mostra in modo interessante la scoperta dell’istinto (sesso e violenza, amore e morte) da parte di un gruppo di adolescenti rinchiusi in un’astronave che dovrebbe, nel giro di ottantasei anni, arrivare ad un nuovo pianeta abitabile, che andrebbe a sostituire una Terra ormai invivibile.
I ragazzi, selezionati per generare in vitro coloro che andranno a colonizzare il nuovo pianeta, inizialmente bevono un liquido blu che li rende tranquilli, razionali e inoffensivi, e il ritmo della vita nell’astronave è quindi lento, statico; ma quando due di loro cominceranno a sospettare qualcosa e si rifiuteranno di assumere la sostanza contravvenendo alle regole del posto, gli istinti vitali a lungo sedati emergeranno in maniera prorompente, cambiando il corso della narrazione e, ai fini del nostro discorso, accelerando il ritmo del film (le corse veloci dei ragazzi nei corridoi stretti di quell’ambiente claustrofobico…) sulla scia delle pulsioni e del desiderio, più o meno “consentiti”, e poi della violenza e della morte.
Pulsioni e istinto che troviamo in tutto il loro fulgore nel già citato “Estate ’85” di François Ozon, film che ricorda Fassbinder e il primo Almodóvar per la pienezza e l’urgenza, l’assolutezza del desiderio anche al di là dell’amore, e per il tema fatidico della mancata reciprocità del sentimento (Each Man Kills the Thing He Loves, cantava Jeanne Moreau in “Querelle de Brest”).
Per il nostro discorso: slancio, passione, istinto, movimento distruttivo che porta alla morte, giovinezza come libertà di assaporare tutto della vita, dalla vita. Il piacere e la bellezza, ma anche la sfrontatezza e l’egoismo. E la motocicletta fatale, questo simbolo di vita e libertà che ci portiamo dietro da Il selvaggio e da “Easy Rider” con il mito dei belli e dannati, padroni di sé ma purtroppo non del loro destino.
In questo senso “Nomadland” di Chloé Zhao, che pure è un road movie, rappresenta un movimento diverso: non solo perché vi si parla di spostamenti nello spazio (e di terra, territorio, Nevada e altro), quando il vero avvicinamento è quello nei confronti di se stessi, ma anche perché, come ha scritto Paola Casella, “la struttura di “Nomadland”, che molti hanno superficialmente definito ripetitiva, è quella della ballata o del poema, torna su se stessa per ripetere, come un sonetto o un ritornello, lo stesso concetto: che non c’è fuga da se stessi ma un continuo ripercorrere le proprie tracce, in cerca di un allontanamento progressivo dalle miserie della vita e dall’attaccamento a quelle cose concrete – una casa, una famiglia – che in certe situazioni, e ad una certa età, non interessano più, diventano un bagaglio ingombrante e una zavorra” (1).
Movimento lento comunque, meditativo; ci si muove ma è come se ci si prendesse una pausa da tutto, per arrivare in un luogo, fisico o metaforico che sia, in cui si può stare bene davvero, al di là di ogni obbligo o convenzione. La vita come scelta.
Lentezza che richiama la camminata della seconda parte di “Sesso sfortunato o follie” porno di Radu Jude, in cui la protagonista si muove in uno spazio urbano fortemente connotato in senso capitalistico-consumistico-convenzionale per permettere al regista di ironizzare sottilmente su questo, ironia amara che è anche l’asse portante del film (l’opposizione ad una moralità conformista e bigotta che si scaglia contro chi, il sesso, lo fa in modo gioioso e scanzonato, in un linciaggio da caccia alle streghe); che fa il paio, per restare in esterni e in città, con la follia rivoluzionaria di “Nuevo orden” di Michel Franco, movimento esagitato, verde di vernice, vivo ma anche irrazionale e ingiusto pur partendo da motivazioni legittime, poi imbrigliato da un potere che lo sfrutta a proprio vantaggio. Il movimento liberatorio e purificatore che diventa reazione, e costrizione. Potere bruto.
Per assonanza geografica ma non di toni e atmosfere, anche se con la medesima drammaticità politica e sociale, “La cordigliera dei sogni” di Patricio Guzmán presenta invece un movimento lento e riflessivo, direi dolente, alla scoperta delle Ande come montagne che proteggono Santiago, quindi il Cile, con la sua bellezza ma anche con l’orrore della sua storia, quello che ha costretto il regista a lasciare il paese nel 1973. In questo film le Ande, scrive Silvana Silvestri, “non sono da ammirare, o da scalare, sono un veicolo di viaggio nel tempo, un gigantesco sipario che avvolge la solitudine, un gigante che tutto osserva e ricorda. Ben presto diventano un grande dipinto, poi una immagine pubblicitaria, il punto di osservazione per comprendere il Cile di oggi” (2).
E la macchina da presa le ripercorre e sovrasta lentamente e pacatamente, mostrandole in tutta la loro maestosità anche attraverso la voce fuori campo che collega questa parte a quella storico-politica e alle voci degli artisti, intervistati dal regista, che l’hanno vissuta in prima persona.
Ravviviamo l’atmosfera di queste pagine con “Extraliscio – Punk da balera” di Elisabetta Sgarbi: musica, ballo, gioia, caos, divertimento… nella rivisitazione del liscio che questa band opera. O con la scena finale di “Un altro giro” di Thomas Vinterberg, la danza leggera e vorticosa che il protagonista riesce nuovamente a effettuare dopo anni di forzature e inibizioni, grazie all’alcol (sarò sincera, non ho amato per niente questo film dal contenuto peraltro molto ambiguo, ma non si può non farsi sedurre dalla libertà e dalla scioltezza della danza finale e del salto nel vuoto di Mads Mikkelsen che in effetti, in gioventù, era un ballerino… movimento ed energia allo stato puro).
E con questo possiamo tornare a cose più serie. Sulla infinitezza di Roy Andersson con il movimento che torna su se stesso, la realtà sempre uguale, l’assurdo di un’esistenza che non può cambiare… “Gloria mundi” di Robert Guédiguian con quella scena iniziale che è la vita, il movimento della vita quando prende forma, e poi con la danza delle generazioni in una realtà sociale che ha ormai preso una certa piega, e che pare non poter mutare… “Due” di Filippo Meneghetti, vicinanza e lontananza e il voler disperatamente tornare vicine dopo il distacco, un movimento a due… E un altro movimento a due che in realtà è un monologo, “The Human Voice” di Pedro Almodóvar (da Cocteau), tutto in una stanza, o quasi, quindi fermo, per dire di un allontanamento, o meglio di un abbandono, da elaborare. O il movimento singolare e concitato di “The Shift” di Alessandro Tonda, quello di un’ambulanza che gira a vuoto per la città avendo al suo interno un terrorista adolescente ferito con l’esplosivo ancora addosso, che minaccia di farsi saltare in aria se il mezzo si fermerà a cercare aiuto…
O possiamo parlare di movimenti psicologici, interiori. In “Stitches – Un legame privato” di Miroslav Terzic è quello sottile, viscerale, di vicinanza tra una madre e il figlio adolescente che non sa di essere tale, ma che lei sente e che in effetti, quando la cosa viene svelata, è attratto inesorabilmente da lei; in “I profumi di Madame Walberg” di Grégory Magne riguarda due persone molto diverse che si avvicinano perché si comprendono in modo profondo e si aprono l’un l’altra, pervenendo alla propria verità interiore nell’ambito di un percorso esistenziale, come avviene in molti film francesi.
Ma, anche in questo senso, il film che più colpisce tra quelli usciti dopo il secondo lockdown è il già citato “The Father – Nulla è come sembra” di Florian Zeller in cui tutto sembra muoversi ma al contempo tornare indietro e il disorientamento che proviamo, il senso di essere “in alto mare” è lo stesso del protagonista poiché ci muoviamo insieme a lui tra realtà presente e ricordi, senza distinguere gli uni dagli altri… in un movimento nel tempo ma anche nello spazio… che è poi il ciclo, il movimento della vita che significa anche morte, la vecchiaia e la morte. Scrive Giampiero Frasca: “Inizio, centro e fine in “The Father” sono soltanto successioni convenzionali che introducono svolte e nessi paradossali: nell’osservare il deterioramento cognitivo di un anziano genitore attraverso i suoi rapporti con la figlia, le consuete scansioni del racconto sono una sorta di blocco unico e indistinguibile che punta all’accumulo di eventi sgradevoli e imbarazzanti per illustrare una situazione diventata progressivamente sempre più ingestibile. Al contrario degli altri lavori dedicati allo stesso argomento, “The Father” rinuncia in partenza a ogni pretesa di riscontro obiettivo, per immergersi in una narrazione condotta in modo apparentemente sconnesso e disorganico per simulare e rendere tangibile una soggettività malata e totalmente inattendibile. […] Nel suo sforzo tutt’altro che facile di mimesi, Zeller frantuma ogni parametro temporale e i riferimenti ambientali, proponendo una logica immaginaria fatta di salti, buchi logici, loop disorientanti e penosa ciclicità. […] E così l’architettura della casa diventa una planimetria escheriana nella quale il corridoio sfocia naturalmente nella stanza di una casa di cura; stanza della casa di cura che forse è lì da sempre, solo percepita con un differente arredamento” (3). Labirinto, frammentazione, disorientamento; mancanza di direzione, anche se ci si continua a muovere.
Una direzione precisa ce l’ha invece come si diceva, per concludere, il movimento di Cassie, la protagonista di ”Una donna promettente” di Emerald Fennell. Lei ha chiaro in testa cosa vuole fare: vendicare l’amica Nina per lo stupro che ha subito, e che l’ha portata al suicidio. Non c’è nient’altro per lei, nient’altro che conti, e quell’obiettivo sarà alfine perseguito; anche se, come scrive Ilaria Feole, “se Cassie vince, alla fine del film, è solo perché ha già perso, e ha perso (il controllo, la gioia di vivere) da anni: dietro le sue unghie arcobaleno, dietro il rosa confetto del suo guardaroba, dietro l’ossessivo trincerarsi di una trentenne nell’età adolescenziale c’è un trauma che ha calcificato la sua mente intorno a una ferita insostenibile […].
Questa donna promettente vince solo dopo aver perso, perché non c’è vittoria in un sistema di patriarcato interiorizzato come quello in cui Cassie si muove, dove i suoi ostacoli sono anche e soprattutto altre donne […]. Ma soprattutto, quella di Cassie è una vittoria letteralmente postuma: la sua missione per inchiodare i colpevoli di una violenza sessuale ha come esito il suo annientamento, ma non è un imprevisto, perché Cassie è ben conscia che, finché non ci scappa il morto, nessuno prenderà sul serio i comportamenti di chi «è solo un ragazzo» che magari «saltellava con il pisello di fuori». Non farà notizia, finché non sarà morta” (4).
Film molto diversi quindi l’uno dall’altro, alcuni sfolgoranti di energia altri dall’andamento pacato e lento, ma che ci danno un’idea di come si sta muovendo il cinema oggi, al di là della pandemia. Ed è “un sentimiento nuevo/ che mi tiene alta la vita”, come cantava Battiato.
NOTE
- Paola Casella, “Nomadland”, il coraggioso film-fenomeno che celebra l’irrequietezza, https://www.mymovies.it/film/2020/nomadland/news/il-coraggioso-filmfenomeno-che-celebra-lirrequietezza/?fbclid=IwAR18xcP_Jy8GgrxX9j3jSq4QR9IfuvN6pYi0Gy-lm4UgQPMTDLfj1Ag-d2g
2) Silvana Silvestri, Patricio Guzmán, “La Cordillera” è testimone, https://ilmanifesto.it/patricio-guzman-la-cordillera-e-testimone/
3) Giampiero Frasca, recensione di “The Father – Nulla è come sembra”, https://www.cineforum.it/recensione/The-Father-Nulla-e-come-sembra
4) Ilaria Feole, “Le regole del gioco”, https://filmtv.press/pubblico/opinionisti/le-regole-del-gioco?fbclid=IwAR2G9l_8kOQjtMKiY5GuNVROUftyiG4iI3k6107fTGenNPsVkrJuas3osbI
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
INIZIATIVE IMPORTANTI AL 71. ITALIA FILM FEDIC
di Paolo Micalizzi
Anche quest’anno l’Italia Film Fedic di Montecatini Terme ha avuto successo nell’interesse dei partecipanti e della Stampa nazionale. I partecipanti sono stati più dell’anno scorso ed a Montecatini sono ritornati dei Soci Fedic che avevano frequentato il Festival quando era organizzato dalla Fedic, che ivi si era costituita nel 1949, e che oggi vi fa ritorno con la Presidenza di Lorenzo Caravello e la Direzione artistica di Gianluca Castellini e Paolo Micalizzi ed il coinvolgimento organizzativo degli altri membri del Consiglio Direttivo e la partecipazione di tutti i Cineclub Fedic. Oltre 50 poi gli autori che hanno preso parte al Concorso Fedic Short che ha visto vincitore Marco Rosati con il suo “Fight Cineclub”, un’opera sull’attività del Cineforum che ritorna al dibattito conclusivo accendendo un’accesa discussione dopo la proiezione. La Giuria gli ha attribuito il primo premio con la seguente motivazione: “Nell’epoca post moderna il dibattito diventa lo specchio di un contesto severo in cui ogni pensiero e ogni idea vengono espressi tenendo conto degli altri e del passato”.
Ad attribuirglielo una Giuria prestigiosa composta dai critici cinematografici Fulvia Caprara (“La Stampa”, Vice Presidente del SNGCI) e Franco Dassisti (“La Rosa purpurea” di Radio24) e dall’attrice Milena Vukotic, che l’anno scorso è stata insignita del Premio Fedic alla carriera. Che quest’anno è stato attribuito al più celebre “cartoonist” italiano: Bruno Bozzetto. In omaggio al regista di importanti lungometraggi d’animazione come “West and Soda” (1965), “Vip, mio fratello superuomo” (1968) e “Allegro non troppo” (1976) è stato proiettato il cortometraggio “Tapum! La storia delle armi” (1958) l’opera che significativamente l’ha fatto esordire nel cinema e un altro della serie “Il signor Rossi” dedicata a questo personaggio che caricaturalmente impersonava l’italiano medio dell’epoca e che lui ha dichiarato, in un suo intervento al Festival, per vendicarsi del direttore di un Festival che aveva rifiutato un suo cortometraggio.
Da segnalare, giustamente, che la Giuria di Fedic Short ha attribuito anche una Menzione speciale a “Ridens” di Alessandro Valbonesi con la seguente motivazione: “In un’epoca in cui la pandemia ci ha privato dei piaceri più istintivi e naturali, ridere diventa l’ultimo baluardo della libertà. E se fosse proibito? Nel nostro futuro distopico potrebbe succedere anche questo. Una risata ci salverà”.
Importante al Festival è stato il Focus sulla Cineteca Fedic che dal gennaio 2017 è depositata presso l’Archivio nazionale cinema d’impresa di Ivrea sulla quale, intervistata da Paolo Micalizzi, si è soffermata l’Archivista Mariangela Michieletto che ha anche riferito che sul canale Youtube “Mi ricordo – L’Archivio di tutti” dal 25 gennaio 2021 sono stati messi online 70 cortometraggi di autori Fedic e che la playlist verrà progressivamente arricchita nei prossimi mesi su segnalazione del Comitato Scientifico che presieduto da chi scrive ed è composto, inoltre, da Giorgio Ricci e Giorgio Sabbatini dal Presidente Fedic Lorenzo Caravello e da Gianluca Castellini, responsabile della Rete REFF dei Festival Fedic e da Laura Biggi che è alla guida di Fedic Scuola. Nell’occasione sono state proiettate “Domenica sera” (1962) di Franco Piavoli e “L’amata alla finestra” (1958) di Giuseppe Ferrara, due cortometraggi che hanno segnato l’esordio nel cinema di questi due Autori e che fanno parte della Cineteca Fedic insieme ad altri di Autori storici della Fedic e di Autori contemporanei.
Il Festival era arricchito da tante altre iniziative che hanno dato vitalità alla manifestazione. Dalla presentazione dei libri “Pensavo fosse un comico, invece era Troisi” di Ciro Borrelli e “Le molte vite di Lino Banfi” di Alfredo Baldi all’incontro con tutti gli Autori partecipanti al Fedic Short coordinato dai critici Alfredo Baldi e Carlo Griseri che con essi hanno imbastito dato vita ad un interessante dibattito sulle loro opere.
Vi è stato anche un doveroso Omaggio alla filmmaker Fedic, scomparsa quest’anno, Rossana Molinatti della quale è stato proiettato il cortometraggio “Calicanto” (2004), un delicato ritratto della sorella anziana. Ed in suo Omaggio, oltre al ricordo di Maria Teresa Caburosso e Giorgio Sabbatini, un Video di Paolo Mameli dedicato alle maschere per il Carnevale di Venezia da lei create ispirandosi a famosi pittori.
In programma anche alcune opere di Fedic Scuola e il primo lungometraggio di Luca Zambianchi dal titolo “Quel che conta è il pensiero” che segna l’esordio nel cinema professionale di un autore Fedic che già si era distinto nel cortometraggio. Ed un Omaggio a Dante nel centenario della sua morte con “Inferno notte” di Simone Savogin.
FESTIVAL ED EVENTI
PESARO 2021
di Paolo Vecchi
Prendendo ancora una volta direzioni inconsuete, come scrive il suo direttore Pedro Armocida in quella sorta di dichiarazione di intenti che apre il catalogo di ogni festival, la 57a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro ha rimescolato le carte del concorso aprendo ai corti, presenti in misura doppia rispetto ai loro “fratelli maggiori”. Coerentemente con questa scelta, la giuria, composta da Walter Fasano, Edoardo Gabbriellini ed Eleonora Marangoni, ha attibuito il Premio Lino Micciché a “Un bananero no es casualidad”, di produzione spagnola ma sceneggiato, fotografato, montato e diretto dall’argentina Luiza Gonçalves. Nel corso di dieci minuti, in teoria una sorta di saggio sulle piante che ornano San Sebastian, la regista, un’artista multimediale che si è prodotta anche nel campo di fotografia, performance, poesia, pittura e scultura, sottopone con ironia un filo conduttore quasi pretestuoso a una serie di manipolazioni non prive di grazia.
Quasi una beffa appare tuttavia che gli sia stato preferito “What Do We See When We Look at the Sky?”, solo segnalato, opera seconda di Alexandre Koberidze, un georgiano che vive e lavora in Germania. Qui si passa ad un altro estremo, perché i minuti sono 150, ma le spalle ben più larghe rispetto all’opera che ha vinto non dipendono assolutamente dalla durata. Intorno a un intreccio esile – un ragazzo e una ragazza vittime del colpo di fulmine al primo incontro si danno appuntamento per il giorno successivo ma non si riconoscono perché le loro fattezze sono cambiate – l’autore costruisce un poema sinfonico sulla città di Kutaisi, le sue piazze, i suoi giardini, i suoi abitanti ma anche i suoi cani, disegnando con levità di tocco personaggi straordinari nella loro eccentrica normalità. Filo conduttore i mondiali di calcio, il cui epos stralunato culmina con l’incantevole ralenti del videoclip di “Notti magiche” eseguito ovviamente da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Questo sorprendente risultato rimanda carsicamente alla grande stagione del cinema georgiano di mezzo secolo fa, degli Iosseliani, Abuladze, Shengelaja, Gogoberidze, della quale recupera la dimensione poetico-fantastica coniugandola ad un personalissimo uso dei tempi e degli spazi.
La Giuria Giovani ha premiato “One Thousandand and One Attempts to Be an Ocean” di Yuyan Wang, cinese ma operante a Parigi, che in undici minuti concentra una serie di micro eventi rubati alla rete accompagnati dall’onirica monotonia di una colonna sonora minimalista, riproponendo senza grande originalità gli ennesimi stilemi di un’avanguardia sostanzialmente autoreferenziale. Due le segnalazioni: “This Day Won’t Last” del tunisino Mouaad el Salem ,che merita attenzione se non altro per il coraggio civile di denunciare la discriminazione degli omosessuali in quello che rimane tuttavia il più laico dei paesi maghrebini; “Edna”, di Eryk Rocha, figlio di tanto Glauber, lungometraggio documentario girato in un suggestivo biancoenero, con al centro una figura di donna forte, protagonista delle lotte contro i feudatari lungo l’autostrada che attraversa la foresta amazzonica.
Tra le altre sezioni, da citare come sempre “Corti in Mostra”, che ha fatto il punto sull’animazione italiana di oggi e, sempre curati da Pierpaolo Loffreda, i focus su due autori di notevole interesse, Michele Bernardi e Magda Guidi.
Continuando nel suo percorso di riflessione e documentazione sul cinema italiano che dura ormai da più di mezzo secolo, la Mostra ha poi dedicato l’evento speciale a Liliana Cavani. Sullo schermo dello Sperimentale sono passati i due corti di diploma al CSC e nove lungometraggi, uno dei quali, il nietzschiano “Al di là del bene e del male” (1977), nella copia restaurata dalla Cineteca Nazionale e reintegrata dei numerosi tagli censori.

A conclusione della rassegna si è svolta una tavola rotonda con la partecipazione della regista di Carpi, alla quale è intervenuto tra gli altri Italo Moscati, a lungo suo collaboratore alla sceneggiatura. Per l’occasione è stato pubblicato il tradizionale volume edito da Marsilio e curato dal direttore del festival affiancato da Cristiana Paternò, con saggi di specialisti come Francesca Brignoli, Orio Caldiron, Paola Casella e Alberto Anile, analisi dei singoli film e testimonianze di Marco Bellocchio, Chiara Caselli, Angelo Guglielmi e dello stesso Moscati. Un testo prezioso, che si propone come riferimento obbligato per chi voglia approfondire la collocazione di questa discussa protagonista nel contesto di mezzo secolo della nostra cinematografia.
IL SATURNIA FILM FESTIVAL HA PREMIATO ANCHE MILENA VUKOTIC E LE DONNE REGISTE
di Paolo Micalizzi

Articolato in più appuntamenti il Saturnia Film Festival 2021. E’ iniziato il 17 luglio a Sorano e si è sviluppato con una tre giorni(30 luglio – 1 agosto) a Saturnia, Montemerano e il suggestivo spazio intorno alla Piscina dell’Hotel Terme di Saturnia, per proseguire con altre iniziative fino al 21 agosto. Siamo stati presenti all’iniziativa di sabato 17 luglio, quando alla Fortezza Orsini di Sorano è stato attribuito all’attrice Milena Vukotic il Premio alla Carriera con la seguente motivazione: “Per avere emozionato con la sua arte diverse generazioni diventando una vera e propria icona. Una grande donna, attrice e professionista dello spettacolo”. Questa la risposta di Milena Vukotic :” Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4° edizione del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra particolarmente vivace e innovativo. Intanto per l’argomento del Festival, il “cinema breve”, un genere di film la cui importanza nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento che permette l’affacciarsi al mondo del cinema di un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbero stati esclusi. Ma l’importanza del Festival viene anche dalla felice formula di “Festival itinerante” che consente la partecipazione diretta di pubblici diversi, tutti ugualmente appassionati, a seconda delle località nelle quali le proiezioni hanno luogo. Quindi avere il privilegio di aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località storica di grande fascino come Sorano e di ricevere nell’occasione il premio alla carriera, è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio tutti gli organizzatori e in particolare Antonella Santarelli”.
L’iniziativa di Sorano era focalizzata sul cinema al femminile, ed infatti all’insegna di “Donne nel Cinema” sono state premiate alcune opere da una giuria di professioniste riunite dalla rete Facebook delle “Mujerese nel Cinema” che era presente con una delegazione di 25 rappresentanti da tutta la Toscana. Il gruppo è nato il 9 ottobre 2019 e ne fanno parte quasi 9000 professioniste coinvolte nel settore dell’Audiovisivo, La Mission del gruppo è fare rete tra le donne di ogni maestranza che lavorano nel cinema, dai reparti artistici a quelli tecnici; diventare uno spazio dove promuovere e avviare sinergie , progetti, creando anche nuovi linguaggi. Una testimonianza del loro lavoro è stato appunto dato a Sorano dove sono stati proiettati tre cortometraggi. “Accamòra” di Emanuela Muzzupappa ci porta nelle aspre campagne calabresi dove la raccolta dei fichi è un rito che per Antonio, il protagonista, è un punto saldo della sua esistenza. Ma la sua vita sarà sconvolta da una notizia, mentre un giorno con il fratello sta portando a termine la raccolta dei fichi.
In “Gas Station” di Olga Torrico protagonista è invece Alice che lavora in una stazione di servizio abbondonando la musica che aveva costituito per lei più di una ragione di vita. Ma un giorno afoso d’estate si ripresenta il suo vecchio insegnante di musica e….. Infine, “Journey Together” di Sara De Martino racconta la storia di Abou, un uomo lontano dal suo paese e dai suoi affetti che grazie ad un incontro scopre come continuare ad amare.
La serata è stata presentata dall’attore Matteo Nicoletta che lo ha anche fatto alle Terme di Saturnia Natural Destination in cui si è svolta la cerimonia di premiazione della Quarta edizione del Saturnia Film Festival la cui Giuria era presieduta da Paolo Orlando, Direttore della Distribuzione Medusa Film, e composta anche da Mario Mazzetti, Alessandro Amato, Luigi Chimenti, Claudia Catalli e Sara Cosetti. Il premio per la migliore regia è stato attribuito a “ I’m afraid to Foirget your face” di Same Halaa che ha anche avuto la targa come “miglior Fiction internazionale”. Il film racconta una storia d’amore osteggiata dalle famiglie, che porta alla perdita della persona amata, e indaga su cosa si sia disposti a fare per rivedere, nonostante tutto e tutti, il suo viso, almeno per l’ultima volta. Il premio gli è stato attribuito perché è “una storia apparentemente semplice, valorizzata da uno sguardo delicato e mai invadente, da una direzione attoriale asciutta e funzionale e da una sapiente gestione del ritmo, che restituiscono un’opera matura e potente che trasporta lo spettatore ad empatizzare con il doloroso addio del suo protagonista”.

Il premio per la migliore sceneggiatura è stato vinto da “ May I ask your seat?” di Tabish Habib, incentrato su un autobus in cui sono racchiuse un microcosmo di storie, contrasti social e sociali ed emergenze emotive, ed è stato consegnato dal critico cinematografico Augusto Sainati , curatore della corrispondenza tra Federico Fellini e Tuillio Pinelli a cui il premio era dedicato, cittadino di Pitigliano nella Maremma toscana. Quello per il miglior corto della Fiction Italiana è andato a “Il branco” di Antonio Corsini, che racconta di u n adolescente ricco e problematico che organizza combattimenti tra cani insieme ad un gruppo di delinquenti , la cui vita cambierà quando conoscerà una ragazza. Premio per la migliore animazione a “Mila” di Cinzia Angelini, una storia di guerra che assume la prospettiva di un bambino che è ispirata alle storie della seconda guerra mondiale della madre del regista. Miglior documentario “Les aigles de Carthage” di Adriano Valerio che restituisce l’atmosfera di rivalsa del popolo tunisino dopo la finale di Coppa d’Africa del 2004.Migliore attore Zoltan Cservak protagonista del corto “Una nuova prospettiva” di Emanuela Ponzano e miglior attrice Lea Van Acken e Athena Strates, le due amiche del Corto “Cracks” di Andrea Cazzaniga.”Solitaire” di Edoardo Natoli si è poi conquistato una menzione speciale per la regia.
Alla cerimonia di premiazione, conclusa dall’ideatrice del Festival Antonella Santarelli e dal direttore artistico Alessandro Grande reduce dal successo del suo film “Regina”, era presente l’attore Simone Liberati che ha ricevuto il premio “Nuovi volti del cinema”.
Il Saturnia Film Festival è proseguito con alcuni eventi speciali dedicati a Federico Fellini(I Vitelloni) e Giulietta Masina(Le notti di Cabiria). Ma è stato anche proiettato “Cani di razza”, il cortometraggio con cui Matteo Nicoletta si è fatto conoscere nel 2017, che lo aveva diretto insieme a Riccardo Antonaroli.
ALCUNE NOTE SU “IL CINEMA RITROVATO”
di Paolo Micalizzi
Ricchissimo, come sempre, il programma di “Il Cinema Ritrovato” di Bologna che quest’anno si è svolto dal 20 al 27 luglio. Difficile da seguire per intero da chi soggiorna nel capoluogo emiliano per tutto il periodo, figuriamoci chi, per vari motivi, lo può frequentare soltanto per qualche giorno. Ed allora, si va alla ricerca di ciò che particolarmente lo interessa. Nel mio brevissimo periodo la mia attenzione è caduta sul film di Sam Wood “Gli amori di una spia” (Stamboul Quest), un’opera del genere Mata Hari con Myrna Loy nel ruolo di una spia tedesca chiamata di volta in volta con un nome diverso. Dove si vede l’uso di un armamentario insolito, come per esempio quello dell’inchiostro invisibile sulla biancheria di seta,o dei microfilm nascosti nelle capsule dentali.
Ho potuto anche vedere “Harlem” del 1943 di Carmine Gallone che Luca Martera considera, come recita il titolo del suo libro, il film più censurato di sempre, avendo avuto trentun minuti di tagli che arrivano a quaranta se si considerano anche le modifiche ai dialoghi perché antirazzista. Il film, riferisce lo scrittore, è ispirato in parte alla storia del primo campione dei pesi massimi Primo Carnera, che figura anche tra gli interpreti, che dopo aver vinto nel 1933 il titolo grazie all’aiuto di Al Capone, fu battuto l’anno dopo dall’ebreo Max Bear e nel giugno 1935 dal “bombardiere nero” di Detroit Joe Luis alla vigilia dell’invasione italiana dell’Etiopia. Il protagonista è un pugile italo-americano (Massimo Girotti) che sconfigge un pugile abissino in una New York di metà anni Trenta, interamente ricostruita a Cinecittà.
Una storia che rovescia i fatti riguardanti la vicenda americana di Primo Carnera facendo vincere il pugile bianco per dimostrare la superiorità degli “ariani italiani” nei confronti dei “biechi impresari ebrei” e dei “selvaggi tifosi afro -americani dello Yankee Studium. Censurata, la pellicola riprese a circolare dopo la guerra in un’edizione di 85 minuti, priva di tutti i riferimenti anti-americani e antisemiti ma conservando il razzismo nei confronti dei neri con il ricorso al doppiaggio stereotipato. Nella storia figurano Amedeo Nazzari nel ruolo del fratello maggiore di Girotti che da vent’anni vive a New York ed è ben conscio dei -compromessi e dei rischi che si nascondono dietro il facile successo. In quell’ambiente poco pulito lui stesso sarà arrestato per un omicidio compiuto dalla socia (Elisa Cegani) di un boss (Osvaldo Valenti) per favorire una speculazione edilizia. Sarà il fratello pugile che per trovare i soldi che possono sbloccare i piani del gangster sfiderà il campione dei massimi. Ma uscito dal carcere, il fratello sarà falciato da una scarica di mitra. Un melodramma sportivo utilizzato dal regime fascista per la sua propaganda antisemita.
Con piacere ho poi visto un film del 1966 con la regia di May Zetterling. Mi riferisco a “Giochi di notte”, tratto da un romanzo della stessa Zetterling, che alla Mostra di Venezia del 1966 dove lo vidi( la proiezione era solo per giurati e giornalisti) conteneva una scena di masturbazione che nella copia italiana venne censurata. Il film è incentrato su un rapporto morboso, quello di un giovane con la madre(Ingrid Thulin) che rivive questo suo passato ,in cui la madre conduceva una vita turbolenta, insieme alla fidanzata, mentre si trova nel castello avito. E’ considerato una delle indagini più intelligenti sulla pubertà. E conferma la Zetterling, la cui attività era soprattutto di attrice, una regista interessante dal punto di vista femminile.
Serata in Piazza Maggiore con Nanni Moretti. Presentava il suo documentario “La cosa” (1990) in cui testimonia i dubbi e i pensieri dei simpatizzanti e tesserati del Partito Comunista Italiano alla vigilia della trasformazione in PDS, quando ancora non era stato deciso il nuovo nome e se ne parlava come la “Cosa”.
In ricordo dei cento anni della nascita di Giulietta Masina, Gianfranco Angelucci le ha dedicato il libro intitolato semplicemente Giulietta Masina. Attraverso esso la Mostra ha ricordato la grande attrice di film indimenticabili come “La strada” o “Giulietta degli spiriti” in una Lezione di cinema in cui l’autore ha conversato con il Direttore de “Il Cinema Ritrovato” Gian Luca Farinelli.
Un’iniziativa interessante è poi costituita dalla Mostra Mercato dell’Editoria cinematografica che riscuote sempre più interesse. Essa offre una selezione delle più importanti e prestigiose edizioni internazionali di libri e DVD. Un aggiornamento molto utile per tutti gli appassionati di cinema.
Andandosi ad accreditare al Festival, quest’anno ci si è imbattuti subito in una Mostra dedicata a “Gino Sensani e i costumi per il cinema”. Una Mostra sul primo grande costumista cinematografico italiano che nel corso della sua carriera ha creato i costumi di una novantina di film. Ha anche insegnato al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma la Storia del costume formando una generazione di costumisti del dopoguerra. Una Mostra che gli rende merito e lo porta ad essere conosciuto dalle generazioni successive.
OCCHIO CRITICO
“NONOSTANTE LA NEBBIA” DI GORAN PASKALJEVČ
di Tullio Masoni
Più di 10.000 bambini non accompagnati sono scomparsi in Europa negli ultimi 3 anni. Circa metà sono scomparsi in Italia…
Con queste parole si chiude il film di Paskaljevič; l’ultimo, perché il regista sarebbe morto poco dopo a 73 anni.
All’inizio piove, e la nebbia invade lo schermo. Passando in auto Paolo vede un bambino seduto, solo, alla fermata dell’autobus. Lo fa salire e se lo porta a casa.
Il bambino ha 8 anni, si chiama Mohammed, viene dalla Siria e, come abbiamo appena visto nell’incipit, è stato abbandonato sulla strada da un amico più grande. Parla solo arabo salvo dire “Okay” e “Sweden”: la Svezia, dove crede troverà i genitori che invece sono affogati per il naufragio del gommone.
La moglie di Paolo, Valeria, stravolta per la perdita del figlio Marco, dopo una iniziale diffidenza si affeziona al piccolo siriano. Cosa accadrà? Adottare un bambino straniero non è facile, per la coppia, e neppure creare attorno a lui un clima di accoglienza vera.
L’opera di Paskaljevič in Italia è nota solo parzialmente, ma “Nonostante la nebbia” (2019), per via della co-produzione di Rai-Cinema con Serbia e Macedonia vorrebbe essere un film molto italiano: ci sono Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Anna Galiena e Luigi Diberti, poi i paesaggi della provincia a nord di Roma: Campagnano, Civita Castellana, Fiano, il lago di Vico…
Simone Emiliani, recensendolo, non ha dato scampo: un Paskaljevič irriconoscibile, una storiella che fa pensare a uno spot pubblicitario mal fatto. Il regista che Emiliani riconoscerebbe è quello dell’ammiratissimo “La polveriera”, opera visionaria – che qualcuno definì un vero, possente pugno nello stomaco – stilisticamente preziosa perché fondata su un arrischiato melange di fantastico e documentario. Posso capire; “Nonostante la nebbia” sembra anche a me irrisolto. D’altra parte, però, occorre tener presente che in Paskaljevič una vena intimistico-minimalista esiste. Penso a “Zemaljski dani teku-I giorni terrestri corrono” (1979), presentato alla Mostra di Pesaro del 1982, che con essenzialità, profondità e pudore, racconta l’amicizia di due anziani e il lutto vissuto da uno quando l’altro muore. Il regista serbo è testimone di tragedie e, come altri cineasti jugoslavi, si è egregiamente servito dell’azzardo linguistico per raccontarle, ma il doloroso e quieto ”Zemaljski dani teku” credo sia fra i suoi esiti migliori.
“Nonostante la nebbia” affronta un tema molto difficile e, al di là di una impostazione forse coerente, la fatica di trovare una sintesi efficace si avverte presto. Volendo temperare la propria generosità per toni bassi, cioè operando su alcuni essenziali contrasti – ad esempio quello fra il centro di accoglienza e la casa agiata della coppia – e con l’uso di un unico tempo per ripresa e montaggio, Paskaljevič tenta di costruire l’insieme senza ricorrere agli effetti del crescendo. Sembra quindi rinviare alla compostezza di “Zemaljski dani teku” ma la materia su cui agisce è molto diversa, cioè richiede una dinamica di scrittura meno lineare. A conferma ricorderei l’altro aspetto del dramma, ossia l’equilibrio familiare spezzato dalla perdita e il conseguente, vano tentativo compiuto dai genitori, soprattutto da Valeria, di sostituire il figlio scomparso con l’improbabile adozione di Mohammed. Un soggetto simile pone il problema della credibilità con forza particolare; nel film di Paskalievič, invece, troppi aspetti si fermano all’accenno: la religiosità di Valeria, ad esempio, o l’atteggiamento affettivo dei suoi genitori verso il piccolo rifugiato. A poco rimedia, infine, l’idea – visionaria – che affida alla follia materna di Valeria una metaforica fuga dal mondo col bambino/figlio: una “inutile” sparizione nella stessa nebbia da cui Mohammed e il suo amico più grande erano all’inizio spuntati.
DUE OSCAR: “UN ALTRO GIRO” DI THOMAS VINTERBERG;
“MINARI” DI LEE ISAC CHUNG
di Paolo Vecchi
Martin, professore di liceo, sta attraversando una profonda crisi. In famiglia il rapporto con la moglie e i due figli è diventato di pura routine, a scuola ha perso la capacità di interessare gli allievi. Una possibile svolta sembra presentarglisi alla cena di compleanno tra colleghi. Quando ormai il livello etilico è arrivato molto in alto, qualcuno cita la teoria enunciata dallo psichiatra norvegese Finn Skarderud, secondo la quale l’alcol, bevuto con metodo, può favorire l’approccio alle difficoltà della vita di tutti i giorni. I quattro amici decidono di metterla in pratica, con risultati dapprima altalenanti.
Rispetto ai numerosi film sull’etilismo, l’originalità di “Un altro giro” consiste nel fatto che l’alcol apre davvero una fase positiva nella vita dei protagonisti. Martin, infatti, recupera il proprio carisma nei confronti degli allievi e si riavvicina ai figli e alla moglie. Vero coup de theatre in questo percorso è il momento in cui il protagonista impone alla classe una verifica a sorpresa. Una delle ragazze dovrà decidere se votare per un poliomielitico iperteso e anemico, mentitore in politica, infedele in amore e consumatore seriale di Martini, oppure per un obeso, depresso e cardiopatico, fumatore, bevitore e impasticcato di sonniferi, infine per un eroe di guerra pluridecorato, che tratta le donne con rispetto, ama gli animali, non ha mai fumato e beve solo una birra ogni tanto. Alla risposta, fin troppo ovvia, che l’allieva avrebbe scelto il terzo , tra la sorpresa e l’ilarità generale Martin scopre le tre fotografie corrispondenti alle definizioni, svelando che ha preferito Hitler a Roosevelt e Churchill Ma anche il professore di musica riesce a far cantare meglio il coro scolastico, quello di filosofia ottiene un risultato straordinario da un allievo depresso per l’incapacità ad affrontare la tensione degli esami, sciogliendogli la lingua con un paio di sorsi di superalcolico che lo fanno dissertare brillantemente su Kierkegaard e la malattia mortale – siamo in Danimarca – di fronte al commissario esterno, mentre quello di ginnastica imposta come calciatore un magrolino occhialuto che segnerà un magnifico gol nella partita interscolastica, anche se la sua rimane una figura tragica, annaspante come il suo cane obeso, pur non precludendo al film una conclusione dionisiaca, ambiguamente liberatoria.
Thomas Vinterberg , formatosi nell’ambito del Dogma di Lars Von Trier ma in seguito allontanatosi dal vate, con “Un altro giro” ha vinto l’Oscar per il miglior film straniero, dedicandolo alla figlia morta in un incidente all’inizio della lavorazione. La sua è una commedia che possiede un sicuro equilibrio tra tonalità amare e soprassalti comici, momenti convulsi e un tempo che si sospende sulle note della “Fantasia D. 940” di Schubert, un capolavoro che impone fatalmente la propria temperatura emotiva alla narrazione.
La famiglia Yi, coreani immigrati, si trasferisce dalla California all’Arkansas. La casa acquistata da Jacob, il padre, non entusiasma la madre Monica, anche perché sperduta nella pianura e lontana dal più vicino ospedale. David, il figlio piccolo venuto dopo Anne, è infatti cardiopatico e potrebbe da un momento all’altro avere necessità di un ricovero. Jacob e Monica si guadagnano da vivere sessando i pulcini in un allevamento, ma il primo nutre l’ambizione di diventare agricoltore. Non avendo la possibilità di pagare una baby sitter, la coppia fa venire dalla Corea la madre di Monica, Soon-ja, il cui carattere eccentrico è in un primo momento mal sopportato da David.
Lee Isac Chung è nato a Denver, ma immaginiamo che in “Minari” ci sia più di un elemento autobiografico, vista la sua condizione di immigrato della seconda generazione. Anche per chi è approdato in America negli anni della presidenza Reagan il sogno è quello, eterno quanto troppo spesso illusorio, dell’ascensore sociale. Un’ attrattiva alla quale non sfugge Jacob che, partendo dalla pura sussistenza garantitagli da un lavoro senza grosse prospettive, cerca di trasformarsi in piccolo imprenditore. Lo affianca Paul, certo singolare per il suo misticismo d’accatto ma in qualche modo a lui vicino in quanto ha combattuto in Corea, dunque è arrivato a contatto con quella lontanissima cultura. In maniera graduale quanto efficace, il regista mette in parallelo l’esistenza dei protagonisti con un universo tipicamente americano, concentrandosi più sui contrasti interni al gruppo che su quelli sociali. Il film è infatti, anche, un mélo familiare, con l’ambizione di disegnare in maniera pregnante i componenti del nucleo: un padre attivo sul piano del lavoro quanto un po’distratto su quello dei rapporti interpersonali, una madre insoddisfatta ma concreta, una figlia già saggia a dispetto dell’età e un bambino dalla personalità spiccata ancorché bizzarra. Momento di svolta l’arrivo di Soon-ja, la nonna che non sa far da mangiare, dice le parolacce e si entusiasma per il wrestling in tv, dunque lontana dagli stereotipi dell’anziana dedita ai nipoti. L’evolversi del suo rapporto con David, dapprima di totale rifiuto da parte del bambino, è uno dei fili conduttori più interessanti di “Minari”.
In un film che con il pudore dell’ellissi insiste su elementi simbolici tuttavia crudeli – si veda, ad esempio, l’immagine ricorrente della ciminiera dalla quale escono le ceneri dei pulcini bruciati in quanto maschi, dunque inutili ai fini del profitto – Soon-ja rappresenta l’elemento di giuntura tra due situazioni così distanti, oltre che custode di una memoria che solo la pratica della tradizione è destinata a preservare.
Il minari è una sorta di prezzemolo asiatico, tocco indispensabile nei piatti coreani. Soon-ja, che ne ha portato con sé i semi dalla madrepatria, individua nella sponda riparata di un torrentello dietro casa il luogo adatto per piantarli. Consumatesi tutte le vicissitudini del film, Jacob va a raccoglierlo là dove è cresciuto rigogliosamente, a sottolineare che i drammi possono comunque essere metabolizzati, quasi messi tra parentesi, anche grazie a un forte richiamo alla continuità della cultura materiale dei padri.
Yoon Yeo-yeong nel ruolo della nonna ha vinto l’Oscar per il miglior secondo ruolo femminile, ma tutti gli attori di questo film lieve nella sua durezza risultano impeccabili.
THE BOYS: IT’S ONLY ROCK AND ROLL BUT I LIKE IT
di Marco Incerti Zambelli
Dopo una serie di pregevoli documentari e mentre rimane misteriosamente inedito in Italia il suo Just Noise, spettacolare ricostruzione dei moti di indipendenza di Malta alla fine della prima guerra mondiale con Harvey Keitel e Malcom Mc Dowell, Davide Ferrario ritorna sugli schermi nostrani con un’agrodolce commedia a tempo di rock. “The boys” è il titolo ed è anche il nome di una band di un certo successo negli anni ‘70 i cui componenti, sfumate le glorie di un tempo andato, ricordato con efficaci inserti di repertorio, continuano comunque a ritrovarsi a suonare insieme, legati da una intatta amicizia. Ferrario raduna un quartetto di pregevoli attori, a loro agio da anni sia sui palcoscenici teatrale sia sugli schermi, per raccontarne le vicende. Giovanni Storti è Carlo, batterista e notaio di successo, padre e nonno attento e devoto, collezionista di preziosi memorabilia rock in una magica stanza a metà tra wunderkammer pop e Rock Cafè, qui in una misurata interpretazione, più incline ad una briosa ironia che ad una facile comicità.
Marco Paolini è Joe, il tastierista tormentato da forse fin troppo insistiti problema alla prostata, che offrono tuttavia occasione per un delizioso cameo di Mariella Valentini, fiamma giovanile ed ora medico urologo mentre Giorgio Tirabassi, talentuoso musicista anche nella vita, impersona Bobo il chitarrista, angosciato da una giovane moglie che rivendica una maternità che lo spaventa. Neri Marcorè, anche egli cantante e strumentista di provata qualità, il più giovane, o meglio il meno anziano, entrato nel gruppo in sostituzione del fratello maggiore, vera anima e leader del gruppo morto suicida all’apice del successo, è travagliato da problemi economici del ristorante che gestisce con la moglie. L’occasione di un inaspettato rilancio del gruppo arriva con la proposta dell’agente di un trapper di successo che vuole interpretare una cover di un loro brano e intende acquistare i diritti di tutto il repertorio. Non risparmia il sarcasmo l’Autore nel tratteggiare la manager come una sorta di stereotipata Crudelia Demon ed il mondo del cantante rap, vacuo e superficiale, tutto Instagram e like. Ma è anche l’espediente narrativo che imprime una svolta: la necessità di rintracciare Anita, la vocalist del gruppo, spinge i quattro ad un viaggio verso il Molise su un celeste e vintage furgoncino Volkswagen, accompagnati da Steve, un ingenuo giornalista sincero fan del gruppo. Sarà l’epifanica apparizione di Isabella Russinova, la cantante ritrovata, a far maturare nei quattro la necessità di riconsiderare il rapporto con sé stessi e con le donne che li affiancano, in un ritrovato ed orgoglioso sussulto di dignità, suggellato dalla poetica e commovente sequenza finale. Punto di forza è la musica di Mauro Pagani, che offre alcune sue inedite composizioni degli anni del successo dei Boys a far da perfetto contrappunto all’intera vicenda.
A partire da un soggetto di Cristina Mainardi, Ferrario confeziona un film che certamente ha nella nostalgia un tratto distintivo, una nostalgia che però non si rinchiude nel puro rimpianto di ‘come erano belli quei tempi, adesso è tutto orribile’ ma capace di diventare motore di una lettura del presente in grado di indicare degni percorsi e onorevoli soluzioni. L’Autore dirige con partecipazione i suoi attori, mettendone in luce aspetti che le pur gloriose carriere avevano messo un poco in ombra, offre aperture sulla natura di sicuro fascino, dalle campagne del Molise alle acque del Po, regala un’arguta, godibilissima citazione dai musical aquatici di Esther Williams nella dolcemente onirica scena della piscina a Capracotta, fa emergere echi da “Still Crazy” di Bryan Gibson e “Almost Famous” di Cameron Crowe e dona a Steve la battuta centrale del film ‘Voi avevate Jimi Hendrix , noi abbiamo X Factor’.
P.S. Chi scrive è coetaneo di quei personaggi, da ragazzo suonava in un gruppo che pur non avendo mai inciso un disco qualche piccola soddisfazione l’ha data e tuttora si ritrova ogni tanto a suonare con gli amici…
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
VIAGGIATORI INVISIBILI NO BORDERS.
FLUSSO DI COSCIENZA DI MAURO CAPUTO
di Marcello Cella
Esistono viaggiatori che nessuno vuole vedere e che non desiderano mostrarsi. Esistono viaggiatori che non percorrono le strade più conosciute e che per spostarsi non usano i mezzi di trasporto più comodi. Esistono viaggiatori che preferiscono muoversi a piedi di notte nei boschi sui monti al confine fra l’Italia e la Slovenia. Esistono viaggiatori che quando attraversano il confine per entrare in Europa abbandonano tutto il bagaglio che li ha accompagnati fino a quel momento, tutte le cose che potrebbero riportarli al punto di partenza, tutto ciò che potrebbe rivelare la loro identità. Esistono viaggiatori che, come l’acqua dei fiumi, non possono più tornare indietro ma solo avanzare verso una meta incerta e pericolosa, ma inevitabile perché, come l’acqua dei fiumi, se incontrano un ostacolo troveranno il modo di aggirarlo. E se il modo non si trova la morte è una compagna di viaggio sempre presente, una possibilità da mettere in conto e forse nemmeno la peggiore se l’alternativa è morire di fame o sotto le bombe di una delle tante guerre che insanguinano il pianeta. Questi viaggiatori sono i migranti che percorrono ogni giorno, ogni notte, da anni i confini di Grecia, Montenegro, Macedonia, Bosnia, Serbia, Croazia, Slovenia, che affrontano il “gioco”, “The Game”, il percorso ad ostacoli lungo la rotta balcanica per entrare in Europa. Si stima che siano state oltre 800.000 le persone che hanno utilizzato questo percorso faticoso, difficile e pericoloso per fuggire dalle tante disgrazie che affliggono i paesi che stanno a sud del ricco Occidente.
“No borders. Flusso di coscienza”, uscito quest’anno, ma girato fra il 2019 e il 2020, racconta l’odissea di questi migranti utilizzando un punto di vista inusuale, tutto interiore, un flusso di coscienza appunto (la bella voce fuori campo dell’attore Adriano Giraldi e le musiche fortemente evocative del compositore Francesco Morosini), che accompagna le immagini dei sentieri segnati dalle tracce, dagli oggetti di uso comune, dai vestiti e dai documenti abbandonati da questi invisibili viaggiatori. Oggetti e documenti che raccontano meglio di tanta sociologia spicciola le provenienze e le vite individuali e collettive di questo anonimo esercito di persone in fuga. Del resto, al di là dei drammi legati alla migrazione, si tratta di raccontare una presenza che in realtà è un’assenza. Come afferma il sociologo algerino Abdelmalek Sayad, citato nel libro con cui viene distribuito il documentario, “La porta d’Europa. Il confine italiano della rotta balcanica”, la migrazione non è un fenomeno solo economico o demografico. L’esperienza della migrazione è segnata da una doppia assenza, dal Paese in cui il migrante è nato e nel Paese in cui sceglie di vivere. “Una è l’assenza dell’immigrato dalla propria patria, l’altra è l’assenza dell’emigrato nelle cosiddette “società d’accoglienza”, nelle quali è incorporato ed escluso al tempo stesso. (…) La presenza dell’immigrato è sempre una presenza segnata dall’incompletezza, è colpevole in sé stessa. E’ una presenza fuori posto in tutti i sensi del termine”.
Il cineasta Mauro Caputo e la sua troupe hanno girato per un anno e mezzo lungo questi sentieri, attraversando villaggi di confine e boschi che in altri tempi sono stati testimoni di altri passaggi e altri scambi fra i popoli che li hanno vissuti, cercando di ricostruire storie e percorsi dei migranti, raccogliendo oggetti e documenti, unici testimoni di queste identità abbandonate. “La parola d’ordine è “ricominciare daccapo”. – racconta la voce dell’attore Adriano Giraldi – “In quelle radure avviene una sorta di rito individuale: i migranti si rendono invisibili, senza nulla che possa farli identificare. All’apparenza si azzera tutto: la propria origine, i luoghi in cui si è transitasti. Un nuovo spazio e un nuovo tempo cominciano in quei boschi (…). L’identità di ognuno, tenuta stretta per tutti quei chilometri (…) adesso, al traguardo illusorio di quell’invisibile porta d’Europa, è da dimenticare, da nascondere agli sguardi che li incroceranno nel lungo cammino che ancora li attende”. Ma grazie ai nomi delle persone lasciati nei documenti abbandonati, raccolti dal regista, è come se li avessimo incontrati e conosciuti. Come se avessimo conosciuto le loro storie in cammino dentro gli zaini e le scarpe rotte.
“No borders. Flusso di coscienza” non è però solo un documentario che cerca di raccontare le storie e la vita dei tanti Omar, Mohamed, Azra che hanno percorso quei sentieri, immaginando i paesi da cui provengono, lontani ma così vicini, vicini a tal punto da far pensare che Trieste non confina solo con la Slovenia, ma anche con la Somalia, l’Afghanistan, l’Iran, l’Iraq, la Siria, l’Eritrea, la Tunisia, il Pakistan, il Marocco, il Mali, la Turchia…Come in uno specchio in cui lo spettatore riconosce le proprie paure e misura la propria indifferenza al dolore altrui, anche noi occidentali siamo tirati in causa perché viviamo a metà strada tra la nostra paura e la curiosità per questi destini diversi che improvvisamente ci si palesano senza bussare alla porta. Fin dall’inizio il documentario di Mauro Caputo mette bene in evidenza i sentimenti in cui tutti ci dibattiamo quando entriamo in contatto con queste persone: la paura e la curiosità. “La paura è uno stato emotivo di forte preoccupazione, di insicurezza e di angoscia che si avverte in presenza o al pensiero di pericoli reali o immaginari. La paura è sempre stata uno strumento di potere, usata spesso come arma politica e di propaganda. (…) La curiosità è un istinto che nasce dal desiderio e dal piacere di accrescere il proprio sapere. E’ la curiosità che ci ha portato in questi luoghi, giorno dopo giorno, tenacemente, come il fluire del tempo, della storia, dell’acqua del Danubio che percorre la lunga via d’Europa, attraversandone liberamente i confini. Perché la curiosità è l’antidoto alla paura. E’ la strada che porta alla conoscenza”. Questi sono i sentimenti che ci definiscono come esseri umani e che definiscono la nostra posizione, il nostro ruolo, il nostro punto di vista, il nostro sguardo rispetto all’umanità dolente, la dimensione etica evocata dallo scrittore Giorgio Pressburger, fuggito nel ’56 dall’Ungheria in Italia con in tasca solo i pochi soldi fornitigli dalla Croce Rossa, a cui il film è dedicato: “Noi non siamo esseri umani se non prendiamo su di noi la responsabilità di un altro uomo e attraverso questo uomo di tutta l’umanità. Appena appare un volto sull’orizzonte della nostra coscienza di quel volto ne siamo responsabili, anche senza sapere nulla di lui. Punto essenziale dell’esistenza di ognuno o di noi è l’assunzione di questa responsabilità”.
PANORAMA LIBRI
a cura di Paolo Micalizzi
HARLEM – IL FILM PIU’ CENSURATO DI SEMPRE di Luca Martera
La nave di Teseo – CSC, Centro Sperimentale di Cinematografia, aprile 2021
Pagg. 345, Euro 22
Il più censurato dell’intera storia del cinema italiano perché, sostiene l’autore, era un film di propaganda fascista più razzista, antisemita e antiamericano. Uscito alla fine dell’aprile del 1943, riferisce Luca Martera che è uno specialista di archivi ed esperto in ricerche storico-investigative, cioè due mesi prima dello sbarco degli alleasti in Sicilia e tre mesi prima della caduta del fascismo, il film di Carmine Gallone fu una delle più plateali opere di mistificazione del regime fascista , pensata e realizzata quasi 80 anni fa per illustrare alle masse il “razzismo di Stato” e sancire così la superiorità della stirpe ariana attraverso un incontro di boxe tra un italo-americano e un pugile nero, trent’anni prima del film “Rocky” con Sylvester Stallone. Il pugile italiano era Primo Carnera e quello nero Max Bear. Nel film di Gallone il pugile italiano si chiama Tommaso Rossi, detto Tom Ross, ed è interpretato da Massimo Girotti . Egli viene chiamato in America dal fratello Amedeo, detto Sam Ross, che a New York, dove si era trasferito, aveva fatto fortuna. Tom, boxeur, appena arrivato, combatte contro un campione nero e vince proprio quando il fratello Sam, per una serie di ingiustizie, finisce in galera accusato di assassinio. I soldi guadagnati dal giovane Tom bastano per pagare la libertà del fratello che però sarà falciato da una raffica di mitra appena esce dal carcere. Nella vicenda vi sono altri personaggi come Elisa Cegani che è la vera assassina : uccide Joe Smith (Luigi Pavese) in quanto amante del boss Chris Sherman (Osvaldo Valenti), per favorire una speculazione edilizia. Vi figurano anche Vivi Gioi nel ruolo della fidanzata di Massimo Girotti ed Enrico Glori in quello dell’impresario , ma anche Erminio Spalla in quello dell’allenatore. Ci sono anche i radiocronisti EIAR Mario Ferretti e Augusto De Angelis nel ruolo di se stessi. Il soggetto è tratto dall’omonima novella di Giuseppe Achille e alla sceneggiatura collaborò anche Sergio Amidei che in seguito fu uno dei massimi protagonisti del Neorealismo. Il film fu prodotto dalla Cines su esplicita richiesta di Luigi Freddi, il capo della cinematografia fascista, alla ricerca di un soggetto di propaganda anti-americana.
Luca Martera ricostruisce la storia di “Harlem”, che ebbe una seconda versione nel 1946 con il titolo” Harlem – Knock Out”, fornendo una serie di ricerche relative alle sue origini ed alla sua realizzazione, alla sua uscita nelle sale ed al suo ritiro, alle recensioni ed al sequestro del film , alla nuova versione del 1946 ed a tutti i tagli subiti fino alla riscoperta.
CHAPLIN di Peter von Bagh
Edizioni Cineteca di Bologna, giugno 2021
Pagg. 556, Euro 25
Una rilettura di tutte le opere (trentacinque nel 1914 e dieci lungometraggi tra il 1923 e il 1967) di Charles Chaplin da parte di una delle “voci più originali della critica cinematografica internazionale”, scomparso a 71 anni nel 2014. Un’operazione volta, come afferma l’autore, a chiarire prima di tutto a se stesso il senso dell’opera di Chaplin che deve essere per un critico cinematografico la prima e la più sacra responsabilità. Un libro scritto nei suoi ultimi anni di vita e maturato lungo una vita intera. Una lettura dell’intera opera di Chaplin, come giustamente è scritto in seconda di copertina, dove si fondono sapere storico, vocazione letteraria e ricerca archivistica. Un libro di un critico finlandese, avverte nella prefazione il Direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, che costituisce per i lettori italiani un’occasione straordinaria. Un libro che si articola in un dialogo dell’autore con tutta la critica che si è occupata di Chaplin. Un libro terminato nel 2013, dopo otto anni di lavoro, e dato alle stampe in Finlandia e tradotto in italiano dopo altri otto anni. Un libro, ancora secondo Farinelli, che oltre alla scoperta di Chaplin porta alla scoperta di Peter von Bagh, “studioso finlandese innamorato della vita e della bellezza del cinema, illuminato dall’ironia e dalla grazia”.
NANNI MORETTI. IL CINEMA COME CURA di Roberto Lasagna
Mimesis / Cinema, maggio 2021
Pagg.152, Euro 14
Un volume che inizia nel modo che segue invitandoci ad “uscire dagli schemi” e “curarsi con il cinema, seguendo un autore che ci parla di insofferenze e di punti di vista sulle relazioni; un autore mai imparziale che ci invita a mettere in discussione i nostri schemi mentali anche quando sembra volerci far soprattutto sorridere”. Il suo cinema, continua l’autore, ci dice di noi in molti modi, ridesta il nostro bisogno di reagire, di essere osservatori attivi del nostro tempo. Curare, aggiunge, per ritrovarsi dentro quelle visioni che provocano la messa in dubbio delle certezze, attitudine comune all’autore, con il quale il cinema diviene strumento di autoanalisi. Concludendo che” tutto il cinema di Nanni Moretti poggerà su un transito di progressiva maturazione, attingerà dalle opere precedenti per formulare un percorso di senso, fatto di rimandi interni, strappi ed evoluzioni, e di sonore prese in giro del suo ambiente”.
Sono i concetti con i quali Roberto Lasagna, laureato in psicologia e filosofia, ripercorre il cinema di Nanni Moretti dai cortometraggi a “Tre piani” passando per i primi lungometraggi come “Io sono un autoarchico” ed “Ecce Bombo” che fanno conoscere un nuovo attore, Nanni Moretti appunto, “comico e tragico, destinato a crescere e maturare con il suo cinema”. Ma anche la Sacher Film che produce le opere d’esordio di Carlo Mazzacurati (Notte italiana) e Daniele Lucchetti (Domani accadrà) e gli scavi interiori che effettua con opere come “Caos calmo” ed i film successivi. Fino ad arrivare a “Tre piani” in cui, conclude Roberto Lasagna, “nell’ispirarsi al libro di uno scrittore ebreo, Moretti ritrova quella dimensione autoriflessiva in cui anche attraverso un film, sia possibile specchiarsi, attraverso il bisogno di raccontare quel segreto intimo che siamo sempre più sollecitati ad affidare ad un interlocutore astratto”
LE MOLTE VITE DI LINO BANFI di Alfredo Baldi
Edizioni Sabinae, giugno 2021
Pagg. 153, Euro 18
Un libro, avverte l’autore, realizzato con l’amichevole partecipazione di Lino Banfi, in cui le molte vite si riferiscono a Pasquale, Lino…Libero. Che sono i personaggi da lui interpretati in tantissimi film che lo hanno reso popolare allietando milioni di spettatori e telespettatori. Tante vite, avverte l’autore del libro. La prima è quella della gavetta, dei tempi “eroici” in cui si è dedicato con “grandi sacrifici” allo spettacolo dal vivo -avanspettacolo e cabaret- nel quale si è cimentato dal 1954 al 1973 costruendo passo dopo passo le basi della sua comicità. La seconda è quella della sua affermazione come attore di cinema che ha inizio nel 1973 con “Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia” ed è andata avanti una ventina di anni “rallegrata, oltre che dalla tua verve e dalle tue battute, dalla voluttuosa e provocante presenza di affascinanti Soldatesse, Dottoresse, Insegnanti, Liceali, Ripetenti e così via” che portavano nomi , tanto per citarne qualcuno, di Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Gloria Guida, Nadia Cassini e Laura Antonelli. Ma nella vita di Lino Banfi figurano, per usare un gioco di parole, altre vite che Alfredo Baldi racconta in maniera piacevole, parlando anche di quella privata in maniera diffusa “ forse ancora più emozionante e divertente, soprattutto agli inizi della carriera professionale”. Buona lettura, quindi, per conoscere un personaggio, l’undicenne Pasquale Zagaria, che era destinato alla carriera sacerdotale ed è diventato, invece, seguendo la sua passione, un attore con la vocazione di divertire il pubblico. Riuscendoci molto bene.
CREDITS
Carte di Cinema 25
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E. Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 25 della rivista online, Danilo Amione, Roberto Baldassarre, Paola Brunetta, Marcello Cella, Marino Demata, Mario Galeotti, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Paolo Vecchi, Marco Incerti Zambelli.