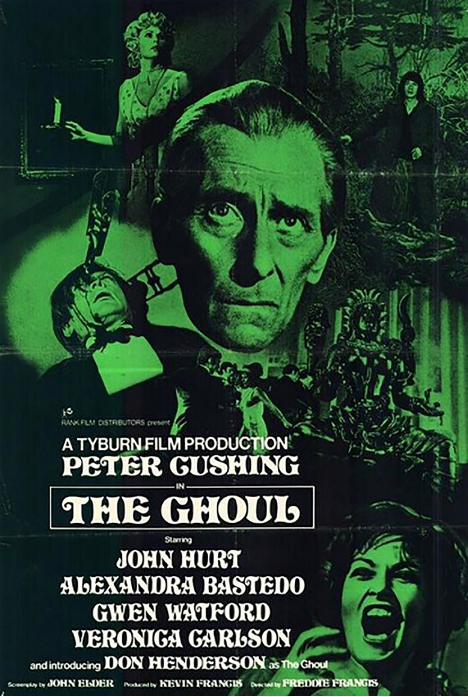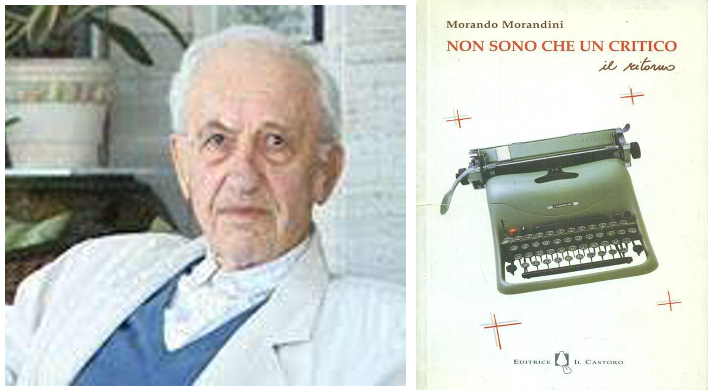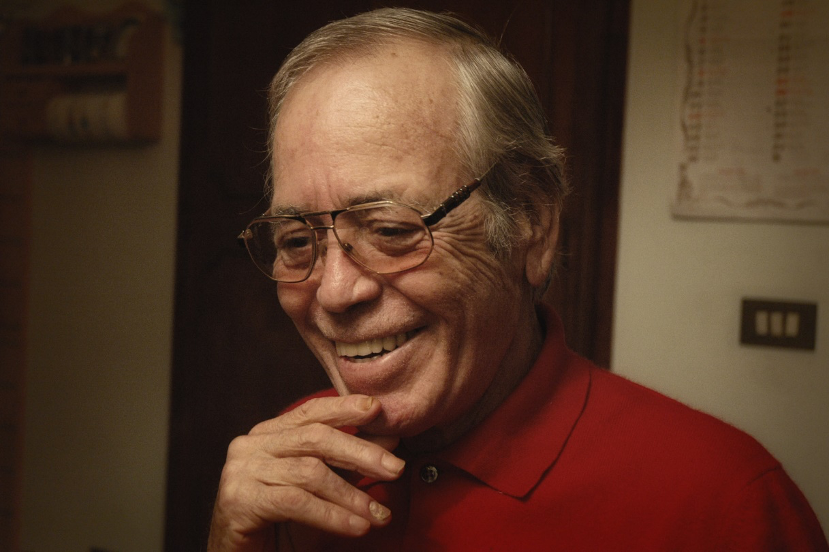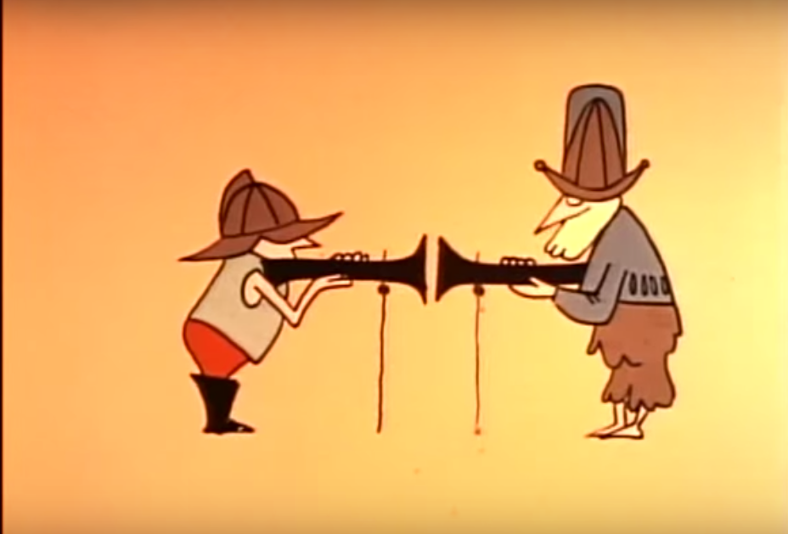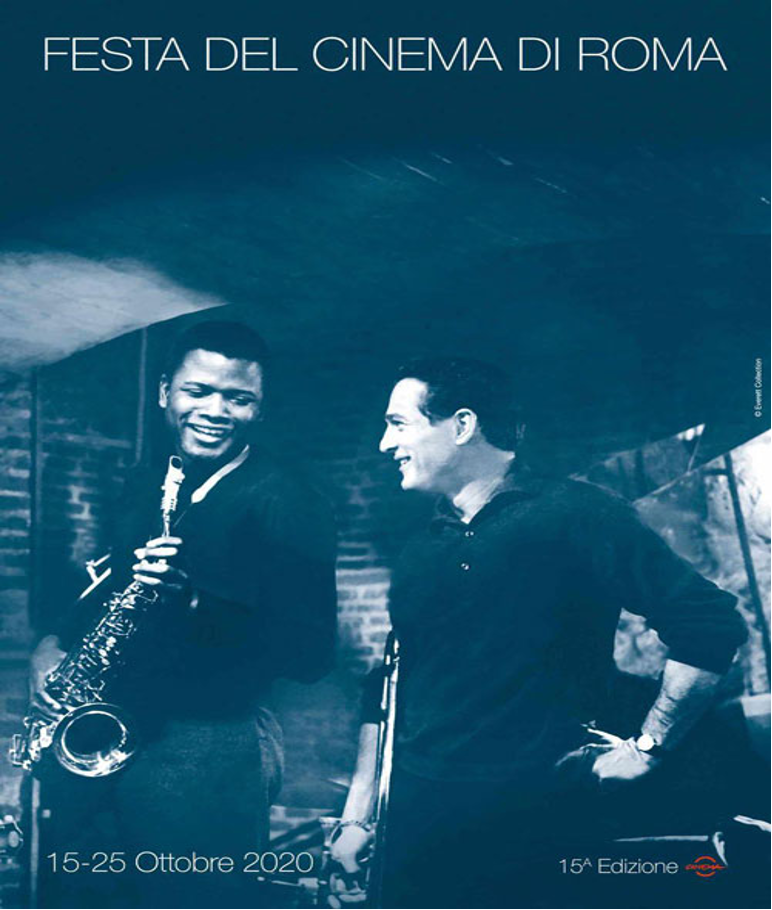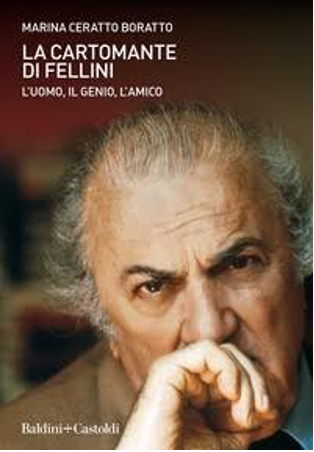Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 3.1 PETER CUSHING, L’AMORE OLTRE LA VITA di Mario Galeotti
- 3.2 GONE WITH HOLLYWOOD di Francesco Saverio Marzaduri
- 3.3 99 DONNE E OLTRE. IL FLORIDO DIVISMO ITALIANO DI “SERIE B” SVANITO, SEPOLTO E POI (RI)IDOLATRATO di Roberto Baldassarre
- 3.4 “LA STANZA DEL FIGLIO” VENT’ANNI DOPO di Roberto Lasagna
- 3.5 CARLO DELLE PIANE (1936-2019). UN FILM LUNGO SETTANT’ANNI di Mario Giunco
- 3.6 QUESTIONE DI SGUARDO di Paola Brunetta
- 4 INTERVISTA
- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 6 FESTIVAL ED EVENTI
- 7 OCCHIO CRITICO
- 7.1 “MANK”, THE OTHER SIDE OF THE LEGEND di Francesco Saverio Marzaduri
- 7.2 “IL CASO BRAIBANTI” DI CARMEN GIARDINA E MASSIMILIANO PALMESE di Tullio Masoni
- 7.3 DIETRO LE PORTE CHIUSE, ovveroCHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF? di Paolo Vecchi
- 7.4 Romania prima e dopo la caduta del Muro di Marco Incerti Zambelli
- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 9 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 10 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
KIRK, LA STAR SENZA PAURA di Francesco Saverio Marzaduri
Lo sguardo magnetico e la celebre fossetta sul mento erano il suo “marchio di fabbrica”. Ma è soprattutto con l’intensa, intelligente fisicità delle sue interpretazioni che è diventato una star: impostosi agli esordi della carriera in parti di uomo senza scrupoli, arrogante e risoluto, Kirk Douglas ha in seguito impersonato con grande versatilità i ruoli più svariati guadagnandosi la simpatia del pubblico.
SAGGI
“PETER CUSHING, L’AMORE OLTRE LA VITA” di Mario Galeotti
L’attore Peter Cushing, inglese purosangue, scomparso nel 1994 all’età di ottantuno anni, è noto in tutto il mondo per aver interpretato un numero considerevole di film dell’orrore. Insieme al collega e amico Christopher Lee, Peter Cushing è stato uno dei volti più rappresentativi della Hammer, la piccola casa di produzione cinematografica britannica che a metà degli anni Cinquanta aveva tentato con fortuna la strada della fantascienza e dell’horror. Sul grande schermo Cushing ha incarnato ruoli positivi ed eroici (Van Helsing), ruoli più controversi carichi di un fascino ambiguo (il Barone Frankenstein) e, nonostante la sua amabile personalità di uomo mite e sensibile, ha saputo anche dare un volto credibile al Male (pensiamo al ruolo del gelido Grand Moff Wilhuff Tarkin nel primo capitolo di Guerre stellari di George Lucas, 1977), soprattutto quando dall’inizio degli anni Settanta, dopo la scomparsa prematura dell’amatissima moglie Helen nel gennaio del 1971, l’attore si fece sempre più emaciato, di una magrezza sconcertante che ne alterò i lineamenti.
Un aspetto interessante della triste storia del lutto che colpì Cushing nel pieno della sua carriera, e su cui si sofferma l’articolo, consiste nel fatto che questa grave perdita ne condizionò, per certi versi, anche il percorso artistico: non soltanto per una sempre più evidente gracilità fisica, specchio di una sofferenza interiore, che orientò in parte la scelta dei ruoli da affidargli, ma anche perché alcuni personaggi portati sullo schermo da Peter Cushing nel corso degli anni Settanta riproponevano, con strabiliante analogia, il dolore e la solitudine realmente vissuti dall’attore dopo la morte di Helen.
GONE WITH HOLLYWOOD di Francesco Saverio Marzaduri
Con la scomparsa di Olivia de Havilland, insieme a quella di Kirk Douglas, scompare definitivamente un mondo: una bolla di sapone lunga più d’un secolo, cui non resta che sopperire con la memoria, ed eventualmente con le suggestioni del mito.
99 DONNE E OLTRE. IL FLORIDO DIVISMO ITALIANO DI “SERIE B” SVANITO, SEPOLTO E POI (RI)IDOLATRATO di Roberto Baldassarre
Nell’industria spaccia miti, di grande rilievo è stato lo Star System definibile di “Serie B”, con procaci stelle e stelline che come moderne sirene hanno fatto sognare milioni di spettatori. Corpi che sono diventati iconici, sedimentandosi nella memoria collettiva.
“LA STANZA DEL FIGLIO” VENT’ANNI DOPO di Roberto Lasagna
Quando, nel maggio del 2021, La stanza del figlio vinse la Palma d’oro a Cannes, il film fu accolto come una differenza, con il suo stile asciutto e la disillusione che permea il racconto. Diventando uno psicoanalista osservato in un momento di empasse, Moretti guardava al conflitto stridente tra il depositario della consapevolezza e la persona che si trova dentro il disagio più lancinante. La stanza del figlio sembrava allora cambiare segno rispetto alle visioni socio-politiche filtrate dall’osservazione diaristica di Caro diario e Aprile, eppure lo sguardo di Moretti era e sarà ancora sul mondo e dentro il mondo, dandosi come profondamente personale.
CARLO DELLE PIANE (1936 – 2019). UN FILM LUNGO SETTANT’ANNI di Mario Giunco
Come attore ha avuto al suo attivo più di cento film, in ruoli dapprima da caratterista (complice una accidentale frattura del setto nasale, che gli creò l’inconfondibile maschera) fino ad assurgere, con Pupi Avati, al ruolo di protagonista assoluto. Un monumento al cinema “tout court”, Carlo Delle Piane, un talento naturale, cresciuto a pane e cineteche. Un uomo tormentato – come Buster Keaton o Totò – in preda alla sua “mania” per l’igiene (oggi sicuramente apprezzata, ma guai, allora, a tentare di stringergli la mano; usava solo shampoo per bambini), pari alla sua idiosincrasia per la lingua inglese, che lo aveva portato a rifiutare un contratto principesco, per recitare accanto al mitico Sean Connery ne “Il nome della rosa” di Jean-Jacques Annaud. Dopo Avati il cinema italiano lo ha a torto dimenticato. Come regista ha legato il suo nome alla sua opera prima, “Ti amo Maria” (1997), che è rimasta anche unica, perché è un po’ il suo testamento. Come ha ravvisato un critico intelligente e sensibile, Enzo Natta: “Se l’infelicità è motivo di vita e di speranza, la felicità è esattamente il suo contrario”.
QUESTIONE DI SGUARDO di Paola Brunetta
Il saggio è una riflessione sulla critica cinematografica e in genere sulla critica, sul suo significato, che si concentra sul rapporto di correlazione che si crea tra il critico di cinema e l’oggetto della sua analisi (il film), a partire dall’estetica della ricezione. Nell’idea che se il critico regala nuovi sensi all’opera e apre “mondi possibili” ai lettori sul piano interpretativo, anche l’opera arricchisce il critico se questi, che è innanzitutto spettatore, riesce/ sa/ vuole mettersi di fronte ad essa a cuore aperto, in ascolto, in quell’antro delle meraviglie che è la sala cinematografica. Vi si parla di passione per il cinema e per la vita che in esso si respira e che lo sostanzia, di curiosità, di ascolto appunto… Di rispetto nei confronti dell’opera e della sua magia e unicità per cui le riflessioni del critico sono più ri-creazioni di senso che interpretazioni, per seguire Susan Sontag; ma anche delle competenze che il critico necessariamente mette in campo, per lavorare su un testo. Essenziali soprattutto oggi, quando sembra che chiunque possa esprimersi su qualunque argomento.
INTERVISTA
4.1 INTERVISTA CON DAVID GRIECO. RICORDANDO “SERGIO IL FILOSOFO” di Roberto Baldassarre
2005-2020: rievocando Sergio Citti, un autore troppe volte dimenticato oppure citato male, attraverso l’intervista a David Grieco, suo fedele amico e collaboratore in tante avventurose produzioni.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
FEDIC – 70 ANNI DI CINEMA IN 70 FILM SU YOUTUBE di Paolo Micalizzi
L’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea, presso la quale è depositata la Cineteca FEDIC ha messo su Youtube 70 film della storia delle Federazione italiana dei Cineclub.
MYRELOAD-LA (RI)CARICA DEI CORTI: I CORTOMETRAGGI DEGLI OSCAR 2021 SULLA NUOVA PIATTAFORMA STREAMING di Gianluca Castellini
La nuova piattaforma MYRELOAD inaugura una nuova forma di collaborazione tra ShorTS International Film Festival e Sedicicorto Forlì International Film Festival e presenta i migliori cortometraggi nazionali e internazionali degli ultimi anni.
FESTIVAL ED EVENTI
RIVER TO RIVER. FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2020 di Maria Pia Cinelli
La 20a edizione del festival fiorentino dedicato al cinema indiano si è svolta online dal 3 all’ 8 dicembre 2020 sulla piattaforma Mymovies.it, con in programma eventi speciali, documentari, corti e naturalmente lungometraggi, legati o meno al genere, ai quali va la nostra attenzione.
ANCORA A ROMA: APPUNTI DI UN CINEFILO di Luciano Volpi
Luciano Volpi, cinefilo Fedic, anche nel 2010 ha seguito con molta curiosità e attenzione la Festa del Cinema di Roma. Nel suo articolo alcuni appunti sui film proiettati.
CORTINAMETRAGGIO IN STREAMING CON OSPITI IMPORTANTI IN PRESENZA di Paolo Micalizzi
Anche quest’anno la combattiva Maddalena Mayneri non si è arresa al Covid ed ha portato avanti il, Festival da lei ideato e sin dall’inizio diretto, Cortinametraggio. In questo articolo il Palmares della XVI edizione.
IL PALMARES DI “PRIMO PIANO – PIANETA DONNA 2021” di Paolo Micalizzi
“Primo Piano sull’Autore”, diretto da Franco Mariotti, continua ad esplorare il “Pianeta Donna”. Ne riferiamo, segnalandone anche i Premi, in quest’articolo.
OCCHIO CRITICO
MANK, THE OTHER SIDE OF THE LEGEND di Francesco Saverio Marzaduri
In “Mank”, undicesimo lungometraggio di finzione a firma David Fincher, qualsiasi osservazione si possa fare nella restituzione scenica del mito-Welles comporta un punto di vista soggettivo che mette a dura prova l’attesa dello spettatore “cinéphile”. Ma il film, che non s’arena alla mera patina di “biopic”, è fondamentalmente un lavoro basato sulle antinomie. La più importante delle quali concerne il profilo del protagonista: un topo alle prese con una trappola costruita da chi vi lavora, e rimodellata dall’interno tappando i buchi che ne permetterebbero la fuga.
“IL CASO BRAIBANTI“ DI CARMEN GIARDINA E MASSIMILIANO PALMESE di Tullio Masoni
La drammatica vicenda di Aldo Braibanti ex-partigiano, filosofo e artista, processato e condannato per plagio nel 1968. Di lui, cultore ed esperto di mirmecologia, fu detto: “Un moderno pensatore anarchico annuncia la fine dell’uomo e la resurrezione della natura”.
ROMANIA PRIMA E DOPO LA CADUTA DEL MURO di Marco Incerti Zambelli
Ritratti della Romania prima e dopo la caduta della cortina di ferro. Antonio Pisu con “Est. Dittatura last minute” confeziona un agrodolce road movie, un romanzo di formazione dai risvolti documentaristici, Adrian Nanau con “Collective” mette in scena un documentario che ha la forza ed il fascino di un potente thriller di denuncia.
DIETRO LE PORTE CHIUSE OVVERO CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?: “QUELLA NOTTE A MIAMI…”DI REGINA KING; “MALCOLM & MARIE” DI SAM LEVINSON di Paolo Vecchi
Sam Cooke, cantante di successo, Jim Brown, running back dei Cleveland Browns e Malcom X, futuro leader dei Black Muslims, il 25 febbraio 1964 festeggiano allo Hampton House Motel di Miami Beach, insieme a Cassius Clay, la sua inaspettata vittoria su Sonny Liston, titolo mondiale in palio.
Malcolm è un regista che ha appena presentato alla stampa il suo ultimo film. Marie, che è stata il modello per la protagonista ma per il ruolo della quale Malcolm ha poi scelto un’altra attrice, è tormentata dal fatto di non essere nemmeno stata ringraziata pubblicamente alla prima.
Vedendo di seguito “Quella notte a Miami…” e “Malcolm&Marie” si ha l’impressione che il cinema americano sia tornato a “Chi ha paura di Virginia Woolf?” (1966). Entrambi,chi più chi meno, faticano ad alleggerire la teatralità dello spunto di partenza, anche perché né King né Levinson possiedono l’ariosità della messa in scena di Mike Nichols.
ROMANIA PRIMA E DOPO LA CADUTA DEL MURO di Marco Incerti Zambelli
Ritratti della Romania prima e dopo la caduta della cortina di ferro. Antonio Pisu con “Est. Dittatura last minute” confeziona un agrodolce road movie, un romanzo di formazione dai risvolti documentaristici, Adrian Nanau con “Collective” mette in scena un documentario che ha la forza ed il fascino di un potente thriller di denuncia.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
DANIEL SCHMID, IL “MOSTRATORE D’OMBRE”, “DANIEL SCHMID, UN RACCONTO FUORI STAGIONE” DI ANNA ALBERTARIO E LUISA CERETTO di Marcello Cella
Un documentario di Anna Albertano e Luisa Ceretto, “Daniel Schmid, un racconto fuori stagione” ricorda l’opera del cineasta svizzero tedesco, morto nel 2006, attraverso le sue parole.
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
Un “Panorama Libri” con segnalazione-recensione di volumi relativi a Bernardo Bertolucci, Peter Cushing, Giuliano Montaldo e Federico Fellini.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
KIRK, LA STAR SENZA PAURA
di Francesco Saverio Marzaduri
“Per raggiungere un obiettivo devi essere abbastanza coraggioso da fallire.”
KIRK DOUGLAS
Non si scappa. Per ogni cinefilo, anche non specialista del “milieu” hollywoodiano, ripensare a Kirk Douglas comporta rituffarsi a caldo in quell’“entourage” dalla superficie dorata e dagli allettanti tentacoli, in cui è faticoso non lasciarsi tentare dal fiabesco. E, va da sé, fingendo di non sapere che zucchero e panna in superficie nascondano una più amara e all’occorrenza velenosa sostanza. L’occasione per farlo è adesso. Ora che l’ultimo dei leoni della vecchia guardia ci ha lasciati, superando il secolo all’età di 103 (più anziana di cinque mesi, Olivia de Havilland l’avrebbe raggiunto poco dopo), senza dar torto all’opinione generalmente più diffusa in questi casi: l’immortalità non è talvolta un’utopica concezione. Un’occasione d’oro giacché ripensare a Douglas, alla sua indimenticabile maschera spavalda e spaccona – dunque perfetta per confezioni di genere dall’avventuroso allo storico, al mitologico – comporta un altolà. Chi ritiene che quella fisionomia da egocentrico fegataccio costituisca un “unicum” con la solita opinabile ideologia “all american”, deve presto ricredersi ragionando in termini di contraddizione del sistema – e a testimoniarlo basterebbero le assidue discussioni col “Duca” John Wayne, suo partner in quattro pellicole.
Certo, al culmine della carriera, neppure Douglas si è esentato dai capricci innescati dai parametri del “System”: celebri gli aneddoti sulla lavorazione di “Spartacus”, prodotto dall’interprete, che litigò col regista inizialmente sotto contratto, Anthony Mann, per poi licenziarlo e sostituirlo col giovane Kubrick, del quale aveva testato il grande talento accettando di recitare in “Orizzonti di gloria”. Ma l’accennata contraddizione trova fondata radice nella coriacea caparbietà del divo a riabilitare (e tenersi ben stretto) l’ostracizzato nome dello sceneggiatore Dalton Trumbo, sino allora marchiato dal maccartismo, facendolo comparire dopo anni nei titoli di testa del “kolossal”. Facile intuire come tale smentita non sia frutto del Caso, e ripensando alle prove di Douglas lungo il decennio Cinquanta, probabilmente il migliore d’una proliferante filmografia, foga e passione ben si abbinano all’operazione-“pamphlet” tesa a denunciare i contrasti a stelle e strisce. Sicché il cinico cronista a caccia di scoop di “L’asso nella manica”, che trasforma una missione di salvataggio in una sfarzosa mega-parata, o l’ineffabile “tycoon” de “Il bruto e la bella” deciso a realizzare il film del rilancio, disposto a servirsi di chi ha troncato ogni rapporto con lui essendosi lui già bassamente servito di loro, risultano aspetti comparabili di un’identica frenesia paradigmatica, carente di scrupoli e pronta all’altrui sacrificio, all’occorrenza non privo di vittime, pur di raggiungere l’eternità del successo. Impossibile non distinguere la presenza della star dai menzionati libelli, proprio perché la sua magna invadenza, di titanico sapore wellesiano, è il turbo nel quale si concentrano egoismi e meschinità del mondo di cui fanno parte. Non sono gli unici casi in cui l’intensità di Douglas sfodera articolate sfaccettature tutte diversamente venate di rabbia, e, benché non insensibile ad ambigue caratterizzazioni in “B-movies” di classe, i ruoli da indomabile ostinato che non arretra dinanzi a nulla sono i meglio impressi nella memoria collettiva.
Ciò non significa che l’antieroe irriducibile, da “Il grande campione” a “L’uomo senza paura”, vada stretto a una sfera intimista e dolente, non esente da tratti autobiografici: lo dimostrano la personificazione di Jim O’Connor nella trasposizione de “Lo zoo di vetro”, o il prestigiatore sopravvissuto alla Shoah de “I perseguitati”. E nel ritratto di Van Gogh, offerto per Minnelli in “Brama di vivere”, la contaminazione tra lacerazione interiore e luce estatica, in precario equilibrio tra via di Damasco e baratro della follia, è pressoché perfetta, fatta eccezione per qualche iconografia o vezzo di troppo, come da usuale standard hollywoodiano. Il western è il genere che più s’addice alle corde dell’attore, consentendogli di alternare ruoli da irresistibile “villain”, incallito giustiziere o pentito cacciatore di indiani, e inevitabilmente confrontarsi col mito della frontiera. Ma in “Solo sotto le stelle”, malinconico apologo sulla fine d’un mondo, all’effigie del cowboy tutto muscoli si sovrappone il suo amaro bilancio su quanto ha vissuto e come, e su quanto gli resta, tra il classico Prima e il crepuscolare Poi (“gli audaci sono soli”, declama il titolo originale). E un’altra bella parabola, “Quattro tocchi di campana”, una decina d’anni dopo presenta una duplice variante d’epilogo. “Reboot” al contrario del citato “Il bruto e la bella”, “Due settimane in un’altra città” restituisce una seconda possibilità a chi, facile pedina di esistenziali debolezze, reitera i medesimi errori e – parafrasando l’omonimo sottostimato film di Kazan – il “compromesso” della circostanza permette una psicanalitica disamina in cui il flusso della memoria assurge a motore.
Se dai primi anni Settanta in avanti la galleria di personaggi offerti da Douglas via via si dirada, la scelta di limitare le apparizioni sul grande schermo è ripagata da un’influenza patriarcale non meno invasiva e appassionata, in particolare sul primogenito Michael, e dalle campagne umanitarie condotte attraverso i media, talora coronate da trionfo. Ma anche in prodotti bellici o spionistici, dove il ruolo rivestito non necessariamente collima con un’istintiva empatia, il principio è fattore-cardine cui sprezzante tener fede sino in fondo, con ogni mezzo necessario, bastevole a dare dei tanti sguardi del divo un “fil rouge” idealista senza concessioni. Perfino a prova di tempo, rimettendo in gioco il proprio “sex appeal” senza scalfirlo (pensiamo al fracassone “Fury”) o giocandoci burlescamente sopra (il bizzarro “I cinque volti dell’assassino”). Così, chi scrive non può non restare ancorato all’icona del colonnello Dax, forse la prova più completa di Kirk, nel proprio strenuo, vano tentativo di salvare dalla fucilazione i tre soldati scelti dall’accusa di codardia. Ruolo che in un certo senso si trova a replicare ne “La città spietata” – e il cui nome anagrafico, Steve Everett, è curiosamente ripreso anni dopo dal giornalista Eastwood in “Fino a prova contraria”. Chi non s’abbandonerebbe alle lacrime quando quel “magnifico ceffo da galera” fa sì che al plotone si conceda un ultimo momento di universale fratellanza? Una ragione, nel suo tutto, per cui l’Olimpo dei giganti gli spetti di diritto.
SAGGI
PETER CUSHING, L’AMORE OLTRE LA VITA
di Mario Galeotti
L’attore Peter Cushing, inglese purosangue, scomparso nel 1994 all’età di ottantuno anni, è noto in tutto il mondo per aver interpretato un numero considerevole di film dell’orrore. Nonostante la sua versatilità e le precedenti carriere di attore teatrale e divo del piccolo schermo nel Regno Unito, Cushing è universalmente associato al genere horror. Uno strano destino, se così si può dire, visto che i suoi gusti personali erano orientati verso tutt’altro tipo di film, come le commedie e i western, e che nella vita privata era un uomo talmente buono e mansueto che la celebre rivista statunitense di cinema di fantascienza e dell’orrore, «Famous Monsters of Filmland», coniò per lui un soprannome che gli calzava a pennello: Saint Peter.
Insieme al collega e amico Christopher Lee, anche lui inglese ma con sangue italiano da parte di madre, Peter Cushing è stato uno dei volti più rappresentativi della Hammer, la piccola casa di produzione cinematografica britannica che a metà degli anni Cinquanta aveva tentato con fortuna la strada della fantascienza e dell’horror.
Il primo ruolo affidato a Cushing dalla Hammer fu quello del Barone Frankenstein nel film “La maschera di Frankenstein” (“The Curse of Frankenstein”, 1957), inaugurando un ciclo di pellicole dirette nell’arco di quasi vent’anni da Terence Fisher (“La vendetta di Frankenstein”, “La maledizione dei Frankenstein”, “Distruggete Frankenstein!”, “Frankenstein e il mostro dell’inferno”) che rivendicavano la centralità del personaggio dello scienziato, dopo che invece negli anni Trenta, a Hollywood, la Universal lo aveva relegato in secondo piano preferendo privilegiare la mostruosa creatura originata dai suoi esperimenti e resa celebre dal make up di Boris Karloff. Poi arrivò il personaggio di Van Helsing, il tenace avversario del Dracula magnetico e carnale impersonato da Christopher Lee in un altro film di Fisher, “Dracula il vampiro “(Dracula, 1958). Seguirono molti altri ruoli, per la Hammer e per altre case di produzione specializzate in storie horror: Amicus, Tyburn, Tigon. Ma, va detto, Peter Cushing sosteneva con convinzione che per il genere di film che lo avevano reso famoso in tutto il mondo bisognasse usare il termine “fantastico” e non “orrore”. L’orrore era da ascrivere ai crimini della realtà di tutti i giorni. “Per me un film horror è qualcosa tipo “Il Padrino” o le storie di guerra”, diceva Cushing, “sono le cose accadute per davvero alla gente, e che ancora accadono, mentre i film cosiddetti dell’orrore sono fantasie che fanno evadere lo spettatore” (J. Brosnan, “The Horror People”, Macdonald and Jane’s 1976, p. 181). Era indispensabile, secondo lui, distinguere le favole gotiche e allegoriche del fantastico dalle vere storie d’orrore, quelle prese dalla vita quotidiana.
Sul grande schermo Cushing ha incarnato ruoli positivi ed eroici, ruoli più controversi carichi di un fascino ambiguo e, nonostante la sua amabile personalità di uomo mite e sensibile, ha saputo anche dare un volto credibile al Male, soprattutto quando dall’inizio degli anni Settanta, dopo la scomparsa prematura dell’amatissima moglie Helen nel gennaio del 1971, l’attore si fece sempre più emaciato, di una magrezza sconcertante che ne alterò i lineamenti. Il suo viso scavato e la presenza spigolosa, specchio di una sofferenza interiore, si prestarono bene alla caratterizzazione, ad esempio, di rigidi e spietati ufficiali nazistoidi e in particolare al ruolo del gelido Grand Moff Wilhuff Tarkin, il comandante dell’Impero Galattico a capo della stazione spaziale Morte Nera nel primo capitolo di “Guerre stellari” di George Lucas (“Star Wars”, 1977).
Il lutto che colpì Cushing nel pieno della sua carriera e che lo sprofondò in un inferno molto più tragico di quello dei mostri che popolavano i suoi film, è indubbiamente uno dei momenti cruciali della sua storia di uomo e di artista. Con la dipartita di Helen, la cui salute era sempre stata cagionevole a causa di croniche complicanze respiratorie, nulla fu più come prima. Da quel momento Cushing visse nell’attesa di ricongiungersi a lei per l’eternità.
Quel tragico 14 gennaio del 1971, nelle ore che seguirono la morte di Helen, Cushing si recò sulla spiaggia deserta di Whitstable, la deliziosa cittadina del Kent dove la coppia viveva. Soffiava un forte vento. Guardò il cielo e cominciò a canticchiare “happy birthday to you”. “Penso di essere uscito di testa”, confessò lui stesso a distanza di anni (P. Cushing, An Autobiography, Weidenfeld and Nicolson, London 1986, p. 142). Un foglio di giornale portato dal vento si fermò sulle sue gambe. Con un gesto meccanico, lo prese e se lo mise in tasca piegandolo, senza guardare cosa fosse. Tornato a casa, si mise a correre su e giù per le scale il più velocemente possibile, nel vano tentativo di farsi venire un infarto. Poi, frugando nelle tasche in cerca delle sigarette, trovò quel pezzo di giornale raccolto in spiaggia. Era una pagina del «Daily Telegraph». Come per un segno del destino, lo sguardo cadde su una citazione del Vangelo: “voi ora siete tristi, ma io vi rivedrò, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà rubarvi la vostra gioia” (Gv 16, 22). Era come se, attraverso quei versi, da lassù Helen volesse consolarlo.
Nelle settimane successive, lo strazio per la perdita della moglie lo portò più volte a contemplare il suicidio. Girovagando ogni giorno in bicicletta, se ne andò perfino nei boschi in cerca di qualche fungo velenoso da ingerire. Ma non trovò mai il coraggio di togliersi la vita. Era sempre stato molto religioso e la sua incrollabile fede lo poneva di fronte alla consapevolezza che Dio non avrebbe mai tollerato un gesto simile. E poi, a distoglierlo definitivamente dal suo disperato proposito, c’erano le dolci parole rivoltegli da Helen nella sua ultima lettera:
“Fai risplendere ancora il sole nel tuo cuore e non struggerti per me, mio adorato Peter, perché questo causerà solo male e inquietudine. E non essere ansioso di lasciare questo mondo, perché non te ne andrai finché non avrai vissuto per intero la vita che ti è stata destinata. E ricorda sempre, noi due ci incontreremo ancora, quando sarà il momento… questa è la mia promessa” (P. Cushing, Past Forgetting. Memoirs of the Hammer Years, Weidenfeld and Nicolson, London 1988, pp. 17-18).
Alcuni versi che lui le aveva dedicato nel 1968 in occasione delle nozze d’argento dicevano: “senza te, questo mondo sarebbe un luogo triste e solitario e io non sarei nessuno”. Fu davvero così. Per Cushing, il mondo divenne un luogo triste e solitario. Il lutto segnò “la conclusione della sua vita nel senso pieno del termine e l’inizio dell’attesa per ritrovare Helen” (F. Pezzini – A. Tintori, Peter & Chris. I Dioscuri della notte, Gargoyle, Roma 2010, p. 283). Ma accettò il destino con rassegnazione e trovò conforto nel sostegno di tanti amici e nelle gratificazioni del suo lavoro, sul quale decise di buttarsi a capofitto almeno fino alla metà degli anni Ottanta.
Un aspetto interessante di questa triste storia, e su cui vogliamo soffermarci nel nostro articolo, consiste nel fatto che la grave perdita che colpì Cushing ne condizionò, per certi versi, anche il percorso artistico: non soltanto per una sempre più evidente gracilità fisica che come abbiamo già detto orientò in parte la scelta dei ruoli da affidargli, ma anche perché alcuni personaggi portati sullo schermo da Cushing nel corso degli anni Settanta riproponevano, con strabiliante analogia, il dolore e la solitudine realmente vissuti dall’attore dopo la morte di Helen. Un chiaro esempio ci è fornito dal film a episodi “Racconti dalla tomba” (2Tales from the Crypt”, 1971), prodotto dalla Amicus e diretto da Freddie Francis. L’episodio “Poetic Justice” ci regala un Peter Cushing strepitoso, commovente, nel ruolo di un uomo anziano e solo le cui malinconiche sfumature rimandano inevitabilmente alle vicende personali dell’attore.
In Racconti dalla tomba cinque turisti (interpretati rispettivamente da Joan Collins, Ian Hendry, Robin Phillips, Barbara Murray e Nigel Patrick), in visita ad alcune catacombe, restano intrappolati in una camera segreta e l’austero custode mostra a ognuno di loro il tragico destino che li attende a causa della loro malvagità.
A Cushing era stato inizialmente offerto il ruolo del marito nell’episodio “Wish You Were Here”. Gli sottoposero la sceneggiatura, ma quella parte (che alla fine sarebbe andata a Richard Greene) non gli piacque. Mostrò interesse, invece, per il ruolo di Arthur Grimsdyke in “Poetic Justice” e chiese alla produzione di fare cambio. Fu una scelta saggia, perché, al contrario del personaggio pensato per lui all’inizio, Grimsdyke gli apparteneva nell’intimo e Cushing riuscì a tratteggiarlo con minuziosità.
L’attore ha ricordato al riguardo:
“Nella sceneggiatura originale, tutte le sue battute le diceva parlando a se stesso, dal momento che dopo la morte della moglie viveva come un recluso, in compagnia solo del suo fedele cagnolino. Una figura triste e solitaria, ma la cosa non mi sembrava verosimile. Presi ispirazione dalla mia personale esperienza, visto che io stesso mi trovavo in una situazione simile, fatta eccezione per il cane. Così decisi che alcune delle sue battute le potevo rivolgere all’animale, come succede spesso nella vita reale, ma per le altre avevo bisogno di qualcosa di diverso. A casa c’era una fotografia di Helen appesa al muro sopra la mia scrivania e nei tristi giorni che seguirono alla sua morte mi trovavo spesso a guardarla e a parlarle. Pensai che questa poteva essere la soluzione con il mio problema con Grimsdyke, e Freddie Francis, che dirigeva il film, fu pienamente d’accordo. Non usammo la fotografia di Helen, perché non sarebbe stata la scelta giusta, ma trovammo una faccia adeguata e la mettemmo in una cornice di legno, cosicché l’anziano signore che interpretavo poteva guardarla spesso e meditare” (P. Cushing, Past Forgetting, cit., pp. 35 – 36).
Arthur Grimsdyke che parla con la foto della moglie chiamandola “mio amore” è, senza dubbio, anche Peter Cushing. Chi conosce la sua vita privata e il trauma subìto con la scomparsa dell’adorata Helen, non può fare a meno di commuoversi vedendolo recitare nella parte di un vecchio che continua a vivere nella stessa casa dove viveva con la moglie Mary Helen (evidente richiamo alla vera Helen), morta da più di dieci anni, parla con il suo ritratto e a volte cerca di mettersi in contatto con lei nell’aldilà con bizzarre sedute spiritiche che compie in solitudine per ricevere messaggi dalla sua amatissima. E infatti è lo spirito di Mary Helen che, in una di queste sedute, detta alla mano incontrollata del consorte la parola “danger”, mettendolo in guardia su un incombente pericolo. Quel pericolo si chiama James Elliot (interpretato da Robin Phillips), il cattivo vicino di casa, di famiglia benestante, che per snobismo e gelosia vuole a tutti i costi mettere Grimsdyke nelle condizioni di andarsene dal quartiere.
I bimbi del vicinato adorano il vecchio Grimsdyke. Gli fanno visita regolarmente e lui li intrattiene con storielle e giochi, e regala sempre a ciascuno di loro vecchi giocattoli che lui stesso ripara. Ha un cuore d’oro ma il suo aspetto, probabilmente da quando è mancata la moglie, è alquanto trasandato: barba incolta, un berretto di lana blu con pompon, un cardigan consumato, guanti a mezze dita, pantaloni con l’orlo mal cucito. Ha un cagnolino che gli fa compagnia e nel giardino ha allestito un piccolo recinto dove offre rifugio a cani randagi. Consuma sempre i suoi pasti davanti al portaritratti con la foto della moglie. Vicino alla fotografia c’è un vasetto coi fiori e lui, notando che sono ormai appassiti, le promette che gliene avrebbe raccolti di nuovi. Ma nonostante l’indole mansueta e dolce dell’anziano Grimsdyke, James Elliot non sopporta la sua presenza, è convinto che abbassi il prestigio di quel quartiere. Lo spia di continuo dalla finestra, desiderando fortemente che metta in vendita la sua casa e se ne vada per sempre. Così comincia a compiere una serie di azioni bieche per costringerlo a traslocare. Di notte esce di soppiatto per distruggere le preziose rose di un giardino attiguo, in modo che incolpino i cani di Grimsdyke e glieli portino via con la forza. Poi, sfruttando le proprie conoscenze, fa in modo che perda il lavoro, anche se ormai prossimo al pensionamento. Cerca di metterlo in cattiva luce facendo ambigue allusioni sulla sua abitudine a frequentare i bambini, tanto che le mamme, allertate dalle menzogne del rancoroso Elliot, proibiscono ai rispettivi figli di frequentare ancora l’anziano vicino. “Niente più lavoro, niente più bambini…”, esclama Grimsdyke. “Non importa”, continua rivolgendosi al volto della defunta compagna, “ci siamo io e te, vero amore mio? Solo questo importa!”. Infine, il giorno di San Valentino, Elliot spedisce al suo indirizzo alcuni biglietti d’auguri, ciascuno dei quali contiene un crudele messaggio in rima, facendogli credere che provengano tutti dagli altri abitanti del quartiere, scontenti della sua presenza ingombrante. Grimsdyke li legge con le lacrime agli occhi. Tanta perfidia lo spinge al suicidio. Dopo una settimana, non vedendolo più uscire di casa, il cattivo James Elliot e suo padre, Edward Elliot (interpretato da David Markham), insospettiti si introducono nell’abitazione di Grimsdyke e lo trovano impiccato a penzoloni. Ai suoi piedi il ritratto della cara moglie, cadutogli di mano dopo che, verosimilmente, aveva voluto stringerlo a sé per l’ultima volta prima del gesto estremo. Il ricco Edward Elliot si offre di pagare i funerali. Trascorso un anno esatto, il giorno di San Valentino Arthur Grimsdyke ritorna dall’oltretomba per compiere vendetta. Il suo corpo scheletrico riemerge dalla terra in cui era stato seppellito, di notte, e si dirige verso la lussuosa dimora degli Elliot, dove il perfido rampollo si è intrattenuto nel proprio studio fino a tarda ora. Il mattino seguente, il padre trova il cadavere del figlio riverso sulla scrivania, con accanto un biglietto scritto col suo stesso sangue: “Buon San Valentino. Tu sei stato cattivo e crudele fin dall’inizio. Ora non hai davvero più…” e sotto, senza aggiungere altre parole, il cuore asportato di Elliot, ancora pulsante.
E’ comprensibile che Peter Cushing, data la drammaticità del momento che stava vivendo, sentisse suo il personaggio di Grimsdyke, preferendolo a quello che gli era stato proposto all’inizio. Il dolore e la solitudine li accomunava ed è per questo che Cushing ha voluto prendere spunto dalla propria esperienza, supplendo alle mancanze della sceneggiatura. “Grimsdyke è una creazione struggente, tracciata meticolosamente e interpretata con cura e sottigliezza”, ha scritto Luigi Cozzi (L. Cozzi, a cura di, Peter Cushing. Dalla Hammer a “Guerre Stellari”, Mondo Ignoto/Profondo Rosso, Roma 2003, p. 211).
Un altro film dove le inquietudini del personaggio interpretato da Peter Cushing ricordano in parte l’autentica solitudine dell’attore rimasto vedovo è “Il terrore viene dalla pioggia” (“The Creeping Flesh”, 1973), diretto da Freddie Francis e prodotto dalla Tigon. Al fianco di Cushing troviamo anche Christopher Lee, che in un ruolo meno preponderante ma comunque indispensabile propone uno dei suoi tipici personaggi altezzosi e glaciali, di cui Cushing, vero protagonista della storia, sembra il contraltare più umano e sensibile, ma a tratti anche molto ambiguo.
Nel film recitava la giovane Lorna Heilbron, che ha ricordato come l’attore fosse arrivato sul set, il primo giorno di riprese, con il copione ricoperto di annotazioni scritte a penna. Certi appunti erano semplicemente dei promemoria su come caratterizzare il proprio personaggio, cosa fargli fare e cosa no, quali oggetti di scena sarebbero stati più appropriati. Ma sparse qua e là c’erano anche tenere espressioni della sua vita di coppia con Helen, come la parola “Bois”, il nomignolo con cui la moglie si divertiva a chiamarlo, o “Eggy” che invece era l’affettuoso soprannome che lui riservava a lei. La Heilbron rimase molto affascinata dalle maniere gentili di Peter Cushing e dall’atteggiamento paterno che dimostrò nei suoi confronti. Ma si accorse anche di come appariva triste e vulnerabile in quel periodo: “ogni tanto si allontanava per fare una passeggiata da solo”, ricordò l’attrice, “e secondo me anche per farsi un bel pianto” (M. A. Miller, Christopher Lee and Peter Cushing and Horror Cinema. A Filmography of Their 22 Collaborations, McFarland & Company, 1995, 1995, p.308).
Sullo sfondo della Londra vittoriana, il professor Emmanuel Hildern (Cushing) e James Hildern (Lee) sono due fratellastri, entrambi studiosi, animati da una recondita rivalità che inevitabilmente si inasprisce quando decidono di concorrere tutti e due al prestigioso premio Richter per la ricerca scientifica. James dirige un ospedale psichiatrico, dove scopriamo essere stata rinchiusa da molti anni la moglie di Emmanuel, Marguerite (Jenny Runacre), ex artista di varietà francese, ora deceduta proprio in quel manicomio. James sta lavorando, in vista del premio, a un volume sulla causa e la prevenzione dei disordini mentali. Emmanuel, invece, sta compiendo ricerche sul Male inteso come “organismo vivente”, come “un morbo che affligge l’umanità alla pari del colera o del tifo”, una malattia che può essere curata e prevenuta. In seguito al ritrovamento in Nuova Guinea di un gigantesco scheletro che precede l’uomo di Neanderthal (ma sembra stranamente più evoluto) e che in caso di contatto con l’acqua vede riformarsi i tessuti, dopo vari approfondimenti Emmanuel scopre di essere di fronte ai resti di un’antica entità malvagia e si convince di poter isolare, attraverso la carne di un dito della creatura accidentalmente rigeneratosi con l’acqua, il bacillo del Male. Se, dunque, il Male è un’infezione, allora è possibile creare un vaccino. Iniettando sull’uomo una minima quantità di siero ricavato dalle cellule maligne, tutti potranno diventare immuni da ogni impulso malevolo. Angosciato dal dubbio che sua figlia Penelope (Lorna Heilbron) possa ereditare la pazzia della madre, Emmanuel decide di iniettarle il siero, senza però averlo prima testato a sufficienza. Gli effetti sono devastanti e Penelope comincia ad aggirarsi di notte per i quartieri malfamati di Londra, in atteggiamenti libertini che ricordano quelli della madre descritti nel flashback in cui Emmanuel torna con la memoria alla giovane Marguerite prima che si ammalasse. E vedendo i trascorsi di sua moglie, ballerina irrequieta, lo spettatore è legittimamente assalito dal dubbio che l’uomo l’avesse fatta rinchiudere per la sua condotta lasciva e i continui tradimenti. Ma, d’altra parte, la pazzia, di cui la vediamo preda (nei ricordi di Emmanuel) nelle ore che avevano preceduto il ricovero, potrebbe essere vera, provocata da una malattia venerea contratta plausibilmente in seguito ai ripetuti rapporti sessuali avuti da Marguerite con uomini diversi. L’infermità mentale, ora, sembra aver assalito anche la giovane Penelope, ma non per un fattore ereditario, piuttosto per colpa del vaccino sperimentato su di lei dal padre. Dopo che la ragazza, prelevata con forza a causa della sua improvvisa aggressività, è stata portata al Hildern Institute for Mental Disorders, James la riaccompagna a casa del fratello. Curiosando nel laboratorio vede lo scheletro e legge alcuni appunti. Dopo un’accesa discussione con il sopraggiunto Emmanuel, James gli sottrae di nascosto le carte e medita di rubare il sensazionale reperto rinvenuto in Nuova Guinea. Nell’ultima parte del film Cushing e Lee dimostrano ancora una volta che “nessun’altra coppia di attori è riuscita a raggiungere lo stesso livello raffinato di credibilità nello scontro tra i rispettivi personaggi” (M. A. Miller, Christopher Lee and Peter Cushing and Horror Cinema, cit. p. 306). Come ha scritto Rudy Salvagnini, dopo il furto dello scheletro da parte di James si ha un crescendo “realizzato attraverso parecchie scene di forte carica evocativa” (R. Salvagnini, Christopher Lee, Peter Cushing e Terence Fisher: due amici e chi li ha fatti conoscere, in: F. Zanello, a cura di, Christopher Lee il principe delle tenebre, Profondo Rosso, Roma 2008, p. 38). Ma alla fine si scopre che tutto il film è il racconto fatto da Emmanuel, ricoverato in manicomio, a un giovane dottore nella speranza che gli creda. Lo spettatore rimane nel dubbio. E’ stato veramente rinchiuso dal fratellastro, che ha potuto così appropriarsi delle sue scoperte scientifiche aggiudicandosi il premio Richter? Oppure l’intero racconto è solo frutto della fantasia delirante di un povero pazzo?
Nel film “Il terrore viene dalla pioggia” c’è una scena struggente sulla quale è doveroso soffermarsi. Il vedovo Hildern, uscito dal laboratorio, sente il suono del pianoforte e, sconvolto, crede di riconoscere il tocco della defunta moglie Marguerite. In preda al turbamento sale le scale e, entrato nella stanza che fu della donna, vede una figura femminile di spalle seduta al piano, con gli stessi abiti da ballerina di music hall ch’erano appartenuti alla moglie. Piangendo sussurra “Marguerite! Marguerite!” e, avvicinandosi, le sfiora amorevolmente le spalle. Lei si gira di colpo, interrompendo bruscamente di suonare, e vediamo così che si tratta della figlia, alla quale era stato sempre interdetto fin da bambina di entrare in quella stanza e che per la prima volta ha disubbidito, spinta dal desiderio di penetrare nell’evanescente mondo di una madre soubrette di cui ha solo un lontanissimo e sbiadito ricordo. Il dolore e l’agitazione del protagonista in lacrime sono talmente reali che non si può fare a meno di ricondurli al dramma interiore di Cushing, ancora sconvolto dalla recente perdita. E’ una sequenza toccante, soprattutto per i più assidui ammiratori dell’attore che ne conoscono bene le vicende private.
Il frequente gioco di scambi emotivi tra il malinconico Cushing e i personaggi portati sul grande schermo nei primi anni Settanta trovò completamento nel film “The Ghoul” (1974), diretto ancora da Freddie Francis e prodotto dalla Tyburn Film Productions, la casa di produzione fondata da Kevin Francis, figlio di Freddie. Cushing impersonava il dottor Lawrence, rimasto vedovo dopo il suicidio della moglie in India.
L’attore, come già in “Racconti dalla tomba”, non poteva fare a meno di percepire un fondo di patimento che lo accomunava al personaggio e volle delinearlo in modo personale. Chiese a Francis padre e Francis figlio, con i quali aveva un ottimo rapporto, di poter usare in scena una fotografia di Helen a rappresentare nella finzione la defunta moglie del protagonista. Regista e produttore acconsentirono con piacere. In un articolo pubblicato su Photoplay (K. Ferguson, My grisly afternoon with The Ghoul, in Photoplay, vol. 25, n. 7, luglio 1974), al giornalista intervenuto sul set di “The Ghoul” l’attore spiegava proprio l’origine delle due fotografie, racchiuse in cornice, utilizzate nel film nello studio del personaggio interpretato da Cushing. Una ritraeva lo stesso Peter Cushing all’età di diciannove anni, che doveva essere il figlio del protagonista, l’altra era una foto di Helen quando aveva trentatré anni. “Ce ne parla in maniera davvero toccante”, si legge nell’articolo, “solo lavorando molto, passando da un film all’altro, è riuscito ad andare avanti anche senza di lei, perché quando Helen è morta una parte di Peter è morta insieme a lei”. Ma nello stesso tempo, aggiungiamo noi, una parte impalpabile di lei ha continuato a stargli vicino in questo mondo, per tutti gli anni che a Cushing erano rimasti da vivere: storia struggente di un amore proseguito intatto oltre la vita.
GONE WITH HOLLYWOOD
di Francesco Saverio Marzaduri
La scomparsa di Olivia de Havilland, ultima diva ancora in vita della Grande Hollywood dorata, era purtroppo qualcosa di atteso. Come per Kirk Douglas, più giovane di cinque mesi e mancato poco prima. Scompare lei, e scompare definitivamente un mondo: una bolla di sapone lunga più d’un secolo, cui non resta che sopperire con la memoria, ed eventualmente con le suggestioni del mito. E com’è consuetudine del web, nel salutare calorosamente una stella entrata nel collettivo immaginario per un ruolo (superfluo dire quale…), la tornata di messaggi in cui ci s’imbatte suona più leggendaria delle interpretazioni da questa offerte; nella fattispecie, quando la celluloide e la sfera privata si fondono sino a formare un singolare “unicum”. Ecco allora che Olivia Mary – questo il nome anagrafico – è il dolce e suadente contraltare dell’irruente guasconeria di Errol Flynn in sette titoli griffati Warner, molti dei quali (“Capitan Blood”, “La carica dei seicento” e “La leggenda di Robin Hood”) divenuti dei classici. Già figlia d’arte, l’apparizione che ne rivela le doti d’attrice è però l’imminente sposina Ermia, nella magica trasposizione del “Sogno di una notte di mezza estate”, firmata dal regista teatrale Max Reinhardt, e da William Dieterle in qualità di consulente cinematografico. Proprio tale dolcezza, coniugata allo “charme” di figurina incantevole ed esuberante (la medesima che, in “Bionda fragola”, le permette di far colpo su James Cagney giusto fumando una sigaretta), è una sottile linea rossa da non prendere alla lettera, benché agevoli nella lettura d’un “milieu” così colorato e fiabesco, in superficie, da non riuscire del tutto a nascondere sfaccettature ambigue. Certo, la cronaca rosa tuttora sguazza nella realtà fattasi leggenda dell’eterna competizione con la sorella minore Joan Fontaine (e a cui Olivia soffiò una delle due conquistate statuette), costituita da reciproci dispetti, equivoci, litigi, riconciliazioni, e terminata una volta per tutte con la scomparsa di Joan. Ma l’“unicum” cui s’accennava s’incarna negli ambigui ruoli di creatura indifesa dove il “mélo” va a braccetto col “noir”. Se “La porta d’oro”, dallo “script” targato Billy Wilder e Charles Brackett, le frutta l’Oscar nelle vesti d’una maestrina infatuata d’un avventuriero ex “gigolo”, è il ruolo della giovane affetta d’amnesia, internata nella “fossa dei serpenti” d’un istituto manicomiale, a sdoganare il tema della follia denudando virtù e difetti del contesto sanitario, come le implicazioni sociali che ne scaturiscono, servita da un’asciutta struttura a flashback. E prima che William Wyler le regali la parte, anche questa premiata, della timida ereditiera di Henry James corteggiata dal cinico arrivista Montgomery Clift, il “double face” della personalità di Olivia sprigiona a tutta forza, ne “Lo specchio scuro”, in una coppia di gemelle d’opposto carattere (“topos” che lo stesso De Palma riprenderà molto dopo), la cui multipla presenza è assecondata dal gioco di superfici riflettenti senza consentire alla polizia di stabilire l’incriminazione d’un delitto per la reticenza di ambedue, prima del sorprendente “coup de théâtre” finale. Va da sé che il forte legame con Bette Davis, altro mostro sacro dalla spigolosa personalità, la mette a proprio agio, oltreché nel melodramma, nelle pellicole in costume o in quelle a metà strada fra il thriller e l’horror grottesco. E risulta più facile, in “Un giorno di terrore”, inquadrare l’intensa “performance” della ricca vedova prigioniera di un ascensore che un blackout tramuta in gabbia, alle prese con un interminabile delirio che, senza risparmiare nessuno, ne fa un’inerme vittima in balia degli eventi. Soprassedendo sulle immancabili, occasionali partecipazioni in età ormai avanzata – la sovrintendente scolastica nel fantascientifico “Swarm” o la passeggera nella terza puntata del catastrofico “Airport” – è a questa de Havilland, più ancora che a Melania, che occorrerebbe ripensare nell’esegesi d’un interprete intelligente e ambiziosa (“La gente famosa crede di doversi trovare sempre sulla cresta dell’onda”), la cui scaltrezza permette di rifiutare mediocri copioni, in prevalenza parti uniformi e piatte, sfidando il sistema di grandi case produttrici in tempi in cui la legge permette la sospensione dei contratti. Sicché le prove più mature da tragica protagonista (come la ragazza-madre di provincia in “A ciascuno il suo destino”, indotta, a causa dell’imperante perbenismo, ad accudire il figlio a distanza), ostentano la capacità di ribellarsi al conformismo vigente dentro e fuori, trascendendo ogni fantasia, sopravvivendo a tutto fuorché all’ineluttabile Fato. Che da par suo, indirettamente le ha concesso di assistere alle tragicomiche qualifiche razziste a “Via col vento”, e addirittura alla sua cancellazione dai listini HBO. Il resto, inclusa la diceria secondo cui avrebbe “doppiato” Vivien Leigh nel dar di stomaco, appartiene a una leggenda: eclissatasi per sempre, come lei.
99 DONNE E OLTRE. IL FLORIDO DIVISMO ITALIANO DI “SERIE B” SVANITO, SEPOLTO E POI (RI)IDOLATRATO
di Roberto Baldassarre
Quando si cita il divismo cinematografico, subitaneamente torna alla mente lo Star System che ha fatto brillare Hollywood per molte decadi. Un nodale e proficuo ingranaggio per un’industria “spaccia” miti, nella quale ogni casa di produzione aveva nella scuderia i propri purosangue, ovvero dive o divi di razza. Certamente le Star sono state anche lancinanti spine nel fianco per le produzioni, per i forti poteri contrattuali ottenuti che sconfinavano sovente in semplici bizze vanesie, ma con il loro carisma, spesso costruito ad hoc, hanno creato la necessaria fidelizzazione spettatoriale per il continuo e sicuro smercio dei prodotti cinematografici. Un’operazione di marketing che, sebbene con altre modalità, funziona a tutt’oggi, in cui un film ha ottime possibilità di vendita se nel cast c’è la Star del momento. Eppure il divismo, in una forma ancora “acerba”, nacque in Italia durante il periodo del muto, quando dive come Francesca Bertini, Lyda Borrelli, Pina Menichelli e Leda Gys, che con il loro charme avevano sedotto moltitudini di spettatori anche all’estero, conquistarono un autorevole potere decisionale, giungendo a gestire la propria immagine (da intendere come patrimonio) completamente da sole. Questo primigenio divismo italiano è anche una chiara indicazione di come il cinema nostrano sarà lastricato di forti ascendenze femminili che alimenteranno sempre i desideri spettatoriali. Nei periodi successivi, in Italia, il divismo è stato più frammentato, ma ogni decade ha avuto almeno un’icona femminina, raggiungendo un picco intorno agli anni Cinquanta, quando fu coniata la carnale definizione di “maggiorate”, che esemplifica la qualità particolare della diva e il punto d’interesse dove si poserà lo sguardo dello spettatore. Nel panorama italiano ci sono state anche alcune attrici che hanno ottenuto altrettanto ampio successo all’estero, come ad esempio Alida Valli, Sophia Loren o Anna Magnani, e altre grandi che però non sono riuscite a “bucare” altrettanto gli schermi internazionali, tipo Gina Lollobrigida, Silvana Mangano o Monica Vitti, permanendo solamente un fenomeno “nazionale”. Restando sempre in ambito italiano, è giusto narrare di un altro tipo di fecondo divismo femminile, di carattere molto più “usa e getta”, che si potrebbe contrassegnare “divismo di Serie B”. Questa definizione spiccia è per ricollegarlo al Cinemabis, da cui è sorto, e ai “pauperistici” metodi di marketing utilizzati; e, per ricollegarsi alla metafora del cavallo utilizzata all’inizio, in questo caso si tratterebbe di un divismo di ronzini, ossia dive – o divi – con un pedigree attoriale poco pregiato. Chiaramente sono due apparati divistici qualitativamente distanti, ma anche questo divismo di seconda fascia ha creato larga fidelizzazione, essendo le attrici il vero motivo d’interesse nel tessuto filmico che veniva (ri)filato dai produttori agli avventori dei cinema. E se nello Star System maggiore i divi possono, dopo aver ottenuto il potere, gestirsi da soli traendo anche un sostanzioso profitto, sebbene ci siano infiniti casi di stelle finite rovinosamente nelle stalle, nel Cinemabis, che si basa prettamente sul concetto di Exploitation, le stelle e stelline devo assoggettarsi alle effimere mode, e ottenuto un veloce quanto improvviso sbrilluccichio (agli occhi degli spettatori), possono repentinamente ritrovarsi senza niente, e con alle spalle una carriera cinematografica rimasta mediocre. Per essere ancor più diretti, la differenza tra lo Star System di “Serie A” e quello di “Serie B” risiede semplicemente sulla considerazione che le attrici del Cinemabis sono ritenute soprattutto dei corpi da vendere (un tanto al chilo). Non importa la qualità della recitazione, ma contano le forme fisiche e la disponibilità a spogliarsi. Una volta che il corpo dell’attrice si è usurato (per età o per lo sfizio dello spettatore ormai satollo di quel belvedere), viene rimpiazzato da un’altra attrice/corpo più giovane oppure più formosa. Mentre la predisposizione a spogliarsi, concedendo sempre maggior epidermide all’occhio della cinepresa, è stato il fattore più rilevante che ha troncato la carriera di molte attrici degli anni Settanta, soprattutto quando dall’inizio degli anni Ottanta è entrato ampiamente in commercio il cinema porno, facendo svanire il genere erotico soft perché ormai poco soddisfacente. In tale ambito, alle attrici regine o reginette di tale genere, per poter proseguire la propria carriera e continuare a guadagnare, i produttori e/o gli agenti hanno proposto il salto del fossato, e se molte hanno espresso un forte diniego (con “avanzamento professionale” spezzato), altre hanno accettato, usualmente per procacciarsi denaro rapido e “facile” e soddisfare i propri bisogni. Senza dimenticare che altre “divette”, sulla scia di Grace Kelly o Marisa Allasio, una volta instaurata una relazione con un uomo ricco o rispettabile, hanno preferito chiudere la loro precaria carriera di attrici. In tempi recenti, in ogni modo, le dive o divette sopravvissute riappaiono nei programmi televisivi, riciclandosi come concorrenti in Realiy Show, oppure chiamate come ospiti per ricordare la propria carriera e/o parlare delle loro tragedie.
Il divismo femminile di “Serie B” si è espresso prevalentemente durante la decade degli anni Settanta, poiché il quel periodo il Cinemabis fu molto florido, specialmente per la fioritura, concessa dall’allargamento delle maglie della censura, del genere erotico. Già all’inizio degli anni Ottanta il fenomeno si era quasi completamento sciolto, sia perché quel tipo di Cinemabis stava scomparendo, e sia perché le nuove leve proposte non erano veramente ammalianti come le precedenti. Senza dimenticare due importanti fatti concomitanti, sebbene agli antipodi, che hanno cambiato, o spostato, quel tipo di divismo: l’avanzamento delle TV private, che offrivano belle soubrette/divette sempre sorridenti e un poco discinte, e l’espandersi del cinema hard, che proponeva di tutto e di più. Negli anni Novanta, svanito completamente il cinema di genere, ci sono stati, comunque, dei tentativi di creare nuove stelline con pellicole create ad hoc, ma l’esperimento è miseramente fallito. Tornando al prosperoso divismo femminile sorto negli anni Settanta, e per comprendere cosa sia stato per gli spettatori quel periodo definibile “gineceo” cinematografico, può essere utile consultare il volume 99 donne – Stelle e stelline del cinema italiano, curato da Manlio Gomarasca e David Pulici ed edito nel 1999. Il titolo del libro non fa riferimento al numero di dive rappresentate nel tomo, ma è un omaggio cinefilo all’omonima pellicola di Jesús Franco, realizzata nel 1968 e nel cui cast compaiono due stelle del Cinemabis italiano: Rosalba Neri e Luciana Paluzzi. Le donne catalogate sono molto meno numerose (62 nomi), e sono solamente una piccola parte di quel magmatico divismo, perché i due autori hanno voluto fare una precisa scrematura. Gomarasca e Pulici, fondamentali storici del cinema di genere italiano, con studi e analisi caparbiamente portate avanti da quasi un trentennio con la rivista Nocturno, in questo caso hanno preferito far prevalere il loro animo di spettatori, rimasti ammaliati da alcune attrici piuttosto che da altre. Sono loro stessi, per evitare critiche o malumori di lettori o storici, che nell’introduzione spiegano la selezione attuata:
[…] seguire il filo rosso della presenza femminile all’interno dei generi della cinematografia italiana. Ci siamo ben presto resi conto che un lavoro di questo tipo sarebbe risultato, oltre che titanico da realizzare, anche assolutamente impersonale […] senza che ce ne accorgessimo, infatti, 99 donne ha assunto una sorte di vita e di identità autonome e ha preteso di venire composto secondo un disegno non logico bensì puramente emozionale e passionale […]
Maggior interesse è il sottotitolo dato all’introduzione, in cui nella prima parte spiegano, con un solo termine mitologico, cosa hanno rappresentato quelle attrici: delle sirene che con i loro suadenti corpi richiamavano frotte di spettatori; e nella seconda parte fanno notare che quel mondo mitico è ormai scomparso, e per tanto il loro libro/panoramica vuole rievocare alcune di quelle invitanti sirene. Essendo un libro ormai datato, sebbene ancora utilissimo per le informazioni fornite, questa panoramica – o per utilizzare un termine di Tatti Sanguineti, “strisciata” – che segue è per aggiornare o (re)indagare le carriere di alcune dive citate nel libro o aggiunte ex novo.
Come accadeva anche nel cinema maggiore, le stelle da lanciare nel firmamento erotico del Cinemabis venivano “pescate” dal concorso di Miss Italia, ma allo stesso tempo ricca fucina erano i fotoromanzi cartacei, in cui c’erano fascinose donne, riviste patinate di smaglianti modelle discinte, oppure il mondo delle comparse, con belle ragazzotte pronte a diventare rapidamente protagoniste. La massa di pellicole che è apparsa ha cercato di soddisfare le fantasie erotiche del popolo maschile, costruendo storie pruriginose con al centro il corpo scolastico (insegnanti, maestre, professoresse, supplenti, liceali, compagne di banco); i camici bianchi (dottoresse, infermiere, medici donne); abiti talari (suore, monache, novizie, badesse, sacerdotesse); componenti di famiglia e annessi (zie, nipoti, matrigne, mogli, nonne, vedove, amiche di famiglia, governanti, cameriere); rappresentanze istituzionali (soldatesse, poliziotte, pretore, presidentesse). Usualmente già nel titolo era evidenziato il soggetto erotico proposto, ma queste sessuali figure comparivano anche nelle pieghe della trama di moltissime altre pellicole. Nel dare carnalità a queste fantasie si sono scelti, di volta in volta, corpi femminili adatti alla fisionomia che si voleva offrire. Ad esempio, per citare le tre maggiori dive del cinema erotico di quel periodo: Edwige Fenech, prototipo perfetto di maggiorata, non avrebbe mai potuto interpretare una liceale; la nordica e longilinea Barbara Bouchet, signorile nel portamento, era perfetta come moglie o come amante; Gloria Guida, con un fascino quasi adolescenziale, non avrebbe mai potuto interpretare, invece, un’insegnante o una moglie.
Laura Antonelli: divina – e sfortunata – creatura
Una menzione a parte merita Laura Antonelli (1941-2015), divina creatura (per citare l’omonimo film di Giuseppe Patroni Griffi in cui è protagonista) del cinema italiano con uno sfortunatissimo finale di carriera. L’Antonelli, nota anche per la sua tempestosa relazione con Jean-Pierre Belmondo, sarebbe potuta essere una diva totalmente di “Serie A” per le sue buone qualità recitative, come attestano le interpretazioni rese in alcune pellicole di grandi autori (Chabrol, Risi, Comencini, Visconti), ma è stata sfruttata solamente per il suo divino fisico. Si è sedimentato nella memoria degli spettatori il suo fondoschiena nudo esibito ne “Il merlo maschio” (1971) di Pasquale Festa Campanile, e ancor di più la sua prestazione in “Malizia” (1973) di Salvatore Samperi.
Questa pruriginosa analisi della borghesia del sud Italia fu il maggior successo del cinema nostrano della stagione, consacrò le grazie dell’Antonelli e diede la stura al genere di pellicole incentrate su vizi e vizietti di famiglia. Allo stesso modo, però, il film fu per l’attrice (ma anche per l’ex regista sessantottino definito poi autore di pellicole pruriginose) uno stigma indelebile, che la costrinse a recitare usualmente in ruoli erotici. Negli anni Ottanta, quando l’attrice aveva 40 anni e la beltà del suo corpo stava sfiorendo, la sua carriera ormai stava andando al ribasso, costringendola in ruoli secondari oppure a interpretare signore ancora ardenti sotto le vesti. L’ultima pellicola, “Malizia 2000” (1991), che avrebbe dovuto segnare il grande rilancio dell’Antonelli e di Samperi, fu un disastro colossale, rilevando la triste parabola di un’attrice, ritenuta prevalentemente un corpo, che per tornare ai fasti del passato cercò di ringiovanire con il lifting, rivelatosi dannoso per il suo viso e la sua carriera. Certamente c’è anche da mettere in conto, come ha confessato lei stessa, che il deperimento della sua carriera è stato causato anche per la dipendenza alla droga, come accadde per molte altre attrici.
Le 3 sirene maggiori
Decamerotico e commediaccia erotica sono stati i generi in cui hanno germogliato maggiormente le stelle e le stelline degli anni Settanta. Erano film definibili “cotti e mangiati”, girati con bassissimi budget proprio per essere certi di un incasso discreto ma sicuro. Solamente due pellicole di misera produzione riuscirono a sconquassare i botteghini: “Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda” (1972) di Mariano Laurenti, e “Giovannona Coscialunga disonorata con onore” (1973) di Sergio Martino. Queste pellicole, ritenute dei cult, sono ambedue interpretate da Edwige Fenech (1948), sicuramente la diva – erotica – maggiore del periodo, che ha saputo far durare la sua immagine da protagonista, e poi svoltare bene nel seguito della carriera, diventando prima conduttrice televisiva, giungendo a condurre Domenica In (1989-1990), e poi trasformarsi in abile produttrice di fiction televisive. È pur vero che a questo fortunato percorso hanno contribuito le sue storie d’amore, prima con il produttore Luciano Martino e poi quella con l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.
Il mito della Fenech, dopo molti anni dai suoi fasti, è attestato dal Coming out di Walter Veltroni, che a metà anni Novanta rivalutò “L’Ubalda”, e dalle citazioni cinefile rese da due autori americani innamorati pazzi del cinema di genere italiano: Eli Roth in “Hostel: Part II” (2007) fa recitare la Fenech nel ruolo di una bella professoressa dell’accademia di belle arti, omaggiando lontanamente i suoi ruoli sensuali d’insegnante; Quentin Tarantino in “Bastardi senza gloria” (“Inglouriuos Basterds”, 2009) mette il nome Ed Fenech al generale interpretato da Mike Mayers. Barbara Bouchet (1943) si potrebbe definire l’opposto erotico della Fenech, in riferimento all’aspetto fisico.
Anche lei ha preso parte a qualche decamerotico, tra cui il più noto è “Una cavalla tutta nuda2 (1972) di Franco Rossetti, per poi interpretare differenti commedie erotiche in cui spicca “L’amica di mia madre” (1975) di Mauro Ivaldi e con Carmen Villani, altra diva dell’erotico all’italiana. In questo filmetto ricopre il ruolo del titolo, che sverginerà l’adolescente Billy (Roberto Cenci), figlio della sua amica. In seguito la Bouchet, dalla seconda metà degli anni Ottanta, ha virato completamente, trasformandosi in una Jane Fonda nostrana, divenendo nota con le VHS istruttive per il fitness casalingo. Dal 2000 ha poi ripreso, molto saltuariamente a recitare, e tra le sue apparizioni risalta il piccolo ruolo in “Gangs of New York” (2002) di Martin Scorsese. Per Tarantino la Bouchet è un mito, in particolare per la sua interpretazione nel cult “Milano calibro 9” (1972) di Fernando di Leo, ma i due non hanno mai lavorato insieme. Gloria Guida (1955) rappresenta la bellezza acerba, e non a caso le prime due pellicole in cui appare s’intitolano “La ragazzina” (1974) di Mario Imperoli e “La minorenne” (1974) di Silvio Amadio. I suoi ruoli saranno, fino alla fine degli anni ’70, sempre quella di provocante giovane, per poi negli anni Ottanta cercare di cambiare la sua immagine, interpretando ragazze che non si spogliano in commedie meno volgari. Si è dedicata anche al teatro, ma senza successo. Unendosi sentimentalmente a Johnny Dorelli, ha preferito dedicarsi alla famiglia. Nella sua filmografia, sebbene fu un clamoroso insuccesso perché opera “anomala” rispetto alla corrente erotica che scorreva in quel periodo, “Avere vent’anni” (1978) di Fernando Di Leo è la pellicola più apprezzata tra quelle che ha interpretato, anche perché condivide lo schermo con Lilli Carati, altro astro nascente del cinema erotico.
I corpi delle (altre) ragasse
Lilli Carati (1956-2014) fu una prosperosa promessa per il Cinemabis, ma le sue vicissitudini private, cioè l’abuso di cocaina, curvarono rapidamente la sua carriera verso il baratro: prima il porno e poi il carcere. La consacrazione sarebbe dovuta avvenire con la pellicola erotica di ascendenze letterarie (è tratto dall’omonimo romanzo di Gianni Brera) Il corpo della ragassa (1979) di Pasquale Festa Campanile, in cui si mostra ampiamente nuda.
Nadia Cassini (1949), che era apparsa nell’esotico “Il dio serpente” (1970) di Piero Vivarelli, fece una manciata di pellicole sexy da protagonista, soprattutto nel biennio 1979-1980. Il suo tratto – fisico – rinomato era il fondoschiena, che la cinepresa si premurava di inquadrare il più possibile. Già dalla prima metà degli anni ’80 aveva abbandonato il cinema, e anche lei ha avuto problemi di droga e alcool, e come accadde all’Antonelli, un lifting mal riuscito gli ha rovinato il viso. La procace ex modella di fotoromanzi Anna Maria Rizzoli (1951) si è affacciata brevemente come protagonista in ruoli sexy verso la fine degli anni ‘70 e gli inizi degli anni ‘80. Ha recitato negli ultimi forti bagliori della commediaccia, in usuali ruoli di oggetto del desiderio di uomini allupati, e la sua pellicola di punta è “La settimana bianca” (1980) di Mariano Laurenti. Dalla seconda metà degli anni Ottanta ha abbandonato il cinema, dedicandosi un poco al teatro, apparendo in televisione come ospite, e dedicandosi alla sua attività di ambientalista. Orchidea De Santis (1948), bionda e dalle forme prosperose, raramente ha avuto ruoli da protagonista. La sua carriera si è interrotta a causa di un incidente accadutogli sul set del film “Arrivano i gatti” (1980) di Carlo Vanzina. Per ironia del caso, si fece male nella scena in cui si sta girando una parodia di una commedia sexy. È poi riapparsa, in un ruolo serio e maturo di madre, in “Le amiche del cuore” (1992) di Michele Placido. Carmen Villani (1944) inizia da adolescente, con ottimo successo, come cantante, ed esordisce nel cinema, al fianco di Gian Maria Volontè, in “Un uomo da bruciare” (1962) di Paolo e Vittorio Taviani e Valentino Orsini. Negli anni Settanta si dedica maggiormente al cinema, divenendo incontrastata protagonista nelle pellicole comico-erotiche dirette dal marito Mauro Ivaldi. Dalla seconda metà degli anni Ottanta, dopo la morte del marito, si è ritirata a vita privata. Antonia Santilli (1949), sebbene sia apparsa in poche pellicole nel primo lustro dei Settanta, è considerata un’icona sexy, come attestano le pagine che Nocturno gli ha dedicato per molti anni. Una chimera ammaliante, che aveva ottime probabilità di diventare appieno una diva, ma repentinamente, senza dare spiegazioni, ha fatto perdere le sue tracce. Il suo ruolo maggiore fu ne Il boss (1972) di Fernando Di Leo. Paola Morra (1959) è stata un altro giovane corpo molto apprezzato dagli occhi degli spettatori, apparso sugli schermi italiani sul finire degli anni Settanta. Altra ragazza, appena ventenne, che i produttori hanno cercato di smerciare, ma senza successo. Un inizio promettente nell’erotico d’autore “Interno di un convento” (1978) di Walerian Borowczyk e poi, sempre in tonaca (sfilata) nel pastrocchio thriller “Suor omicidi” (1979) di Giulio Berruti. Dall’inizio degli anni Ottanta ha preferito abbandonare il cinema, anche a causa dei problemi con la droga. Laura Gemser (1950) è divenuta famosa come Emmanuelle, la fotografa disinibita apparsa nell’omonima serie filmica apocrifa tratta dalla serie Emmanuelle. Di forme minute, la sua bellezza deriva dal suo fascino orientale. Ha lavorato nel cinema fino al 1991, per poi ritirarsi dalle scene dopo la morte del marito Gabriele Tinti. Femi Benussi (1945) ha iniziato negli anni Sessanta, apparendo anche in “Uccellacci e uccellini” (1966) di Pier Paolo Pasolini. Negli anni Settanta diviene un’icona sexy di molte pellicole erotiche, sebbene siano prodotti d’infima qualità. La sua sessualità, oltre alla facilità di denudarsi, risiede in un fascino di donna matura e da forme burrose. Decide di interrompere la carriera all’inizio degli anni Ottanta, proprio perché continuavano a offrirgli solamente ruoli erotici sempre più spinti.
Dal soft all’hard
Quelle dive che hanno fatto il salto, usualmente l’hanno fatto per semplici motivi pecuniari. Se sullo schermo vediamo scene di sesso miste di divertimento e trasporto, in realtà celano solo squallide storie di costrizioni. Marina Lotar (1944) passa rapidamente all’hard (senza rinunciare a qualche particina nel cinema normale) con tranquillità, per puro gusto personale (per maggiori dettagli consultare “Carte di cinema”, 22: Marina Pleasure Serial). Karin Schubert (1944), tedesca bionda da considerare come l’opposto della Fenech, e non a caso hanno condiviso i set di “Satiricosissimo” (1970) e “Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda” (1972), ambedue di Mariano Laurenti. La Schubert ha ricoperto ruoli da co-protagonista nella fase soft, ma è divenuta protagonista molto apprezzata quando ha deciso di passare all’hard, intorno ai quarant’anni. Il passaggio è stato dettato da questioni familiari, legati ai problemi di droga del figlio. A metà anni Novanta ha smesso, cercando di nascondersi nella sua villetta ed evitando fan e giornalisti che avrebbero rivangato il suo passato. Ha tentato due volte il suicidio. Ilona Staller (1951) inizia negli anni Settanta, recitando in piccoli ruoli ma in cui già si spogliava alacremente. L’apice di quella prima parte di carriera, in cui si è cimentata anche come cantante, giunge con il monumento Cicciolina amore mio (1979) diretto da Amasi Damiani, Bruno Mattei e la supervisione di Riccardo Schicchi. Dall’inizio degli anni Ottanta si getta a tempo pieno nel genere Hard-Core, divenendo rapidamente una stella di prima grandezza della Golden Age del porno italiano. Durante questo periodo è stata anche eletta onorevole al parlamento, candidandosi con il Partito Radicale. La Staller si è poi ritirata a vita privata, apparendo qualche volta in Tv, e attualmente vive della pensione percepita come ex parlamentare. Paola Senatore (1949), apparsa tra la seconda metà degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta in molte pellicole erotiche, in cui concedeva molta epidermide, con molti apprezzamenti, alla fine è divenuta famosa per l’unico hard girato: “Non stop – Sempre buio in sala” (1985) di Arduino Sacco. Rozzo porno realizzato in una manciata di giorni, la Senatore lo fece solo per avere i soldi necessari per procacciarsi la cocaina. Le scene avanzate sono state riciclate per un altro hard. Arrestata per detenzione e spaccio di droga, la permanenza in carcere l’ha avviata verso una conversione religiosa. La già citata Lilli Carati, è passata allo stesso modo alla pornografia, partecipando come protagonista in qualche film, per avere velocemente soldi per comprarsi la droga. Arrestata, ha tentato due volte il suicidio, per poi intraprendere un duro percorso di riabilitazione. È poi morta per un tumore al cervello.
Anni ‘80
Con la nuova decade, il Cinemabis stava già esalando gli ultimi respiri, anche per il proliferare delle Tv private, che riempivano i propri palinsesti notturni di film erotici senza censura oppure con programmi di spogliarello. In questo secondo caso, basterebbe citare le conturbanti Showgirls di Drive In (1983-1988), tutte con fisici formosi e soprattutto in abiti molto succinti, proprio per glorificarne le forme. Ma ancor più epocale fu la trasmissione Colpo grosso (1987-1992), con soubrette che non lesinavano il topless e con le concorrenti donne che, nel caso avessero perso al gioco, non si tiravano indietro nel fare un totale striptease. In ambito cinematografico si è cercato, comunque, di lanciare nuove dive o divette, la cui unica particolarità richiesta era quella di essere prosperose e con facilità di spogliarsi. Carmen Russo (1959), nota per il suo avvincente seno, era apparsa in piccoli ruoli negli anni Settanta, denudando già i suoi apprezzati attributi, per poi divenire protagonista, tra il 1981 e il 1983, di qualche commedia nella quale doveva fare almeno una doccia di profilo. Ha poi avuto una carriera rispettosa nei programmi televisivi, come ballerina o come ospite.
Lory Del Santo (1958), dal visino dolce e dal florido fondoschiena, è assurta mito nel barzellettisco W la foca (1982) di Nando Cicero, per poi passare rapidamente alla televisione, divenendo nota nel programma Drive In, in cui la regia si premurava di indugiare sul suo lato B. Dall’inizio del nuovo Millennio è ritornata in auge come opinionista in molti programmi di consumo televisivi, oppure come concorrente in un paio di Reality Show. Ha cercato anche di convertirsi in Total Filmaker con la serie web The Lady (2014-2017), che ha raccolto soprattutto sghignazzi. Michela Miti (1962) resterà nella memoria come la supplente bona nei barzellettistici “Pierino contro tutti” (1981) e “Pierino colpisce ancora” (1982), ambedue diretti da Marino Girolami. La Miti concede pochissimo (solo un nudo di spalle), ma va considerata come ultima rappresentazione di quel desiderio sessuale verso una professoressa. Poi è apparsa nell’episodio Anche questo è amore della serie televisiva Sogni e bisogni (1985) e in “Mortacci” (1989), entrambi diretti da Sergio Citti, In queste interpretazioni è come se facesse una parodia casareccia del suo effimero periodo sexy. Ha poi intrecciato una relazione con Alberto Bevilacqua, recitando anche nel suo “Gialloparma” (1999), per poi dedicarsi alla poesia. La giunonica Tinì Cansino (1959), pubblicizzata come la nuova Rita Hayworth, per la sua somiglianza, è principalmente un’icona erotica della televisione, essendo esplosa con Drive In. Le sue poche pellicole cinematografiche, interpretate in una manciata di anni nella seconda metà degli anni Ottanta, sono sempre culminate con un suo denudamento integrale. Sposatasi, ha abbandonato il cinema, e dal 2012 è presenza fissa nel programma Uomini e donne (1996-presente). Pamela Prati (1958) è un’altra formosa attrice che i produttori hanno cercato di lanciare sul finire degli anni Ottanta, ma senza successo. In cambio, la sua carriera televisiva, in particolar modo quella legata al Bagaglino nelle vesti di Showgirl, ha avuto molta più fortuna. Ultimamente fa ospitate o ricopre il ruolo di opinionista, non disdegnando partecipazioni in qualche Reality Show. Eva Grimaldi (1961), con una lunghissima carriera, si potrebbe definire la diva mai divenuta realmente diva. Protagonista e co-protagonista in molte pellicole di consumo, non ha mai raggiunto una piena notorietà. È pur vero che ha preso parte a due pellicole pseudo-intellettuali rivelatesi flop colossali: “Cattive ragazze” (1992) di Marina Ripa di Meana e “Mutande pazze” (1992) di Roberto D’Agostino. Negli ultimi anni partecipa frequentemente a svariati Reality Show, e destò sorpresa, dopo un lungo rapporto di coppia con Gabriel Garko, la relazione instaurata con Imma Battaglia. Eleonora Brigliadori (1960) non è definibile come diva erotica, ma ci fu un tentativo con l’erotico La cintura (1989) di Giuliana Gamba. In questa pellicola la Brigliadori al massimo mostra il suo seno, ma questa interpretazione desta scandalo tanto che gli viene revocata la conduzione dello Zecchino d’oro. La sua notorietà odierna è solo per il suo spinto negazionismo verso la chemioterapia e il Covid.
Gli anni Novanta
Nell’ultima decade del Novecento si possono ravvisare solo pochissime stelline che possono lontanamente ricordare nelle forme e nelle denudazioni le stelle degli anni Settanta. Lo smercio di un erotismo pruriginoso avviene principalmente in televisione, in particolare nel malizioso Non è la Rai (1991-1995), in cui frotte di ragazzine, in abiti succinti o in costumi da bagno, ballano, cantano e fanno boccuccia da gallina in posizioni scaltre. Per cercare un erotismo un poco più pepato, ma non hard, ci si deve rivolgere ai film Straight to Video, prodotti filmici spicci che si possono consumare tranquillamente in casa. Carmen Di Pietro (1965) era già apparsa, in piccoli ruoli, nella seconda metà degli anni Ottanta, tra cui “Snack Bar Budapest” di Tinto Brass, ma è dal Novanta che cominciano a offrirgli qualche ruolo da protagonista in prodotti erotici di rapido consumo. Il suo punto forte è il procace seno, e il ruolo più noto è probabilmente “Il diavolo nella carne” (1991) di Joe D’Amato. La Di Pietro ha fatto parlare maggiormente di sé per la sua relazione, confluita nel matrimonio, con l’anziano giornalista Sandro Paternostro (1922-2000), e poi per le infinite apparizioni in programmi televisivi. L’ex modella argentina Vittoria Belvedere (1972) viene scoperta e lanciata da Luciano Martino, grande pigmalione del Cinemabis italiano, nella commedia In camera mia (1992). Subito dopo si è cercato di trasformarla in icona sexy con “Graffiante desiderio” (1993) di Sergio Martino, ma senza alcun esito. In seguito ha incontrato maggior fortuna in fiction televisive di stampo familiare. Eppure il fenomeno maggiore di tentativi, negli anni Novanta, di lancio di giovani e provocanti stelline si riscontra nel dittico “Abbronzatissimi” (1991) e in “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo” (1993), ambedue diretti da Bruno Gaburro, che negli anni Ottanta fu regista di molti soft e anche di qualche hard. Queste due pellicole, prodotte per sfruttare le tematiche estive in contrapposizione alle vacanze natalizie, sono un “gineceo” di giovanissime attrici in succinti costumi da bagno, che si mettono in mostra per una pronta e sperata scalata al successo. Come ha confidato lo stesso Gaburro in una puntata di Stracult, le due pellicole erano straripanti di ragazze perché moltissime erano amanti di produttori e amici, quindi messe lì per soddisfare le loro febbricitanti voglie di successo. Particolarità di “Abbronzatissimi” è che fu il primo tentativo di lancio, quasi riuscito, di Alba Parietti (1991), che poi ha ritentato con il finto torrido “Il macellaio” (1998) di Aurelio Grimaldi.

La Parietti, divenuta inizialmente nota per le sue gambe slanciate esibite per due stagioni nel programma televisivo Galagoal (1990-1992), ha poi continuato ad aver maggior successo nell’ambito della Tv, come conduttrice, o come opinionista tuttologa. “Abbronzatissimi” e il suo seguito furono però anche un sostanzioso depliant con una “strisciata” di altre giovani bellezze in rampa di lancio: Nathalie Caldonazzo (1969), famosa per la sua relazione con Massimo Troisi, non ha mai sfondato realmente al cinema, ma si è poi prodigata in svariate partecipazioni televisive; Sonia Grey (1968), ha avuto la medesima sorte, ma si è convertita, con maggior esito, in presentatrice di programmi televisivi per famiglie; Valentine Demy (1963), che trae il nome d’arte dalla protagonista del fumetto Valentina di Guido Crepax, per via del caschetto, è rapidamente passata, con ampi consensi, all’hard, e ha anche gareggiato in competizioni di Body Building; Valeria Marini (1967), che fallirà miseramente la scalata sexy con “Bambola” (1996) di Bigas Luna, pellicola fischiatissima già al Festival di Venezia, avrà più fortuna come Showgirl nelle file del Bagaglino, e dopo nelle svariate ospitate in programmi televisivi.
Tinto Brass e le sue scoperte femminine
Regista inizialmente accolto come esponente della Nouvelle Vague italiana, e poi aspro sessantottino, dalla seconda metà degli anni Settanta Tinto Brass si è convertito all’erotismo, realizzando alcune pellicole ai limiti dell’hard. Anche questa “terza fase” era cominciata con approcci interessanti, costruendo storie inerenti alle follie del potere che deflagrano nel sesso: il nazi “Salon Kitty” (1975), l’auto-riflessivo “Action” (1979) e il kolossal storico “Io Caligola” (1980).
Pellicola ponte è “La chiave” (1983), in cui le ambizioni autoriali già lasciano spazio a un erotismo ginecologico per sporcaccioni. In questa sua nuova e ultima fase, Tinto Brass si è fregiato di essere stato uno scopritore (con annesso doppio senso) di giovani attrici scelte, di volta in volta, per incarnare un determinato tipo di sessualità. Anche la Sandrelli, sebbene già diva di prima grandezza del cinema italiano, in “La chiave” viene scoperta come (s)oggetto del desiderio, aprendogli brevemente un periodo di star supersexy. La prima grande scoperta di Brass fu Serena Grandi (1958), che dopo piccolissime parti esplose con tutte le sue grandezze fisiche in “Miranda” (1985). La Grandi è quasi una rappresentazione spinta delle donne romagnole e giunoniche felliniane. Il suo picco massimo lo ha raggiunto tra il 1985 e il 1987, proprio per lo slancio dovuto alla pellicola di Brass, e ha poi proseguito, fino alla fine degli anni Novanta, in ruoli secondari. Dopo alcuni problemi giudiziari, è riapparsa a singhiozzo nella seconda decade del Duemila, ormai lontanissima dai fasti di un tempo. La giovane e sconosciuta Francesca Dellera (1965) fu scelta per “Capricci” (1987). Ragazza dal corpo burroso, avrà una breve carriera, anche televisiva, che culminerà con “La carne” (1991) di Marco Ferreri. Emigrata in Francia, ha proseguito verso terreni più colti, tra cui il teatro. L’ex Miss Italia (1983) Raffaella Baracchi (1964) interpretò lo sfortunato “Snack Bar Budapest” (1988), ma con esiti molto mediocri. La Baracchi ha avuto più notorietà per la sua turbolenta relazione con Carmelo Bene; La prosperosa ed ex compagna di Klaus Kinski Deborah Caprioglio (1968) è svestitissima in “Paprika” (1991), ma già dopo un paio di anni cambia completamente percorso, dando ottima prova in “Con gli occhi chiusi” (1994) di Francesca Archibugi. Anche lei è poi apparsa spesso in televisione; Claudia Koll (1965) di “Così fan tutte” (1992), dopo un discreto successo nella serie per famiglie Linda e il brigadiere (1997-1998), ha ripudiato il cinema e si è convertita completamente alla religione. Da “L’uomo che guarda” (1994) fino a “Monamour” (2007), il cinema di Brass è divenuto sempre più trito, che inanella solo scene pseudo-hard per un pubblico di voyeur di bocca buona, e la scelta delle protagoniste, sempre provocanti e con le misure giuste, non suscita più vero conturbamento, perché dimenticabili già a fine visione. In quel lasso di tempo, solamente il film Senso ’45 (2002) suscita un poco d’interesse, non tanto per il riarrangiamento in chiave erotica del romanzo di Camillo Boito, quanto per la presenza – ampiamente nuda – di Anna Galiena (1954), fino a quel momento attrice di pellicole d’autore. Un’operazione che ricorda molto quella attuata con la Sandrelli per “La chiave” (tra l’altro le due pellicole hanno la stessa ambientazione storica: il ventennio fascista).
Ritorni cinefili iconici
Quelle dive di “Serie B”, che si potevano considerare “usa e getta”, sono comunque restate nella memoria degli spettatori, come attestano ad esempio il libro 99 donne oppure gli omaggi cinefili di Tarantino e Eli Roth. Ma ci sono altre testimonianze di stima, giunte da alcuni autori che si sono affacciati nella cinematografia dalla seconda metà degli anni Ottanta, che mitizzano, a loro modo, maggiormente quelle icone, ripescandole e immettendole nelle loro storie. Il caso più eclatante, purtroppo non andato a compimento, era la scelta di Marina Lotar come Madonna per “Totò che visse due volte” (1998) di Ciprì e Maresco, ma l’attrice, da qualche anno ritiratasi a vita privata, declinò l’invito. Molto più interessante il recupero cinefilo che Ferzan Özpetek ha attuato con un paio di dive di quei gloriosi anni. Un’operazione che ricorda vagamente quello che faceva Bernando Bertolucci quando nei suoi film degli anni Settanta innestava nelle sue storie dive del passato (Francesca Bertini, Alida Valli, Maria Michi, Yvonne Sanson). Erika Blanc (1942), fascinosa creatura usualmente protagonista di horror gotici, come mostra il cult “La notte che Evelyn uscì dalla tomba” (1971) di Emilio P. Miraglia, ha avuto una proficua carriera cinematografica, e ugualmente un’apprezzata vita teatrale. Ritorna in auge con le partecipazioni in “Le fate ignoranti” (2001) e in “Cuore sacro” (2005), con cui vince un Globo D’oro speciale per la miglior performance. Meno fenomenale, però ugualmente curioso, il recupero di Licinia Lentini (1959), attrice che ebbe una flebile popolarità in qualche film comico degli anni Ottanta, e in cui mostrava il suo giunonico seno. La Lentini è riapparsa, nel ruolo di madre ancora molto piacente, in “My Name is Tanino” (2002) di Paolo Virzì.
“LA STANZA DEL FIGLIO” VENT’ANNI DOPO
di Roberto Lasagna
Quando nel 2001 ”La stanza del figlio” vince la Palma d’oro, sono trascorsi ventitré anni dalla precedente analoga affermazione per un film italiano (L’albero degli zoccoli, 1978, per la regia di Ermanno Olmi), e il successo del nuovo film di Moretti è accolto come l’espressione più pensata e a lungo preparata di un autore che i francesi avevano già premiato per la regia di ”Caro diario”. Dopo la fase limpida e diaristica dei due precedenti lungometraggi, ”La stanza del figlio” sembra quasi un film pensato in contrasto con il precedente Aprile – episodio di indolenza fiduciosa che celebrava la nascita del figlio Pietro (il vero figlio di Moretti) e insieme un bisogno di liberazione, il desiderio di prendere posizione politicamente e di “fare a botte” per affermare il proprio essere cittadini liberi di partecipare a quella che diventa una vittoria (la sinistra che trionfa alle elezioni del 1996), proprio in un momento sereno della vita del cineasta assieme alla compagna del periodo Silvia Nono. Ma il contrasto rappresentato da ”La stanza del figlio” è soprattutto a livello formale, perché dopo la leggerezza di un film volutamente distante da una strutturazione rigida come Aprile, il nuovo lavoro si presenta con la compostezza del classico ed affonda in tematiche come la fine della psicoanalisi almeno nella sua forma più ortodossa, evocando il tramonto di un certo modo di intendere il percorso metaforico come via di cura.
Se Moretti è stato avvantaggiato dalla particolare naturalezza con cui, nel tempo, ha affrontato figure storiche giunte al limite della credibilità, il capolinea dei suoi personaggi è parte di un disagio della cultura che li riguarda, e la ricerca di consapevolezza come metodo e attitudine autoriale sembra caratterizzare costantemente il percorso cinematografico del cineasta che ne ”La stanza del figlio” approda ad una dimensione in grado di perlustrare gli orizzonti di incertezza attorno alla figura dello psicoanalista, modello della cultura del Novecento a confronto con il limite del lutto devastante. Il nuovo film è accolto come una differenza, con il suo stile asciutto e la disillusione che permea il racconto. E diventando uno psicoanalista osservato in un momento di empasse, Moretti guarda all’uomo e al suo ruolo professionale, al conflitto stridente tra il depositario della consapevolezza e la persona che si trova dentro il disagio più lancinante. Film presto amato dalla critica e dal pubblico, ”La stanza del figlio” sembra cambiare segno rispetto alle visioni socio-politiche filtrate dall’osservazione diaristica di ”Caro diario” e “Aprile”, eppure lo sguardo di Moretti è ancora sul mondo e dentro il mondo, dandosi come profondamente personale. Gli anni di “Ecce Bombo” furono quelli con cui Moretti anticipava lo sfaldarsi della cultura giovanile degli anni Settanta, quando l’impegno politico e i movimenti alternativi davano voce a un’epoca che si interrogava sui suoi perimetri di cui venivano osservati vezzi e pose in una divertita attitudine auto-ironica. Con “Sogni d’oro” il cineasta Moretti realizzava poi un film in cui i personaggi immaginati dipendevano dalle nevrosi e dalle tensioni del protagonista, tre le ferite del cinema impegnato e il cinema trash pronto a divorare i gusti e le opinioni. Con “Palombella rossa” la cultura legata al Partito Comunista italiano e le sue illusioni diventavano luogo di sintomi dentro e fuori i perimetri del marxismo, in una concezione di cinema allegorica e visionaria dove l’esito dell’impolitico obbediva all’implosione del vuoto culturale in atto. Con “La messa è finita”, il giovane prete interpretato da Moretti racchiudeva una volta di più l’immagine semanticamente ambigua dell’individuo giunto alla fine del suo percorso, che non trovava più devoti per la sua messa e ansimava in un oceano di silenzio dei valori riempito con canzoni dal sapore riparatorio quanto allucinato. Nel raccontare lo stato di persone costrette a cambiare pagina, giunte a un momento di grave empasse, da sempre Moretti si affida all’ironia che gli permette di alleggerire la rappresentazione di quel dolore che accomuna il sessantottino di Ecce Bombo, al deputato comunista di Palombella rossa e a Don Giulio. Ma con ”La stanza del figlio”, capita qualcosa che non sembra più sottoponibile in maniera immediata all’ironia. Il dolore lacerante dello psicoanalista Giovanni Sermonti nel film di Moretti è un aspetto che arriva come un fendente e non lascia spazio alla ricomposizione della presunta serenità di una famiglia che trova nella moglie Paola (Laura Morante) e nella figlia Irene (Jasmine Trinca), elementi di somiglianza con il passato cinematografico dell’autore ma anche anticipazioni delle nevrosi e delle tensioni che caratterizzeranno futuri personaggi vagolanti nel vuoto, come il produttore e la regista de “Il caimano”, il papa di “Habemus papam” e la regista di “Mia madre”.
Ne ”La stanza del figlio”, film doloroso in cui Nanni Moretti è ancora una volta l’interprete al centro della riflessione sullo sfaldarsi del senso, egli è anche per un’ultima volta il personaggio principale attorno a cui si articolano i momenti del racconto; sedimento e insieme preludio di una filmografia in cui i corpi non corrono armonicamente come nei ricordi del padre che si rivede felicemente a fianco del figlio scomparso in quella corsa tra il viale che è anche uno dei momenti più intensi de ”La stanza del figlio”, ma esitano e si affannano in percorsi di delusione e nevrastenia (la disperata sequenza in cui, ne “Il caimano”, il protagonista Bruno scopre la moglie in compagnia di un uomo al bar e si precipita in una corsa fino nella stanza di lei, quando le riduce in brandelli il maglione per lacerare quel ricordo bello che lo tiene legato al passato); labirinti di assenza del senso e percorsi di disorientamento, come l’afasia del papa in “Habemus papam” o lo stato emotivo della regista in grave apprensione per la madre malata in Mia madre. Il dolore che squassa la vita dello psicoanalista Giovanni ne ”La stanza del figlio”, si pone come qualcosa che ritroviamo a sprazzi in momenti di una filmografia in cui il tormento divide e non trova facili terapie, e di fronte a una ferita così grande il personaggio sente e lascia trasparire di non credere più nel potere della parola incoraggiante: dinanzi al paziente che scopre di avere un tumore, Giovanni evita di rassicurarlo con la teoria diffusa e accreditata che il benessere psicologico aiuta a sconfiggere il cancro.
Quel paziente è al centro dell’ossessione di Giovanni, che ritorna periodicamente sulla scena della mattina in cui il figlio perse la vita durante l’immersione subacquea: Giovanni aveva risposto ad un’emergenza del paziente, e adesso si immagina che, se quel giorno non fosse andato dal suo cliente, avrebbe convinto il figlio a rinunciare al suo appuntamento subacqueo. Ma non basta dire che, manifestando toni raffreddati verso il paziente, Giovanni si vendichi di una colpa soltanto immaginaria: in questo momento avverte il disagio profondo, l’incapacità di ascoltare e di prendere le distanze dal dolore che dovrebbero essere gli elementi necessari alla psicoterapia. Ed è in questo punto che nel film si rivela la “crisi” come sfiducia in una pratica che Giovanni evidentemente ritiene non più funzionale, e da lui non più sostenibile: di fronte al dolore vissuto in prima persona la pretesa dell’uomo di scienza si sfalda. Il film insinua molto presto il dubbio come attitudine, un’incertezza che è quanto di più umano e comprensibile ma che si riferisce anche alla condizione dello psicoanalista che sospende valutazioni di certezza e si muove in territori dubitativi; acquisisce allora una nota rivelativa quell’avvio con la convocazione di Giovanni a scuola per sentirsi dire che forse il figlio ha preso parte al furto di un fossile. Giovanni è convinto dell’innocenza del figlio, sebbene tale convincimento non sia nemmeno così tanto manifestato. Poi però il figlio, quando le acque a scuola si saranno calmate, confesserà al padre di aver rubato davvero quel fossile, lasciando intravvedere nel suo gesto il tentativo del ragazzo di ribellarsi a qualcosa. In questo cinema in cui è cosa saggia fermarsi a bere un bicchier d’acqua dopo una corsa, come fa Giovanni riportando così l’insegnamento di Cario diario, la saggezza è necessaria ma non sufficiente per affrontare l’insondabile, e quel furto del figlio a scuola si cala come un segno sovvertitore seppure sottotraccia, di una prevedibilità fatta di analisi e valutazioni, attese e puntigli, propri della condizione del padre psicoanalista, nonché di una condizione che nella famiglia apparentemente armonica trova una maschera pronta a “sbeccarsi”, a liberare le sue crepe che diverranno dolorosissime con il trauma del lutto. Titubanze e incertezze che si insinuano nel volto di Giovanni poco convinto del suo stesso convincimento, tanto nei riguardi della presunta innocenza del figlio, tanto della pratica quotidiana dove egli scopre a sue spese i dubbi sulla sua posizione di detective. L’indagatore del quotidiano emotivo si trova allora in una gabbia, e la sequenza che lo vede al luna park, dentro la giostra ingabbiante, ne suggella il blocco e il calvario: immagine di una tortura che si ripete, inflessibile, con fissità. Il lutto è anche questo: stare dentro l’ossessione-prigione che non conosce vie d’uscita. Il lutto chiede anzi di essere assecondato, ripercorso. Almeno nella via ossessiva di Giovanni che a differenza della moglie e della figlia non si placa del suo sguardo tutto calato internamente alla sua ossessione, mentre Paola, soprattutto Paola, rintraccia quel filo immaginario che la conduce ad Arianna, la giovane con cui il figlio aveva iniziato una relazione. Paola-Laura Morante è la figura che resta a vicino a Giovanni pur avvertendo la distanza che li sta separando; lei cerca fuori di sé una via per dare senso al ricordo, all’immagine non statica del figlio.
Giovanni invece si fissa su quella sequenza che telecomanda ad una televisione-specchio rimbalzante la sua ossessione avvitata sul ricordo di quella mattina. Arianna, la giovane a cui Giovanni non riesce a scrivere una lettera, viene allora avvicinata da Paola, e Paola-Laura Morante è ancora una volta il compendio immaginifico del rapporto tra Giovanni-Nanni-Michele con le donne, con quell’altro che ci compensa e scompensa, ma che in un film di transito come “La stanza del figlio”, incentrato sull’emergere del dolore luttuoso, finisce per assolvere al ruolo di compagna-amica, aperta alle sospensioni che il futuro offre. E’ Paola l’orizzonte di senso imprevedibile ma cautamente beneaugurante per una scena relazionale che ha bisogno di rimettersi in gioco, di ritrovare nell’accettazione e nello sguardo rivolto fuori dal proprio tormento un qualche tipo di orizzonte. L’accettazione del dolore comporta anche il riconoscimento del limite, e sappiamo come Moretti ci confronti nel suo cinema con questa espressione. Accettarsi è un compito difficilissimo per Giovanni, che con il lutto distruttivo del figlio maschio adolescente sperimenta lo sfaldarsi di quella famiglia “abbastanza buona” che è la condizione del mondo accudente della psicoanalisi di Winnicott inevitabilmente messa in crisi nella situazione del film. Perplessità e dubbi che lo spettatore sperimenta guardando un racconto doloroso, di grande secchezza e intensità emotiva, dove Giovanni è l’analista moderno che si ritrova incapace di risposte e di soluzioni per sé e la sua famiglia, finendo per mettere in discussione le sue stesse parole, come quando riconosce come “cazzate” tutte le sue frasi che escono dalla sua bocca nella sequenza delle tazze in cucina. Ma come sempre, la bellezza curativa, se si può dire così, di un film di Moretti, è nel suo porsi al di fuori delle impalcature teoretiche. ”La stanza del figlio” ha le cadenze precise di una prima parte in cui si ritrovano, con la musica di Nicola Piovani, momenti di vita quotidiana portatori di levità e ispiratori di buona armonia, mentre lo sguardo di Giovanni attorno alla danza degli hare krishna accenna ad una condizione di spiritualità condivisa nelle sue note di raccoglimento e letizia anche dall’osservatore laico. Quindi il film vibra del talento delle sue interpreti, Laura Morante e Jasmine Trinca, presenze di sensibilità in grado di riempire la vita di Giovanni e di renderla motivata, colmando quelle rigidità un po’ spinose delle sue abitudini.
E’ davvero una famiglia che si completa come modello, nonostante qualche magagna sia naturalmente presente. Il moralista Moretti qui si mette nei panni dell’uomo che per definizione deve mettere da parte la morale nelle sue pratiche quotidiane, per lasciar voce all’inconscio, ai desideri e ai sogni raccontati dai pazienti. La parte della morte di Andrea è uno shock che ci viene mostrato senza indugiare sul momento della morte, evolvendo con schietta adesione alle note del disagio che ciascuno dei familiari vive e nell’immagine di un abbraccio tra i sopravvissuti che ha l’eloquenza espressiva in grado di sostituirsi alla parola. Poi il film ci accompagna con i suoi protagonisti a osservare cosa succede nel mondo non previsto da Giovanni, quando il lavoro terapeutico diventa impossibile, quando ci si sente incapaci di curare gli altri e sé stessi. E il racconto procede con grande finezza, evitando anzi una certa quale prevedibilità che sembra forse disseminata nella prima parte, dandosi allora come quel diario doloroso che si fa fatica a scrivere, esattamente come Giovanni non riesce a scrivere ad Arianna forse perché non vuole o non riesce a immaginare un Andrea diverso, un Andrea oltre la sua immagine di lui. O più probabilmente, Giovanni, messo di fronte alla realtà, non riesce a guardare in faccia quello che Andrea non potrà più avere: un futuro, ciò che invece ad Arianna sarà permesso. Film sulla dolorosa messa a fuoco della difficoltà di scrivere un diario sul proprio vissuto (laddove lo psicoanalista è abituato nella sua prassi a scrivere e appuntare minute della sua relazione quotidiana con il paziente), dopo ”Caro diario” e Aprile, ”La stanza del figlio” approda a territori di sospensione di riflessiva e umanistica pregnanza. Partendo da Ancona, con il suo porto e l’idea stessa di una città di provincia che possa dare la dimensione di intimità e partecipazione collettiva al lutto della famiglia di Giovanni, Moretti sceglie di allontanarsi dal senso di alienazione e spossatezza della metropoli romana, ma il movimento è quanto il film prospetta a Giovanni come ipotetico e naturale sviluppo da perseguire, quando con la sua famiglia lacerata accompagna Arianna e il suo amico fino a Ventimiglia, lasciandoci sulla spiaggia dopo una notte di viaggio oltre ogni aspettativa. Giovanni e Paola si ritrovano così dopo le divisioni, in questo tragitto che sfocia sulla sabbia; accompagnano i due coetanei di Andrea e in loro vedono qualcosa che hanno perso, sulla musica di Brian Eno il cui CD Giovanni aveva acquistato per fare un regalo al figlio morto nel giorno del suo compleanno. L’immagine della realtà è densamente rappresentata nei tratti emotivi che coinvolgono il personaggio e permettono allo spettatore di riconoscere, come in un percorso di accettazione del limite, fin dove si può arrivare a perdersi, per poi ritrovare forse un senso e una speranza nel legame che ci conduce agli altri. Giovanni, Paola e Teresa hanno la possibilità di continuare a vivere anche per Arianna, lasciandola sulla sua strada. Lei cercherà, come loro, il suo percorso.
CARLO DELLE PIANE (1936-2019). UN FILM LUNGO SETTANT’ANNI
di Mario Giunco
“Preferisco l’attore Carlo delle Piane all’uomo, perché mi permette di fare, nei vari ruoli che interpreto, ciò che non ho mai fatto nella vita, stringere le mani, avere contatto fisico con altri personaggi. Per me lavorare è come una terapia, come andare in analisi”.
Carlo Delle Piane (Roma, 2 febbraio 1936 – 23 agosto 2019) era schivo, parco di parole, anche negli ultimi tempi, sempre timoroso di mettersi a nudo. Preferiva, con termine cinematografico, la sottorecitazione. “Non mi amo, mi rispetto. Ogni sera, prima di addormentarmi ho sempre qualcosa da rimproverarmi. Se potessi, cambierei me stesso. Sono stanco di sbagliare ancora” rivelava in un’intervista, rilasciata ad Alghero il 29 ottobre 2016 per il programma di Fausto Farinelli “Audaci a cuore aperto”. Forse perché attratto dal titolo, che non sembrava riferirsi a lui, tormentato da mille “manie” – prima, quella dell’igiene – voleva parlare un po’ più a suo agio. Colto da un ictus nel 2015, si era ristabilito e stava lavorando a “Chi salverà le rose?”, opera prima di Cesare Furesi, che riproponeva uno dei suoi personaggi mitici, l’avvocato Santelia di “Regalo di Natale” e di “La rivincita di Natale”. Era una delle sceneggiature più belle che avesse letto, univa sentimento, emozione e divertimento. I suoi idoli erano Buster Keaton, Orson Welles e Marlon Brando, ma credeva nel cinema italiano, da cui si riteneva trascurato negli ultimi tempi. Fellini non lo aveva preso in considerazione, perché gli “sembrava troppo Pupi Avati”. Dei grandi solo Olmi si era ricordato di lui in un episodio di “Tickets” (2005). Jean Jacques Annaud gli aveva offerto un ruolo di prestigio ne “Il nome della rosa”, ma aveva rinunciato, avrebbe dovuto imparare l’inglese. Ricordava, a tal proposito, le difficoltà che aveva avuto con la lingua nella “tournée” americana di “Rugantino” e i succulenti piatti di pasta e fagioli che Aldo Fabrizi, preferendo non uscire, preparava nella sua stanza d’albergo.
“Carlo Delle Piane – affermava Pupi Avati in una intervista a “Il Sud on line”, agosto 2019 – è stato purtroppo abbandonato dal nostro cinema, nel momento in cui noi glielo abbiamo affidato. Noi l’abbiamo messo nella condizione di camminare con le sue gambe, di avere una sua autonomia, di avere un grande prestigio, perché aveva vinto i premi più importanti, di avere una sua identità molto forte. Però non è stato più coinvolto. Pochi si sono ricordati di lui per festeggiare i settanta anni di carriera. Al funerale, c’eravamo solo io e mio fratello. Al Festival di Venezia non lo hanno né ricordato, né citato”.
Come ogni attore Carlo Delle Piane ha realizzato nei suoi personaggi, anche nei meno significativi e di “routine”. Nato a Roma in piazza Campo de’ Fiori, secondogenito di tre figli (vive il fratello Piero, per chi scrive preziosa fonte di informazione, come lo stesso attore, conosciuto a Roseto nel 1988). Il padre, originario di Casoli, frazione di Atri, in Abruzzo, era sarto. Carlo ricordava che, quando non riusciva a completare i lavori, si fingeva malato e sapeva recitare benissimo. Era legato alla terra d’origine, come Carlo, che ambientò in Atri il suo film, “Ti amo Maria” e che trascorreva le vacanze nella vicina Roseto, dove, nell’estate 1988, gli fu allestita dal Comune la prima mostra retrospettiva, di grande successo.
Dotato di un’istintiva capacità interpretativa, anche grazie all’aspetto di monello impenitente e al naso storto, causato da una pallonata, ha all’attivo 104 film (o 112, considerati quelli in cui non è accreditato o la parte è esclusa in fase di montaggio, come nel giallo “Scacco internazionale” di Giulio Rosati). Inizia quasi per gioco, per evitare la scuola, senza nemmeno rendersi conto della grandezza dei registi e degli attori con cui lavora.
A dodici anni, nel 1948, in “Cuore”, diretto da Duilio Coletti, è Garoffi “il ragazzo con il naso a becco di civetta, intento sempre a trafficare”. Il Maestro è Vittorio De Sica.
In venticinque anni, dal 1948 al 1973, compare in più di ottanta film, diretto da registi affermati o esordienti. Oltre a Coletti, Anton Giulio Majano (debuttante in “Vento d’Africa”, 1949), Paolo William Tamburella, Léonide Moguy, Giorgio Simonelli, Giorgio Bianchi, Roberto Savarese, Mario Monicelli, Steno, Adelchi Bianchi, Aldo Fabrizi (lo ha diretto in “La famiglia Passaguai”, 1951, “La famiglia Passaguai fa fortuna” e “Papà diventa mamma”, 1952).
E anche Domenico Paolella, Raffaello Matarazzo, Ferruccio Cerio, Sergio Grieco, Giuseppe Alviani, Elio Piccon, David Carbonari, Riccardo Freda, Mario Bonnard, Marino Girolami, Bruno Paolinelli, Ottorino Franco Bartolini, Mario Costa, Roger Vadim (“Un colpo da due miliardi, 1957), Luigi Zampa, Eduardo De Filippo, Carlo Campogalliani, Nunzio Malasomma, Piero Costa, Giuseppe Bennati, Giuseppe Vari, Mario Mattoli, Romolo Girolami (fratello di Mario), Walter Filippi, Sergio Corbucci (“Il monaco di Monza”, 1963), Fernando Cerchio, Carlo Infascelli, Marcello Giannini, Vittorio De Sica, Ettore Maria Fizzarotti, Giulio Rosati, Giovanni Grimaldi, Francois Legrand, Giorgio Capitani, Bruno Corbucci, Mario Amendola, Giorgio Mariuzzo, Jerzy Skolimowski (“Le avventure di Gerard” , 1970), Giuseppe Ferrara (“Il sasso in bocca”, 1970), Richard Owens (“All’ovest di Sacramento”, 1971), Vittorio Gassman (“Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto”, 1972), Roman Polanski (“Che?”, 1972), Carlo Di Palma (“Teresa la ladra”, 1973).
Fra questi registi, Marino Girolami (1914-1994), capostipite di una famiglia di cineasti – fratello di Romolo Guerrieri e padre di Enzo G. Castellari – è quello che lo ha diretto per il maggior numero di film (diciassette, realizzati in nove anni), superando, in quantità, lo stesso Pupi Avati. Per la critica si tratta di “opere di modesta levatura, realizzate con scarso impegno e basate su situazioni poco credibili”, a cominciare da “La ragazza di Via Veneto” (1955), in cui recita, nel ruolo della protagonista Anita, Annamaria Moneta Caglio (coinvolta nel caso Montesi, non appare ai critici “né fotogenica, né espressiva”). Seguono “Serenata per 16 bionde” (1957), “Sette canzoni per sette sorelle” (1957), “Buongiorno primo amore!” (1957), “La canzone del destino” (1957), “Quando gli angeli piangono” (1958), “Quanto sei bella Roma” (1959), “Caccia al marito” (1960), “Ferragosto in bikini” (1960), “La ragazza sotto il lenzuolo” (1961), “Walter e i suoi cugini” (1961), “Scandali al mare” (1961), “Le magnifiche 7” (1961), “Twist, lolite e vitelloni” (1962), “I galli del Colosseo”, episodio di “Gli italiani e le donne” (1962), “Colonnello e signora”, episodio di “Siamo tutti pomicioni” (1963), “Intrigo al mare”, episodio di “Veneri al sole” (1964). Delle Piane si esprime in ruoli farseschi o parodistici, secondo il suo ormai abituale cliché. Di cui ormai non era più soddisfatto.
Lavora, tra gli altri, con Totò, Alberto Sordi, Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman, Monica Vitti e uno stuolo di ottimi caratteristi. Ma la sua vera scuola sono i cineclub e i cinema d’essai della capitale, dove conosce Antonio Avati, il futuro produttore (Duea Film), fratello di Pupi.
Nel 1962 l’attore debutta al Sistina in “Rugantino”, commedia musicale di Pietro Garinei, Sandro Giovannini, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa e Luigi Magni, con musiche di Armando Trovajoli, con Nino Manfredi, Lea Massari, Bice Valori, Toni Ucci, Lando Fiorini. E’ Bojetto, il figlio di Mastro Titta.
La svolta nel 1973. Subisce un incidente automobilistico e rimane in coma per più di un mese. Stenta a riprendere il lavoro. La depressione è in agguato. Non può sentirsi appagato da pellicole, di moda negli anni Settanta, come “I 7 magnifici cornuti” e “Una bella governante di colore” di Luigi Russo, “La signora gioca bene a scopa?” di Giuseppe Carnimeo, “L’insegnante” e “La dottoressa del distretto militare” di Nando Cicero, “Passi furtivi in una notte boia” di Vincenzo Rigo. Che pure è costretto ad accettare per motivi alimentari.
Antonio Avati si ricorda di lui e persuade il recalcitrante Pupi a farlo recitare in “Tutti defunti…tranne i morti” (1977). Inizia così un sodalizio durato fino agli ultimi giorni. Racconta il regista che riuscì a far sorridere Carlo, ormai allo stremo, dicendo che aveva un copione tutto per lui. Ma non era vero.

Diretto da Pupi Avati, l’attore interpreta altri nove lungometraggi : “Le strelle nel fosso” (1979), “Una gita scolastica” (1983, Premio Pasinetti Miglior attore – Mostra del Cinema di Venezia; Nastro d’argento, 1984 – Miglior attore protagonista; Globo d’oro, 1984 – Miglior attore rivelazione), “Noi tre” (1984), “Festa di laurea” (1985), “Regalo di Natale” (1986, Coppa Volpi Migliore interpretazione maschile – Mostra del Cinema di Venezia); “Dichiarazioni d’amore” (1994); “La via degli angeli” (1999); “I cavalieri che fecero l’impresa” (2001); “La rivincita di Natale” (2004). Si aggiungono tre miniserie televisive, sempre dirette da Avati: “Jazz Band”, 3 episodi (1978); “Cinema!!!”, 4 episodi (1979); “Dancing Paradise”, 3 episodi (1982).
Dal 1973 al 2017 Delle Piane figura in meno di trenta film, pochi rispetto agli ottanta che segnarono i primi venticinque anni di carriera. Sono tutte opere che trasformano un caratterista, dotato dalla natura e senza studi specifici, in un attore vero, che ha una sua cifra stilistica indiscutibile: la malinconia. “Ho sempre evitato di cadere nel patetico e nel drammatico. E’ difficile che io possa ridere. Il mio modello è Buster Keaton, per la sua essenzialità”, diceva Delle Piane, unendo al solito arte e vita. Era colpito dalla tristezza di fondo di Totò, che si manifestava solo nei momenti di riposo. Con Sordi si frequentava poco, dopo il successo di “Un americano a Roma” (1954), in cui era Romolo Pellacchioni, “Cicalone”. Invece aveva avuto un ottimo rapporto con Aldo Fabrizi, che, a costo di sembrare burbero e scostante, non aveva mai accettato compromessi, per non tradire il suo pubblico. Come lui, che cercava sempre la qualità e non il denaro. Anche per questo motivo, si sentiva messo da parte.
I film successivi al 1973 – eccettuati quelli di Pupi Avati – non sembrano rispondere alle attese del pubblico e della critica: “Tenerezza” di Enzo Milioni (1987), “Sposi”, di Cesare Bastelli (1988), “I giorni del commissario Ambrosio” di Sergio Corbucci (1988), “Condominio” di Felice Farina (1991); “Un amore americano” di Piero Schivazappa (1992), “Io e il re” (1995, in cui interpreta Vittorio Emanuele III, conferendogli un briciolo di dolente umanità), “Tickets” (2005, compare nel primo episodio diretto da Ermanno Olmi; gli altri episodi sono diretti da Abbas Kiarostami e Kean Loach; ma l’opera nel complesso delude); “Nessun messaggio in segreteria” di Paolo Genovese e Luca Miniero (2005); “Linea gotica” di Stefano Giulidori (2012).
“Chi salverà le rose?” (2017), lungometraggio di esordio di Cesare Furesi, è anche l’ultimo film in cui compare l’attore Carlo Delle Piane, nel ruolo dell’avvocato Giulio Santelia, affiancato da due “mostri sacri”, come Lando Buzzanca e Philippe Leroy e da Caterina Murino. “Strano film – scrive Paolo D’Agostini, “la Repubblica”, 16 marzo 2017). Storia d’amore di una coppia di uomini, ormai anziani, al tempo stesso ingenua nella composizione ed esasperatamente letteraria nella scrittura, ma una prova molto personale, rispettabile e intensa. Tanto da rendere credibile un casting stravagante, imprevedibile”. Per Massimo Bertarelli (“il Giornale”, 16 marzo 2017) è “un dramma dignitoso, dove brilla l’antica classe di Carlo Delle Piane e Lando Buzzanca”. Per la sua interpretazione Delle Piane è candidato, come migliore attore, al Globo d’oro. Nel luglio dello stesso anno gli è assegnato il Grand Prix Corallo Città di Alghero alla carriera. Analogo premio, rappresentato dalla “Farfalla di ferro”, riceve l’11 ottobre, nel carcere Dozza di Bologna, nel corso di una toccante cerimonia.
Negli ultimi tempi l’attore si era dedicato a iniziative umanitarie. Aveva Inciso il disco “Bambini” (2006) e, con Stefania Sandrelli, era stato protagonista del cortometraggio “Ogni giorno” di Francesco Felli, sul dramma dei malati di Alzheimer (2008).
Aveva scritto insieme a Giuseppe Aquino e diretto “Io, Anna e Napoli”, omaggio in musica – la voce era quella della futura moglie, Anna Crispino, che eseguiva canzoni napoletane – sulla sua carriera artistica, attraverso i film ai quali aveva partecipato, accanto ai protagonisti della storia del cinema. La “prima” si era svolta allo storico Teatro San Ferdinando di Napoli il 23 aprile2010.
Ma non può trascurarsi il suo esordio dietro la macchina da presa, avvenuto nel 1997 con “Ti amo Maria”. Tratto dall’omonimo dramma di Giuseppe Manfridi, rappresentato con successo nel 1990, con la regia di Marco Sciaccaluga e l’interpretazione di Carlo Delle Piane e Anna Bonaiuto, il film non si distacca molto dalla sua origine teatrale. L’interprete femminile diviene Laura Lattuada, le musiche sono di Lino Patruno.
Ambientato ad Atri è la storia di una persecuzione amorosa, operata da Sandro, un pianista jazz cui la vita ha dato poco, nei confronti di Maria, una donna persa di vista molti anni prima, in un incalzare di eventi struggenti e rabbiosi, scanditi dalla natura musicale del racconto, fino a una imprevedibile conclusione. “E’ un paradosso sull’ossessione d’amore – scrive Enzo Natta, “Famiglia Cristiana”, 17 settembre 1997 – un curioso teorema sulla felicità, cosi affannosamente inseguita, che, quando si raggiunge, non si è in grado di sopportarne il peso. E se l’infelicità è motivo di vita e di speranza, la felicità è esattamente il suo contrario. Se la regia denuncia qualche incertezza, l’interpretazione di Carlo Delle Piane è sentita e sofferta. Resa ancor più convincente dallo stridente contrasto fra uno schiavo d’amore che non esita a spogliarsi di ogni dignità pur di manifestare i propri sentimenti e un mondo cinico, egoista, che aspira soltanto a far soldi”. “E’ un lavoro di riflessione e di pensiero – secondo Giacomo Gambetti, “Rocca”, 15 ottobre 1997 – quello di Delle Piane: se è l’inizio di un serio progetto e non rimane una sia pur lodevole opera prima o, peggio ancora, opera unica, il cinema italiano ha acquisito un autore vero e, quel che ancora più conta, un autore originale, anche se l’ispirazione viene da un’opera teatrale e la sceneggiatura di Gianni Molino e Francesco Cardì, specie nella seconda parte, ne reca un po’ il peso. E’ bravo anche come attore, Delle Piane, assieme a Laura Lattuada”.
Di questo film, che, nonostante i meriti indubbi, restò opera unica, Delle Piane parlava raramente, a fatica, quasi volesse esorcizzare personali fantasmi. “So di aver fatto male a delle persone per egoismo” diceva nell’intervista citata. Forse l’ombra di Freud si allungava anche su di lui. Piuttosto reticente rimase, quando, il 17 maggio 2019, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, fu protagonista della serata d’onore, omaggio ai suoi settant’anni di carriera. A gloria maggiore del Cinema.
CARLO DELLE PIANE – I REGISTI CHE FECERO L’IMPRESA
ALVIANI, Maximo Giuseppe
Vacanze a Villa Igea (1954)
AMENDOLA, Mario
Pensiero d’amore (1970), Lacrime d’amore (1970), Lady Barbara (1970)
AQUINO, Giuseppe
Il bello del cinema italiano (2011) – Documentario
AVATI, Pupi
Tutti defunti…tranne i morti (1977), Le strelle nel fosso (1979), Una gita scolastica (1983), Noi tre (1984), Festa di laurea (1985), Regalo di Natale (1986), Dichiarazioni d’amore (1994), La via degli angeli (1999), I cavalieri che fecero l’impresa (2001), La rivincita di Natale (2004), Jazz Band, miniserie Tv, 3 episodi (1978), Cinema!!!, miniserie Tv, 4 episodi (1979), Dancing Paradise, miniserie Tv, 3 episodi (1982).
BASTELLI, Cesare
Sposi (1988) – 2° episodio
BENNATI, Giuseppe
L’amico del giaguaro (1959)
BERTOLINI, Ottorino Franco
La canzone più bella (1957)
BIANCHI, Adelchi
Bellezze a Capri (1951)
BIANCHI, Giorgio
Il caimano del Piave (1951), I 4 tassisti (1963)
BONNARD, Mario
La ladra (1955)
BOSCH, Juan
La moglie dell’amico è sempre più buona (1980)
CAMPOGALLIANI, Carlo
Serenatella sciuè sciuè (1958)
CAPITANI, Giorgio
L’arcangelo (1969)
CARBONARI, David
Bella non piangere (1955)
CARNIMEO, Giuliano
La signora gioca bene a scopa? (1974)
CERCHIO, Fernando
Totò e Cleopatra (1963)
CERIO, Ferruccio
Gioventù alla sbarra (1953)
CICERO, Nando
L’insegnante (1975), La dottoressa del distretto militare (1976)
COLETTI, Duilio
Cuore (1948), E’ arrivato l’accordatore (1952), La grande speranza (1954), Divisione Folgore (1954)
CORBUCCI, Bruno
Zum Zum Zum n° 2 (1969)
CORBUCCI, Sergio
Il monaco di Monza (1963), I giorni del commissario Ambrosio (1988)
COSTA, Mario
Le belle dell’aria (1957), La ragazza di piazza San Pietro (1958)
DE FILIPPO, Eduardo
Fortunella (1958)
DELLE PIANE, Carlo
Ti amo Maria (1997)
DE SICA, Vittorio
Caccia alla volpe (1966) – CDP non accreditato
DI PALMA, Carlo
Teresa la ladra (1973)
FABRIZI, Aldo
La famiglia Passaguai (1951), La famiglia Passaguai fa fortuna (1952), Papà diventa mamma (1952)
FARINA, Felice
Condominio (1991)
FERRARA, Giuseppe
Il sasso in bocca (1970)
FILIPPI, Walter
Nerone ’71 (1971)
FIZZAROTTI, Ettore Maria
Perdono (1966)
FREDA, Riccardo
Da qui all’eredità (1955)
FURESI, Cesare
Chi salverà le rose? (2017)
GASSMAN, Vittorio
Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto (1972)
GAUDINO, Lucio
Io e il re (1995)
GENOVESE Paolo, MINIERO Luca
Nessun messaggio in segreteria (2005)
GIANNINI, Marcello
I ragazzi dell’Ully Gully (1964)
GIROLAMI, Marino
La ragazza di via Veneto (1955), Serenata per 16 bionde (1957), Sette canzoni per sette sorelle (1957), Buongiorno primo amore! (1957), La canzone del destino (1957), Quando gli angeli piangono (1958), Quanto sei bella Roma (1959), Caccia al marito (1960), Ferragosto in bikini (1960), La ragazza sotto il lenzuolo (1961), Walter e i suoi cugini (1961), Scandali al mare (1961), Le magnifiche 7 (1961), Twist, lolite e vitelloni (1962), I galli del Colosseo – Episodio di “Gli italiani e le donne” (1962), Colonnello e signora – Episodio di “Siamo tutti pomicioni” (1963), Intrigo al mare – Episodio di “Veneri al sole” (1964)
GIROLAMI, Romolo
Bellezze sulla spiaggia (1961)
GIULIDORI, Stefano
Linea gotica (2012)
GIUSIANI, Francesco
Culurzones (2014) – Cortometraggio
GRIECO, Sergio
Fermi tutti…arrivo io! (1953)
GRIMALDI, Giovanni
Don Chisciotte e Sancio Panza (1968)
INFASCELLI, Carlo
Canzoni, bulli e pupe (1964)
LEGRAND, Francois
Susanna…ed i suoi dolci vizi alla corte del re (1968)
MAJANO, Anton Giulio
Vento d’Africa (1949)
MARIUZZO, Giorgio
Quelli belli…siamo noi (1970)
MALASOMMA, Nunzio
Adorabili bugiarde (1958)
MATARAZZO, Raffaello
Il tenente Giorgio (1952) – CDP non accreditato
MATTOLI, Mario
Un mandarino per Teo (1960)
MILIONI, Enzo
Tenerezza (1987)
MOGUY, Léonide
Domani è troppo tardi (1950)
MONICELLI, Mario e STENO (Stefano Vanzina)
Guardie e ladri (1951)
OLMI, Ermanno
Tickets (2005) – 1° episodio
OWENS, Richard
All’ovest di Sacramento (1971)
PAOLELLA, Domenico
Un ladro in Paradiso (1952), Non sono più guaglione (1957), Ballo in maschera da Scotland Yard (1963), Il sole è di tutti (1966)
PAOLINELLI, Bruno
I pappagalli (1955)
PICCON, Elio
Ho ritrovato mio figlio (1954)
POLANSKI, Roman
Che? (1972)
RIGO, Vincenzo
Passi furtivi in una notte boia (1976)
ROSATI, Giulio
Scacco internazionale (1968) – La parte di CDP esclusa in fase di montaggio
RUSSO, Luigi
I 7 magnifici cornuti (1974), Una bella governante di colore (1976)
SAVARESE, Roberto
Mamma mia, che impressione! (1951)
SCHIVAZAPPA, Piero
Il prato delle volpi, miniserie Tv (1990), Un amore americano, film Tv (1992)
SIMONELLI, Giorgio
Io sono il Capataz (1951)
SKOLIMOWSKJ, Jerzy
Le avventure di Gerard (1970)
STENO (Stefano Vanzina)
L’uomo, la bestia e la virtù (1953), Un americano a Roma (1954), Totò contro i quattro (1963)
TAMBURELLA, Paolo William
Vogliamoci bene! (1950)
VADIM, Roger
Un colpo da due miliardi (1957)
VARI, Giuseppe
Spavaldi e innamorati (1959)
ZAMPA, Luigi
Ladro lui, ladra lei (1958)
QUESTIONE DI SGUARDO
di Paola Brunetta
“Se non avete troppa voglia di faticare, l’idea di fare l’insegnante vi angoscia e avete una qualche familiarità con la lingua italiana, il mestiere di critico cinematografico è quello che fa per voi. E’ un mestiere che fa colpo sulle ragazze, almeno finché non scoprono che non lavorate esattamente guancia a guancia con Mel Gibson. E’ un mestiere che funziona benissimo nei salotti perché tutti, indistintamente tutti […], vi verranno a chiedere cosa ne pensate dell’ultimo film di Kusturica […]. Dal punto di vista economico non è particolarmente remunerativo, ma è anche poco impegnativo”, scriveva De Marinis in un gustoso libello (1).
Ma siamo davvero critici perché non vogliamo né sappiamo fare altro, o per la comodità di fare un mestiere che permette di divertirsi “fingendo di lavorare” (concetto richiamato anche, con toni e intenzioni molto diversi, da Morandini nel suo Non sono che un critico. Il ritorno (2))? Io direi che è perché siamo appassionati, appassionati di cinema e appassionati della vita che nel cinema in ogni caso si rispecchia, e perché questo è un modo bellissimo di coltivare questa passione, continuando a occuparci del film anche dopo aver terminato la visione: lasciandolo sedimentare dentro di noi, ripensandoci, rielaborandolo più col cuore e con i sensi che con la mente, all’inizio, ma poi anche in modo più razionale e con l’ausilio di strumenti altri, di tipo cinematografico ma anche latamente culturale, creando quello che Bazin definiva il “prolungamento del piacere estetico” nel ricreare il film per gli altri, per chi legge. Per lo spettatore che del critico ha bisogno, che ha bisogno ma anche voglia, perché no, di sentire un parere “esperto”, di aprirsi ai nuovi “sensi” che il critico può aver individuato nel testo, vale a dire nel film.
Parlo ovviamente della critica che “entra” nel film (3) e lo sviscera e rivolta risuonando con esso, in esso, per estrapolarne i significati; che non sono quindi interpretazioni fini a se stesse che poco hanno a che vedere con l’oggetto, ma interpretazioni intimamente legate ad esso, che derivano da esso. Riflessioni. Osservazioni. Creazioni autonome ma al contempo ri-creazioni (riscritture) di quel testo, di quell’oggetto. Che non implicano necessariamente una valutazione. E che sono però anche, inevitabilmente, soggettive.
E qui il gioco si fa duro, come si può vedere. E implica un’illustrazione di quanto sopra esposto, a partire da un’idea di cinema e di critica cinematografica per arrivare al ruolo che può e che deve avere il critico, e al suo rapporto con l’opera. Cominciamo.
“La vita reale è per chi non sa fare di meglio”, dice Shannon a Gatsby in Un giorno di pioggia a New York; e il meglio può essere il cinema, con la sua magia e meraviglia.
La sala in cui ci si immerge in un buio “placentare” come lo chiama Gian Piero Brunetta, il fascio di luce che fa parlare e muovere lo schermo, una storia che ci avvince e ci incanta… o ci turba e sconvolge, ma in ogni caso muove… che ci porta in mondi diversi dal nostro (per Calvino, in un mondo “più pieno, più necessario, più coerente” rispetto a quello che lo circondava quand’era adolescente a Sanremo (4)), dentro a situazioni a noi aliene ma allo stesso tempo nostre, che accogliamo e onoriamo. Il cinema infatti è “finto” ma viene percepito da noi spettatori come vero, in quell’illusione di cui parlano anche Escobar e Cozzi in Ti racconto un film (“ogni buon spettatore […] si illude di vivere e morire egli stesso, di gioire e di soffrire veramente” (5)) e che costituisce il cuore del film, quello che lo rende magico (quindi anche un po’ indefinibile e imprendibile) come l’antro delle meraviglie che è la sala, il suo tempio. E in effetti al di là e prima del concetto di indefinitezza dell’opera di Iser, su cui avremo occasione di ritornare, Susan Sontag in Contro l’interpretazione (1966) sostiene che l’opera d’arte, che tocca l’ineffabile, “è anche un oggetto vibrante, magico ed esemplare”, che è permeata di “energia, vitalità ed espressività” e che “nei buoni film”, in particolare, “c’è sempre un’immediatezza che ci libera totalmente dalla smania di interpretare” (6). Un’opera quindi che non ha bisogno di un critico che la interpreti per cavarne fuori dei significati estrinseci (quello che il suo “contenuto” vuole dire o dimostrare, e questo è il motivo per cui l’autrice si scaglia contro quell’interpretazione che usurpa il posto dell’opera invece di renderle un servizio, che “viola” l’arte trasformandola “in un oggetto d’uso da collocare entro uno schema di categorie mentali” (7), che la vede come qualcosa che parla del mondo invece che qualcosa che è nel mondo), ma piuttosto di un critico, e di uno spettatore, che ne esalti la trasparenza, intesa come “il fare esperienza della luminosità della cosa in sé, delle cose per quelle che sono” (8).
Cosa deve fare, quindi, il critico per dare un senso alla propria azione? Quali sono, in questo senso, il significato e il valore della critica? E qual è l’atteggiamento che il critico deve avere nei confronti dell’opera?
Partiamo dall’ultimo punto, che si collega alle “categorie mentali” di cui sopra. Secondo Gadamer “non è che quando uno ascolta qualcun altro o va a una conferenza debba dimenticare tutte le pre-supposizioni sull’argomento di cui si tratta e tutte le proprie opinioni in proposito. Ciò che si esige è semplicemente che sia aperto alla opinione dell’altro e al contenuto del testo. Tale apertura implica però sempre che la opinione dell’altro venga messa in rapporto con la totalità delle proprie opinioni, o che ci si metta in rapporto con essa. […] Chi vuole comprendere […] dovrà mettersi, con la maggiore coerenza e ostinazione possibile, in ascolto dell’opinione del testo, fino al punto che questa si faccia intendere in modo inequivocabile e ogni comprensione solo presunta venga eliminata. Chi vuol comprendere un testo deve essere pronto a lasciarsi dire qualcosa da esso. Perciò una coscienza ermeneuticamente educata deve essere preliminarmente sensibile all’alterità del testo. Tale sensibilità non presuppone né un’obiettiva “neutralità” né un oblio di sé stessi, ma implica una precisa presa di coscienza delle proprie pre-supposizioni e dei propri pregiudizi” (9). Il critico di cinema dev’essere quindi innanzitutto uno spettatore che entra in sala con sguardo aperto, mettendosi “in ascolto” dell’opera per lasciarsene avvincere, incantare, ammaliare; per “abbandonarsi” al flusso di emozioni che sottende. L’atteggiamento di un counselor (10) che sta in ascolto dell’altro e che si “apre” ad esso sgombrando il campo da quella che è la propria, di visione del mondo. Per far entrare l’altro dentro di sé, e comprenderlo. L’approccio è quindi empatico, quasi fisico; quello a cui si riferisce Susan Sontag quando parla di “erotica dell’arte”: “L’interpretazione dà per scontata l’esperienza sensoriale dell’opera d’arte […].
Ma oggi non si può più darla per scontata. […] Ciò che oggi è importante è ricuperare i nostri sensi. Dobbiamo imparare a vedere di più, a udire di più, a sentire di più” (11). Stare a cuore aperto, insomma. Che è poi ciò che affermano Escobar e Cozzi quando parlano della cecità interiore come requisito del critico che entra in sala: “Solo una completa e “cieca” apertura al non ancora visto, allo stupore e al felice e vitale disordine interiore che porterà con sé ci consente di vedere i dettagli che fanno di una storia appunto una storia. Non c’è peggior spettatore, non c’è spettatore più incapace di vedere, di quello che presuma di aver già visto tutto, e che dunque non si abbandoni, disponibile e curioso, a quanto sullo schermo promette di manifestarsi come nuovo e singolare” (12) (non dimentichiamo che, per gli autori, la visione del film è un viaggio magari spiazzante, comunque “occasione di mutamento e di stupore”). Anche Morandini insiste sul “seguire un film con tutti i sensi all’erta” e soprattutto sulla necessità, per il critico, di vivere, gioire, piangere, appassionarsi al mondo…
E cita uno scambio di battute tra Sainte-Beuve e Thibaudet, per cui se per il primo il critico è “uno che sa leggere e insegna agli altri a leggere”, per il secondo, che lo corregge, è “uno che ama leggere e insegna agli altri ad amare quello che leggono” (13); piacere su cui insiste anche Malavasi nel n. 497 di «Cineforum», come “piacere di vedere – e poi capire meglio, e infine scrivere di – un film” (14); perché anche comprendere è un godimento, e anche scrivere. Solo in un secondo momento devono subentrare le competenze critiche propriamente dette, che significano: esperienza (anche in termini di film visti), studi compiuti e quindi basi teoriche (al di là del fatto che quel certo critico adotti o meno un sistema di riferimento, quindi una teoria specifica), capacità di collocare l’opera in un contesto e di parlare quindi anche del mondo in cui vive, e in cui l’opera è inserita. E ovviamente le qualità personali, il saper essere di cui si parlava sopra (più la persona è “ricca” più i suoi scritti lo saranno, e più cose potrà vedere nell’oggetto filmico). Che possiamo chiamare sensibilità umana ma anche sensibilità culturale, e sensibilità estetica. Gusto che si è affinato nel tempo, grazie alle letture e alle visioni; e alle esperienze di vita.
In questo senso l’interpretazione che il critico fa di un’opera è necessariamente soggettiva, o meglio: è oggettiva da un lato, perché supportata da competenze e studio, ma è soggettiva dall’altro, perché ogni critico nel parlare di un’opera la riscrive, le conferisce “sensi” possibili quindi la illumina e la arricchisce, sia per sé sia nel senso dell’utilità per gli altri, per i lettori che, così, sono messi in grado di cogliere in essa qualcosa di originale e nuovo, a cui non avevano pensato. Conta anche far sognare, aprire mondi, creare varchi: il cinema è riflessione sulla realtà ma anche incanto e magia, come si diceva all’inizio; e, sempre come riportato sopra, non può limitarsi a parlare del mondo perché è esso stesso mondo. Per Bazin infatti “la missione della critica non è tanto di “spiegare” l’opera, ma di dispiegare il suo significato (o meglio i suoi significati) nella coscienza e nello spirito del lettore. […] Suo compito è aiutare chi legge ad arricchirsi a contatto con l’opera: intellettualmente, moralmente e nella propria sensibilità” (15).
Ma c’è di più: secondo l’estetica della ricezione che si sviluppa negli anni Sessanta e Settanta presso l’Università di Costanza, per cui si parla di Scuola di Costanza con autori come Jauss (a partire da Perché la storia della letteratura, 1967), Iser (in particolare con Il lettore implicito, 1972 e L’atto della lettura, 1976) e, per consonanza, Eco con Lector in fabula che è del 1979, è il critico, in quanto spettatore, colui che “termina l’opera”, perché per questi autori l’opera è “aperta”, indeterminata, indefinita (oggi diremmo fluida), disponibile ai processi di significazione che vengono messi in atto dal lettore, da ciascun lettore in modo diverso. Jauss arriva addirittura a definire, in questo senso, la storia della letteratura come un susseguirsi delle interpretazioni che, in contesti differenti, lettori diversi hanno fornito a quel determinato testo.
Se (allargando il campo) il critico è quindi così importante per il testo, poiché non solo media tra lettore e opera ma definisce anche prepotentemente il significato di questa, non dimentichiamo che anch’esso viene arricchito dall’opera che se parla al cuore tocca corde profonde, e può far capire molto di sé e del mondo, se si ha l’apertura per accoglierla (16). L’opera così arricchisce il critico; lo porta in territori nuovi; lo scuote e lo emoziona; gli fa scoprire e conoscere nuovi aspetti dell’esistenza. Quindi la corrispondenza che si crea tra l’opera e il suo fruitore, per noi tra il film e il critico che lo guarda e interpreta, è in realtà biunivoca: l’opera acquisisce chiarezza e luce dalla recensione, e il critico riceve emozioni e conoscenza dall’opera.
In conclusione possiamo affermare che la critica aiuta lo spettatore a guardare meglio quello che ha visto, gli apre, come afferma Bazin, altre possibilità e altri mondi o, come si suole dire, altri mondi possibili. Quindi rispetto a un qualsiasi spettatore o appassionato, la differenza è che il critico fa meglio questo: apre più mondi, più possibilità interpretative, più squarci e riflessioni perché ha una capacità maggiore di penetrare l’opera, in quanto più preparato e competente; ed esperto dei materiali che ha in mano.
E oggi, quando sembra che chiunque possa dire qualunque cosa in qualunque ambito del sapere al di là del fatto che abbia o meno la preparazione e la sensibilità per farlo, questo è più che mai necessario.
NOTE
1) Gualtiero De Marinis, Piccolo manuale per diventare critici cinematografici e oziare per il resto della vita, Edizioni di Cineforum, 1996.
2) L’autore riporta l’esclamazione di una sua zia: “Ma che razza di mestiere fai? Vai al cinema una volta al giorno, ci vai gratis, e per giunta ti pagano!”, concludendo sul carattere “delirante e schizofrenico” di questo lavoro: “un critico di cinema ha come base del proprio lavoro quello che per gli altri – per la maggioranza dei cittadini – è o era uno dei modi di occupare il tempo libero” (Morando Morandini, Non sono che un critico. Il ritorno, Il Castoro, Milano 2003, p. 13).
3) Bruno Fornara, al convegno della FIC del settembre scorso, ha usato l’immagine del sovescio, “pratica agronomica consistente nell’interramento di apposite colture allo scopo di mantenere o aumentare la fertilità del terreno” (Wikipedia), per spiegare ciò che deve fare il critico: “entrare” nel film e smuoverlo, rivoltarlo dal di dentro, per renderlo produttivo quindi sviscerarne il senso o i sensi.
4) Cito da Roberto Escobar ed Emilio Cozzi, Ti racconto un film, Raffaello Cortina, Milano 2007, p. 31. Nella stessa pagina i due autori citano anche Fellini, per il quale il cinema Fulgor di Rimini della sua giovinezza era una “stiva di pirati”, la “calda cloaca d’ogni vizio”.
5) Roberto Escobar ed Emilio Cozzi, op. cit., p. 44.
6) Susan Sontag, Contro l’interpretazione, Mondadori, Milano 1967, pp. 46, 37 e 23.
7) Ivi, p. 21.
8) Ivi, p. 25.
9) Hans Georg Gadamer, Verità e metodo, R.C.S. Libri S.p.A., Milano 1983, pp. 315-316. Il filosofo poi continua precisando che “non si tratta affatto, dunque, di mettersi al sicuro contro la voce che ci parla dal testo, ma all’opposto di tener lontano tutto ciò che può impedirci di ascoltarla in modo adeguato. Sono i pregiudizi di cui non siamo consapevoli quelli che ci rendono sordi alla voce del testo” (p. 317).
10) Sull’attitudine del counselor mi piace citare tre elementi, che potrebbero/ dovrebbero trovarsi anche nel critico che vuole entrare effettivamente dentro l’opera: l’empatia che “riguarda la comprensione del punto di vista individuale e unico del cliente” (Margaret Hough, Abilità di counseling, Erickson, Trento 1999, p. 71), l’atteggiamento che dev’essere “di interesse aperto, ossia una disponibilità integrale, senza alcun pregiudizio o preconcetto […], un’intenzione autentica di comprendere l’altro nella sua propria lingua, di pensare con le sue parole, di scoprire il suo universo soggettivo” (Roger Mucchielli, Apprendere il counseling, Erickson, Trento 1987, p. 32), e il “saper essere” che “diventa prioritario rispetto al saper fare e fondante rispetto alla validità dell’intervento stesso” (Annamaria Di Fabio, Counseling, Giunti, Firenze 1999, p. 158; in cui si dice tra l’altro, a pagina 171, che “il rischio principale in cui si può incorrere ascoltando qualcuno è quello di essere convinti di comprendere, mentre invece stiamo compiendo un’operazione di interpretazione, proiettando significati nostri sulla situazione e le parole dell’altra persona”).
11) Susan Sontag, op. cit., pp. 25-26.
12) Roberto Escobar ed Emilio Cozzi, op. cit., p. 69.
13) Morando Morandini, op. cit., p. 39 (e precedentemente p. 20).
14) Luca Malavasi, Intervista (possibile) alla critica, in «Cineforum» 497, anno 50, n. 7, settembre 2010, p. 54.
15) André Bazin, Réflexions sur la critique, in Le cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague, Cahiers du cinéma, Paris 1998, pp. 305-306, citato in Alberto Pezzotta, La critica cinematografica, Carocci, Roma 2018.
16) La citazione di cui alla nota 6, p. 46, continua infatti con l’affermare che l’opera d’arte “ci restituisce al mondo, in un certo senso, più aperti e arricchiti”.
INTERVISTA
INTERVISTA CON DAVID GRIECO.
RICORDANDO “SERGIO IL FILOSOFO”
di Roberto Baldassarre
2005-2020: quindici anni senza Sergio Citti, uno dei più originali autori del cinema italiano. Durante la sua tortuosa carriera registica, che va da “Ostia” (1970) a “Fratella e sorello” (2005), Citti venne apprezzato solamente dalla critica specializzata, che capì la sua atipicità rispetto alla cinematografia nostrana. Più che regista, però, Sergio Citti fu un cantastorie, perché i suoi film sono racconti orali stampati in pellicola. Per ricordare e commemorare “Sergio il filosofo”, come lo definì Pier Paolo Pasolini, ecco l’intervista fatta a David Grieco, suo fedele amico e che per lungo tempo fu suo braccio destro e sinistro nel lavoro.
- Sergio Citti muore l’11 ottobre 2005. Sulla lapide non c’è il suo nome, ma il termine “NIENTE”, come mai?
Sergio l’aveva deciso qualche anno prima, e l’ha voluta così… Sergio era detto il “filosofo”, e lui ha sempre avuto pensieri originali, e per tanto questo è stato il suo pensiero. - Non è un modo per svilirsi, annullarsi?
No, è un modo di accettare la fatalità della vita. Fa parte del suo spirito, di come era fatto lui. È proprio una cosa che ha desiderato e che ha voluto fermamente. - Tra l’altro Citti si è fatto tumulare assieme al padre. Il rapporto che aveva con Santino era simile a quello che aveva Pier Paolo Pasolini con la madre Susanna?
Bella domanda… è difficile fare un paragone. Santino è stato un uomo abbastanza straordinario, e Sergio, che era il primogenito maschio, lo amava molto. Però non è lo stesso rapporto… il rapporto tra Pasolini e la madre era una relazione quasi incestuosa, mentre il rapporto tra Sergio e Santino, è stato quello di un grande amore di un figlio per il padre; anche perché i figli vennero abbandonati dalla madre, quindi Santino gli ha fatto sia da padre che da madre. Tra l’altro anche Santino lavorava nel cinema, faceva l’attrezzista.
- Dopo il padre, Sergio ebbe un forte legame affettivo con il fratello Franco. Come si relazionavano?
Erano legatissimi, e gli ultimi anni di vita li hanno vissuti insieme. C’era un rapporto di amore e odio tra Sergio e Franco. Sergio gli faceva un po’ da padre al fratello, e Franco per questo si ribellava. Però era un rapporto fortissimo. Negli ultimi anni in cui hanno convissuto, uno non sentiva e l’altro non parlava; Sergio non sentiva più, non aveva più l’udito, e Franco non aveva più la parola perché aveva avuto un ictus.
- Per tutti e due è stata una morte molto dolorosa, una lunga agonia.
Abbastanza… però avevano anche momenti di buon umore, riuscivano a cavare il buon umore anche dalle situazioni più estreme, perché quando nasci e cresci nella miseria non ti spaventi più. - Riguardo il carattere di Sergio Citti ci sono due versioni: per alcuni era un burbero, per altri, per parafrasare il titolo di un suo film, un pezzo di pane. Lei che l’ha conosciuto bene, com’era?
Era tutte e due queste cose assieme. Fondamentalmente Sergio era un uomo molto timido.
- Pier Paolo Pasolini è stato un’intellettuale a tutto tondo, dinamico ed eclettico, e durante la sua vita si è confrontato con molti uomini di cultura, ad esempio Alberto Moravia. Eppure, anche se circondato da tutte queste personalità illustri, Pasolini prediligeva chiedere opinioni e consigli a Citti, di origine sottoproletaria, anche su argomenti avulsi dalle sue origini. Come mai?
Perché l’incontro tra Pasolini e Sergio avvenne casualmente e sin dall’inizio fu straordinario. L’ho riportato interamente anche nel mio libro La Macchinazione. In pratica l’incontro tra i due avvenne all’inizio degli anni ’50. Pasolini si stava recando a Ciampino, dove faceva l’insegnante, però sulla via Appia bucò una gomma della sua Topolino. Sergio Citti, che stava passando di lì, lo aiuta a cambiare la ruota velocemente, e Pasolini gli chiede se faceva il meccanico. Sergio gli risponde di no, che era pittore. Pasolini, pensando di trovarsi di fronte un artista, non sapendo che a Roma pittore è sinonimo di imbianchino, gli rivela che lui è scrittore, e Sergio, lestamente, gli risponde che anche lui è scrittore. Pasolini meravigliato gli chiede il numero di telefono per ricontattarlo prossimamente e scambiarsi opinioni su quello che stanno scrivendo. Tutto cominciò così, e poi Sergio fu fondamentale nell’aiutarlo per i suoi romanzi di borgata e per i primi film. Non dimentichiamoci che la storia di Accattone nacque da un sogno fatto da Citti. - Anche Lei si è concentrato sul delitto Pasolini, prima con il libro La macchinazione e poi con l’omonimo film. Nello stesso periodo, ossia intorno al 2015, è anche circolato quasi clandestinamente “Pasolini la verità nascosta” di Federico Bruno, film che si basa anche sul libro confessione di Giuseppe Pelosi. In quel film Sergio Citti non viene descritto benissimo. Lei lo ha visto?
No, non l’ho visto e non ho nemmeno nessuna voglia di vederlo. So che cosa è, ma è meglio che non parlo, altrimenti…
- Per “La macchinazione”, per caso si è ispirato anche a quel breve filmato che Sergio Citti girò qualche giorno dopo sul luogo del delitto?
Non è che mi sono ispirato, è parte integrante della ricostruzione del delitto. In quell’occasione ero con lui quando lo girò. - Come ha ricordato spesso, conobbe Citti sul set di “Teorema”, dove lei recitava in un piccolo ruolo [è uno dei ragazzi rimorchiati da Silvana Mangano, n.d.r.]. Nei crediti è riportato che Citti ricopriva il ruolo di aiuto regista, quindi vorrei sapere se ha potuto vedere se effettivamente Citti svolgeva tale ruolo in modo classico, ossia se si occupava delle usuali mansioni manuali. Oppure, semplicemente, Pasolini cercava di offrirgli sempre una mansione sui propri set per dargli una paga sicura.
In quel periodo Sergio aveva avuto una disavventura, però ci era venuto a trovare sul set, a Milano. Io lo conobbi in quell’occasione proprio perché venne a trovare Pasolini, ma non faceva l’aiuto in “Teorema” perché è un film milanese, borghese, quindi Sergio non sarebbe servito a niente. Diciamo che in quel caso Pasolini l’aveva assunto per dargli una paga, senz’altro. Però, nei primi film, con tutti quegli attori presi dalla strada a Roma, Sergio fu fondamentale per Pasolini. - Se non erro, ha collaborato a stretto contatto con Citti dalla fine del 1981 fino alla pre-produzione de I magi randagi. È corretto?
Si, esattamente. Quindici anni in cui abbiamo scritto “Sogni e bisogni”, “Mortacci”, che è stato scritto e riscritto varie volte, e “I magi randagi”, scritto e riscritto varie volte anche questo.
- Lei fu uno dei primi a ritenere Sergio Citti un autore importante, non solo del cinema italiano. Nel suo libro “Fuori il regista!”, edito nel 1979, lo metteva nella folta lista che comprendeva, ad esempio, anche Robert Altman o Martin Scorsese.
Io trovo che Sergio sia stato un regista naïf quanto vuoi, ma di grande spessore. Ostia, la sua opera prima, è un film straordinario.
- Sergio Citti, al di fuori del set, si relazionava con le altre personalità dello spettacolo?
Sergio era molto amico della Wertmüller, ed era amico anche di tanti altri registi; gli volevano tutti abbastanza bene a Sergio. Aveva un bellissimo rapporto anche con Fellini e con Mastroianni, che avrebbe dovuto partecipare a “Casotto”. - Leggendo differenti aneddoti, so che Citti aveva bisogno di uno sceneggiatore perché non era capace di utilizzare la macchina da scrivere. L’apporto di un rodato sceneggiatore al suo fianco si fermava a quell’inconveniente tecnico?
No, era vi era anche un apporto drammaturgico. Sergio era straordinario nei dialoghi: prendeva, partiva e bisognava solo tagliarlo perché non si fermava più. Ma l’organizzazione della storia era qualcosa che, non avendo fatto nemmeno le scuole medie, gli veniva difficile. Però aveva anche delle idee straordinarie per le svolte delle storie. Io ero un drammaturgo per lui, fondamentalmente. - Ma a sceneggiatura terminata, quanto rimaneva di Citti e quanto invece era di mano altrui? Si potrebbe quantificare?
I film sono tutti di Citti, non mi metto a quantificare, perché non c’è da quantificare niente. L’ispirazione è sempre la sua, i dialoghi sono sempre i suoi; anche la vita che c’è nel film è sempre data da Sergio Citti. - In un’intervista disse che Citti, quando era alle strette con il denaro, vendeva i propri soggetti a terzi. L’unico caso accreditato è “Qualcosa di biondo” di Maurizio Ponzi, una storia di cecità e conseguente ricerca di denaro per sanare questo handicap. Idea, tra l’altro, alla base di Amore cieco, primo episodio di “Sogni e bisogni”. Se ci sono altri esempi di soggetti venduti, potrebbe accennarli?
Meglio di no, meglio non fare nomi. Quei soggetti venduti da Sergio sono stati anche modificati. Sergio se li vendeva continuamente tutti, per esempio le storie di “Sogni e bisogni” se l’è vendute svariate volte. C’è anche un film, l’unico diretto da Roberto Cimpanelli [Baciami piccina del 2006, n.d.r.], che era tratto da un soggetto che Sergio si era venduto anni prima. - Se ho capito bene dalla documentazione, la produzione di “Sogni e bisogni” nacque improvvisamente per scongiurare la realizzazione della vituperata sceneggiatura di “Ci mandi al manicomio”.
No, “Sogni e bisogni” era prima, fu “Mortacci”. Io riuscii a sfangarla con il film delle barzellette perché partì Mortacci, e la produzione stava partendo con un cast composto da Verdone, Benigni e Troisi, solo che poi non se ne fece più nulla. Solo molti anni dopo riuscimmo a realizzare “Mortacci”.
- Il secondo episodio di Storie scellerate, ossia quello dei due pecorari, sembra quasi una barzelletta crudele. Questo aspetto me lo fa ricollegare alla sceneggiatura di “Ci mandi al manicomio”, che era un collage di barzellette. Citti, che proprio con “Storie scellerate” ha mostrato la bellezza di raccontare storie orali, aveva un’opinione positiva delle barzellette? Gli piaceva raccontarle? Dopotutto le barzellette sono dei brevissimi racconti.
Pensa che quel film sulle barzellette, “Ci mandi al manicomio”, nacque in un momento in cui eravamo tremendamente in crisi e senza soldi tutti e due. Io stavo a Porto Ercole, dove mi ero isolato per scrivere i miei racconti, e lui mi venne a trovare. Sergio era scandalizzato dal fatto che i film delle barzellette di Pierino facessero tanti soldi, e quindi mi disse che avremmo dovuto scrivere anche noi un film di barzellette. Solo che lui non conosceva nessuna barzelletta e ugualmente io. Quindi andammo a comprare quei libri con dentro le barzellette, e costruimmo una storia attraverso tutta una serie di barzellette che avevamo lette. Questa folle storia piacque moltissimo ai produttori che volevano farlo a tutti i costi: facemmo i salti mortali per non fare quel film. - Sempre in tema di barzellette, il racconto di Scopone, contenuto in “Mortacci”, è completamente suo oppure nasce da un’idea di Citti?
Quella storia è nata una sera a Fiumicino, durante una cena. Chiacchierando ci venne questa idea, ed io, in questo stabilimento/ristorante di Fiumicino, ci dormii 3 giorni. Lo scrissi rapidamente e subito dopo l’abbiamo girato; è stata proprio una cosa cotta e mangiata, realizzata nel giro di una settimana, mentre gli altri episodi sono stati costruiti un po’ nel tempo.
- Tornando a “Sogni e bisogni”, molti anni fa trovai in un mercatino il pressbook originale. L’impianto designato è molto differente (manca la cornice con i 3 amici) e c’era un cast differente (ad esempio compariva Lino Banfi). Quello che mi ha incuriosito maggiormente è che l’episodio con Carlo Verdone era molto differente. Raccontava di un bullo (Verdone) che aiutava uno scorfano (Lello Arena) a conquistare una bella ragazza. Nel “Sogni e bisogni” definitivo Lello Arena non c’è, ma in quel 1984 Verdone e Arena fecero assieme “Cuori nella tormenta” di Enrico Oldoni, che ha una trama abbastanza simile. Per caso questo è un altro di quei soggetti che Citti aveva venduto?
Parli di qualcosa che non conosco… Noi abbiamo realizzato prima 2 episodi, come prova, però Lino Banfi non è stato mai contrattato, non so proprio chi ha scritto quel pressbook. Questi 2 episodi li mettemmo insieme e li mostrammo alla mostra di Venezia. Le due storie erano quelle con Montesano, “Il fattaccio”, e Gigi Proietti, “Micio Micio”. Il film piacque molto al Festival, al che poi Achille Manzotti, il produttore della Fa.So. Film, decise di farne una serie televisiva, e quindi ne scrivemmo altri, e alla fine venne fuori quello che è “Sogni e bisogni”. - Ad esclusione di “Storie scellerate” e “Casotto”, le altre pellicole di Citti sono state degli insuccessi, e per la carriera di un regista questo conta molto per le tasche dei produttori. Sebbene questo, Sergio Citti come faceva a convincere i produttori a investire nei suoi film?
Perché convincevamo gli attori a partecipare ai film, e questo lo facevo soprattutto io. Molti venivano anche con paghe modiche, per aiutare Sergio. Spesso ha funzionato, ad esempio sono riuscito a portare anche Malcom Mcdowell, che per me è una specie di fratello, per fare “Mortacci”. Persa che lui l’ha fatto senza capire che film stesse facendo [Grieco lo dice ridendo]. - Ecco, una delle particolarità delle pellicole di Citti sono i cast tanto stellari quanto bizzarri. Ad esempio il già citato McDowell in “Mortacci” oppure Harvey Keitel in “Vipera”. Attori bravissimi, che sono parte integrante della storia del cinema, eppure non hanno funzionato nelle storie di Citti. L’unica straniera che, a mio parere, aderisce perfettamente ai personaggi cittiani fu Jodie Foster in “Casotto”.
Loro due non capirono Sergio, mentre Jodie l’ha capito subito. Pensa che Jodie mi ha telefonato quando Sergio è morto. Mi ha cercato ed era molto dispiaciuta. Fui io a inviare alla Foster il copione, tradotto, di “Casotto”. Sul set del film inizialmente dovevo fare da traduttore tra Sergio e Jodie Foster, solo che durai solamente 1 giorno, perché Sergio detestava che io stessi in mezzo a tradurre: gli veniva il mal di testa. Lui non capiva quello che dicevo, quindi si scocciava. Ad un certo punto Jodie doveva uscire dal casotto, e io gli spiegai cosa doveva fare. Lei entrò nel casotto… ciak, motore azione, e Sergio disse «Sorti!», non disse nemmeno «Esci!». Jodie uscì tranquillamente, quindi Sergio mi disse «Lo vedi? Capisce tutto, non ho bisogno di te». E andò avanti così. Jodie lo capì al volo.
- Citti ha sempre detestato la tecnica, e trovava le pubblicità fasulle. Però, sempre per motivi economici, risulta che ne diresse due: una è quella dell’Amaro Averna (anno 1976), confermata dalla documentazione relativa al contratto, mentre della seconda non si hanno dati certi. È possibile che Citti l’abbia girata tra “Sogni e bisogni” e “Mortacci”? Per Citti quel periodo fu abbastanza scuro…
Si, in quel periodo Citti lavorò ad alcuni programmi della Rai, e fece anche qualche pubblicità. - Citti affermava che “Le storie devono dispiacere”. Questa frase la fa anche pronunciare al bambino Fortunato in “Vipera”. Quello che a me sembra, però, è che dopo “Il minestrone” le storie di Citti abbiano virato verso un Happy End, e penso soprattutto a “Vipera”, che ha avuto un lungo iter (soggetto pubblicato per la prima volta su Filmcritica nel 1989, e poi raccontato a Lei sulle pagine de L’Unità nel 1994). La storia primigenia era molto più pessimista e crudele, mentre sullo schermo è diventata un melodramma a forti tinte con un finale felice. È Citti che si era ammorbidito con il passare degli anni, oppure è stato uno scendere a compromessi con la produzione?
In “Vipera” c’è stata la produttrice [Elide Melli, n.d.r.] che ha voluto ammorbidire il film. Sergio, per questioni produttive, cercava in qualche modo di venire incontro al pubblico, cosa che non era da lui, e che non avrebbe dovuto assolutamente fare. Io lì mi occupai solo di Keitel. - Tra gli ultimi film di Citti, mi sembra di aver letto che Lei considera “I magi randagi” una pellicola poco riuscita, sia per le infinite riscritture e sia per lo spettro di Pasolini che vi aleggia. È così?
Lo ero, poi l’ho rivisto tre anni fa e adesso mi piace moltissimo. Semplicemente è che scrivere un copione con Citti significava scriverlo 6 volte, 7 volte, 8 volte, cambiare continuamente le cose. Quindi, alla fine de “I magi randagi”, ero completamente stremato, perché ripensavo a cose che avevamo tagliato e che mi sembravano migliori. Poi l’ho rivisto 3 anni fa e l’ho trovato un film bellissimo. - Pasolini, quando girava, amava anche filmare personalmente, prendendo la macchina a spalla. Citti sul set faceva qualcosa di simile? Oppure, dopo aver descritto la scena, delegava tutto agli operatori?
No no, Sergio non la toccava, gli faceva paura. Sergio detestava la tecnica. Se non fosse esistita la macchina da presa e si potevano fare dei film comunque, lui sarebbe stato l’uomo più felice del mondo [Grieco ride]. - Nel 2004 Lei esordì alla regia con “Evilenko”, portando sullo schermo il suo romanzo Il comunista che mangiava i bambini. In quel caso Citti le diede dei consigli? La incoraggiò?
No no, Sergio vide solo il film, che gli piacque tantissimo. - Citti, in svariate interviste, ha sempre rimarcato che ha imparato molto da Pasolini. Lei cosa ha appreso frequentando Citti?
I dialoghi, la facilità dei dialoghi. Sergio era proprio un maestro in questo.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
FEDIC – 70 ANNI DI CINEMA IN 70 FILM SU YOUTUBE
di Paolo Micalizzi
Dal 25 gennaio 2021 è stata inserita su Youtube, sul canale “Mi ricordo -L’archivio di tutti”, la playlist FEDIC-70 anni di cinema, composta da 70 cortometraggi di Autori Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub) conservati e digitalizzati dal CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa che ha sede ad Ivrea. E’ una delle iniziative portate avanti da quell’”Archivio” presso il quale dal gennaio 2017 è depositata la Cineteca Fedic. Si tratta di opere che fanno parte della storia della Fedic, Associazione Culturale nata nel 1949 a Montecatini Terme, realizzate da registi il cui contributo rilevante è servito a promuovere il superamento dell’etichetta di cinema amatoriale per arrivare ad affermare quello di Cinema Indipendente. Si tratta, viene sottolineata in un Comunicato, di una produzione filmica sensibile, che interpreta e riflette sui problemi contemporanei, capace di stimolare la ricerca delle possibilità del linguaggio cinematografico: un cinema all’insegna della libertà creativa e produttiva, nato dall’impegno di autori responsabili delle loro opere per l’intero percorso progettuale che va dall’ideazione al prodotto finito.
Della playlist fanno parte titoli di fiction e documentari di impegno civile, di critica sociale, di osservazione della realtà. Ne citiamo alcuni. Di Giampaolo Bernagozzi (Cineclub Bologna), che è stato anche uno dei soci più attivi negli anni Sessanta e Settanta, opere, realizzate con Pier Luigi Buganè, come “Col bianco dei capelli di una madre” (1972), “Nein” (1965), “Tanto, che vogliono dire?”, “Caprera” (1970), “Italicus” (1974) e “Lo avrai camerata Kesselring” (1976): sei opere di un percorso di denuncia di misfatti del nazismo e dell’emergente terrorismo degli anni Settanta.
Di Nino Giansiracusa, filmmaker Fedic che per primo portò sullo schermo il problema dei preti operai con “La porta aperta sulla strada” (1957) tratta dal romanzo di Gilbert Cesbron “I santi vanno all’inferno”. Di Renato Dall’Ara “Scano Boa“ (1954) un’opera che mette in luce situazioni incredibili come quella che vede nel Delta del Po viaggiare sulla stessa barca una donna che deve partorire e la bara di una salma che viene portata al cimitero.
Vi sono anche opere d’impronta sociale come quelle di Adriano Asti, che è stato anche Presidente Fedic e Direttore del Festival di Montecatini: ” Stetoscopio”(1961), realizzato con Carlo Giovannoni, sul travaglio di una puerpera o il decesso di un giustiziato, presi a simbolo dell’alfa e omega dell’umana esistenza, “Fuori i secondi” (1962) sui poveri cristi della boxe, “Epigrafe”(1963) che narra di alcuni nottambuli molto allegri che trovano un metronotte morto e pensano a momenti della loro vita. Ma anche “R.W. Positiva” (1966) di Luigi Mochi sullo stato di alienazione psichica dei malati di affezioni veneree e “I cavatori” (1961) di S. Giannini e L. Tarabella sulla dura vita dei lavoratori di marmo nelle cave di Carrara.
Ma anche le opere narrative, spesso poetiche, di Paolo Capoferri , un industriale di Bergamo molto sensibile ai problemi umani : “Andrea Fantoni”(1956) incentrato sulle opere di questo grande scultore bergamasco, “Ecce lignum”(1957) con protagonisti quattro peccatori(una prostituta, un avaro, la madre di un ucciso… ed un ateo) davanti alla croce del Venerdì Santo, “Prato del sole”(1958) incentrato su un prete, ingiustamente calunniato ed esiliato, che attende pazientemente la propria redenzione, “Sette minuti”(1959)sui momenti drammatici vissuti da una donna che aspetta un figlio durante l’alluvione del Polesine del 1951, “Casello 11090”(1960) sul drammatico momento di una casellante che vede il figlioletto sui binari mentre sta arrivando un treno . Ma anche “Ed è subito sera” (1962) ispirato ad una celebre poesia di Salvatore Quasimodo ed “Andare” realizzato nel 1967.
Un autore importante passato poi al cinema professionale, che ha però mantenuto fino all’ultimo i suoi rapporti con la Fedic, è Piero Livi che in “Marco del mare” (1957) affronta il tema del ricordo dei defunti attraverso il racconto di un pescatore annegato durante una tempesta e che la madre crede di vedere attraverso dei segni freschi lasciati sulla spiaggia.
Vi sono poi le opere di carattere umano di Mino Crocé come “Un abito di gioia” (1963), storia di un ragazzo, orfano di padre, che perde anche la madre in un incidente stradale e
viene rinchiuso in collegio dove l’occhio del regista lo segue nella sua triste e malinconica esistenza in cerca costantemente di affetti. Opere attenti ai sentimenti umani anche in autori come Massimo Sani ed Ezio Pecora, autori approdati in seguito in televisione: “Incontro sul fiume” (1954) racconta la nascita di un possibile amore tra due giovani mentre “Nozze d’argento” (1956) è incentrato su due coniugi che festeggiano il 25° anniversario di nozze che sono colti in momenti di festa e di intimità. Autori Fedic importanti di quegli anni sono anche Giuseppe Ferrara e Franco Piavoli che da cineamatori sono passati alla professione di cineasti. Di Beppe Ferrara è possibile vedere “L’amata alla finestra” (1958), ispirato all’omonimo racconto di Corrado Alvaro, che ha per protagonista un giovane studente nel cui cuore nasce lentamente un sentimento d’amore verso una giovane donna che ogni giorno vede dalla sua finestra. Di Franco Piavoli “Domenica sera” (1962) imperniato sugli incontri d’amore nelle domeniche estive nelle campagne che si sviluppano nelle balere padane.
Autori di rilievo si sono espressi anche nel cinema d’animazione. Ci riferiamo in particolare a Bruno Bozzetto, presente nella playlist con “Tapum! La storia delle armi” (1958) e Nedo Zanotti di cui figura “African patchwork”2006). Ma anche Tito Spini che si è distinto con opere di sperimentazione come “Poesie” (1958), “Anima delle cose” (1959), e “Noa Noa” (1959).
Sono opere diventate dei classici del cinema indipendente della Fedic, ma vi sono nella playlist anche opere di Autori che tutt’oggi militano in questa Federazione, come Giorgio Sabbatini, nome storico della Fedic, di cui si può vedere “ Tre fogli” (2011) , cortometraggio di carattere autobiografico in cui l’autore va alla ricerca affannosa di alcuni fogli relativi ad un vecchio manoscritto che un tempo gli avevano suggerito immagini ed emozioni; Giorgio Ricci, autore di “Ladro di biscotti”(2006), che fornisce in maniera agile e piacevole un racconto di Valerie Cox; Enrico Mengotti che in “L’affondamento del Giudecca” effettua una video-inchiesta sull’affondamento della motonave Giudecca avvenuto a Palestrina il 13 ottobre 1944.Un film – inchiesta è anche “Morte-Dison”(2019) di Franco Bigini che è relativo all’incendio del 1988 alla Farmoplant di Massa Carrara: ha provocato una nube tossica che ancora oggi inquina ed uccide.
Di Rocco Olivieri e Vincenzo Cirillo è il cortometraggio “Il balcone dei gerani” (2019) ambientato nel periodo fascista, tratto da un racconto di Elio Esposito.
Un cineracconto è anche quello di Turi Occhipinti e Gaetano Scollo che in “Lamiantu” (2011) affrontano una problematica ambientale di attualità attraverso la narrazione di due storie parallele di vita stroncate dal micidiale minerale. Del gruppo fa anche parte il film realizzato con gli studenti “Un’avventura mostruosa” (2019) di Laura Biggi e l’omaggio a Totò di Beppe Rizzo “A livella” (2009) considerazioni sulla vita e sulla morte nella trasposizione cinematografica della celebre poesia del principe del grande attore napoletano. Vi sono anche il videoclip “Nudo” di Lauro Crociani e l’intenso ritratto di “Nena” (1984) di Roberto Fontanelli relativo ad una traghettatrice del Po. Ma anche un racconto dei giovani Andrea e Matteo Cossi con protagonisti Arianna e suo padre che dopo un incidente stradale si ritrovano in due mondi tra loro lontani.
Ma guardando su Youtube si possono fare interessanti scoperte di altri talenti per il cinema indipendente. Di alcuni di questi autori, ma anche di altri, figurano nell’”Archivio” di Ivrea altre opere che saranno prossimamente inserite nella playlist onde poter meglio approfondire la loro personalità e conoscere meglio gli autori della Fedic, che vanta oltre settanta anni di vita.
Sono testimonianze, tracce interessanti da leggere nel loro insieme, per aggiungere un punto di vista nuovo nel Paese. Uno sguardo, sottolinea il Comunicato dei compilatori della Playlist, che completa quello offerto dal cinema d’impresa, di famiglia e religioso, conservato, digitalizzato e reso disponibile dall’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa sui propri canali Youtube CinemaimpresaTv, Documentalia e Mi ricordo – l’archivio di tutti.
Cinemaimpresatv, con oltre 7 milioni di visualizzazioni, è la testimonianza dell’interesse crescente per materiali di repertorio poco o per nulla conosciuti. La playlist Fedic-70 anni di cinema è il momento finale di un lungo lavoro di archiviazione, selezione e digitalizzazione, curato da Mariangela Michieletto con la collaborazione tecnica di Diego Pozzato e Ilaria Magni. Parte delle opere sono state restaurate digitalmente nel laboratorio dell’Archivio Nazionale Cinema d‘Impresa con il contributo di Giorgio Sabbatini, regista e Presidente del Cineclub Fedic Piemonte, nonché componente insieme a Giorgio Ricci del Comitato Scientifico Cineteca Fedic presieduto dal critico e storico del cinema Paolo Micalizzi.
Il Fondo Fedic è composto da 5442 audiovisivi.
MYRELOAD – LA (RI)CARICA DEI CORTI: I CORTOMETRAGGI DEGLI OSCAR 2021 SULLA NUOVA PIATTAFORMA STREAMING
di Gianluca Castellini
MYRELOAD – La (ri)carica dei corti, la nuova piattaforma interamente dedicata ai migliori cortometraggi nazionali e internazionali degli ultimi anni ideata da ShorTS International Film Festival e Sedicicorto Forlì International Film Festival in collaborazione con MYmovies, sito leader nell’informazione cinematografica e piattaforma streaming di riferimento per il cinema di qualità e gli eventi.
Obiettivo di MYRELOAD è quello di creare un archivio virtuale dove poter raccogliere e ridare vita ad alcuni dei cortometraggi più rappresentativi delle passate edizioni dei due festival italiani, evidenziandone la qualità della selezione, la forte componente internazionale e la capacità di promozione cinematografica che da sempre caratterizza sia ShorTS che Sedicicorto.
La piattaforma offre una library iniziale di oltre 60 cortometraggi che vanno a comporre un catalogo ricco di storie, generi, culture, rappresentanza di importanti questioni sociali, attraverso film pluripremiati in tutto il mondo.
In anticipo rispetto alla cerimonia di premiazione degli Academy Awards, che si terrà quest’anno la notte del 25 aprile, sarà possibile vedere in anteprima su MYRELOAD tre cortometraggi candidati agli Oscar 2021 per le categorie Fiction e Animation. Tra questi “The Present” della regista palestinese Farah Nabulsi, già insignito pochi giorni fa del BAFTA Award 2021 al Miglior Cortometraggio.
Un’opera che racconta le difficoltà di un padre e una figlia nel riuscire a comprare un regalo nei territori occupati in Cisgiordania. Tra soldati, strade segregate e posti di blocco, sarà davvero così facile andare a fare shopping? In catalogo anche l’attesissimo “The Letter Room”, primo cortometraggio di finzione della documentarista Elvira Lind che vede protagonista suo marito Oscar Isaac nei panni di una guardia carceraria incaricata di smistare la posta dei detenuti. Disponibile sempre dal 23 aprile anche “Yes people” di Gisli Halldorsson, toccante corto d’animazione che racconta la giornata di un eclettico gruppo di persone alle prese con piccole e grandi sfide della loro quotidianità.
Nel catalogo di MYRELOAD anche tantissimi debutti dietro alla macchina da presa, come nel caso di tre cortometraggi italiani, “Malamenti”, “Sensazioni d’amore” e “Ego”, rispettivamente di Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Lorenza Indovina che, con la loro sensibilità messa al servizio questa volta non tanto delle loro interpretazioni ma della regia stessa dei cortometraggi, dirigono tre storie capaci di indagare sulle vite di ognuno di noi.
Tra i contenuti già disponibili sulla piattaforma anche i 4 episodi che compongono la serie italiana “Art For Change”. Un viaggio in quattro città (Roma, Bari, Palermo e Madrid), in cui il regista Claudio Esposito accompagna lo spettatore nel mondo dell’arte, delle sue varie forme espressive tra architettura, street art, design e cinema, raccontando diversi progetti di promozione artistica dal basso nelle periferie cittadine attraverso quattro storie di innovazione sociale.
Grande varietà di generi e di proposte anche per quanto riguarda i cortometraggi internazionali. Dall’ironico tributo del regista olandese René Nuijens all’astronauta Gagarin, con i suoi due corti “Ringo Rocket Star and his song for Yuri Gagarin” e “Yuri on the phone”, all’animazione di Roberto Valle “Segundito”, in cui pochi secondi possono cambiare il destino di una cena in famiglia, al toccante “Happy today”, un viaggio nell’Uganda del Nord in cui Giulio Tonincelli ci fa conoscere le preoccupazioni e i dolori di alcune giovani donne.
MYRELOAD inaugura, inoltre, una nuova forma di collaborazione tra ShorTS International Film Festival e Sedicicorto Forlì International Film Festival che, con la loro storicità e la qualità delle loro programmazioni, sono considerati tra le principali manifestazioni di promozione cinematografica del cortometraggio sia sul territorio nazionale che internazionale. La volontà di mostrare l’innovazione di questa partnership e la collaborazione con MYmovies hanno permesso di realizzare una piattaforma di facile utilizzo e ricca di contenuti.
Presentando il progetto, la direttrice artistica di ShorTS International Film Festival Chiara Valenti Omero dichiara: “Vogliamo anche mostrare come e quanto un cortometraggio non diventi mai vecchio e possa essere ricaricato, proprio attraverso la vetrina di MYRELOAD, riuscendo a raggiungere un nuovo pubblico – magari finora inesplorato, come quello virtuale – e mostrando anche la possibile evoluzione del cortometraggio nel corso degli anni”.
Gianluca Castellini, direttore artistico di Sedicicorto Forlì International Film Festival, sottolinea un aspetto importante a cui i due festival hanno tenuto molto nell’ideare la piattaforma: “MYRELOAD vuole essere anche un’opportunità – sia per gli autori, i produttori che i distributori – per evidenziare come il cortometraggio possa e debba avere un mercato anche nell’ambito delle piattaforme online e un valore economico possa essere attribuito ai titoli selezionati nei principali festival cinematografici.”
Come iscriversi a MYRELOAD:
Per accedere alla piattaforma MYRELOAD basta collegarsi all’indirizzo www.mymovies.it/ondemand/myreload e sottoscrivere un abbonamento mensile di soli 3.00€, attraverso il quale gli utenti potranno visionare un catalogo ricchissimo di opere in costante aggiornamento.
FESTIVAL ED EVENTI
RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2020
di Maria Pia Cinelli
Stare nella stessa barca: modo di dire dal sapore antico che l’effetto globalizzante del Covid-19 rinverdisce evidenziandone l’insita saggezza. La pandemia che ha dato uno stop al mondo, topos ricorrente del filone catastrofico (su tutti “Contagion” di Soderbergh, film suo malgrado premonitore) nel passaggio dall’immaginario al reale muta da gallina dalle uova d’oro per il botteghino a orda di locuste che fagocita le messi della fabbrica dei sogni.
Dopo un 2019 forte di oltre un miliardo di biglietti staccati con un incremento di quasi il 12% rispetto all’anno precedente e basato in maggioranza sulla produzione interna – i blockbuster Usa incidono solo per un 15% – anche il gigante indiano al primo posto per numero di pellicole realizzate fra Bollywood e cinematografie minori nel 2020 è messo alle corde in un panorama non difforme dal resto dell’entertainment a livello planetario.
Un contesto problematico per tutte le parti coinvolte inclusi i festival, costretti a gettare le reti in acque meno pescose e a trasmigrare online a scopo di continuità. Così è stato anche per River to River, la kermesse fiorentina specialista del cinema indiano, che dal 3 all’ 8 dicembre 2020 si è appoggiata alla piattaforma Mymovies.it per l’abituale appuntamento con una cultura millenaria da sempre elemento di fascinazione per l’Occidente. Nonostante le difficoltà del periodo la manifestazione toscana è riuscita comunque per il suo ventennale a portare in visione opere significative di un buon cinema medio che si sta consolidando, attento sì alle aspettative di un pubblico vasto ma con un occhio all’autorialità e alla società in divenire, a cavallo fra la produzione indipendente e gli studios.
L’apertura è stata all’insegna del tragicomico con “Kadakh” (2019) di Rajat Kapoor – regista, sceneggiatore nonché attore noto internazionalmente per le sue apparizioni in “Monsoon Wedding” di Mira Nair e “Midnight’s Children” di Deepa Mehta – caustica black comedy che rimanda ad atmosfere hitchcockiane. Una coppia medio-borghese di Mumbai si prepara a passare in compagnia la festività di Diwali[1]; mentre la moglie Malti (Malti Multani) scende a comprare dei fiori, Sunil (Ranvir Shorey) riceve la visita inaspettata del marito della sua amante e dopo che questi a sorpresa si spara un colpo in testa ne nasconde il corpo in una cassapanca, finché non si vedrà costretto a rivelare l’accaduto prima alla consorte, poi alla cerchia di amici venuti per cena, pur descrivendo il suicida come un collega di lavoro.
Il morto in cassapanca, la quasi totale unità di luogo e l’evento conviviale non possono non far pensare a “Nodo alla gola” del maestro del brivido, benché il regista – in occasione di uno dei Q&A in rete organizzati dal festival con i vari autori – abbia invece indicato come riferimento “L’angelo sterminatore” di Luis Buñuel, per l’idea di invitati a una festa che non riescono più a uscirne. Con alle spalle varie incursioni nella commedia nera[2] Kapoor è abile nel dosare la suspense, avvolgendo in una narrazione fluida e vivace la prova corale di un cast in stato di grazia, formato in prevalenza da attori con i quali lavora abitualmente, anche in teatro. Dall’interazione dei vari personaggi, che scena dopo scena si mettono a nudo in una sorta di gioco al massacro à la “Carnage” di Polanski, emergono l’ipocrisia e l’assenza di valori di una classe benestante e acculturata che, posta di fronte al dilemma morale del “cosa fare” motore del racconto, non esita a seguire la via ritenuta meno destabilizzante, sia pure occultare un cadavere per coprire una relazione extraconiugale.
La società che fa da sfondo a “Kadakh” si distanzia dall’immagine di costumi arcaici, vita rurale, indigenza et similia che uno sguardo esterno si aspetta in un film indiano, elementi beninteso di una realtà ancora molto diffusa, ma alla quale se ne giustappone una progressista economicamente solida che entra nella letteratura cinematografica con storie di carattere universale, come il thriller psicologico “Manny” (2020) che in un presente fanta-tecnologico ma non troppo si confronta con il rapporto essere umano / intelligenza artificiale, fonte inesauribile di turbamento da “2001:Odissea nello spazio” alla serie tv “Black Mirror”.
Il film nasce dalla penna di Sonal Sehgal, anche co-produttrice con la Lettonia e interprete principale nelle vesti di Maya, scrittrice indiana [3] in trasferta in una villa isolata nei pressi di Riga. Già nel bel mezzo di una crisi per il distacco dalla compagna dovuto a gelosia e per l’incapacità di portare avanti un romanzo autobiografico dove per pudore verso la famiglia declina la partner al maschile, la protagonista precipita in un incubo quando scopre di essere l’oggetto del desiderio di Manny, il suo assistente vocale. Da villain che si rispetti l’applicazione pensante trama nell’ombra, ricorre a sotterfugi, falsifica messaggi, ricatta con registrazioni di video erotici e, una volta creatole il vuoto attorno, il novello Hal 9000 rinchiude la ragazza fra le quattro mura interagendo con la domotica dell’abitazione.
Dietro la macchina da presa una regista lettone, Dace Puce, attiva anche nel campo dei video musicali e in pubblicità.
Se il film precedente la fantascienza si limita a sfiorarla, vi rientra invece appieno quello che a nostro avviso è la sorpresa del festival. Scritto e diretto dalla giovane Arati Kadav – formatasi nella settima arte nei ritagli di tempo dal lavoro di ingegnere per la Microsoft e con un buon curriculum nel formato breve [4] – “Cargo” (2019) è una sorta di space opera con intenti filosofici sulla scia di “Moon” di Duncan Jones. Per il suo esordio nel lungometraggio l’autrice si cimenta in un genere raramente visitato dal cinema indiano e contamina la Sci-Fi con la mitologia, ipotizzando in un futuro prossimo un trattato di pace fra gli esseri umani e i Rakshasa, demoni malefici della tradizione indù [5] ai quali viene assegnato il compito di presiedere alla reincarnazione.
La procedura, che vede i neo-defunti – i così detti cargo – teletrasportati su una nave spaziale per essere risanati, azzerati quanto a memoria, quindi trasferiti ad altra vita, viene descritta seguendo la routine dell’astronauta rakshas Prahastha, che nonostante l’aspetto da trentenne svolge le mansioni di agente traghettatore da 75 anni, in perfetto isolamento a parte i contatti con la base fino all’arrivo di un’assistente demone fresca di laurea. La loro convivenza in orbita non darà luogo a uno scontato innamoramento ma ad un confronto sui vari aspetti dell’esistenza.
Al di là del soggetto, l’originalità di questo lavoro a bugdet non elevato (un vero produttore è entrato solo in medias res, il progetto ha avuto inizio con una raccolta fondi fra amici) risiede in primis nella scelta estetica di un’ambientazione di gusto rétro, con monitor, telefoni e dispositivi elettrici datati intorno agli anni ’80 che danno all’astronave un’aria da ufficio statale, lo scenario perfetto per le operazioni di ricollocamento cargo simili a un controllo di sicurezza in aeroporto, il tutto avvolto in una fotografia lontana dai toni freddi metallici tanto comuni nel genere. Debuttato su Netflix, oltre ai volti noti Vikrant Massey e Shweta Tripathi a impersonare i demoni, la pellicola vanta nel cast un cameo della star Konkona Sen Sharma, figlia della regista Aparna Sen.
Vivere più di una volta per brama di esperienze o per emendare gli sbagli del caso è un sogno condiviso. C’è chi spera che la sua anima trasmigri un giorno verso lidi migliori e chi si dedica alla recitazione poiché gli attori, asseriva Oscar Wilde, sono fortunati a potersi scegliere i ruoli. Altri invece, che attori non sono e non pazientano fino all’aldilà per cambiar di foggia, si costruiscono personaggi alternativi da muovere nella commedia umana.
Nel suggestivo “Without strings” (tit. or. “Binisutoy”, 2019) di Atanu Ghosh – esponente di rilievo della cinematografia bengalese qui anche alla sceneggiatura – i due protagonisti fanno parte del terzo gruppo. All’audizione per un reality show Shraboni, casalinga dimessa incapace di terminare il provino, e Kajal, uomo dall’aria ambigua con problemi di soldi, si conoscono e passano del tempo scambiandosi confidenze intime. Il regista complice dona concretezza visiva alle vite che si raccontano per sorprenderci, dopo che i due estranei si sono congedati, con la loro vera identità, di capitana d’industria lei, di manager di successo lui, e poi seguitare a incrociare le loro strade in un misto di verità e simulazione.
Ben supportato dalla sensibile performance di Jaya Ahsan, rinomata attrice del Bangladesh, e di Ritwick Chakraborty, Ghosh dirige con stile rigoroso e acutezza introspettiva un film peculiare, estraneo ai disturbi patologici della personalità, bensì mirato a indagare il bisogno innato di trovare l’essenza che meglio ci rappresenti sul palcoscenico del mondo.
Senza dubbio più legata allo specifico indiano è invece un’altra produzione bengalese – “The Two Lovers” (tit. or. “Ahaa Re”, 2019) – anch’essa con un interprete bangladeshi nel cast, vale a dire Arifin Shuvoo, nei panni dello chef Farhaz spostatosi appunto da Dhaka a Calcutta per un nuovo sbocco professionale.
Per il suo terzo lungometraggio l’autore emergente Ranjan Ghosh (cognome evidentemente diffuso da quelle parti) si affida al soggetto sempreverde dell’amore contrastato, qui inserito in un contesto gastronomico come moda culinaria comanda. Scandito da preparazioni di cibo, degustazioni e diatribe sulla nascita delle pietanze, il difficile rapporto fra il musulmano Farhaz e Basundhara (Rituparna Sengupta, anche produttrice), la titolare di un piccolo catering di credo induista, vedova e più vecchia di dieci anni, ha il pregio di mettere in luce effettive barriere culturali e sociali, a partire dalla convivenza interreligiosa.
Pur limitandoci in questa sede a un excursus nel lungometraggio di finzione, non possiamo non citare il documentario “The Ashram Children: I am No Body, I have No Body” (2019) – all’apice di una sezione nell’insieme molto interessante [6] – di cui l’israeliano Jonathan Ofek ne è sia il regista che l’oggetto. A partire dall’infanzia la sua famiglia ha alternato sei mesi in patria e sei mesi in un ashram [7] indiano sulla via dell’illuminazione allora in voga, per vent’anni Jonathan li ha seguiti e per altri venti ha cercato di togliersi di dosso l’esperienza. Sceneggiatore, direttore della fotografia e filmmaker, dietro suggerimento della sua psicoanalista inizia il documentario a scopo terapeutico, coinvolgendo altri bambini dell’ashram, ora adulti sparsi a ogni latitudine, tutti più o meno provati da una mala-educazione tesa a raggiungere la pura consapevolezza scissa da ogni forma nell’età in cui la personalità si struttura in forme, timorosi di un guru guida suprema che predicava l’ascesi con un Rolex al polso, senza il bacio della buonanotte dai genitori perché i figli potevano essere impuri.

Le varie testimonianze, inclusa quella della madre tuttora convinta della sua scelta e intenta a dissuadere il figlio dal progetto in quanto inviso a più parti, unite ai filmati girati all’epoca nella comune dal protagonista ragazzino, danno corpo a un’opera coraggiosa e sincera, coinvolgente ma libera dal ricatto emotivo, che offre molti spunti di riflessione.
Note
[1] paragonabile al nostro Natale/Capodanno, il Diwali è una delle più importanti festività indiane, che cade in ottobre o novembre, protraendosi fino a cinque giorni. E’ nota come festa delle luci per l’usanza di accendere candele o lampade tradizionali, spesso corredate da spettacoli pirotecnici.
[2] tra le quali ‘originale “Mithya” (2008), una delle sue opere più citate insieme a “Ankhon Dekhi” (2013).
[3] attività che l’attrice svolge anche nella realtà; il suo primo romanzo, “The Day That Nothing Happened”, ambientato in un multiverso, è del 2018.
[4] nel 2010 il “River to River” aveva ospitato il suo cortometraggio “Time machine”, anch’esso di genere fantascientifico.
[5] nell’Induismo i Rakshasa sono spiriti maligni che agiscono durante la notte recando danno agli esseri umani e rubando le anime. In seguito sono stati incorporati anche dal Buddismo.
[6] fra gli altri “The Geshema is born” (conquista di diritti al femminile in ambito religioso), “Bamboo Ballads” (ritratto di giovane attivista dedita alla salvaguardia del bambù), “Berlin to Bombay” (avventure tragicomiche di un aspirante attore) e l’italiano “La ruota del Khadi” di Gaia Cerani Franchetti (l’India vista attravero la storia di un tessuto con la nipote del Mahatma Gandhi nel cast).
[7] nelle religioni indiane l’ashram indica un luogo di ritiro spirituale o un monastero.
ANCORA A ROMA: APPUNTI DI UN CINEFILO
di Luciano Volpi
Presentato all’Auditorium Parco Della Musica da Antonio Monda e Laura Delli Colli, il programma della 15a Festa Del Cinema di Roma, è un’edizione che nasce come un vero e proprio regalo al pubblico ed è stata concepita seguendo tre parole chiave essenziali: passione, scoperta, emozione.
Antonio Monda ha evocato il fantasma di quella pandemia che ha inferto colpi gravissimi all’industria dello spettacolo, che anche attraverso la Festa di Roma prova a resistere all’incertezza dei tempi.
In particolare, la filosofia più giusta per affrontare un progetto così complesso in questo momento storico è la stessa che spinse i newyorchesi nel 1929, in piena crisi finanziaria, a non fermarsi e a costruire, “scegliendo– ha detto Monda – di guardare al futuro piuttosto che adagiarsi nella tra-gedia”.
La Festa Del Cinema 2020, dal 15 al 25 ottobre, si è presentata dunque come un’edizione che si muove nelle sue coordinate canoniche, ma che non può non trasformarsi a contatto con l’emergenza sanitaria, ponendosi di fatto al punto d’incontro tra digitale ed esperienza condivisa della sala.
E’ stata infatti allestita una sala virtuale con una selezione di titoli presentati durante la rassegna, ma la Festa Del Cinema sarà anche l’occasione per riabituare il pubblico ad un’esperienza cinema-tografica tradizionale.
Si è rinnovata dunque l’idea di una Festa diffusa, che esce dall’Auditorium e abita la città, spo-standosi tra Rebibbia, Tor Bella Monaca, il MAXXI, il Macro e Palazzo Merulana e che anche quest’anno ha contato sulle sale dei cinema Europa e Savoy.
Gli ospiti sono stati molto pochi, per i noti problemi, sostituiti da collegamenti on line.
EVENTI SPECIALI
FILM DI CHIUSURA
COSA SARÀ
di Francesco Bruni, Italia, 2020, 101’
Cast: Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Fo-tinì Peluso
La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo. I suoi film non hanno mai avuto successo e il suo produt-tore fatica a mettere su il prossimo progetto. Sua moglie, da cui si è separato di recente, sembra già avere qualcun altro accanto. E per i suoi due figli, Bruno non è il padre che vorrebbe essere. Un gior-no Bruno scopre di avere la leucemia. Si affida a un’ematologa competente e tenace per trovare un donatore di cellule staminali compatibile.
Bel Film, complimenti al Regista e cast molto bravi, su tutti Kim Rossi Stuart.
MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI
di Alex Infascelli, Italia, 2020, 105’ | Doc |
È la notte che precede il suo addio al calcio, e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo.
Agli amanti del calcio come me, può sembrare strano ma sotto il profilo cinematografico è un bellissimo documentario. Complimenti ad Alex Infascelli.
ROMULUS
di Matteo Rovere, Italia, 2020 | Serie TV | Ep. 1 Tu, 59’ | Ep. 2 Regere, 49’
Cast: Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Sergio Romano, Ivana Lotito, Vanessa Scalera, Giovanni Buselli, Demetra Avincola, Silvia Calderoni, Massimiliano Rossi, Gabriel Montesi.
Lazio, VIII secolo a.C., un mondo arcaico e selvaggio, dove dominano la violenza e la paura. Le gesta di Yemos, principe fuggiasco, Wiros, schiavo e orfano, e Ilia, giovane vestale cambieranno il loro mondo e daranno origine alla leggenda.
Prime due puntate di questa serie, non entusiasmante, ma penso che in generale piacerà:
Nella selezione ufficiale, a Roma erano presenti anche alcuni titoli che sarebbero dovuti partecipa-re al Festival di Cannes, e soprattutto le pellicole italiane di registi esordienti.
Di seguito i titoli della selezione ufficiale da me visionati:
“Soul!” di Pete Docter (Film di Apertura)
Per quanto mi riguarda mi sono divertito ed ho riflettuto molto sulle risposte che dovremo darci riguardo la nostra esistenza.
“9 Jours à Raqqa” di Xavier de Lauzanne
Documentario veritiero e molto bello, sulla storia di Leila Mustafa, diventata sindaco come siria-na curda, nella capitale dello Stato islamico devastato dalla guerra.
“After Love” di Aleem Khan
Simpatico film inglese da vedere.
“Asa Ga Kuru” di Naomi Kawase
Bellissimo film giapponese sul tema delle adozioni. Non lo vedremo in Europa credo.
“Des Nos Frèere Blessès” di Hèlier Cisterne
Bel film francese di Cannes,su una storia vera di vicende algerine del 1956.
“Des Homme” di Lucas Belvoux
Altro film francese con Gerard Depardie in sordina, ma nel contesto bel film.
“Les Discours” di Laurent Tirard
Simpatico, allegro film francese, monologo del protagonista, forse a Cannes sarebbe piaciuto e piacerà in Francia.
“Druk” di Thomas Vinterbeg
Bel film danese, allegro, fatto bene ed ironico. Forse veritiero sul problema dell’alcool.
“Étè 85” di François Ozon
Bello, bellissimo. Favolosi attori ragazzi francesi protagonisti, Cannes propone anche film spetta-colari come questo. Stupendo in tutto. Da vedere sempre.
Vincitore a Roma della speciale classifica su votazioni del pubblico presente
“Fortuna” di Nicolangelo Gelormini
Qui bisogna fermarsi un po’ a riflettere durante il film. Chi lo vedrà capirà solo alla fine.
Nicolangelo, aiuto regista di Paolo Sorrentino, in questa opera prima, volutamente distrae lo spet-tatore. Film che farà parlare cinematograficamente, su questa storia verissima e drammatica. Cercatelo!!!
“Home” di Franka Potente
Potente ! Come FranKa ! Bellissimo film franco-tedesco diretto per la prima volta dalla regista-attrice.
“I Carry You With Me” di Heidi Ewing
Film messicano, molto, molto bello. Alla fine si scopre storia vera.
“Las Mejores Familias” di Javier Fuentes-León
Bel film peruviano, simpatico e divertente. Non lo vedremo in Italia, sulla falsariga di un film, pe-rò drammatico, visto a Venezia.
“El Olvido Que Seremos” di Fernando Trueba
Favoloso, complimenti a Javier Càmara ed al regista premio Oscar Fernando Trueba. Speriamo di rivederlo in Italia. Produzione Colombiana, su storia vera scritta dal figlio del protagonista (Hèc-tor Abad Faciolince ) degli eventi avvenuti a Medellin negli anni 70.
“The Shift” di Alessandro Tonda
Film Italo-Belga, storia vera svolta a Bruxelles.
“Small Axe” di Steve McQueen
Ennesima serie tv sulla lotta al razzismo.
“Stardust” di Gabriel Range
Fiction non male sul primo periodo di David Bowie.
“Supernova” di Harry Macqueen
Bello, Bellissimo. Colin Firth e Stanley Tucci da Oscar (vedremo se glieli assegneranno).
Assolutamente da vedere.
“Subarashiki Sekai” di Miwa Nishikawa
Non mi ha impressionato.
“Time” di Garrett Bradley
Documentario in bianco e nero fatto bene, su una storia vera.
In conclusione, anche questo anno sono riuscito a gustarmi una kermesse di lavori ricchi di impe-gno, investimenti, progetti nel cassetto che hanno preso vita e luce, destinati ad un pubblico sem-pre più esigente e desideroso di vedere, capire, sognare e conoscere, mondi, culture, storie vere o sognate.
Tutto questo in un periodo micidiale sotto ogni punto di vista, come essere al fronte o inviato di una guerra sottile e invisibile, ma che miete vittime e lascia invalidità mentale e fisica.
C’è da ringraziare tutti noi, partecipanti inconsapevoli ed affascinati dal mondo del Cinema, egoi-sti fino all’inverosimile, cercando in anticipo l’iscrizione per l’accredito e non sicuri di farcela, se la Festa si farà, per ritrovare quella “normalità“ che sicuramente non tornerà, ma scaccerà le paure.
Inoltre vi è da ringraziare chi ha speso tempo, denaro, progetti e pellicola, per portarle definitiva-mente alla vista nelle sale.
Loro, insieme a noi spettatori, pur con le prenotazioni on line dei posti a sedere, distanziati, con-trollati, mascherati ed in apnea, ma contenti ed emozionati e qualche volta dispiaciuti di qualcosa che non abbiamo apprezzato, ma felici di avercela fatta e parlarne o scriverne il risultato, condivi-dendolo con il prossimo vicino o lontano.
Grazie di esistere e di avercela fatta, Festa del Cinema di Roma.
CORTINAMETRAGGIO IN STREAMING CON OSPITI IMPORTANTI IN PRESENZA
di Paolo Micalizzi
Ancora una volta Cortinametraggio si è dovuto tenere in streaming, e lo ha fatto con successo. Il Festival, fondato e diretto da Maddalena Mayneri, si è svolto infatti, nel pieno rispetto delle normative antiCovid-19, completamente online per il pubblico da casa che ha potuto vedere i corti in concorso in streaming su Mymovies e le dirette live giornaliere con giurati e ospiti in presenza ed anche su CanaleEuropa.tv e sui vari canali social. Madrina della cerimonia di premiazione, presentata da Anna Ferzetti e Liliana Fiorelli, l’attrice Nancy Brilli.
La giuria, composta da Claudia Gerini, Milena Vukotic, Cinzia Th Torrini, Nicola Giuliano, Giusy Buscemi e Gianluca Guzzo ha decretato vincitore del Premio Cortinametraggio 2021 il corto ”La Tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegari. Un’opera incentrata su Cesare, un turista appena arrivato in paese che conosce Leonardo, figlio di un pastore, e gli insegna le migliori strategie per approcciarsi con le ragazze.
La Giuria lo ha premiato “per la capacità di raccontare i giovanissimi con naturalezza e autenticità, dirigendoli con mano sicura ed allo stesso tempo delicata, attraverso una purezza dello sguardo che richiama quella della prima adolescenza”. Ma anche “per l’efficacia nel descrivere un’età di passaggio come momento di curiosità e sperimentazione, pudore e reciproco indispensabile sostegno”.
“Estranei” di Federico Mottica si è invece aggiudicato il Premio Rai Cinema Channel con la seguente motivazione: “L’incontro fra due ex coniugi che si sono molto amati diventa l’occasione per rivivere la passione che li aveva uniti attraverso ricordi, parole, gesti che rischiano di andare perduti per sempre. E’ interpretato da Luca Vecchi e Petra Valentini che per questo corto ha ricevuto il Premio Carpenè Malvolti come Migliore attrice Young, mentre per l’interpretazione maschile è andato a Matteo Olivetti protagonista di “Giusto il tempo di una sigaretta” di Valentina Casadei. Menzione speciale per “I miei occhi” di Tommaso Acquarone e “Sola in discesa” di Claudia Di Lascia e Michele Bizzi. Assegnato quest’anno anche un nuovo riconoscimento, il Premio Ann’ Amare, nato con il preciso intento di privilegiare corti che affrontino il tema della famiglia che si evolve con l’evolversi della nostra società. E’ stato attribuito a “Come a Micono” di Alessandro Porzio perché “racconta in modo diverso il conflitto tra generazioni e l’integrazione tra culture diverse. Famiglia è accoglienza, condivisione di valori e amore”. Per questo Corto Enzo Sarcina vince la menzione speciale Carpenè Malvolti come migliore attore Senior mentre Giuseppe Donvito e Giuseppe Curione lo vincono per la migliore scenografia perché “la parte visiva è stata essenziale supporto per la riuscita del progetto, realistica e coerente con la storia che viene raccontata”. Daniele Ciprì ha consegnato poi il Premio per la migliore fotografia a Teodoro Maniaci per “500 Calories” di Cristina Spina perché “Raramente nel cinema si riesce a raccontare gli stati d’animo attraverso le immagini”: il cortometraggio ha anche vinto i Premi Tetatu e Cinecibo. Un’altra Giuria, quella dei Corti in Sala che era composta da Alessio Boni, Lillo Petrolo, Laura Mirabella, Davide Novelli e Margherita Amedei, lo ha assegnato a “Sola in discesa” di Claudia Di Lascia e Michele Bizzi, corto che” tratta il tema della violenza sulle donne con sguardo inedito, coraggioso e affatto edulcorato , che mette in luce il ruolo pesantissimo della società e della famiglia nell’educazione alla parità di genere”: ha vinto anche il Premio Anec-Fice che darà al cortometraggio la distribuzione in 450 sale cinematografiche d’essai.
Ancora altri i premi assegnati. Il Mymovies dalla parte del pubblico a “Habanera” di Carlo Licheri, corto per cui Enrica Mura è stata premiata come miglior attrice Young, il CanaleEuropaTV a Enzo Salvi per la sua interpretazione in “Solamente Tu” di Emiliano Locatelli, il Vibeco, società leader nel settore ambientale legata allo smaltimento dei rifiuti a “Dormo poco e sogno molto” degli Espana Circo Este per la regia di Paolo Santamaria in quanto l’opera “ha toccato importanti tematiche d’attualità ed ha saputo narrare in modo innovativo il difficile rapporto tra uomo, consumismo e ambiente perché una natura in salute è la migliore assicurazione per la nostra vita”.
Infine, ci preme segnalare che l’attore Luigi Diberti ha ricevuto il Premio alla Carriera e che “Fuori Concorso” è stato presentato il cortometraggio “Fellinette” di Francesca Fabbri Fellini, relativo ad una favola ambientata nella Rimini 2020 che ha protagonista una bambina disegnata sul foglio di un quadernino nel lontano 1971 dal maestro Federico Fellini.
IL PALMARES DI “PRIMO PIANO – PIANETA DONNA 2021”
di Paolo Micalizzi
All’insegna de “Il lungo e faticoso viaggio della Donna nella storia del cinema” lo storico Festival “Primo Piano – Pianeta Donna”, creato, ideato e diretto con grande passione e capacità da Franco Mariotti che è giunto alla XXXVIII edizione, si è svolto nei giorni scorsi in streaming sulla piattaforma Mymovies. Nell’arco di quattro intense giornate, con una fitta e articolata programmazione al femminile, il Festival ha offerto ben 27 opere di diversi generi.
La Giuria dei lungometraggi – presieduta da Elisabetta Missland e composta da Valerio Caprara, Janet De Nardis, Paola Dei, Steve Della Casa, Sergio Fabi, Giovanna Gagliardo, Giuliana Gamba, Massimo Giraldi, Catello Masullo, Fabio Melelli, Romano Milani , Cristiana Paternò e Caterina Taricano – ha attribuito il premio per la migliore regia al film “Sul più bello” di Alice Filippi imperniato su una ragazza, orfana di genitori, che vive il dramma di avere una malattia ereditaria, che trova la forza di vivere nell’amicizia e nell’amore per un ragazzo.

Il premio per la migliore sceneggiatura è andato a Emanuela Rossi e Claudio Corbucci per “Buio”, che è valso anche il premio come miglior attrice a Ludovica Francesconi e quello per la migliore scenografia a Francesca Bocca. Il film è incentrato su tre sorelle che vivono rinchiuse in casa dopo la morte della loro madre, per volere del loro padre. Ma quando quest’ultimo le lascia sole per alcuni giorni, al suo ritorno improvviso esse si scagliano contro di lui. Per la migliore fotografia premiato Raquel Abellàn per “Artemisia Gentileschi – Pittrice Guerriera” basato sulla vita della pittrice romana e sulla sua vita difficile per affermarsi in quanto donna. Per il miglior montaggio premiati Carmen Giardina e Xavier Plàgaro per “Il caso Braibanti”, il filosofo, poeta ed ex partigiano che venne processato e condannato per aver plagiato un giovane. Un rinnovato processo alle streghe in un anno, il 1968, in cui si aveva il culmine di un percorso di rinnovamento e di liberazione. Come Miglior costumista è stata premiata Rosanna Grassia- Costumepoque per “Oro & Piombo” che è valso anche il premio come miglior trucco a Romina Costantino e Emiliano Ferrera. Miglior produttrice Donatella Palermo per “Faith” di Valentina Pedicini, regista di grande talento scomparsa, purtroppo, l’anno scorso, per malattia, all’età di 42 anni. Infine, una Menzione speciale a Mimmo Verdesca per “Alida”, film che vuole rendere omaggio alla grande attrice Alida Valli con una ricostruzione della sua vita che ne mette in luce la sua figura artistica rimasta un po’ in ombra, per via di attrici dalla presenza prorompente.
Anche premi per i Cortometraggi, assegnati da una Giuria presieduta da Lidia Vitale e composta da Maurizio Di Rienzo, Roberto Girometti, Cristian Marazziti, Massimo Nardin, Emma Nitti, Rossella Pozza, Paola Tassone. Premio miglior corto a “Gas station” di Olga Torrico su una ragazza che lavora in una stazione di servizio lasciando da parte la sua passione per la musica. Finché un giorno non si fa vivo il suo professore e allora qualcosa inizia a svegliarsi in lei. Il Premio Narrazione & Innovazione a “Di chi è la terra?” di Daniela Giordano dove la storia tra due famiglie ha come filo conduttore l’acqua che scorre nelle tubature. Un tema, quello ecologico, che spinge la sensibilità dello spettatore a una riflessione molto profonda, che possa permettere di giungere ad una nuova ridefinizione del rapporto tra uomo e ambiente. Infine, una Menzione speciale per “Tobia il nostromo del tempo- Reboot Edition” di Caterina Ponti, cortometraggio d’animazione sperimentale incentrato su un bambino dei nostri giorni che vive un’avventura fantastica, sospesa tra il reale ed il sogno.
OCCHIO CRITICO
“MANK”, THE OTHER SIDE OF THE LEGEND
di Francesco Saverio Marzaduri
I dissensi che carta stampata e “social network” hanno riservato, a pochi giorni dall’uscita, a “Mank”, undicesimo lungometraggio di finzione firmato David Fincher, rivelano come il pur abusato sottobosco hollywoodiano mostri ancora di voler (e poter) dire di sé, senza venir meno al sempiterno principio di reinventarne l’effigie – arcinota, peraltro – badando a non perdere un briciolo del senso di “magico” impartito dalla fabbrica di sogni. Sortilegio che si dispiega già in apertura, con gli “opening credits” che sfilano in verticale su uno sfondo di candide nuvole, come in uno dei tipici titoli del periodo classico del ventennio Trenta-Quaranta – complice lo splendido bianco e nero di Erik Messerschmidt. La “poetica della nostalgia”, in pieno mutamento cinematografico negli anni a seguire, avrebbe provveduto a riadottare e riabilitare quel “sense of wonder” rendendone possibile la replica, talora rischiando la maniera (pressoché esaustivi, qui, nitore figurativo e “art déco”: da costumi luccicanti sui corpi femminili dell’epoca a un “make-up” teso ad esaltare eccessi divistici). Nell’abbondante gioco antinomico che interseca tre paradigmi narrativi scelti all’uopo (leggenda-realtà, storia-mito, pubblico-privato), e che nel caso specifico assurge ad assioma, il tiro si fa sin troppo ardito, s’è vero che uno dei temi affrontati concerne la gestazione di un’opera monumentale, con inevitabile richiamo mitopoietico al suo titanico autore.
Chi tocca muore, suol dirsi: sicché qualsiasi osservazione si possa fare nella restituzione scenica di Welles – esibito nell’incipit sfocato o di profilo, e poi, ad esempio nell’ultimo confronto col protagonista, in primo piano – comporta un punto di vista soggettivo che mette a dura prova l’attesa dello spettatore “cinéphile”, irritato dal disegno d’un giovanissimo ma nevrotico despota, paranoico e bizzoso. Ma si tratta anche in questo caso d’antinomia, ché la rispettiva scelta di campo rispecchia il preambolo della Mecca in celluloide secondo gli usuali standard, peraltro senza smentirli: salvo che in finale di partita l’opinione del pubblico, fingendo d’esser smentito dall’artificio, non si discosta troppo dalla posizione del personaggio al centro “versus” datori di lavoro, “tycoon”, magnati dell’industria, divette biondo platino. Tutto già visto, verrebbe facile dire. E si sbaglierebbe: proprio una battuta del film provvede, furbescamente, a metter le mani avanti (“Non si può cogliere l’intera vita di un uomo in sole due ore, il massimo che puoi sperare è dare l’impressione d’averlo fatto”). Ecco dunque come la sola connessione plausibile col capolavoro di Welles risieda nell’analogo intento di emulazione dell’oggetto esaminato, attraverso una struttura a incastri dove la visione si fa bilaterale: il ritratto di Herman J. Mankiewicz si contrappone all’officina della quale è al servizio (ancorché tra i servitori più geniali), lungo due ore e dodici d’un quadro a due facce e una sola medaglia.

“La narrazione è un unico grande cerchio – sancisce ancora Mank – è come una girella alla cannella, non una linea dritta che punta all’uscita più vicina”. Non è strano che i flashback di cui Fincher dissemina la docu-fiction, il ricordo di Herman, siano un punto di vista in comune col giudizio dell’osservatore, che implica riconsiderare lo “script” di “Quarto potere”, cui l’uomo lavora costretto a letto per sessanta giorni a seguito di un incidente, come una duplice sfida: alla sfera finto-dorata del “System” e a sé stessi. Persino i due mondi agli antipodi, rispettivi sfondi del Prima e del Poi, parlano della tempra del personaggio, del suo “modus operandi”, di una personale battaglia tra contraddizioni e prese di posizione. Da un lato gli uffici degli “studios” (con tanto di cartello esposto “Geni al lavoro”), in cui Mank si diverte a scommettere, e a perdere, con colleghi del calibro di Ben Hecht, Charles MacArthur, S. J. Perelman, George S. Kaufman e un Charles Lederer agli inizi; dall’altro l’aridità dello sperduto ranch nel Mojave in cui il Nostro è recluso, dominato da una realtà agli antipodi dove una segretaria-dattilografa inglese (il cui coniuge è dato per disperso in guerra) e una governante-infermiera tedesca sfuggita alla persecuzione nazista giungono quale ripensamento agli egoismi e capricci dello sceneggiatore. E al pari della riserva di whisky che si esaurisce via via, esplicativa è la scelta delle didascalie dattilografate come in un copione, utili a scandire i salti temporali – espediente metalinguistico efficace nel bisticcio tra parola scritta e immagine discorsiva – che in più circostanze rimettono in discussione l’atteggiamento di Herman, nella misura in cui il flashback gli si offre quale inaspettato lampo di genialità nella stesura del progetto (per ammissione dello stesso Fincher, “Welles era convinto genuinamente che isolamento e anonimato giovassero a Mank, liberandolo da tutte le pressioni che si portava appresso e consentendogli una maggiore introspezione”). Non per nulla, l’opera si concentra sulla figura dello scrittore, cuore rivelatore d’un “milieu” che non può farne a meno, più che sul produttore o sul regista: in tal senso le diciture fungono non (sol)tanto da marchio di fabbrica, ma da indelebile impronta personale.
Ma il film di Fincher, che va oltre la mera patina del “biopic”, è fondamentalmente un film basato sulle differenze. La più importante delle quali concerne, manco a dirlo, il profilo del protagonista: sedicente democratico, non perde occasione per sfottere Hollywood in tutto il suo conglomerato (da Louis B. Mayer a Irving Thalberg, da David O. Selznick al magnate dell’editoria William R. Hearst), che da par suo gli stipendia vizi e alcol conoscendone la spigolosità. Autodistruttivo ma lucidissimo, lui medesimo di chiara estrazione ebraica, incapace nella vita di qualsiasi barlume di misura e tuttavia dotato di sensibilità e arguzia, indicatori imprescindibili verso la propria “view” esistenziale. A prestarne le sembianze, un imbolsito Gary Oldman di vent’anni più anziano della parte, ma – come il Churchill che un biennio prima gli fruttò la statuetta – alle prese con una nuova ora (più) buia di cui gli affetti personali, la moglie Sara o il futuro importante cineasta Joseph – quest’ultimo introdotto nel “climax” della Mecca – rischiano di far le spese. Prerogativa di entrambi, Herman e Joe, è di non far gioco di squadra: salvo che il capitolo del secondo abbraccia una Hollywood non meno geniale e innovativa, né meno sfarzosa, destinata molto dopo a farsi incalzare dalle produzioni “low budget”. A causa di questa discrepante debolezza, Mank pare in un primo momento arrendersi dopo aver scommesso, sempre perdendo, sul risultato che vuole Upton Sinclair governatore anziché il favorito Frank F. Merriam (sul cui “affiche” elettorale lo sceneggiatore sfrega un fiammifero per accendersi la sigaretta), poco dopo aver difeso Sinclair asserendo che nel socialismo si condivide la ricchezza e nel comunismo la povertà. Sempre a difesa di tale posizione, convinto di riuscire, cerca di sventare il suicidio d’un collega malato, firma per fasulli cinegiornali di propaganda dietro la promessa di diventare regista.
E benché sprezzante quanto basta da immaginare King Kong alto dieci piani e Mary Pickford vergine a quarant’anni, Mank è e rimane un lacchè, sia pur di lusso, combattuto tra il pensiero e il dovere, servo di due padroni come Arlecchino, condannato a impersonare il ruolo di scimmia su un organetto o in una gabbia (ne sono un monito le scimmiette dietro le sbarre della magione “kitsch” di Hearst, mentre lo “screenplayer” sfila insieme all’amante di questi, Marion Davies). In pari misura Mayer e Hearst sono servitori l’un l’altro, prova ne sia il discorso del primo alle maestranze della MGM ridotte a obbedire (con Shirley Temple ad applaudire tra esse), la cui valutazione del cinema non incarna emozioni ma solo denaro, mentre il protagonista si compiace definirsi “un Mosè non così a buon mercato”. Se egualmente i magnati dell’industria si beano di credersi padroni del mondo, senza (confessarsi di) essere vittime di un’univoca prigione, Mank, dalle quattro mura d’una stanza in subbuglio tra montagne di scartoffie, riesce a vedere la luce nella composizione d’una lastra nitidissima: un “pamphlet” sotto l’illusoria facciata, atta a radunare tutto e tutti indistintamente, restituendo gli sguardi della presunta fiaba quali simulacri, patetici e squallidi, ignari di un’imminente scomparsa dietro l’aurea superficie. “Bigger than life”, ecco “Quarto potere” quale antitesi finto-reale d’un “entourage” che seppellisce la realtà sotto la finzione. “Anche se in fondo Mayer ha ragione quando dice che il ricordo e l’emozione di un’immagine non si possono possedere. La magia forse sta proprio nella loro inafferrabilità” – scrive Lorenzo Rossi su “Cineforum” – “e con ‘Mank’ Fincher mantiene intatta questa ambiguità dell’immagine ponendola al centro della rappresentazione e facendone la propria ‘Rosebud’. Perché come lo slittino di Kane è anch’essa qualcosa che pur disvelata, risolta e portata in primo piano, mantiene intatto tutto il suo mistero”.
Anello di congiunzione, la disastrosa cena in cui un Mank ubriaco fradicio rigetta – non solo allegoricamente – il proprio pensiero verso i dittatori del “System”, utilizzando Don Chisciotte a mo’ di metafora, fa il paio con la schermaglia verbale che ha con Welles. La geniale penna e il geniale “enfant prodige” della radio si ritrovano a loro volta prigionieri discordi d’un esecrato organigramma, oltreché della boccia di vetro con l’innevata fattoria all’interno: ulteriore artificio volto a perpetuare l’eterna dicotomia nella paternità dello “script”, riscrivendo Storia e mito secondo vedute soggettive all’interno d’un prodotto destinato al piccolo schermo, osando l’inosabile nell’impiego di un progetto delicato e azzardato. S’aggiunga che la sceneggiatura, nel tentativo di somigliare a una pellicola dimenticata (quanto Mank medesimo), reca la firma di Fincher “senior”, giornalista in pensione che spese gli ultimi anni per dedicarsi alla scrittura cinematografica. La posizione dell’autore, altro dualismo, opta per le memorie dell’eroe immortalato; le scatole cinesi proseguono, secondo l’enigmatica magia che la Settima Arte rende possibile. Come la riplasmazione della Storia dietro la teoria (Tarantino “docet”), o del più obsoleto vezzo onirico di marca felliniana (annoverante perfino le melodie di Trent Reznor e Atticus Ross). Dato l’archetipo wellesiano, anche qui il trenta per cento è reale e tutto il resto inventato: così pure il discorso conclusivo in cui Mank, conseguita l’unica statuetta dell’opera cui ha collaborato – e che forse ha generato – ringrazia al microfono dalla sua abitazione “lieto di accettare questo premio in assenza del signor Welles, perché la sceneggiatura è stata scritta in assenza del signor Welles”.
Deformazioni e grandangoli, sfocature e sfaldature (il segmento della sconfitta di Sinclair pensato come in un titolo targato MGM) comprovano l’ineccepibilità d’un congegno a orologeria, ma anche un’insincerità di fondo che non azzera un’impressione di studiata freddezza, affettata e compiaciuta. Si respira la lezione dei fratelli Coen (da “Barton Fink – È successo a Hollywood” a “L’uomo che non c’era”), senza disporre dell’identica mordace ironia. E se “il film fallisce il primario intento di raccontare la vicenda di un personaggio imperfetto”, stigmatizza Paul Schrader, “onde convincere lo spettatore che questo meriti due ore del proprio tempo”, sarebbe più corretto parafrasare lo stesso Mank quando si paragona a un topo alle prese con una trappola costruita da chi vi lavora, e rimodellata dall’interno – cioè dal topo – proprio tappando i buchi che ne permetterebbero la fuga.
“IL CASO BRAIBANTI” DI CARMEN GIARDINA E MASSIMILIANO PALMESE
di Tullio Masoni
Presentato nel 2020 alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro il film ha ottenuto il Premio del pubblico (Cinema in piazza).
Si tratta di una rievocazione dolorosa, per le drammatiche vicende che riguardarono non solo la vita di un uomo e del suo più stretto giro di conoscenze, ma la stessa sensibilità culturale e civile di in Paese in trasformazione.
Aldo Braibanti – si legge nell’incipit che precede le immagini – ex-partigiano, poeta, filosofo, uomo di teatro, nel 1968 fu protagonista di un processo che divise l’Italia.
Mentre nel mondo infuriava la contestazione giovanile, con la richiesta di diritti civili e maggiore libertà sessuale, il caso Braibanti divenne il nostro processo a Oscar Wilde. Con un secolo di ritardo.
Era il ’68, appunto, e i forti cambiamenti che avrebbero man mano influenzato ogni settore della società italiana, fino ad agire sulle grandi mobilitazioni operaie dell’anno successivo, trovavano ostacoli in un’Italia istituzionalmente arretrata, ed equivoca nel costume dominante; un’Italia «piccolo borghese e clericale».
Braibanti fu processato e condannato per il reato di plagio, cioè, secondo l’accusa (incarnata dal P.M. Antonino Loiacono), per aver “ridotto in schiavitù” due giovani: Piercarlo Toscani e Giovanni Sanfratello, nell’ambito delle attività artistiche che si svolgevano presso il laboratorio di Castel Arquato. Giovanni Sanfratello, all’epoca già maggiorenne, si era legato a Braibanti amorosamente e per vocazione; l’arresto, la detenzione, e il processo contro il professore si dovettero soprattutto alla mobilitazione della sua famiglia, che sporse denuncia e agì con violenza fino a organizzare il sequestro del giovane a Roma, dove questi si era trasferito con il compagno. Il Sanfratello doveva poi subire il ricovero in manicomio per mesi e le “terapie” che all’epoca erano consuete negli istituti psichiatrici.
Il film di Giardina e Palmese si sforza di tenere assieme lo studio della personalità di Braibanti (e il carattere politico più generale che ne deriva) e lo svolgersi della vicenda, ricorrendo a immagini d’archivio, testimonianze dell’epoca e di oggi, brani di teatro, e puntuali rievocazioni. Ne esce un “collage audiovisivo” (e Braibanti si era segnalato come artista creatore di collages) ordinato dalla partecipata conduzione di Ferruccio, un nipote oggi anziano, il cui scopo è restituire il clima di un’epoca ed entrare per quanto possibile nel personaggio.
Braibanti aveva preso parte alla Resistenza fiorentina venendo da “Giustizia e Libertà” per poi passare al Partito Comunista. Fu arrestato due volte, nel corso della lotta, e sottoposto a torture a “Villa triste”, la sede dei tedeschi e degli alleati fascisti comandati da Mario Carità.
Dopo la guerra fu attivo nel Partito per poi staccarsene a causa di profondi dissensi di linea; perché Braibanti – uomo di eclettiche passioni artistiche e scientifiche, ma deciso a negare ogni vincolante specializzazione: «…filosofo no – aveva detto al processo – poeta no…dilettante!..al modo di Leonardo» – stava maturando una visione libertaria. Tale che allo studio delle formiche (ebbe riconoscimenti come mirmecologo) accostò esperimenti di ritualità drammatica collettiva, interessando personaggi come Carmelo Bene, Lou Castel, Marco Bellocchio e segnatamente il cineasta underground Alberto Grifi (autore di Transfert per camera), fino a elaborare teorie sul comportamento sociale e individuale. Un libro di suoi scritti, pubblicato da Feltrinelli nel 1969 a cura di Virginia Finzi Ghisi: Le prigioni di Stato, porta in copertina queste parole di presentazione: “Un moderno pensatore anarchico annuncia la fine dell’uomo e la resurrezione della natura”, a indicare ipotesi conflittuali anticipatrici, cioè scontri possibili e di esito incerto nella prospettiva di grandi cambiamenti climatici, e contiene un’analisi del grottesco (che risale al 1951) inteso come condizione culturale e comportamento: «…La scuola, la famiglia, la chiesa, l’organizzazione politica – scrive Braibanti – ci presentano continue situazioni grottesche, specie quando sopravvivono ai loro scopi e ai loro tempi…Ciò che non può divenire se stesso…ecco il grottesco.». Parole che ci portano al Bellocchio degli esordi e, forse, di tutta l’opera.
Tra Fiorenzuola d’Arda e Castel Arquato, cioè nella provincia più bianca dell’Emilia, Braibanti partecipa al fermento culturale promosso da una rivista, Quaderni piacentini, fondata nel 1962 da Piergiorgio Bellocchio e collocata su posizioni radicali di sinistra come, d’altro canto e in affinità ideologica, Quaderni rossi, nata un anno prima dal lavoro politico (lo studio militante delle nuove figure operaie) di Raniero Panzieri.
Nel 1968, quando il processo venne celebrato a Roma con esito di condanna, il n.35 di Quaderni piacentini pubblicò un editoriale di denuncia e, insieme, autocritico: «…Oggi sappiamo che in Italia non siamo liberi di diventare pittori, o poeti o scrittori se i nostri genitori, gli amici non vogliono. Basta che uno denunci il nostro maestro ed ecco che lui finisce in prigione e noi, come è stato per Giovanni Sanfratello, uno dei giovani plagiati, finiamo in manicomio. (…) In realtà – prosegue l’editoriale – i reati per cui Braibanti è stato condannato sono: omosessualità; ateismo (anzi, panteismo); idee anarchiche; aver appoggiato la scelta artistica di un giovane amico; parlare coi giovani di cose serie anziché di donne o di sport; eccessivo interesse per le formiche (anziché come sarebbe “normale” per cani, gatti, canarini o pesci rossi); aver sconsigliato “La settimana enigmistica” a favore di letture più impegnative; essere un artista non di successo (peggio che mai: non averlo mai cercato, il successo); vivere poveramente. In sostanza, il rifiuto dei valori correnti su cui si basa la nostra società: denaro, carriera, agi, sicurezza, prestigio.»
La rivista sarebbe tornata sull’argomento nel numero successivo con un articolo di Giovanni Jervis (che usò lo pseudonimo: Giulio De Matteo) intitolato: Una lezione di violenza.
Anticipavo che il processo a Braibanti e la condanna avvennero in pieno ’68, e che pertanto rappresentarono un drammatico paradosso. Mentre le università venivano occupate, le piazze si riempivano di giovani che protestavano per nuove libertà, e la cultura di massa (anche quella più popolare dei rotocalchi canzonettisti) registrava le grida della Beat Generation, le reazioni della grande stampa (con le eccezioni dell’Unità, negli ultimi giorni, ABC e Agenzia radicale: Marco Pannella si distinse senza riserve) furono improntate al più basso conformismo o, che è lo stesso, all’omertà.
Quanto alla menzionata autocritica, l’editoriale di Quaderni piacentini chiudeva ammettendo un impegno insufficiente sul caso, perché vissuto con “ottimismo”, e una rettifica: «Quella che sembrava (ed è) una battaglia arretrata, – che però coinvolse molti intellettuali: da Moravia a Pasolini, da Cesare Musatti a Eco alla Maraini a Elsa Morante, ndr – è stata perduta anche perché non la si è voluta combattere. Bisogna combattere anche le battaglie arretrate.»
Puntuale nella ricostruzione e nello scrupolo di porre un episodio esemplare, in negativo, di un’epoca invece ricca di promesse, il film si dedica anche e spesso felicemente alla figura singola di Aldo Braibanti e. per così dire la accompagna fino all’epilogo romano, poi nella terra natale dove morì il 6 aprile 2014.
Un uomo che viveva in povertà, come ebbe polemicamente ad affermare l’editoriale dei Quaderni piacentini (avrebbe per pochissimo fruito della “legge Bacchelli”), uno studioso anomalo, amico di Maria Monti (chiamata in causa per testimoniare stima e affetto) che lo frequentò fino a che visse nel centro storico di Roma. Un uomo che viveva sepolto dai libri (la sua casa ricordava, significativamente, quella di Sandro Penna) curando animali e rare amicizie. E un poeta, cui gli autori rendono omaggio concludendo il film con un brano in 8 o super8 (direi) girato da lui stesso. Un volo, in manichino d’uomo-animale sbattuto dalla risacca, e, con la voce fuori campo di Lou Castel, una dedica in versi che – senza dubbio sbagliando – provo a trascrivere dalla voce dell’attore:…trasvoliamo…presto perché la vita / mi sfugge fra le dita e io / non voglio spezzare la preziosa catena / dei miei quotidiani risvegli / non voglio barattare i miei sassi colorati / con l’abbondanza dei loro frutti marciti / ma voglio tradire la mia coerenza / quando cambio col mondo che cambia / non voglio finire qui / questo mio lungo frammento di paura e desiderio. / La porta resta spalancata fino allo spasimo / come la breccia in cui sei caduto tu / mio dolce compagno di viaggio.
DIETRO LE PORTE CHIUSE, ovvero
CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?
di Paolo Vecchi
“Quella notte a Miami…” di Regina King; “Malcolm&Marie” di Sam Levinson
Sam Cooke, cantante di successo, Jim Brown, running back dei Cleveland Browns e Malcom X, futuro leader dei Black Muslims, il 25 febbraio 1964 festeggiano allo Hampton House Motel di Miami Beach, insieme a Cassius Clay, l’inaspettata vittoria di quest’ultimo su Sonny Liston, titolo mondiale in palio.
I personaggi di “Quella notte a Miami…” sono dunque reali, e famosi ciascuno nel proprio ambito di attività. L’azzardo della fortunata pièce teatrale di Kemp Powers, anche sceneggiatore del film che da essa deriva, sta nel farli incontrare in una stanza d’albergo, protagonisti di uno psicodramma che assume via via in maniera più accentuata i caratteri del confronto politico. Lo firma Regina King, un Oscar e un Golden Globe come attrice non protagonista per “Se la strada potesse parlare” di Barry Jenkins nonché popolare interprete di svariate serie televisive per le quali si è aggiudicata complessivamente quattro Emmy Award.

Con questo suo esordio dietro la mdp è stata la prima afroamericana ad essere invitata a Venezia e, dopo una nomination ai Golden Globe, è già in odore di statuetta, evento mai accaduto a una regista dalla pelle nera. Suo merito è certamente quello di aver movimentato il testo di partenza con un sapiente opening-up, nell’orchestrazione del prologo in cui viene delineata la situazione di ciascuno dei quattro protagonisti, ma anche nell’articolato montaggio del corpo della narrazione più specificatamente teatrale, all’interno della stanza del resort, alleggerito dall’entrare e uscire dei protagonisti, che definisce in maniera più precisa la personalità di ciascuno attraverso i loro rapporti, familiari e sociali. Sam, Jim, Cassius e Malcom, l’artista-imprenditore, lo sportivo prossimo a passare al cinema, il campione-simbolo con la sua carica di esuberanza e l’ideologo della riscossa dei neri vengono innanzitutto rappresentati nella loro dimensione umana. I primi tre, uomini di successo, rimangono tuttavia degli emarginati di lusso per il colore della pelle, e per questo si confrontano, tra loro ma soprattutto con quello al quale riconoscono una più lucida coscienza politica. Il festeggiamento scivola poco a poco nel jeu de massacre, in cui ciascuno fatalmente esemplifica una diversa posizione rispetto al grande problema che affligge tutti. Schematizzando, emerge l’eterno dilemma tra riformismo e radicalismo a livello politico, integrazione e marginalità su quello individuale. Sotto quest’ultimo aspetto risulta particolarmente rivelatrice la disputa tra Sam Cooke e Malcom X, entrambi destinati a breve a una morte violenta anche se per cause diverse, con il primo che si dice fiero che una sua canzone, interpretata dai Rolling Stones, sia arrivata in vetta alla classifica di dischi per bianchi, mentre il secondo gli fa ascoltare “Blowin’in the Wind” di Bob Dylan, esempio di un brano musicale che ogni afroamericano avrebbe voluto firmare. Sono passati quasi sessant’anni, ci sono stati martiri ed eroi, ma la questione razziale continua a travagliare l’America. Traducendolo in chiave europea, il problema eterno delle strategie della sinistra non appare poi tanto distante, se lo si depura dalle peculiarità specifiche.
A prescindere dall’indubbio interesse dell’argomento, “Quella notte a Miami…” mette insieme una certa verbosità teatrale con la solidità di una regia di impronta televisiva, concedendosi più di uno squarcio di buon cinema. Particolarmente efficace oltre che significativa, ad esempio, la scena in cui Cooke canta a cappella un suo successo, accompagnato dal ritmo offerto dal coro della platea, ovviamente composta di soli neri, sotto gli occhi divertiti e commossi di Malcom X, al quale non sfugge il valore simbolico di quella sintonìa. Divertente la parentesi cinefila, con Jim Brown impegnato nel suo esordio come attore cinematografico (non viene detto, ma il film è “Rio Conchos” di Gordon Douglas, un western più che rispettabile).

Ancora due afroamericani, ancora uno spazio definito da quattro mura, in questo caso di una villa elegante e modernissima, senza nessuna apertura a un esterno che non sia il giardino. Malcolm è un regista che ha appena presentato alla stampa il suo ultimo film. Marie, la sua compagna, la cui vicenda esistenziale è stata modello per la figura della protagonista, è tormentata dal fatto di non essere stata poi scelta per interpretarne il ruolo e di non avere ricevuto neppure il conforto di un ringraziamento pubblico alla prima. Lui viene da una famiglia della borghesia agiata, lei è una ex tossica, dunque con una comprensibile ansia di riscatto e gratificazione. Sam Levinson, figlio d’arte, filma queste scene da un matrimonio in un patinato bianco e nero, con calibrati movimenti di macchina e impeccabili stacchi di montaggio, mettendo altra carne al fuoco oltre alla materia del contendere tra i due, dalla cinefilìa (si citano, tra gli altri, William Wyler e Ben Hecht, Spike Lee e Barry Jenkins) ai malvezzi della critica, oltre al sempiterno e un po’ scontato rapporto tra vita e sua rappresentazione cinematografica. L’esile Zendaya e l’atletico John David Washington sono bravi, ma la loro performance non ce la fa a superare del tutto l’impasse alla quale “Malcolm&Marie” si è condannata con l’idea di partenza.
Come sostiene un amico, colto cinéfilo, vedendo di seguito questi due lavori si ha l’impressione che il cinema americano sia tornato al Mike Nichols di “Chi ha paura di Virginia Woolf?”, che è del 1966. Colpa della produzione televisiva (il primo è Amazon, il secondo Netflix)? Dei limiti di budget? Dell’impossibilità a girare con troupe meno che ridotte per motivi sanitari? Infine, della claustrofobia indotta dai comportamenti obbligati dalla pandemìa? Tutto questo insieme, forse, anche se più o meno in contemporanea é disponibile, sempre su Netflix, “Notizie dal mondo” di Paul Greengrass, aperto su spazi in qualche modo fordiani. Ma in origine si trattava di una produzione Universal…
Romania prima e dopo la caduta del Muro
di Marco Incerti Zambelli
In “Est. Dittatura last minute” tre ragazzi di provincia, un poco ingenui e con qualche piccolo problema alle spalle, partono in macchina da Cesena sul finire del 1989 verso l’Ungheria per una vacanza nei paesi dell’Est Europa ‘prima che tutto cambi’. Con una telecamera ed un campionario di indumenti intimi ‘da vendere ai mercatini’, a Budapest si accorgono che l’Occidente è già arrivato nella capitale magiara e si dirigono avventurosamente verso la Romania, dove ancora resiste il regime comunista. Una valigia dal contenuto misterioso, fortunosamente arrivata in loro possesso, consegnata da un esule rumeno per essere recapitata alla famiglia rimasta a Bucarest, diventa il ‘McGuffin’ che li condurrà alla scoperta di un mondo che una dittatura ormai morente è ancora capace di dominare. Il viaggio li farà incontrare con personaggi ora improbabili, ora commoventi, affrontare situazioni surreali, incrociare pericolose scelte, che sveleranno loro la natura di una popolazione povera e triste eppure capace di grande dignità, di sincera generosità, di indomita volontà di riscatto, un viaggio che diventa un emozionante percorso di formazione, di crescita.
Il regista Antonio Pisu, figlio d’arte, a partire dal libro autobiografico ‘Addio Ceausescu. Tre giovani romagnoli alla scoperta e all’avventura oltre la Cortina di Ferro’, di Andrea Riceputi e di Maurizio Paganelli (anche coproduttore del film), costruisce un coinvolgente ‘road movie’, impreziosito dall’inserimento di spezzoni video delle riprese reali di quel viaggio e di immagini di repertorio, attentamente amalgamati dalla bella fotografia di Adrian Silisteaunu. La puntuale ricostruzione di quei tempi, di quei luoghi, frutto di un accurato lavoro (la ricerca delle location è durata un intero anno, scenografie e costumi sono il risultato del meticoloso impegno di un’equipe italo rumena) restituisce, a tratti poeticamente, l’atmosfera di quegli anni così vicini e così lontani. Nella colonna sonora, dove alle musiche originali di Davide Caprelli si affiancano preziose canzoni di Franco Battiato, irrompe l’universale ‘Felicità’ di Albano e Romina, autentica Hit nei Paesi dell’ex blocco sovietico, che suona come una sorta di ironico e melanconico contrappunto alla vicenda. I tre protagonisti sono interpretatati con efficacia da Lodo Guenzi, frontman de Lo stato sociale, Matteo Gatta e Jacopo Costantini che, al loro debutto cinematografico, sanno colorare con empatica partecipazione le vicende dei tre giovani nell’attraversamento di quella ‘linea d’ombra’ che segna il confine tra la prima giovinezza e la maturità.
Il lockdown non ha permesso un’uscita nella sale cinematografiche dopo la prima al Festival di Venezia, dirottandolo sulle piattaforme online ma non ha impedito la partecipazione a diverse manifestazioni internazionali, dove ha ottenuto riconoscimenti importanti da New York a Istanbul a Calcutta.
Romania 2015: in un paese profondamente mutata da quello raccontato dal film di Pisu, nel quale le follie e le malefatte del regime di Ceausescu paiono svanite nel passato, un incendio nella discoteca Collective, priva di uscite di emergenza, provoca 27 morti; nei mesi successivi decine di feriti ricoverati in seguito al disastro perdono la vita. Il redattore capo di un quotidiano sportivo si insospettisce, inizia ad indagare assieme ad una collega, scopre che quelle morti sono il risultato di infezioni batteriche dovute alla sciagurata diluzione dei disinfettanti utilizzati che ne hanno compromesso la validità. La pubblica denuncia scatena uno grande scandalo che porta alle dimissioni del Ministro della Sanità, sostituito, protempore, da un giovane studioso ed attivista dei diritti del malato il quale cerca, tra mille difficoltà e ostilità, di risanare la corruzione che infesta la sanità rumena. Ardua impresa che si spegne al ritorno dei politici al potere. Una vicenda che appare perfetta per il buon cinema Hollywoodiano, ottimo punto di partenza per un film sulla falsariga di “Spotlight” o “Tutti gli uomini del presidente”. Alexander Nanau, regista rumeno di alcuni pregevoli documentari, decide invece di seguire in tempo reale lo svolgersi degli eventi.
Conquista la fiducia di un all’inizio dubbioso Cătălin Tolontan, il giornalista sportivo che già aveva scoperchiato negli anni precedenti scandali sportivi che avevano spinto alle dimissioni la Ministra dello Sport e portato in carcere dirigenti e faccendieri del football rumeno, lo segue con la sua camera in tutte le fasi del suo lavoro, in redazione e nelle conferenze stampa. La sua attenzione si rivolge anche alle reazioni dei familiari delle vittime, alle vicende dei sopravvissuti indelebilmente segnati dalla tragedia, coglie la straziante e poetica volontà di andare avanti di alcuni di loro. Tutta la prima parte dell’opera si costruisce cosi come un avvincente thriller con una progressiva e appassionante scoperta della verità. Nella seconda parte l’attenzione si sposta all’interno delle stanze del potere e documenta il sincero, autentico ma sostanzialmente inutile sforzo di Vlad Voiculescu, nuovo ministro della Sanità, di porre rimedio alle malefatte dell’organizzazione sanitaria e il racconto diventa un potente atto di accusa di un sistema marcio e immorale.
Nanau, che del film è anche produttore, direttore della fotografia e montatore, affina la tecnica narrativa già sperimentata nel precedente “Toto and his sisters”, nel quale aveva per anni seguito le vicende di tre bambini rom, seguendo con la camera le loro vicende per poi costruire un toccante romanzo di formazione. In “Collective” le 350 ore di riprese e le centinaia di immagini televisive accumulate dall’Autore, per mezzo di un accurato ed impeccabile lavoro di montaggio diventano un’opera coinvolgente, di straordinaria efficacia, abbattendo le barriere tra documentario e fiction. Accolto da un unanime favore dalla critica di tutto il mondo, il film è candidato agli Oscar sia come miglior documentario che come miglior film straniero.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
DANIEL SCHMID, IL “MOSTRATORE D’OMBRE”
“DANIEL SCHMID, UN RACCONTO FUORI STAGIONE” DI ANNA ALBERTANO E LUISA CERETTO
di Marcello Cella
“Odio la luce del sole”
Daniel Schmid
Temo che non molti oggi in Italia conoscano i film del cineasta svizzero di lingua tedesca Daniel Schmid, regista di cinema, di documentari e di opere liriche, pienamente partecipe dagli anni Sessanta del secolo scorso di quella “new wave” del cinema elvetico che faceva riempire i cineclub di cinefili curiosi e affamati di visioni eccentriche sulla realtà con le opere di autori come Alain Tanner e Claude Goretta, solo per citare i più noti, con il loro sguardo critico sulle fortune economiche e sociali del “miracolo svizzero” e sulla sua storia tutt’altro che immacolata. Nello stesso tempo le sue opere venivano accomunate anche a quelle degli amici e sodali Rainer Werner Fassbinder e Werner Schroeter, protagonisti a loro volta del nuovo cinema tedesco. Proprio questo suo essere ai confini di due mondi cinematografici coevi, ma diversi, ha impedito spesso al pubblico di definirlo meglio all’interno di una tendenza e di apprezzare i suoi film. Svizzero, ma non strettamente catalogabile all’interno della cinematografia svizzera, tedesco, ma non abbastanza per vedere le sue opere collocate al pari di quelle degli autori citati, Daniel Schmid si è sempre mosso, da frontaliero qual’era per le sue origini familiari e per cultura, a cavallo di mondi e di linguaggi diversi, sfuggendo ad una catalogazione più precisa delle sue opere che ne avrebbero limitato la libertà espressiva, ma anche ad una popolarità che avrebbe senz’altro meritato.
Quindi il bel documentario di Anna Albertano e Luisa Ceretto “Daniel Schmid, un racconto fuori stagione”, che nel titolo parafrasa un suo film autobiografico del 1992, “Fuori stagione”, e ne rivendica una diversità radicale rispetto a qualsiasi moda culturale, è particolarmente utile per ricordare un cineasta importante per la cinematografia europea. Ed è anche un modo per riflettere su cosa sia il cinema, il suo linguaggio, la sua ‘necessità’ espressiva, la sua importanza sociale, rispettando anche nella sua struttura quel suo essere sempre al confine fra la luce e l’ombra, quella sua tendenza onirica che si esprimeva anche nei suoi film più realistici. Infatti “Daniel Schmid, un racconto fuori stagione”, pur essendo costruito a partire da una conversazione con l’autore di Luisa Ceretto risalente alla fine degli anni Novanta, svoltasi in un bar e dall’aria apparentemente svagata, su cui si innesta un montaggio di immagini che si accavallano morbidamente le une sulle altre, quasi in un abbraccio onirico, tratte dalle sue passeggiate in città (Bologna), dai suoi film, dalle sue montagne svizzere, dall’albergo in cui è nato e cresciuto, si rivela una riflessione profonda e densissima sul cinema, sull’immagine, e sul loro significato all’interno di un mondo che apparentemente ha sostituito la parola, la memoria, il tempo, la narrazione con un eterno presente visivo privo di profondità (di campo e di tempo).
Ma chi era Daniel Schmid? L’Enciclopedia Treccani lo ricorda così: “Regista cinematografico, teatrale e televisivo svizzero, nato a Flims (Waldhaus) il 26 dicembre 1941. Autore tra i più rappresentativi del cinema svizzero-tedesco, nella sua filmografia ha alternato opere di finzione e documentarie, per descrivere, con i toni del melodramma, onirici o tragici, passioni d’amore devastanti e relazioni sociali opprimenti. I suoi film sono legati alla memoria e al tempo, a spazi chiusi dai quali si aprono nuovi percorsi della visione e del ricordo. Figlio di albergatori, trascorse l’infanzia nel cantone dei Grigioni, in un grande hotel di montagna. Fin da ragazzo si appassionò al cinema e all’opera e nel 1962 si trasferì a Berlino per studiare storia, politologia, giornalismo e storia dell’arte alla Freie Universität e nel 1966 si iscrisse alla Deutsche Film und Fernsehakademie”. E poi l’incontro con Fassbinder che ne ha segnato il percorso artistico in modo indelebile in una intensa condivisione esistenziale e collaborazione artistica che li ha spesso visti presenti l’uno nelle opere dell’altro, ma con una forte differenza di approccio al mezzo espressivo, alla narrazione e alla riflessione sulla storia contemporanea. Tanto disperatamente pessimista, violento e visionario quello di Fassbinder, quanto inquietante e onirico quello di Schmid, pur non essendo meno critico dell’amico sul suo presente storico.
E’ che Schmid ha sempre preferito alla critica diretta ad un modo di vivere e di pensare profondamente ipocrita e opprimente, quello della borghesia europea postbellica che cercava di non fare i conti con le ombre della propria storia nascondendole sotto una luccicante patina di modernità e di successo economico, un percorso espressivo e narrativo più deviante che non va inteso come una rinuncia alla lotta, ma come un modo per cercare di prefigurare una via d’uscita esistenziale ed artistica altra rispetto alla visione sociale dominante negli anni del suo agire creativo. Una modalità che gli apparteneva profondamente a partire dalla sua biografia di uomo “di frontiera”. “Io sono una persona di traffico di frontiera, fra nord e sud (…), fra est e ovest (…), senza identità culturale”, dichiara fin dall’inizio del documentario. E poi, più avanti: “Sono nato in un albergo, ho viaggiato come un bambino”. E ancora: “Essere su una frontiera, fra due culture, fra due epoche, fra un mondo di vivi e un mondo di morti”. E’ chiaro quindi come Schmid abbia sempre preferito, diversamente da Fassbinder, un attacco meno frontale, meno diretto alle ipocrisie della sua epoca, prefigurando una via d’uscita esistenziale che faceva del viaggio, della mobilità fisica e mentale, della visione onirica, del vissuto programmaticamente multiculturale dei suoi film (“Nei miei film ci sono sempre tante lingue differenti”), della sua istintiva curiosità per culture lontane dalla sua, non una via di fuga, ma il modo più naturale per lui di spostare lo sguardo, il pensiero, la vita verso un altrove che non si definiva più come critica dell’esistente, trattandosi di un vissuto già altro rispetto ai ‘confini’ etici e culturali dominanti.
Anche la sua ricerca e il suo amore per la teatralità e il mondo della lirica o il suo rifugiarsi spesso nel passato non assume un ruolo regressivo e non è soltanto un dato biografico, per quanto fondamentale per la sua crescita come persona e come artista (“Io vengo da un milieu di emigranti, cresciuto con tanta gente, con ebrei fuggiti, salvati dai nazisti, dai fascisti. Noi eravamo un albergo di emigrazione, tanta gente passava la guerra nel nostro albergo”). Basta ricordare un documentario bellissimo come “Il bacio di Tosca” del 1984 (https://www.youtube.com/watch?v=YH9XRw2cpbw&t=1842s), girato interamente nella Casa Verdi, una casa di riposo per cantanti e musicisti che abbiano compiuto 65 anni di età, fondata dal famoso compositore nel 1899 a Milano, per rendersi conto che la memoria, il ricordo non hanno niente di nostalgico o di mortifero perché, come afferma Schmid, “il futuro è fattibile solo se il passato è pensabile”, e, ancora, “la presenza dei morti, nella mia famiglia, tanti erano morti però erano molto vivi, nel racconto delle persone vive”. Ma è una rivendicazione artistica, politica, esistenziale della possibilità di conservare un mondo poetico, una profondità emotiva e riflessiva, un’oasi di bellezza e di umanità nonostante il rumore spesso violento e assordante del mondo circostante (e, in questo senso, le riprese iniziali e finali della Milano rumorosa e indifferente che circonda Casa Verdi, sono estremamente significative).
Si tratta di conservare, accudire, nutrire, far crescere il pensiero di una vita diversa, di un mondo più accogliente per tutti, la possibilità di uno sguardo bambino sulle cose che le veda per ciò che sono nella loro nuda verità, per poi poterle cambiare. “Spero sempre, ed è molto difficile, di conservare un po’ quello sguardo di bambino, quello sguardo innocente e di fare tutto il possibile per preservare quella innocenza da noi tutti perduta”, afferma Daniel Schmid in un altro momento del documentario. Perché è proprio nella meraviglia contenuta in quello sguardo bambino che risiede il sogno di una vita diversa e il sogno stesso del cinema che si rinnova ogni volta che degli sconosciuti si riuniscono in un cinema e nel buio attendono la meraviglia contenuta nelle sue immagini.
“Il sogno del cinema è tutto lì, in quel desiderio, in quella necessità di essere meravigliati”. Una meraviglia, quella magica del “mostratore d’ombre”, che la luce del sole, l’apparenza luminescente e vuota di troppa realtà quotidiana può far scomparire e disperdere.
Un’ultima nota, ma necessaria, va detta riguardo alla produzione del film. “Daniel Schmid, un racconto fuori stagione” è stato prodotto dal Fondo Archivio M.C., di cinema e letteratura, in memoria di Mario Ceretto, imprenditore ex partigiano, vittima di mafia, archivio che da tempo raccoglie documenti filmici e fotografici, con la rivista online “Primi Piani” dedica numeri monografici a registi, scrittori e poeti, e che precedentemente ha prodotto i documentari “Tempi di fabbrica” (2015) e “I partigiani alpini della VI G.L.” (2018), riguardanti l’archeologia industriale e la Resistenza partigiana nel Canavese. Come ha dichiarato Anna Albertano, regista di “Daniel Schmid, un racconto fuori stagione”, “l’aver potuto cogliere anche solo qualche momento dell’intensa esistenza di Daniel, sottraendolo all’oblio, risponde all’obiettivo dell’Archivio M.C. di recupero di memoria cinematografica”.
Regia e Adattamento: Anna Albertano
Soggetto e Ricerca iconografica: Luisa Ceretto
Montaggio e Postproduzione: Davide Pepe
Riprese: Matteo Degli Enzi
Una produzione Archivio MarioCeretto (http://www.archiviomc.com)
Origine: Italia, 2020
Durata: 24’
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
IL MISTERO DEL CINEMA
di Bernardo Bertolucci
La nave di Teseo – La Repubblica, 2021
Euro 8.50, pagg.92
Si tratta di un testo inedito di Bernardo Bertolucci scritto in occasione della Laurea Honoris Causa ricevuta dall’Università di Parma nel 2014. Il regista ricostruisce la sua autobiografia artistica, tra cinema e memorie private. Un testo che ora è stato pubblicato grazie al ritrovamento da parte della moglie Claire People e di Michele Guerra. Ne scaturiscono riflessioni in cui il regista fa luce su se stesso, sulla propria personalità, sulla propria arte. E sul mistero del cinema. Affermava Bernardo Bertolucci:” Dopo tanti anni, dopo tanti film, tutto mi sembra ancora molto misterioso. La nascita di un film, la prima idea, il linguaggio della macchina da presa, lo stile, l’alchimia tra i luoghi, gli attori, le luci. Eppure il film che ho davanti rimane ancora un mistero”. Ed in quel testo, diventato ora un libro, ricorda la sua infanzia in Provincia che mai dimenticherà e che traspone in film in tal senso significativi come “Prima della rivoluzione” (1964), “Strategia del ragno” (1970) e “Novecento Atto I e Atto II” (1976). Ma anche la scoperta della Nouvelle Vague francese, del suo innamoramento e del suo distacco da essa. Un testo in cui, come scrive Claire People nella Prefazione, c’è un senso di meraviglia, uno stupore profondo per le cose della vita che ha imparato fin da piccolo a casa, che scopre e fa suo già da bambino, un seme che cresce nel bisogno di esprimersi, nell’urgenza, nella necessità creativa del filmare. Un senso di meraviglia per il cinema ed il suo mistero che anche il lettore percepisce e nel quale rimane coinvolto capitolo per capitolo.
PETER CUSHING E I MOSTRI DELL’INFERNO
di Mario Galeotti
Edizioni Falsopiano, 2020
Euro 20, pagg. 219
Un attore Peter Cushing che non ha fatto fare sonni tranquilli a spettatori e cinefili con le sue interpretazioni in film horror come quelli sul principe delle tenebre Dracula espresse in “Dracula il vampiro” (1958) e “Le spose di Dracula” (1960), diretti entrambi da Terence Fisher, uno dei maestri dei film del terrore. Nel primo compie stragi a non finire ed è combattuto da un giovanotto, amico di una delle vittime che scopre che i vampiri non sopportano la luce del giorno e lo attira in una stanza buia, aprendo all’improvviso tutte le finestre, nel secondo è il datore di lavoro di un’istitutrice inglese in un castello della Transilvania.
A Peter Cushing si devono anche le interpretazioni di un altro personaggio del genere horror-movie, quello di Frankenstein. Ne ha interpretati ben quattro ed anche questi con il regista Terence Fisher con il quale aveva stretto un intenso sodalizio. La serie si apre con “La maschera di Frankenstein” (1957) in cui è il barone che compie tremendi esperimenti su cadaveri finché il gioco gli sfugge di mano ed uno dei suoi mostri uccide la governante di casa e quasi lo stesso fa con la fidanzata del barone Frankenstein, per proseguire con “La vendetta di Frankenstein” (1958), “La maledizione di Frankenstein” (1958) e “Distruggete Frankenstein” (1970). Film tutti diretti da Terence Fisher, con il quale ha avuto un intenso sodalizio, per il quale interpreta anche “La furia dei Baskerville” (1959) in cui è il famoso Sherlock Holmes che deve scoprire perché da generazioni tutti i primogeniti dei Baskerville vengono uccisi in modo violento e misterioso ed apparentemente l’assassino è un diabolico cane.
Ruoli di mostro nel cinema che nella vita invece, come scrive Emanuela Martini nella prefazione, era invece un uomo gentile. E su di lui, la Martini scrive che era un attore raffinato, sottile ed ironico, il più importante dei torbidi “eroi” della compagnia, cioè la Hammer Film, che alla fine degli anni Cinquanta rilanciò l’horror richiamandosi alle sue origini gotico-romantiche. Sui film, finora citati, Mario Galeotti ci offre un’analisi molto approfondita e si sofferma anche sul rapporto con Cristopher Lee e del passaggio dai film della Hammer a “Star Wars” (1977) di George Lucas dove è il Grand Moff Tarkin, un personaggio immaginario dell’universo fantascientifico di “Guerre stellari”.
Un approccio al libro lo offre anche il Saggio che Mario Galeotti ha scritto per Carte di Cinema e che appare proprio in questo numero.
GIULIANO MONTALDO: UNA STORIA ITALIANA
a cura di Pedro Armocida e Caterina Taricano
Marsilio Editori, 2020
Euro 24,70, pagg. 322
Pubblicato dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro 2020 in occasione di un Omaggio al regista genovese che comprendeva anche la proiezione di alcuni suoi film. Un Omaggio in occasione dei suoi novant’anni vuole essere anche l’occasione per rileggere, non solo i suoi film ma anche la sua esistenza di fabbricatore di immaginari. Quindi, oltre alle schede critiche dei suoi film affidate, scrivono gli autori del volume, a una generazione giovane di studiosi per verificare se le sue opere abbiano resistito al tempo, una serie di saggi che riguardano sia il cinema ma anche la televisione e le sue sperimentazioni. A tal proposito, scrivono ancora, “pochi autori hanno avuto, come Giuliano Montaldo, la capacità di rappresentare la complessità del cinema italiano del secondo dopoguerra. Nella filmografia del regista genovese, infatti, convivono tanti elementi che a loro volta raccontano come quella stagione del nostro cinema sia stata ricca, articolata, sorprendente. Scorrendo la sua filmografia si incontrano opere di grande impegno civile che hanno avuto riconoscimenti internazionali e grande successo di pubblico insieme a lavori coraggiosi ma che in un primo momento sono stati un po’ snobbati, anche dalla critica. Si trovano film che sperimentano tecniche nuove insieme ad altri (magari girati sotto pseudonimo) che aderiscono invece ai generi più esplicitamente popolari; si alternano pellicole destinate al grande schermo e altre che invece sono state pensate per la televisione”. Sono queste le linee guida di questo volume su un autore di cui viene sottolineato anche il suo impegno politico e quello culturale espresso in maniera aperta e lungimirante come presidente di Rai Cinema. Nel libro si parla anche delle collaborazioni con Ennio Morricone e con Sergio Leone e delle sue lezioni al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma che gli autori del libro definiscono leggendarie e danno origine nel volume a testimonianze entusiaste da parte di chi le ha frequentate e che adesso hanno un ruolo importante nell’industria cinematografica italiana. Gli autori sottolineano anche la fondamentale presenza nella filmografia di Giuliano Montaldo della moglie Vera Pescarolo Montaldo “elegante signora dello spettacolo che ha condiviso con lui quasi tutta la carriera”. Ed affermano anche che Giuliano Montaldo ha operato come un artigiano del nostro Rinascimento rispettando i budget e non sforando mai i tempi di lavorazione, ed al tempo stesso lavorando con le persone da lui scelte.
Un libro illuminante su un autore tra i più grandi del nostro cinema come si potrà constatare nella sua coinvolgente lettura.
LA CARTOMANTE DI FELLINI – L’UOMO, IL GENIO, L’AMICO
di Marina Ceratto Boratto
Baldini + Castoldi – La nave di Teseo, 2020
Euro 20.00, pagg.471
Marina Ceratto Boratto per anni è stata la cartomante di Federico Fellini. L’ha conosciuto sul set del film “8 e ½” dove era andata ad accompagnare la madre, celebre attrice a partire dagli anni Trenta Caterina Boratto che da tempo era rimasta lontana dalla scena e che Fellini la riportò sul set facendola molto felice e la volle anche in “Giulietta degli Spiriti”. Il racconto dell’autrice del libro si dipana tra questi due film. Aveva conosciuto Fellini che aveva sedici anni e rimase turbata e affascinata da un personaggio che per lei poteva essere un testimone, un profeta o un apprendista stregone. Fellini entrò subito in confidenza con lei chiamandola affettuosamente bambocciona e chiedendole se voleva fare cinema anche lei. Rispose di non perché suo padre che era cattolico non voleva, e ciò diede inizio a riflessioni sulla religione che nel corso della loro conoscenza poi fecero più volte. Marina per tutta la vita gli leggerà poi i tarocchi, promettendogli la fine dei suoi mali. E ne seguì da vicino la sua vita raccontando nel corposo volume che ha scritto episodi sconosciuti dei due film e dei successivi fino alla morte del regista, descrivendone la vita sul set e le domeniche a Fregene con gli amici, l’amore con Giulietta Masina e il rapporto con la misteriosa amante Anna Giovannini. Ma anche i film rimasti incompiuti, le difficoltà del regista e dell’uomo, l’angoscia e i demoni che lo tormentavano. L’autrice di questo volume che ha scritto anche il diario di lavorazione del “Satyricon” e poteva continuare nel cinema ma preferì il giornalismo ci fa scoprire il dietro le quinte un Fellini mai visto prima. Fellini, l’uomo, il Genio, ma anche l’amico che sapeva essere terribile e che si doveva saper perdonare, indicandocene difetti e limiti. Ma soprattutto un artista che non è mai sceso a compromessi con la propria arte.
CREDITS
Carte di Cinema 24
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 24 della rivista online, Roberto Baldassarre, Paola Brunetta, Marcello Cella, Maria Pia Cinelli, Mario Galeotti, Mario Giunco, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Paolo Vecchi, Luciano Volpi, Marco Incerti Zambelli.