Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 3.1 L’EVOLUZIONE DEL GANGSTER MOVIE DAGLI ANNI ’60 A SCORSESE di Marino Demata
- 3.2 SANGUE E CELLULOIDE – VIAGGIO TRA I DRACULA CINEMATOGRAFICI a cura di Riccardo Poma
- 3.3 UNA RIFLESSIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, DI COME IL CINEMA HA TRATTATO INFEZIONI BATTERICHE, VIRUS E PANDEMIE di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
- 3.4 MARINA PLEASURE SERIAL: ICONOGRAFIA VIDEO DI UNA LEGGENDA DEL PORNO ITALIANO E PANORAMICA DELL’HARD ITALICO DEL TEMPO CHE FU di Roberto Baldassarre
- 3.5 UN PALCO AL CINEMA. IL FILM D’OPERA ITALIANO NEGLI ANNI TRENTA-CINQUANTA DEL NOVECENTO – PRIMA PARTE di Mario Giunco
- 3.6 ALCUNI ASPETTI DELL’INTRAMONTABILE COMICITÀ DI STANLIO E OLLIO di Mario Galeotti
- 3.7 KILL BILL “OPERA LIMITE” DI TARANTINO di Roberto Lasagna
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 6 OCCHIO CRITICO
- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 8 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
ROGER CORMAN: LA RIVOLUZIONE ESPLODE A HOLLYWOOD
di Francesco Saverio Marzaduri
Signore incontrastato dell’“exploitation movie” girato in pochi giorni e in grande economia, ha saputo oltrepassare i limiti di “budget” risicati creando una tecnica di cui è riconosciuto maestro. Con molta furbizia e grazie a tante vecchie star in disarmo.
BALLATA DI UN “COMICO BIANCO”
di Francesco Saverio Marzaduri
Maschera comica lunare, con fossetta accattivante, Francesco Nuti è stato interprete e in seguito anche regista di commedie fresche ed eleganti, venate di malinconia. Un grande talento, non esente da pericolose cadute nel narcisismo (e nell’ambizione).
SAGGI
L’EVOLUZIONE DEL GANGSTER MOVIE DAGLI ANNI ’60 A SCORSESE
di Marino Demata
Il saggio segue l’evoluzione del genere cinematografico del “Gangster movie” dalla fine degli anni ’60 al recente “The Irishman” di Martin Scorsese. Gangster movie è uno dei generi che si trasforma più radicalmente di altri, e, in questa trasformazione si ribaltano completamente le modalità con le quali, nel cinema classico venivano viste le figure dei gangster, intesi solo come elementi perturbatori dell’ordine costituito da ripristinare e da conservare.
Secondo l’Autore, il punto di rottura più radicale e clamoroso, rispetto al cinema Gangster classico, avviene ne 1967 con “Bonnie & Clyde” di Arthur Penn, perché per la prima volta viene costruita una coppia di gangster, con le cui gesta e con la cui personalità il pubblico consente pienamente. Per la prima volta si crea una forte empatia con lo spettatore, le cui cause sono da ricercare non solo nell’orientamento e nella bravura del regista, ma anche da motivi storici e politici, che vengono passati in rassegna.
Il saggio segue l’evoluzione di questo nuovo tipo di cinema con film come “La caccia”, “Butch Cassidy” e “Gloria” di Johan Cassavetes, che stravolge talmente le caratteristiche tradizionali del genere, a tal punto che, attraverso un film perfetto, sembra che ne voglia fare una vera e propria parodia.
Attraverso i suoi quattro Gangster movie, Scorsese completa l’evoluzione di questo genere cinematografico. La tesi dell’Autore è che il regista, con una serie di espedienti, ricerche e colloqui con i veri gangster ancora in vita, abbia voluto conferire ai suoi film un carattere eminentemente documentaristico, capace di ricreare storie, personaggi e ambienti proprio come essi si sono verificati. D’altra parte, l’amore per il documentario è attestato anche dai suoi docu-film di ricerca sul cinema americano e sul cinema italiano (“Il mio viaggio in Italia”), entrambi concepiti e realizzati negli anni ’90.
Naturalmente avrebbero potuto trovare spazio molti altri esempi di Gangster movie (citiamo per tutti “C’era una volta in America”), e altri autori, come Brian De Palma, le cui analisi non vengono riportate nel presente saggio. Nulla vieta che in futuro si possa ritornare sull’argomento con maggiore spazio a disposizione.
SANGUE E CELLULOIDE – VIAGGIO TRA I DRACULA CINEMATOGRAFICI
a cura di Riccardo Poma
Un particolarissimo boy meets girl che inizia con “Avatar” e chiude sul “Dracula” di Coppola, fissato in 1400 inquadrature di 450 pellicole che attraversano praticamente tutta la settima arte. Titoli di testa, con i nomi delle attrici e degli attori che vanno a comporre l’immagine di un bacio, degni di Saul Bass, una colonna sonora che spazia da Steiner a Rota, da Rozsa a Morricone, da Delerue a Bregovic.
UNA RIFLESSIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, DI COME IL CINEMA HA TRATTATO INFEZIONI BATTERICHE, VIRUS E PANDEMIE
di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
Una riflessione di come il cinema ha trattato infezioni batteriche, virus e pandemie, causate da altrettanto diversi e sconosciuti microrganismi mortali e non; pandemie che si sono succedute nel corso dei secoli. Una valutazione di come il cinema ha trattato il loro impatto sulla società civile e sull’ambiente per vedere se il cinema si è attenuto alla realtà dei fatti scientifici o ha scelto la mera spettacolarizzazione cinematografica.
MARINA PLEASURE SERIAL: ICONOGRAFIA VIDEO DI UNA LEGGENDA DEL PORNO E PANORAMICA DELL’HARD ITALICO DEL TEMPO CHE FU
di Roberto Baldassarre
Un profilo biografico e artistico della pornodiva Marina Lotar, compiuto attraverso un cofanetto video celebrativo; e di riflesso uno sguardo all’industria del porno italiano degli albori.
UN PALCO AL CINEMA. IL FILM D’OPERA ITALIANO NEGLI ANNI TRENTA-CINQUANTA DEL NOVECENTO – Prima parte –
di Mario Giunco
Mario Giunco in questo articolo ripercorre la filmografia relativa al Film d’Opera italiano negli anni Trenta-Cinquanta. I film in questione sono elencati in ordine alfabetico, per regista. Essendo la filmografia molto vasta in questo numero è pubblicata la prima parte del saggio, che inizia da Piero Ballerini e termina con Giacomo Gentilomo; nel prossimo numero sarò pubblicata la seconda parte.
ALCUNI ASPETTI DELL’INTRAMONTABILE COMICITÀ DI STANLIO E OLLIO
di Mario Galeotti
Uno degli aspetti più interessanti che emerge da un’accurata analisi dei film della coppia Stan Laurel & Oliver Hardy è la natura spesso accidentale e improvvisa degli eventi che scatenano la loro irresistibile comicità. Il punto di rottura, nelle avventure di Laurel e Hardy, può anche derivare da un gesto o da un’azione compiuti in maniera premeditata con l’intento di stravolgere una situazione di calma apparente, ma più spesso scaturisce da un evento imprevedibile, inatteso, che si concretizza all’improvviso in circostanze del tutto fortuite e con effetti comici ancora più esilaranti. Le numerose argomentazioni e letture critiche sulle dinamiche della coppia Stanlio e Ollio non hanno, a nostro avviso, messo sufficientemente in risalto questo elemento.
KILL BILL “OPERA LIMITE” DI TARANTINO
di Roberto Lasagna
Kill Bill è il “film limite” della filmografia di Quentin Tarantino, la cui dismisura, estetica e di durata, prelude all’allargamento di orizzonte dei film che seguiranno ed è probabilmente l’opera tarantiniana che più scopertamente riflette sui linguaggi e sulla rappresentabilità della violenza attraverso di essi.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
LA FEDIC ALLA MOSTRA DI VENEZIA
di Paolo Micalizzi
Micallizzi presenta il 25. Forum Fedic che si svolgerà al Spazio Incontri del Venice Production Bridge (Hotel Excelsior) del Lido di Venezia nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il Forum sarà incentrato sui Festival e sugli Autori Fedic. Con il Premio FEDIC. attribuirà alcuni riconoscimenti, relativi al cinema italiano presente nelle varie Sezioni della Mostra.
CARLOTTA BRUSCHI: IL CINEMA COME PROFESSIONE
Intervista di Paolo Micalizzi
L’intervista di Paolo Micalizzi a Carlotta Bruschi, la quale da anni fa parte della Giuria del Premio Fedic, mette a fuoco la passione dell’intervistata per il cinema e analizza la professione da lei scelta: quella di Segretaria di Edizione.
FESTIVAL ED EVENTI
77. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA: CHE LA FESTA COMINCI
di Paolo Micalizzi
L’articolo presenta il Programma articolato della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si farà Live nella data stabilita, cioè 2 – 12 settembre, dopo l’insorgere della pandemia. Come ha detto il Direttore Artistico Alberto Barbera: “È con grande senso di responsabilità e di impegno che abbiamo affrontato una situazione ignota e senza precedenti. Una situazione nella quale le regole del gioco cambiavano in continuazione, costringendoci a grande flessibilità e disponibili e continue correzioni di rotta”.
OCCHIO CRITICO
SPIKE LEE: BLACK MOVIE MATTERS
di Marco Incerti Zambelli
Spike Lee è autore poliedrico e prolifco, ma spesso le sue opere non raggiungono il pubblico italiano. Il proliferare delle piattaforme digitali permette ora di gettare uno sguardo d’insieme sui suoi ultimi lavori, che confermano la sincera passione, il rigoroso impegno, l’ingegnoso talento di un maestro della cinematografia degli ultimi decenni.
NEL CENTRO ITALIA DEI TERREMOTI: DUE FILM DI EMILIANO DANTE
di Tullio Masoni
Due film sul terremoto e il dopo all’Aquila, Accumuli, Amatrice, Arquata del Tronto Camerino, Visso, Norcia…Identità individuali e collettive nella difficile sopravvivenza. Una leale e inventiva ricerca di linguaggio.
SUL DANUBIO: “CUETIZ” DI TAMAS YVAN TOPOLANSKY; “FINAL CUT- LADIES AND GENTLEMEN” DI GYORGY PALFY”
di Paolo Vecchi
Mihaly Kértesz, sbarcato a Hollywood dove ha anglizzato nome e cognome in Michael Curtiz, sta girando “Casablanca”, che diventerà una leggenda della storia del cinema. Ma gli USA sono appena entrati in guerra, alle abituali difficoltà del bizzoso regista con il tycoon Warner e il produttore Wallis si aggiungono quelle con Johnson, occhiuto commissario governativo, incaricato di controllare la funzionalità del film alle esigenze propagandistiche.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
LO SGUARDO LATERALE. I DOCUMENTARI DI GIACOMO VERDE
di Marcello Cella
Una riflessione sui documentari di Giacomo Verde, videoartista, pittore, attore, regista, attivista e molto altro, recentemente scomparso.
INTERVISTA A JACOPO BROGI
di Paola Dei
“LABORATORIO GRECIA” è un viaggio che attraversa la Storia greca ed europea passata e recente: dalla seconda guerra mondiale alla crisi che viviamo. Un documentario di Storia e di tante storie: vita quotidiana nell’epicentro del neoliberismo applicato.
Il fascismo e l’occupazione di ieri, la Resistenza: un paese che deve al proprio popolo la sua Liberazione.
La Guerra Fredda e la dittatura militare, la troika di oggi: la speranza e la rabbia, la disperazione, il dolore, la catarsi di un popolo rassegnato ma combattivo, omologato ma rivoluzionario, indifferente ma generoso e solidale. Un viaggio condiviso assieme ad intellettuali, politici e gente comune. Analisi e referti dal laboratorio greco. Cronache del nostro avvenire: in cammino fra le generazioni, per abbandonare l’eterno presente ed inventare un Futuro dalle misure umane.
«Se la Democrazia può essere distrutta in Grecia, può essere distrutta in tutta Europa» (Paul Craig Roberts).
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
ROGER CORMAN: LA RIVOLUZIONE ESPLODE A HOLLYWOOD
di Francesco Saverio Marzaduri
 Roger Corman e Vincent Price
Roger Corman e Vincent Price
Non capita sovente che il nome d’un regista acquisti meriti e importanza senza che la sua produzione annoveri un solo titolo davvero degno di nota. Impossibile discernere tale nome da un genere frequentato con assiduità o da una produzione visibilmente grama in “mise-en-scène” e impianti narrativi. Ed è ugualmente impossibile separare la firma da un periodo controculturale fortemente condizionato dal mutamento di mode, gusti, pubblici. Eppure, dall’alto delle proprie 94 lune, a tutt’oggi Roger Corman non cessa d’essere un caso più unico che raro: la garanzia di una tecnica che non si premura granché di realizzare confezioni di qualità opinabile, il cui esito – risibile per palati esigenti, più semplicemente ingenuo – non va a scapito di un’indiscutibile professionalità.
Perché di tecnica, relativamente a Corman, si deve parlare in barba a giudizi talmente standard e uniformi da suonare datati come (e forse più de)i suoi film: a testimoniarlo, l’autobiografia “Come ho fatto cento film a Hollywood senza mai perdere un dollaro” in cui l’autore, con molta ironia, snocciola un “modus operandi” cominciato dalla più collaudata gavetta, posto al contempo come un’alternativa-sberleffo ai “System” di magne produzioni in piena crisi. Non vi è genere che il cineasta di Detroit non attraversi – dalla fantascienza al gangster, per tacere ovviamente dell’horror – senza che gli incassi, conseguiti tra drive-in e pidocchietti, lo pongano mai in condizione di rimetterci, inclusa l’abitudine di riutilizzare un medesimo set per più progetti all’anno, e nel minor tempo possibile, procurandogli la pronta etichetta d’incontrastato sovrano dell’“exploitation”.
Una tecnica, dunque, ch’è anche predefinito stilema: alzi la mano chiunque, guardando uno dei vari adattamenti da Poe, non individui la mano di Corman in un’abilità costruttiva desunta dall’impiego di sanguigni “décor” (perlopiù dovuti alla firma tutelare di Daniel Haller), giocati su cariche tonalità cromatiche a pastello grazie a un prodigioso apporto fotografico, spaziante da Floyd Crosby e Arthur Grant al futuro regista Nicolas Roeg – e in quest’ultimo caso debitore delle correnti “pop”. E ancora nel sodalizio col compositore Les Baxter, così come nella scelta di gloriosi volti hollywoodiani la cui età avanzata non scalfisce la professionalità (Boris Karloff, Peter Lorre, Basil Rathbone, Ray Milland), consentendo a una di esse, Vincent Price, di associare all’opera cormaniana la propria caratteristica, mefistofelica icona. Il gusto dell’eccesso, l’edificazione d’un universo parossistico morboso e soffocante, quasi metafisico e pervaso da una vena beffarda e sarcasticamente macabra: indici bastevoli a far di Corman un marchio di fabbrica, dove il concetto d’“idea”, nel senso più etimologico del termine, non esce scalfito in una struttura narrativa sopperente alla scarsezza economica, impreziosita dalla collaborazione con Charles Beaumont, Dick Matheson e un giovane Robert Towne. L’occasionale introduzione di segmenti onirici, a base di filtri e distorsioni ottiche, acclude ulteriore pregio a una fecondità barocca, “kitsch” finché si vuole, che nell’abilità d’impastare effetti orrifici e note grottesche meglio condensa la ridefinizione estetica del “fantasy” cinematografico.
 Roger Corman sul set de “Il pozzo e il pendolo”
Roger Corman sul set de “Il pozzo e il pendolo”
Si può convenire come molti lavori scaturiti dalla “factory”, senza la pretesa d’esser presi sul serio e a un passo dalla dichiarata parodia, lascino il tempo che trovano e l’apparato non possa non ritenersi arcaico (per cui sarebbe inesatto non definirlo “invecchiato”). Vero è che se nella gran parte dei casi la ghianda permette alla quercia di fiorire, non si può non riconoscere alla griffe cormaniana l’introduzione d’un metodo che, in epoca di influenze e correnti, non poco contribuisce permettendo al decadente “milieu” di ritemprare le finanze, risorgendo più rigoglioso e potente. Una figura rinascimentale a tutto tondo, sotto la cui ala crescono nomi nel comparto registico (Scorsese, Coppola, Bogdanovich, Cameron…) ed attoriale (Nicholson, De Niro, Bronson e Dennis Hopper, Peter Fonda, Bruce Dern) destinati a lasciare impronte indelebili. E lo stesso può dirsi relativamente alla controtendenza che partorisce generi e “spin-off” in linea con la voga ribellista sessantottina, bruciati in tempi rapidissimi – lo “youth”, offerto dallo psichedelico “Il serpente di fuoco”, o il “bikers” de “I selvaggi” – trovando in “Easy Rider” l’eponima vetta.
Un’inestricabile esperienza di cinema e vita, talvolta pagata a proprio rischio e pericolo, come dimostra lo scomodo “L’odio esplode a Dallas”, oggetto di minacce nella gestazione e – ironia della sorte – film assai più profetico di quanto la tormentata uscita faccia presumere. E anarchicamente “vintage” da tornare a confrontarsi con le grandi produzioni dirigendo, con visionaria inventiva, l’apocalittico-avvenirista “Frankenstein oltre le frontiere del tempo”, tratto da un romanzo di Brian Aldiss, in un’epoca dove nomi come il suo, ghiotto menù per cinefili e “aficionados”, non si possono non salutare con tenero anacronismo; ciò prima di lasciarsi definitivamente alle spalle la regia per dedicarsi alla produzione e alla distribuzione nazionale di grandi cineasti europei, occasionalmente concedendo qualche “cameo”. Non vogliamo dire che gli spunti socio-politici o i risvolti psicanalitici appaiano materia inferiore rispetto ad emblemi figurativi o a eventuali significazioni morali spiegate dalle funzioni terrorizzanti dell’horror: rivedendo in chiave odierna un “must” gangsteristico qual è “Il clan dei Barker (forse il capolavoro di Corman), non sfugge una certa allegoria nel ritratto della madre sanguinaria del titolo originale, e nel suo cieco odio verso una società alienante, a sua volta restituito nella morbosa educazione sentimentale dei quattro figli.
Forse, nell’attuale cinematografia a stelle e strisce, non è così palpabile il vuoto lasciato da artigiani della Settima Arte altrettanto prolifici, dotati d’identica purezza e originaria semplicità della celluloide che fu. “Sine dubio”, non si può non riconoscerla lezione anticonformista, rivoluzionaria al punto che perfino in Italia è stata (e per più d’uno è ancora) eletta a eclettico modello di riferimento. Un maestro? Sì, senza ma e senza se.
 “Il clan dei Barker”, 1970
“Il clan dei Barker”, 1970
BALLATA DI UN “COMICO BIANCO”
di Francesco Saverio Marzaduri

“Recitar! Mentre preso dal delirio
Non so più quel che dico
E quel che faccio!
Eppur è d’uopo, sforzati!
Bah! Sei tu forse un uomo?
Tu se’ Pagliaccio!”RUGGERO LEONCAVALLO, Pagliacci
“Non si muore d’amore, si muore quando non si mangia.
”FRANCESCO NUTI, Son contento
Un gran lavoro, una decina d’anni fa o poco più, fecero Matteo Norcini e Stefano Bucci rastrellando interviste, testimonianze, istantanee, contributi per il monumentale volume “Francesco Nuti – La vera storia di un grande talento”, pubblicato da Ibiskos e dedicato alla sottostimata arte dell’attore-regista fiorentino, pratese d’adozione. E mai titolo suonò più confacente per il documentario-tributo realizzato da Mario Canale, il cui titolo è un palese riferimento a una fortunata pellicola, “Francesco Nuti… e vengo da lontano”. Perché, come Willy Signori e numerosi altri personaggi d’una variegata galleria, a Nuti era sufficiente l’espressione tenera e sorniona da fanciullone sorridente, la mitica fossetta sul mento, a farne una sfera a parte in un’epoca in cui all’agonizzante commedia italiana si sopperiva con una fucina di comici in embrione, cui i successi del piccolo schermo, tra cabaret e varietà, recavano manforte. Poco meno di quarant’anni sono trascorsi da quando Nuti apparve come la sorpresa tutta toscana all’interno d’un sottocapitolo del nostro cinema per il quale il compianto critico Stefano Reggiani coniò l’espressione “stagione malincomica”, i cui assortiti regionalismi non nascondevano un “fil rouge” di fondo: l’aria candida, sprovveduta d’una generazione innegabilmente disarmata di fronte a un periodo funestato da mutamenti socio-politici e culturali, attentati terroristici, cambi di casacca ideologica e quant’altro. Se Nanni Moretti è riconosciuto l’eponimo esponente d’un nutrito gruppo di cineasti – da Giordana a Piscicelli, a Giuseppe Bertolucci – indotto ai rancidi bilanci del Sessantotto, fraintende chi tuttora ne scambia contraddizioni e tormentoni, anche ilari, per pillole di comicità. Lo sguardo generazionale è, però, anche materia per buffoneschi apologhi, mini-cronache di fallimenti intrise d’amarezza, in cui i neonati beniamini dello schermo televisivo fungano da nitida lastra per un pubblico in grado di guardare oltre il riverbero. Senza per questo rinunciare al sogno.

In una filmografia che conta una quindicina di titoli e una decina di regie non eccelse, il segreto dell’arte di Francesco – che non si definisce comico quanto “attore comico” – risiede nell’effimera bolla di sapone che scinde la candida maschera “à la” Harry Langdon da egoismi e meschinità d’una sfera pronta a travolgere il sogno. Senza disporre della simpatica indolenza, tipicamente partenopea, di Troisi o della nevrosi d’un Verdone con cui reagire alla realtà metropolitana, peraltro serbandone analoghi impacci, la fisionomia di Nuti suggerisce maggiori affinità con la surreale mimica di Nichetti, tanto che la lunare stramberia (all’occorrenza non esente da gag da cartone animato), senza smaltire un grammo della propria innata “clownerie”, assurge a “modus operandi” per non cadere nelle trappole del sistema. Non rinunciando neppure al modello di Benigni, la cui ruspante veracità fa un corpo comico d’“azione”, anziché di “reazione” come nel caso di Cecco, fedele a una concezione umoristica tesa a sposare una poetica neorealista di stampo zavattiniano con una “vìs” propriamente vernacolare. L’impressione è di non trovarsi di fronte a un comico, o a un fantasista, ma ad un interprete brillante dietro cui si celano sfumature di malinconia e tristezza, tranquillamente predisposto per travisare la classica figura di Pierrot in una presenza attoriale idonea per registri drammatici. Non per niente la terza ed ultima collaborazione col regista e mentore Maurizio Ponzi, “Son contento” (che annovera un toccante soliloquio con un usignolo spirato), ruota sulle vicissitudini sentimentali tra un cabarettista in crisi creativa e la fidanzata, che portano il primo a una forte e profetica depressione, facendo luce su quel binomio pubblico-privato che si rivela strumento vincente – ed egoistico – per l’esuberanza dell’artista nel saggiare nuovi lidi. Tale dualismo trascende l’artificio convincendo l’interprete, dopo la spontanea freschezza dei lavori precedenti, a compiere il balzo verso la regia senza rinunciare alla cassetta. Viceversa, il gusto dell’ammiccamento cinefilo, scimmiottante soprattutto la produzione americana, benché pretenzioso, ancora non ha la supponenza che si vedrà una decina d’anni più tardi.

Innegabile che lo humour di Nuti sia degno d’amorevole empatia per le fiabe dolci-amare in cui la poetica, nemmeno troppo velata, del suo Candide concilia col sapore rustico, genuinamente agreste e mai dimenticato delle origini. Avvalendosi di nomi prestigiosi che firmano con lui i copioni (Elvio Porta, Franco Ferrini, Enrico Oldoini, Luciano Vincenzoni, Sergio Donati, Vincenzo Cerami), ribadito dal sodalizio con Ponzi per tre film[1] – tuttora i migliori del regista – Francesco “in primis” non fa mistero di trovarsi a suo agio nella solidale collaborazione coi medesimi nomi, a cominciare dal fratello Giovanni autore di tutte le colonne sonore, le cui melodie sovente ricalcano Ry Cooder, e dal gruppo musicale di cui membro, i “Barluna”; e ancora il produttore-egida Gianfranco Piccioli, il montatore Sergio Montanari, l’operatore e direttore della fotografia Maurizio Calvesi, gli abituali sceneggiatori e futuri cineasti Ugo Chiti e Giovanni Veronesi – quest’ultimo da Cecco tenuto a battesimo, come accade ai giovani Ricky Tognazzi e Ferzan Özpetek. Del resto, nella moltitudine di usuali caratteristi, basterebbe la presenza-feticcio dell’ex impresario teatrale Novellantonio Novelli, grande amico e portafortuna in quasi tutte le pellicole del Nostro, a rimarcare una sanguigna volontà di reiterare le radici qual irrinunciabile oggetto transizionale custodito gelosamente, un po’ mentore e un po’ “spiritual guidaince” (riprovato dalla scelta di nomi affini per i vari Maestro, Merlo, Segugio o semplicemente Novello). Si pensi, inoltre, alla passione per il biliardo che il protagonista di “Io, Chiara e lo Scuro”, il seguito “Casablanca, Casablanca” e il tardivo “Il signor Quindicipalle” eredita dalla famiglia. E ancora alla toscanità dei luoghi, materia da adattare all’allegro funambolismo (la Paperino frazione di Prato, che prelude al quartiere Ovosodo riutilizzato dal livornese Virzì): su tutti Narnali, dove il padre di Nuti, nativo del Mugello, svolge la professione di barbiere e l’artista vive dall’infanzia al successo. Topografico cenno nell’ultimo episodio dedicato alla stecca ma soprattutto nella prima pellicola di cui è protagonista assoluto, dopo il debutto avvenuto l’anno prima con “Ad ovest di Paperino” insieme ai “Giancattivi”: “Madonna che silenzio c’è stasera”.

Nel film di Alessandro Benvenuti, anch’egli all’esordio come interprete e regista, umori e disagi di tre esistenze solitarie, che vagheggiano di evadere dalla quotidiana routine, si coalizzano in risposta a un muro di ostilità all’insegna d’un demenziale “nonsense”, risolto in perfidi frizzi e goliardici lazzi. Fermo restando nel “climax” dell’operazione surreale, che sfiora topici spunti del periodo (compresa ovviamente l’alienazione giovanile in famiglia e in società), il fine è la semplice attesa del domani, mentre il tempo trascorre nella costruzione di situazioni grottesche e irriverenti. Tra apologhi irreali – come quello dei piccioni capaci di trasformarsi in principi azzurri, nonché allegoria dei “dropout” al centro – la sagoma di Nuti già evidenzia i tratti caratteristici dello smarrito, disoccupato e oppresso dai familiari. In “Madonna”, che replica il paradigma del vagabondaggio d’una giornata impiegata nel film precedente, il ruolo dell’impacciato, assillato dall’incombente presenza materna e alla costante ricerca d’un posto che non trova mai, non s’arena alla gag chapliniana o allo stornello canzonatorio in stile Benigni (la “Pupp’a pera” destinata a tornare, in versione rock, in “Caruso Pascoski di padre polacco”), esplicitando un marcato autobiografismo. Fuori e dentro la finzione, Francesco è un perito chimico tessile che serba inalterato il nome anagrafico, come negli altri due film di Ponzi, giocando a reiterare e rimescolare sé stesso e la famiglia: sugli “ending credits” di “Io, Chiara e lo Scuro”, mentre s’appresta a concludere una partita vincente, il protagonista racconta di sé al navigato concorrente, e in “Son contento” il fattore si riverbera (extra)diegetico nel bagaglio umoristico del fantasista. Piglio autobiografico col quale (tentare di) fuggire una realtà “bigger than life” monotona e uniforme, dove le fabbriche di “Madonna” appaiono luoghi sinistri memori di Petri e, secondo la lezione di De Sica, c’è chi ruba una bicicletta mentre i bambini – potenziali Franti o Lucignolo, quando non “olvidados” – ci guardano e imitano. Nel florilegio di citazioni, in cui figura perfino una parodia de “Il laureato”, il trasognato e spicciolo zen di Cecco lo sorprende nell’atto di monologare con le stelle e la natura come un San Francesco (e i panni d’un monaco, suo malgrado capace di miracoli, Nuti li vestirà nel segmento “Sant’Analfabeta” per la miniserie televisiva “Sogni e bisogni” di Sergio Citti), vaneggiando d’incontrare la fortuna un anno prima di dissertare della Creazione sotto forma di tavolo verde – e il Padreterno, mancino, non si sa che stecca usi, se in legno o in alluminio.[2] Ma, come accade al Billy Fisher di John Schlesinger, si tratta d’un emisfero immaginifico edificato su una stentata evasione i cui trionfi sono tristi e privi di sbocchi, che porta Francesco a vincere per caso una corrida canora, per poi sperperare l’assegno in premio con una rossa prostituta, con cui non combina nulla. La stessa filosofia del Magnifico, il sedicente amico del babbo che l’ha abbandonato, non è che un patetico castello di carte sbugiardato dal giovanotto quando scopre che chi pronostica di far fortuna a Machu Picchu è un altro infelice fra tanti, sposato con prole, che ha abbandonato i sogni. Non rimane che raccattare quel gramo barlume d’onirismo confidando nella vincita d’una schedina; e vuoi mai che il buffonesco sforzo di “spostare la Chiesa”, dato l’improvviso scampanellio, non sortisca l’effetto o la speranza di riallacciare con l’ex fidanzata non si verifichi in un inatteso squillo di telefono, prima d’una nuova avventura l’indomani…

Se si pensa a “Casablanca, Casablanca”, a volte la bugia è un espediente per convincere il produttore a realizzare dubbi progetti. Ma laddove il sogno si eleva a univoca ancora di salvezza, onde evadere dal grigio torpore del trantran, il contraltare è costituito dall’abbandono (e dal conseguente senso della partenza), “pattern” non meno irrinunciabile. Il Francesco di “Madonna” è abbandonato dal genitore nella misura in cui il ruolo paterno è quello che meglio contorna la produzione dell’artista. Senza rinunziare alla dimensione favolistica tra lo zuccheroso e l’assurdo, la cui origine ipertestuale appare dichiarata in “Miracolo a Milano”, “Tutta colpa del Paradiso” è incentrato sul tentativo d’un ex galeotto dal cuore d’oro, il cui passato è stato spazzato via, di riottenere il figlioletto adottato da una giovane coppia; rintracciatolo in Val d’Ayas, dove il bimbo vive coi genitori nella baita denominata “Paradiso”, desiste dall’iniziale proposito folgorato dalla meraviglia del paesaggio, illuminato dal calore degli abitanti e dal ricambiato amore per chi, ignaro dei suoi trascorsi, gli offre ospitalità. E ancora la voglia di paternità, che nel privato si concretizza durante un periodo di forte difficoltà, fa capolino in “Willy Signori e vengo da lontano”, “Io amo Andrea” e “Caruso, zero in condotta”: nel primo caso indotta da immotivato rimorso, nel secondo dal desiderio di uno dei personaggi di costituire un nucleo familiare, esente da legami sessuali, e nel terzo dal patetico sforzo di accudire la tredicenne figlia con cui non dialoga, membro d’una combriccola di teppisti; ma pure “Caruso Pascoski”, nelle ultime scene, diventa genitore. A mo’ di “transfert”, l’abbandono della figura paterna si ripresenta in quello del protagonista nelle disparate vicissitudini sentimentali, ove l’imperante femminismo tiene testa a fanciulleschi capricci (e nella realtà innesca un’ambigua natura rassomigliante la finzione al privato, con Cecco che s’atteggia a duro variando le partner in un perseverante tira e molla). Salvo che l’affettiva burrasca svela presto l’artificiosità dell’assunto, arrancando nel tentativo di dar ritmo all’impianto umoristico, elemento primario; e il cripto-sciovinismo dilagante – per il quale le “spalle” femminili rinunciano a propositi personali, quando non scontano misogini ritratti – tradisce il carattere furbetto degli esordi colorandolo d’un cattivismo talora irritante (“Il potere va mantenuto”, somatizza un autoironico Francesco, “sennò che maschilisti siamo?”), sbeffeggiando il “politically correct” e occhieggiando a Villaggio nelle soluzioni comiche.

Va da sé come lo spaesamento d’una creatura alle prese con un mondo oscuro, carente d’amore, che non si pone scrupoli nell’affidarlo al suo destino, ravvicini la maschera nutiana all’universo di Collodi, complice ancora una volta la toscanità di cui il burattino è deittico simbolo. Ma mentre “Madonna” si pone come l’inizio felice di un’avventura nella provincia pratese, “OcchioPinocchio” n’è il sofferto epitaffio: l’esperimento di un “reboot” della fiaba – di per sé territorio delicato, che lo stesso Fellini reputava insidioso – si scontra con l’ambizione d’un interprete convintosi d’una crescita registica che s’è ingolfata, risolta in accurati movimenti di macchina e presunti virtuosismi fini a sé stessi; e un esigente autocompiacimento camuffa tra le righe l’insicurezza d’una firma non ancora all’altezza di più illustri colleghi, dove il narcisismo è solo una facciata. Ne esce una filmografia perennemente oggetto di critica, incerta tra il prodotto di cassetta (non privo di sguaiati toscanismi, o gag tipo il dialogo tra sordi, ribadite sino allo sfinimento) e il vezzo autoriale, intriso d’intimismo quando non bizzarro romanticismo, nei quali la veracità delle radici s’insinua nell’“amarcord” sessantottesco o nel ripensamento generazionale. E gli abbozzi d’un tempo evolvono nell’imborghesimento. Produzione inclassificabile, nel senso etimologico del termine, quanto l’esigenza di rifare Pinocchio “ex novo” girandolo in un’America avulsa dall’abituale connotazione (memore delle “location” di precedenti lavori, ad esempio la Genova notturna, piovosa ed onirica di “Stregati”) su atmosfere ondeggianti tra Leone, Welles e Wenders. L’esigenza si sposa all’insistenza di esportare il prodotto fuori dai confini nazionali: e pensare che Francesco, dopo aver compiuto un primo viaggio negli Stati Uniti in cerca dell’ispirazione per “Caruso Pascoski”, aveva dichiarato di non interessarsi minimamente al mercato né al cinema americano, in prima persona constatandone la differenza da quello italiano. Nel caso in oggetto, non si tratta più nemmeno di commedia d’emigrazione verso Casablanca o Tunisi, altrove degna d’un Sordi: l’autenticità si disperde in un mega-sogno cinefilo, pingue e costosissimo, la cui titanica impresa s’inerpica in uno sbagliato collage irto di rimasticature mal integrate da sprazzi di originalità o d’inventiva nella reinterpretazione, palesando il trucco. Scrive Tullio Kezich:
“(…) è stato come girare ‘Le veglie di Neri’ fra i grattacieli, gli inseguimenti di macchine e i cazzottaggi nei saloon. A seguito di tale passo più lungo della gamba sono nate complicazioni di ogni genere: ritardi, sospensioni, accuse. Con il risultato che, a vederlo finalmente completato sia pure con qualche enigmatico rabbercio (…), si rimpiange che il film non sia più ‘povero ma bello’.”[3]

Nondimeno, persino dietro l’eccesso di presunzione si colgono i segnali d’un disagio e un’angoscia per una maschera superata dai tempi, non più in linea con la “naïveté” degli esordi e virante verso una dimensione cinematografica d’ingestibile megalomania, inaugurata dalle incomprensioni tra compagni sul set di “Ad ovest di Paperino”, che sceglie di lasciarsi alle spalle la risata non volendo – o non riuscendo – adempiere al compito (“Pinocchio non c’è più…”, ripete ossessivo il personaggio di fronte a un caminetto nella magione dell’odioso padre). Né è un caso che anche qui la riproposta di Geppetto, restituita nel proprio rovescio, sia il ritratto d’una creatura conforme con l’immagine e l’opulenza di un’epoca avvenirista e, a dispetto del protagonista, menzognera; che ritrovato il figlio, della cui esistenza non ha mai saputo, cerca di adeguarlo al “milieu” capitalista cinico e spietato, e non riuscendovi, senza neppure sforzarsi di comprenderne il candore, se ne sbarazza. Tardiva riproposta di molto cinema americano, Pinocchio/Leonardo è un disadattato che in un Lucignolo al femminile, marchiato come fuorilegge e in perenne fuga, individua il paradossale corrispettivo; sul piano del registro ilare-lunare, l’operazione potrebbe rinviare a Tati la cui sagoma d’innocente emarginato incappa in una roboante, incomprensibile megalopoli (vedi caso, “Playtime – Tempo di divertimento”, il progetto più ambizioso dell’autore, analogamente non fu compreso dal pubblico che ne decretò il declino).

Col senno di poi, già l’opera per cui Cecco fu salutato come nascente cineasta, il succitato “Stregati”, accolto da critiche sorprendentemente positive ma da tiepidi incassi, è quello in cui l’egotismo del Nostro meglio si esplica. La magica creatura venuta dal nulla è una figura del Fato, un po’ filosofo e un po’ pazzo, al timone d’una stazione radio notturna, il cui stralunato atteggiamento d’impenitente dongiovanni induce occasionali conquiste alla propria irreale sfera come un’ultima carta da giocare, o adesso o mai più. Una patinata bolla di sapone, di fatato “charme” come il suo autore, testimonianza del decennio in cui realizzato: ma, appunto, una fantasia destinata a svanire senza lasciare indelebile traccia. La bugia rivela quell’affettazione della favola che “OcchioPinocchio” ulteriormente tradisce; il sogno si trasforma in un incubo d’immani proporzioni, che fa sfumare anche un’ipotetica rilettura di “Mary Poppins”. Lontana è l’epoca di osare l’inosabile battendo un campione di stecca e acquisirne l’eredità, consegnando al mito l’“ottavina a nove sponde” e riuscire dove altri non possono, a mo’ di miraggio, trovandosi “vis–à–vis” con lo stambecco bianco albino, simboleggiante quel pizzico di lindo ottimismo contro il sudiciume. E il progetto de “I casellanti”, pensato per l’amico e modello ispiratore Benigni, resta una fiabesca utopia sulla carta: un isolato casello toscano resistito al conflitto, in cui gli abitanti continuano a inebriarsi di felicità, è gestito da due fratelli, uno dei quali – il personaggio di Francesco – sordomuto dalla nascita, mentre l’altro s’infatua d’una donna enigmatica che decide di seguire. Torna anche l’amato biliardo. Neanche a farlo apposta, il paradigma di “OcchioPinocchio” sopravanza il lenocinio come una preveggenza, mostrando un Prima, un Dopo, un Durante fattisi parabola circolare (ed esistenziale) in cui l’innocente spaesamento acquista graduale ed evoluta consapevolezza, e si conclude con una sospensione senza epilogo, mentre l’originario corpo muore e la mente, valicando il guado, consegue la maturità (il fotogramma del protagonista che, insieme alla nuova compagna, s’incammina verso il cielo lungo un gigantesco naso di legno). Altresì, tornando a canovacci ormai logori, le ultime regie ostentano un Nuti raggrinzito, consumato da egocentrismi, frustrazioni, rancori, suonando piatti tentativi di critica sociale, e i cui “excipit” sono ulteriori sbiaditi ricordi d’un percorso artistico a ritroso. E decisamente poco convincente è la prova d’attore fornita per “Concorso di colpa”, mediocrissimo poliziesco di Claudio Fragasso incentrato su un delitto anni Settanta a ridosso del sequestro Moro, che mette in luce evidenti limiti interpretativi nonostante la presenza del vecchio sodale Benvenuti. Pressoché ignorato alla sua uscita, e forse l’ultimo riuscito lavoro di Cecco, “Io amo Andrea” rappresenta un percorso anomalo: il conflitto tra ruoli, già trattato in una filmografia dove il sessismo è ulteriore componente dell’autore (e non esattamente in senso positivo), è affrontato con un cimento che sembra voler prendere le distanze dalla comicità che fu, lasciandosela alle spalle quasi totalmente, per misurarsi con un discorso su usi e costumi, mentalità e affetti a confronto d’un assetto inopinatamente mutato. Esperimento in linea con una dimensione di maggior intimismo, volto ad azzardare l’aggiornamento di un modello contro le aspettative d’un pubblico altrettanto cambiato; un’alternativa al toscanismo offerto da neonati modelli paratelevisivi, meno vernacolari e più scopertamente edificanti, da Panariello a Pieraccioni, che da sempre elegge Nuti a dichiarato ipertesto per il personaggio di eterno Peter Pan (sua l’espressione “comico bianco” per l’amico-collega), fatta eccezione per il nichilismo ruspante e anarcoide di Ceccherini.
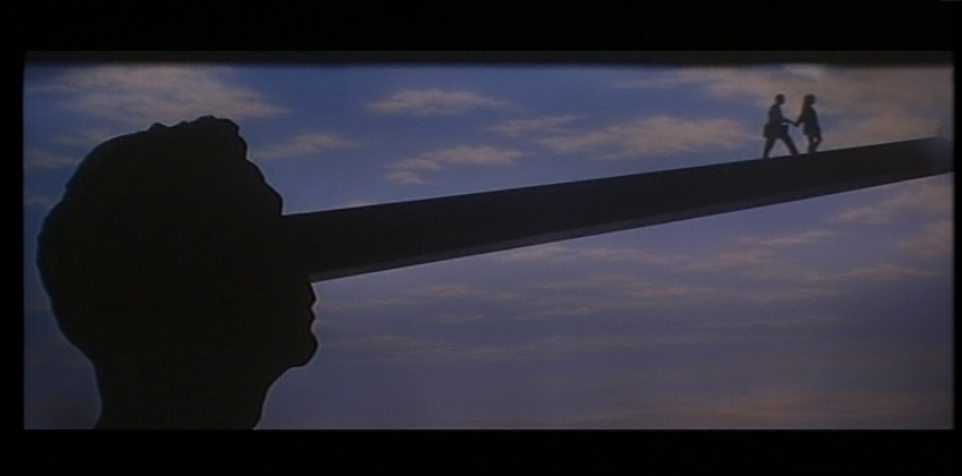
Il decennio Ottanta fa di Francesco un asso pigliatutto, miniera d’incassi per una produzione che, come nella stragrande parte dei casi, lo induce a bissare la medesima formula, sia pure per prodotti assolutamente atipici. Poi l’oblio, seguito da una malinconia autodistruttiva spiegata da un’esistenza all’insegna della sfrenatezza, e da una prostrazione fatta di troppe bevute e sporadiche, imbarazzanti apparizioni (tristemente nota quella concessa a Radio 24), conclusa con un terribile incidente che ne compromette irrimediabilmente lo stato fisico. Il che indurrebbe a un tirar di somme rintracciabile, senza spingersi troppo oltre, nella lunga arringa di difesa con cui l’avvocato di “Donne con le gonne” riesamina l’esistenza, prima che il caso, del protagonista; come se in tale dissertazione, di nuovo la realtà eclissasse la fantasia, e in quella che rimane la sua maggiore vittoria al botteghino – oltreché l’ultima – un Nuti involontariamente oracolare scrivesse il proprio commiato: di un artista confuso, prigioniero della catena d’un trionfo incontrato quasi per caso, e conseguente vittima d’una certezza appartenente a un’epoca remota. Innegabile che lo sforzo della sperimentazione, valicando l’iniziale dimensione ma stando attento a non tradirla, risulti scottante o addirittura incomprensibile (e non è il primo, né l’unico caso). È evidente che non sia riuscito appieno nell’intento, a dispetto di chi non detenga quel pizzico di follia da non provarci neppure. Ma anche se il difetto non fosse nel manico quanto nel senso delle proporzioni, che avesse ragione Cecco, in uno dei tanti aforismi, ad affermare “meglio pazzo che essere un calendario”?

[1] Per la cronaca l’attore-regista avrebbe dovuto partecipare a un quarto progetto, “Qualcosa di biondo”, sostituito poi dal succitato Tognazzi, addetto al “casting”, che per il ruolo vinse un David di Donatello. Da segnalare inoltre la curiosa partecipazione di quest’ultimo, in analoghe parti di sprovveduto terzo incomodo, per “Son contento” e “Caruso Pascoski”.
[2] A rifletterci, un’umoristica “religiosità” risiede anche nei nomi del duo, Francesco e Chiara, così come la seconda, in senso terminologico, contrasta con la terza figura del titolo, lo Scuro.
[3] KEZICH, Tullio: Cento film 1994. Roma-Bari, Laterza, 1995. Pag. 138.
SAGGI
L’EVOLUZIONE DEL GANGSTER MOVIE DAGLI ANNI ’60 A SCORSESE
di Marino Demata
“Bonnie & Clyde”: Il film dello strappo
Il Gangster movie è uno di quei generi cinematografici che ha subito più rilevanti e radicali trasformazioni a partire dai tardi anni ‘60. Sarebbe sufficiente pronunciare due titoli per verificare la distanza siderale che intercorre tra il vecchio tradizionale film di gangster, tipo anni ’50, e il nuovo Gangster movie: “Bonnie & Clyde” (1967) e “Butch Cassidy” (1969). Con notevoli differenze, a vantaggio del primo titolo, questi due film sono stati in ogni caso capaci di scavare un solco mai più colmato col film di gangster della old Hollywood.
Solo un grande regista come Arthur Penn poteva concepire e imporre alla produzione un film così totalmente innovativo come “Bonnie & Clyde” (in italiano “Gangster story”), da diventare poi un’opera
che determina una virata decisiva nella intera storia del cinema e non soltanto del genere “gangster”.
Girando “Bonnie & Clyde”, Arthur Penn spazza via tutti gli stereotipi del vecchio Gangster movie americano. Il gangster, secondo le regole del cinema di Hollywood, non può apparire altro che un pericolo pubblico da catturare e da abbattere; è un elemento di disturbo e di eversione rispetto all’ordine costituito. E lo schema narrativo dei Gangster movies, dagli anni ’30 fino agli inizi degli anni ’60, mostra da un lato, nel gangster, l’evoluzione della malvagità in ferocia, e dall’altro, nelle forze dell’ordine o nell’eroe occasionale che surroga magari la debolezza della polizia, l’abnegazione e il sacrificio di chi ha scelto di lottare per ripristinare quei valori calpestati su cui si fonda la società. In quel periodo della storia del cinema, il vero protagonista è quest’ultimo e il film è in genere la storia dei sacrifici e delle capacità di lotta contro chi ha violato le leggi. Lo stesso modo di girare il film, la distribuzione delle luci e delle ombre, il tipo di inquadrature riservate al gangster e all’eroe, i primi piani, sono tutti elementi funzionali a creare, nei confronti del pubblico, un’atmosfera negativa nei confronti del malvivente e di solidarietà nei confronti di chi lo combatte. C’è la possibilità di una evidente lettura politica di tale procedimento, che ci porta a concludere che la costante accettazione di tali procedure narrative è funzionale alla accettazione di un ordine sociale di stampo conservatore, che va assolutamente salvaguardato. In questo contesto il gangster, beninteso, non è mai un rivoluzionario, ma un elemento comunque di disturbo dell’ordine su cui si fonda la società.

Di fronte a tali regole, Arthur Penn si sente in grado, forte della coraggiosa sceneggiatura di Robert Benton e David Newman, di girare un film innovativo in tutti i sensi. A partire dal titolo, che fa risaltare i nomi dei due gangster. Non è stato frequente in passato che film avessero per titolo nomi di gangster. Ricordo Scarface e pochi altri. Nel caso di Scarface, interpretato dal Paul Muni, il titolo serviva ad incutere timore e curiosità nel pubblico, perché tutti avrebbero voluto vedere le efferatezze di un malvivente tra i più sanguinari della storia, e poi la sua inevitabile fine. Per il film di Penn il caso è diverso. Lo spettatore, al termine del film, guarda i due nomi stampati suo cartellone e consente implicitamente con la scelta del titolo. Per questo motivo non siamo per niente d’accordo col titolo italiano, “Gangster story”. Perché quel titolo, tra l’altro estremamente generico, spazza via proprio uno degli elementi innovativi del film. Arthur Penn, con la scelta del titolo “Bonny & Clyde”, ha voluto rimarcare che il film è dedicato a questi due protagonisti realmente esistiti, intesi, al contrario di “Scarface”, come due personaggi che lo spettatore amerà fin dalle prime sequenze.

Inoltre, con “Bonnie & Clyde”, Penn ha realizzato un meraviglioso affresco che è innanzitutto una tenera storia d’amore tra un uomo e una donna che non possono fisicamente amarsi per l’impotenza di Clyde. Come afferma Tullio Kezich, nella sua ispirata e, come al solito, eccellente recensione, Il film ha creato fra i due “un rapporto schietto e profondo: tanto che, sotto un certo profilo, “Gangster story” è la più gentile storia d’amore comparsa da anni sugli schermi”.
È un amore che si nutre di una profonda complicità e che nasce fin dalla prima sequenza del film. Lo spettatore, dopo aver visto scorrere i titoli di apertura su un primissimo piano delle labbra sensuali di Bonnie/Faye Dunaway, assiste al primo incontro tra i due futuri gangster. Bonnie, uscita da un negozio, vede da uno specchietto un uomo vicino alla propria auto e gli dice “Ehi, giovane, cosa stai facendo con l’auto di mia mamma?”. In quel momento gli sguardi si incrociano e si collegano per non scollegarsi mai più, fino alla fine del film e della storia. E in quel momento avviene anche l’immediato collegamento empatetico con lo spettatore, che sarà anch’esso costante (o meglio in costante crescita) fino alla fine del film. Questo significa che fin dalle prime battute il regista ha voluto creare una corrente di simpatia e di affetto triangolare, tra Bonnie, Clyde e lo spettatore. Eppure, i due protagonisti, poche sequenze dopo, inizieranno una lunga serie di azioni contro la legge. Per dirla in breve, Penn è stato dunque in grado di costruire una storia, fedelissima ai fatti realmente accaduti, nella quale due gangster, per la prima volta nella storia del cinema, ricevono l’incondizionata simpatia dello spettatore.
Quest’ultimo consente pienamente pure con gli aspetti di divismo negli atteggiamenti dei due protagonisti: ci riferiamo alla soddisfazione di Bonnie e Clyde quando vedono le loro foto sui giornali, o quando notano che la stampa li segue con morbosa attenzione. Fino al punto che i due protagonisti finiscono per inviare direttamente loro le foto e altro materiale alla stampa. Ad un certo punto dello svolgimento del film appare chiaro che il pubblico è stato completamente affascinato e rapito dalla storia e dalle gesta dei due gangster.
Perché quest’amore a prima vista, e poi sempre crescente da parte del pubblico? Non basta la bravura registica di Arthur Penn a spiegare tutto: non bastano gli studiati movimenti della macchina da presa, gli efficaci shot-reverse, i primi piani, sguardo nello sguardo, e il mantenere un punto di vista della narrazione sempre dalla parte dei due protagonisti. Certo c’è anche tutto questo. Ma non si può prescindere da due ordini di considerazioni di carattere sociopolitico, per così dire:
1- La storia di Bonnie e Clyde (e quindi il film) si svolge in un lasso di tempo di due anni, dal 1932 al 1934, un periodo buio della storia americana, da un punto di vista sociale. È il periodo della grande depressione, che nel cinema era stato fatto rivivere in “Furore” di John Ford, tratto dall’omonimo grande romanzo di John Steinbeck. E l’America descritta da Penn è simile a quella di Ford: un’America poverissima e sottoproletaria, dove la diffusa miseria stride con la ricchezza delle classi al potere. In questo contesto, i crimini di Bonnie e Clyde, che prevalentemente sono rapine in banche sparse nei vari Stati degli Usa, vengono visti dalla popolazione poverissima dell’epoca come una giusta punizione verso i ricchi. Le banche in particolare sono molto odiate, perché non concedono prestiti a chi non offre sufficienti garanzie e tolgono la casa a chi non paga una sola rata di mutuo: nell’immaginario collettivo della povera gente sono il vero nemico. In una delle prime sequenze ”Bonnie & Clyde” si riposano in una casa apparentemente abbandonata, dove si imbattono in un uomo anziano. Poco distate c’è una vecchia auto con una donna e due bambini. L’auto è piena di vecchie masserizie, qualche materasso, altri oggetti ammassati che testimoniamo l’estrema povertà di quelle persone. L’uomo spiega: “una volta questa era la mia proprietà.

Adesso non più. Se l’è presa la banca. Ci hanno sfrattati. Ora appartiene a loro” E indica un cartello proprio davanti all’edificio: “Property of Midlothian Citizens Bank”. La macchina da presa passa dal primo piano del cartello all’espressione un po’ sbigottita di Clyde e poi a Bonny che, con aria di sincera indignazione afferma: “Che vergogna!” Aggiungiamo che nel corso delle loro frequenti ruberie, i due gangster molto raramente colpiscono persone indigenti. Insomma, nel film non si scorge nessuna esplicita riprovazione per i crimini dei due gangster da parte delle popolazioni povere. E nessuno pare abbia mai smentito questa versione di Penn e nessuno l’ha mai accusata di essere immaginaria. I due gangster venivano visti, in quell’epoca buia di miseria e di sopraffazione, come due eroi, impegnati essenzialmente contro le sopraffazioni delle banche.
2 – Penn gira il suo film in un momento particolare della storia americana. Il 1967, quando esce il film, è l’anno delle grandi manifestazioni contro la guerra del Vietnam e, in genere, contro la politica Usa. A marzo del 1967 ha luogo un oceanico raduno delle forze della “contro-cultura”. Il 21 ottobre, cioè poche settimane dopo l’uscita del film nelle sale, mentre i veterani della guerra marciano verso la Casa Bianca, 50.000 giovani si ammassano al Lincoln Memorial, fino ad arrivare a circondare il Pentagono. Facile e logico, per chi ha visto il film, il collegamento con i due gangster che vogliono guadagnarsi la loro libertà attaccando il cuore del potere: le banche.
Penn stesso è ben lungi dal prendere le distanze da questa interpretazione del film e dal messaggio di cui era portatore e sostiene invece esplicitamente l’attualità del film per il momento storico nel quale esso è stato girato ed è uscito nelle sale. Il regista racconta orgogliosamente alla più importante rivista francese di cinema, “Les cahiers du Cinema”, che cinque uomini di colore, durante la proiezione del trailer di “Bonnie and Clyde”, si identificarono a tal punto con i due personaggi, che affermarono: “ecco, così bisogna fare…In questo modo”. Tra l’altro, lo stesso Penn era certo che si fosse alla vigilia di una rivoluzione che probabilmente sarebbe partita dall’America di colore. E uno dei più grandi critici cinematografici americani, Roger Ebert, nella sua consueta recensione sul “Chicago Sun-Times”, solo poche ore dopo l’uscita del film nelle sale, lo definì “una pietra miliare nella storia del cinema americano, un’opera intensa e brillante”. E aggiunse, sull’attualità del film, “il fatto che la storia si svolga 35 anni fa non significa niente. Doveva pur avere una collocazione temporale. Ma è stata girata ora e parla di noi.”
Infatti, lungo tutto l’arco del film, la storia dei due gangster appare come la storia di due persone alla ricerca della propria libertà e felicità, contro un ordine sociale che tendenzialmente nega, a gran parte della popolazione, entrambi gli obiettivi. Noi comprendiamo bene allora che, nelle intenzioni del regista, la corrente di simpatia che si crea fin dall’inizio del film, tra lo spettatore e i due protagonisti, è finalizzata non a creare direttamente una incondizionata ammirazione verso chi delinque, ma a rendere sempre più intollerante proprio quell’ordine sociale contro il quale tanta parte della società scende in piazza o comunque protesta o almeno dissente.
E la morte violentemente tragica di Bonnie e Clyde, alla quale, nella sceneggiatura di Robert Benton e David Newman si allude soltanto, viene mostrata da Penn in tutta la sua spietata crudeltà. Robert Kolker, nel suo bellissimo saggio “A cinema of loneliness”/”Un cinema di solitudine”, rassegna di autori innovativi negli anni ’60 e ’70, nel capitolo dedicato ad Arthur Penn, si sofferma proprio sulla scena dell’uccisione dei due gangster e sugli effetti che essa determina nello spettatore. La simpatia e l’affetto che, lungo tutto l’arco del film, è cresciuta verso i due protagonisti da parte del pubblico in sala, spinge quest’ultimo a desiderare la loro sopravvivenza. Quando invece Penn, modificando la sceneggiatura, offre al pubblico, attraverso la sequenza dell’imboscata e dell’uccisione dei due gangster in slow-motion, una immagine di grande sofferenza, lo spettatore si sente lasciato solo. Quei due personaggi che ha amato fin dalla prima sequenza sono stati annientati. Il sogno di libertà e felicità – perché tale appariva allo spettatore – si è infranto.
Ma c’è da dire che l’operazione filmica messa in essere da Penn, con la violenta sequenza finale, in contrasto con l’originaria sceneggiatura, non rappresenta, secondo Robert Kolker una sorta di nemesi alla quale lo spettatore sarebbe sottoposto nel finale a dispetto della forte simpatia verso i due protagonisti. Al contrario le atrocità dell’agguato e della morte hanno la funzione di “rafforzare la mitica dimensione dei due personaggi”, e, rafforzandone la dimensione, ne confermano la simpatia, a cui si aggiunge il rimpianto per la loro fine.
D’altra parte, non c’è alcun dubbio che mettere lo spettatore di fronte ai particolari di una fine violenta e tragica è un ulteriore elemento innovativo nella storia del cinema, ed è il risultato di alcune svolte “reali” nella storia americana di quegli anni. Ci riferiamo naturalmente all’assassino di Kennedy (a cui Penn continuamente allude in questo e in altri suoi film) e alla guerra del Vietnam. Cioè i due traumi degli anni ’60, che hanno reso “la cultura particolarmente attenta ai dettagli della sofferenza fisica, e hanno inserito tali dettagli in un contesto profondamente emozionale, per non dire politico.” (1)
Su “Bonnie & Clyde”, come si diceva, Arthur Penn ha avuto il totale controllo, al punto da essere libero di modificare totalmente il finale, rispetto a quanto concordato in precedenza con gli sceneggiatori. La sua capacità innovativa è stata libera di esprimersi nel modo più ampio possibile. Al contrario c’è un film anteriore, girato nella maniera classica, nel quale Penn non ha potuto muoversi con la medesima libertà. Eppure, anche in quel caso, sono già evidenti i segnali di innovazione, sia pure ancora in gran parte inespressi. Ci riferiamo al film del 1966, “La caccia”, con un cast stellare formato da Marlon Brando, Robert Redford e Jane Fonda.
il film rappresenta indubbiamente uno dei peggiori film usciti dalla macchina da presa di Arthur Penn, nettamente inferiore anche al suo film precedente, “Mickey one”, con Warren Beatty. Eppure, la storia piaceva a Penn: in una cittadina del Texas negli anni ’60. Calder (Marlon Brando) è stato imposto come sceriffo dal magnate della città, Val Rogers (E.G. Marshall), per tenere a freno le intemperanze di una gioventù prevalentemente rissosa e festaiola. Calder non è felicissimo dell’incarico, ma lo assolve con equilibrio, avendo come parametro il rispetto della legge. Tra le molte sotto storie che il film ci mostra, una delle più significative è quella di Anna (Jane Fonda), il cui sposo Bubber Reeves (Robert Redford) è in prigione da due anni con accuse abbastanza discutibili.
Nel corso di uno dei fine settimana movimentati da alcol e donne, arriva la notizia che Bubber è evaso assieme ad un altro carcerato. La città entra in fibrillazione soprattutto alla notizia che i due evasi hanno ucciso un uomo per rubargli l’auto. In realtà, anche in questo caso lo sfortunato Bubber non c’entra con la morte dell’uomo, ma i chiassosi cittadini del sabato sera hanno già emesso il proprio verdetto; il colpevole è Bubber. Inizia così la caccia all’uomo, che, malgrado la ferma opposizione dello sceriffo (Brando), che viene anche picchiato dalla folla, viene ammazzato.
Sembra chiaro che Arthur Penn ha puntato molto su questo personaggio: le colpe che sono valse la galera a Bubber non sono ben chiare dallo sviluppo del film. Ma una cosa è certa: quasi anticipando “Bonnie e Clyde”, Penn crea un antieroe e si mette dalla sua parte. Assieme al pubblico. E, guarda caso, proprio l’evaso, il fuggitivo, risulta essere, assieme a quello di Marlon Brando, il personaggio più simpatico e amato dal pubblico. Noi non possiamo non vederlo come una sorta di anticipazione del personaggio di Clyde del film successivo. Con Bubber, dunque, Penn ha iniziato a costruire, da un personaggio che viene da un’altra storia e con altre caratteristiche, la figura del gangster amato dagli spettatori, che ritroviamo in “Bonnie e Clyde”.

“Butch Cassidy”
George Roy Hill realizza il suo “Butch Cassidy” due anni dopo l’arrivo nelle sale di “Bonnie & Clyde” e certamente gli elogi incondizionati della critica più seria e avveduta al carattere innovativo del film di Penn gli saranno interamente pervenuti. Io non so, in verità se, senza “Bonnie & Clyde”, ci sarebbe stato ugualmente “Butch Cassidy”. Certamente, per il discorso che stiamo portando avanti in queste pagine, ci interessa soprattutto rilevare che col suo film, Roy Hill ha dato in ogni caso un ulteriore colpo al vecchio schema del Gangster movie.
A partire proprio dal titolo, che, per intero, suona “Butch Cassidy and Sundance Kid”, che, proprio come per il film di Penn di due anni prima, celebra, in questo modo così visivamente palese, ancora una volta i due gangster protagonisti. Anche questi diventano immediatamente i nuovi beniamini dello spettatore, che ammira le loro gesta contro la legge, e tifa decisamente per loro, per la riuscita dei loro colpi, per la loro capacità di fuggire in tempo in barba a tutti i piani messi in essere dalle autorità, prima americane e poi boliviane, per la loro cattura.
Il film ha una vocazione umoristica perfino sfrontata, merito anche dei due protagonisti, tra i quali giganteggia da leader Paul Newman sul giovane e meno affermato Robert Redford. In ogni caso si tratta, agli occhi del pubblico, di un gioco di coppia, proprio come quello tra Bonnie e Clyde. Stavolta si tratta di due uomini uniti, fino alla bella scena finale, da un senso pieno di lealtà e soprattutto di solidarietà. Anche questa nuova coppia di gangster è specializzata nella rapina in banca e, solo occasionalmente, nell’assalto ai treni. Lo Stato nel quale operano è il Wyoming, fino alla successiva e avventurosa fuga in Bolivia, dove dapprima lavoreranno, per poi riprendere il discorso interrotto con la vita da banditi.
Come coppia di gangster non vengono descritti nel film in maniera perfetta: commettono, soprattutto nel periodo americano, molti errori e sono anche approssimati nei loro piani e calcoli. Questi difetti, naturalmente, sono ben spesi e utilizzati dal regista, per accentuare gli aspetti di imprevedibilità e di comicità, che rendono il film progressivamente più piacevole e i due protagonisti, proprio in virtù delle loro debolezze e improvvisazioni, sempre più simpatici e amati.
E c’è anche da aggiungere che una scena come quella di Paul Newman che scorrazza in bicicletta al ritmo di “Rainddrops keep falling on my head” non avrebbe mai potuto esistere in un film gangster, o gangster western, che si voglia, di qualche anno prima. I tempi sono veramente cambiati!
Questo film rappresenta, dunque, un altro duro colpo alla concezione del Gangster movie classico, che forse sopravvive ancora – ma solo in parte – in qualche film classicheggiante come “Il mucchio selvaggio” (1969) di Sam Peckinpah, che, probabilmente un po’ fuori tempo massimo, ci fa rivivere, col suo capolavoro “tosto”, gli schemi e le gesta dei gangster anteguerra, in un canovaccio tipico del western classico. Eppure, anche questo grande film, così misuratamente “classico”, ci presenta dei segnali che ci indicano la fine di un’epoca. C’è una diffusa aura di malinconia che si sprigiona dai personaggi del film, e c’è come la constatazione un po’ mesta che tutti loro sono fuori tempo e fuori luogo. Si prenda la scena in cui i protagonisti vedono le auto (il film si svolge all’alba della Prima guerra mondiale). Per alcuni di loro è la prima volta che vedono un’auto. Uno di loro dice, con tono mesto, direi rassegnato: “d’ora in poi le guerre si faranno con le auto.” Dove c’è la malinconica consapevolezza che le cose stanno veramente cambiando. Si dirà: ma i personaggi dicono queste cose nel 1913. Ma questo veramente non significa niente! L’azione del film è del 1913. Ma il regista sta parlando a noi, attraverso il film, nel 1969. E questa è la cosa importante e reale. La sua sensibilità, che ci vuole trasmettere, è rivolta alle donne e agli uomini del suo tempo, del 1969. Qualcosa sta cambiando. E come…
Il colpo di grazia: “Gloria” di John Cassavetes
Nel 1980 toccherà ad uno dei grandi ribelli del cinema, uno dei fondatori del New American Cinema, John Cassavetes, dare il colpo di grazia alle vecchie concezioni e regole del Gangster movie. La cosa che può apparire più strana è che tale colpo di grazia viene sferrato proprio nel contesto di un film, “Gloria”, che, su un piano strettamente formale e sulle modalità utilizzate nel girarlo, sembrerebbe il meno “rivoluzionario” dei film di Cassavetes.

“Gloria” appare subito curatissimo rispetto ai film precedenti: non si avverte l’improvvisazione che caratterizza l’intero arco dell’opera del regista e il lasciar fare agli attori appare assai mitigato dalle esigenze di un controllo del proprio lavoro che addirittura diventa meticoloso e non piu’ cosi artigianale come in passato. Si aggiunga a questo che Cassavetes ha voluto, in questa occasione, circondarsi di collaboratori di alta professionalità per ciò che riguarda la colonna sonora (Bill Conti) e la fotografia (Fred Schuler), per confezionare un prodotto perfetto nelle sue intenzioni e negli stessi risultati.
Eppure, le cose non stanno proprio così: quei risultati alla “cinema-contro”, che nei precedenti film Cassavetes aveva raggiunto anche attraverso l’improvvisazione e la prevalenza del lavoro degli attori, qui li raggiunge preparandoli invece minuziosamente attraverso una sceneggiatura accurata ed una preparazione tutta professionalizzata. Ma, in buona sostanza, “Gloria” finisce con essere il più anti-hollywoodiano di tutti i film di Cassavetes. Perché? Semplice: se solo leggiamo la trama, ci rendiamo conto che il regista mette addirittura alla berlina le convenzioni hollywoodiane, procedendo allo scardinamento di ogni vecchia regola del Gangster movie, proseguendo l’opera già intrapresa da tempo, di destrutturazione dei generi tradizionali sui quali si fondava il cinema tradizionale: “Jack Dawn è un mafioso che non ha saputo tacere. Prima che gli arrivino in casa i killer consegna il piccolo Phil e un quaderno-memoriale alla vicina di casa, Gloria. Il rapporto tra la non più giovane Gloria e il giovanissimo Phil, rimasto ormai senza famiglia, è piuttosto difficile. Senza contare che la mafia vorrebbe mettere le mani sul quaderno lasciato da Jack. Per difendere il ragazzo, Gloria diventa un’abile pistolera e, alla fine, riesce a rifugiarsi a casa di Tony, un boss di cui era stata amante. Ma proprio lì trova ad aspettarla lo stato maggiore del clan mafioso…”
Questa volta dunque lo spirito moderno e innovativo di Cassavetes si esercita sul genere noir-gangster, come è toccato in precedenza con altri generi. Ma il mutamento questa volta è così radicale, che “Gloria” può essere visto – senza esserlo in realtà – come una sorta di parodia del vecchio Gangster movie, nel quale il regista non esita a sbeffeggiare tutti i sacri ingredienti del cinema tradizionale di genere.
E così, al posto di Humphrey Bogart, col suo impermeabile stretto in vita, troviamo addirittura una donna, la scattante e vitalissima Gena Rowlands, nella parte della protagonista. E, a completare la coppia di protagonisti, ci sarà addirittura un bambino di soli sei anni, Phil. E’ lui il maschio, l’uomo che si cala nei panni del partner di Gloria. Certo, in altri tempi, un progetto del genere avrebbe fatto inorridire qualsiasi produttore della cosiddetta “mecca del cinema” e un film, con tali premesse non si sarebbe mai realizzato, perché una tale coppia di protagonisti sarebbe apparsa irriverente verso il pubblico e verso il cinema tradizionale.
Lo stesso ritmo forsennato del film rappresenta un elemento di novità: ll Gangster movie tradizionale aveva momenti di accentuato movimento, ma aveva anche lunghe pause nella narrazione. In “Gloria”, invece, il ritmo è senza pause nè soste: il racconto è una continua fuga da qualcuno e da qualcosa e in particolare dai gangster che vorrebbero mettere le mani sulla documentazione in possesso di Phil e Gloria, costringendo i due protagonisti ad una perpetua corsa in avanti.
Gli avvenimenti ed il loro ritmo incalzano ed essi sono tutti consequenziali a quanto succede nelle scene iniziali del film, che poi costituiscono l’unico ‘fatto”, l’unico episodio del racconto, che non avra’ altre pieghe ed altre novita’ (altro elemento veramente dissacrante!), ma che costituisce la matrice di tutto lo sviluppo della storia stessa.
Cassavetes fa in modo che questa “strana coppia”, nata dall’incontro di due solitudini, giochi con la dialettica vita-morte lungo tutto l’arco del film, in una sottile reciproca linea di confine che sembra debba spezzarsi da un momento all’altro. Il teatro di questa dialettica è la città caotica, sporca, terreno di dominio dei gangster e della malavita, un sistema con regole ferree dalle quali non si può ‘sgarrare”, pena la persecuzione e la morte.
Il primo Scorsese
Il Gangster movie è uno dei generi più frequenti nella ampia filmografia di Martin Scorsese, che, da giovane, da grande consumatore delle poltrone delle sale cinematografiche, aveva senza dubbi seguita l’evoluzione del genere fin qui descritta, con la sola eccezione di “Gloria”, che esce nel 1980, 7 anni dopo il suo primo film-gangster, “Mean streets”. E, in ogni caso, abbiamo anche prove della amicizia e frequentazione, in quei primi anni ’70, con Cassavetes, che fu prodigo di consigli su come girare “Mean streets”.

I quattro Gangster movie di Scorsese, che passeremo in rapida rassegna, rappresentano, passo dopo passo, il graduale delinearsi di caratteristiche nuove del genere, per arrivare ad una concezione fortemente influenzata dai registi innovatori, primo fra tutti Arthur Penn, ma anche dalla sua straordinaria propensione al documentario. Si noterà infatti più di una differenza tra i film completamente di fiction del regista italo-americano, e i film che invece fanno riferimento a fatti e personaggi realmente esistiti. La realtà e la verità storica vengono trattate con grandissimo rispetto. Anche il più efferato dei gangster merita che si dica la verità su di lui, senza mitizzazioni, ma anche senza inutili esagerazioni che ne enfatizzino inutilmente la crudeltà e la efferatezza.
Il Gangster movie secondo Scorsese manifesta una continua ansia di verità e di realismo. A tal punto che non sono infrequenti i colloqui, o vere e proprie interviste, a gangster (o ex gangster) dei quali Scorsese porta sullo schermo storie, fatti e misfatti. Robert De Niro, per costruire, nel modo il più realistico possibile, il suo personaggio in “Casinò” di imprenditore e proprietario di sale da gioco, riuscì, su sollecitazione di Scorsese, ad incontrare in varie occasioni Frank Roshental, alla cui vita il film si è ispirato, e a discutere con lui.

Quello che emerge insomma è il rispetto, non per questa o quella figura di gangster, ma il rispetto della verità, per fare film realistici, che avessero il rigore del documentario. In sintesi, quello che vogliamo dimostrare attraverso l’esame dei quattro Gangster movie di Scorsese, è lo svilupparsi progressivo di un approccio essenzialmente documentaristico, come se il regista volesse dimostrare che, su questo terreno, non è necessario inventare nulla, perché la verità sta sempre più avanti della finzione. Purché la si sappia ben riconoscere.
Siamo nel 1973 e il giovanissimo Scorsese, valendosi di una sceneggiatura scritta a quattro mani con l’amico Marcio Martin, gira “Mean streets”, il suo primo Gangster movie, impegnando due attori che diventeranno tra le icone della sua filmografia: Harvey Keitel e Robert De Niro.
“Mean streets” è un film complesso e rappresenta un primo passo verso la concezione documentaristica del Gangster movie, i cui passi decisivi saranno i due film degli anni ’90, “Goodfellas” e “Casinò”. In “Mean streets” l’aspirazione documentaristica, più che focalizzarsi sui personaggi, i singoli gangster alle cui gesta il regista, da ragazzo, aveva in qualche modo assistito o delle quali aveva sentito parlare, si concentra invece sull’ambientazione: Little Italy, con le sue luci, le sue feste, le processioni e anche i piccoli gangster di quartiere. Little Italy è stato il quartiere dove è nato e cresciuto il giovane Martin, che è soprattutto interessato a rendergli omaggio attraverso il suo film. Che proprio per questo motivo è prevalentemente ed essenzialmente un film autobiografico. nel quale si rivelano le contraddizioni della personalità del regista, dai ricordi della sua infanzia a Little Italy, con l’ambiente pittoresco enfatizzato dalle giornate dei festeggiamenti per San Gennaro, alle sue ansie religiose entro le quali sono preponderanti i sensi di colpa e l’ossessione del peccato.
In tal senso è veramente significativo il modo col quale inizia il film. Assistiamo al risveglio concitato di Charlie (Harvey Keitel, alter ego del regista) sicuramente da un incubo. Una voce fuori campo (la voce è quella di Scorsese) ci manifesta quello che è uno dei concetti chiave del film: “Tu non fare penitenza per i tuoi peccati in chiesa, ma per la strada e a casa. Tutto il resto sono cazzate e tu lo sai.” Oggi può sembrare strana una tale ossessione per il peccato in un ragazzo che poi vedremo radicato nel mondo della mafia locale. Un grande critico cinematografico, forse il più grande negli Usa, Roger Ebert, storicizza questa sequenza: essa può oggi sembrare incomprensibile se non si rammenta che il film è stato girato prima del Concilio Vaticano II, che rappresentò, per il mondo cattolico, una svolta ridimensionatrice dell’ossessione per il peccato.

Ma, dopo essersi soffermato sul personaggio autobiografico di Charlie, Scorsese sembra invitare lo spettatore ad osservare, proprio attraverso gli occhi del suo personaggio, il composito mondo della malavita locale, di origine italiana. È qui che il film assume un carattere quasi documentaristico, che si mescola con l’autobiografismo rappresentato dal suo alter ego
Charlie, infatti, passati i temporanei tormenti domenicali, si rituffa nel mondo della malavita, dove ha una grande aspirazione: diventare proprietario di un ristorante, che possa gestire con capacità ed eleganza. Il boss locale, zio Giovanni, sarebbe disposto ad accontentare Charlie, ma lascia intendere che esistono due ostacoli: il suo rapporto con una ragazza epilettica e con Johnny Boy (Robert De Niro), a cui piace vivere con un piede all’interno della organizzazione malavitosa e con un piede fuori. A tal punto che sembra che a volte se ne prenda gioco: Michael, uno dei malviventi locali, non riesce in alcun modo ad ottenere da Johnny la restituzione dei soldi che gli deve e si rivolge a Charlie, sapendolo di lui amico. Ma Johnny prende tutto come un gioco e sembra non avere alcuna intenzione di mettere la testa a posto.
Nell’ambito di questo rapporto tra Charlie e Johnny, memorabile è la scena del loro incontro al bar Volpi. Johnny si presenta portando con sé due ragazze, braccia sulle loro spalle, a destra e a sinistra, e procede verso Charlie che sta seduto con aria di disapprovazione. Johnny appare allo spettatore al rallenty e
al suono di Jumpin’ Jack Flash dei Rolling Stones e l’intera scena è caratterizzata da una colorazione rosso acceso (il colore dell’Inferno?).
Il pubblico avrà una ulteriore idea del tipo di scapestrato rappresentato da Johnny, allorché lo vedrà fare esplodere una cassetta della posta. Per quale ragione? Ci si chiede. Nessuna ragione.
Con questo film Scorsese comincia a tratteggiare quel mondo della criminalità organizzata in senso piramidale, che approfondirà poi negli anni Novanta con “Quei bravi ragazzi” e con “Casinò” e, infine, recentemente, con “The Irishman”. Dunque, con “Mean streets” del 1973 siamo appena agli inizi. Eppure., già si intravedono alcuni elementi tipici che caratterizzano quel mondo: il rispetto delle gerarchie, l’obbedienza cieca alle regole, la realizzazione completa degli incarichi ricevuti senza possibilità di discuterli. Naturalmente, date le premesse, il distacco documentaristico è meno marcato, perché il regista si sente emotivamente coinvolto nella parte autobiografica della narrazione. Nondimeno resta inequivocabile la voglia di Scorsese di documentare il vero. Una tendenza che, in vario modo, gli proviene dalla multipla frequentazione di varie cinematografie, dal neorealismo, alla Nouvelle Vague, e dal nuovo cinema americano di Mekas e di Cassavetes.
Per poter girare questo film Scorsese ha avuto molte difficoltà di ordine finanziario. Roger Corman sembrava propenso ad un finanziamento, ma non se ne fece nulla, di fronte alla pretesa che i personaggi fossero afroamericani. Tra l’altro lo stesso Cassavetes gli sconsigliava fortemente di accettare qualsivoglia condizionamento esterno. E però, sempre le difficoltà finanziarie furono i presupposti per aspetti positivi del film, come la necessità di girare con camera in spalla, di utilizzare accorgimenti tecnici che aiuteranno il regista a crearsi il suo stile. E, come per i film di Cassavetes, specialmente quelli degli esordi, molto è stato lasciato da Scorsese alla improvvisazione degli attori.
Scorsese anni ’90: il decennio del documentario
Definiamo gli anni ’90 il decennio del documentario per Martin Scorsese per due ragioni essenziali. Innanzitutto, gira due nuovi Gangster movie nei quali viene accentuata la propensione per il documentario, preceduto da una accurata indagine sulla vita dei personaggi descritti e sugli ambienti e le regole dell’organizzazione malavitosa. In secondo luogo, a riprova della sua passione per il vero da trasporre cinematograficamente, fa uscire due meravigliosi documentari sul cinema americano e sul cinema italiano, che sono due autentici capolavori, solitamente poco ricordati quando si parla delle opere di Scorsese.
I due film sono “Goodfellas” (“Quei bravi ragazzi”) e “Casinò”. Il primo, del 1990 esce nelle sale a quasi vent’anni dal suo primo Gangster movie, “Mean streets”. La più importante novità è che “Goodfellas” è proprio una storia vera con personaggi realmente esistiti e pienamente riconoscibili dalle “gesta” narrate nel film.

Alcuni dei personaggi del film, che copre un arco di trent’anni, erano ancora viventi durante la lavorazione: una ghiotta occasione che Scorsese non si lascia sfuggire, per convincerli a conversare con lui e De Niro al fine di ristabilire alcune verità e addirittura ricevere consigli su come impostare la recitazione perché fosse più aderente possibile alla personalità dei personaggi reali.
Il personaggio principale del film è l’italo-irlandese Henry Hill, interpretato nel film da Ray Liotta. Attorno a lui ruotano le vicende di tutti gli altri personaggi. Si prenda ad esempio la prima parte del film: è come un “romanzo di formazione” del giovanissimo Henry, che, di fronte alle difficoltà sue e della propria famiglia, sceglie di voler diventare un gangster, proprio come quelli che vivono al marciapiede di fronte. “Per me, – dice agli spettatori la voce fuori campo di Henry/Ray Liotta, che si racconta – essere un gangster era meglio che essere il Presidente degli Stati Uniti.” E poi, una volta entrato nel “sistema” e, pur incaricato solo di piccoli lavoretti, Henry si sente importante: “Avevo il mio posto. Ero trattato come un grande. E ogni giorno rimediavo qualcosa.” E infine, il fatto più importante per lui: ” a tredici anni guadagnavo più soldi degli adulti del quartiere.”
Henry riuscirà a mettere insieme una fortuna straordinaria, grazie anche a felici intuizioni e ad alcuni “colpi” fortunati, come quello agli uffici della Air France, realizzato con la complicità dei suoi più stretti amici, Jimmy Conway (Robert De Niro) e Tommy DeVito (Joe Pesci). Ma, nel suo percorso, non mancheranno gravi scivoloni sia nei suoi “affari”, che lo porteranno ad un lungo soggiorno in carcere, sia anche nella vita privata, dove Henry diventerà presto insofferente della donna che si è scelta come moglie (Lorraine Bracco), preferendole un’altra donna.
Ma, proprio su questo episodio famigliare, si sofferma Scorsese, per cogliere l’occasione di sottolineare le ferree regole dettate dagli stati maggiori della malavita, che non gradisce grossi problemi di famiglia per i propri affiliati. Pertanto, a Henry viene consigliato di sistemare le cose in famiglia come se nulla fosse mai successo e soprattutto senza traumatiche separazioni
Dunque non si sfugge alle regole del sistema che in più occasioni richiama all’ordine i propri affiliati. E questo è uno dei punti sui quali Scorsese batte maggiormente in “Goodfellas”. Conoscere l’universo malavitoso vuol dire conoscere innanzitutto le sue regole.
Alcune ce le ricorda direttamente la voce fuori camp di Henry, allorché, raggiunto l’obiettivo di entrare a far parte del clan malavitoso, afferma “Per essere membri di un clan devi essere italiano al 100 per 100. Così possono risalire ai tuoi parenti, al paese…È il massimo onore che si può ricevere. Così fai parte di una famiglia, di un clan. Nessuno può fotterti e tu puoi fotterti chi vuoi”.
Altre norme, sempre tutte rigorosamente “non scritte” le ricorda Jimmy Conway (Robert De Niro), forse il più serio dei tre bravi ragazzi del film, per i quali è una sorta costante richiamo all’ordine e alle regole. Lo ritroviamo ad affermare “mai tradire gli amici e tenere sempre la bocca tappata”.
Le storie di gangster raccontate in questo film da Scorsese sono tratte dal romanzo di Nicholas Pileggi, che si presenta come una cronaca fedele e uno spaccato della vita e delle gesta di tre gangster seguiti nell’arco di quasi trenta anni, all’ombra di una gerarchia incarnata del personaggio di Paul Cicero, mirabilmente interpretato da Paul Sorvino. E una cronaca fedele come quella di Pileggi – che sarà poi co-sceneggiatore di “Casinò” – è l’ideale per Scorsese, che, come abbiamo visto, continua ad appassionarsi alle descrizioni documentaristiche, facendo di molti dei suoi film del “quasi-documentari”.
Con un tono tragico e grottesco ad un tempo, Scorsese riesce a padroneggiare l’intera materia, grazie anche alla ottima sceneggiatura scritta assieme a Pileggi, con consumata esperienza, realizzando così un film perfetto, dove è quasi impossibile trovare dei difetti, un film dove si condensano le sue precedenti esperienze cinematografiche e che rappresenta la summa mai raggiunta dal genere “Gangster movie”.
Nel 1995 Scorsese, da una sceneggiatura scritta a quattro mani con lo stesso Pileggi, gira “Casinò”, ove l’ambientazione presso le gigantesche sale da gioco di Las Vegas offre l’occasione al regista di entrare nell’ambito del faraonico, del gigantesco, in una parola del volutamente esagerato.
Ma questo film ha una particolarità non trascurabile. Il romanzo di Pileggi, “Casinò”, non era ancora finito, quando il film fu iniziato a girare. Il romanzo cresceva di pari passo col film, e quest’ultimo si giovava dell’improvvisazione e della presenza di situazioni che avevano la necessità di essere verificate e approfondite. E poiché anche questo film si basava su avvenimenti e personaggi reali, molti dei quali ancora in vita (il film è ambientato negli anni ’70), non fu difficile a Scorsese e Pileggi parlare direttamente con alcuni gangster. Dal canto suo, Robert De Niro riuscì ad avere degli incontri col personaggio reale dal quale era ispirato il suo ruolo, Sam “Asso” Rothsein, vale a dire – nella vita reale – l’imprenditore e proprietario di casinò Frank Rosenthal, che, inizialmente riluttante, accettò poi di buon grado di incontrare più volte l’attore.
Viene fuori un film brillante, calato nella realtà sfavillante di Las Vegas e le sue case da gioco: una realtà descritta il più possibile proprio come esistita negli anni ’70. Non solo Rosanthal, ma anche altri personaggi dell’epoca, e dello stesso mondo del crimine, alla fine collaborarono col regista e con gli attori per rendere il più possibile veritiere le interpretazioni e le situazioni, secondo le intenzioni e le direttive di Scorsese.
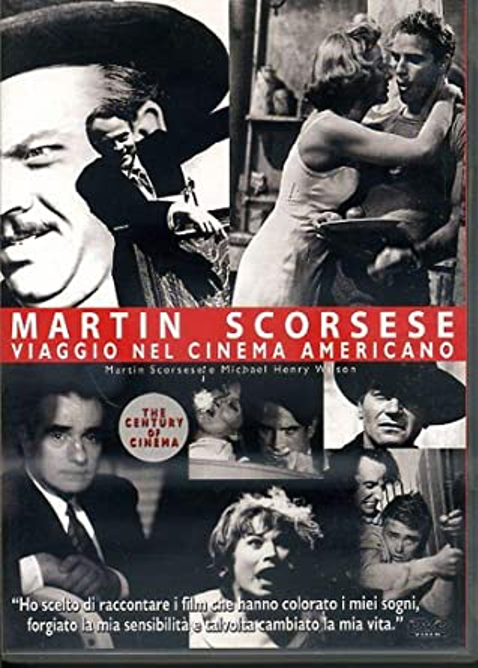
A dimostrare ulteriormente la vera e propria passione di Scorsese per il documentario, prendono corpo proprio negli anni ’90 di “Goodfellas” e “Casinò” i due grandi documentari sul cinema. “Un secolo di cinema – Viaggio nel cinema americano” è un affresco di quattro ore sul meglio del cinema americano secondo Scorsese, dagli albori, fino ai suoi giorni, attraverso filmati e testimonianze dei grandi registi USA, alcuni dei quali di prima mano (Coppola, De Palma, Arthur Penn, Clint Eastwood, ecc,) altri, purtroppo scomparsi, attraverso immagini di repertorio (Cassavetes, Orson Welles, Billy Wilder, e tanti altri). Oltre alle interviste, nel film possiamo ammirare la scelta dei filmati tratti dai film più amati dal regista.
Da sottolineare la grande attenzione che Scorsese pone nel citare e descrivere i Gangster movie, dal citato “Scarface”, a “Le forze del male”, da “Le vie della città”, che insieme ad altri rappresentano il Gangster movie classico degli anni ’30 e ’40, fino ai recenti “Il Padrino” e “Senza un attimo di tregua” di John Boorman.
Il documentario successivo, “Il mio viaggio in Italia”, è sicuramente di grande interesse non solo per le puntuali considerazioni del regista sul cinema italiano, ma anche da un punto di vista autobiografico: Scorsese infatti ci segnala quanto sia stato importante, per la sua formazione, vedere, da bambino e poi da ragazzo, importanti titoli del nostro cinema. Anche in questo caso si tratta di una carrellata ricchissima di considerazioni e spunti straordinari, che confermano la passione e l’attitudine del regista verso la forma filmica del documentario.
In quattro ore vengono passati in rassegna i più significativi registi e film del nostro Paese. E, per soffermarci solo sul cinema del dopoguerra, esaminato dopo una lunga disanima del cinema anteriore, ci sembra ancora significativo il lungo excursus sul più documentaristico dei film del neorealismo, “Paisà” di Rossellini. Di “Paisà” infatti sceglie due episodi, quello dell’arrivo degli alleati in Sicilia e quello su Napoli. Sul primo episodio Scorsese non può fare a meno di ricordare l’emozione dei propri nonni e genitori vedendo in TV quella parte di film girato nelle loro terre di origine. Ma questi ricordi si intrecciano alle prime importanti considerazioni sia sul valore artistico-cinematografico dell’episodio, sia sulla portata storico-epica della Resistenza e in particolare del sacrificio di una ragazza siciliana per salvare la vita di altre persone in lotta per la libertà. “Nessuno si rende conto come e perché’ è morta quella ragazza. Ma noi lo sappiamo”. Grazie a “Paisà!” E sul toccante episodio girato a Napoli Scorsese si lascia andare ad una considerazione personalissima: se la mia famiglia non fosse emigrata in America, io sarei potuto essere uno di quei bambini che si vedono nel film, abbrutiti dalla guerra e impossibilitati a fare altro che rubare ai militari americani.
Dove il discorso di Scorsese diventa meno personale e più attento a fornire importanti riferimenti e considerazioni critiche è nella parte denominata “Da Rossellini ad Antonioni”. Scorsese si sofferma su “Viaggio in Italia” di Rossellini, con Ingrid Bergman e George Sanders e, attraverso una ricca selezione di immagini, ne fa una analisi precisa ed una critica cinematografica preziosa, che lascia in ogni caso trapelare il suo grande amore e traporto per questo film, da lui considerato uno dei capolavori di Rossellini.

Non ci sembra un caso se il lungo documentario di Scorsese è, anche nel titolo, un omaggio questo film. Infatti, cosa è “Il mio viaggio in Italia” se non una volontaria parafrasi-omaggio al film di Rossellini, “Viaggio in Italia”? Eppure, dice alla fine con amarezza Scorsese, questo film non piacque in Italia, fu un fiasco di critica e di pubblico. E invece in Francia il film fu osannato da tutto il gruppo dei giovani cineasti che ruotavano attorno a Bazin e a Jacques Doniol-Valcroze fondatori nel 1951 della rivista Cahiers du cinéma e che daranno vita e linfa a quella generazione di giovani registi denominata “Nouvelle Vague”: Truffaut, Rohmer, Rivette, Godard, Chabrol e tanti altri. Sono questi giovani futuri registi a cogliere la grande portata innovativa presente nel film di Rossellini e ad esaltarne la cifra realistica, a chiamarlo in Francia, a tributargli quei riconoscimenti che l’Italia gli aveva negato per quel film.
A noi è sembrato francamente molto significativo che, finito di girare il terzo film della trilogia dei suoi Gangster movie (diventata quadrilogia col recente “The Irishman”), Scorsese abbia trovato il tempo e la voglia di dedicarsi per qualche anno ai due documentari che da tempo aveva in mente, quello sul cinema americano e quello sul cinema italiano. C’è, a nostro giudizio, un filo logico e operativo che collega le varie fasi del cinema di Scorsese, e in particolare la forma del Gangster movie, con la sua passione per il documentario.
Alla fine non ci sembra una forzatura sottolineare come tra “Quei bravi ragazzi” e “Il mio viaggio in Italia” non ci sia poi nessun salto logico e nessun cambio di spartito: in entrambi l’elemento prevalente che collega il tutto è la sua passione critica per la realtà, da scoprire e poi da commentare da par suo.
La conclusione del percorso: “The Irishman”
Con “The Irishman” siamo alla conclusione di un lungo percorso che ha portato Scorsese, a modificare profondamente il genere del Gangster movie, forte anche del lavoro di chi, prima di lui, aveva già portato avanti la rivoluzione di questo (penso soprattutto ad Arthur Penn). Con quest’ultimo Gangster movie Scorsese non può ricorrere ai colloqui con gli ex gangster, né ad altri tipi di testimonianze. Eppure, vuole continuare ad essere aderente alla realtà. Il film “deve” documentare la vita, i pensieri e i crimini di cui si è macchiato Frank Sheeran, detto l’Irlandese., nell’obbedire alla cupola malavitosa,
A riempire questo vuoto di informazioni, di storie, di testimonianze viene in soccorso una testimonianza di seconda mano, ma sicuramente veritiera al 100%. Si tratta della testimonianza di Charles Brandt, il procuratore dello Stato del Dalaware, che per ben cinque anni ha incontrato Frank Sheeran in un lunghissimo interrogatorio che rifletteva l’esigenza dello spietato “irlandese”, sicario della mafia, di liberarsi del fardello dei suoi atroci ricordi, accompagnati ad evidenti sensi di colpa.

Nel 2004 Charles Brandt scrive il saggio “I heard you paint houses”, oggi pubblicato in Italia col medesimo titolo del film, “The Irishman”; ed è proprio sulle testimonianze raccolte da Brandt nel suo saggio, che si basa il film di Scorsese. Certo, si dirà, si tratta di una testimonianza di seconda mano: Scorsese si fida di Brandt, che, a sua volta, si fida di quello che racconta l’Irlandese. Ma sono molte le argomentazioni che il procuratore, così zelante e ligio al dovere, porta a favore della tesi della assoluta veridicità delle dichiarazioni a lui rilasciate da Frank Sheran, il quale, tra l’altro, aveva spontaneamente e senza alcuna pressione né necessità, contattato Brandt, dopo aver letto il suo libro “Il diritto di rimanere in silenzio”.
“Io sono bravo a tirare fuori dalla gente quel peso che tutte le persone che hanno commesso un crimine si portano dentro”, ha affermato l’ex procuratore nella recente intervista all’ANSA. E nelle ben 472 pagine di confessioni e considerazioni emergono dati molto interessanti, anche perché inediti. Ad esempio, rivelazioni sul ruolo della Mafia nella morte di Kennedy, sulle quali Scorsese si sofferma abbastanza esplicitamente in alcuni passaggi del film, ad esempio allorché il boss Bufalino dice a Sheeran “se siamo riusciti a uccidere il Presidente degli USA possiamo uccidere anche il presidente del sindacato” (riferito ad Hoffa). E allorché ci mostra un gruppo di mafiosi intenti a rimettere in alto la bandiera americana, tenuta a mezz’asta per la perdita del Presidente. E ancora Scorsese non manca di mostrarci il disgusto di alcuni boss di fronte ad una apparizione televisiva di Robert Kennedy, allora procuratore di Stato, nemico giurato delle cosche mafiose americane.
“Non ci sono grosse differenze tra il libro e il film anche grazie al fatto che sono stato coinvolto fin dall’inizio nella sceneggiatura – afferma Brandt, che rivela di esserselo aspettato di venire chiamato prima o poi da Scorsese per la cessione dei diritti del libro.
Ci siamo soffermati sul libro di Brandt e sulle sue dichiarazioni, per sottolineare un aspetto che Brandt evidenzia con grande sicurezza: l’adesione di tutto quello che viene riportato nel film alla realtà. Che è poi per Scorsese l’adesione ad un tipo di Gangster movie che è ricerca della realtà e della verità, che raggiunge, con “The Irishman” il livello più alto.
Ovviamente ci sono momenti di pura fiction nel film, soprattutto nella costruzione di qualche personaggio, ma il tutto è all’interno di un quadro più che mai realistico e di piena adesione alla realtà dei fatti così come sono accaduti. Quello che vogliamo affermare è che “The Irishman” rappresenta la summa della concezione del genere Gangster movie secondo Scorsese, e cioè un film che ha come protagonista assoluto un celebre malvivente e, nello stesso tempo, aderente il più possibile allo svolgimento dei fatti. Aderente cioè alla realtà come e più di un documentario. Insomma, più che un film, “The Irishman” è un “docu-film”. E fare di un docu-film il capolavoro che è “The Irishman”, è cosa che solo un grandissimo regista come Scorsese poteva permettersi…
(1) R. Kolker: “A cinema of loneliness” – Oxford University Press – pagg 45-46.
SANGUE E CELLULOIDE – VIAGGIO TRA I DRACULA CINEMATOGRAFICI
a cura di Riccardo Poma

1. Il romanzo
“Dracula”è un romanzo epistolare scritto dall’irlandese Bram (Abraham) Stoker (1847 – 1912) e pubblicato per la prima volta nel 1897. Si tratta di uno degli ultimi esempi riconosciuti di romanzo gotico, genere narrativo caratterizzato dalla mescolanza di elementi romantici ed elementi dell’orrore, sviluppatosi in Europa a partire dalla metà del XVIII secolo.

Grazie al ritrovamento di molti appunti e diari dello scrittore, sappiamo che egli eseguì un attento lavoro di documentazione prima di mettersi al lavoro sul personaggio, che fu creato mescolando suggestioni di diversa natura: storiche, come ad esempio la figura di Vlad III, sanguinario Principe di Valacchia; cronachistiche, come rivelano i molti appunti e ritagli di giornali posseduti dallo scrittore in merito ad un caso di omicidio con dissanguamento avvenuto nel 1892 in New England, appena cinque anni prima della stesura di “Dracula”; letterarie, come il romanzo “Il vampiro”di John Polidori (1819), tra i primi a tralasciare la concezione folkloristica del vampiro per farne un essere seducente ed aristocratico come sarà quello di Stoker. Oltre che per l’innovativo stile di scrittura, “Dracula”fu molto apprezzato perché, come ogni grande classico, si prestava a tutta una serie di riflessioni, soprattutto in merito alla società vittoriana cui lo stesso Stoker apparteneva, riflessioni non proprio lusinghiere e, anzi, piuttosto critiche. Una ragione, questa, che rende il personaggio ancora decisamente affascinante: disinibito e libero di esprimere liberamente sé stesso (e la propria animalesca sessualità), Dracula è il mezzo attraverso cui vengono a galla l’ipocrisia e il perbenismo di molte culture occidentali. Il simulacro di ciò che vorremmo essere ma che, a causa di costrizioni impartite dall’esterno (ad esempio dalla società di cui facciamo parte), non siamo.
2. I primi film muti: “Dracula halàla” e “Nosferatu”
Come sempre avvenuto con la maggior parte dei grandi personaggi classici della letteratura, era impensabile che “Dracula”non sarebbe mai stato trasposto in immagini per il cinema. Prima di parlare del celeberrimo “Nosferatu”(1922) del tedesco Friedrich Wilhelm Murnau (la più antica pellicola ispirata a Bram Stoker giunta ai giorni nostri) occorre citare un dimenticato lungometraggio unghereseuscito appena un anno prima, nel 1921, secondo molti il primo vero film tratto da “Dracula”. Si tratta del misterioso “Dracula Halàla”(letteralmente “La morte di Dracula”), diretto dal cineasta magiaro Kàroly Lajthay. Della durata di circa 60 minuti, il lungometraggio era interpretato da Erik Vanko e Lena Myl, e considerato il secco rifiuto della vedova di Stoker a vendere i diritti del romanzo l’anno successivo (quando partì la produzione di “Nosferatu”), è difficile pensare che la piccola casa produttrice ungherese avesse il permesso di girare un film tratto da “Dracula”. In rete o negli archivi fotografici è possibile rintracciare qualche locandina e qualche fotogramma estrapolato dai giornali dell’epoca, ma purtroppo il film risulta perduto sin dalla fine della seconda guerra mondiale.

Si arriva dunque a “Nosferatu”, il primo vero film tratto da Dracula di Bram Stoker. La trama riecheggia quella del romanzo: il giovane agente immobiliare Hutter parte da Wisborg (Germania) verso i Carpazi per concludere un affare col misterioso conte Orlok. Non sa che si tratta di un vampiro, e che il suo obiettivo è quello di raggiungere l’Europa per spargere la peste. Lo fermerà, sacrificandosi, proprio la moglie di Hutter, la giovane Helen… Quando Florence Balcombe, la vedova di Bram Stoker, rifiutò di cedere i diritti del romanzo alla tedesca Prana Film, il regista Murnau e il produttore Albin Grau decisero di provare a girare il film lo stesso. Allo sceneggiatore Henrik Galeen fu quindi chiesto di ispirarsi a Stoker cambiando però i nomi dei personaggi e le ambientazioni. Tuttavia, la parentela con esso era così evidente che quando la Balcombe fece causa allo studio il film venne subito giudicato illegale e ne venne ordinata la totale distruzione. Non solo: la piccola Prana, costretta a versare ingenti risarcimenti, dovette chiudere per bancarotta, rendendo di fatto “Nosferatu” la sua unica produzione terminata. Per fortuna la sentenza ufficiale arrivò soltanto nel 1925, e dunque qualche copia del film (soprattutto quelle destinate ai mercati esteri) continuò a girare riuscendo a giungere fino a noi. Girato quasi tutto in esterno e in luoghi reali (Germania e Slovacchia), con appena una macchina da presa (l’operatore era Fritz Arno Wagner), il film è oggi considerato un capolavoro del cinema espressionista e uno dei primi veri, grandi horror della storia. Grazie ai costumi e alle scene dello stesso Grau, grande esperto di esoterismo, e alla regia innovativa ed evocativa di Murnau, l’atmosfera del film appare ancora oggi particolarmente inquietante e malata, e la sua potenza metaforica offre moltissime chiavi di lettura: psicanalitica (la fascinosa presenza di Orlok svela la sessualità repressa dei coniugi Hutter e della società in cui vivono), storico-politica (in una società instabile e colma di paure collettive, Nosferatu sembra lo spettro anticipatore della piaga del nazismo e della seconda guerra mondiale), filosofica (come sottolineano le tantissime riprese di animali, il vampiro è un prodotto della natura e, dunque, è un essere al di là del bene e del male). Alla lucida critica di Stoker – per il quale la figura del vampiro serviva per criticare le regole sociali e morali della perbenista Londra vittoriana – Murnau sovrappone la sua personale visione delle cose (e del cinema) che parte dal romanticismo (il tema dell’ineluttabilità) e arriva ad un pessimismo radicale che non concede catarsi (l’unico omologo stokeriano che manca nel film è quello di Van Helsing, ovvero il bene che può fermare il male).

La fotografia di Wagner riesce a dare al film un tono espressionista eppure innegabilmente realistico, riuscendo a creare immagini dal forte potere suggestivo e simbolico (è entrata nella storia la salita del vampiro sulle scale, con l’ombra proiettata sul muro a rivelarne la mostruosa natura). Per constatare quanto quest’opera abbia influenzato il cinema venuto dopo basterebbe dire che l’idea che i vampiri temano la luce (idea oggi unanimemente riconosciuta in ambito narrativo) viene proprio da qui: non è presente in Stoker e non era presente nella sceneggiatura di Galeen, ma Murnau la improvvisò per differenziare il finale da quello del romanzo. In giro per il mondo si trovano parecchie versioni di Nosferatu, alcune virate in blu (scene di notte) e giallo (scene diurne o interni), altre con i nomi dei personaggi “corretti” (e con Wisborg che diventa Brema). Attorno al film sorsero una serie di leggende, soprattutto riferite all’attore che interpreta il conte Orlok: secondo alcuni si trattava di un vero vampiro (Max Schreck, in tedesco, significa qualcosa come “massimo spavento”), secondo altri dello stesso Murnau pesantemente truccato. Ovviamente si trattava di teorie prive di fondamento.
3. Il Dracula della Universal
Per il primo adattamento autorizzato di “Dracula”(anche se alcune fonti citano una trasposizione teatrale già intorno al 1900) si dovrà attendere il 1927, quando a Broadway esordisce l’omonimo adattamento firmato dai drammaturghi Hamilton Deane e John L. Balderstone. Visto il successo dello spettacolo, la Universal (che in quegli anni progettava di portare in scena diversi adattamenti tratti da romanzi dell’orrore – quello subito successivo sarà Frankenstein) acquistò i diritti dello spettacolo e, nel 1931, produsse “Dracula”, primo film ufficiale tratto dal romanzo di Stoker. Prodotto da Carl Laemmle Jr. e diretto da Tod Browning, il film è interpretato dall’attore ungherese Bela Lugosi, nei panni del primo vampiro cinematografico aristocratico ed elegante, ben diverso da quello animalesco immaginato da Stoker e portato in scena da Murnau ma molto simile a quello raccontato da John Polidori ne “Il vampiro”.

La derivazione teatrale rende il film statico e decisamente verboso (soprattutto nella seconda parte), ma ancora oggi si fa apprezzare per le ottime prove attoriali (Lugosi su tutti), per il notevole impianto scenografico e luministico, per alcune scene piuttosto inquietanti (l’apparizione delle mogli di Dracula, l’arrivo del vascello, le peregrinazioni notturne di Lucy), per una regia moderna capace di notevoli carrellate e audaci movimenti di macchina. Questo primo capitolo ebbe anche il merito di rendere iconica la performance di Lugosi, che aveva già interpretato il conte nella versione teatrale e non riuscì più a scrollarsi di dosso il ruolo del vampiro: quando nel 1956 morì per attacco cardiaco (dopo anni di film minori e b-movie tra i quali citiamo almeno “Plan 9 from outer space” di Ed Wood), la moglie e il figlio lo seppellirono con addosso il mantello di Dracula. Secondo i diari dell’attore Manners, che nel film interpreta John Harker, molte sequenze non furono dirette da Browning, in costante contrasto con Laemmle Jr., ma dal direttore della fotografia Karl Freund (futuro regista de “La mummia”). Se si esclude il brano d’apertura (un passo tratto dal “Lago dei cigni” di Tchaykowsky), il film fu inspiegabilmente girato senza musiche: la colonna sonora che accompagna le versioni trasmesse oggi fu composta nel 1999 dal musicista Philip Glass appositamente per la distribuzione home-video. Durante la lavorazione del film, sugli stessi set e sulla medesima sceneggiatura ne venne girato un “gemello” in lingua spagnola, diretto da George Melford e interpretato da Carlos Villarìas (Dracula) e Lupita Tovar (Eva/Helen). A lungo considerato perduto, il film fu ritrovato negli anni settanta e reso disponibile nelle versioni home-video del “Dracula” di Browning. Chi lo ha visionato sostiene che sia migliore e più dinamico di quello “originale”. Come Lugosi, anche Van Sloan era già presente nello spettacolo teatrale (ovviamente negli stessi panni, quelli di Van Helsing).
L’ottimo successo della pellicola spinse la Universal a produrre una serie di seguiti: “La figlia di Dracula” (1936), “Il figlio di Dracula” (1943), “Al di là del mistero” (1944), “La casa degli orrori” (1945) e la commedia “Il cervello di Frankenstein” (1948) con Gianni e Pinotto. Lugosi tornò nel ruolo del conte soltanto in quest’ultimo (dunque lo interpretò soltanto due volte), eppure ancora oggi – forse perché interpretò il vampiro in altri film – vige l’errata convinzione che sia uno degli attori che lo interpretò più volte.
4) Il Dracula della Hammer e gli anni settanta
Quando l’interesse verso il personaggio pareva scemato – e quando oramai la figura del vampiro sembrava essere stata spremuta in ogni modo possibile – la britannica Hammer, medio-piccola casa produttrice specializzata in prodotti di fantascienza, decide di rispolverare i mostri resi noti venticinque anni prima dalla Universal. Dopo il primo, fortunato adattamento di Frankenstein di Mary Shelley (“La maschera di Frankenstein”, 1957, di Terence Fisher), con Peter Cushing (Frankenstein) e Christopher Lee (la creatura), la Hammer gira il celebre “Dracula il vampiro” (1958), confermando peraltro la stessa squadra che si era distinta nel film precedente: oltre a Fisher regista, infatti, tornano gli attori Peter Cushing (stavolta nei panni di Van Helsing) e Christopher Lee (in quelli di Dracula). Quello di Lee è un vampiro aristocratico come quello di Lugosi, più perverso ma meno inquietante e notturno, per quanto l’esibizione dei canini (per la prima volta associati al personaggio di Dracula) lo renda comunque decisamente spaventoso. La sceneggiatura di Jimmy Sangster modifica ruoli e parentele dei personaggi e rende Van Helsing il vero protagonista, ma rimane molto fedele allo spirito del romanzo di Stoker, grazie anche ad una messa in scena disturbante e a colpi di scena azzeccati. Gli spaventi sono sempre ottenuti attraverso il montaggio e la musica, ma quella di Fisher resta comunque una regia superiore alla media dei b-movie horror di quegli anni. Da segnalare anche le tre o quattro incursioni nella commedia e il finale schifiltoso, vero e proprio precursore dello splatter odierno. Come già era accaduto a Lugosi, anche Lee fece fatica a scrollarsi di dosso il personaggio del vampiro, anche perché – lui sì – lo interpreterà altre otto volte tra film Hammer e film di altre case.

Visto il grande successo del film la Hammer, come già aveva fatto la Universal molti anni prima, mise in produzione una serie di seguiti associati al personaggio: “Dracula, principe delle tenebre” (1966), “Le amanti di Dracula” (1968), “Una messa per Dracula” (1970), “Il marchio di Dracula” (1970): Dracula colpisce ancora!” (1972, l’unico in cui si riforma la celebre coppia Cushing/Lee) e “I satanici riti di Dracula” (1974). Il filone vanta anche una serie di spin-off, in cui mancano i personaggi di Dracula e Van Helsing ma si affronta il tema del vampirismo: “Le spose di Dracula” (1960), “Il mistero del castello” (1963) e “La leggenda dei 7 vampiri d’oro” (1974). Quando nel 1961 muore l’unico figlio di Stoker e della Balcombe, Irving Noel Stoker, la figlia Anne Elizabeth (1916 – 1998) si mostra probabilmente meno rigida in merito alla concessione dei diritti di sfruttamento, e infatti a partire dalla seconda metà degli anni sessanta le produzioni ispirate a “Dracula” aumentano in maniera esponenziale, anche al di fuori del filone Hammer. Tra le più importanti citiamo almeno: “Il conte Dracula”, film spagnolo del 1970 diretto da Jesus Franco e interpretato da Christopher Lee (per la prima volta nei panni del conte in un film non prodotto da Hammer) e Klaus Kinski (nel ruolo di Renfield); “Vampira” (1974) di Clive Donner, primo tentativo di parodia del romanzo, con David Niven alle prese con un Dracula anziano; “Dracula padre e figlio” (1976), produzione francese diretta da Edouard Molinaro, di nuovo con Lee; “Zoldan, il mastino di Dracula” (1979), film diretto da Albert Band con protagonista nientemeno che il cane di Dracula.

Qualche parola in più va sicuramente spesa per il celebre “Dracula cerca sangue di vergine…e morì di sete!!!”, uscito nel 1974 per la regia di Paul Morrissey. Prima di qualsiasi analisi, urge leggere la trama: per poter sopravvivere il conte Dracula (Udo Kier) necessita di sangue di vergine, ma in Transilvania è diventato molto difficile trovarne. Per ovviare al problema, il suo assistente gli suggerisce di andare in Italia, nazione assai religiosa e, di conseguenza, teoricamente piena di pulzelle vergini. Giunto nello stivale il conte aspira al sangue di tre giovani e bellissime sorelle, rampolle di una famiglia di nobili decaduti, ma non ha fatto i conti con Mario, il servitore della famiglia, che ama intrattenersi con le fanciulle. Prodotto da Andy Warhol con la stessa squadra de “Il mostro è in tavola…barone Frankenstein”(1973), il film è una delle tante variazioni sul tema del romanzo di Stoker, stavolta in chiave camp-splatter-erotica. L’impressione che la ragion d’essere del film siano gli indugi sui corpi delle tre giovani donne e dell’ex attore porno Joe Dallessandro è forte, ma il film conserva un suo inspiegabile e contorto fascino, e effettivamente non somiglia a nient’altro che si possa trovare in giro (a partire dall’improbabile cast, nel quale spunta anche Vittorio De Sica, all’ultima apparizione prima della scomparsa). Anche i contributi tecnici sono quelli di un film italiano di prim’ordine: fotografia di Luigi Kuveiller, trucchi di Carlo Rambaldi, musiche di Claudio Gizzi. La versione italiana del film è attribuita, oltre che a Morrissey, ad Antonio Margheriti, ma probabilmente si trattò soltanto di una trovata commerciale del produttore Carlo Ponti per vendere il film anche da noi: secondo i membri del cast e della crew, infatti, Margheriti non apparve praticamente mai sul set, e fu contattato soltanto come tecnico per le scene in 3D (che però non furono mai girate).
5) 1979: un nuovo Dracula e un nuovo Nosferatu
Nel 1979 escono due nuovi film ispirati alla figura di Dracula, nonostante si tratti, più che di nuovi adattamenti da Stoker, di due remake. Si tratta di “Dracula” di John Badham, rifacimento targato Universal del film del 1931 di Tod Browning, e di “Nosferatu – Il principe della notte” di Werner Herzog, rifacimento di quello che il regista considerava il più grande film tedesco di tutti i tempi, il “Nosferatu” di Murnau. Nel primo caso si tratta di un tentativo, parzialmente riuscito, di rinverdire uno dei “mostri” più celebri della Universal, accentuandone, anche grazie all’ottima prova di Langella, gli aspetti erotici e fascinosi che cinquant’anni prima potevano essere solo suggeriti. Il film possiede ottimi contributi tecnici, un bel cast e qualche interessante trovata visiva, ma va detto che non aggiunge molto al filone dei vampiri. Diverso invece il discorso sul film di Herzog. Quest’ultimo – che definì il film del 1922 “il film più importante mai girato in Germania” – amplifica alcune riflessioni di Murnau (la maestosità indifferente della natura, l’idea della sessualità repressa dalla società) e rende il suo Nosferatu un personaggio profondamente herzoghiano: un antieroe tragico e sommesso, quasi restìo a dare sfogo alle proprie pulsioni e stufo dell’eternità cui è condannato. Uno sconfitto su tutti i livelli cui l’attore Klaus Kinski, lontano dai ruoli istrionici del passato, riesce a infondere una verità psicologica inaspettata, soprattutto per un mostro. Anche se, a conti fatti, la vera protagonista del film, il “bel personaggio”, è la Lucy di Isabella Adjani, che si sacrifica per amore ed è l’unica ad avere compreso la natura del mostro. Ma il film è interessante anche a livello stilistico: Herzog sceglie una regia affascinante in cui inquadrature statiche di stampo pittorico (che rimandano al romanticismo) si alternano a inquadrature dinamiche in cui la camera, perennemente a mano, sembra voler cercare la verità del realismo documentario anche nel fantastico. Riuscitissime – e ancora oggi, soprattutto oggi, piuttosto scioccanti – le sequenze della città in preda alla peste a ai topi.

Per evitare il doppiaggio ogni sequenza “parlata” venne girata sia in tedesco che in inglese, e dunque la versione tedesca e la versione anglofona sono leggermente diverse anche a livello visivo. Herzog scelse di ripristinare i nomi originali dei personaggi del romanzo, anche se inspiegabilmente inverte quelli di Lucy e Mina. Nel 1988 uscì una sorta di seguito italiano e non ufficiale del film di Herzog, “Nosferatu a Venezia”, con Kinski che riprende il medesimo ruolo. Funestato da una produzione travagliata ai limiti dell’assurdo (la regia è attribuita al produttore Carminito, ma molte scene furono girate in realtà da Mario Caiano e Maurizio Lucidi, licenziati dopo pochi giorni di riprese, da Pasquale Squitieri, che se ne andò dopo l’ennesima lite con Kinski, da Luigi Cozzi, ai tempi aiuto regista, e dallo stesso Kinski), è un film dell’orrore piuttosto confuso e poco pauroso, elegante a livello visivo (ottima la fotografia sospesa di Antonio Nardi, belle le musiche di Vangelis) ma irrimediabilmente sciocco a livello narrativo, con un Kinski sempre più istrione che alterna grandi momenti (notevole la scena in cui si aggira in una Venezia deserta) a ridicoli scivoloni nel trash (non volle nè truccarsi nè rasarsi come fece per il film di Herzog, col risultato di non conservare alcuna parentela d’immagine col personaggio interpretato 10 anni prima). La troupe smise spesso di girare per protesta contro i continui eccessi dell’attore tedesco (pare che avesse anche molestato la protagonista Barbara De Rossi), a riprova del fatto che girare un film con lui era sempre una scommessa rischiosa. Nemmeno il cast internazionale – Christopher Plummer, Donald Pleasence – riuscì a salvare il film da un clamoroso insuccesso.
6) Il Dracula di Coppola e gli anni novanta
Nonostante nel 1982 – a 70 anni esatti dalla morte di Stoker – scadano i diritti di “Dracula”, il cinema degli anni ottanta e novanta sembra non avere più molto interesse a raccontare la storia del celebre Conte transilvano, preferendo affrontare la tematica del vampirismo – con le sue innumerevoli sfaccettature – in maniera originale e meno legata al personaggio che la rese celebre. Ad andare controcorrente rispetto a questa tendenza c’è sicuramente Francis Ford Coppola che, nel 1992, gira un’ennesima trasposizione del romanzo scegliendo, a partire dal titolo, di rimanere molto fedele allo spirito dello scrittore irlandese. Nonostante ad entrare prepotentemente nell’immaginario collettivo sia la magistrale performance di Gary Oldman nei panni di Dracula, la vera novità presentata dal film è nell’evoluzione del personaggio femminile, la Mina di Winona Ryder. Non vittima, ma coraggiosa artefice del proprio destino: il conte la soggioga, certo, ma lei SCEGLIE di innamorarsi di lui, e il suo gesto è uno schiaffo, una violenta ribellione verso la morale bigotta e repressiva dell’epoca vittoriana, la stessa che voleva irridere Stoker. Una figura femminile più vicina a quelle degli “apocrifi” (Herzog su tutti) piuttosto che al romanzo e ai film “fedeli”.

Ma quello di Coppola è soprattutto un film sul cinema, o meglio, su un modo di fare cinema che all’alba degli anni novanta sembra quasi del tutto estinto: il regista, infatti, evita il più possibile gli effetti digitali e torna ai trucchi del cinema di una volta (l’iride, la sovrapposizione fotografica), ottiene effetti allucinati distorcendo le immagini con grandangoli estremi, opta per un gusto visivo tipicamente espressionista che rimanda non soltanto al “Nosferatu” di Murnau (l’uso delle ombre) bensì anche a “Il gabinetto del dottor Caligari” (1920) di Robert Wiene (le scenografie irrealistiche, quasi dipinte). E accoglie, in ultima istanza, quelle che sono le rotture tipiche del post-modernismo, come dimostrano per esempio molti ironici stacchi di montaggio (memorabile quello tra il cadavere nella cripta e l’arrosto al sangue servito al tavolo dei protagonisti). Scelte tutt’altro che gratuite: anche il cinema è, come sottolineano le parole di Mina dinnanzi al cinematografo, un qualcosa di troppo libero per non essere considerato scandaloso dalla società, soprattutto quella di un tempo. Lo stesso Dracula di Coppola è un personaggio profondamente meta-cinematografico, vera e propria summa di tutti i Dracula in celluloide venuti prima, da quello mostruoso di Murnau a quello elegante e dandy di Lugosi, dei quali ha rubato (o forse sarebbe più corretto dire “succhiato”, vista la natura del personaggio) le caratteristiche salienti. Insomma, in questo Dracula trasformista e cangiante sembrano convivere tutti i Dracula del passato. Il film avrà così tanto successo da spingere Mel Brooks a girarne una parodia intitolata “Dracula morto e contento” (1995), con Leslie Nielsen nei panni del Conte. Tra i film che tra gli anni ottanta e gli anni novanta ripropongono, anche fugacemente, il personaggio di Dracula, citiamo almeno “Scuola di mostri” (1987, Fred Dekker), sorta di divertissement citazionista in cui ritroviamo molti dei mostri Universal (quindi ovviamente anche Dracula), “Vlad Tepes – La leggenda di Dracula” (1994, Mario Salieri), adattamento italiano pornografico del romanzo con la pornostar Selen nei panni della protagonista, e “Nadja” (1994, Michael Almereyda), rifacimento in chiave lesbo de “La figlia di Dracula” del 1936.
7) Dai primi anni duemila ad oggi
Il personaggio di Dracula tornerà sporadicamente a partire dal 2000, anno in cui esce, prodotto da Wes Craven, “Dracula’s Legacy – Il fascino del male”. Come sottolinea il titolo originale (“Dracula 2000”), il film si svolge ai giorni nostri, ed è interpretato, tra gli altri, da Christopher Plummer (per la seconda volta alle prese coi vampiri, dopo “Nosferatu a Venezia”), Johnny Lee Miller e un giovane Gerald Butler. Il colpo di genio della sceneggiatura di Joel Soisson dovrebbe essere quello di far coincidere la storia di Dracula con quella di Giuda Iscariota (ecco perchè teme l’argento – di cui erano fatti i trenta denari – e le croci), ma il risultato ha deluso più o meno tutti, e lo stile patinato (montaggio sincopato, inquadrature sghembe, musica metal in quasi ogni scena) lo fa apparire già vagamente datato.
Da segnalare un altro film uscito nel 2000, non basato sul personaggio di Dracula ma decisamente in argomento: “L’ombra del vampiro” di E. Elias Merhige si ispira alla leggenda – totalmente priva di qualsiasi fondamento – secondo cui Max Schreck, l’attore che interpretò il Conte nel “Nosferatu” di Murnau, fosse davvero un vampiro, assunto dallo stesso regista per rendere il suo film più realistico e pauroso. Prodotto tra gli altri da Nicolas Cage e scritto da Steven Katz, il film non solo non rende giustizia a uno dei capolavori riconosciuti della storia del cinema, bensì è anche diffamatorio e disonesto nei confronti di Murnau (interpretato da John Malkovich), che non era affatto un folle dispotico e arrogante coi collaboratori ma una persona affabile e assai razionale. Si potrebbe anche sorvolare sulle inesattezze storiche che propone (nessuno morì sul set del film; nessuna scena venne mai girata di notte, ma di giorno con l’effetto notte; Max Schreck – qui interpretato da Willem Dafoe – ebbe una luminosa carriera sia prima che dopo “Nosferatu”, ma il film ha una trama piuttosto sciocca, non porta nessun brivido e la riflessione meta-testuale che vorrebbe proporre – il vero vampiro è la macchina da presa – è mal strutturata e priva di fascino. Nonostante la miriade di pareri negativi e lo scarso successo commerciale, ebbe comunque due nomination agli Oscar, attore non protagonista a Dafoe e make-up.

Altro film che invece rilegge il personaggio di Dracula è “Van Helsing” (2004, Stephen Sommers), un roboante blockbuster d’azione che tenta il cross-over steampunk tanto di moda nei primi anni duemila (si pensi ad esempio a “La leggenda degli uomini straordinari”, del 2003). Stavolta a ritrovarsi nello stesso film sono i più noti personaggi/mostri Universal, ovvero Van Helsing (non più un anziano e riflessivo studioso, ma un aitante e coraggioso bad-ass cacciatore di mostri), il dottor Jekyll, il mostro di Frankenstein e, dulcis in fundo, l’uomo lupo. Oltre ovviamente a Dracula. Il risultato è inferiore alle aspettative, colmo di battutine, battutacce ed effetti in computer grafica non così straordinari (la morte di una delle mogli di Dracula è da apoteosi del trash, ma anche le trasformazioni dei lupi mannari sono terribili). Hugh Jackman nel ruolo di Van Helsing non delude, ma il Dracula che gli hanno messo accanto (interpretato da Richard Roxburgh) è uno dei meno affascinanti di sempre, e alla fine si rivela un villain come mille altri, tanto per cambiare smanioso di conquistare il mondo. Comunque, grande successo di pubblico.
Nel 2012 tocca invece al nostro Dario Argento misurarsi col romanzo di Stoker. Scritto dal regista con Enrique Cerezo, Stefano Piani e Antonio Testori, “Dracula 3D” è stato fischiato un po’ dappertutto (specialmente a Cannes, dove fu presentato) e ha raccolto pochi consensi anche in sala (500mila euro di incasso contro sette milioni di costi realizzativi). Il film è stato unanimemente riconosciuto come uno dei più brutti mai sfornati dal regista: dialoghi risibili, attori (tra i quali non poteva mancare la figlia Asia Argento) di raro pressapochismo, computer grafica tremenda (e pensare che è uscito in 3D!), e un compiacimento maniacale sui nudi femminili che fa tornare in mente un certo cinema horror erotico degli anni settanta. Nemmeno il coinvolgimento di grossi nomi internazionali (Rutger Hauer nel ruolo di Van Helsing, Thomas Kretschmann in quello di Dracula) ha salvato il film dalla più totale disfatta. Le location sono state il meraviglioso ricetto di Candelo (Biella) e il suggestivo castello di Montalto Dora, Ivrea (TO).

Due anni dopo esce nelle sale quello che, al giorno d’oggi, risulta essere l’ultimo Dracula girato per il cinema (nel 2020 è uscita infatti una miniserie televisiva targata Netflix), anche se la storia di questo “Dracula Untold” (2014, Gary Shore) non si basa direttamente sul romanzo quanto su ciò che potrebbe essere avvenuto prima, ovvero sui fatti che portarono Vlad III principe di Valacchia a divenire il più sanguinoso e celebre vampiro della storia. Pentitosi delle atrocità compiute quando lottava per i turchi, Vlad si converte e prende in moglie una brava donna che gli dà un figlio, Ingeras. Quando il giovane sultano turco pretende un ignobile, nuovo tributo (1000 bambini da addestrare, tra i quali anche Ingeras), Vlad si rifiuta facendo scoppiare la guerra. Per poter battere il nemico, accetta di fare un patto con una misteriosa creatura sanguinaria che vive tra le montagne. Riuscirà nel suo intento, ma diventerà lui stesso un vampiro. Scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless e inizialmente intitolato “Dracula Year Zero”, il film è a tutti gli effetti un prequel del romanzo di Bram Stoker. L’idea non era malvagia e la scelta di Luke Evans come novello Dracula poteva essere azzeccata, ma il film annega presto nelle più stanche banalità, adducendo motivazioni alquanto discutibili (addirittura si cerca di motivare in maniera sensata l’attitudine all’impalamento di Vlad) e trascinando per un’ora e mezza una storia prevedibile e senza sussulti. Da notare l’armatura che sfoggia Vlad nel finale, la stessa che indossa Gary Oldman all’inizio film di Coppola, suggerendo che “Dracula Untold” sia in qualche modo anche il prequel di quel film.
In conclusione, appare chiaro che il romanzo di Stoker (e il personaggio da lui creato) rimanga ancora oggi una fonte inesauribile di storie e significati, trasponibili dentro qualsiasi epoca, società o cultura. Questo a riprova del fatto che, come ogni grande classico, “Dracula” possieda un’universalità genuina che lo rende di fatto un romanzo eterno, capace di affascinare i lettori (e gli spettatori) di passato, presente e, a questo punto, futuro. È indubbio che molte delle trasposizioni cinematografiche (soprattutto le più recenti) non siano state all’altezza dell’opera originale, ma è pur vero che a cent’anni dal “Nosferatu” di Murnau risulta difficile dire qualcosa di nuovo. Al cinema converrebbe forse fermarsi per qualche anno, senza dimenticare il sanguinoso, affascinante conte ma aspettando piuttosto l’idea giusta per rendergli nuovamente giustizia. In fin dei conti, è un personaggio che la merita.
UNA RIFLESSIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, DI COME IL CINEMA HA TRATTATO INFEZIONI BATTERICHE, VIRUS E PANDEMIE
di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
Questa vuole essere una riflessione di come il cinema ha trattato infezioni batteriche, virus e pandemie, causate da altrettanto diversi e sconosciuti microrganismi mortali e non; pandemie che si sono succedute nel corso dei secoli. Una valutazione di come il cinema ha trattato il loro impatto sulla società civile e sull’ambiente. Cerchiamo di esaminare se il cinema si è attenuto alla realtà dei fatti scientifici o ha scelto la mera spettacolarizzazione cinematografica.
Il cinema è un’arte, con le sue tecniche precise, che si occupa di raccontare storie, far vivere sogni o altrimenti concepire incubi; che gioca con le emozioni attraverso l’immagini ed il suono. La medicina è una scienza più o meno esatta che cerca di basarsi su evidenze e che deve affrontare il duro compito di fare la diagnosi di una malattia ed intraprendere il migliore percorso terapeutico possibile. In sintesi, il cinema è un creatore di fantasie, mentre la medicina si occupa della realtà scientifica dei fatti.

Tre film esemplari per la loro vicinanza alla realtà scientifica
Un film classico di fantascienza e paradigma per eccellenza del genere è “The Andromeda Strain” (1971, Robert Wise). Costruito su un romanzo di Michael Crichton. È la storia di scienziati che cercano di analizzare un microbo di origine extraterrestre, che ha annientato un remoto villaggio. Utilizzando gli unici due sopravvissuti, trasferiti in un laboratorio all’avanguardia, gli scienziati cercano di trovare risposte prima che il virus devasti il mondo.
Il film del genere che forse con maggiore precisione scientifica descrive una malattia infettiva è “Outbreak” (1995, Wolfgang Petersen). Il film narra l’intervento dell’esercito americano in un piccolo villaggio in Africa per fermare la diffusione di un virus mortale e mantenerlo segreto. Tuttavia, uno scimpanzé rompe l’isolamento e lo trasporta negli Stati Uniti. Il film è sorprendente perché allude all’origine virale della malattia. Le particelle rilasciate da una persona infetta in un cinema affollato sono seguite dalla cinepresa. Uno scienziato viene infettato in un laboratorio descrivendo accuratamente le precauzioni di biosicurezza. La parte finale del film abbandona la scienza dando la priorità all’azione e allo spettacolo, nonostante è considerato ancora uno dei tentativi più onesti ed accurato nel trattamento dell’infezione batteriologica nella cinematografia commerciale.
“Contagion” (2011, Steven Soderbergh), presenta uno scenario abbastanza simile a quello con cui viviamo oggi con il coronavirus. Vale a dire, il virus proviene dalla Cina e i pipistrelli sono la causa della malattia. L’infezione viene trasmessa banalmente attraverso un semplice contatto. Non mancano le immagini alle quali ci siamo abituati in questi mesi, città vuote, aeroporti chiusi, ospedali improvvisati, fosse comuni, cercare il paziente “0”, tute protettive speciali, politici in difficoltà di fronte alla crisi sanitaria ed economica, l’uso dell’esercito, guanti in lattice, maschere. Paura e panico diffuso. Un thriller realistico e sincero, senza effetti speciali, che fugge dal sensazionalismo. Può o meno piacere, ma è virtuoso e serio dal punto di vista scientifico e sociale, sulle cause e sugli effetti di una pandemia.
Tutto è iniziato con le grandi epidemie storiche
Parliamo di alcuni film che hanno ripreso grandi epidemie storiche come la peste nera, la tubercolosi o l’influenza, chiamata erroneamente “spagnola”. Un film muto ambientato nella Firenze rinascimentale del XV secolo, con la peste in mezzo. “Die Pest en Florenz” (1918, Otto Rippert), scritto da Fritz Lang, basato su “The Masque of the Red Death” di Edgar Allan Poe. “La Peste” (1992, Louis Puenzo), basato sul noto romanzo di Albert Camus. “Quiet Killer” (1992, Sheldon Larry), sulla peste nera, cosi come “Trollsyn” (1994, Ola Solum). “Arrowsmith” (1931, John Ford), basato su un romanzo di Sinclair Lewis. La febbre tifoide è l’argomento principale di “Dr. Bull” (1933, John Ford). Un altro film costruito su un famoso romanzo è “The Citadel” (1939, King Vidor), con la tubercolosi come sfondo. La pellicola “1918” (1985, Ken Harrison), sull’influenza tristemente famosa che ha ucciso milioni di persone.
Con le armi biologiche e il terrorismo abbiamo gli ingredienti adatti per suscitare l’interesse del grande pubblico. Questo è il caso dell’acclamato “12 Monkeys” (1995, Terry Gilliam). Tre adattamenti liberi dello stesso romanzo omonimo di Richard Matheson (1954). “Last Man on Earth” (1964, Sidney Salkow). “The Omega Man” (1971, Richard Fleischer) e il più recente, “I Am Legend” (2007, Francis Lawrence). Un film considerevole è Hei Tai Yang 731 (1988, Tun Fei). Racconta gli esperimenti di guerra biologica giapponese contro i prigionieri di guerra cinesi durante la Seconda Guerra Mondiale. L’Ebola come arma mortale per la guerra batteriologica nel film “Operation Delta Force” (1997, Sam Firstenberg). “Deadly Outbreak” (1995, Rick Avery). “Mission Impossible II” (2000, Brian De Palma), un blockbuster che vede Tom Cruise salvare il mondo da un terrorista che vuole impadronirsi di un micidiale virus geneticamente creato.

Il rilascio di agenti biologici pericolosi può essere dovuto a incidenti di laboratorio imprevisti, come alcune teorie cospirative suggerite in questi giorni sul Covid-19. Alcuni esempi in film come “The Satan Bug” (1965, John Sturges); “Code Name Trixie” (1973, George Romero). Famoso regista creatore dei non morti o zombi. “The Missing Are Deadly” (1975, Don McDougall); “Virus” (1980, Kingi Fukasaku); “The Stand” (1994, Mick Garris), basato su un romanzo di Stephen King. Il film “Resident Evil” (2002, Paul Anderson), come “World War” Z (2013, Marc Forster) sono pellicole di grande successo commerciale, in cui prevalgono azione, terrore, effetti speciali, zombi, ecc. Uno spettacolo cinematografico che ha il suo pubblico fedele ed entusiasta.
Altri virus: Vaiolo. AIDS, Ebola, Tubercolosi
Un virus mutante e mortale che può causare l’apocalisse, è un’opportunità succulenta per il cinema. Vari film come “Plague” (1978, Ed Hunt); “Jericho Fever” (1993, Sandor Stern). “Pandora’s Clock” (1996, Eric Laneuville). “Fatal Error” (1999, Armand Mastroianni). L’iconico “28 Days Later” (2003, Danny Boyle), apprezzato e riconosciuto con vari riconoscimenti. “Virus” (2013, Kim Sung-su).
Un altro aspetto fondamentale delle infezioni e delle pandemie è la Quarantena. L’argomento è affrontato nel film “Isle of the Dead” (1945, Mark Robson), come pure “Cassandra Crossing” (1976, George Kosmatos). “Daybreak” (1993, Stephen Tolkin) è un dramma ratto dall’opera teatrale “Beirut” di Alan Bowne. La serie TV “Containment” (2016, Julie Plec) parla delle incertezze causate da una quarantena ad Atlanta dopo un’epidemia mortale. Un dramma ad uso televisivo.
A proposito di altri microrganismi, uno degli esempi più virtuosi e stato, “Panic in the Streets” (1950, Elia Kazan), che si basa sulle misure di sicurezza contro la diffusione della peste polmonare. Il vaiolo centra la trama di entrambi, “The Killer that Stalked New York” (1950, Earl McEvoy), così come il film “80,000 Suspects” (1963, Val Guest). Quest’ultimo è basato sul romanzo “The Pillars of Midnight” de Trevor Elleston. In “Yibola bing du” (1996, Herman Yau) l’Ebola è il protagonista. In “Contagious” (1997, Joe Napolitano), il colera è il battere da combattere. “Voyage of Terror” (1998, Brian Trenchar-Smith), un virus letale indefinito. Serie TV del National Geographic, “The Hot Zone” (2019, Michael Uppendahl). Stimolante perché parte dalla scienza e dalla sua metodologia nella lotta contro il colera, sebbene sia alla fine un thriller di fantascienza per il consumo televisivo.
L’AIDS è stato rappresentato con dignità nel cinema con due film. Il riconosciuto “And the Band Played on” (1993, Roger Spottiswoode), ed il più premiato e riconosciuto, “Philadelphia” (1994, Jonathan Demme), che mostra accuratamente il progressivo deterioramento fisico causato dalla malattia.

Per ultimo, affrontiamo un argomento legato alle pandemie dal punto di vista degli uomini che cercano di sopravvivere all’apocalisse, alla ricerca di un posto dove mettersi al sicuro ed essere in grado di ricominciare. “Cargo” (2017, Ben Howling y Yolanda Ramke) è un film di Netflix che affronta la lotta di un padre per proteggere la piccola figlia da una strana epidemia. Un film italiano “Pandemia” (2011, Lucio Fiorentino). Opera prima, racconta la storia di due giovani sopravvissuti a una pandemia, che sfuggono alla desolazione alla ricerca di un nuovo futuro. “Light of My Life” (2019, Casey Affleck). Un padre e una figlia fuggono da una pandemia mortale che uccide misteriosamente le donne.
La responsabilità del cinema con il genere sulle pandemie
In conclusione, dopo questo viaggio storico, possiamo dire che le malattie infettive sono state raramente rappresentate nel cinema con la precisione e il rigore scientifico richiesti, ad eccezione di documentari specifici sulla divulgazione e formazione professionale, per l’uso e il consumo da parte di specifici settori sanitari direttamente coinvolti nelle malattie infettive. Non nel cinema commerciale, proiettato nei cinema o che raggiunge le nostre case attraverso la televisione classica o piattaforme multimediali online come Nexflix. Amazon, etc. Sono stati fatti alcuni tentativi, come il documentario scientifico “Pandemic: How to Prevent a Outbreak” (2020, Doug Shultz). Una serie TV di sei episodi molto interessante che presenta il lavoro di medici e scienziati nella loro lotta per evitare potenziali e future epidemie.
Film del genere hanno descritto le conseguenze delle pandemie in un modo molto approssimativo, inesatto e trascurato, sfruttando l’emozione e privilegiando l’intrattenimento. Diciamo che il rigore e la precisione scientifica sono stati sacrificati per privilegiare gli interessi cinematografici commerciali. Alla fine, anche il cinema commerciale e di consumo ha i suoi propri limiti. Oltre a quelli del linguaggio cinematografico, tempi, tecnici, produzione, ecc. L’industria cinematografica è fondamentalmente un business e le malattie apocalittiche hanno un interesse speciale, morboso quasi, per il grande pubblico, per il suo grande impatto sociale, psicologico ed economico.
In sintesi, è ovvio che il cinema, con la sua potente influenza sulla mente, i sensi e l’empatia, può essere allo stesso tempo un mezzo che rafforza la conoscenza, la ragione, l’intelligenza, o tutto il contrario, che promuove gli istinti più elementari dell’essere umano come sospetto, sfiducia, egoismo, paura, panico. In ogni caso, una grande responsabilità per il cinema.
Bibliografia. “Infectious Diseases in Cinema: Virus Hunters and Killer Microbes”. Author: Pappas, Georgios; Seitaridis, Savvas. Publication: Clinical Infectious Diseases. Publisher: Oxford University Press. Date: 2003-10-01

MARINA PLEASURE SERIAL: ICONOGRAFIA VIDEO DI UNA LEGGENDA DEL PORNO ITALIANO E PANORAMICA DELL’HARD ITALICO DEL TEMPO CHE FU
di Roberto Baldassarre
Gettando uno sguardo al mercato video della prima metà degli anni Ottanta, si scopre l’esistenza del corposo cofanetto Marina Pleasure Serial. Tale occasionale recupero, classificabile come videoarcheologia, ossia lo studio e la ricostruzione dei primi cataloghi VHS degli anni Ottanta, presta l’occasione per almeno un paio di riflessioni, sul soggetto protagonista e su quello che vi gravita intorno. Infatti, il cofanetto si rivela un efficace passepartout per tracciare un profilo sull’importanza dell’icona porno Marina Hedman Bellis, meglio nota come Marina Frajese, e per tratteggiare la fisionomia dell’industria hard italiana del primo lustro degli anni Ottanta. Questa serie di VHS, distribuita dalla U.Mida Films (nome sbarazzino, ma perfetto per il genere), consta di 20 videocassette [la numerazione del catalogo va dal 400 al 419], e fu pubblicato per il mercato del noleggio e della vendita tra il 1986 e il 1987. Si presuppone che nelle intenzioni della U.Mida Films esso racchiudeva il meglio di quanto compì Marina nel primo lustro della decade, ma per migliore non s’intende la qualità delle pellicole, benché siano a loro modo ritenuti dei classici, ma per le prestazioni che l’attrice elargisce ampiamente. Per tanto, Marina Pleasure Serial è anche un’agevole “catalogo” delle performance dell’attrice svedese in quel primo scorcio del decennio – perpetuate comunque anche nel secondo lustro –, che testimonia come fosse assurta in pochi anni a icona incontrastata nell’immaginario collettivo dei voyeur. Non a caso il suo nome appariva nei titoli dei film, come già era prassi in molte produzioni di Totò, proprio perché il nome MARINA era garanzia di godibile spettacolo, inteso in quel contesto come porcaggine assicurata.
COORDINATE BIOGRAFICHE SU MARINA
Gli usuali dati biografici riportano che Marina Hedman Bellis nasce a Göteborg il 29 settembre 1944, ma i documenti presso l’anagrafe italiana riferiscono che il reale genetliaco è l’11 giugno 1941. Negli anni Sessanta svolse il lavoro di hostess sugli aerei di linea svedesi, per poi smettere quando si sposò, in Svezia, con il giornalista italiano Paolo Frajese (1939-2000), con cui ebbe due figli (un maschio e una femmina). Marina Hedman è espressione esemplare della bellezza nordica: capelli biondi e fluenti, pelle delicata e fisico giunonico. In pratica, Marina è proprio come il sogno erotico rappresentato prepotentemente da Anita Ekberg nell’episodio Le tentazioni del Dottor Antonio, diretto da Federico Fellini e presente in “Boccaccio ’70” (1963). Dopo la separazione dal marito, Marina comincia a muovere i primi passi nel cinema, iniziando la sua carriera d’attrice nel 1976. Già il suo anno d’esordio contraddistingue la sua doppia vita d’attrice: da un lato comparsa – propensa al nudo – in pellicole normali, protagonista in ambito hard. Saranno pochissimi i film mainstream in cui avrà un ruolo abbastanza consistente, e tutti saranno di qualità poco eccelsa. La sua prima apparizione cinematografica è nella commedia “Donna cosa si fa per te” (1976) di Giuliano Biagetti, e sul finire del medesimo anno compare anche in “Emanuelle in America” (1976) di Joe D’Amato. In questa pellicola erotica, terzo capitolo apocrifo ricavato dall’originale personaggio descritto dalla scrittrice Emmanuelle Arsan, la Hedman appare in una scena porno girata ad hoc per il mercato estero (per esattezza compie una fellatio con coito, ripresa in primo piano). Questo è un escamotage distributivo uguale a quello che veniva attuato durante gli anni Cinquanta e Sessanta, come testimoniano, ad esempio, i famosi extra della commedia “Due notti con Cleopatra” (1954) di Mario Mattoli e con Alberto Sordi e Sophia Loren, in cui la giovanissima attrice partenopea, nelle copie estere, mostrava il seno discinto. Da questo momento, fino al 1984, la carriera artistica di Marina si dividerà tra cinema mainstream, in cui fa brevi comparsate o recitando in ruoli di secondo piano (a volte per sfruttare l’innesto di scene porno girate per l’occorrenza), e cinema hard, come indiscussa protagonista. Tra le più note pellicole mainstream di successo in cui ha partecipato, Marina è riconoscibile in: “Primo amore” (1978) di Dino Risi; “Gegè Bellavista” (1979) di Pasquale Festa Campanile; “La città delle donne” (1980) di Federico Fellini; e “Fantozzi subisce ancora” (1983) di Neri Parenti. È comparsa anche in alcune avventure dell’Ispettore Giraldi nella serie dei delitti, e tra queste pellicole è divertente citare la simpatica (parodica?) comparsata in “Delitto sull’autostrada” (1982) di Bruno Corbucci. In una scena l’ispettore Giraldi (Tomas Milian), nascosto dentro a un confessionale per scoprire maggiori dettagli su un delitto, ascolta inavvertitamente la confessione di una donna (Marina Hedman), che gli confessa tutti i tradimenti che ha commesso. Il commissario Giraldi gli consiglia di andare alla fiera delle vacche e dei bovini. Infine, non va dimenticato che Ciprì e Maresco avrebbero voluto Marina Lotar in Totò che visse due volte (1998), nel ruolo della Madonna. Al di là della loro provocazione, la loro scelta era per sottolineare come l’attrice sia un’icona sacra da venerare.

I DIVERTIMENTI PORNOGRAFICI SERIALI DI MARINA
Mettendo in conto anche i frammenti hard girati ad hoc per i mercati esteri (si suppone che, oltre a quelli certificati, perché riconoscibili, ne abbia girati altri ancora non identificati), la carriera pornografica di Marina Hedman si è svolta tra il 1976 e il 1991, anno del suo ritiro. Riprendendo come modello Marina Pleasure Serial, si capisce come i ruoli più congeniali dell’attrice svedese fossero quelli di elegante signora avvezza al sesso; personaggi funzionali al suo fisico un poco in carne e alla sua età, riconducibile al genere MILF (ante litteram). Tra queste 20 pellicole campione, Marina Hedman è stata matura signora borghese in ben 12 film, e “La zia svedese” (1980) ne è il più fulgido esempio. Il titolo, che sfrutta le origini dell’attrice (e tutto l’immaginario sessuale che comporta il paese scandinavo), si riallaccia a quelle commedie erotiche degli anni Settanta che avevano per tema pruriginoso gli svezzamenti in ambito familiare, tipo “Grazie… nonna” (1975) di Marino Girolami e con Edwige Fenech (altro sogno erotico straniero trapiantato nel cinema italiano).

Benché “La zia svedese” faccia leva sulle scene di sesso esplicito, prevalentemente attuate da Marina Hedman, accade che come nei prototipi della decade precedente la zia procace e il giovane nipote vergine s’innamorino teneramente (anche se nel finale si separano). Interessante anche notare come, nel medesimo anno, la Hedman interpretò un’altra zia in “Con la zia non è peccato” (1980) di Giuseppe Pulieri. Questa è una pellicola realizzata in due versioni: soft e hard. Altra signora borghese viziosa, di chiare origini svedesi, c’è in “I vizi della signora” (1982) girato dalla Hedman in Spagna. Infatti, il titolo originale è Sueca bisexual necesita semental, tradotto letteralmente: “Svedese bisessuale ha bisogno di uno stallone”. In “Jojami” (1984), “Nido d’amore” (1984), “Sesso allo specchio” (1984) e “Pin Pon” (1984), Marina è una signora con prole, e non trova peccaminoso l’incesto (con la figlia o il figlio). Altro ruolo che calza a pennello all’attrice, sempre riscontrabile in questa serie di VHS, è quello di dottoressa o di maestra. Marina (s)veste i panni di sessuologa in “Wendee” (1984), e in questi rispettabili panni medici il suo personaggio ha la possibilità di fare sesso con uomini e con donne, per puri scopi terapeutici. In “Fashion Love” (1984) è in realtà una truffatrice che si finge maestra privata, ma i suoi modi educati e la bella presenza convincono il padre delle due ragazze ad assumerla. Durante il soggiorno in quella casa impartirà alle due adolescenti altri tipi di lezioni. Ruoli “particolari”, invece, sono riscontrabili in “Swoosie” (1984), in cui è la cameriera costretta da due delinquenti, entrati nella villa, a fare sesso insieme alla padrona (che in realtà è una transessuale); e in “Attenti a quelle due… ninfomani” (1981), in cui è una giovane ragazza (sic!) che si diletta a ballare, ma è molto più pratica nell’arte copulativa.
MARINA E LE ALTRE
Marina Pleasure Serial conferma, attraverso questi 20 esempi filmici, il perché l’attrice svedese svettasse rispetto alle altre attrici di quel periodo. Nelle pellicole proposte si vedono alcune delle prime pornostar presenti nel panorama italiano, che hanno bazzicato i rudimentali set hard prima della seconda ondata di pornodive. Attrici con bei visi ma dai corpi normali, incarnazioni porno-cinematografiche di donne che potevano essere classiche dirimpettaie della vita quotidiana. A volte erano pornostar per caso, come accadde per i primi attori porno (l’importante erano le erezioni). Mentre Marina Lotar eseguiva scene estreme – almeno per quel periodo –, molte altre attrici accettavano solo rapporti etero (con solo penetrazione vaginale) e rapporti saffici. Tra le attrici che si vedono in questa serie, compare in tre pellicole la nera Sonia Bennet, che era espressione sessuale dell’esotismo. C’èra Guia Lauri Filzi, corrispettiva mora di Marina e sovente in ruoli similari, ma mai attuando scene estreme come quelle dell’attrice svedese. Laura Levi, dalla presenza scenica normale, ma un vero peperino nelle scene di sesso. Marilyn McCall che ha le forme acerbe di un’adolescente, e non a caso interpreta sempre ruoli di teenager (a volte è figlia di Marina). Sabrina Mastrolorenzi, dal viso dolce, con un fisico che si situa tra quello della Levi e della McCall.
LE PERFORMANCE DI MARINA
Marina è divenuta rapidamente un mito perché sin dall’inizio si è cimentata in scene porno inusuali per quel periodo. In Marina Pleasure Serial il film non è presente, perché si è preferito inserire il numero 2, probabilmente per questioni di diritti, ma la Hedman divenne mitica per la fellatio che eseguì al cavallo Principe in “Marina e la sua bestia” (1985) di Arduino Sacco. Sin da subito, merito anche del critico Sergio Gmerk Germani, è stato svelato che il membro del cavallo fosse posticcio, ma la buffa truffa non toglie che Marina accettò senza remore di fare una scena di zoofilia. Marina Hedman non partecipò solamente a scene eterosessuali e copule saffiche, ma fu una delle prime a girare scene anali, doppie penetrazioni, sesso con transessuali (prassi normale nella seconda decade degli anni Ottanta, ma novità assoluta agli albori), scene di pissing, e finanche caviar, cioè coprofagia, come si può vedere in “Apprendiste viziose”. Anche quest’ultima tipologia di lussuria, presente nella pellicola di Andrea Bianchi, sembrerebbe falsa, ma come per la finta scena del cavallo Principe, quello che conta è vedere che Marina riceve degli escrementi sul volto.
L’HARD ITALIANO DELLE ORIGINI
Seppure l’hard poggia sempre sulle medesime intenzioni (mostrare più atti sessuali possibili), queste 20 videocassette danno l’idea di come ci fosse un certo sperimentalismo, benché bislacco, in cui si cercava di contaminare il porno con differenti generi: comico (“Sesso allegro”), commedia erotica (“La zia svedese”), grottesco di pseudo derivazione da “The Rocky Horror Picture Show” (1975) (Swoosie), dramma esistenziale (“L’amica di Sonia”), horror (“Orgasmo esotico”), poliziesco (“Fashion Love”). Le venti VHS mostrano com’erano pellicole girate senza badare troppo alle raffinatezze produttive. Prodotti realizzati a ritmi industriali, girati in pochi giorni. Ne sono prova anche le date di distribuzione nei cinema, molto ravvicinate tra loro. I cast prevalentemente erano composti con i medesimi attori, soprattutto maschili, perché ancora l’industria porno italiana non aveva una vera struttura (talent scout o uffici di casting). Anche i set ruotavano intorno agli stessi luoghi, affittati per qualche giorno e sfruttati al massimo per realizzare differenti porno da montare e smerciare in seguito.
Marina Pleasure Serial è soprattutto composto da pellicole dirette da Mario Siciliano e da Franco Lo Cascio (che si firma con il nome fittizio di Lucky Faar Delly, cioè Luciano Fardelli). Osservando i loro hard, benché entrambi sfruttino al massimo le situazioni su cui innestare le scene porno, hanno un’impostazione molto differente. Certamente il tenore delle pellicole non migliora, ma le regie di Lo Cascio spesso sono molto più “raffinate”, approfittando anche dell’ambiente in cui si svolge la vicenda, e con scene di sesso girate con più cura.
IL MERCATO HOME VIDEO
Marina Pleasure Serial segnò anche l’inesorabile passaggio che il cinema hard stava effettuando, ossia dalle sale cinematografiche al mercato delle videocassette. Molti hard sarebbero stati realizzati direttamente per l’uso casalingo, per approfittare del nascente commercio delle VHS (noleggio e vendita), e così evitare i costi di stampa per le proiezioni nei cinema a luci rosse. Inoltre, le VHS di Marina Pleasure Serial confermano come la Hedman fosse l’unica diva remunerativa per il commercio dell’hard casalingo. In quel periodo le VHS avevano un prezzo superiore alle 100.000 lire, eppure i suoi film, secondo stime redatte in quel periodo da riviste specializzate, vendevano settimanalmente 350 esemplari al pezzo. Comprare una VHS porno non era solo un modo per vedere il film in solitudine, ma per il fruitore era come portare la propria pornoattrice preferita nella propria casa.

UN PALCO AL CINEMA. IL FILM D’OPERA ITALIANO NEGLI ANNI TRENTA-CINQUANTA DEL NOVECENTO – PRIMA PARTE
di Mario Giunco
Il nostro collaboratore Mario Giunco in questo articolo ripercorre la filmografia relativa al Film d’Opera italiano negli anni Trenta-Cinquanta elencandola, in ordine alfabetico, per regista. Una filmografia molto vasta che pubblicheremo in due parti.
Di seguito la prima parte che inizia da Piero Ballerini e termina con Giacomo Gentilomo.
Nomi noti e meno noti, artisti geniali, direttori e orchestre di prim’ordine, figure sbiadite dal tempo e dall’oblio rappresentano, per almeno trent’anni del secolo scorso, la stagione d’oro del film d’opera italiano e segnano la parabola di un genere, nato dal teatro per adeguarsi al linguaggio dello schermo e tornato ai nostri giorni al teatro, dopo aver fatto proprie le esperienze dello schermo.
Pietro Mascagni non autorizzò l’uso della sua partitura per il film “Cavalleria rusticana” di Amleto Palermi. “Il film musicale – affermava – non deve essere un’opera filmata. L’opera è fatta solo per il teatro. Bisognerebbe fare della musica per il cinematografo, non copiare il palcoscenico. E allora si avrebbe il film lirico: che manca ancora”. Mascagni era convinto della dimensione unicamente teatrale dell’opera. Nel 1930 inaugurò le rappresentazioni del Carro di Tespi, dirigendo la “Bohème” di Puccini a Torre del Lago e “Cavalleria rusticana” a Lucca. Con la sua presenza – insieme a quella di famosi cantanti – intendeva dare credibilità e prestigio ai teatri itineranti all’aperto. Per oltre un decennio quattro strutture mobili – tre per la prosa e una per la lirica – trasportate su camion autosufficienti (con sedie per il pubblico, camerini per attori, cantanti e orchestrali, un generatore di energia elettrica, un palcoscenico sormontato da una cupola Fortuny per gli effetti di luce) percorsero la penisola, rendendo fruibile un patrimonio, fino ad allora riservato ai teatri importanti e alle grandi città. Tra il 1930 e il 1935 si svolsero in media duecento recite per ogni stagione estiva. Nel 1936 gli spettatori ammontarono complessivamente a oltre un milione.
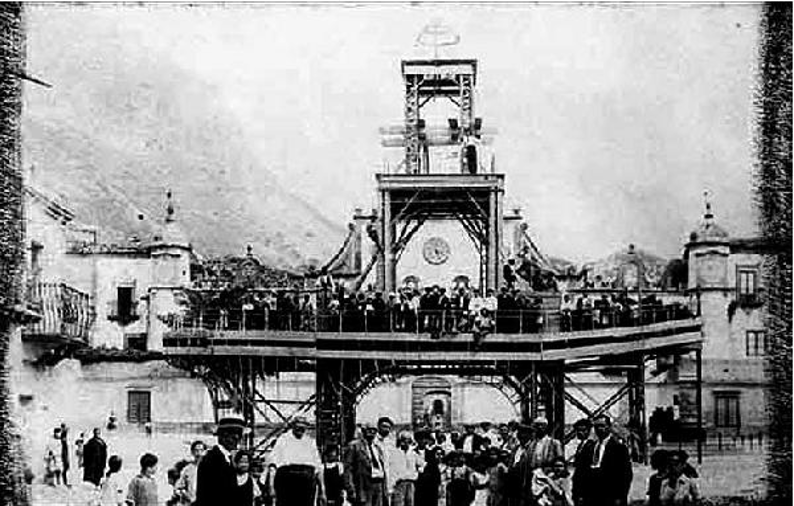
Le rappresentazioni cessarono con lo scoppio della guerra. Non ripresero nemmeno al termine del conflitto. Archivi, biblioteche, musei, teatri erano stati danneggiati. Alcuni degli spazi superstiti, già adibiti a rifugio per sfollati, furono trasformati in cinema o sale da ballo, per fornire divertimento a buon prezzo. L’industria cinematografica si adeguò, anche perché attori e cantanti famosi stentavano a trovare lavoro.
I film-opera degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, tratti in grandissima parte dal patrimonio musicale italiano otto-novecentesco, sono considerati lavori minori di registi, che forse sono ricordati per prodotti di maggiore impegno. Eppure gran parte di questi autori, a contatto con una materia, per alcuni versi sfuggente, per altri codificata da una tradizione, che non permetteva eccessivi svolazzi o gratuite trasgressioni – a differenza di quanto accade oggi – rivelano una perizia autentica, da veri professionisti. I loro lavori assolvono a una funzione storica e culturale importante. Come era accaduto con i Carri di Tespi, l’opera va verso la gente, auspice il cinema, mezzo di comunicazione alla portata di tutti.
Ma poteva il pubblico, che cominciava a familiarizzarsi con i capolavori del neorealismo, accostarsi alle vicende buffe e sentimentali di Figaro, del conte d’Almaviva e di Rosina, della sonnambula Amina, di Nemorino, di Adina e del dottor Dulcamara? Si sarebbe mai appassionato ai tragici racconti di “Traviata”, “Tosca”, “La Bohème”, “Madama Butterfly”, “Cavalleria rusticana”, “Pagliacci”, che, pur affrontando i temi universali del male di vivere, della gelosia e del tradimento, sembravano estranei al comune sentire?
Quasi tutti i registi “aspergono di soavi licor gli orli del vaso”. Accanto al fior fiore dei cantanti d’opera (Tito Gobbi, Ferruccio Tagliavini, Mario Del Monaco, Tito Schipa, Nelly Corradi, Fedora Barbieri, Ebe Stignani, Giulietta Simionato) chiamano attori affermati o promettenti (Amedeo Nazzari, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Gino Cervi, Vittorio De Sica, Massimo Serato, Antony Quinn, Rossano Brazzi, Pierre Cressoy, Paolo Carlini, Aldo Silvani, Cesco Baseggio, Raf Vallone, Pierre Brasseur, Michel Simon, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Monica Vitti, Antonella Lualdi, Anna Magnani, Pina Cei, Elisa Cegani, Olga Villi, Alida Valli, Rina Morelli, per citare i maggiori). Cercano di dare credibilità a storie improponibili, come la rossiniana “Cenerentola”. Ricorrono a “location” suggestive, fuori dai teatri, accuratamente tenute segrete. Affidano le musiche a orchestre prestigiose (Orchestra e Coro dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), a compositori e direttori di qualità (Alessandro Cicognini, Giuseppe Morelli, Tullio Serafin, Francesco Molinari Pradelli, Fernando Previtali, Luigi Gui, Oliviero De Fabritiis, Franco Ferrara, l’astro nascente Bruno Maderna). Ravvivano la grande tradizione musicale italiana, che rischiava di essere perduta. La confezione è tutt’altro che scadente, anche se la produzione successiva (di venti e trenta anni dopo: il “Flauto Magico di Bergman- Mozart”, il “Don Giovanni” storicizzato di Losey, i sontuosi e raffinati lavori di Zeffirelli), realizzata con maggiore disponibilità di risorse e di mezzi, con la partecipazione di attori-cantanti di rilievo (uno per tutti Ruggero Raimondi), sembra oscurare la precedente. Ma non completamente, perché i nomi di geniali artigiani e di almeno tre registi di valore (Carmine Gallone, Mario Costa, Camillo Mastrocinque) sono degni di figurare in qualsiasi repertorio.
E’ difficile definire i confini di un genere, che raramente comporta la pura e semplice trasposizione sullo schermo dell’opera lirica, nata per il teatro, soggetta a determinate convenzioni e a codici stilistici ben delineati. Non senza qualche titubanza, abbiamo usato il termine “film d’opera” in senso lato, includendovi le opere trasferite sullo schermo con veri cantanti (in qualche caso doppiati da altri cantanti), o con attori doppiati da cantanti, o con attori e cantanti, che agiscono insieme. Abbiamo incluso nella filmografia, tra le altre, le biografie cinematografiche – spesso liberamente romanzate – di grandi musicisti del passato (tra cui “Melodie eterne” e “Casa Ricordi” di Carmine Gallone, “Arte e amori di Gioachino Rossini” di Mario Bonnard e un autentico ‘gioiello’, “Torna, caro ideal!”, di Guido Brignone, sul compositore Francesco Paolo Tosti).
FILMOGRAFIA
PIERO BALLERINI (1901-1955)
Nel 1943 si trasferisce a Venezia, dove sono installati due studi cinematografici. Sua è la regia di “Un fatto di cronaca”, l’ultimo film interpretato da Osvaldo Valenti e Luisa Ferida. Nel dopoguerra riprende la sua attività di regista e sceneggiatore con pellicole di carattere commerciale.
1942 – LA SONNAMBULA
Regia: Piero Ballerini. Sceneggiatura: Pietro Ballerini, Domenico Valinotti, Carlo Salsa. Fotografia: Antonio Marzari. Musiche: Nino Piccinelli. Cast: Angelo Alessi, Luisella Beghi, Ernesto Conti, Desiderata Ferrero, Ermanno Filano.
È la storia d’amore fra Vincenzo Bellini e la contessina Ornella, affetta da sonnambulismo. Il musicista compone una romanza per lei morente, che diventerà protagonista di una delle sue opere più rinomate.

1946 – LUCIA DI LAMMERMOOR
Regia: Piero Ballerini. Sceneggiatura: Piergiuseppe Franci e Piero Ballerini. Fotografia: Mario Albertelli. Cast: Nelly Corradi (Lucia), Mario Filippeschi, Italo Tajo, Adelio Zagonara, Loretta Di Lelio. Musiche: Gaetano Donizetti. Orchestra e Coro del Teatro di Roma. Direttore d’orchestra: Oliviero De Fabritiis. Maestro del Coro: Giuseppe Conca.
Le recensioni rilevano la riproduzione quasi integrale dell’opera, purtroppo penalizzata dal sonoro. Molto belle le location (si ignora dove siano state fatte le riprese).
CESARE BARLACCHI
Conosciuto come regista di opere liriche, attività che svolge dalla seconda metà degli anni Trenta (spesso al Regio di Parma), si dedica anche al cinema, dapprima come documentarista. Esordisce nel lungometraggio con “L’ombra della valle” (1946).
1952 – LA FAVORITA
Regia: Cesare Barlacchi. Musiche: Gaetano Donizetti. Direttore d’orchestra: Graziano Mucci. Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Cast: Gino Sinimberghi, Sofia Lazzaro (poi Sophia Loren, con voce di Palmira Vitali Marini), Paolo Silveri, Franca Tamantini, Alfredo Colella, Giorgio Costantini.
Le voci liriche “prestate” agli attori non cantanti non sono particolarmente apprezzate dai critici.
1952 – LA SONNAMBULA
Regia e sceneggiatura: Cesare Barlacchi. Fotografia: Carlo Carlini. Musiche: Vincenzo Bellini. Direttore d’orchestra: Graziano Mucci. Coro della RAI diretto da Gennaro D’Angelo. Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Cast: Gino Sinimberghi (il conte), Franca Tamantini (Lisa), Alfredo Colella (Alvino), Paola Bertini (Amina).
Secondo il critico A. Albertazzi (“Intermezzo”, n. 9/10, 31.5.1952), nonostante l’inevitabile staticità, gli interpreti sono ben diretti e ben doppiati nel canto.
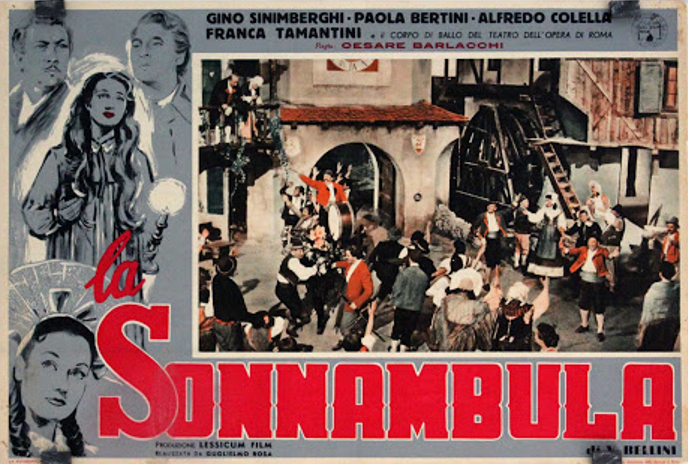
MARIO BONNARD (1889 -1965)
È attivo in veste di attore dai tempi del muto, in ruoli brillanti e languidi, che ispireranno il Gastone di Petrolini. Lavora a lungo in Germania. Ritorna in Italia nel 1932. Si rivela un ottimo professionista, attento ai gusti del pubblico. Spazia dalla commedia al film storico, dal melodramma al “peplum”, all’impegnato. Con “La città dolente” (1948) documenta l’esodo di Pola. “Gli ultimi giorni di Pompei” (1959), film interrotto per malattia, fu portato a termine da Sergio Leone. Era il fratello minore del compositore di colonne sonore Giulio Bonnard.
1942 – ROSSINI (ARTE E AMORI DI GIOACHINO ROSSINI)
Regia: Mario Bonnard. Soggetto: Alfredo Ponchielli. Sceneggiatura: Parsifal Bassi, Luigi Bonelli, Mario Bonnard, Luciano D’Oria, Gherardo Gherardi, Vittorio Gui, Alberto Luchini, Vittorio Nino Novarese, Edoardo Nulli. Fotografia: Mario Altobelli. Montaggio: Renzo Lucidi. Scenografia: Piero Filippone, Saverio Fino. Costumi: Vittorio Nino Novarese. Musiche: Gioachino Rossini, selezionate da Vittorio Gui e dirette da Fernando Previtali. Voci: Gianna Pederzini, Tancredi Pasero. Cast: Nino Besozzi (Rossini), Paola Barbara (Isabella Colbran), Camillo Pilotto (Domenico Barbaja), Armando Falconi (re Ferdinando II di Borbone), Memo Benassi (Beethoven), Cesare Fantoni (Paganini), Paolo Stoppa (Andrea Leone Tottola).
“Forse il Rossini di questo film non ha le caratteristiche del vero genio, ma è un genio addomesticato dall’aneddoto” (Dino Falconi, “Il Popolo d’Italia”, 10.1.1943).

GUIDO BRIGNONE (1886 – 1959)
Nato da una famiglia di artisti. Suo padre era l’attore Giuseppe Brignone e sua sorella l’attrice Mercedes Brignone. Sua figlia, Lilla Brignone, è stata una delle più celebri attrici teatrali e televisive del dopoguerra. Esordisce come regista cinematografico nel muto. Con il sonoro firma lavori di ampio successo commerciale e nel 1934 è il primo regista italiano a vincere la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, con il film “Teresa Confalonieri”. È autore di “feuilleton” in costume, melodrammi sentimentali, polizieschi (il primo regista italiano a cimentarsi con questo genere), avventurosi e “peplum”.
1932 – LA WALLY
Dal romanzo di Wilhelmine von Hillern. Regia: Guido Brignone. Sceneggiatura: Gian Bistolfi. Fotografia: Ubaldo Arata. Montaggio: Giorgio Simonelli. Scenografia: Gastone Medin, Ivo Perilli. Musiche: Alfredo Catalani. Cast: Germana Paolieri (Wally), Isa Pola, Carlo Ninchi, Achille Majeroni, Renzo Ricci.
Secondo il critico Mario Gromo (“La Stampa”, 22.1.1932) è un film degno di rispetto, che mostra “scolastica diligenza e buon impegno dei mezzi sonori”. Le doti del regista “esperto e volonteroso, si manifestano in qualche tocco delicato”.
1932 – PERGOLESI
Regia: Guido Brignone. Soggetto e sceneggiatura: Gian Bistolfi. Fotografia: Ubaldo Arata, Domenico Scala, Anchise Brizzi. Musiche di Giovan Battista Pergolesi, selezionate da Vittorio Gui e dirette da Fernando Previtali. Scenografia: Giovanni Spallani. Cast: Elio Steiner (Pergolesi), Dina Pola, Tina Lattanzi, Livio Pavanelli, Carlo Lombardi, Romolo Costa, Giacomo Almirante, Mina d’Albore, Laura Pasini, Vincenzo Bettoni, Lydia Simoneschi.
Film di pura fantasia, pregevole per la ricostruzione dell’ambiente settecentesco.

1939 – TORNA, CARO IDEAL!
Regia: Guido Brignone. Soggetto: Ettore Maria Margadonna, Aldo Vergano. Fotografia: Tino Santoni. Montaggio: Vincenzo Zampi. Musiche: Francesco Paolo Tosti, dirette da Guido Albanese ed Ettore Montanaro. Scenografia: Ottavio Scotti. Costumi: Gino Carlo Sensani, Maria De Matteis. Cast: Claudio Gora (Francesco Paolo Tosti), Laura Adani (Maria Vernowska), Germana Paolieri, Ernesto Sabbatini, Carlo Lombardi, Achille Majeroni, Giovanni Onorato, Cesare Polacco, Mercedes Brignone.
“Il film è lineare e patetico nella sua fluida spontaneità. Brignone vi ha messo accenni di commozione sincera e tocchi ambientali (la tappa al “convento” michettiano di Francavilla al Mare è felicemente raccontata) d’efficacia sicura” (Achille Vesce, “Il Mattino”, 24.12.1939).
“Non era facile rievocare l’ambiente mondano e artistico dell’epoca in cui visse e operò Francesco Paolo Tosti. Brignone ha mostrato molto gusto e misura nell’allestire la decorosa e decorativa scena. Le divagazioni paesistiche e ambientali sono animate su uno sfondo musicale, che si bea, in un rigurgito di sentimentalismo e malinconia, dell’onda ora lenta e commossa, ora travolgente e drammatica, della vena melodica di Tosti” (Francesco Callari, “Film”, 30.12.1939).
1943 – MARIA MALIBRAN
Regia: Guido Brignone. Soggetto: Guido Cantini, Franco Riganti. Sceneggiatura: Franco Riganti, Thea von Harbou, Tomaso Smith. Musiche di Vincenzo Bellini e Gioachino Rossini, adattate da Renzo Rossellini e dirette da Luigi Ricci. Scenografia: Virgilio Marchi. Costumi: Ilse Naumann. Cast: Maria Cebotari (Maria Malibran), Rossano Brazzi, Renato Cialente, Rina Morelli, Loris Gizzi (Rossini), Roberto Bruni (Bellini), Silvia De Bettini, Tina Lattanzi, Aldo Silvani, Armando Migliari, Amilcare Pettinelli.
È la biografia romanzata della celebre soprano franco-spagnolo. Il film è stato girato negli stabilimenti romani di Cinecittà. “Un film dignitoso, corretto, decorativamente ineccepibile” (Sandro De Feo, “Il Messaggero”, 7.4.1943).
MAX (Massimo) CALANDRI (1906 – …)
Sceneggiatore e regista, negli anni Trenta inizia la sua attività come aiuto regista e direttore di produzione. Nel 1943 si trasferisce al nord per lavorare a Venezia, al Cinevillaggio della Giudecca, dove dirige, nel 1944, il suo primo film, “Rosalba”, insieme al regista Ferruccio Cerio. Nel dopoguerra gira film, spesso ambientati a Venezia, per chiudere la carriera nel 1959.
1947 – LOHENGRIN
Regia: Max Calandri. Sceneggiatura: Piero Ballerini, Gian Maria Cominetti. Fotografia: Giuseppe Caracciolo. Cast: Antonio Cassinelli (Lohengrin, voce Giacinto Prandelli), Giulio Oppi, Jacqueline Plessis (Elsa di Brabante, voce Renata Tebaldi), Inge Borg (Ortuda, voce Elena Nicolai), Giampiero Malaspina, Giuseppe Modesti, Attilio Ortolani (Telramondo, voce Antonio Cassinelli), Leonardo Severini.
È la trasposizione cinematografica dell’opera di Wagner, ripresa in teatro (traduttore Salvatore Marchesi). La riduzione musicale è di Bruno Maderna (1920-1973). La scenografia è di Luigi Scaccianoce (1914-1981), collaboratore, tra gli altri, di Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini e Dino Risi. L’Anonimo di “Segnalazioni Cinematografiche” (vol. XXIV, 1948) nota la lentezza nello svolgimento “.

FLAVIO CALZAVARA (1900-1981)
Laureato in Scienza del diritto e attratto dal mondo dello spettacolo si trasferisce nel 1927 in Argentina. Torna in Italia nel 1933 e diviene assistente alla regia di Alessandro Blasetti e Romolo Marcellini. Esordisce nella regia nel 1939 con “Piccoli naufraghi”, ben recensito sulla rivista “Cinema” dal giovane Michelangelo Antonioni. Lavora in quattro film con Doris Duranti, attrice di punta del regime, che in “Carmela” (1942) si strappa la camicetta, rimanendo a seno nudo (qualche mese dopo Clara Calamai, nella “Cena delle beffe”, diretta da Blasetti). Dopo il 1950 lavora a film con tematiche popolari, drammi sentimentali e commedie musicali.
1954 – RIGOLETTO E LA SUA TRAGEDIA
Regia: Flavio Calzavara. Sceneggiatura: Flavio Calzavara, Paola Ojetti, Jacopo Corsi. Cast: Gérard Landry (duca di Mantova), Janet Vidor (Gilda), Aldo Silvani (Rigoletto), Gualtiero Tumiati (Monterone), Cesare Polacco (Sparafucile). Cantanti: Mario Del Monaco, Tito Gobbi, Giuseppina Arnaldi.
I critici sottolineano la buona caratterizzazione di Rigoletto.

FERNANDO CERCHIO (1914-1974)
Nel 1938 entra nell’Istituto Luce come montatore e dopo un paio d’anni inizia a dirigere per lo stesso ente alcuni documentari (tra cui “Comacchio”). Lavora al suo primo lungometraggio (“La buona fortuna”) per proseguire, nel dopoguerra, con prodotti destinati al grande pubblico, come i film mitologici della fine degli anni Cinquanta.
1948 – CENERENTOLA (Uscita originale 14.5.1949)
Regia: Fernando Cerchio. Musiche: Gioachino Rossini. Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma dir. Oliviero De Fabritiis. Burattini di Maria Signorelli. Cast: Lori Randi, Gino Del Signore, Afro Poli, Vito De Taranto, Fiorella Carmen Forti, Franca Tamantini, Enrico Formichi, Ugo Marchi, Giuliana Rivera, Tina Zucchi. Cantanti: Fedora Barbieri, Fernanda Cadoni Azzolini.
Gli interni sono stati girati nel Palazzo Reale di Torino, gli esterni nei castelli di Stupinigi e di Tolcinasco e nel Palazzo Reale di Monza.
“L’adattamento cinematografico non ha tolto a ‘Cenerentola’ nulla della sua scintillante gaiezza: anzi gli ha portato magia di sfondi e varietà di ritmi figurativi. Da cui un’alacrità e una festevolezza che non derivano soltanto dall’argomento, ma sono sollecitate, scena per scena, dall’industrioso regista” (Recensione su “La Stampa”, 12.3.1949). Per A. Albertazzi (“Intermezzo”, n. 8/9, 15.5.1949) è un film “decoroso e accurato”.

MARIO COSTA (1904-1995)
Inizia a lavorare nel cinema negli anni Venti. Nel 1938 dirige il documentario “Le fontane di Roma”. Del 1943 è il primo lungometraggio, “La sua strada”. È considerato uno specialista del genere, che coltiva nel dopoguerra.
1946 – L’ELISIR D’AMORE (Uscita originale 31.1.1947)
Regia: Mario Costa. Adattamento cinematografico e sceneggiatura di Mario Costa, con la collaborazione di Alessandro Cicognini. Fotografia: Mario Bava. Musiche: Gaetano Donizetti. Direzione musicale: Alessandro Cicognini, Giuseppe Morelli. Maestro del Coro: Gennaro D’Angelo. Cast: Gino Sinimberghi (Nemorino), Nelly Corradi (Adina), Tito Gobbi (Belcore), Italo Tajo (Dulcamara), Loretta Di Lelio (Giannetta). Tra le comparse Gina Lollobrigida e Silvana Mangano.
Film realizzato a guerra ancora in corso, non valutato positivamente dai critici, anche per la mediocre qualità del sonoro. Le voci di Gino Sinimberghi , Nelly Corradi (notata da Max Ophuls per il film “La signora di tutti”), Tito Gobbi e Italo Tajo sono considerate inadeguate.
1946 – IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Regia: Mario Costa. Sceneggiatura: Mario Costa, Paolo Salviucci, Carlo Castelli. Sceneggiatore (non accreditato): Cesare Zavattini. Fotografia: Massimo Terzano. Operatore: Mario Bava. Musiche: Gioachino Rossini. Direttore d’orchestra: Giuseppe Morelli. Cast: Ferruccio Tagliavini (conte d’Almaviva), Tito Gobbi (Figaro), Nelly Corradi (Rosina), Vito De Taranto (don Bartolo), Italo Tajo (don Basilio).
“E’ la prima volta – scrive il critico di ‘Segnalazioni cinematografiche’- che un’opera lirica viene interpretata cinematograficamente, pur senza del tutto rifiutare l’impostazione teatrale, con soluzioni sceniche e mimiche, che ottengono le risultanze più lusinghiere. Soprattutto dal punto di vista di una più vasta diffusione del patrimonio musicale, in edizioni affidate a complessi di primissimo piano”.
1948 – PAGLIACCI (AMORE TRAGICO)
Regia: Mario Costa. Musiche: Ruggero Leoncavallo. Soggetto: Sinclair Lewis (è il primo statunitense ad ottenere il Premio Nobel per la letteratura). Sceneggiatura: Carlo Castelli, Anton Giulio Majano, Mario Costa. Fotografia: Mario Bava. Montaggio: Otello Colangeli. Cast: Gina Lollobrigida, Nedda (voce Onelia Fineschi), Afro Poli, Canio (voce Galliano Masini), Tito Gobbi, Tonio e Silvio, Filippo Morucci, Beppe (voce Gino Sinimberghi).
Prendendo lo spunto da episodi della vita di Leoncavallo, il film riporta alla prima della sua opera più famosa. “Mario Costa ha acquistato una tale sicurezza nel riprendere le opere liriche che pochi altri potrebbero competere con lui nello stesso genere” (“Intermezzo”, n. 8/9 del 15.5.1949).

GIUSEPPE FATIGATI (1906-1975)
Inizia a lavorare per il cinema come aiuto regista, poi come organizzatore e direttore di produzione. Approda alla regia nei primi anni Quaranta.
1943 – PAGLIACCI
Basato sull’opera di Ruggero Leoncavallo, il film viene girato a Montalto Uffugo (Cosenza) e a Berlino. E’ realizzato in due versioni, tedesca e italiana.
Regia: Giuseppe Fatigati. Sceneggiatura: Harald Bratt, Cesare Giulio Viola. Fotografia: Fritz Arno Wagner. Musiche: Ruggero Leoncavallo, Vincenzo Bellini, Luigi Ricci. Direttori d’orchestra: Werner Pledath, Willy Schmidt-Gentner. Cast: Beniamino Gigli (Canio), Alida Valli (Giulia), Paul Horbiger (Canio, suo padre), Carlo Romano (Ruggero Leoncavallo). Cantanti: Beniamino Gigli, Adelio Zagonara, Leone Paci, Mario Boviello, Adriana Perris.
E’ una ricostruzione della genesi dell’opera. Il padre di Leoncavallo era un magistrato napoletano, che lavorava in Calabria, dove si trovò a giudicare un omicidio del quale era stato testimone il figlio. Nel film Canio torna a casa, dopo aver scontato venti anni di galera e trova la figlia Giulia, ormai ventenne, ignara del suo passato e prossima alle nozze. Sarà il non ancora famoso musicista a raccogliere lo sfogo di Canio e a condurre a buon fine la vicenda. Nel frattempo compone l’opera che, rappresentata nel finale, renderà cosciente Giulia del dramma vissuto da bambina. Carlo Romano, che interpreta Leoncavallo, è il doppiatore di Fernandel (don Camillo) e dei “messicani” dei film di Sergio Leone.
“L’intreccio biografico-romanzesco è abbastanza ingegnoso, ma la realizzazione è alquanto meccanica e convenzionale” (“Segnalazioni cinematografiche”, vol. 17, 1943).

CLEMENTE FRACASSI (1917-1993)
Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, alla fine degli anni Trenta inizia a lavorare nel cinema, come aiuto regista di Mario Camerini e Mario Soldati. Chiamato a sostituire quest’ultimo, esordisce nella regia con “Romanticismo” (1950). Dirige Marcello Mastroianni in “Sensualità” (1952) e Sophia Loren in “Aida” (1953).
1953 – AIDA
Regia: Clemente Fracassi. Sceneggiatura: Carlo Castelli, Clemente Fracassi, Anna Gobbi, Giorgio Salviucci. Fotografia: Piero Portalupi, Pasqualino De Santis. Musiche: Giuseppe Verdi. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI è diretta da Giuseppe Morelli. Cast: Sophia Loren (Aida, dopp. Renata Tebaldi), Lois Maxwell (Amneris, dopp. Ebe Stignani), Luciano Della Marra (Radames, dopp. Giuseppe Campora), Afro Poli (Amonastro, dopp. Gino Bechi), Antonio Cassinelli (Ramfis, dopp. Giulio Neri). Afro Poli e Antonio Cassinelli, pur essendo cantanti, sono doppiati.
È la trasposizione cinematografica – mancante di alcune parti e con l’inserzione di una voce narrante- dell’omonima opera verdiana. Il film è stato edito a colori negli USA e in Francia.
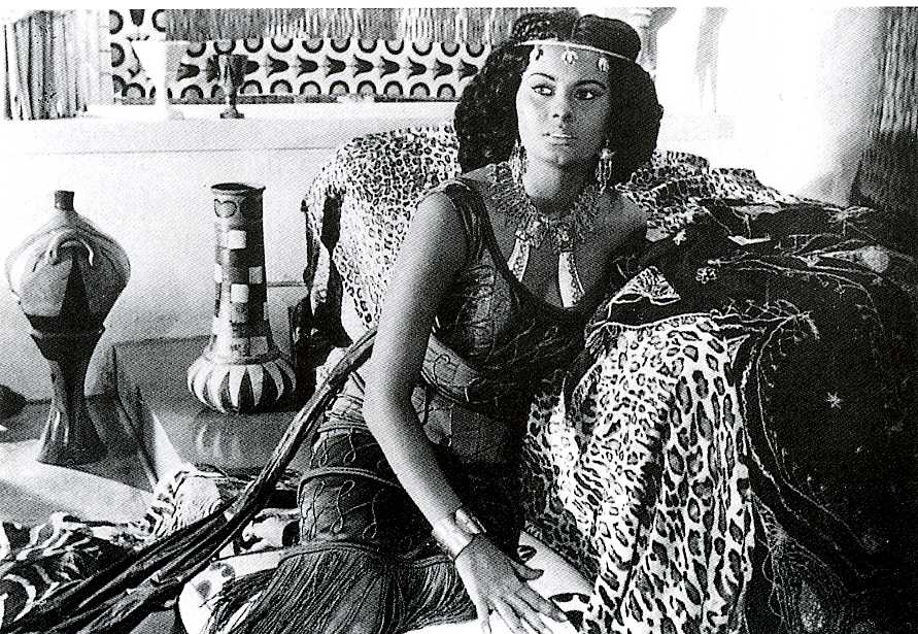
1955 – ANDREA CHENIER
Regia: Clemente Fracassi. Sceneggiatura: Clemente Fracassi, Jacques Rémy, Anna Gobbi. Musiche: Umberto Giordano, Giulio Cesare Sonzogno. Cast: Raf Vallone (Gerard), Antonella Lualdi (Madeleine de Coigny), Michel Auclair (Andrea Chénier), Sergio Tofano, Antonio Piefederici, Rina Morelli.
È l’unica versione cinematografica dell’opera di Giordano, distribuita solo in Francia. Realizzata con notevole larghezza di mezzi e ottimamente fotografata, il film non ottenne lo sperato successo commerciale.
“La regia non ha saputo conferire all’azione il calore e il ritmo necessari”, annota U. Tani (“Intermezzo”, 24-31.12.1956).
CARMINE GALLONE (1885-1973)
È un intellettuale in senso compiuto. Compie studi classici, conosce le lingue, si apre alla cultura europea. Scrive testi drammatici e si trasferisce a Roma per seguire la vocazione teatrale come autore, traduttore e attore. Lavora, oltre che in Italia, in Francia, Germania, Inghilterra e Austria. È conosciuto per i suoi film musicali e per quelli storici, improntati all’esaltazione della romanità (è stato paragonato a Cecil B. De Mille). Non si accontenta di mettere semplicemente in scena l’opera lirica. Cambi di ambientazione, sequenze in esterni, personaggi aggiunti, azione a sufficienza e la voce del narratore fanno la differenza, rispetto ad una banale trasposizione su pellicola dell’originale.
“È indubbio che nelle sue biografie filmate Gallone ha molto da farsi perdonare, per quanto riguarda la verità storica, ma i suoi personaggi sono essi stessi personaggi da melodramma. Questi racconti vogliono essere ‘nazional-popolari’, rivolti cioè ad un vasto e indifferenziato pubblico che magari non frequenta il teatro lirico, anche se conosce l’opera. (…) Gallone non ha nulla da invidiare ai colleghi hollywoodiani che si sono dedicati ad imprese simili alle sue; lui è anzi più ricco, più variato e anche più rispettoso, tutto sommato, delle fonti cui si è ispirato. Lui è innamorato e alfiere della musica dell’opera lirica in tutte le sue forme. In un suo intervento durante un convegno veneziano del 1959 affermò che ‘l’avvento dello spettacolo lirico assoluto sullo schermo non è stato occasionale, ma bensì una logica conseguenza degli svolgimenti musicali del cinema’. Mentre noi distinguiamo tra ‘mélo’ e ‘melodramma’, Gallone non separa tali dimensioni, nel senso che tutti i suoi film-con-musiche (veri e propri mélo, biografie, opere, opere parallele) sono dei drammi a forti tinte e di passioni accese di cui la musica fornisce una risonanza amplificatrice, ne esalta la componente emozionale” (Ermanno Comuzio, “Carmine Gallone. Il re dell’opera alla sbarra. La parola alla difesa”, in “Il melodramma al cinema. Il film-opera croce e delizia”, a cura di Sebastiano Gesù, Catania, Giuseppe Maimone Editore, 2009).
1935 – CASTA DIVA
Regia: Carmine Gallone. Sceneggiatura: Walter Reisch, Corrado Alvaro (dialoghi). Fotografia: Franz Planer, Massimo Terzano. Musiche: Willy Schmidt-Gentner. Cast: Martha Eggert (Maddalena Fumaroli), Sandro Palmieri (Vincenzo Bellini), Gualtiero Tumiati (Niccolò Paganini), Achille Majeroni (Gioachino Rossini), Giulio Donadio (Felice Romani), Gino Viotti (Maestro Zingarelli).
Il film racconta in modo romanzesco (la trama è quasi completamente inventata) la giovinezza di Vincenzo Bellini.

1938 – GIUSEPPE VERDI (DIVINE ARMONIE)
Regia: Carmine Gallone. Soggetto e sceneggiatura: Lucio D’Ambra, Carmine Gallone. Musiche: Giuseppe Verdi. Cast: Fosco Giachetti (Giuseppe Verdi), Gaby Morlay (Giuseppina Strepponi), Germana Paolieri (Margherita Barezzi), Camillo Pilotto (Andrea Barezzi), Cesco Baseggio (il padre di Verdi), Lamberto Picasso (Gaetano Donizetti), Pierre Brasseur (Alexandre Dumas figlio), Gabriel Gabrio (Honoré de Balzac), Henri Rollan (Victor Hugo), Gianni Agus, Beniamino Gigli.
La vita del compositore e le sue opere più importanti, fra cui spicca “Nabucco”. Uno dei maggiori successi del 1938.
1939 – IL SOGNO DI BUTTERFLY
Regia: Carmine Gallone. Soggetto: Ernst Marischka. Sceneggiatura: Guido Cantini. Fotografia: Anchise Brizzi, Alberto Fusi. Musiche: Giacomo Puccini. Cast: Maria Cebotari (Rosa e Madame Butterfly), Fosco Giachetti, Germana Paolieri, Lucie Englisch, Luigi Almirante, Paolo Stoppa, Tito Gobbi, Saro Urzì.
La tragica vicenda di Butterfly si rinnova in quella di una cantante lirica, abbandonata con un figlio da un direttore d’orchestra americano.
1940 – AMAMI ALFREDO
Regia: Carmine Gallone. Soggetto: Guido Cantini. Sceneggiatura: Carmine Gallone, Guido Cantini. Fotografia: Anchise Brizzi. Musiche: Giuseppe Verdi. Cast: Luigi Almirante, Aristide Baghetti, Maria Cebotari, Lucie English, Claudio Gora, Paolo Stoppa.
È la storia d’amore fra una celebre cantante malata e uno sconosciuto compositore (Giuseppe Verdi). Fra i personaggi storici Arrigo Boito.

1940 – MANON LESCAUT
Regia: Carmine Gallone. Sceneggiatura: Guido Cantini, Carmine Gallone. Fotografia: Anchise Brizzi. Musiche: Giacomo Puccini. Le romanze dell’opera sono cantate da Maria Caniglia. Cast: Alida Valli (Manon Lescaut), Vittorio De Sica (Renato Des Grieux), Lamberto Picasso (Visconte Des Grieux), Giulio Donadio (marchese De Brienne), Dini Di Luca (sergente Lescaut), Jole Valer (Musette).
“Il regista si è appropriato della favola, vi ha giocato con l’arbitrio legittimo della sua fantasia di poeta e ha mirato a toccare il cuore delle folle. Difetto? Non direi: ché a questo risultato vi giunge con misurata ricerca degli effetti, con l’ausilio delle melodie di sfondo, con la tavolozza delicata dei suoi pastelli” (Ottavio Profeta, “Il Popolo di Sicilia”, 15.2.1940).
1940 – MELODIE ETERNE
Regia: Carmine Gallone. Soggetto e sceneggiatura: Ernst Marischka, Guido Cantini. Musiche di W.A. Mozart e L. van Beethoven, adattate da Alessandro Cicognini. Direttore d’orchestra: Luigi Ricci. Canzoni e romanze cantate da Margherita Carosio. Cast: Gino Cervi (Mozart), Claudio Gora (Giuseppe II), Conchita Montenegro (Aloisia Weber), Luisella Beghi (Costanza Weber), Jone Salinas (Nannina Mozart), Paolo Stoppa (Harbel), Lauro Gazzolo (Deiner), Luigi Pavese (Leopoldo Mozart), Giulio Donadio (Schikaneder), Maria Jacobini (Anna Maria Mozart), Sandro Ruffini (l’uomo che commissiona il “Requiem”), Augusto Marcacci (Salieri), Cesare Polacco (Haydn).
Il film ripercorre, in maniera romanzata, la vita di W.A. Mozart, interpretato da Gino Cervi (1901-1974). “Un Gino Cervi piuttosto in carne non appare un Mozart ideale, ma il film è abbastanza fedele ai fatti e il finale (con il compositore a letto malato che prova pagine del ‘Requiem’ con amici musicisti) forse ha ispirato la soluzione di ‘Amadeus’ di Milos Forman” (Ermanno Comuzio, “Carmine Gallone. Il re dell’opera alla sbarra. La parola alla difesa”, cit.).

1946 – AVANTI A LUI TREMAVA TUTTA ROMA
Regia: Carmine Gallone. Soggetto: Carmine Gallone. Sceneggiatura: Carmine Gallone, Gherardo Gherardi, Gaspare Cataldo. Fotografia: Anchise Brizzi. Musiche: Giacomo Puccini. Cast: Anna Magnani, Tito Gobbi, Hans Hinrich, Gino Sinimberghi, Edda Albertini, Guido Notari, Carlo Duse, Tino Scotti, Ave Ninchi.
La “Tosca” di Puccini fa da sfondo alla storia di due cantanti lirici, fidanzati e compagni di lavoro, che partecipano alla Resistenza romana, in attesa degli alleati.
“Statica e teatrale la parte operistica vista con l’occhio scialbo del documentario; facile, lenta, grossolana l’umana vicenda, che parallelamente si svolge” (“Il Tempo”, 8.12.1946).
1946 – RIGOLETTO
Regia: Carmine Gallone. Soggetto: Victor Hugo, Francesco Maria Piave. Sceneggiatura: Carmine Gallone. Musiche: Giuseppe Verdi. Maestro concertatore e direttore dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma: Tullio Serafin. Cast: Tito Gobbi (Rigoletto), Marcella Govoni (Gilda, voce di Lina Pagliughi), Mario Filippeschi (duca di Mantova), Giulio Neri (Sparafucile), Marcello Giorda (Monterone), Roberto Bruni (Borsa), Virgilio Gottardi (Marullo).
Fu il maggiore incasso cinematografico in Italia nella stagione 1946-47.
1947 – ADDIO MIMI’
Regia: Carmine Gallone. Sceneggiatura: Carmine Gallone, Hamilton Benz, Rowland Leigh. Fotografia: Arturo Gallea. Cast: Martha Eggerth, Jan Kiepura.
Storia d’amore fra due giovani cantanti polacchi. Lei è ammalata come Mimì e muore mentre canta insieme al suo amato nell’ultima scena della “Bohème”.
“Il duo Heggerth – Kiepura dà sfogo a tutte le già notevolissime possibilità canore. Diretto con il solito dignitoso mestiere, il film si presta a una buona messe di sorrisi e di lacrime” (F. Gabella, “Intermezzo”, n. 9/10 del 31.5.1951).

1947 – LA SIGNORA DELLE CAMELIE
Regia: Carmine Gallone. Sceneggiatura: Carmine Gallone, da “La Traviata”, su libretto di Francesco Maria Piave (con l’aggiunta di brani di un presunto diario di Marie Duplessis) . Fotografia: Arturo Gallea. Musiche: Giuseppe Verdi. Direttore d’orchestra: Ettore Panizza. Cast: Tito Gobbi, Nelly Corradi, Gino Mattera, Manfredi Polverosi, Flora Marino, Nerio Bernardi, Massimo Serato. Voci principali: Tito Gobbi, Gino Mattera, Onelia Fineschi.
1947 – LA LEGGENDA DI FAUST
Regia: Carmine Gallone. Dal dramma di Goethe e Charles Gounod, con brani tratti dal “Mefistofele” di Arrigo Boito. Sceneggiatura: Carmine Gallone, Leopold Marchaud. Fotografia: Vaclav Vich, Arturo Gallea. Musiche di Hector Berlioz, Arrigo Boito, Charles Gounod, adattate da Alessandro Cicognini. La voce di Nelly Corradi è di Onelia Fineschi, quella di Cesare Barbetti è di Onofrio Scarfoglio. Cast: Nelly Corradi (Margherita), Thérèse Dorny (Marta), Claudio Ermelli, Guglielmo Leoncini, Gilles Quéant, Gualtiero Tumiati, Italo Tajo, Livia Venturini, Gino Mattera, Cesare Barbetti.
1949 – LA FORZA DEL DESTINO
Regia: Carmine Gallone. Soggetto: Angelo Saavedra. Sceneggiatura: Mario Corsi, Ottavio Poggi, Lionello De Felice. Fotografia: Aldo Giordani. Musiche: Giuseppe Verdi. Direttore d’orchestra: Gabriele Santini. Cast: Nerio Bernardi (don Angelo Saavedra), Paola Dalgas (Dana), Nelly Corradi (donna Leonora, voce Caterina Mancini), Vito De Taranto (fra’ Melidone), Tito Gobbi (don Carlos), John Kitzmiller (scudiero moro), Gino Sinimberghi (voce Galliano Masini), Mira Vargas (voce Cleo Elmo).
“Il film si stacca dagli altri dello stesso genere. Il regista ha cercato di cogliere i momenti essenziali, riuscendo anche ad ottenere particolari effetti, specialmente nelle sequenze finali” (N. Freda, “Hollywood”, n. 237/1950).
1949 – IL TROVATORE
Regia: Carmine Gallone. Pare che l’assistente regista – non accreditato sui titoli di testa – sia stato il giovane Sergio Leone. Soggetto: Marino Onorati. Sceneggiatura: Tullio Covaz, Mario Corsi, Ottavio Poggi, con inserti del poema originale di Antonio Garcia Gutierrez. Fotografia: Aldo Giordani. Musiche: Giuseppe Verdi. Cast: Gianna Pederzini
(Azucena), Vittorina Colonnello (Leonora, voce Franca Sacchi), Gino Sinimberghi (Manrico, voce Antonio Salvarezza), Enzo Mascherini (conte di Luna), Enrico Formichi (Ruiz), Cesare Polacco (Fernando).
Ai critici il film sembra troppo lungo e con una recitazione insufficiente. Ritenuta buona la parte musicale.

1953 – PUCCINI
Regia: Carmine Gallone. Soggetto e sceneggiatura: Carmine Gallone, Leonardo Benvenuti, Glauco Pellegrini, Aldo Bizzarri. Fotografia: Claude Renoir. Montaggio: Rolando Benedetti. Musiche: Giacomo Puccini. Direttori d’orchestra: Francesco Molinari Pradelli, Fernando Previtali. Supervisione musicale: Carlo Rustichelli. Cast: Gabriele Ferzetti (Giacomo Puccini), Marta Torén (Elvira), Nadia Gray (Cristina Vernini), Paolo Stoppa (Giocondo), Myriam Bru (Delia), Sergio Tofano (Giulio Ricordi), Jacques Famery (Antonio Puccini), Carlo Duse (Arrigo Boito), René Clermont (Illica), Oscar Andriani (Giacosa), Mario Feliciani, Gino Sinimberghi, Nelly Corradi, Beniamino Gigli, Rosanna Carteri, Giulio Neri, Antonietta Stella.
La vita del compositore narrata con notevoli licenze. Molto apprezzata la colonna sonora.
1953 – CAVALLERIA RUSTICANA
Regia: Carmine Gallone. Fotografia: Riccardo Pallottini, Karl Struss. Musiche: Pietro Mascagni. Cast: May Britt (Santuzza), Ettore Manni (Turiddu), Kerima (Lola), Anthony Quinn (Alfio), Virginia Balestrieri (Mamma Lucia), Umberto Spadaro (zio Brasi), Grazia Spadaro (zia Camilla).
La novella di Giovanni Verga, pubblicata nel 1883 e messa in scena come atto unico l’anno dopo, è musicata da Pietro Mascagni nel 1890. Quattro le edizioni filmiche nel muto (1909, 1916, 1917, 1924) e un’edizione sonora nel 1939, con la regia di Amleto Palermi. Gallone segue più Mascagni che Verga. Per rendere ancora più decorativa l’azione si avvale della fotografia dello statunitense Karl Struss, utilizzato anche da Chaplin ne “Il grande dittatore” e in “Luci della ribalta”. Il film è distribuito in USA con il titolo “Fatal Desire”.
1954 – MADAMA BUTTERFLY
Regia: Carmine Gallone. Dall’opera omonima di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Sceneggiatura: Carmine Gallone, Yvao Mori. Fotografia: Claude Renoir. Con Kiauru Jacigusa (Madama Butterfly), Nicola Filacuridi (Pinkerton), Michiko Tanaka (Suzuki), Ferdinando Lidonni (Sharplen), Yoshio Kosugi (bonzo), Satoshi Nakamura (Yamadori).
1954 – CASA RICORDI
Regia: Carmine Gallone. Sceneggiatura: Leonardo Benvenuti, Luigi Filippo D’Amico, Agenore Incrocci, Vittorio Nino Novarese, Furio Scarpelli, Carmine Gallone. Fotografia: Marco Scarpelli. Musiche: Riccardo Zandonai. Cast: Paolo Stoppa (Giovanni Ricordi), Renzo Giovampietro (Tito Ricordi), Andrea Checchi (Giulio Ricordi), Roland Alexandre (Rossini), Gabriele Ferzetti (Puccini), Fosco Giachetti (Verdi), Roldano Lupi (Domenico Barbaja), Marcello Mastroianni (Donizetti), Maurice Ronet (Bellini), Marta Toren (Isabella Colbran), Memmo Carotenuto, Lauro Gazzolo, Vira Silenti, Aldo Silvani, Sergio Tofano, Elisa Cegani (Giuseppina Strepponi), Nelly Corradi, Claudio Ermelli, Giuseppe Porelli (non accreditato).
La storia romanzata della grande dinastia di editori musicali e di alcuni protagonisti del melodramma italiano (Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini), tutti passati da Ricordi.

1954 – CASTA DIVA
Regia: Carmine Gallone. Soggetto e sceneggiatura: Luigi Filippo D’Amico, Agenore Incrocci, Léo Joannon, Walter Reisch, Furio Scarpelli, Carmine Gallone. Fotografia: Marco Scarpelli. Musiche: Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Niccolò Paganini. Cast: Antonella Lualdi (Maddalena Fumaroli), Nadia Gray (Giuditta Pasta), Maurice Ronet (Bellini), Fausto Tozzi (Donizetti), Marina Berti (Beatrice Turina), Renzo Ricci (Giudice Fumaroli), Aldo Silvani, Lauro Gazzolo (Domenico Barbaja), Danilo Berardinelli (Paganini), Renzo Giovampietro, Camillo Pilotto.
La biografia romanzata di Vincenzo Bellini. Fuori trama l’incontro con Paganini.
1956 – TOSCA
Regia: Carmine Gallone. Soggetto: Victorien Sardou. Fotografia: Giuseppe Rotunno. Musiche: Giacomo Puccini. Cast: Franca Duval (Floria Tosca, voce Maria Caniglia), Franco Corelli (Mario Cavaradossi), Afro Poli (Scarpia, voce Giangiacomo Guelfi), Vito De Taranto (sacrestano), Fernando Alfieri (Spoletta), Antonio Sacchetti (Cesare Angelotti), Aldo Corelli (Sciarrone), Dino Conti (secondino), Franco Pugliese (voce cantante), Adelio Zagonara (voce cantante).
GIACOMO GENTILOMO (1909-2001)
Dalla natia Trieste si trasferisce a Roma nel 1931, pensando di essere assunto come scenografo. I suoi bozzetti futuristi sono apprezzati, ma trova lavoro solo come segretario di edizione, montatore, sceneggiatore e aiuto regista (con Carlo Ludovico Bragaglia e Mario Mattoli). Diventato regista realizza “Amanti in fuga”, presentato alla prima edizione del Festival di Cannes (1946) e “I fratelli Karamazoff”, premiato, nel 1948, con due Nastri d’argento (migliore sceneggiatura e miglior commento musicale di Renzo Rossellini). I suoi film vanno dalla commedia sentimentale e musicale al giallo-rosa. Dopo la guerra predilige melodrammi popolari e film d’avventura.
1951 – ENRICO CARUSO, LEGGENDA DI UNA VOCE
Regia: Giacomo Gentiluomo. Soggetto: Frank Thiess. Sceneggiatura: Maleno Malenotti, Fulvio Palmieri, Piero Pierotti, Giovanna Soria, Giacomo Gentiluomo. Musiche: Carlo Franci. Cast: Ermanno Randi (Enrico Caruso), Gina Lollobrigida (Stella), Lamberto Picasso (maestro Vergine), Franca Tamantini (soprano Carragi). Mario Del Monaco doppia Caruso nel canto. Gina Lollobrigida è doppiata da Dhia Cristiani, ma doppia, a sua volta, il piccolo Maurizio Di Nardo, che interpreta il cantante da bambino.
Biografia romanzata con notevoli licenze.

1952 – MELODIE IMMORTALI. MASCAGNI
Regia: Giacomo Gentiluomo. Scritto da Maleno Malenotti. Sceneggiatura: Ivo Perilli, Piero Pierotti, Giovanna Soria, Liana Ferri, Giacomo Gentiluomo. Cast: Pierre Cressoy, Carla Del Poggio, Vera Molnar, Mario Del Monaco.
I difficoltosi inizi della carriera del compositore.
ALCUNI ASPETTI DELL’INTRAMONTABILE COMICITÀ DI STANLIO E OLLIO
di Mario Galeotti
Tornati alla ribalta grazie al recente biopic diretto da Jon S. Baird (Stanlio & Ollio, USA/UK/Canada 2018), i comici Stan Laurel (1890 – 1965) e Oliver Hardy (1892 – 1957) non finiscono mai di stupire, divertire ed emozionare anche a distanza di così tanto tempo.
Prendendo spunto dal commovente film biografico uscito anche nelle sale italiane e passando in rassegna la filmografia dell’intramontabile coppia di attori, uno degli aspetti più interessanti che emerge da un’accurata analisi è la natura spesso accidentale e improvvisa degli eventi che scatenano la loro irresistibile comicità.
Le numerose argomentazioni e letture critiche sulle dinamiche della coppia Laurel e Hardy non hanno, a nostro avviso, messo sufficientemente in risalto il peso che l’assoluta casualità degli avvenimenti – in prevalenza incidenti di natura fisica, ma non solo – ha avuto sull’interazione dei due personaggi e sullo svolgimento delle loro storie, dal muto al sonoro, dalle comiche a due rulli ai lungometraggi. Dopotutto, l’incontro stesso dei due attori sul set cinematografico e la nascita della coppia comica più famosa del mondo sono avvenuti per caso, frutto se vogliamo di un evento spontaneo.
Lo scrittore e filosofo francese Georges Bataille, analizzando i motivi scatenanti della risata, ha parlato di elementi imprevedibili e sbalorditivi che causano un “passaggio, brusco e improvviso, da un mondo in cui ogni cosa è ben individuata, data nella sua stabilità, secondo un ordine generalmente stabile, a un mondo in cui tutt’a un tratto la nostra sicurezza è sconvolta e ci rendiamo conto che era ingannevole” (G. Bataille, Non-savoir, rire et larmes, 1953, in Ridere la verità. Scena comica e filosofia, a cura di R. Prezzo, Raffaello Cortina, Milano 1994). Questo passaggio dall’ordine al disordine è l’elemento fondante del cinema comico, fin dall’epoca del muto con le scatenate slapstick comedies, e in particolare di tutta la filmografia di Stanlio e Ollio anche dopo il passaggio ai dialoghi e al medio e lungometraggio. Giorgio Cremonini ha definito questo meccanismo come la “rottura di una logica consequenziale che trascina con sé la logica del reale” (G. Cremonini, Playtime. Viaggio organizzato nel cinema comico, Lindau, Torino 2000, p. 14), dove pertanto viene meno una condizione di coerenza che fino a quel momento sembrava data per certa. Le figure più ricorrenti dei gag visivi, infatti, capovolgono “la nostra visione convenzionale di vedere le cose attraverso la rappresentazione di un mondo alla rovescia”, sovvertendo le relazioni spazio-temporali e mostrandoci “la realtà quotidiana in maniera stranita e straniata” (A. Moscariello, Gag. Guida alla comicità slapstick da Stanlio e Ollio ad Aldo, Giovanni e Giacomo, Dino Audino Editore, Roma 2009, p. 1).

Il punto di rottura, nelle avventure di Laurel e Hardy, può anche derivare da un gesto o da un’azione compiuti in maniera premeditata con l’intento di stravolgere una situazione di calma apparente, ma più spesso scaturisce da un evento imprevedibile, inatteso, che si concretizza all’improvviso in circostanze del tutto fortuite e con effetti comici ancora più esilaranti. Riguardando i film della coppia, si possono individuare quattro categorie di eventi accidentali e impensati dai quali scaturisce gran parte della comicità: l’evento traumatico, l’evento devastatore, l’evento risolutore e l’evento che cambia radicalmente il corso degli avvenimenti successivi.
L’evento traumatico, che rappresenta un turbamento momentaneo della quiete e che coincide prevalentemente con una caduta o comunque un infortunio, proviene quasi sempre dalla condotta maldestra di Stanlio ai danni dell’amico. Potremmo definirla un’ingenua idiozia, una perenne e puerile vocazione all’instabilità. Anche Buster Keaton per certi versi risulta essere un bambino maldestro, ma non di rado dimostra buona volontà, si sforza quantomeno di crescere, di stare al passo coi tempi e con il mondo che lo circonda, o almeno ci prova perché costretto: “il paradosso comico sta nel fatto che la sua sconfitta è iscritta proprio nella sua totale disponibilità a essere ciò che il mondo vuole che sia” (G. Cremonini, Playtime, cit., pp. 55 e 56). Il personaggio di Stan Laurel, invece, è irrimediabilmente estraneo a quel mondo, non ha alcuna intenzione di maturare, è e rimarrà sempre così, con il suo atteggiamento infantile che provoca involontariamente uno sconvolgimento dell’ordine di cui la prima vittima è il suo partner Oliver Hardy. Anche Ollio è incapace di adattarsi al mondo che lo circonda, anche lui vive costantemente in una dimensione di innocenza fanciullesca, ma a differenza del suo fraterno amico è un bambino che gioca a fare l’adulto, ambisce con ostinazione a collocarsi su un gradino più alto e, ancora prima di cozzare contro una realtà esterna per la quale anch’egli risulta inadeguato nonostante le sue ambizioni di vita sociale, è destinato a scontrarsi innanzitutto con la stramberia di Stanlio e con azioni sconsiderate che provocano turbamenti improvvisi. Come ha notato Marco Giusti, questa dialettica interna alla coppia Laurel & Hardy non è mai generata dalla cattiveria, ma dipende essenzialmente dalla natura selvaggia del primo (che, a sua parziale discolpa, ignora qualsiasi pensiero logico di causa ed effetto) e “l’ottima predisposizione del secondo a ricevere” (M. Giusti, Stan Laurel e Oliver Hardy, Editrice Il Castoro, Milano 1995, p.70).

Va detto che ci sono delle eccezioni. Nel film “La ragazza di Boemia” (“The Bohemian Girl”, James W. Horne, 1936), ad esempio, in alcuni momenti lo zingarello Stanlio sembra quasi più furbo (o meglio, meno stupido) dell’amico e si lascia ammirare per le sue doti di abile e svelto ladruncolo che Ollio non riesce a eguagliare. In altre situazioni invece, come ad esempio in “Lasciali ridendo” (“Leave ‘em Laughing”, Clyde Bruckman, 1928), “Dalla minestra alla frutta” (“From Soup To Nuts”, Edgar L. Kennedy, 1928), “Squadra sequestri” (Bacon Grabbers, Lewis R. Foster, 1929) o Libertà (Liberty, Leo McCarey, 1929) gli eventi traumatici che si abbattono come un fulmine a ciel sereno sul povero Ollio non sono imputabili alla condotta infantile di Stanlio, ma dipendono in questo caso da agenti esterni.
Ma dal momento in cui, alla fine degli anni Venti dopo una fase di rodaggio, sono andati fissandosi quegli schemi abituali della loro comicità che si ritroveranno fino alla fine di carriera, sembra quasi che la Provvidenza agisca attraverso Stanlio e – come ha osservato il documentarista inglese Basil Wright – trasformi “ogni suo gesto innocente nell’intenzionale castigo del suo compare e amico” (J. McCabe, Mr. Laurel & Mr. Hardy. L’unica biografia autorizzata di Stanlio e Ollio, tr. it., Sagoma Editore, Vimercate 2017, p. 58). La causa scatenante del trauma, che consiste sostanzialmente in un capitombolo o un oggetto che cade sulla testa, è dunque quasi sempre Stanlio, con gesti istintivi anche minimi o addirittura con una parola detta nel momento meno opportuno, ma senza premeditazione. L’azione più banale è sufficiente per provocare, senza deliberata intenzione, il caos e, soprattutto, per alterare la pacatezza del povero Ollio. In “Tempo di picnic” (“A Perfect Day”, James Parrott, 1929), il vassoio con i sandwich amorevolmente preparati da Ollio per una scampagnata finisce a terra per ben due volte per colpa della disastrosa concatenazione di piccoli gesti compiuti da Stanlio, sempre ignaro delle più evidenti logiche di causa ed effetto. Costruttori di case in “Il tocco finale” (“The Finishing Touch”, Clyde Bruckman, 1928) e falegnami in “Lavori in corso” (“Busy Bodies”, Lloyd French, 1933), il lavoro manuale diventa inevitabilmente il terreno fertile per la disarmante inettitudine di Stanlio che, senza accorgersene, minaccia ripetutamente l’incolumità di Ollio con una serie di dolorosi traumi fisici che ne provocano l’esasperata reazione e i continui ammiccamenti del Camera – Look (lo sguardo in camera). In “Trainati in un buco” (“Towed in a Hole”, George Marshall, 1933) sono due venditori di pesce al dettaglio che, per un’insolita intuizione di Stan, decidono ch’è più conveniente iniziare a procurarsi da soli il pescato in modo da abbattere i costi e realizzare guadagni più alti. Così acquistano una piccola imbarcazione di seconda mano che necessita di qualche restauro. Ancora una volta, il lavoro manuale si traduce in una serie di irresistibili gag in puro stile slapstick, dove invece delle torte in faccia o delle bucce di banana ci sono tanta acqua e tanta vernice, che diventano il mezzo involontario per minare la quiete di Ollio e per compromettere la buona riuscita dei lavori di ristrutturazione. Anche la parola può risultare altrettanto rovinosa del gesto e avere un effetto traumatizzante, come nel lungometraggio “I figli del deserto” (“Sons of the Desert”, William A. Seiter, 1934): Stanlio, senza alcuna malizia, si lascia sfuggire di bocca che lui e Ollio intendono partecipare al congresso della congrega dei Figli del Deserto, previsto a Chicago la settimana seguente, scatenando così l’ira della signora Hardy che inizia a lanciare a raffica le stoviglie sulla testa di Ollio.

C’è poi un film molto divertente, “I monelli” (“Brats”, James Parrott, 1930), in cui i meccanismi della comicità vengono raddoppiati, con i due attori nella duplice veste di padri e di figli, due piccoli Stanlio e Ollio ancora più sfrenati dei rispettivi genitori. Le stesse dinamiche, dunque, si ripresentano nei due pasticcioni in miniatura e l’evento traumatico viene scatenato questa volta dagli azzardi di uno Stanlio Junior. L’erede di Ollio è seduto sul bordo della vasca da bagno, con i piedi appoggiati a uno sgabello, e il piccolo Stanlio, accorgendosi che la punta del calzino gli è rimasta sotto una gamba dello sgabello, lo alza di scatto provocando ovviamente la caduta dell’amichetto in acqua.
Di ben più vasta portata è la seconda tipologia di evento imprevisto che abbiamo individuato nei film di Stanlio e Ollio: l’evento devastatore, quello cioè che ha effetti disastrosi che vanno ben oltre il trauma temporaneo di una caduta. In “Tutto in ordine” (“Helpmates”, James W. Horne, 1931), approfittando dell’assenza della moglie, Ollio è reduce da una serata tra amici e la casa è completamente a soqquadro. La signora Hardy manda un telegramma per annunciare il suo rientro il giorno stesso, prima del previsto. Allarmato, Ollio chiama l’amico Stanlio per chiedergli di aiutarlo a mettere tutto apposto, e questo la dice lunga sulla sua spocchiosa convinzione di essere il più intelligente dei due. Dopo tutta una serie di gag, l’ultimo sconsiderato gesto di Stan determina la catastrofe: cercando di accendere il caminetto, mentre Ollio corre in stazione a prendere la moglie, genera un incendio che distrugge l’intera casa. Nel film di John G. Blystone “Vent’anni dopo” “(Blockheads”, 1938), vediamo Stanlio nei panni di un surreale reduce di guerra: con la sua sola apparizione dopo il rientro in patria, Stanlio turba con inesorabile e crescente disfacimento l’ordine non solo di casa Hardy, ma anche dell’intero condominio e infine di tutto il quartiere. Nel giorno del suo primo anniversario di nozze, Ollio, innamorato ma visibilmente succube della moglie, corre a prepararle una sorpresa promettendo di rientrare presto. Per caso scopre sul giornale che il vecchio amico e commilitone Stanlio, rimasto per vent’anni a guardia della trincea in Europa ignaro che la prima guerra mondiale fosse finita da tempo, è stato ritrovato e ha fatto ritorno negli Stati Uniti. Così si precipita alla Casa del Soldato per riabbracciarlo, con l’idea di portarlo a casa con sé, ancora più impietosito perché crede erroneamente che gli abbiano amputato una gamba. Con la sua gentilezza, Ollio firma la propria condanna perché da quel momento ha inizio l’imprevedibile sequenza di eventi perturbanti che porteranno a un desolante punto di non ritorno. Come prima cosa, impaziente di provare il congegno di apertura automatica, il rivoluzionario ospite sfonda con la macchina la porta del garage, anche grazie alla complementarietà di Ollio che solo in apparenza è il più avveduto. Credendo che l’ascensore sia guasto, salgono a piedi per raggiungere l’appartamento della famiglia Hardy al tredicesimo piano e vengono coinvolti in continuazione in disavventure d’ogni tipo che li portano a scontrarsi coi vicini e a dover scendere e risalire le scale più volte. Entrati finalmente in casa, dopo un lungo litigio la moglie di Ollio prepara la valigia e se ne va, infuriata per la prolungata assenza del marito proprio nel giorno del loro anniversario di nozze ma soprattutto per la presenza di uno sconosciuto (evento imprevisto), uno dei suoi soliti amici “vagabondi” come li chiama lei. Rimasti soli, Ollio desidera comunque offrire la migliore accoglienza al ritrovato amico e insiste perché si fermi a pranzo. Il passo decisivo verso l’opera di demolizione è il momento in cui il premuroso padrone di casa chiede all’ospite – con una buona dose di autolesionismo, potremmo dire – di accendere il forno. Stanlio apre il gas e si mette alla ricerca di un fiammifero, ma non trovandolo abbandona la stanza lasciando aperta la valvola. Ollio, con la boriosità che lo contraddistingue, dice che dovrà provvedere personalmente come al solito e, con il fiammifero già acceso, si dirige in cucina. Siamo ben consci ormai del fatto che, non appena avrà varcato la soglia, ci sarà un’esplosione. Da qui in avanti ha luogo una serie di frenetiche situazioni equivocanti che coinvolgono la bella dirimpettaia, la signora Hardy improvvisamente rincasata, il marito della vicina e l’intero isolato.
“Sappiamo benissimo”, ha scritto Marco Giusti, “che ai nostri due eroi può capitare di tutto, morire, essere dilatati o trasformarsi fisicamente, o cadere cento volte da un tetto senza farsi male” (M. Giusti, Stan Laurel e Oliver Hardy, cit., p. 61) e che a rimetterci è soprattutto lo sfortunato Oliver Hardy. Non sempre, però, si tratta dell’unica condizione contemplata nelle loro trascinanti avventure. La terza tipologia di evento, infatti, è quella dell’evento risolutore, anch’esso imprevedibile, ma che manifestandosi con salvifico tempismo contribuisce a risolvere una situazione di grave disagio o di pericolo. In “I due Legionari” (“Beau Hunks”, James W. Horne, 1931), quando i beduini mettono sotto assedio il forte, la caduta casuale di un barile pieno di chiodi è l’incidente risolutore che permette di sedare la rivolta. Quando uno degli assalitori, a piedi scalzi, correndo finisce sopra i chiodi, Stanlio e Ollio hanno un’intuizione: aprire tutti gli altri fusti e spargere chiodi dappertutto, in modo da arrestare la corsa dei ribelli che hanno appena fatto irruzione in massa dentro al forte, salvando così il presidio da una fine tragica.

Dalla Legione Straniera all’esercito scozzese in missione in India, anche nel film “Gli allegri eroi” (“Bonnie Scotland”, James W. Horne, 1935) Stanlio e Ollio salvano la guarnigione dai rivoltosi. Dapprima un colpo di pistola, sparato incidentalmente dall’inebetito Stanlio, colpisce un grosso lampadario che cade sui cospiratori, consentendo ai due di scappare. Poi, nella corsa lungo il giardino, i due fuggitivi scontrano per caso un alveare liberando uno sciame di api che si avventa minacciosamente sugli inseguitori. L’ennesimo fatto del tutto imprevisto, dunque, fornisce lo spunto ai due improbabili eroi, che decidono di usare tutti gli alveari come un’arma improvvisata per sconfiggere il nemico. Ma l’evento risolutore può essere anche la classica scivolata sulla buccia di banana, come in uno degli ultimi lungometraggi girati con Hal Roach, “Noi siamo le colonne” (“Chump At Oxford”, Alfred Goulding, 1940). Qui, in veste di netturbini, vediamo i nostri Stanlio e Ollio intenti a mangiare in una pausa dal lavoro, seduti per strada. A fine pranzo, gettando sul marciapiede la buccia di banana (“tanto dopo dobbiamo pulirlo noi”, dice) Stan provoca senza alcuna intenzione la caduta di un malvivente che sta scappando dopo aver compiuto una rapina in banca e ne facilita l’arresto. Nuovamente eroi per caso, il direttore della banca chiede come possa sdebitarsi per questo prezioso servigio, senza sapere che in verità i due ignari paladini della giustizia siano stati solo lo strumento di una casualità. Comunque, approfittando delle circostanze, confessano di sentirsi troppo ignoranti e di voler ricevere finalmente un’adeguata istruzione che permetta loro di avere maggiori possibilità nella vita. E così, come premio, vengono mandati a studiare nella rinomata Oxford.
Concludiamo con un breve cenno a una quarta tipologia, marginale rispetto alle altre: l’evento che, pur senza effetti irrimediabilmente devastatori o di provvidenziale salvataggio, cambia in maniera radicale il corso degli avvenimenti successivi e i destini dei due protagonisti. Generalmente questo evento, a differenza di quelli fin qui esaminati, non è rapportabile a un meccanismo di causa ed effetto originato da un gesto, un’azione, una caduta, un oggetto in movimento o una frase inopportuna detta al momento sbagliato, ma è da collegare ad un incontro inimmaginabile. Ne abbiamo un esempio significativo in “Fra Diavolo”, il film diretto nel 1933 da Hal Roach con la collaborazione di Charles Rogers e tratto dall’omonima opera comica musicata da Daniel Auber su libretto di Eugène Scribe, ambientata in Italia nel diciottesimo secolo. Derubati dei loro risparmi, i due incauti viandanti si improvvisano banditi e, nel risibile tentativo di incutere timore, Ollio si spaccia per Fra Diavolo, un temutissimo brigante molto noto nella zona, che è solito annunciare il proprio arrivo canticchiando sempre lo stesso motivo musicale.

Ma per una tragica fatalità, l’uomo nel quale si imbattono e che vogliono derubare è il vero Fra Diavolo (Dennis King). L’imperdonabile affronto costerebbe loro l’impiccagione, se il famigerato fuorilegge non decidesse di graziarli a patto di diventare i suoi servitori mentre lui, sotto le mentite spoglie del marchese di San Marco, tenterà di portare a termine un colpo molto redditizio ai danni del ricco Lord Rocburg (James Finlayson). Anche nella trasferta scozzese di “Gli allegri eroi”, di cui abbiamo già parlato, un evento di questo tipo segna una svolta decisiva nelle loro vite. Cacciati dall’albergo in cui alloggiavano perché dopo tre settimane non si decidono ancora a pagare, con le valige tenute in pegno dalla locandiera e per di più senza pantaloni (l’incorreggibile Stan ha messo ad asciugare le braghe dell’amico davanti al caminetto, facendole bruciare), Ollio legge per caso il volantino di una sartoria che invita alla prova gratuita per un abito su misura. Corrono all’indirizzo indicato ma anziché salire al secondo piano, dove effettivamente si trova l’atelier, si fermano all’ingresso dello stabile e, senza saperlo, parlano con un funzionario del centro di reclutamento dell’esercito. Convinti di farsi un vestito nuovo, firmano per arruolarsi, senza possibilità di poter recedere dall’impegno preso.
Se, dunque, l’imprevisto è stato, insieme alla fisicità sfrenata e alla carica dirompente del selvaggio Stanlio, una costantenella costruzione di tanti gag della coppia Laurel & Hardy, l’altro aspetto della loro arte comica da tenere sempre in considerazione e che mette ulteriormente in risalto la natura accidentale degli eventi scatenanti è la totale mancanza di cattiveria, sia nelle dinamiche interne alla coppia che nel difficile rapporto col mondo esterno. Nelle primissime comiche (quelle concentrate tra il 1927 e il 1928) non mancano una buona dose di cinismo e un atteggiamento sovente aggressivo, ma dopo il collaudo della coppia Stanlio e Ollio dimostrano in sostanza di essere due perfetti gentiluomini che non farebbero del male a nessuno. Solo se provocati, possono reagire e diventare litigiosi. Il loro ottimismo di bambini mai cresciuti li rende buoni, ben disposti verso il prossimo. È soltanto la loro stupidità, la loro candida ignoranza, a generare senza volerlo inevitabili conflitti e a portare scompiglio.
KILL BILL “OPERA LIMITE” DI TARANTINO
di Roberto Lasagna
Per il giovane Tarantino che lavora alla Video Archives di Los Angeles, alle origini ci sono il culto del cinema e del film. A tal punto che Tarantino vorrebbe fare il critico invece del regista. I suoi film saranno una sorta di reinterpretazione critica e negli anni conserverà una grande ammirazione per Pauline Kael. Quando ha sedici anni, legge un suo libro che lo cattura: “When the Lights Go Down”. E pensa: “Forse un giorno sarò capace di capire un film come fa lei”. Da Pauline, di cui legge tutto quello che lei ha scritto, Quentin impara molto, così come impara dai registi di cui vede i tanti film. Pauline insegna all’autodidatta Quentin il senso di come si possa essere drammaticamente avvincenti, di come poter destare l’attenzione e il coinvolgimento nello spettatore. Per Quentin, Kael è una docente fondamentale nella sua personale scuola di cinema tutta videocassette e visioni private. La celebre critica, che si ritira “dalle scene” prima che Quentin faccia il suo esordio, non scriverà mai di un suo film lasciando il regista con l’interrogativo di sapere cosa avrebbe potuto pensare la sua insegnante ideale su di lui e il suo lavoro. Il fortunato regista di “Kill Bill”, d’altro canto, in ogni suo lavoro utilizza le strutture che trova nel romanzo per applicarle al suo lavoro e disattendere lo standard hollywoodiano. Per un romanziere non è un problema cominciare una storia dalla metà, quando invece nel cinema hollywoodiano non si dispone di questa libertà. Per Quentin il grande regista di riferimento, quello a cui si ispira e a cui vorrebbe somigliare, è Sergio Leone, che ha con la Storia e le storie un rapporto personale e da romanziere. I romanzieri hanno sempre avuto completa libertà di raccontare la storia nel modo che preferiscono, e questa libertà permette loro di raccontare la vita anche quando sembra che non abbiano “niente da dire”. I romanzieri raccontano personaggi, ci introducono al loro mondo, dentro un mondo che è il loro e diventa il nostro. Quentin fa film su se stesso, sul suo mondo, sulle sue passioni artistiche, non obbedendo alla logica del “dover dire” ma raccontando storie che non vogliono avere un recondito messaggio al di là del significato immediato che possono avere, anche se finiscono per rimandare a uno sguardo artistico di ampio respiro. È anche questione di adesione al mondo rappresentato e insieme di affilatezza, taglio espressivo, condensazione di materiali e fonti.

“Kill Bill” è il “film limite” della filmografia di Tarantino, la cui dismisura, estetica e di durata, prelude all’allargamento di orizzonte dei film che seguiranno. Infatti, “Bastardi senza gloria” e poi “Django Unchained”, prenderanno slancio dall’exploit visionario del film con Uma Thurman per configurarsi come orizzonte di ribellione collettiva, dove i Bastardi sono soldati degli Stati Uniti che rendono possibile la sparatoria nella sala cinematografica in cui si favoleggia la fine di Adolf Hitler e la riscrittura della Storia. Un sentimento di vendetta collettivo, dalla parte degli ebrei e degli sfruttati. Una vicenda che, come per Django Unchained, si nutre di un’etica condivisa, di un sogno che verifica la sua tenuta in un immaginario pensato insieme. Ma i Bastardi, nel nome non allineato che portano, sono i reietti che trovano uno spazio nell’immaginario dell’Utopia, mentre per la Sposa l’Utopia è sopravvivere per uccidere Bill.
Tutta la composizione estetica di virulente passione cinematografica si sviluppa in “Kill Bill” attorno ai nodi di visionarietà di un sogno di violenza privata, a muso duro, faccia a faccia tra la Sposa e i combattenti, gli 88 folli come i Sioux di un western – come gli ebrei di “Bastardi senza gloria” che saranno gli esecutori degli scalpi prelevati ai nazisti. La Sposa è anche la sopravvissuta che si ribella ai sentieri selvaggi (evocati dalle inquadrature fordiane e dalla ricerca della figlia e della verità che si svela nella scomoda alterità che la caratterizza) e cerca di strappare lei e la bambina dalla furia dell’incantatore di serpenti Bill.

La violenza come ambito di affermazione irriducibile, come puro istinto che dice molto di chi la esprime, e che lascia spazio in Tarantino ad approfondimenti narrativi. A questo proposito, “Kill Bill”, nei momenti in cui Beatrix si trova ripetutamente dinanzi alla resa dei conti, introduce dei lunghi e fantasiosi flash-back che gettano un po’ più di luce sul passato e sull’addestramento della protagonista, quasi sempre per giustificare quello che succederà nel racconto principale virato al presente. E ciò vale con tratti raramente quasi elegiaci (come nel racconto di Bill e la Sposa che si ritrovano davanti a un set “fordiano” prontamente citato dall’inquadratura da “Sentieri selvaggi”, la chiesetta di El Paso prima della strage che porterà anche la Sposa a un coma di quattro anni) e poi particolarmente risolutori in “Volume 2”, il film delle risposte alle domande lasciate aperte in “Volume 1”. Quando Beatrix è sotterrata viva, il ricordo va al lungo addestramento con il maestro Pai Mei, che le insegnò i segreti per sopravvivere e combattere: questo si rivela utile, adesso, per far sì che Beatrix si liberi dalla bara di legno. Quando poi la donna combatte a colpi di katana contro Elle Driver, il ricordo va all’addestramento e all’occhio che Pai Mei strappò a Elle per punirla della sua intemperanza manifestata durante l’apprendistato: sotto-racconto furente che funziona da preludio all’istintivo accecamento dell’altro occhio che Beatrix strappa ora alla rivale, ma che ha anche il compito di non lasciare in sospeso il mistero del Maestro che fu alla fine anch’egli vittima della vendetta (e Elle, in questo, ci pare a sua volta una vittima che si vendica di un torto terribile).
Una certa innegabile empatia per i personaggi che si vendicano di soprusi ingiustificabili è restituita dalla composizione articolata del racconto, che presenta innesti e approfondimenti di vario stile, con l’idea di presentare meglio le varie radici culturali e con l’effetto di rendere i volti più sfaccettati e meglio comprensibili. Questo è splendidamente reso, in “Kill Bill Volume 1”, dalle immagini del cartoon che ci mostrano O-Ren Ishii undicenne pronta a vendicarsi con il boss Matsumoto che fece strage dei suoi genitori: la vendetta attuata da questa ragazzina, mezza giapponese e mezza cinese nata in una base militare, permette a Tarantino di declinare l’immaginario del cartoon nipponico nel segno della sua poetica che fluisce in un magma di smascheramenti graduali e successivi. Per contratto, la lunga sequenza di animazione, diretta nello stile dei cartoon anime giapponesi, spettava a uno dei maggiori studi giapponesi, la Production I. G. La scelta di Tarantino, apparentemente ardita, di inserire un cartoon dentro un suo film, è invece in linea, come ricorda anche Alberto Morsiani, con lo spirito del film “che cerca di esprimere l’essenza delle varie culture utilizzandone i linguaggi specifici” (A. Morsiani, “Quentin Tarantino”, Gremese, 2018, pag. 135). E succede che Tarantino collabora in prima persona con gli animatori di Tokyo, sia per la stesura dello storyboard dettagliatissimo sia per ogni gesto movimento e taglio dell’inquadratura; così che il risultato finale, con musiche di Morricone e rimando a Leone, riconduce quell’elaborato “western nippo- cinese” che appare “Kill Bill” alla riflessione sull’origine degli spaghetti western e alla fondativa ispirazione nipponica (notoriamente, lo spunto di “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone origina da “La sfida del samurai” di Akira Kurosawa). “Kill Bill” denuncia di voler elaborare i differenti linguaggi lasciandoli confluire in un unico mondo espressivo che li metabolizza e ne reinterpreta forme e contenuti mettendosi al servizio di una storia di vendetta che esprime l’intemperanza di un cuore antico e un impeto morale. Tutto si spiega con la storia dell’infelice ragazza O-Ren, rimasta orfana che, già svantaggiata dalla sua origine cinese-nippo-americana, si avvierà a una carriera di violenza, prendendo il via con una vendetta contro un boss pedofilo disposto a farla entrare nella sua casa e a starle sopra senza sapere che sarà per un’unica e ultima volta. Il sangue che irrompe con la katana con cui O-Ren trapassa in ralenti (e attraverso una modulazione elegiaca in omaggio al tanto amato western) il corpo dell’usurpatore, è in perfetto stile tarantiniano e finisce per rovinare anche preziose stampe giapponesi. L’omaggio a O-Ren ha una funzione specifica che va oltre il tributo al Giappone in cui si svolge la vicenda: considerata la sfortuna che l’ha colpita da bambina e la vendetta che compie contro un usurpatore di corpi e di famiglie, le immagini ci raccontano la natura di ragazzina ferita e permettono di conoscere le terribili prove che dovette superare; l’aspetto androgino di O-Ren che si paleserà nel corso del film, la freddezza che la pone a capo della yakuza di Tokyo e che la mostra capace di decapitare chi la offende per le sue origini meticce, è in parte temperata da una vernice di femminilità che ha radici antiche poi segnate dalla violenza (subita e agita). Il sangue che cola parossistico nel segno del cartoon anime, ha propriamente la funzione di renderci la storia e la sua deriva verso il Male come “un qualcosa di irreale, un cartoon appunto” (A. Morsiani, op. cit., pag. 137). E in questo modo Tarantino non rende irreale la violenza ma ci fa invece pensare a come certi linguaggi, e qui specificamente il cartoon anime, siano particolarmente raffinati ed evoluti tali da permettere di mostrare con grazia artistica situazioni che altrimenti sarebbero insostenibili da reggere ma anche non percepiti in modo tanto vibrante.

La rivendicazione fallica della celebre katana poi, ha un sapore simbolico che riverbera lungo tutto il film, con la Sposa che ne diverrà grande esperta e altri personaggi che se la contenderanno (oltre i ripetuti duelli e la rivalità di Beatrix e Elle – le due predilette di Bill – una certa ironia “freudiana” è ravvisabile nel ruolo dimesso di Budd, il fratello malridotto di Bill, che in “Volume 2” dice di aver venduto la sua “spada di Hanzō” per necessità, in un momento di crisi identitaria, ma in realtà l’ha ancora con sé e la nasconde, forse perché teme di non essere all’altezza in questa frenetica scorribanda virile…).
“Kill Bill” è probabilmente l’opera tarantiniana che più scopertamente riflette sui linguaggi e sulla rappresentabilità della violenza attraverso di essi, ed è ancora un film scomodo, che può apparire un grosso divertissement mentre bisognerà attendere “Bastardi senza gloria” e “Django Unchained” per vedere i protagonisti di una vendetta giustificata collettivamente, gli ebrei nel primo film o il giustiziere di taglie nel secondo film, figure che operano per una nazione o uno Stato, autori di omicidi che il sistema sociale prevede e legittima. Con “Kill Bill” la violenza non ha giustificazioni riconosciute dalla collettività perché il mondo del crimine, questa volta in primo piano rispetto ad altri contesti, si prende tutta l’attenzione come in un western in cui gli sceriffi non hanno maggiore dignità dei migliori maestri di arti marziali. E il film ci porta a comprendere la natura complessa della violenza grazie al suo racconto ondivago ed elettrizzante in cui il “monopolio della forza” non è detenuto dallo Stato come in “Django”, ma va gestito a colpi di katana. In questo film sorprendente – che piacerà molto al pubblico ed è l’esito di un lavoro minuziosamente preparato dal regista nei quattro anni trascorsi tra la distribuzione di “Jackie Brown” e l’inizio della laboriosa produzione che prende avvio nel 2001 – l’irruenza fantasiosa del “Volume 1”, con la sua inventiva e i combattimenti elaborati, fa da controcampo a “Volume 2”, il film delle attese in cui fa la sua comparsa Bill, spietato e non privo di un certo arcano alone romantico, dal fascino moderno e dal gusto antico, mandante dei delitti con il quale il film chiede misteriosamente di fare i conti. In questo film suggestivo e sbandieratamente fantasioso, il regista continua sulla strada avviata da “Jackie Brown” di lasciarsi un po’ alle spalle l’universo quasi esclusivamente maschile dei suoi primi film e accoglie una figura di donna che diventa un’immagine di femminilità molto attuale, al confronto con un individuo arcano, fascinoso e a tratti paterno ma con modi sconcertanti, e con altre figure femminili in lotta come lei con un universo di dominatori.
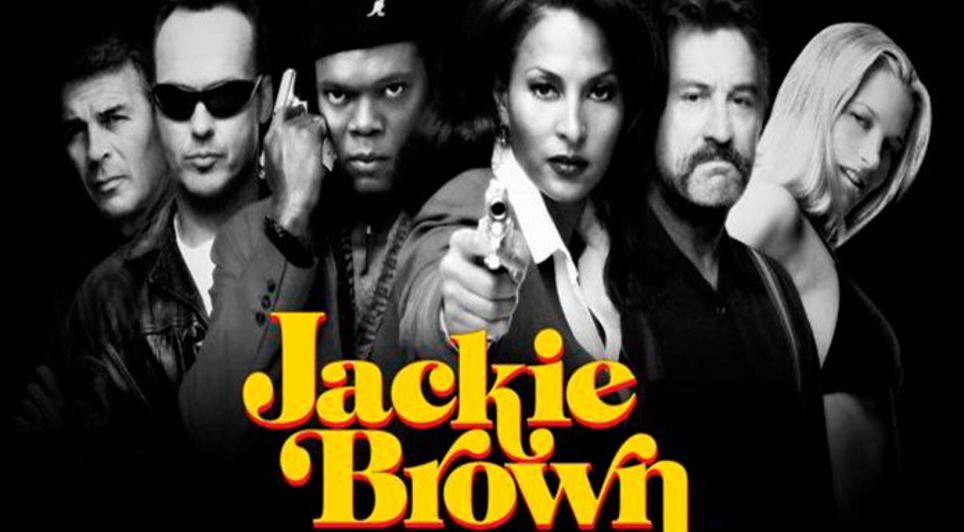
In “Jackie Brown” i personaggi riacquistavano la loro autonomia rispetto al dominio verbale sulla verità esercitato dagli individui di “Le iene” e “Pulp fiction”, e in “Kill Bill” la libertà da inseguire e difendere, anche sotto forma di vendetta, è una scommessa che la Sposa vive attraversando una dimensione estetica ottenuta da Tarantino combinando generi popolari a un livello di elevata consapevolezza teorica. Pensato inizialmente come un film unico, questo lungometraggio costato sessanta milioni di dollari è fino a quel momento il lavoro economicamente più impegnativo del cineasta e viene diviso in due parti soltanto alcuni mesi prima della distribuzione che avviene nell’ottobre del 2003. La decisione viene presa da Harvey Weinsten che, visionato il film, non vuole tagliare nulla e suggerisce a Tarantino di farne due film. In effetti si tratterà di due opere con specifici toni e atmosfere, ma anche modalità narrative differenti e complementari. Due film che escono autonomamente e al contempo non possono esistere senza completarsi o rimandare l’uno all’altro. Il Giappone è l’influenza dominante in “Volume 1”, con il popolare attore di arti marziali Sonny Chiba che interpreta il ruolo dell’esperto di spade Hattori Hanzō e il cartoon anime che introduce la figura di O-Ren Ishii; la Cina è invece più influente in “Volume 2”, dove la leggenda delle arti marziali Gordon Liu interpreta il carismatico maestro Pai Mei, un ruolo che Quentin Tarantino pensava dapprima d’interpretare in prima persona. Diversi sono anche i tempi narrativi: dove appare lisergico e fumettistico “Volume 1”, “Volume 2” è invece più votato alle distensioni di un western visionario, nel suo compito di rispondere agli interrogativi che “Volume 1” lascia in sospeso. Li accomuna lo spirito di contaminazione, che avvicina e riscrive in una forma pop i film di kung fu e di samurai, fumetto e cartoon, spaghetti western e John Ford. L’influenza asiatica impressiona l’estetica facendo del film un manifesto di assimilazione che coniuga in un’unica forma i film realizzati a Hong Kong e i western italiani, evidenziandone le affinità, accogliendo ripetuti omaggi con spirito enciclopedico ma senza per questo chiudere alla pesantezza della referenzialità. L’universo del film è il film stesso, che abbraccia le convenzioni e può far pronunciare alla Sposa, seduta al volante e con lo sguardo in camera nell’avvio di “Volume 2”, un vezzoso riferimento agli slogan di lancio del film, mentre i combattimenti, specie quello ambientato alla Casa delle Foglie Blu, sono studiati come balletti acrobatici che vedono Beatrix librarsi nello spazio e condurre una danza di morte con la stessa facilità e nerbo con cui Pai Mai appare sospeso con il corpo sopra la katana impugnata dalla Sposa. Il segno incisivo dell’estetica si coniuga con la leggerezza aerea che significa possibilità di ribaltamento e riequilibrio, sottrarsi all’ovvio e provare nuove forme espressive, repentine fughe, contaminazioni e cambi di punti di vista. Una libertà espressiva che il regista prende dai romanzi, dove la narrazione in terza persona, improvvisamente, può essere sostituita dal racconto in prima persona di un personaggio, o sotto forma epistolare. “Kill Bill volume 2”, propriamente, riavvia il racconto dal punto di vista della Sposa che guarda in camera lo spettatore e si toglie la maschera. In effetti, di ripetuti smascheramenti vive il film, con il gran finale in cui Bill parla di Superman come dell’eroe che è tale quando non ha la maschera. Quentin Tarantino cerca dunque, nel cinema dell’artificio e della contaminazione, la realtà vera di personaggi che, qui forse ancor più che in “Pulp Fiction”, hanno una vita soprattutto cinematografica; crea un mondo modellandolo sulle sue passioni cinematografiche, domandando cosa potrebbe succedere se un simile universo esistesse davvero. In questa scena citazionista, le donne hanno un ruolo di primo piano, a loro spetta sempre più spesso di gettare la maschera e di buttarsi in giochi pericolosi dimostrando, se ce ne fosse il bisogno, che non sono affatto il sesso debole, anzi dominano la scena, restano sole, affilate dominatrici in balia di istinti non meno terribili di quelli degli uomini. L’universo tarantiniano, che prende tanto dai B-Movies, ci presenta una donna come Vernita Green che ha ucciso per vivere e che finge mostrando scaltrezza ma anche scarso senso della lealtà (per questo, l’immediata reazione della Sposa, che la fredda con il lancio infallibile del coltello, dopo che Vernita ha cercato di uccidere Beatrix sparandole a tradimento, non provoca in chi guarda sgomento ma, più facilmente, immedesimazione). Il “viaggio” a Oriente influenza il lungo periodo di tempo che occorre a Tarantino per mettere a punto la scrittura del film; in esso, la collezione di citazioni dei film di Hong Kong e di arti marziali declina in chiave orientale il compendio di ossessioni rispetto alle forme della cultura popolare, declinazione che si presenta con un aspetto più schiettamente occidentale in altri film e specialmente in Pulp Fiction: “Se incontravo un ostacolo mi fermavo e andavo a vedere un film sulle arti marziali. In realtà andavo a vedere un film di Hong Kong ogni giorno, per qualche volta anche due o tre film ogni giorno (…). Non ho saputo assolutamente nulla dei film di Hollywood usciti quell’anno”. Un ruolo di tutto rispetto è assolto dalla musica, che come avviene per il versante visivo attinge dalle fonti più disparate, unendo Nancy Sinatra (la musica d’apertura è notoriamente “Bang Bang. My baby shot me down”, un testo che racconta di violenza e abbandono ma anche di un ricordo che torna a galla) al fischio, portato in melodia da Bernard Hermann, che si ascolta nella colonna sonora del thriller “Twisted nerve” di Roy Boulting (1968) e si riascolta nella sequenza dell’arrivo di Elle Driver all’ospedale. Sono poi molti i riferimenti che provengono dalla rara collezione musicale del regista che racchiude colonne sonore di migliaia di film, da cui possiamo citare almeno il tema sentimentale della pellicola sui gangster yakuza di Kinji Fukasaku Battles Without Honor and Humanity e il brano di Isaac Hayes Run Fay Run da “È tempo di uccidere, detective Treck”, di Jonathan Kaplan. La colonna sonora originale è stata invece affidata a The RZA, produttore di album del gruppo hip-hop Wu-Tang Clan che ha tratto ispirazione dai film cinesi d’arte marziale.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
LA FEDIC DAL 1993 ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
di Paolo Micalizzi
Sarà incentrato sui Festival e sugli Autori Fedic il 25. Forum Fedic che si svolgerà al Spazio Incontri del Venice Production Bridge (Hotel Excelsior) del Lido di Venezia nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’appuntamento è per giovedì 10 settembre, dalle ore 15 alle 17. Dopo un’introduzione di chi scrive, che oltre ad essere critico e storico del cinema è responsabile di Fedic Cinema, che sin dal 1995 cura quest’iniziativa, e l’intervento del Presidente Fedic Lorenzo Caravello” Fedic 2020: Obiettivo Trasformare gli ostacoli in opportunità”, il Forum si svilupperà parlando appunto di Festival ed Autori Fedic.

E s’inizierà con un Omaggio a Federico Fellini, nell’ambito del Centenario della sua nascita, da parte di Lauro Crociani e Cristiana Vitalesta che presenteranno il loro Video, realizzato sulla base di un’apposita ricerca, “Federico Fellini alle Terme di Chianciano e dintorni” che comprende alcune testimonianze tra cui quella della giornalista Rai Simonetta Guidotti. Sarà poi proiettato, alla presenza dell’autore, il cortometraggio “Indimenticabile” di Gianluca Santoni, che è stato scelto dalla Rete REFF-Festival Fedic, coordinata dal Gianluca Castellini. Seguirà la proiezione dei trailer di alcuni Festival della Rete REFF: “Corto Fiction” di Chianciano Terme, “Fedic Scuola Film Festival” organizzato dal Cineclub Cineamatori delle Apuane, “ColtivaCortiDiretti” portato avanti dal Cineclub Compagnia Genitori Instabili e “Visioni Corte Film Festival” dell’Associazione Sogno di Ulisse.
Spazio poi ai trailer di alcuni cortometraggi, il cui lavoro completo sarà poi inserito in una Compilation della Cineteca Fedic, realizzati da Autori Fedic nel periodo 2019/2020. In programma “Ricordi” (Lettere d’amore) di Sonia e Giorgio Bertuccioli (Cinevideoclub Pesaro), “Una finestra non è abbastanza” di Margherita Caravello e Antonio Nobili (Cineclub Cineamatori delle Apuane), “Diagonia” di Chiara Rizzati e Claudio Venanzini (Fotovideocineclub Fano), “La breve stagione” di Agostino Vincenzi (Cinevideoclub Pesaro), “Writer” di Franca Elisabetta Iannucci (Cineclub Cagliari).
Spazio anche a “Fedic: Il cinema nella Scuola” con gli interventi di Laura Biggi (Responsabile Fedic Scuola) e di Ilaria Copeta(Booktrailer Film Festival). Saranno proiettati i trailer, realizzati nell’ambito di Fedic Scuola, di “Gino” di Carlo Menegatti (Cineclub Delta del Po) e di “Beatrice” di Giorgio Emanuele Torresani (Cineclub Kinema Brescia). E per il Booktrailer Film Festival, “L’occhio del male” di Alessandro Gregori, “Il giardino delle farfalle” di Maria Tallarico, “L’invenzione di Morel” di Nicola Barsottelli e “Blackwoodsmart project” di S.Franceschini. Alcuni filmati saranno presentati dai propri Autori.

Alla Mostra di Venezia, la Fedic sarà presente anche con il Premio FEDIC, organizzato sin dal 1993 da chi scrive, che attribuirà alcuni premi relativi al cinema italiano presente, nelle varie Sezioni della Mostra. In particolare, attribuirà il Premio FEDIC “all’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore” e, inoltre, una Menzione Speciale FEDIC. A valutare i lungometraggi sarà un’apposita Giuria di critici e filmmaker. Un’altra Giuria attribuirà poi una Menzione Speciale FEDIC al miglior Cortometraggio.
CARLOTTA BRUSCHI: IL CINEMA COME PROFESSIONE
di Paolo Micalizzi
Carlotta Bruschi dal 2015 fa parte della Giuria del Premio Fedic, premio collaterale che dal 1993 coordino alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La mia scelta derivava, affidandole da subito anche il ruolo di Segretaria, dal suo chiaro spirito collaborativo. E non mi sono sbagliato, poiché lei lo svolge con passione e diligenza. La scelsi nell’intento di completare la composizione della Giuria, che era composta soprattutto da critici cinematografici, con Soci Fedic.
Alla Mostra, più volte Carlotta mi aveva accennato di volersi dedicare al cinema come professione. E quando lo ha fatto mi ha informato che stava compiendo alcune esperienze come Segretaria di Edizione, una professione per me interessante, anche perché diversa da altri che invece si erano dedicati alla Regia o a quella di Direttore della Fotografia.
Da qui, il motivo di questa Intervista nell’intento di approfondire la sua passione per il cinema ed il ruolo di una Segretaria di Edizione.
Come sei diventata socia Fedic e che attività hai svolto prima di dedicarti al ruolo di Segretaria di edizione?
Ricordo quando ne sentii parlare per la prima volta. Nel 2014 ero giurata del concorso Wag Film Festival, una manifestazione organizzata da volontari de Le Ali di Icaro a Montevarchi Terranuova Bracciolini (AR). Nel complimentami per la passione che ci mettevano ho chiesto se conoscevano un’associazione analoga, magari più vicina a casa, sono originaria di Pisa. In quell’occasione il Direttore Artistico, Jacopo Fontanella, mi fece il nome di Roberto Merlino, allora Presidente FEDIC, e di Corte Tripoli Cinematografica. Rimasi colpita dalle iniziative che offriva l’associazione tanto che arrivò ad ispirarmi la mia prima regia, “Colma”. Fino a quel momento avevo realizzato dei brevi racconti, non avevo ancora studiato la scrittura per film, venivo da un’accademia di fumetto, mi piaceva il cinema, da sempre, e realizzavo storyboard.

Come sei diventata Segretaria di Edizione?
Ho iniziato per caso. Credo il destino mi abbia fatto innamorare di questo ruolo così affine al mio carattere. Ricevetti l’invito a supervisionare in fase di riprese le inquadrature che avevo precedentemente preparato sullo storyboard e dalla matita dei fogli da disegno passai alla penna dei Fogli di Edizione per rendermi utile. Allora sapevo giusto che dovevo annotarmi quale fosse il ciak sbagliato e quale quello corretto da utilizzare in fase di montaggio, ma se avevo intenzione di proseguire dovevo prima colmare le mie tantissime lacune: un conto è vedere un film, un conto è saperne valutare ogni aspetto.
Iniziai a far caso ad ogni tipo di transizione in cui incappavo, dal cinema alla pubblicità, soffermandomi non tanto sulla tecnica ma immaginando il ragionamento che stava a monte, insomma, sul perché quel dato regista o autore aveva scelto di operare così e non altrimenti. Armata di una sana inesperienza e tanta voglia di mettermi in gioco ho ricercato sempre più occasioni per propormi come Edizione in produzioni indipendenti. Sono stata piacevolmente colpita quando alcuni amici registi, fidandosi, hanno iniziato ad inviarmi i loro soggetti e sceneggiature per ricevere suggerimenti. Vinsi la mia timidezza e avvicinai alcune Segretarie di Edizione per chiedere se volevano raccontarmi qualcosa sul loro lavoro. Ricordo con affetto e gratitudine Camilla Percuoco che mi permise di seguirla un giorno su un set mostrandomi per la prima volta l’aspetto burocratico (oltre che alla prelibatezza del mio primo cestino).
Dopo tanti corti ottenni il primo lungometraggio e mi ero iniziata ad affinare quando arrivò la mia prima esperienza professionale: venni selezionata come Stagista Edizione al Corso di Formazione su Set Cinematografico promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca con cui presi parte alle riprese di “Far East” diretto da Cristina Puccinelli. Osservai lavorare da vicino un esperto plasmatore di luce come Ferran Paredes Rubio (tra le tante pellicole di cui ha curato la Fotografia ricordo “Perez”, “Indivisibili”, “Il Sindaco di Rione Sanità”) e soprattutto seguii la mia tutor di Edizione, Giulia Contino (dagli albori Edizione del cinema di Paolo Virzì, proseguendo al fianco di Claudio Caligari, Sergio Castellitto, Claudio Giovannesi). Le devo tanto perché illustrando il suo metodo è riuscita a disciplinare il mio e a trasmettermi la prima regola base di questo mestiere: la costanza. Con quest’anno sono quattro anni che l’Edizione è diventato il mio lavoro e, pur di proseguirlo, mi sono trasferita a Roma, ma con un piede sempre in Toscana all’occorrenza.

Qual è la domanda più frequente quando racconti alle persone il tuo ruolo?
Mi chiedono: “Ah quindi lavori in ufficio?”. Subito mi muovo con cautela onde evitare il fraintendimento. Già da qualche anno nei credits dei film stanno comparendo le diciture “Edizione” o, all’americana, “Script Supervisor” che preferisco di gran lunga perché mi distacca dall’immaginario errato. Per un certo senso potrei essere associata più alla figura di un notaio scribacchino, infatti sui set mi troveresti sempre a scrivere – una volta i Bollettini, appunti che invio all’Editor per orientarsi al montaggio sulla mole di ore di girato; una volta i Diari di Lavorazione, importanti anche a livello legale, con i quali la Produzione viene informata sugli orari e i relativi costi che ha comportato la giornata lavorativa – ma l’obiettivo al quale dedico tutta me stessa è mantenere intatta la continuità del film, e ci riesco con occhi e orecchie ben aperte su quello che mi circonda nel set.
Forse non tutti sanno che le riprese non avvengono quasi mai seguendo l’ordine cronologico della storia – questo può dipendere dalla disponibilità del cast, dalla necessità di accorpare delle location rispetto ad altre e, spesso e volentieri, anche dalle condizioni meteo – persino una nuvola che copre il sole può far slittare delle riprese per settimane. Il mio compito è ripristinare l’ordine, far sì che lo spettatore non percepisca distacchi: se vede un personaggio uscire in una stanza, deve vederlo entrare nella stanza accanto con la stessa andatura, emotività, luci, oggetti in mano se li ha, gli stessi costumi, trucco e parrucco. Il mio ruolo consiste nel far rispettare ogni raccordo per garantire il montaggio del girato.

E qual è, se c’è stata, la cosa più singolare che ti sei trovata a “raccordare”?
Si, c’è stata eccome: l’andamento della corda di una mongolfiera sul set di “Terra Cotta” per la regia di Carlos Solito. Il reparto competente, scenografia, era impegnato nella preparazione di un’altra location e quindi, per ripetere la discesa della mongolfiera già filmata in precedenza, mi sono occupata di manovrare la corda per ricreare la stessa velocità con cui l’oggetto di carta ritoccava terra … Al montaggio larga sentenza.
Come mai la scelta di Edizione e non di un altro ruolo?
L’Edizione permette di avere uno sguardo privilegiato su quello che sarà l’aspetto delle riprese a montaggio ultimato. Diciamo forse più una stima perché, parafrasando umilmente Stanley Kubrick, un film si può definire concluso solo dopo che è uscito dalla sala montaggio o, addirittura, quando finalmente viene proiettato. Inoltre l’Edizione, essendo parte del Reparto Regia, mi lascia una frazione mia, un margine creativo sulla storia che per altre figure sarebbe impensabile. Per esempio nelle mie prime esperienze, agli albori, in più di una circostanza ho suggerito dei movimenti di macchina piuttosto che a inquadrature fisse per agevolare la narrazione, oppure, in rari casi ma che regalano molte soddisfazioni, il Regista mi lascia richiedere, dietro consenso del resto della troupe, un altro take, il cosiddetto “ciak richiesto da Edizione”, dove ho la possibilità di correggere il tiro o proporre una variante, spesso singolare, a cui Regia e Direttore della Fotografia magari non avevano ancora pensato.
Il continuo scambio, confronto e il veder crescere il progetto sotto il peso e la passione di tutti i reparti è poi la cosa che mi fa amare drammaticamente questo mestiere. Dico drammaticamente perché purtroppo non è possibile dare voce a tutti, ma la sinergia che si crea a volte sul set è qualcosa di magico. Impossibile da descrivere.
Se ti chiedessi tre aspetti che ti piacciono di questo mestiere?
Incontrare sempre una troupe diversa, non avere idea della prossima storia in cui dovrò imbattermi, né delle persone con cui dovrò interfacciarmi.

E invece tre che non ti piacciono?
Incontrare una troupe diversa, non avere idea della prossima storia in cui dovrò imbattermi, né delle persone con cui dovrò interfacciarmi. Non scherzo. L’incertezza è una costante di questo mestiere. Mi è capitato di collaborare in più di un’occasione con la stessa troupe, ma cambiando progetto cambiano i tempi di realizzazione e i tempi richiesti – quindi spesso da progetto, a progetto tutto può o non può cambiare. Ma adoro le sfide e non mi lascio abbattere.
Un aspetto poi che fino a pochi mesi fa mi destabilizzava era il non esser consapevole di quando sarei potuta tornare su un set, ma con le dovute precauzioni si può tutto. Per essere giunti al mese di Agosto mi posso ritenere più che contenta perché ho già preso parte a due lavorazioni e mi accingo ad iniziare la terza, armata di mascherina e del doppio dei decibel di voce – perché con quella si fa fatica a farsi sentire.
Quali sono i progetti che ti hanno vista coinvolta come Edizione e su cosa ti appresti a lavorare?
Al momento, in barba all’arsura romana, sto preparando la seconda unità di una serie da venti episodi in onda su Rai Gulp, la tv per ragazzi. Già in passato ho curato l’Edizione di una serie per Disney Channel, “Sara e Marti -Stagione 3”, quindi credo di potermi sentire più che a casa con le tematiche adolescenziali. Ho riso tanto, da cinefila, sul set della rubrica di Sky Cinema, “La Posta del Quore” con l’attrice Michela Andreozzi come conduttrice, e più recentemente in epoca covid, ho chiuso gli episodi della sictom “Ricci e Capricci 2°stagione” che andranno in onda sul canale La5.
La tv è una novità degli ultimi anni, assieme alla partecipazione a uno spot di sensibilizzazione a cura della squadra della Save The Cut, “Incroci” di Federico Caponera, tre storie con rispettivamente tre finali alternativi ambientate tutte e tre nello stesso spazio tempo, la hall di un albergo.
E’ il cortometraggio il mezzo filmico che ho sperimentato più volte, anche come banco di prova. Il primo da Edizione nel 2011, “Riflessi Condizionati” scritto e diretto da Gioia Zanaboni, mi ha vista ricoprire più aspetti nella lavorazione, permettendomi di imparare quali fossero i miei limiti e quali le mie potenzialità.

Li vorrei elencare tutti ma finirei per dimenticare, oltre che ad annoiare qualcuno … Come succede ai colloqui mi limiterò a citare gli ultimi, sebbene ogni cortometraggio realizzato finora abbia costituto un tassello importante nella mia formazione, sia umana che professionale. “Pappo e Bucco” scritto e diretto da Antonio Solito, mi ha vista emozionare di fronte al monitor dove nel riquadro avevo interpreti del calibro di Massimo Dapporto e Augusto Zucchi intenti a districarsi con un’interpretazione allegra quanto malinconica; “L’Acchiappavento” di Carlos Solito, una storia ambientata in Basilicata, una terra arida ma fantasmagorica al contempo, dove mi sono immersa nel silenzio di un bambino sordomuto con il dono per la musica. Sempre altri bambini in “Terra Cotta” di Carlos Solito, mi hanno fatto riscoprire la bellezza dell’artigianalità e del godermi la compagnia degli affetti perché tutto potrebbe sfumare e cadere in mille pezzi. Ultimo, ma non ultimo, una produzione Save The Cut per la Regia di Federico Caponera dove mi ero commossa già solo leggendo lo script, figurati allora cosa è successo quando l’ho visto interpretare da Barbora Bobulova mentre dovevo mantenere la concentrazione su una storia da girare in pochi giorni ma che nella finzione copriva quasi tre anni.
Nel mio percorso non sono mancate le delusioni, ma le considero parte integrante del pacchetto. Ogni sgambetto o sbucciatura di ginocchio ha sempre costituto per me fonte di sprone a riprovarci, a tornare in sella della “bicicletta del cinema”.

Quindi è il cinema il tuo vero obiettivo?
Mi piace, mi è sempre piaciuto guardarlo, studiarlo, appassionarmici. In cuor mio però so che ho ancora esperienza da accumulare prima di poter passare a quel luogo ambito. Non si tratta di come svolgere il mestiere, quello lo so fare e ne sono cosciente. Si tratta più che altro di acquisire consapevolezza e credibilità verso gli altri. È difficile che affidino a una trentunenne una produzione “grossa” insomma, ma non mi lamento delle sfide che già mi attendono. Questo mestiere è in continua evoluzione, persino per le colleghe più esperte che amabilmente noi più giovani chiamiamo “Senior”. Da quest’anno poi sono diventata socia dell’AIARSE (Associazione Italiana Aiuti Regia e Segretari di Edizione) e durante il periodo della quarantena si sono susseguiti incontri online su quanto la nostra professione rimanga ai margini pur essendo così importante. Rimanere uniti come una catena è fondamentale. Il messaggio che deve passare è che il cinema non è solo per sognatori, il sogno non basta. Serve costanza, dedizione e da mettere in conto di dover fare qualche sacrificio. Il tutto però viene ricompensato se sul prossimo set, con il prossimo collega, con il prossimo Regista si instaura qualcosa che io non so descrivere. Rimane indescrivibile cosa fa il mezzo filmico a noi Lavoratori del cine-audiovisivo.
In chiusura, dietro le luci dei riflettori della scena c’è un gruppo coeso, ti senti parte integrante dei Lavoratori del cine-audiovisivo?
Anche qui sono preparata, ho la data: otto maggio 2020. Da quando ho visto la mia piccola faccina sullo schermo assieme a tante altre maestranze di colleghi e colleghe nello spot di sensibilizzazione “Azione! Per i lavoratori dello spettacolo” andato in onda durante la serata di premiazione dei David di Donatello. Figuriamoci, non è stato vedermi in tv, bensì il sentirmi come una goccia che assieme alle altre muovevano un’onda. Anche fuori dal set rimaniamo una squadra, anche fuori dal set lottiamo affinché i nostri diritti, professionalità e stipendi vengano rispettati.
Ci tenevo poi a ringraziarti di questo spazio dedicato all’Edizione Paolo, un mestiere poco conosciuto ma molto importante e ogni centimetro che riesco a dedicargli so che mi tornerà indietro sotto forma di nuove esperienze, lavorative e non. Non si smette mai di imparare.
FESTIVAL ED EVENTI
77. MOSTRA DI VENEZIA: CHE LA FESTA COMINCI
di Paolo Micalizzi
La 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si farà Live nella data stabilita, cioè 2 – 12 settembre. Lo si sapeva già sin dopo poco tempo dell’insorgere della pandemia e se ne è avuta la certezza con la Conferenza Stampa, seppure in Streaming, del 27 luglio. “E’ con grande senso di responsabilità e di impegno che abbiamo affrontato una situazione ignota e senza precedenti, ha detto il Direttore Artistico Alberto Barbera. Una situazione, ha precisato, nella quale le regole del gioco cambiavano in continuazione, costringendoci a grande flessibilità e disponibili e continue correzioni di rotta. La Mostra si terrà nelle date previste, a prezzo di qualche rinuncia ma anche forte di innovazioni favorite dalle opportunità che le circostanze hanno rese possibili.

Circa il programma Alberto Barbera ha dichiarato che la Mostra contiene, per dirla con Bob Dylan, moltitudini di film, di generi, di prospettive. Sono stati invitati un numero consistente di film, come era prevedibile, ma solo di poco inferiore, ha precisato Barbera, alle tradizionali proposte veneziane. Rappresentativi della ricchezza e la varietà del cinema: film d’autore, commedie, documentari, film horror e gangster movie, senza trascurare film che rifiutano la separazione dei linguaggi a vantaggio di una contaminazione produttiva di forme ed estetiche. Come era prevedibile, guardando il programma, si nota che manca qualche titolo spettacolare, dato che il lockdown condiziona ancora la programmazione delle uscite dei film hollywoodiani più attesi, e ci sarà una limitazione nella presenza di alcuni cast dei film invitati a causa della libertà dei viaggi intercontinentali. Ma il programma darà conto della vivacità del cinema contemporaneo, grazie ad un ricambio generazionale che fa affidamento anche alla componente femminile, sinora relegata, ha affermato Alberto Barbera, a percentuali imbarazzanti. In tal senso, ha precisato, quasi la metà sono film diretti da donne, selezionati esclusivamente in base a criteri di qualità e non a seguito di protocolli di genere. Aggiungendo anche che si tratta di una percentuale senza precedenti nell’auspicio per un futuro del cinema scevro di pregiudizi e discriminazioni di sorta.
Alla Mostra erano giunte 2709 opere, di cui 1370 lungometraggi e 1339 cortometraggi. Ne sono state scelte 60 alle quali poi ne sono state aggiunte altre quattro “fuori concorso”. Quindi alla Mostra saranno presenti nella Selezione ufficiale 62 opere così suddivise: 18 nella sezione “Venezia 77” (Concorso), 24 nella sezione “Fuori Concorso” ( di cui 11 documentari), 19 nella sezione “Orizzonti”, 2 nella sezione “Biennale College – Cinema e 1 nella sezione “Fuori Concorso – Proiezioni speciali. Per quanto riguarda i cortometraggi ne verranno presentati 15: 12 nella sezione “Orizzonti”, uno in “Orizzonti – Fuori concorso” ed un altro nella sezione “Fuori Concorso – Proiezioni speciali. Figura anche una serie TV come proiezione speciale “Fuori Concorso”.
Non ci sarà la sezione “Sconfini”, e si dovrà attendere il ritorno alla normalità per essere ripristinata, il Concorso “Venice VR Exspanded” sarà collocata in streaming , e “Venezia Classici” avrà luogo, grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, nella 34.a edizione del festival “Il Cinema Ritrovato” in programma nel capoluogo emiliano dal 25 al 31 agosto, prima delle repliche già previste a Venezia nei mesi successivi. Segno concreto, ha detto Alberto Barbera, di una solidarietà tr i festival e della capacità di reagire alle difficoltà del momento, contribuendo così alla ripartenza della vita culturale del Paese. In tal senso è da sottolineare un’altra collaborazione importante, la condivisione con i Festival di Toronto, Telluride e New York del terzo lungometraggio della regista Chloé Zhao “Nomadland” che è prodotto e interpretato dall’attrice premio Oscar Frances McDormand. Parlando di questo film Alberto Barbera ha dichiarato che si tratta di un viaggio coraggioso e toccante dentro un mondo sconosciuto, lontano dalla nostra coscienza sociale, che acquista un significato del tutto particolare in questo periodo di isolamento causato dalla pandemia, e che dimostra come alcuni valori quali la solidarietà reciproca e il forte senso di comunità possono salvarci dalla solitudine, dal fallimento e dalla disperazione.

Entrando un po’ nel dettaglio circa le opere che saranno presenti nelle varie Sezioni, vi è da dire che in “Venezia 77” , relativa al Concorso per il Leone d’Oro vi partecipano 13 registi esordienti: Hilal Baydarov(In beetween dying), Mona Fastvold ( The world to come), Michel Franco(Nuevo orden), Kiyoshi Kurosawa( Spy non Tsuma), Majid Majidi (Khorshid), Kornél Mundruczò(Pieces of a woman), Susanna Nicchiarelli (Miss Marx), Claudio Noce( Padrenostro), Malgorzata Szumowska con coregia di Michal Englert(Neve gonna snow again), Chaitanya Tamhane( The disciple), Julia von Heinz (Und morgen die ganze welt), Jasmila Zbanic ( Quo vadis, Aida?) e la già citata Chloé Zhao con “Nomadland”. Ad essi sono da aggiungere: “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, “Amants”(Lovers) di Nicole Garcia, “Laila in Haifa” di Amos Gitai, “Dorogie tovarischi”(Dear comrades) di Andrei Konchalovsky, “Notturno” di Gianfranco Rosi.
Quindi, sono quattro i film italiani in Concorso. Ma la presenza del Cinema Italiano nelle varie Sezioni della Mostra di Venezia conterà in totale 17 lungometraggi, oltre a 3 cortometraggi nella Sezione “Orizzonti” e 2 film nella sezione “Classici restaurati” che, come detto, saranno proiettati a “Il Cinema Ritrovato” di Bologna.
Per affrontare la pandemia la Mostra di Venezia che ha seguito, e continua a fare, con la massima attenzione l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, sta elaborando, in accordo con gli organi di controllo nazionali e regionali, un piano di sicurezza anticovid 19, “una scomoda presenza” , ha dichiarato il Direttore Barbera nella Conferenza Stampa, che ha condizionato non poche scelte ed imposto straordinarie misure di sicurezza, applicate con rigore per assicurare a tutti i partecipanti – team, accreditati e pubblico – di poter essere parte attiva della manifestazione in tranquillità e senza correre alcun rischio. L’aumento delle repliche di ciascun film grazie anche all’utilizzo a pieno titolo della multisala Astra del Lido consentiranno di poter vedere la maggior parte dei film. Bisogna aggiungere poi le proposte delle “Giornate degli Autori” e della SIC, due manifestazioni autonome e parallele che da alcuni anni arricchiscono il programma della Mostra.

Un programma, quello delle “Giornate”, giunto alla XVII edizione, improntato al tema del coraggio e concepito come una risposta alla difficile stagione del cinema mondiale che proprio a Venezia vuole riaffermare la forza della creatività e degli autori posti di fronte a una tragedia collettiva senza precedente. A questo proposito il Presidente Andrea Purgatori ha dichiarato che “le Giornate avviano un percorso di rinnovamento e crescita che ci proietta nel futuro”. Ed in questa prospettiva le “Giornate” vogliono rilanciare la loro vocazione originaria che non si limita alla vetrina degli autori in mostra, ma si articola in un progetto permanente di ricerca e dibattito come è nelle aspettative degli autori. In questo senso va il ricordo, nell’anno del centenario della sua nascita, di un grande creatore di storie come Ugo Pirro “che sarà protagonista naturale della fascia di incontri a cui affidiamo un valore importante per la prossima edizione”. Dal canto suo il Delegato Generale Giorgio Gosetti ha sottolineato che è stato ridisegnato il coinvolgimento delle “Giornate” sul territorio associandosi a due realtà (“Laguna Sud e “Isola Edipo”) giovani e capaci di portare contenuti di qualità.
Un altro omaggio sarà quello dedicato a Liliana Cavani nell’ambito di “Il cinema dell’inclusione – Omaggio ai maestri e alle maestre del cinema internazionale”.
Saranno 10 i film in Concorso di cui 5 opere prime,4 gli eventi speciali e 11 titoli selezionati nelle rinnovate “Notti veneziane”. Per l’Italia troviamo in Concorso nella selezione ufficiale il film italiano “Spaccapietre” di Gianluca e Massimiliano De Serio e Fuori Concorso “Samp” di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, “Extraliscio – Punk da balera” di Elisabetta Sgarbi, mentre nelle Notti veneziane figurano “Est” di Antonio Pisu, “Agalma” di Doriana Monaco, “iSola” di Elisa Fuksas, “Nilde Jotti, il tempo delle donne” di Peter Marcias, “En ce moment” di Serena Vittorini e “Solitaire” di Edoardo Natoli.
Anche la SIC-Settimana Internazionale della Critica, organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), si presenta quest’anno, alla sua 35.edizione con interessanti proposte: sette opere prime in Concorso e due eventi speciali, tutti presentati in anteprima mondiale.
“Il cinema, godardianamente un libro di immagini (nessuno è più rosselliniano di Godard), ha dichiarato il Delegato Generale della SIC Giona A. Nazzaro, è anche un contenitore di visioni, come ci ricorda “The Book of Vision”, il nostro evento d’apertura diretto da Carlo S.Hintermann”. Fra le opere prime scelte per il Concorso, film calati nel presente e proiettati verso il futuro. Lituania, Messico, Stati Uniti, Danimarca, Ucraina, Turchia. E tanta Italia. Cinema che rifiuta il conforto delle forme note e del consenso”. Dall’Italia, “Non odiare” di Mauro Mancini e “The Rossellinis” di Alessandro Rossellini.

Sono stati scelti titoli capaci di raccontare il presente, il mondo e la storia, continua Nazzaro, attraverso un cinema libero (ossia non sedotto dalla sua stessa mitologia): scelto film che potessero ripensare le forme del racconto popolare in piena deriva populista e contemporaneamente cercato di individuar sguardi e nomi per un possibile cinema del domani.
All’interno della Settimana della Critica avrà luogo anche il Concorso Cortometraggi SIC@SIC. La quinta edizione propone una selezione di sette cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio, e due eventi speciali fuori concorso, tutti presentati in anteprima mondiale. Il programma nasce dalla sinergia fra il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e Istituto Luce-Cinecittà, ed è una delle iniziative per il supporto allo sviluppo del nuovo cinema italiano e per la promozione dei giovani autori. In Concorso sono i cortometraggi “Accamòra” (In questo momento) di Emanuele Muzzupappa, “Adam” di Pietro Pinto, “Finis terrae” di Tommaso Frangini, “Gas station” di Olga Torrico, “J’ador” di Simone Bozzelli, “Le mosche” di Edgardo Pistone, “Were the leaves Fall” di Xin Alessandro Zheng. Come eventi speciali verranno proiettati “Les aigles de Carthage” di Adriano Valerio e “Zombie” di Giorgio Diritti.
Dopo l’anteprima a Venezia, il Dipartimento Promozione Internazionale Cinema Contemporaneo di Istituto Luce-Cinecittà offrirà ai cortometraggi presentati in Concorso a SIC@SIC varie opportunità di promozione a livello internazionale attraverso una serie di iniziative e festival. Inoltre, i corti saranno messi a disposizione dei professionisti di settore attraverso alcune piattaforme online e i tre premiati parteciperanno al TSFM – Torino Short Film Market, organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio.
Una Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che quest’anno è impreziosita dall’attribuzione del Leone d’Oro alla carriera alla regista Ann Hui e all’attrice Tilda Swinton e la presenza nelle Giurie dell’attrice Cate Blanchet (Presidente Venezia 77) e Claire Denis (Presidente Orizzonti).
Che la Festa dunque cominci! Con il sincero Augurio che il coraggio del Presidente della Biennale Roberto Cicutto e del Direttore della Mostra Alberto Barbera venga giustamente premiato.
OCCHIO CRITICO

SPIKE LEE: BLACK MOVIE MATTERS
di Marco Incerti Zambelli
Negli ultimi anni raramente le opere di Spike Lee hanno trovato la via dello schermo in Italia. Dopo il flop (al botteghino) di “Old Boy”, remake del capolavoro di Park Chan-Wook, solo “BlacKKKlansman”, grazie probabilmente all’Oscar conquistato, è approdato alle sale cinematografiche con un discreto successo commerciale.
In realtà il vulcanico autore afroamericano ha realizzato negli ultimi 5 anni un considerevole numero di lavori: quattro film, due serie televisive di 10 episodi ciascuna, tre stage shows (riprese di spettacoli teatrali), un video game, un lungo documentario ed anche alcuni corti per la rete.
Ora, grazie alle piattaforme digitali Amazon, Netflix, You Tube, è possibile visionare pressoché tutte queste opere e l’occasione è ghiotta per gettare un’occhiata alla sempre pregevole anche se discontinua produzione di Spike.

Su You Tube si trova facilmente “New York, New York”, un breve, sentito ed emozionato viaggio nella città ai tempi della pandemia: sulle note dell’omonima canzone di Frank Sinatra si ripercorrono i luoghi gioiosamente messi in scena nel precedente “Brave”, perfetto fashion movie per Monclerc, ora desolatamente vuoti, per arrivare ad un affezionato omaggio ai lavoratori della sanità impegnati nella lotta al virus.
Presentato in anteprima su CNN, “3 brothers” in 1’35” alterna frammenti dalle riprese in smartphone degli omicidi di George Floyd e Eric Gardner alle sequenze dell’uccisione di Radio Raheem in “Fà la cosa giusta”, per disegnare un’appassionata, potentissima denuncia della violenza e del razzismo della Polizia.
“Rodney King”, visibile su Netflix, è la ripresa dello spettacolo teatrale dello stesso nome, un lungo monologo scritto ed interpretato da Roger Guenveur Smith, che ha a lungo lavorato con il regista ed il cui precedente lavoro teatrale su H.P. Newton era pure diventato un film.
Lee utilizza dieci telecamere che alterna con efficacia e pur rinunciando ai virtuosistici movimenti che caratterizzano il suo narrare, sa rendere la complessa visione dell’autore sulla figura di Rodney King, uomo e simbolo, vittima duplice nella vita personale e nella vita pubblica, esaltando la straordinaria performance dell’attore.
“Pass over”, testo di Antoinette Nwandu portato sul palcoscenico dello Steppenwolf Theatre di Chicago con la regia di Danya Taymor, che si potrebbe tradurre con ‘passare oltre’ ma anche ‘trapassare’, richiama “Aspettando Godot” di Beckett, declinandolo nel presente del ghetto di Chicago. Moses e Kitch, i due giovani protagonisti, chiacchierano di tutto e di niente ad un angolo di strada, schivando pallottole vaganti, interrotti a tratti da un malevolo poliziotto (bianco) e da uno strano, inquietante, ambiguo, intruso (bianco), continuando a sognare una impossibile terra promessa. Con grande rispetto Spike filma in tempo reale la rappresentazione, concedendosi il superamento della ‘quarta parete’, a mettere in rapporto la platea afroamericana con la vicenda narrata. Su Amazon Prime.
Su Netflix le 20 puntate di “She’s gotta have it”. La serie meriterebbe un’analisi non superficiale ma ci basti qui sottolineare che nel riprendere le storie della protagonista del primo film del 1986, uscito in Italia come “Lola Darling”, Spike Lee ne attualizza le avventure erotico artistiche. Inanella per ogni puntata una questione attorno alla quale procedono le libertine relazioni dell’artista con i tre boyfriends (più una intrigante suggestione lesbica) dipinte con felice sensualità, con ironia e affetto non disdegna di mettere in luce le contraddizioni della comunità afroamericana, ammannisce colte citazioni cinematografiche sullo sfondo dell’amata Brooklin nel pieno della gentrificazione, messa in scena con la consueta maestria.
Nel campo della produzione più squisitamente cinematografica,nel 2015 esce “Da sweet blood of Jesus”, ora su Amazon, per la realizzazione del quale Spike Lee ricorre al crowdfunding, dato che nessun produttore era disposto a finanziare il progetto, remake di “Ganja and Hess”, dimenticato film del 1973, esempio tipico della blakploitation allora fiorente. Con il milione e mezzo di dollari raccolto il regista rilegge una confusa vicenda al confine con il vampirismo, nella quale il protagonista, un ricco professore di Antropologia, amante dell’antiquariato ed “emodipendente”, uccide un collega e ne beve il sangue per poi intrecciare una intensa love story con la di lui spregiudicata moglie. Una lussuosa, anche troppo, colonna sonora ed alcune ben riuscite scene erotiche non riscattano tuttavia un’opera che certo non è tra le più riuscite dell’autore afroamericano.

L’anno successivo, con il milione di dollari con il quale Amazon Studios finanzia per la prima volta un film originale, ritrova la sua forma migliore ispirandosi alla trasposizione in ambiente contemporaneo della Lisitrata di Aristofane. “Chi-raq”, il titolo del film, è una contrazione tra Chicago ed Iraq a sottolineare la analogia tra gli scontri tra bande di giovani neri nel sud della città e la guerra in Medio Oriente. La novella Lysistra, incarnata magnificamente dalla bellezza dirompente di Teyonah Parris, intelligente e determinata, dopo la uccisione di una bambina in uno scontro tra gang rivali, decide di negare al fidanzato, capo di una banda coinvolta nell’assassinio, i diritti coniugali. Coinvolge in una sorta di sorellanza mogli e compagne proclamando uno sciopero del sesso, ‘no peace, no pussy‘ lo slogan adottato, per mettere fine alle sanguinose scorribande dei loro uomini, che assume un ancor maggior dirompente effetto in una comunità che nell’eros trova rifugio dalle quotidiane frustrazioni. Su questa base Spike Lee sviluppa un musical hip hop, un melodramma rap, che mette a fuoco temi importanti: la politica delle armi della National Rifle Association, la violenza del nero sul nero, l’abbandono dei poveri alle forze del capitalismo, il corpo femminile come campo di battaglia. Alterna sequenze di drammatica, vibrante predicazione (il sermone di John Cusak, unico bianco all’interno della comunità, ai funerali della bambina) a numeri musicali di fiammeggiante eleganza (la sequenza iniziale di quella celebrazione delle esequie), grottesche parodie della stupidità dei conservatori bianchi (il vecchio generale con mutande a stelle e strisce sul cannone) a ironiche messe in scena della frustrazione dei maschi (le sconfortate litanie degli uomini in quarantena sessuale declamate per convincere le donne a interrompere le sciopero), il tutto legato dai pulsanti, sincopati monologhi di un elegantissimo Samuel L. Jackson in funzione di coro. Lee confeziona un militante, scatenato inno politico, che non risparmia certo la denuncia di complici responsabilità ed al contempo orgogliosamente, e generosamente, esalta la bellezza, la sensualità, il fascino del black people.
Del già citato “BlacKKKlansman” ha già parlato su queste pagine Francesco Saverio Marzaduri ed alle sue acute osservazioni sul n° 18 di Carte di Cinema si rimanda.
“Da 5 bloods” avrebbe dovuto esordire a Cannes 2020, in concomitanza con la direzione della Giuria affidata al regista afroamericano, ma il Covid 19 ha cancellato la manifestazione ed il film debutta su Netflik dalla metà di giugno. Generosamente finanziato per 35 milioni di dollari (che si vedono tutti) sconta in parte la bulimia narrativa e stilistica che contrassegna molte delle produzioni di Lee.

La vicenda è quella di quattro reduci afroamericani del conflitto Vietnamita che tornano nel Sudest asiatico per recuperare il corpo del loro caposquadra, vero e proprio mentore dell’affratellato quintetto, ma anche un tesoro in lingotti d’oro che serviva per compensare i collaboratori sudvietnamiti e che era stato nascosto per essere recuperato in seguito. Fatica vana cercare di riassumerne la trama, tanti e tali sono gli intrecci, le digressioni, le inversioni, i personaggi, le situazioni, le citazioni che si susseguono. Cripto-remake dell’avventuroso “Il tesoro della Sierra Madre” di John Huston è al contempo film di denuncia del misconosciuto ruolo dei soldati neri in Vietnam, di quella guerra stessa, ma anche rappresentazione degli scontri umani tra diverse personalità, tra padri e figli, della fatica di invecchiare portando il peso di tremende esperienze, e diventa, nel prologo e nell’epilogo, solenne invettiva sulla perenne condizione di subalternità della comunità nera. L’autore fatica a tenere uniti i fili pur affidandosi alla comprovata perizia stilistica: alterna l’inquadratura 2,4:1 del racconto contemporaneo al 4:3 dei flashback, colorazione sgranata a rimandare alle documentaristiche riprese a 16mm, inserisce riprese video e documenti d’epoca, esalta l’egregio lavoro alla fotografia di Newton Thomas Sigel con preziosi movimenti di macchina, trova nelle performances dei suoi attori, Delroy Lindo su tutti, un indispensabile sostegno, condisce il tutto con un’accuratissima colonna sonora che ha nel capolavoro ‘What’s going on’ di Marvin Gaye il suo fondamento. Ne risulta, pur nella faticosa durata di più di due ore e mezza e qualche sbavatura, un’opera che conferma la sincera passione, il rigoroso impegno, l’ingegnoso talento di un maestro della cinematografia degli ultimi decenni.
NEL CENTRO ITALIA DEI TERREMOTI
DUE FILM DI EMILIANO DANTE
di Tullio Masoni
…Mi sono ritrovato dentro uno spazio vuoto
inatteso. È un presente condiviso da molti:
stiamo attraversando un intervallo di sospen-
sione della quotidianità, un’interruzione del
ritmo…
(Paolo Giordano, Nel contagio, 2020)
Il terremoto dell’Aquila è del 2009. Poi, fra il 2016 e 2017 ci sono state le devastazioni e le tragedie di Amatrice, Norcia, Visso, Accumuli, Arquata del Tronto.
Emiliano Dante (emilianodante@hotmail.com) è dell’Aquila, abitava in centro storico. Per lui come per altri di cui riferisce brani di vita, il terremoto ha smesso di agire come scoppio rovinoso, shock, male improvviso, ed è diventato condizione costante, incertezza, fuga e resistenza, misura di sé. Un’esperienza di solitaria, grave precarietà, e di faticosa reinvenzione personale e sociale, cominciata “inconsapevolmente” dai documentari sull’abitare, coi quali esordì nel 2003, e proseguita dando forma a un vero progetto artistico, oltre che di necessità testimoniale, con: “Into the blue” (2009), “Habitat” (2014), e “Appennino” (2016). Sugli ultimi due – legati cronologicamente, e dal ricorrere di figure intese anche come caratteri del territorio, cercherò di mettere assieme un sintetico commento.

Il lavoro del cineasta – vale per lui un titolo che comprende scrittura, regia, fotografia, musica, montaggio… – si qualifica, con altro, per il tentativo di leggere il dopo-terremoto attraverso i segni, cioè le ferite materiali e sentimentali che il disastro ha lasciato di “permanenza” in persone e cose. Non si pensi a una modalità di inchiesta o reportage simili a quelli che la TV, spesso onestamente, ha proposto; basta qualche inquadratura per rendersi conto di una esigenza diversa e una diversa profondità. Emiliano non è solo un testimone che usa la telecamera, ma un artista che pur saldamente legato alla città, al territorio e alle persone cui il sisma ha cambiato la vita, non rinuncia mai a cercare un linguaggio proprio: quello che a lui sembra il più giusto sul piano comunicativo e, nel contempo, di esperienza poetica. Raccontare, cioè documentare, cioè indagare luoghi e anime, riflettere su di sé mentre il mondo, attorno, cambia con indisciplina estrema, replica blocchi e lunghe attese, pone la difficoltà di misurarsi col destino.
Emiliano Dante come dicevo è dell’Aquila e, nel centro della città, la sua casa subisce le visite dei ladri. Non c’è quasi più niente da rubare, ma ogni invasione somiglia a una nuova scossa.
Per un lavoro al Centro Sperimentale sono stato all’Aquila più volte. Erano passati sei anni dal terremoto: una città bombardata con tralicci fra le rovine, intonaci di interno desolatamente esposti; e gru, un’infinità. L’avevo scoperta come un grande centro di montagna e visitata, ora mi appariva guasta, come assediata da una volontà di ricostruire che premeva dall’esterno. Il centro restava per la più parte impenetrabile o proibito, con i ruderi della “Casa dello studente” in via XX settembre, le foto degli studenti caduti appese alla rete metallica insieme a “magliette di cordoglio” e alla bella, dolce e perfino rabbiosa poesia di Michele Fianco…Sei aprile/ ma fino a un certo punto. Notte. / intanto. Che dietro no, / non si porta un giorno/ nemmeno uno…
L’effetto “fantasmico” delle dissolvenze di “Habitat. Note personali” si confronta con l’immaginifica del limbo, cioè di una città per la quale i secoli, col terremoto, passano in un attimo: un presente “imposto”, dovuto alla riduzione del tutto a frammento, a irrimediabile incompiutezza.
Il film è in bianco e nero perché il colore suggerirebbe serenità, e invece l’autore vuole si avvertano la più drammatica incertezza e il bisogno permanente di avere un riparo. Ci sono persone che parlano, più che testimoniare, che meditano sulla propria condizione, su un attentato alla vita quotidiana che costringe a inventarsi nel disfacimento o invece spinge alla depressione. “Habitat”, nel suo svolgersi, non smarrisce mai la domanda sulla propria essenza di progetto filmico e al tempo stesso racconta, documenta. Emiliano arricchisce la fotografia con “artifizi” grafici e disegni; e parte dal proprio destino di fruitore del famoso “Progetto casa” voluto dal governo Berlusconi. Un progetto che prevedeva, dopo il ritorno degli abitanti alla città, una trasformazione degli stabili e degli agglomerati in campus universitario ma che, al di là dei buoni intenti (e del fattuale pericolo di infiltrazione camorrista), non poteva rispondere a specifiche e forti esigenze di identità. Agglomerati frazionati sul territorio che costringono all’uso dell’auto per ogni elementare bisogno e, in ultima istanza, tendono a farsi tautologia del terremoto, cioè a sancire – come l’autore avverte – la mutazione antropologica che un’improvvisa condizione di “città diffusa” crea nelle persone e nelle cose. Il centro distrutto dell’Aquila di “Habitat” – presente/assente – mi riporta a “Senza parole”, una esercitazione degli allievi del Centro Sperimentale diretti da Daniele Segre, e, per quanto concerne i faticosissimi tentativi di ripartire (o semplicemente reagire) a “Quattrosoldi”, il programma di documentari radiofonici – altra esperienza del gruppo guidato da Segre – che per un certo periodo Radio 3 ha proposto.
***
Emiliano Dante elabora immagini fotografico-filmiche, e ad esse alterna interventi grafici colorati, disegni e dialoghi a fumetti. Un modo per variare, cioè tenere costante una micro-sperimentazione fantastico-didattica.
Alcune figure presenti in “Habitat” continuano a vivere in “Appennino”.
Il film si apre con magnifiche immagini in b/n di monti e nubi: inquadrature fisse e scandite, per rendere omaggio a una terra, a un carattere regionale.

Il terremoto di “Appennino”, oltre a imporre un confronto dell’autore con se stesso e con altri che hanno condiviso l’esperienza di tenda, mensa, o del “Progetto-casa”, è anche alterità, cioè una condizione esistenziale obbligata che talvolta, per paradosso, implica la tensione a un volontario cambiamento. La voce fuori-campo, tradizionale nella storia del documentario, si avverte segnatamente come voce dell’autore che recita parole di diario: «…un terremoto che non è più il mio – dice riferendosi agli altri che sono seguiti ad Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto – ma è uguale al mio.», e potrebbe avere a contrappunto quella di Stefano: «…se non fosse per i morti la scossa me la terrei…»
I terremoti di “Appennino” sono “terremoti altrui” che muovono i sensi di colpa. “Appennino”, infatti, è la vicenda di già terremotati che guardano un altro terremoto. Incontriamo allora Giancarlo, che scrive e diffonde La scacchiera, un giornale che in qualche modo rappresenta la volontà del factotum di venire a patti col disastro; poi Enzo, unico abitante (abusivo) rimasto a Pescara del Tronto, una frazione di Arquata interamente distrutta; poi Elena – una volontaria di Ancona – e Stefano, entrambi sposati con figli, ma convinti a tentare, nel quadro di un grande impegno nei territori – una nuova storia sentimentale e di coppia; poi i “confinati” negli alberghi sulla costa, il cui profondo disagio è ambientale, sociale ed economico.
Quella del dopo terremoto è una sopravvivenza dai molteplici, squilibrati e imprevedibili aspetti. Anche per l’autore, naturalmente, che con le parole che seguono prova a descrivere, con una punta di humour, il proprio accidentato avvio di lavoro: «Ad agosto voglio fare un film sul post-terremoto all’Aquila. A settembre deve diventare un film sul post-terremoto ad Arquata. Ad ottobre voglio basarlo sul rapporto abitazione, terremoto e montagna. A maggio mi ritrovo con tutti i montanari che vivono al mare da 6 mesi.»
Dante, insomma, ambisce a un’opera di autenticità che non nasconda le debolezze: «Il terremoto è un enorme sarcasmo sulle nostre velleità progettuali» e al tempo stesso dichiari una ricerca di linguaggio leale quanto problematica e consapevole. Appennino, quindi, riassume nel finale l’idea di un cinema che non si trastulla con l’eterno scambio realtà/finzione, ed evita fiacchi (o maliziosi) manierismi: « …Il senso – dice il cineasta al momento di compiere – si dà alle cose. La ricerca del senso è un’attività: il cinema, per me, è questa attività. Grazie al montaggio formare un ordine nel caos generale, dare una forma stabile e definitiva a una vita instabile e transitoria. Una sorta di eternità illusoria ai luoghi, alle persone e al loro passaggio. Trovare all’ultimo un’architettura effimera che non pesi sulla terra.»
HOLLYWOOD SUL DANUBIO
“CURTIZ” DI TAMAS YVAN TOPOLANSKY; “FINAL CUT – LADIES AND GENTLEMEN” DI GYORGY PALFY.
di Paolo Vecchi
Nato a Budapest nel 1888, Mihaly Kértesz esordisce come regista nel 1912 dirigendo un numero cospicuo di film, dapprima in patria, poi in Austria e Germania. Nel 1926, spinto anche dall’aria che comincia a farsi irrespirabile per chi come lui è di origine ebraica, si trasferisce a Hollywood e anglizza nome e cognome in Michael Curtiz, caratterizzandosi da subito come solido professionista buono a tutto fare. “Curtiz”, primo lungometraggio di finzione del trentatreenne Tamas Yvan Topolansky, parte con un cinegiornale in cui Roosevelt annuncia l’attacco giapponese a Pearl Harbour. L’entrata in guerra sorprende il regista durante la lavorazione dell’opera che più di ogni altra lo consegnerà alla storia, e non solo del cinema, “Casablanca”. Irascibile con gli attori e gli addetti ai lavori del set a vario titolo, seriale tombeur de femmes nella vita privata, nonostante una fama consolidata di re del box office si trova ad affrontare, anche per la particolare circostanza storica, una nutrita serie di problemi che vanno oltre la spietata legge dello studio system. Ai rapporti, non sempre facili, con il tycoon Jack L. Warner e il produttore Hal B. Wallis, si aggiunge infatti quello, che diventa via via tempestoso, con Johnson, occhiuto quanto mediocre funzionario ministeriale incaricato di controllare l’allineamento del film alle esigenze propagandistiche del momento. A complicare le cose, il regista, che sta invano cercando per via diplomatica di salvare da Auschwitz la sorella Margit rimasta in Europa, riceve sul set la visita di Kitty, la volitiva figlia che non vede da diciannove anni e vive a New York con la madre. Difensore delle proprie idee di regìa quasi più per esuberanza di carattere che per coerenza aut*oriale, naviga a vista con uno script modificato giornalmente dagli sceneggiatori, i gemelli Epstein e, pur venendo praticamente esautorato dal proprio ruolo, riesce tuttavia a imporre quel finale destinato a commuovere intere generazioni.

Girato in un suggestivo bianco e nero memore di quello del testo di riferimento, solo saltuariamente screziato dal rosso della lampadina che indica il “si gira” nello studio o dall’azzurro del fascio del proiettore, “Curtiz” è innanzitutto il ritratto di un monumentale protagonista del cinema di una volta. Alla sua disincantata grandezza sul piano professionale corrisponde l’ambiguità su quello umano, dentro e fuori il luogo di lavoro. Per quanto riguarda la sua concezione del rapporto con gli attori, appare significativa la scarsa considerazione nei confronti di due mostri sacri come Bogart e la Bergman, qui opportunamente mostrati solo in silhouette, definiti in maniera sprezzante “un protagonista alcolizzato con la faccia da cane, una svedese che fa una norvegese”, mentre dimostra il proprio apprezzamento per Conrad Veidt, un tedesco fuggito dal nazismo dal quale si sforza tuttavia di “far uscire il nazista”.
Senza ricorrere al marchingegno delle somiglianze a tutti i costi, il giovane regista riesce a collocare sapientemente lo spettatore in un contesto di sconfinata ricchezza e crudeltà come quello della Hollywood classica, puntando più sull’analisi dei suoi meccanismi di funzionamento che sul suo fascino, dunque rifuggendo dalle accensioni del mélo. E tuttavia, prima che Curtiz pronunci il consapevole e fatidico “Sei pronto a fare la storia, Bogey?” davanti a un aereo di cartone pilotato da un gruppo di nani ingaggiati per renderne credibili le dimensioni, riesce ad architettare un crescendo di coinvolgente emotività nonostante gli sviluppi siano risaputi anche da chi non è proprio un appassionato cinéfilo. Girato in Ungheria nel 2018, “Curtiz” oggi lo si può vedere su Netflix.

Anche Gyorgy Palfy è nato a Budapest, ma quasi un secolo dopo il suo illustre concittadino. Ha esordito nel lungometraggio con il brillante “Hukkle” (2002), originale film non parlato in cui le vicende che vi si intrecciano sono intercalate dal singhiozzo (il titolo sta per il nostro hic) di un simpatico e pacioso vecchietto. Il seguito della sua non proprio sterminata produzione, a partire dal barocco, eccessivo “Taxidermia” (2004), testimonia di una continua ricerca di temi e stili, ribadita da “Final Cut – Ladies and Gentlemen” (2012), che a “Curtiz” è legato dal rapporto con il cinema. Si tratta infatti di un particolarissimo boy meets girl che inizia con “Avatar” e chiude sul “Dracula” di Coppola, fissato in 1400 inquadrature di 450 pellicole che attraversano praticamente tutta la storia della settima arte. I titoli di testa, con i nomi delle attrici e degli attori citati che vanno a comporre l’immagine di un bacio, sono degni del grande Saul Bass, la colonna sonora spazia da Steiner a Rota, da Rozsa a Morricone, da Delerue a Bregovic, il montaggio racconta una storia eterna attraverso le sue fasi obbligate. Palfy, che ha un paio di soggetti già pronti nel cassetto, dice di avere realizzato questo intelligente divertissement per reagire alla situazione di stallo della cinematografia ungherese, talmente povera da costringerlo a limitare la scelta ai dvd reperibili nel suo negozio di fiducia. “Final Cut” è del 2012 ma, non avendo il regista la possibilità di acquistare i diritti dei frammenti utilizzati, ha dovuto fino ad oggi limitarne la proiezioni ai festival (di Cannes, Torino e Trieste tra gli altri), oltre alle occasioni didattiche. Grazie alla distribuzione Wild Bunch, questo trascinante puzzle, che impegna il cinéfilo in una vertiginosa rincorsa sulle ali della memoria, è oggi disponibile su Sky.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
LO SGUARDO LATERALE
I DOCUMENTARI DI GIACOMO VERDE
di Marcello Cella
“Ho sempre pensato che il valore delle immagini video sta prima di tutto nel loro essere comunque astratte. Più del cosa rappresentano è importante il come: il colore, la luminosità, il contrasto, il ritmo e la qualità del movimento interno o del montaggio, il rapporto con il suono”.
Giacomo Verde, da “Artivismo tecnologico – Scritti e interviste su arte, politica, teatro e tecnologie”, Pisa, BFS Edizioni, 2007, p.63

E’ difficile incasellare l’opera di Giacomo Verde, una di quelle personalità artistiche che sfugge sempre alle definizioni e alle mode culturali. Certo è che la sua ricerca che in più di quarant’anni di lavoro ha spaziato dall’arte al teatro, dal video al documentario, dall’attivismo politico all’analisi teorica dei linguaggi, dalla crossmedialità alla controinformazione, dalla pittura alla musica, ha rappresentato per l’asfittico e spesso opportunista panorama culturale italiano una ventata di aria fresca, con porte e finestre linguistiche aperte e sbattute in faccia al conformismo.
Il fulcro del suo lavoro sta nell’incontro fecondo fra arte e impegno sociale e politico, fra etica ed estetica che mai ha abbandonato nel suo percorso artistico ed esistenziale, nella sua produzione di “azioni e processi” più che di oggetti. Tutta la sua opera è una continua contaminazione di linguaggi espressivi e di generi, una continua riflessione senza sconti e senza ipocrisie sui meccanismi economici, sociali e culturali che regolano le nostre società, un inesausto sforzo di liberare sguardi e menti dai pregiudizi e dai dogmi che li incatenano e gli impediscono di sperimentare la felicità che si prova nell’attraversare mondi e incontrare gli altri, l’Altro, dimenticandosi per una volta, o per sempre, del proprio Ego e confluire nella infinita creatività collettiva. Del resto la sua concezione dell’arte può essere racchiusa in una affermazione come questa: “Dipingere è qualcosa che si riferisce alla propria espressione personale (…). Preferisco fare qualcosa di più collettivizzante, interessante e utile al mondo”.
Quindi è sempre difficile dare una paternità autoriale al suo lavoro, perché, pur non rinunciando mai ad un evidente livello interpretativo del reale mutuato dai vari linguaggi utilizzati, Giacomo Verde rifiuta il privilegio autoreferenziale nel definirsi “autore”, a favore di una creatività collettiva, il General Intellect, che si esprime negli infiniti linguaggi e materiali della vita quotidiana, nella loro poesia incontaminata dalla ragione economica. E’ qui che sua la “visione orizzontale” della società, che nega gerarchie e modelli culturali ed estetici imposti dall’alto e a senso unico si incontra con il suo costante tentativo di umanizzare la tecnologia, di democratizzarne i meccanismi, di metterli al servizio della creatività di tutti gli umani. È qui che sta la sua ricerca di “un’arte nascosta nelle attività quotidiane, diffusa, che sa parlare anche delle zone d’ombra senza bruciarle alla luce, che non si chiude negli spazi privilegiati di musei e gallerie nel nome di una propria “originalità”, un’arte che non inibisce, ma stimola la creatività di ogni individuo, che segue i principi di “Bellezza e Giustizia” (come scritto da James Hillman) piuttosto che i soli principi di “economia politica” e affermazione personale”. In questo senso si fatica a dedurre nella sua immensa produzione artistica qualcosa che possa essere indicato e definito esplicitamente e senza dubbio alcuno come “documentario” nel senso di un genere cinematografico dedito più di altri alla riflessione sulle realtà sociali della nostra epoca, perché tutta la sua opera potrebbe essere definita in questo modo. Non c’è una produzione espressiva di Giacomo Verde che non sia una riflessione sulla realtà sociale, culturale, politica, economica della nostra epoca utilizzando di volta in volta un determinato linguaggio, e non c’è opera di Giacomo Verde che non sia contemporaneamente una riflessione sulle modalità espressive, sulle potenzialità e i limiti di un determinato linguaggio all’interno dei meccanismi sociali in cui si manifesta. Quindi qualcosa che svela la propria natura politica non in base al tema di cui tratta, ma in base al processo da cui nasce, qualcosa che non si limita a criticare il sistema capitalistico come bersaglio culturale e artistico di denuncia, ma come processo di pensieri e azioni che ne legittimano l’esistenza anche quando apparentemente lo criticano, perché non escono da quell’individualismo “borghese”, da quella personalizzazione dell’opera d’arte che è connaturata alla concezione dell’arte e della cultura unicamente come “genere”, cioè come tassello da inserire placidamente e senza intoppi in un “mercato”.

In questo senso anche i lavori che più decisamente possiamo definire come “documentari” non escono da questa logica espressiva e politica. “Solo limoni” (2001), “documentario poetico sui fatti del G8 di Genova del 2001”, e “S’era tutti sovversivi. Dedicato a Franco Serantini” (2002) in effetti rispondono a ciò che Giacomo Verde definisce come “documentario creativo”, cioè un’opera cinematografica che non si limita a riprendere il reale, a registrarlo nella sua, impossibile, oggettività, e che non rinuncia a proporre un proprio punto di vista, etico ed estetico, “d’autore”, inteso come entità collettiva e non individuale. Semmai, per quanto riguarda il reale, Verde cerca non di riprenderlo, ma di “sorprenderlo”, secondo quella tecnica dello “straniamento” ben esplicitata dal sociologo e mass-mediologo Mario Perniola che lo concepisce come un “trasporre l’oggetto della propria percezione abituale in una nuova percezione imprevista e sorprendente”.
Questa tecnica è particolarmente evidente in “Solo limoni” che racconta dal vivo e in prima persona (plurale) i drammatici avvenimenti del G8 di Genova del 2001 secondo una logica inedita e, appunto, sorprendente, sghemba rispetto alle due narrazioni dominanti di quegli avvenimenti, quella del Potere e quella, contrapposta, ma spesso speculare del Movimento.
Nel libretto che accompagna la pubblicazione del video, “Il popolo dei limoni”, Giacomo Verde lo presenta in questo modo: “Abbiamo scelto di parlare di limoni. Abbiamo scelto un approccio sghembo, un punto di vista apparentemente slogato e slegato dal ferro, dal fuoco, dal fumo, dal sangue di Genova e se abbiamo scelto di parlare d’altro è stato perché fosse chiaro che era proprio di Genova che volevamo parlare, è stato perché non volevamo cadere nella trappola vetero-ideologica del presunto impegno che mortifica la forma e fa ammalare di elefantiasi i contenuti, poiché Genova è stato qualcosa che ha travolto tanto i contenuti quanto le forme del nostro pensare, del nostro agire, del nostro immaginare, del nostro assentire o del nostro ribellarci. Un attimo prima che tutto fosse definitivamente sepolto dalla polvere delle Twin Towers. Abbiamo scelto lo spostamento laterale, metonimico, per sottrarci al disinganno di chi credeva che Genova fosse solo l’inizio, mentre oggi si rivela la fine di un certo modo, di un certo mondo e dunque, ovviamente, il principio di un inizio davvero nuovo, stupefacente, terribile, imprevedibile e inevitabile”. Coerentemente con questo assunto “Solo limoni” è un’opera che spiazza lo spettatore fin dall’uso spericolato e anti-realistico della colonna sonora, piena di echi e di inquietanti suoni elettronici che sembrano prefigurare il dramma collettivo che si va compiendo a livello visivo, con le cariche selvagge della polizia, i caroselli delle autoblindo, le reazioni violente dei manifestanti, i pestaggi assurdi, le incursioni dei “black bloc”, le auto incendiate, il sangue, le urla, gli insulti, fino al momento culminante della morte di Carlo Giuliani. Ma Giacomo Verde non si limita alla registrazione degli eventi e usa il livello sonoro per raccontare ciò che avviene a Genova secondo un’altra ottica, un’altra interpretazione che gli viene suggerita dai testi letterari che lo accompagnano, dal “Don Chisciotte” di Cervantes alle parole di Lello Voce, Patrick Chamoiseaux, Elio Pagliarani, Bertold Brecht, Piero Jahier, Roque Dalton, Elemire Zolla e dello stesso Giacomo Verde. Inoltre la telecamera spesso devia dall’”azione” principale e si avventura nelle strade laterali, fisiche e narrative, che inseguono spesso altri eventi apparentemente slegati dal racconto e altre contraddizioni. Come l’anziano signore che attraversa i luoghi devastati dagli scontri fra polizia e manifestanti come l’aborigeno impassibile che, durante la Seconda Guerra Mondiale, incontra i soldati americani nella foresta di Guadalcanal, in “La sottile linea rossa” di Terrence Malick, ignorandone la pericolosità e finanche l’esistenza. Nell’episodio intitolato ironicamente “Super discount”, la telecamera di Giacomo Verde si sofferma lungamente su un manifestante no global che esce da un supermercato devastato e saccheggiato trascinando un pesante carrello pieno di ogni ben di dio. Mentre, nell’episodio “Non calpestare le aiuole”, il racconto di Verde si concentra sui manifestanti che strappano i fiori da alcune aiuole e li pongono pietosamente sul sangue rappreso lasciato sull’asfalto dal cadavere rimosso di Carlo Giuliani. E potremmo continuare. “Solo limoni” assume comunque un tono rabbioso e malinconico, come se stesse raccontando la nostalgia per la fine di qualcosa di bello e di giusto (il movimento no global con i suoi sogni di cambiamento della società) e prefigurasse un futuro oscuro. In questo senso il mistero, svelato nel finale, della foto regalata a Giacomo Verde da un manifestante, che lo ritrae insieme ad una sua amica mentre si ripara dietro un albero dai lacrimogeni della polizia, assume un significato evocativo ed esplicito: la foto infatti richiama nei colori e nella composizione il famoso quadro di Masaccio “La cacciata dal paradiso terrestre”.

In “Solo limoni” è evidente, inoltre, un’altra caratteristica del particolare documentarismo di Giacomo Verde, e cioè l’azzeramento, o comunque la forte limitazione, della distanza fra realtà e osservatore, quella distanza su cui Verde aveva già riflettuto anni prima parlando della distanza tra il quadro e l’osservatore: “La distanza tra il quadro e l’osservatore non funziona più quando “tutti siamo nel quadro”. Tutti siamo parte del tessuto audiovisivo, del flusso sensoriale che caratterizza l’esperienza contemporanea: leggere l’opera vuol dire oggi leggere sé stessi”. Ed evitare un altro rischio dell’artista e dell’arte contemporanea, il rischio dell’’artista-zombie’ “che si nutre di organismi viventi, di eventi vitali e di vita reale per trasformarli in simulacri, rappresentazioni, feticci museali, cose senza vita, decorazioni, nature morte”. L’unica via di fuga per l’artista, come per il documentarista, rimane l’immaginario. Perché “le immagini trasmesse dalla televisione non sono quelle della realtà, ma quelle di chi vuole fissare per noi un punto di vista sul mondo (…) Nei media si tende ad utilizzare le immagini televisive come rappresentazioni del reale, non dell’immaginario”. Qui sta l’inganno, la manipolazione cui cerca di sfuggire Giacomo Verde. I suoi documentari non cercano mai di fissare nella mente dello spettatore un determinato punto di vista sulla realtà, ma semmai cercano di moltiplicare i punti di vista e dichiarano sempre esplicitamente la loro natura ibrida di realtà rappresentata, interpretata e immaginaria al tempo stesso.
Anche in un documentario più classico nella forma come “S’era tutti sovversivi”, che racconta la storia di Franco Serantini, lo studente anarchico ucciso dalla polizia a Pisa durante una manifestazione antifascista il 7 maggio 1972 e, in filigrana, un periodo storico, il movimento del ’68 pisano con le testimonianze di molti dei suoi protagonisti, il tono disincantato e malinconico della narrazione, delle interviste e degli inserti audiovisivi di repertorio, viene in qualche modo ribaltato dal tono rabbioso e corrosivo delle musiche e dei suoni che la accompagnano e contrappuntano, con le canzoni di Paolo Pietrangeli, Caterina Bueno, Michele Straniero e Cesare Bermani.

Mentre il montaggio non rinuncia agli ambigui incroci con la videoarte che donano al documentario un livello di interpretazione sotterraneo, profondo e misterioso, dove, forse, nel silenzio emblematico della riflessione, alberga il vero significato del film e degli avvenimenti che racconta, il non detto che rende “S’era tutti sovversivi” quanto mai attuale, nella sua accusa implicita contro una società ipocrita e violenta che sopprime i suoi figli migliori per mantenere ciecamente in vita un potere muscolare senza futuro e senza poesia che la conduce al disastro politico, morale e culturale. Cosa resta dunque di tanto pensare e agire, di tanta generosa ribellione alle lusinghe melmose del potere? Forse solo ciò che il potere ignora e che solo il popolo minuto riconosce come la vera ricompensa alle proprie sofferenze e delusioni, la creatività quotidiana, quelle piccole azioni e produzioni che rimangono nell’ombra dei media, quelle piccole/grandi lotte e insubordinazioni che hanno, come unica ricchezza, il profumo della libertà. Come il profumo dei limoni.
“Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra,
qui tocca anche a noi poveri
la nostra parte di ricchezza
Ed è l’odore dei limoni”
Eugenio Montale
Marcello Cella
SOLO LIMONI
Documentario poetico sui fatti del G8 di Genova del 2001
regia: Giacomo Verde
montaggio video: Fracesco Pera Turrini, Federico Carmassi
musica originale: Mauro Lupone
composizione video: Mauro Lupone, Uliano Paolozzi Balestrini, Elena Recchia, Giacomo Verde, Lello Voce
riprese video di: Giacomo Verde (giac), Teresa Paoli (ze) – Italy.IndyMedia – Uliano Paolozzi Balestrini, Pulika Calzini, Luca Tomassini, Tiziano, Lorenzo, Edoardo, Philippe, Vincent, Florence etc. – SocialPlus, Fluid video crew, Digipresse – Elena Recchia (bobò), Umberto Sebastiano, Francesco Villa – D.INK –
testi di: Giacomo Verde, Lello Voce, Patrick Chaamoiseaux, Miguel Cervantes de S.,Elio Pagliarani, Bertold Brecht, Piero Jahier, Roque Dalton, Elemire Zolla
voci fuori campo: Giacomo Verde, Lello Voce
foto di: Mirco Del Carlo
produzione: ShaKe Edizioni Underground, Reset, SeStessi Video
nazionalità: Italia
anno: 2001
durata: 44’35”
Web: https://www.youtube.com/watch?v=8dm75-HwNwY
S’ERA TUTTI SOVVERSIVI (dedicato a Franco Serantini)
regia di Giacomo Verde
durata: 56′ /
master: Betacam (girato in MiniDV) Pisa – Lucca,
maggio 2002
Produzione:
BIBLIOTECA FRANCO SERANTINI archivio e centro di documentazione di storia sociale e contemporanea Pisa / BFS EDIZIONI soc. coop. a r. l.
Web: https://www.youtube.com/watch?v=5iWw8Uoo30A
Sito internet di Giacomo Verde: http://www.verdegiac.org

INTERVISTA A JACOPO BROGI
di Paola Dei
Jacopo Brogi è un autore, documentarista e fotoreporter indipendente della Ong United Photo Press, facente parte del Collettivo Vox Populi e della redazione del sito di informazione indipendente ComeDonChisciotte.org.
Lo abbiamo intervistato per conoscerlo meglio e per avere informazioni sul suo lavoro “Laboratorio Grecia”, un viaggio che attraversa la Storia greca ed europea passata e recente: dalla seconda guerra mondiale alla crisi che viviamo. Un documentario di Storia e di tante storie.

Come si è avvicinato alla Regia?
Il cinema è sempre stata una mia grande passione, anche se ho capito che avrei dovuto cimentarmi nella regia, quando siamo entrati nel vivo di questo progetto inerente alla crisi greca ed europea; ha avuto una gestazione di oltre cinque anni, tra preparazione, inchiesta sul campo e riprese.
Siamo un collettivo esiguo ma combattivo, ognuno di noi si è adattato a fare mille mestieri, e alla fine abbiamo autofinanziato e autoprodotto un qualcosa che si spera risulti di pubblico interesse.
È ciò che ci interessa. Personalmente, sono un autodidatta: con tutti i limiti, ma anche le potenzialità che ciò può comportare: non si finisce mai di imparare, e anche questo è un ottimo antidoto per non accontentarsi, ma per migliorarsi. Un grazie va al mio grande amico, collaboratore e consigliere David Mitrani Arenal, colui che ha fatto il montaggio e tutte le animazioni originali. Senza David, non avremmo visto certamente questo tipo di documentario. Un grazie altrettanto prezioso va a Ruggero Arenella per le bellissime riprese e a Umberto Del Noce e Riccardo Donat – Cattin per l’aiuto in terra greca. È un’opera collettiva.
Quali sono state le maggiori difficoltà nella realizzazione dell’opera?
È stato un grande lavoro di studio, di ricerca sul campo (https://labgreece.org/it/sceneggiatura/ ), un lungo viaggio fra la gente comune, ma non solo. Accademici, letterati, politici, tecnici e governanti. Strano a dirsi, ma queste due ultime categorie, oggi come oggi, sembrano esercitare la medesima funzione nei riguardi della società.
Come ha portato avanti la ricerca iconografica e quella dei filmati reali?
Abbiamo utilizzato materiale di archivi pubblici (i principali: governo Usa e governo greco, Commissione Ue) e privati, sempre con un’attenzione massima al rispetto dei diritti d’autore. Ogni contributo, ogni clip è stata contrassegnata in video con il rispettivo logo indicante la provenienza, così come durante i corposi crediti finali troverete tutte le fonti audiovisive utilizzate, oltreché quelle bibliografiche e documentali.
Quanto tempo ha comportato approfondire l’argomento?
Personalmente, sono oltre dieci anni che studio queste dinamiche politiche, economiche e sociali. L’idea e la lavorazione di “Laboratorio Grecia” è il frutto, si spera non troppo amaro, di questa attività di approfondimento e di ricerca.

La ricerca sul campo ê stata fondamentale. Quanto ha trovato sostegno e aiuto in questa direzione?
È stato un lavoro collettivo, e senza la redazione greca del progetto, ciò sarebbe stato praticamente impossibile. Un grande ringraziamento va alla traduttrice ed interprete Nicoletta Fatsea, persona di grande professionalità e di gran cuore, senza la quale sarebbe stato impossibile portare avanti un progetto di queste dimensioni, peraltro prodotto contemporaneamente in tre lingue diverse (italiana, greca, inglese). Teniamo molto alla versione greca del documentario, che è innanzitutto dedicato a loro: sono un grande popolo che ha sofferto e sta soffrendo tanto. E poi molti greci ci hanno supportato e aiutato, in particolare, vorrei menzionare Kostis Gardikis e Dance with Invisible Partners per la colonna sonora davvero straordinaria, Charillaos Trouvas e Ioanna Forti per la loro incredibile voce, e anche Nikos Raftopoulos, persona di grande spessore e grande cultura, oltreché tutto il Collettivo di Kallithea. I greci non si arrendono mai, è anche questo che ci ha spinto per tutti questi anni.
Varie Università hanno già sposato il progetto da far visionare ai ragazzi come documenti storico. Ritiene che potrebbe diventare un film da proporre per le scuole?
Proporlo alle scuole è un nostro obiettivo, ma non è facile, specialmente oggi quando la didattica è diventata, per il momento, virtuale. All’Università di Ferrara lo hanno inserito come materiale di studio, speriamo che altri atenei facciano lo stesso. Il documentario ha fini esclusivamente informativi, divulgativi, didattici e culturali (è no profit). Quindi, ogni proposta in tal senso è benvenuta. Chiunque (istituzioni, aziende editoriali o privati cittadini) può divulgarlo. Chi fosse interessato, può scriverci a info@labgreece.org .

Ha intenzione di girare altri documentari? E su quali argomenti?
La particolare situazione che stiamo vivendo è un qualcosa che farà la Storia, oltreché segnare ineludibilmente il nostro futuro: difficile rimanere immobili ed indifferenti.
Quali difficoltà ha incontrato nella distribuzione?
Il film è uscito al cinema in versione greca lo scorso dicembre. È stato ospitato da sale cinematografiche della capitale; purtroppo non avendo mezzi, sponsor e capacità distributiva, il suo percorso è molto accidentato. Entrati improvvisamente in epoca Coronavirus, di fronte all’immane crisi che arriverà, ci è sembrato comunque appropriato pubblicare la versione italiana del documentario saltando a piè pari il blocco delle attività pubbliche dovuto alla emergenza nazionale in atto. Abbiamo ritenuto necessario pubblicarlo per spirito di responsabilità: quando il Presente sembra incerto e non lascia scorgere futuro possibile, è più che mai importante provare a guardarsi indietro: radici, Storia, memoria. Ma anche fatti, riscontri e documenti. Molto umilmente, nel nostro piccolo, cerchiamo di reagire in maniera umana e razionale a quanto sta capitando.
Per il momento, il documentario (versione italiana) è online da circa cinque mesi e lo scorso 8 maggio, sei tra i maggiori canali web di informazione indipendente (Pandora TV [film con sottotitoli di colore giallo: https://www.youtube.com/watch?v=Ewibly_yhXg ] -; Border Nights, Mepiù, Money.it, ComeDonChisciotte.org) lo hanno trasmesso in contemporanea a livello nazionale.
Stiamo riscontrando molti pareri positivi e avendo varie proposte di collaborazione. Speriamo di poter presto avere l’occasione di portarlo, in qualche modo e appena sarà possibile, nelle sale. Attualmente, non abbiamo alcuna distribuzione, ma amiamo il cinema e soprattutto il cinema in sala, ci piacerebbe dare un piccolo contributo alla socialità, visti i tempi che viviamo, ne abbiamo tutti un gran bisogno.
LABORATORIO GRECIA – IL FILM – DOCUMENTARIO INTEGRALE (sottotitoli di colore bianco):https://www.youtube.com/watch?v=cOFEaY9q6tE&feature=emb_title
IL FILM SUDDIVISO IN EPISODI: https://comedonchisciotte.org/laboratorio-grecia-i-singoli-capitoli/?fbclid=IwAR11APnGRJ4-zVFyLVxYNnBvhowzwRcyj6tTwwVp2_3XOhN4yjUANsv0rzg
CREDITI:
“LABORATORIO GRECIA” – LASCIATECI FARE VOL.2
Scritto e diretto da JACOPO BROGI
Ricerche documentali e inchiesta – JACOPO BROGI
Montaggio e animazioni originali: DAVID MITRANI ARENAL
Interviste: JACOPO BROGI, RUGGERO ARENELLA, UMBERTO DEL NOCE, RICCARDO DONAT – CATTIN
Redazione Atene: NICOLETTA FATSEA
Riprese: RUGGERO ARENELLA, JACOPO BROGI, DAVID MITRANI ARENAL
Musica: Dance with Invisible Partners
Voci narranti: Riccardo Viciani, Antonella Guidelli, Daniele Viciani
Durata: 165 min.
Colore Formato video: HD
Una produzione no profit Collettivo Vox Populi.xyz (2019
Sito web dedicato: www.labgreece.org
CREDITS
Carte di Cinema 22
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 22 della rivista online: Roberto Baldassarre, Marcello Cella, Paola Dei, Marino Demata, Mario Galeotti, Mario Giunco, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Alessandra Pighi, Riccardo Poma, Paolo Vecchi, Xoxan Villanueva, Marco Incerti Zambelli,

