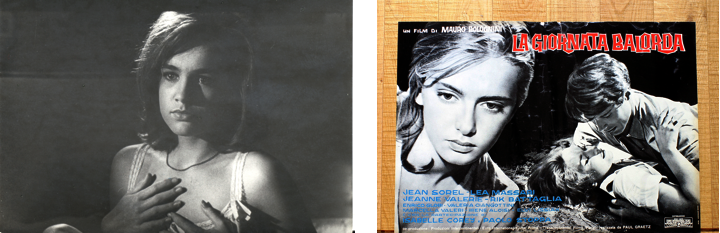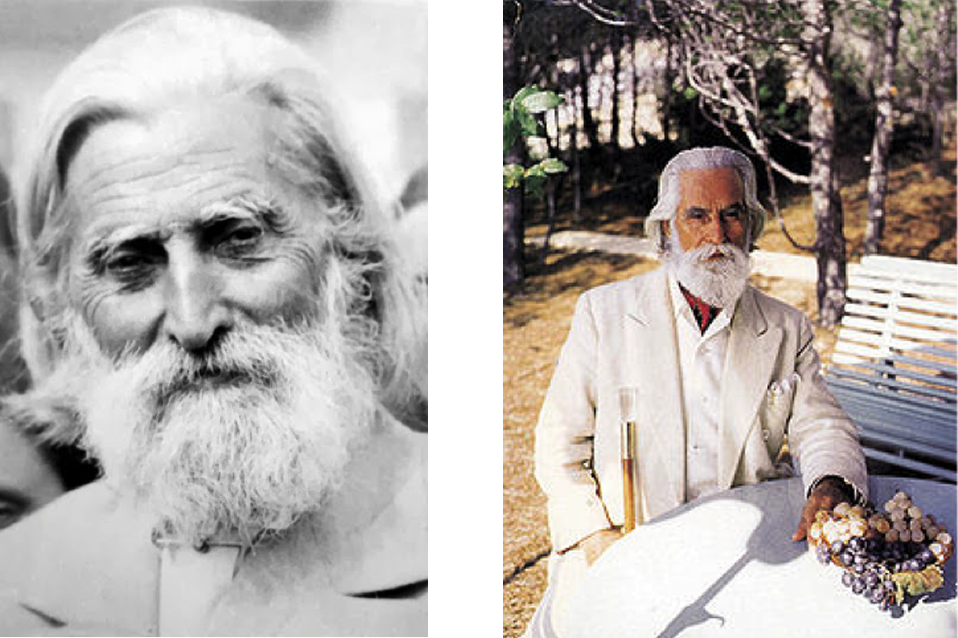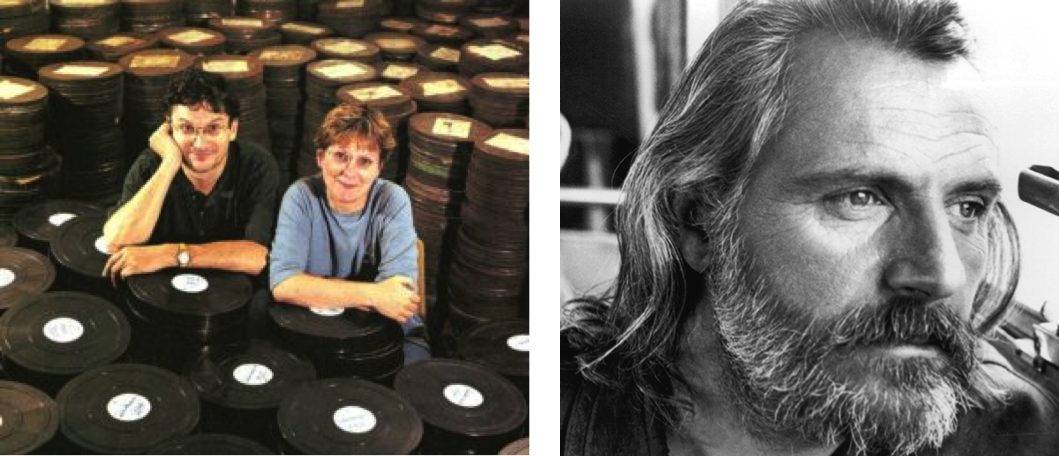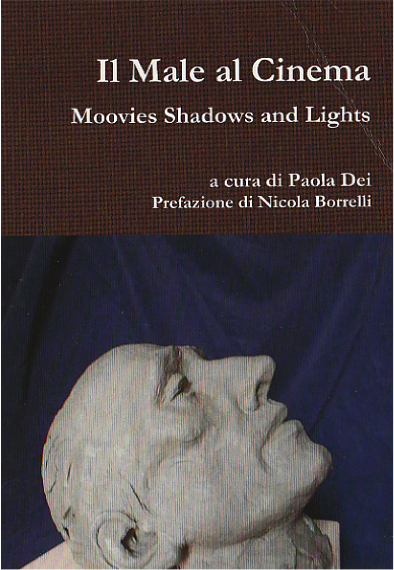Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 3.1 STEVEN SPIELBERG COME JAMES HILLMAN: “READY PLAYER ONE” di Roberto Lasagna
- 3.2 JERRY LEWIS, LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ANORMALE di Francesco Saverio Marzaduri
- 3.3 JAMES BOND – FENOMENOLOGIA DI UN AGENTE SEGRETO DAGLI ANNI ’60 AD OGGI di Riccardo Poma
- 3.4 LA FABBRICA DELL’INVISIBILE La censura cinematografica in Italia, dalle origini a oggi (1913 – 2017) Prima parte (1913-1962) di Alfredo Baldi
- 4 INCONTRI
- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 6 FESTIVAL ED EVENTI
- 6.1 GIOVANI AUTORI E MAESTRI AL FESTIVAL DEL CINEMA DI PORRETTA TERME CHE HA ANCHE OMAGGIATO UN’ATTRICE DIMENTICATA di Paolo Micalizzi
- 6.2 UN FESTIVAL BEN RADICATO NEL TERRITORIO DI TREVISO IL “SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL” di Paolo Micalizzi
- 6.3 TRIESTE FILM FESTIVAL 2018: PREMI, NUOVI TALENTI DELL’EUROPA CENTRO ORIENTALE, CINEMA DEL ‘68 di Paolo Micalizzi
- 6.4 DIMMI DELL’INDIA … di Maria Pia Cinelli
- 6.5 IL FERRARA FILM FESTIVAL 2018 di Maurizio Villani
- 6.6 CINEMA! STORIE, PROTAGONISTI, PAESAGGI A proposito della Mostra sul cinema del Polesine di Maurizio Villani
- 7 OCCHIO CRITICO
- 7.1 DREAM IS OVER: “TONYA” E “UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA” di Marco Incerti Zambelli
- 7.2 Altalene d’autore: “Ore 15.17 – Attacco al treno” e “A casa tutti bene” di Francesco Saverio Marzaduri
- 7.3 FAMIGLIE: “CHIAMAMI COL TUO NOME” DI LUCA GUADAGNINO E “LOVELESS” DI ANDREY ZVYAGINTSEV di Tullio Masoni
- 7.4 DUE FILM DI ADRIAN SITARU: “ILEGITIM” E “FIXEUR” di Paolo Vecchi
- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 9 QUALITA’ IN SERIE
- 10 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 11 CREDITS
ABSTRACT
E ULISSE PRESE IL FUCILE: CRISTI PUIU di Francesco Saverio Marzaduri
L’opera esaustiva di una tra le riconosciute individualità registiche del “Noul Val Românesc”. Nel contempo il ritratto di un cineasta rigoroso, scrupoloso nella registrazione di un quotidiano che s’innesta con la Storia.
STEVEN SPIELBERG COME JAMES HILLMAN: “READY PLAYER ONE” di Roberto Lasagna
In “Ready Player One” la vocazione educativa di Spielberg emerge con più veemenza e il grande videogioco cinematografico detta le regole di una rappresentazione immersiva che vuole manifestarsi come teatro del presente e del futuro, mimesi della nostra esistenza di Avatar e alibi della nostra vita dissolta con disinvolta baldanza nelle figure doppie di un videogioco quanto mai allegorico e animato in maniera metamorfica come un gigantesco affresco rinascimentale.
JERRY LEWIS, LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ANORMALE di Francesco Saverio Marzaduri
Ritratto di un maestro della comicità del Novecento: riflessioni su un paradigma concettuale dietro una maschera ilare.
JAMES BOND – FENOMENOLOGIA DI UN AGENTE SEGRETO DAGLI ANNI ’60 AD OGGI di Riccardo Poma
Il cinema di James Bond ha spesso modificato l’immaginario collettivo degli spettatori di tutto il mondo. Non solo. Ripercorrendo la saga si possono trovare testimonianze precise su quanto il mondo sia cambiato dal 1962 di Licenza di Uccidere al 2015 di Spectre.
LA FABBRICA DELL’INVISIBILE LA CENSURA CINEMATOGRAFICA IN ITALIA, DALLE ORIGINI A OGGI (1913-2017) – PRIMA PARTE (1913-1962) di Alfredo Baldi
La censura cinematografica, ovvero la “Revisione dei film”, nasce in Italia nel 1913, con il governo Giolitti. Si inasprisce durante il Fascismo che emana nel 1923 un Regolamento di attuazione che rimane in vigore per quasi quaranta anni. Terminata la guerra, la nuova legge sulla censura approvata nel 1947 dall’Assemblea Costituente mantiene in vigore molte delle vecchie norme, nonostante che la Costituzione preveda il solo limite del “buon costume”. Con i governi a maggioranza DC la censura diviene sempre più rigida e repressiva e provoca continue proteste degli uomini di cinema e degli intellettuali. Finalmente nell’aprile 1962, dopo oltre un decennio di battaglie, è approvata la nuova legge, tuttora in vigore anche se destinata a scomparire rapidamente.
INCONTRO RAVVICINATO CON UN GRANDE REGISTA: DAVID LYNCH di Paola Dei
Incontro in occasione della Festa di Roma 2017
FILMMAKER ALLA RIBALTA: LAURO CROCIANI di Paolo Micalizzi
Profilo di un filmmaker Fedic attivo dal 1993 con cortometraggi comici o legati a temi filosofiche/spirituali. Opera poi come Presidente di un Cineclub che per divulgare il cortometraggio organizza proiezioni in piazza ed in altri luoghi, corsi di audiovisivi, programmi televisivi ed un Festival giunto alla 18.a edizione.
GIANCARLO GIANNINI MATTATORE AL MISFF 68 di Paolo Micalizzi
Un’edizione del Festival con mattatore l’attore-regista Giancarlo Giannini, premiato, cosi come Sarah Maestri e Sebastiano Somma, con l’Airone d’oro. I premi del Festival ed il rapporto con la Scuola.
GIOVANI AUTORI E MAESTRI AL FESTIVAL DEL CINEMA DI PORRETTA TERME CHE HA ANCHE OMAGGIATO UN’ATTRICE DIMENTICATA di Paolo Micalizzi
Un Festival dell’Appennino bolognese che continua a promuovere il Cinema libero e che nel 2018 ha premiato il regista Silvano Agosti e riscoperto l’attrice Evelyn Stewart, ha omaggiato Roberto Rossellini e presentato giovani autori.
UN FESTIVAL BEN RADICATO NEL TERRITORIO DI TREVISO IL “SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL” di Paolo Micalizzi
Un Festival che vuole essere un ponte tra le culture che ha origine a Palermo e si è ben radicato anche a Treviso: Premi e iniziative, Omaggio a Flaherty.
TRIESTE FILM FESTIVAL 2018: PREMI, NUOVI TALENTI DELL’EUROPA CENTRO ORIENTALE, CINEMA DEL ‘68 di Paolo Micalizzi
Premi ed omaggi, Cinema sui“ Ribelli” del 68 alla ventinovesima edizione di un Festival dedicato all’Europa del centro-orientale
DIMMI DELL’INDIA … di Mariapia Cinelli
Il 17° River to River Florence Indian Film Festival, l’unico in Italia interamente dedicato al cinema indiano, come ogni anno ci accompagna in un viaggio al centro dell’universo eterogeneo dell’industria cinematografica più prolifica del mondo.
IL FERRARA FILM FESTIVAL 2018 di Maurizio Villani
Premi e film di questo Festival diretto da Maximilian Law, giunto alla terza edizione.
CINEMA! STORIE, PROTAGONISTI, PAESAGGI. A PROPOSITO DELLA MOSTRA SUL CINEMA DEL POLESINE di Maurizio Villani
La Mostra aperta a Rovigo, curata da Alberto Barbera si propone di ricostruire con una ricca documentazione la storia del rapporto fra il Polesine – un territorio dalle caratteristiche pressoché uniche – e il cinema.
DREAM IS OVER: “TONYA” E “UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA” di Marco Incerti Zambelli
Due film americani, con attenzione al racconto della realtà dai tratti documentaristici pur nella diversità dei toni, raccontano il venir meno, con amaro umorismo, lo svanire del sogno americano.
ALTALENE D’AUTORE: “ORE 15.17 – ATTACCO AL TRENO” E “A CASA TUTTI BENE” di Francesco Saverio Marzaduri
“Ore 15.17 – Attacco al treno”. 21 agosto 2015. Il mondo assiste stupefatto alla notizia, divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre giovani americani in viaggio per l’Europa. Il film ripercorre le esistenze dei tre amici, dai problemi dell’infanzia alla ricerca del proprio ruolo nel mondo, fino agli sfortunati eventi che anticiparono l’attacco.
“A casa tutti bene” – Un’improvvisa tempesta blocca su un’isoletta una famiglia riunita per festeggiare le nozze d’oro di due anziani genitori. L’ingente parentela è costretta a convivere sotto lo stesso tetto per due giorni e due notti, senza vie di fuga. E la tempesta che tormenta l’isola, ineluttabilmente, finisce per intrecciare (e agitare) le esistenze di fratelli, cugini e nipoti, tra antichi dissapori mai sopiti, un presente che riaccende irrisolti conflitti e un futuro incerto.
FAMIGLIE: “CHIAMAMI COL TUO NOME” DI LUCA GUADAGNINO E “LOVELESS” DI ANDREY ZVYAGINTSEV di Tullio Masoni
“Chiamami col tuo nome” è forse l’opera stilisticamente più riuscita di Guadagnino. Ma subisce il fascino e la compiacenza di una calligrafia cui corrisponde lo smussamento dei contrasti. Rohmer un po’, Ozon di più.
“Loveless”. L’amara, crudele e tragica vicenda di un ragazzo che scompare mentre i genitori stanno divorziando. Un “umiliato e offeso”. Dopo “Leviathan”, Zvyagintsev continua a denunciare i mali della Russia di oggi.
DUE FILM DI ADRIAN SITARU: “ILEGITIM” E “FIXEUR” di Paolo Vecchi
“Ilegitim” esordisce con la rivelazione del passato nascosto di un padre che durante il regime di Ceausescu si è adoperato a impedire l’aborto di molte donne, poi il nucleo del racconto si sposta sul rapporto incestuoso dei suoi figli gemelli in seguito al quale la ragazza è rimasta incinta, riproponendo dunque il problema dell’interruzione della gravidanza.
“Fixeur” sembra dapprima un’inchiesta sulla prostituzione delle minorenni e la “tratta delle bianche” verso la Francia, evolvendo poi come film sul dilemma etico, e in qualche modo teorico, di chi si dedica al cosiddetto cinéma-vérité, o vita in diretta televisiva, oltreché come road movie sulla Romania profonda, lontana da Bucarest cento chilometri e cento anni.
LA STORIA DIETRO LA PORTA CHIUSA: di Marcello Cella
Le due giovani registe serbe raccontano la storia di due donne anziane che fanno i conti con la Storia recente e passata del proprio paese senza sconti per nessuno. Una riflessione sulla Serbia, sui Balcani e sull’Europa consegnata alle giovani generazioni.
TERRITORI DI CONFINE: “QUARTIERE PABLO” DI PIETRO MEDIOLI di Marco Incerti Zambelli
La recente opera di Pietro Medioli è un riuscito esempio di quel ‘cinema del reale’ nel quale la possibilità di ibridazione tra documento e narrazione, che la tecnologia digitale favorisce, apre nuovi affascinanti territori al cinema contemporaneo.
TRUMP: AN AMERICAN DREAM di Giancarlo Zappoli
In quattro episodi ricchi di materiali spesso poco noti a noi europei viene tracciato un ampio ritratto dell’inquilino della Casa Bianca attraverso le testimonianze di collaboratori, ex sostenitori ed avversari.
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
Segnalazioni-recensioni di libri, recenti, dedicati a Michelangelo Antonioni, a “Cinebreviario 1950-2000”, Anton Giulio Majano, “Il Male al cinema” ed a Sandro De Feo.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
E ULISSE PRESE IL FUCILE: CRISTI PUIU
di Francesco Saverio Marzaduri
 A volte può essere il Paese, col proprio retroterra culturale. Altre volte la Storia, col proprio ingombrante fardello. Allo stato dei fatti, è però il Destino a decidere delle esistenze umane e a chiamare al cospetto le citate influenze. È la realtà, al pari di una sinistra presenza, a insinuarsi nella vita di un cineasta in divenire, determinata da eventi che a loro volta fungono da base (e all’occorrenza monito) per una produzione dove il peso della Storia, con le sue drammatiche conseguenze, si rivela fattore vincolante e ineludibile. Per uno spettatore disattento o superficiale, sarebbe facile liquidare la filmografia di Cristi Puiu apparentandola a quelle di cineasti connazionali della stessa generazione, a quel “Noul Val” la cui linea di pensiero non fa del gruppo una corrente cinematografica, ma uno stato d’animo indotto dalla volontà di focalizzarsi sulla storia del Paese, operazione proibita dal regime di Ceaușescu, con accurata esattezza filologica.
A volte può essere il Paese, col proprio retroterra culturale. Altre volte la Storia, col proprio ingombrante fardello. Allo stato dei fatti, è però il Destino a decidere delle esistenze umane e a chiamare al cospetto le citate influenze. È la realtà, al pari di una sinistra presenza, a insinuarsi nella vita di un cineasta in divenire, determinata da eventi che a loro volta fungono da base (e all’occorrenza monito) per una produzione dove il peso della Storia, con le sue drammatiche conseguenze, si rivela fattore vincolante e ineludibile. Per uno spettatore disattento o superficiale, sarebbe facile liquidare la filmografia di Cristi Puiu apparentandola a quelle di cineasti connazionali della stessa generazione, a quel “Noul Val” la cui linea di pensiero non fa del gruppo una corrente cinematografica, ma uno stato d’animo indotto dalla volontà di focalizzarsi sulla storia del Paese, operazione proibita dal regime di Ceaușescu, con accurata esattezza filologica.
Tangibile è il desiderio di ricostruire un’identità socio-culturale a lungo manipolata dagli organi di Partito, né si può negare che Puiu medesimo serbi origini cinematografiche comuni a quelle di film makers più o meno coetanei – la “nuova onda”, appunto. Eppure, non è necessariamente con la registrazione di episodi reali avvenuti in un trentennio di dittatura, grottescamente definita “Età dell’Oro”, che si può analizzarne l’eventuale politique alla stregua di Mungiu, Netzer, Porumboiu e dei tanti altri mai distribuiti da noi. E non occorre individuare nella scelta della camera a spalla, benché non la sola presente, la cifra stilistica dominante, assurta a biglietto da visita per una filmografia che fin dagli inizi, come addetto ai lavori, avrebbe permesso al futuro autore di “Moartea domnului Lăzărescu” (“La morte del signor Lăzărescu”) di trovare nel cinema la giusta forma d’espressione per testimoniare una realtà, quella del Paese, non obbligatoriamente storica e più nascostamente intima. Questo non significa che il Passato e le sue dolenti conseguenze, in Puiu, non abbia rilievo; ma è il Presente, il Qui e Adesso, a imporsi quale principio di necessità: quasi che il regista-sceneggiatore guardasse allo scavo psicologico dei personaggi di volta in volta messi in gioco, facendo della disamina in toto, che comprende loro e il futuro in cui versano, un’analisi introspettiva delle proprie inquietudini, delle proprie ossessioni, dei propri tormenti. Qualcosa, insomma, di assolutamente originale nel campionario di nuovi autori romeni, che nulla ha da invidiare alle visioni d’insieme dei colleghi. Ma se talvolta, si diceva, è il Fato a servire le carte giuste, ecco che il cinema ha permesso a Puiu di trovare un secondo habitat naturale. Come guardare al protagonista di “Aurora”, quarto lavoro di quest’autore, se non a una figura disarmata, privata di un’identità e una storia, alla ricerca di qualcosa d’inspiegabile e tanto alla deriva da vagare per le vie di Bucarest imbracciando un fucile? Un disagiato esistenziale, paranoico e maniacale ma gelidamente lucido, che la macchina da presa segue incessante e invisibile, mostrandone in modo minuzioso e ripetitivo anche i gesti più insignificanti. A interpretarlo, non per niente, è lo stesso Puiu, maschera opaca e occhiata sghemba, la cui regia, precisissima e straordinariamente efficace, pare unicamente interessata ai segnali del disarmo dell’uomo a contatto con l’ambiente che lo circonda – laddove lo sguardo dell’osservatore, nello scrutare e filtrare la realtà, ne diviene l’ineludibile complice.
“Una tra le prime cose che s’imparano del cinema è che si tratta di un’arte dai puntini di sospensione. In quest’opera non mi nascondo dietro le cose: ho pensato che osservare, e rimirare ancora per pochi istanti, mi consentisse di narrare con più facilità.”
Ma non occorre spingersi troppo oltre nella filmografia di Puiu alla ricerca di modelli ipertestuali di riferimento, pur presenti, in quei maestri del cinema realista che vanno da Godard a Bresson, da Wiseman a Depardon, sino a Cassavetes, dove la verità registrata dal mezzo filmico durante la ricerca si fa meta naturale. E quest’ultima, sposando l’apologo di semplicità intimista à la Rohmer al senso di sacralità stile Kieślowski, si trasla in forma di limpido racconto, perseverando nel primario obiettivo del cinema romeno odierno di mettere a nudo destabilizzazioni e crisi di una nazione allo specchio.
“I registi fanno domande circa l’esistenza umana, la natura, il mondo. Cerco di utilizzare lenti che non deformino l’immagine, ma siano attigue a ciò che si coglie nel quotidiano. Nel compiere questa ricerca, occorre trasformarsi in un antropologo visuale.”
Se la politique di Puiu, in questo senso, si apparenta allo sguardo d’insieme generalmente diffuso dal “Noul Val”, prima ancora le origini anagrafiche non si discostano granché da quelle di altri nomi dell’ondata: come molti di loro, anche Puiu è nato a Bucarest e analoga è l’esperienza di vita coltivata fuori dal Paese, che all’inizio degli anni Novanta gli permette di studiare pittura all’École Supérieure d’Arts Visuels di Ginevra e, prima di laurearsi nel ’96, scoprire una realtà differente da quella a lungo imposta in Romania. Il che non gli impedisce, una volta tornato in patria, di esercitare l’apprendistato cinematografico a fianco del maestro Lucian Pintilie (il quale, come lui, non ha mai fatto mistero delle proprie influenze avanguardiste), rispettivamente in qualità di consulente artistico e sceneggiatore per “După-amiaza unui torţionar” (in italiano, “Il pomeriggio di un torturatore”) e “Niki Ardelean, colonel în rezervă” (conosciuto anche come “Niki et Flo”). Titoli che una decina d’anni prima di “Aurora”, pur appartenendo all’occhio polemico e provocatorio del metteur en scène, non riescono a camuffare completamente un punto di vista “giovane”, lucido e disarmante, sulla realtà attuale di un Paese posto di fronte a un avvenire incerto, segnato dalle indelebili cicatrici della Storia. Ma l’autorevole presenza di Pintilie non deve apparire l’unica credenziale di Puiu, giacché il percorso da questi compiuto nel campo è comune a quello della sua generazione: non solo l’esperienza da studente all’estero, che già provvede ad arricchirne il bagaglio culturale, ma anche il corretto professionismo in tutti quei rami, dallo short allo spot pubblicitario, il cui impiego permette di compiere il balzo verso la macchina da presa con una trama a soggetto e una produzione a basso costo.
Il suo debutto come regista-sceneggiatore, “Marfa şi Banii” (letteralmente “merce e denaro”), ha luogo nel 2001, dopo che una tumultuosa crisi economica ha obbligato la Romania a non distribuire alcun titolo. Ma il film riceve numerosi premi in festival internazionali, addirittura gareggiando nella sezione “Quinzaine des Réalisateurs” della Croisette, inaugurando nel Paese una rinascita cinematografica che prolifera di talenti, lo sguardo rivolto a una dimensione del reale di cui si vuole evidenziare ogni contraddizione. Più d’uno sostiene, con buona ragione, che sia questo il primo lavoro della “nuova onda”, sebbene in patria raccolga tiepidi entusiasmi, e perfino qualche noia con la censura. Vi si nota come le influenze europee, lampanti, si alternino ai modelli statunitensi e alle correnti sperimentali: “Marfa”, infatti, segue la strada del road movie d’intrico thrilling per fotografare il viaggio da Constanța a Bucarest di un ventenne aspirante imprenditore, prezzolato da un boss locale per trasportare un pacchetto dal dubbio contenuto. La suspense, tutta velocità e pericolo come in molto cinema americano anni Settanta-Ottanta, si mescola col realismo dell’apologo e lo humour che trapela dai dialoghi vacui e cinici dei protagonisti. Tuttavia il vago desiderio di libertà, tematica ricorrente negli spiriti libertari in procinto di rompere con le ombre del passato e andare controcorrente verso ipotetiche vie di fuga, si trova a fare i conti con l’evidente realtà di un Paese incapace di evadere dalle proprie prigioni morali: il consumismo e la corruzione simboleggiati dal titolo, elevati a incontestabili simboli di un benessere non conseguito, appaiono la meta più comoda da raggiungere (“Viviamo in una finzione cosmica, e non possiamo evaderne”). Non esiste altro rifugio, la concezione di amicizia si macchia all’istante in nome di loschi profitti, la voglia di allontanarsi alla ricerca di sé stessi è un’utopia tutta (o meglio, solo) americana: i nuovi animi ribelli non cercano neanche lontanamente di somigliare ai prototipi, ne restano sbiadita copia. E come si verifica in tanto successivo cinema romeno, preferiscono cedere all’insofferenza e al conformismo. Fotografia implacabile di una Romania contemporanea in cui la transizione democratica e la legittima rincorsa al benessere sono minati da opportunismo e violenza dietro ogni angolo, l’esordio di Puiu è contrappuntato dall’assidua presenza della macchina a spalla, inversa alla concezione di metafora, in interminabili camera-car dove l’atto di spiare l’azione si fa machiavellica complicità dello spettatore verso la vicenda narrata e il realismo che la permea, quasi vi fosse trascinato di peso. Ma pure sinistra effigie tesa ad avvertire, senza poterlo fare, che qualcosa di nefasto e demoniaco succederà ai personaggi, troppo tardi per tornare indietro.
Si tratta di un calvario ancora poco spirituale, lontano dalla santità di lì a poco volta a rinsanguare il progetto di sei opere ambientate nella periferia di Bucarest, che il cineasta mira a concepire memore dei “Racconti morali” di Rohmer. Con tale serie Puiu intende esplorare sei tipi di storie d’amore, e già con “Moartea domnului Lăzărescu” si vuole esaminare l’amore per il prossimo, seguito, nelle successive opere in lavorazione, da quello tra un uomo e una donna e da quello per i figli, poi da quello per il successo a quello tra amici, per concludere con l’amore carnale. La Settima Arte diviene espediente introspettivo atto a evincere la dimensione globale più veritiera, come il regista è chiamato ad assumere il ruolo di un investigatore entro un perimetro che permetta di risalire da un ristretto raggio a una più ampia area. E l’intento della macchina da presa, in questo senso, è esorcizzare la fiction per arrivare alla sfera più genuina della mente umana quale modalità per esprimere la politique, intesa come sguardo, assurta a finestra sul mondo. Si mira a squarciare il velo della finzione onde conseguire, in modo intenzionale, il reale quotidiano del mondo (l’individuo e l’area in cui è al centro) per ottenere un’idea antropologica ch’è l’esatta antitesi dell’archetipo iniziale.
“Vorrei ottenere sei lavori che evocano un dato periodo di tempo con una dimensione forte e dal valore storiografico importante. Sono nato nel ’67, quindi questo periodo di tempo è importante per me. La Romania è cambiata molto. È assai difficile trovare le immagini della vecchia Bucarest nella narrativa romena.”
La vita si fa dispositivo più importante dell’arte, e il reiterante impiego della cinepresa si fa terzo occhio. A propria volta, il riutilizzo degli stessi interpreti e comprimari è qualcosa che Puiu eredita dalla Nouvelle Vague, ma prima ancora dalla letteratura, con Balzac in testa. L’autore afferma di aver progettato una sinossi per ognuno di questi lavori, laddove di amore – nel senso religioso del termine – in “Marfa” non c’è traccia (nemmeno negli slanci fra i due protagonisti). Ma già la cifra autoriale, fondata su un notevole dosaggio di realismo critico, dramma sociale, sperimentalismo formale e humour nero, fa la propria apparizione prima di stemperarsi nei successivi Golgota di “Moartea” e “Aurora” in tono via via più asciutto.
Se in un certo senso Puiu è il talento più “americano” del “Noul Val”, il suo mentore Pintilie riesce ad esserlo senza l’impellente necessità di guardare al prototipo. Il cortometraggio “Un cartuș de Kent și un pachet de cafea” (“Un pacchetto di Kent e un cartoccio di caffè”) ostenta la scelta arbitraria, anche se non dichiarata, di una mise en scène occidentale che non rinuncia ai dilemmi intimisti del reale quotidiano nel suo Paese: ma l’azione si riduce a pochi personaggi, addirittura a due, e si ricollega a un modo di fare cinema inevitabilmente europeo, nella fattispecie francese. L’esplicito tributo all’episodico “Coffee & Cigarettes” di Jarmusch, di cui Puiu riprende il paradigma e gli frutta l’Orso d’Oro a Berlino per il miglior corto, inscena – molti anni prima di Mungiu – un padre e un figlio seduti al tavolo di un bar intenti a discutere senza capirsi: troppo grande è il divario culturale, sociale e affettivo che separa le due generazioni, e di nuovo a fare capolino sono i symbol del benessere occidentale assurti a merce di scambio e corruzione.
Su un’analoga falsariga, nel segmento “Reveillon” (“Vigilia di Capodanno”) del corale “I ponti di Sarajevo”, del 2014, si mette a confronto una coppia di mezz’età nell’atto di coricarsi la notte di San Silvestro e, riflettendo su un volume del filosofo Hermann Graf Keyserling, trova motivi sufficienti a sfamare, tra pregiudizi e autoironia, il proprio appetito xenofobo: si ride a denti stretti su quel che i romeni pensano dei vicini ungheresi, greci, slavi, bulgari, e inevitabilmente sugli odiati rom. A contare qui è il tassello di un mosaico, la Storia, che il signor Popescu cerca di spiegare alla coniuge, assemblando pezzi che non s’incastrano in un puzzle destinato a restare incompleto. “I ponti di Sarajevo”, infatti, è un’opera collettiva firmata da tredici registi del cinema europeo in occasione del centenario del primo conflitto mondiale, i cui episodi offrono una visione globale della città, tra quel che ha rappresentato nella storia europea dell’ultimo secolo e quel ch’è oggi in Europa. L’operazione “visione d’insieme”, che torna ad assumere valenza mistica, è ciò che mostra “Trois exercices d’interprétation”, risultato di un lavoro di gruppo guidato da Puiu medesimo, che scrive la sceneggiatura sulla base di un testo del poeta e teologo russo Vladimir Solov’ëv, “I tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo”. Imperniato su tre temi – la guerra, la morale, la religione – quest’adattamento, in forma di linguaggio contemporaneo, è una ricerca che il cineasta compie incoraggiando gli interpreti a improvvisare, mantenendo il significato originale del volume, attraverso dialoghi tra personaggi che incarnano il passato, il presente e il futuro, esprimendo l’incertezza nella visione dello stato in cui versano la cultura, il progresso, la Chiesa. Opera di nicchia, non concepita per un vasto pubblico, l’esito è un trattato intelligente, divertente e ironico, ancora una volta degno dell’amato Rohmer, in cui ogni esercizio annovera un incontro improvvisato con destrezza fra quattro diversi personaggi.
“Le mie principali influenze derivano dalla letteratura romena, e uno degli artisti che mi hanno più influenzato è Eugène Ionesco col suo Teatro dell’Assurdo. Gli altri sono due poeti, che io definirei i ’poeti della silenziosa disperazione,’ George Bacovia e Virgil Mazilescu. Nella letteratura universale e nell’arte ho trovato altri modelli quali Franz Kafka, Dostoevskij, e il pittore italiano Giorgio Morandi.”
Uno sguardo carico di pessimismo verso la Romania del Duemila trapela dalle immagini del secondo lungometraggio, “Moartea domnului Lăzărescu”, salutato come l’atto di conseguita maturità del nuovo cinema nazionale e della sua scuola neo-realista, ribadito dalla premiazione a Cannes nella sezione “Un Certain Regard”. Valendosi in sceneggiatura del sempre fedele Răzvan Radulescu, Puiu inscena una vera e propria Crocifissione ai danni di un eccentrico sessantenne col vizio della bottiglia, per tutta la notte trasportato in ambulanza da un ospedale all’altro. Col risultato che le ultime ore di vita dell’anziano protagonista rimbalzano tra medici indifferenti che si rifiutano di ricoverarlo, ottusa burocrazia, corruzione e inefficienza di un sistema in toto. Non priva di parentesi ferocemente ironiche, quest’insolita dark comedy è un’odissea urbana di due ore e mezza nel ventre malato della capitale romena, dai colori volutamente scabri e narrata in tempo reale come un documentario in presa diretta, in cui visione del cinema e visione della vita collimano. La storia di un essere umano che muore da solo, circondato dall’indifferenza degli altri – sembra dirci il cineasta – è la dipartita di un Paese che sceglie deliberatamente di sbandare in modo irreversibile: lo testimonia la scelta di un interprete realmente malato, spentosi poco tempo dopo le riprese, e l’immagine conclusiva in cui Lăzărescu, ridottosi come un bambino a bofonchiare parole incomprensibili, è spogliato dei propri luridi abiti in una stanza semibuia d’ospedale; il suo corpo, nudo e pieno di grinze, inerme giace su una lettiga nella remota possibilità che qualcuno si faccia vivo e scopra il misterioso male che lo affligge. Nessuno, neppure i vicini di casa e i pochi filantropi che si offrono di aiutarlo, riesce a capire cosa sia: ma si tratta di un cancro allegorico, che nel colpire a mo’ di esempio un individuo solo e disarmato condanna un’intera coscienza collettiva. “Moartea” è una sorta di morte in diretta, che partendo da un macabro spunto, somigliante a un episodio del nostrano “I nuovi mostri”, finisce per raccogliere una testimonianza da cinéma vérité che riecheggia il film dedicato da Wenders all’agonizzante amico e mentore Nicholas Ray.
“Per me il cinema è meno una forma d’arte che una tecnica per indagare il reale. E questo non è un racconto romeno, ma un racconto della Romania. Quel che è veramente grande nel cinema (nell’arte, in generale) è che le persone che non incontri mai, in qualche angolo del mondo e in una diversa cultura, possono scriverti il film e persino farlo.”
Il film è un successo di critica, e a parte Cannes riceve numerosi altri riconoscimenti in festival internazionali. Cinque anni dopo, il secondo viaggio di Puiu nel lungometraggio, “Aurora”, presenta tutta un’altra immagine di antieroe solitario: contrariamente a un personaggio che riceve la morte, qui è di turno la figura di qualcuno che la morte la dà. Per il secondo capitolo delle “sei storie dalla periferia di Bucarest”, Puiu gioca l’azzardo estremo: addirittura tre ore per fotografare un disagio esistenziale che, nel diario di un folle paranoico che pare uscito da qualche cruento film americano, si traduce nella dissacrazione del mito cinematografico del delitto, ridotto a gesto niente affatto spettacolare ed esente da pathos. E la macchina da presa, al solito ombra soggettiva invisibile, lo pedina come in un atipico “Delitto e castigo” in tutti gli episodi della propria folle e placida quiete domestica, sia quando acquista un fucile da caccia sia quando prepara gli omicidi, prima di confessare alla polizia le proprie efferatezze. L’omonimia con il capolavoro di Murnau ha il sapore del contrappunto ironico sposato all’idea del film-fiaba, cui l’autore romeno, ricorrendo all’ellisse, oppone quella del cinema quale investigazione della realtà.
“Sono stato molto influenzato dal testo di Arnheim “Film come arte”, in cui si osserva che il regista ’può scegliere il proprio movente.’ Il solo obbligo di cui l’interprete dispone è quello di essere. Ritengo che la dichiarazione politica del film sia che, al fine di sopravvivere, andare d’accordo con gli altri, occorra negoziare e scendere a compromessi. Il campo artistico è considerato la cosa peggiore, tutti gli eroi che scegliamo come modelli sono compromessi, e questo è l’aspetto fascista della cosa: così è Viorel, che vorrebbe imporre la propria filosofia sul mondo senza negoziare. Per vivere in comunità, è necessario scendere a compromessi e concedere. In un certo senso, devi essere tu una conferma dell’istituzione nazionale, a cominciare dall’educazione. È un quesito importante, e mi rendo conto che potrebbe essere una risposta a tutte le uccisioni. Un individuo vittima della propria filosofia, non abbastanza flessibile per scendere a compromessi, potrebbe ammazzare qualcuno o sé stesso, o abbandonare la comunità. Raccontare una simile vicenda coinvolge esaminando alcune risposte estreme alla domanda di come sia possibile l’esistenza in comunità.”
Un’effettiva comunità è ciò che offre l’ultima fatica di Puiu, “Sieranevada”, anch’esso presentato in concorso a Cannes, e incentrato su un gruppo di famiglia riunito per ricordare il defunto patriarca. Ma come in tutte le riunioni di famiglia, ne succedono di ogni colore: baruffe e rinfacci, schermaglie e rimbrotti, segreti scoperchiati e colpi di scena, rivelazioni e sorprese, drammi e melodrammi, urla e strepiti, risate e lacrime. Anche in questo caso l’autore non rinuncia alla radicalità, scevra da indulgenze, della presa diretta sulla vita con blocchi di piani-sequenza in tempo reale, che, come i lavori precedenti, conducono il film a una sterminata lunghezza. Nella capitale romena, a pochi giorni dalla strage di “Charlie Hebdo” (topos di una certa rilevanza nell’economia del racconto), un ex medico ora piazzista di farmaci si reca, accompagnato dall’assillante moglie, alla commemorazione del padre, una lunga seduta di canti e di preghiere cui segue un abbondante buffet. Durante la cerimonia però, al nipote è chiesto d’indossare il miglior abito del defunto, e in qualche modo interpretarne la parte in una sorta di grottesca risurrezione simbolica prima del definitivo commiato. A officiare la bizzarra cerimonia regolandone tempi e tappe è la matriarca vedova, e tutto femminile è l’allestimento mentre schegge di un passato che non molla la presa s’alternano all’attualità “occidentale” di un paese travolto da un’economia di mercato tardivamente scoperta. Il mosaico parentale in cui Puiu catapulta il pubblico non è facile da decifrare: si fatica a capire chi siano i figli della matriarca e chi i nipoti, chi i generi e le nuore, chi gli altri partecipanti. E giacché l’approccio registico rifugge da qualsiasi didascalico intento, e tutto è immortalato come in presa diretta, tocca all’osservatore dipanare il groviglio dell’identità e degli affetti, degli amori e dei disamori, e tracciarne la mappa. Ma è sempre, va da sé, la lezione del cinema quale visione del reale – anzi, del cinema che vuole confondersi con la vita – a prevalere sul risultato. Puiu procede per blocchi giustapposti, ognuno costituito da un lungo piano-sequenza che, da una postazione fissa, ruota e sposta il suo occhio a periscopio per seguire la frenesia dei personaggi (e della vita). Pure, a parte l’ouverture e una sequenza in sottofinale, l’intera opera si svolge nel chiuso di un appartamento, e si resta basiti dalla maestria dell’autore nel fare cinema giocando i più assortiti registri, pedinando i presenti e il loro inquieto andirivieni, l’urlarsi e lo sbattersi addosso, il toccarsi e il gridarsi contro, tra porte spalancate o chiuse con impeto che, incessanti, ridisegnano la scena. Scegliendo di catturare l’hic et nunc, tanto da chiedersi se vi sia un dettagliato canovaccio o se molto si conceda all’improvvisazione, Puiu sfodera un campionario umano costituito da mogli ambiziose che discutono solo di ipotetiche vacanze in Thailandia, giovani maschi paranoici che delirano sull’undici settembre tirando in ballo le peggiori teorie cospirazioniste, consorti tradite “perché lui ha sempre voluto da me sesso orale e io a quel porco non l’ho mai fatto”, amiche tossiche e vomitanti della giovinastra di casa. E non manca l’accesa discussione tra una vecchia comunista fedele a Ceaușescu e una meno anziana, che del regime e del Conducător non vuol più saperne.
“Sieranevada” è una rappresentazione della Romania di ieri e di oggi, un affresco e uno scontro tra dimensioni di una Storia destinata all’irresolutezza. Partendo da uno spunto autobiografico (un pranzo seguito alle esequie del padre), e ambientando l’apologo in uno scenario che potrebbe essere qualsiasi altro, Puiu compone un mosaico soggettivo il cui realismo sorprendente è attraversato da una moltitudine di punti di vista, che come frammenti di un puzzle conducono lo spettatore all’estrema ricerca di una verità restituita in una visione globale unitaria, e non solo indotta dalle pareti domestiche. Il film gioca su una sensazione di smarrimento: segnata dal tumulto prima e dopo il ventun dicembre, e incapace di filtrare correttamente la cronaca quotidiana, la memoria del Paese è sempre più oggetto di ansia e paranoia, e, continuando a restare assorbita dalle proprie storie e da quel che accade fuori dai confini, risulta così miope da non distinguere i due nuclei, né da sapere ciò che succede in un assetto familiare.
“La questione della verità mi preoccupa molto. Nella vita si parla spesso di tante cose: alcune hanno senso, altre no, altre ancora sono futili. Sono ossessionato dalla questione della verità e della menzogna, e dalla manipolazione dell’informazione durante la rivoluzione romena. C’è una sorta di confusione che cerco di mettere in scena con onestà: la questione del terrorismo internazionale, ad esempio, attraversa le discussioni della famiglia.”
Di fatto i dialoghi sono come sospesi, carcerati in celle mentali: non appaiono sciocchi come si vorrebbe credere, ma neanche particolarmente intelligenti. E tutto, a conti fatti, evapora nell’inconsistenza: è una sorta d’illusione, un modo per fuggire responsabilità reali che coincide con la progressiva quanto agiata modalità di non (voler) ragionare più per proprio conto. Un paradosso, dato che l’assurdo delle conversazioni è calato in un’atmosfera quotidiana anche più assurda eppur plausibile. Il gusto beffardo del profano, che non teme di sconfinare nel laido in più d’una parentesi, reca numerose affinità con Buñuel, tanto che Giulio Sangiorgio ne scrive come de “L’angelo sterminatore” personale di Puiu, indipendentemente dalla connotazione (extra)religiosa che gli si vuole tributare. Più semplicemente, “Sieranevada” si può leggere in filigrana come un “Giudizio universale” romeno, che in materia di satira su religione e cerimoniali prende a modello il Teatro dell’Assurdo, secondo la collaudata formula della commedia nera nazionale, oltre che la rivendicata anima latina del Paese. Perfino, riporta alla mente un cortometraggio di analoga impostazione, “Corul pompierilor”, a firma di Cristian Mungiu.
Lo stesso leitmotiv della morte, luogo canonico dell’intera produzione di Puiu, è presenza aleggiante nel senso più rappresentativo del termine, e la cinepresa, il terzo occhio, ne prende il posto. L’autore rivela che il mezzo filmico è disposto in modo da impersonare il defunto, la cui anima teneramente “spia” i parenti in gesti e parole, egoismi e meschinità, prima di abbandonare la salma, girovagare per quaranta giorni e partire definitivamente, secondo la tradizione ortodossa. Non sorprende che tra i produttori del film s’iscriva il decano Pintilie, noto per il proprio delicato tocco surreale, anche se della sua notoria leggerezza qui non v’è traccia. E sarebbe un errore non segnalare, a tal proposito, che la condizione di prigionia determinata dalla Storia e/o dal suo conseguente squallore quotidiano, già nei personaggi dell’ex torturatore Franț Ţandără o del “colonnello in pensione” Niki Ardelean avevano in sé una drammaticità che permetteva al giovane Puiu di costruirvi su la propria politique, già allora innestandovi i luoghi canonici dell’esistenza quale gabbia non proprio dorata. E condannando entrambe le maschere a dissipare i restanti anni in angusti anfratti, senza uscita come la loro vita. Nel primo caso, anzi, un infernale contrappasso si offre in forma di bizzarro Cenacolo a un’esistenza intrisa di atrocità sulle pelli altrui, la medesima che ora tocca a Franț subire. Come di un calvario esistenziale, nel secondo caso, è protagonista il Niki prodotto della (e ormai fuori dalla) politica del Passato, mesta ombra destinata a un anacronismo privo di riserve, sbocchi, contestualità. La nuova realtà lo obbliga a non discernere più con precisione il suo stile di vita, proprio di un momento in fase di estinzione, da quello della figlia e del consuocero Flo. Né si accorge di quella realtà, l’undici settembre, di cui i protagonisti di “Sieranevada” dissertano con una paranoia ereditata dalla propria Storia. La solitudine morale dell’anziano militare prelude a quella di Viorel, di cui persino anticipa l’azione sanguinosa quando armato di martello, come in Dostoevskij, uccide il consuocero. La banalità può essere la condizione originaria di un crimine, e un delitto si potrebbe commettere nella più grande banalità. E sia nell’uno sia nell’altro caso emerge il pattern della cinepresa, oggetto, positivo o deleterio che sia, fatto per catturare e immortalare la realtà a imperitura memoria, come fa l’enigmatico Flo ai danni della famiglia di Niki.
In conclusione, l’esperienza di Puiu come sceneggiatore e produttore esecutivo, firma per spot televisivi e interprete, quando non ospite in produzioni televisive o in documentari, parla da sola del contributo dato all’arricchimento di una cinematografia nazionale, già non più la cenerentola est-europea di un tempo. È anche grazie al talento di Puiu, ancorché non prolifico, se l’Europa ha ricominciato a mostrare interesse per la Romania consentendone l’ingresso, ogni volta che poteva, in tutte le rassegne e i festival più rappresentativi. La Croisette, nella fattispecie, diventa per il cinema romeno quella comoda ancora di diffusione altrimenti accessibile grazie alla diffusione via web, laddove in patria è la televisione satellitare a renderlo fruibile. Ed è l’idea che il cinema sia qualcosa di più di una lezione o un aforisma à la Truffaut, peraltro ugualmente preziosi, che orienta la sincerità di Puiu nel suo concepire opere ambiziose e appassionate, anche se prevalentemente pensate per i festival e non fruibili ad un più largo pubblico.
SAGGI
STEVEN SPIELBERG COME JAMES HILLMAN: “READY PLAYER ONE”
di Roberto Lasagna
In questa summa spielberghiana sulla cultura videoludica cogliamo molto di più: un viaggio cinematografico, in continuo sconfinamento, tra il dentro e il fuori delle vite immaginarie, tra il singolo e il collettivo, tra l’individuo e gli infiniti doppi, messi sotto scacco dalla situazione contemporanea dell’indebitamento collettivo ma invitati a liberarsi attraverso un’etica della visione e la riflessione consapevole sul proprio stato di “players”. Una corsa che l’autore vuole sfrenata e amorevolmente citazionistica – gli omaggi, tra i moltissimi e i più gustosi, paiono quelli a “Saturday Night Fever” e “Shining”, quest’ultimo realizzato come una vera perlustrazione-collisione che ha il sapore della reviviscenza, come i veri ebrei che accompagnano gli attori nel finale di “Schindler’s list”, o come i segreti dell’arca perduta fatalmente discoperti in un film, “Ready Player One”, che resta in primo luogo un gesto d’amore per il mezzo e le sue evoluzioni che si vogliono consapevoli e in compagnia degli amati maestri, da Kubrick a Zemeckis (quest’ultimo, tra i più originali e prossimi allievi della poetica spielberghiana, cui è dedicato il “cubo” che riporta indietro nel tempo innestando nuove possibilità per i protagonisti in fuga).
Il nuovo film del regista di “Jurassic Park” e “Schindler’s List” – un binomio che nei primi anni novanta siglò la misura produttiva solo apparentemente doppia di un cineasta che siamo soliti considerare il narratore del meraviglioso e della riproduzione storica, il Peter Pan risarcitore della rappresentazione fatalmente perduta – è un kolossal divertissement-saggio teorico, messa a punto delle tecnologie digitali al servizio della verosimiglianza e della meraviglia (con un processo di adeguamento-innovazione che Spielberg da sempre ricerca e rilancia, con evidente periodicità, ponendosi anche in questa direzione come il cineasta anticipatore), di una consapevolezza etica della visione come tramite imprescindibile, oggi come ieri, per vivere intensamente ed essere sorveglianti del proprio destino in una società capitalistica in cui occorre guardare alle profonde dinamiche, alle questioni economiche e materiali, con defibrillante lucidità. Una meraviglia e una defibrillazione che altrove, nella cinematografia di questo perenne wonder boy del cinema, paiono in primo piano oppure assunte come momento da disvelare/disvelante, un invisibile divenuto per incanto visibile, mondo a parte che invece di darsi come completamente metafisico appare in una cinematografica e contornante fisicità.
Ciò succede sovente in Spielberg, e succedeva in quello stato di grazia che è “Always”, sempre alla ricerca di un cuore umanissimo per rilanciare il racconto cinematografico, sia esso divorato dai furori della cinefilia (lì i classici hawksiani, Garnett e gli aerei), oppure, come in “Ready Player One”, calato nella plumbea morsa ipercinetica che accompagna la vita e la visione di questi ragazzi e individui di ogni età – nella società del 2045 immaginata dal romanziere Ernest Cline da cui il film è tratto -, costretti, per riscattarsi da orizzonti di povertà e disagio esistenziale, a una fuga dentro una realtà che li manovra e occulta le vere chiavi della liberazione e ostacola con la violenza il comando di Oasis, il mondo virtuale in cui è però possibile rintracciare le mappe nascoste e le chiavi del comando celate (come i programmi segreti di autodistruzione della Morte nera, cui fa eco sul piano immaginario il volto del supercattivo di “Rouge One” Ben Mendelsohn).
“Ready Player One” è la quadratura del cerchio del cinema di Spielberg, un film di giovani, giovanissimi, molto somiglianti al nerd Steven Spielberg, come il protagonista Wade/Parzival, che persino nell’aspetto somiglia al regista da giovane, e che, nella società del 2045, sono indebitati, senza famiglia, divorati da una nostalgia che è propria di una cultura videoludica inevitabilmente iconica ed immagazzinatrice, che richiede la perlustrazione continua di miti, abiti mentali, situazioni che nel film rimandano di continuo al pop, a una frenesia di frequentazioni che avvicinano/allontanano, ad abilità e attitudini che smarcano e richiedono adesione. Immersivo ed escapista, il film di Spielberg che somiglia per alcuni aspetti a “Tron” e “Blade Runner”, è anche tutta un’altra cosa: della fuga è una poderosa rivendicazione, perché quel mondo culturale stratificato che ci abita, ci riguarda, va conosciuto, contiene un cuore antico seppure manipolato dal capitale; e “Ready Player One” è anche una riflessione sul capitalismo, sulla possibilità di riscattarsi e liberare nuovi orizzonti, attraverso divagazioni dal labirinto, percorsi a ritroso (proprio come in “Shining!”), consapevolezza di guida e di espressione. Un ritorno al reale (l’amore per una ragazza che forse si nasconde, e nasconde uno sguardo imprevisto), che deve procedere attraverso i linguaggi e la cultura che si conoscono, e che prospetta una nuova speranza anche nella prospettiva di un capitalismo non solo parassitario ma vitalistico e aperto sul mondo (si pensi al primo piano del cadavere del creatore di Oasis, perfetto alter-ego spielberghiano e creatore di questi mondi, con gli occhi chiusi da una moneta con scritto ‘liberty’. E non è forse una moneta, del resto, a fornire una vita bonus al protagonista?). Spielberg e i suoi personaggi ci paiono sempre di più delle figure chiamate dal loro Daimon, per usare termini consueti alla psicologia di James Hillman: proiettate verso un destino che è una vera vocazione. Nel caso del regista, la vocazione che emerge in “Ready Player One” è quella dell’artefice della fucina dell’immaginario messosi al servizio delle nuove generazioni per offrire un film che sia al contempo modello e compagno di viaggio, una visione complice del giovane videogiocatore e nello stesso tempo raffigurante l’esigenza di una consapevolezza di sguardo, tanto opportuna nella moderna società degli inganni operati ai danni del più piccolo in campo. Padre e produttore, Spielberg si trova oggi a essere finalmente riconosciuto anche dalla critica come un maestro e un regista responsabile del gusto cinematografico, e la sua presunta doppia anima, di uomo del business e di artista di fama, si dissolve dinanzi all’evidenza del talento, tanto in fatto di affari che di realizzazioni cinematografiche, al servizio della storia del cinema e dell’industria culturale che in lui vede un protagonista assoluto degli ultimi 45 anni.
Da sempre il suo cinema migliore edifica avventure ai confini della realtà, inseguendo un sogno escapista che culmina nel grande incontro, con una figura aliena, lontana, divenuta prossima, palpabile, di cui è possibile respirare l’aura, coglierne i bagliori, i risvegli. Alieni o sopravvissuti, personaggi riemersi dalla tenebra o figure di luce, fantasmi o esploratori, aviatori o avventurieri, soldati da difendere o individui esuli in non-luoghi come l’aeroporto di “The Terminal”, quelli di Spielberg sono protagonisti di un viaggio verso il futuro e l’altrove, e il regista si fa promotore con i suoi film di un movimento di emersione, dove i racconti svolgono la funzione di invito all’immedesimazione nei confronti di vicende e personaggi esemplari, cui capitano fatti ben poco ordinari, destinati a scardinare l’ovvietà dell’esistenza e a richiedere un cambiamento, un attraversamento in una terra di nessuno, in un oblio che hai poi necessità di una riappropriazione d’immaginario, di una nuova identificazione in uno scenario di simboli e codici che il personaggio, proprio come Indiana Jones o Wade Watts, conosce a fondo per intuito e conclamata frequentazione. Da sempre il cinema di Spielberg è una rivendicazione d’immaginario e in “Schindler’s list”, prima ancora che in “Ready Player One”, il protagonista è l’industriale che scopre la virtù salvifica di un capitalismo al servizio della sopravvivenza del singolo in uno scenario di guerra e morte per milioni di individui. Questo sogno rooseveltiano motiva uno dei film più sorprendenti di Spielberg e lo ritroviamo, sotto altra luce, nel nuovo film del regista americano, che conferma Spielberg come l’uomo che unisce il grande artista popolare ma anche il paladino del capitalismo moderno al servizio dell’uomo, un capitalismo riletto alla luce del sogno di un umanesimo che porti libertà e nuove motivazioni negli scenari contemporanei. In questo Spielberg appare come dominato dal suo Daimon, dalla vocazione a insegnare attraverso un film, una possibile visione dell’esistenza che coniuga esperienza ludica e riflessione umana, esattamente come i suoi film si presentano, di volta in volta, come divertissement o come film d’impegno, come sogni di fuga o come esperienza didattica. In “Ready Player One” la vocazione educativa emerge con più veemenza e il grande videogioco cinematografico detta le regole di una rappresentazione immersiva che vuole manifestarsi come teatro del presente e del futuro, mimesi della nostra esistenza di Avatar e alibi della nostra vita dissolta con disinvolta baldanza nelle figure doppie di un videogioco quanto mai allegorico e animato in maniera metamorfica come un gigantesco affresco rinascimentale. Ridiscendere tra le strade digitali di Oasis, per i personaggi del film, è come un’emersione, che si conclama nella sequenza del viaggio a ritroso, quando il tempo torna indietro e il personaggio può scegliere una strada differente perché conosce i possibili sviluppi della vicenda, e dinanzi a un destino scritto da altri può riscattarsi, scegliere il proprio, quello evocato dal proprio Daimon.
JERRY LEWIS, LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ANORMALE
di Francesco Saverio Marzaduri
Torna anzitutto alla mente, parlando di Jerry Lewis, l’agguerrita difesa che ne fece quaranta e passa anni fa una giovane e già autorevole firma della più schietta critica militante, tal Goffredo Fofi, in contrapposizione alla festosa accoglienza che all’astro nascente dell’umorismo ebraico-americano, Woody Allen, ne faceva il resto del mondo. Senza infingimenti esecrava il secondo – un “insopportabile coglione”, scriveva – ma lo storico direttore di “Ombre Rosse” fu il primo a spiegare ciò che negli anni seguenti sarebbe stato individuato come assioma dell’arte comica di Lewis. Non è necessario scomodare i francesi, all’epoca più predittivi e meno oziosi dei colleghi italiani: ci sta che i “Cahiers” abbiano compreso prima il fulcro di tale comicità, nel suo consistere semplicemente nell’inversione di quanto può apparire – ma solo apparire – normale.
Prima che Lewis si misurasse con la regia (che conta una dozzina di pellicole in tutto), facendosi supervisore tout court dei propri progetti, la maschera erede di Chaplin e di Stan Laurel che l’avrebbe lanciato dalla seconda metà degli anni Quaranta in poi tracciava, nel registro comico, uno sguardo aggiornato dei prototipi addirittura ante litteram: l’errore senza macchia in situazioni ogni volta inappropriate, bigger than life come una modernità già all’epoca invasiva e frenetica – e peggio per chi non s’adatta, un dropout puro di cuore resta un dropout. Sicché la maschera lewisiana possiede tutto ciò che l’ordine stabilito non gradisce ed emargina: il corpo dinoccolato, il candore dietro una sghemba fisionomia, la voce stridula e biascicata (da noi restituita dal timbro meno fedele ma efficace di Carlo Romano), i gesti non coordinati e non conformi destinati a naufragare prima del compimento. E anche se le meticolose, fondamentali esegesi di Giorgio Cremonini nel suo Castoro, o di Toni D’Angela nel recente volume “Jerry Lewis o l’impossibile”, ne esaminano la concreta plasticità in una sfera di “astratta” normalità, l’espressione “bastian contrario”, che racchiude il senso d’ogni formula comica, aiuterebbe a capire meglio una compiutezza artistica tanto asciutta e volutamente priva di sbavature da non sapere, forse, di esser tanto in anticipo.
Perché l’Ordine, o pseudo-tale, è un acquario schizofrenico ignaro di esserlo e pronto all’imminente distruzione, come ostentano i prodotti che vedono Jerry protagonista (i migliori dei quali, “Dove vai sono guai” e “Pazzi, pupe e pillole”, firmati dal cartoonist Frank Tashlin), per tacere di quelli in cui fa da sparring al più piacente lover Dean Martin, in un’epoca prossima al consumismo “usa e getta” e futuro bersaglio di critica e denudamento. Ma già il fatto di esser l’elemento di contrasto del duo – e la vera stella – costituisce fattore di denuncia rispetto al conformismo dilagante: Lewis avrebbe messo alla berlina l’orridezza, tutta abiti sgargianti e pose da macho, ne “Le folli notti del dottor Jerryll” in cui lo swinger Buddy Love è l’allegorico, mostruoso double face del candido, sgraziato e impacciato professor Kelp. Il doppio è d’altra parte uno dei più collaudati marchingegni comici per riprodurre l’altro che è in noi, attraverso varianti combinatorie al ballo di sua maestà l’Assurdo, che nell’arte di Lewis si fa concezione teorica in linea con l’aritmetica del buffonesco. Né Jerry ha fatto mistero che uno dei suoi film preferiti sia l’inglese “Incubi notturni”, che annovera il celebre episodio del ventriloquo impossibilitato a liberarsi del proprio fantoccio, con la personalità di quest’ultimo che gli si sovrappone e lo spinge alla follia.
Nondimeno, ogni innesco ilare deve possedere quel quid di fanciullesco e innocente necessario al funzionamento: numerose le circostanze in cui il balocco (e non allocco) Jerry, a chi gli dà dello scemo, risponde lamentoso alla maniera di un bambino, senza per questo volersi inimicare chi gli è “nemico”. E nel migliore tra i titoli del sodalizio con Martin, “Il nipote picchiatello”, un goffo garzone di barbiere, per sfuggire a un gangster che per errore gli ha nascosto in tasca un diamante rubato, si camuffa da ragazzino e per tale si fa passare in un college femminile, dileggiando il vano universo adulto (e anticipando “L’idolo delle donne”, seconda regia di Lewis e tra le migliori). In “Sherlocko… investigatore sciocco”, gustosa parodia dell’hard boiled, il protagonista gioca coi cliché del genere buttandosi nella ricerca di un ricco rampollo, per poi scoprire di essere lui (e facendo, per dimostrarlo, la barba al ritratto del nonno, ovviamente con le sue fattezze). Spesso la formula conduce il corpo lunare di Jerry sul fertile terreno del ludico, a rischio del saccarosio e della maniera: scalcinato prestigiatore ne “Il ponticello sul fiume dei guai”, si ritrova a far da padre putativo a un orfanello giapponese cui torna il buonumore, e ne “Il balio asciutto” fa da babysitter ai tre gemelli di un’amica di cui è da sempre innamorato: in una scena, per non farsi riconoscere dal futuro suocero completamente ubriaco, si esibisce in una funambolica serie di personaggi mutando gamma, posa, travestimento.
Ma è nell’esordio dietro la macchina da presa, “Ragazzo tuttofare”, che il comico per la prima volta mette in scena se stesso e il proprio faceto riverbero: il bellboy del titolo originale, ribattezzato Stanley in omaggio al modello artistico più venerato (e il tributo continua con un sosia di Laurel con tanto di bombetta). La doppiezza nell’opera lewisiana, però, non avrebbe il medesimo impatto senza il pungente sguardo alle nevrosi collettive americane, con annessi rovesci e si pensi (sempre ne “Il balio asciutto”) alla satira sul potere ipnotico della pubblicità ai danni d’una vecchietta. La debordante schizofrenia di massa, nel senso fragoroso del termine, è paradossalmente “sedata” da un’operazione quasi muta, improponibile per i canoni in voga ai tempi, e se ne sarebbe rammentato il Mel Brooks de “L’ultima follia”, dove gestualità e mimica, nei propri studiati disastri, vanificano l’apparente normalità del quotidiano. Il meccanismo implica una mise-en-scène che si regge su sé stessa e sui classici complementi di comicità: il vuoto e il pieno, lo spazio e il tempo, il molto e il poco, il possibile e l’impossibile. E sempre è l’azione comica a scardinare il vero ridicolo insito nell’altro, che trova diverso il presunto scemo e ci ride sopra senza accorgersi della propria idiozia: come spiegare perché l’altro in questione, una società troppo miope e frenetica, soltanto nell’epilogo chiede al Nostro per quale ragione non pronunci mai parola? E ne “Il mattatore di Hollywood”, terza regia di Jerry, non è forse un paradosso che la candida maschera, relegata ai margini, dialoghi con un clown e uno struzzo, e addirittura si lasci addormentare da due marionette?
Al pari dell’emisfero adulto, Hollywood è fatta oggetto di dissacrazione consentendo a Lewis, ben prima di Blake Edwards, di smontarne il fatuo mito e preludere a quella lezione che avrebbe trovato in Altman, nei Coen e soprattutto in Landis e Tarantino le eponime firme del paradigma, ai confini tra demenzialità e demenza. E già l’incipit de “Il mattatore”, con la presentazione degli studios Paramutual, informa che niente di ciò che sin lì si è creduto (di credere) è da prendere sul serio; così, durante il ciak di una scena d’amore, due attori si scambiano effusioni salvo, dietro le quinte, insultarsi e infamarsi a vicenda. Anche qui Jerry è un onesto lavoratore, assunto dal direttore come “spia” per individuare le cause di alcune folli spese, e che muovendosi tra i set causa catastrofi a catena, tra le quali l’esilarante doppiaggio di un film col proprio stridulo timbro. Ma una fortuita circostanza, in seguito a uno dei suoi innocenti disastri, lo trasforma in ciò che (non si) vorrebbe diventare: una star, con tanto di nome sull’affiche del film quale protagonista (manco a dirlo, quello che s’è appena visto). Continua il gioco dell’ossimoro e del comico eletto a matematica filosofia, e già “Hollywood o morte!” ne fornisce conferma, ripensando alla cinefilia di chi è abile nel declamare al contrario i cast dei suoi film preferiti. E in “Jerry 8¾”, mix dei citati “Ragazzo tuttofare” e “Il mattatore di Hollywood”, il velleitario mondo della televisione, in apparenza risate e vanità, è fatto a brandelli dal candido à la Voltaire, permettendosi persino di schernire la permalosa regina del gossip Hedda Hopper, sbellicandosi davanti a uno dei suoi famigerati cappellini. Qui, come in altri lavori, Lewis gioca con la destrutturazione della celluloide chiamando alcuni noti volti (tra cui un Peter Lorre all’ultima apparizione), molti nella parte di sé stessi: se ne “Il mattatore” a un certo punto fa capolino la famiglia di “Bonanza”, in “Jerry 8¾” il Nostro gioca a rifare George Raft emulandone insieme le pose allo specchio, dopo averlo simpaticamente parodiato ne “L’idolo delle donne”. E nell’irrisolto “Controfigura per un delitto”, in cui dirige gli amici Peter Lawford e Sammy Davis jr. (che anticipano la coppia del televisivo “Attenti a quei due”), l’autore chiama Peter Cushing e Christopher Lee a riproporre in cameo i loro noti personaggi.
Il luogo canonico del doppio è occasione per una moltiplicazione di travestimenti e pantomime, che in “Tre sul divano” è travolgente soluzione per le pazienti della fidanzata psicanalista, accomunate da un’idiosincrasia per il maschio. Ne “I sette magnifici Jerry” nessuno degli zii d’una trovatella è scelto da quest’ultima come padre adottivo: solo il fedele chauffeur, camuffato dallo zio clown che ne rifiutava la parentela, ottiene l’adozione della bimba conferendo umanità al solo personaggio di Lewis davvero spregevole del film (ovvero alla sua effigie). E nel meno riuscito “Scusi dov’è il fronte?” un patriottico milionario, organizzato un esercito privato per sconfiggere il Führer – esercito diretto come una troupe cinematografica, secondo l’incessante interscambio realtà-finzione – favorisce l’avanzata alleata sdoppiandosi nei panni d’un generale nazista che in più occasioni si ritrova davanti. Evidente l’impiego della collaudata formula à la Chaplin, memore anche di Keaton nella trattazione bellica in salsa rosa. Ma è con “Il ciarlatano” che il topos della doppiezza, ostentato dallo scambio di persona, acquista una (dis)articolazione narrativa volutamente dilatata, senza fretta alcuna di giungere alla soluzione comica. Come se l’autore, conscio di essere oggetto di culto dai fautori della Nouvelle Vague, ne restituisse politique e cifra stilistica con un apologo confezionato secondo i crismi, scardinati e destrutturati, dei thriller francesi, con quel quid di bizzarro a far la differenza. L’esito è concepito dal fattore-sorpresa dell’altro da sé: se ne “Le folli notti del dottor Jerryll” l’apparizione di Buddy Love si annuncia sui volti attoniti dei passanti, qui la presenza di un tranquillo impiegato, somigliante a un feroce gangster presumibilmente morto, determina nei cattivoni di turno conseguenze di volta in volta scompiscianti. E anche qui l’ossimoro sta nella protervia della società, che si crede al di sopra d’ogni sospetto, rivolgendosi al mite protagonista in modo ignominioso, salvo trattarlo con indulgenza quand’è costretto a ricorrere al travestimento per sfuggire al nemico. Si accondiscende col fittizio che si vorrebbe essere, e non si è perché mitizzato, e al solito il camuffamento è il più che valido escamotage per (far) ridere di noi; non si è altrettanto disposti con chi è al naturale, senza aspirare ad essere e senza volere, perché consolidato a una più quieta esistenza (la stessa che il protagonista non riesce a conseguire).
Se la presenza di un insolito narratore (in giacca, cravatta, bermuda e pinne) ulteriormente ribadisce l’artificio dell’assunto, dramma e terrore, strettamente connaturati al pagliaccesco, sono a un passo. E s’è lecito ridere per esorcizzare l’imminente tragedia, non si può ridere di essa. Seguendo il citato “Scusi, dov’è il fronte?”, il misterioso “The Day the Clown Cried” – uno tra i più celebri casi d’inedito “disperso”, dovuto a polemiche su premesse e contenuti disagevoli per l’epoca – insegna che anche una maschera è capace di osare spingendosi oltre le sfumature fin lì consentite, preludendo al Benigni de “La vita è bella” nella trattazione di analoghi temi. Sebbene il film, dalla tormentatissima lavorazione, non vide mai la luce (Lewis medesimo, non amando che se ne parlasse in sua presenza, fece di tutto per non divulgarne la distribuzione), il corpo comico, qui poco ilare e assai spregevole, opta per uno sdoppiamento a favore di bambini internati con lui in un lager. Se inizialmente il personaggio, che torna a farsi apprezzare dopo il declino, svolge la mansione per una possibile concessione di libertà pattuita col nemico, la risata non sostituisce la tragedia e l’opportunismo fa i conti col rimorso. Intrattenutili sul treno per Auschwitz, il clown accompagna i bambini alle “docce”: entratovi lui stesso, cerca di farli ridere un’ultima volta prima di morire gassato con loro. Persino negli ultimi film da lui diretti, “Bentornato, Picchiatello” e “Qua la mano Picchiatello”, Jerry ripropone un paradigma conforme alla propria politique, con l’ormai azzerato desiderio di (voler) ridere in una società sopraffatta dal consumismo: mutati sono i registri (come testimoniano i prodotti datati in cui la maschera lewisiana non è sfruttata al suo meglio), che ormai impongono una comicità più intellettuale contrapposta a una più goliardica. Non c’è posto per i pagliacci e in “Bentornato, Picchiatello”, infatti, un altro clown disoccupato si ritrova a cambiare lavoro e identità (nei panni di un disc jockey sogna d’imitare John Travolta), incappando nei soliti disastri fino ad accettare un incarico da postino: ma il nuovo stile di vita lo spaventa sino a fargli decidere di consegnare la posta nei suoi abiti da pagliaccio, e ciò gli spalanca le porte dell’Accademia dei Clowns. In “Qua la mano Picchiatello”, un complessato narra in flashback la propria sventurata vicenda allo psicanalista, condita di fallimentari tentativi di suicidio. Con la ribaltata ancorché ovvia conclusione che se il protagonista guarisce, è il dottore a impazzire.
Lontani anni luce i tempi in cui, per sfuggire alla pazza folla, era sufficiente colmare il vuoto di uno spazio smisuratamente grande col proprio minuscolo corpo mimando gli strumenti di un’orchestra inesistente; muovere una bocca da cui uscivano note musicali, quando non dirigere un vero coro; o dattilografare su una macchina da scrivere invisibile (da cui, però, usciva un foglio stampato). E, a mo’ di misogina vendetta, sabotare una diretta televisiva in un college femminile. Sfumati i trascorsi dell’Assurdo in cui una lumaca sorpassava un imbranato infermiere imprigionato in una camicia di forza, sfumati gli inseguimenti da cartoon con le falciatrici telecomandate. Superati i giochi meta-testuali in cui uno scambio di sottotitoli, in americano e in giapponese, non consentiva a due personaggi di dialogare e comprendersi. Indotta a fronteggiare un clima in cui il concetto di comicità risulta drasticamente cambiato, e basta un’apparizione per raggiungere il notorio quarto d’ora di celebrità, la maschera lewisiana tocca l’apice del tragico insito in essa con l’interpretazione di Jerry Langford in “Re per una notte” di Scorsese. Uno showman vicino al declino, che sul palco fa e rifà ogni volta uno spettacolo uguale a sé stesso, e nei fuori onda è accompagnato da una palpabile vena di mestizia: la medesima di chi sa che lo show business non è più quello da un pezzo, e cavalcando l’incomprensibilità e ingestibilità dei nuovi tempi genera sedicenti comici, mostruosi la loro parte. Trentaquattro anni dopo quel ruolo, se ne ritrova eco nell’intervista di sette minuti rilasciata da un novantenne Lewis agli schermi tv: nella sua abitazione di ricordi, un divo prossimo alla scomparsa, visibilmente infastidito, risponde alle domande dell’interlocutore con una serie di “Why?” e di “No”, addirittura scimmiottandolo. Forse, solo un’interpretazione. Eppure le sfumature che si colgono sono la riprova d’una comicità, un’arte, un universo inesorabilmente sfumati. Citando il Soriano di un celebre omaggio al mito di Laurel e Hardy, e a quella comicità da cui anche Jerry discendeva, triste, solitario y final.
JAMES BOND – FENOMENOLOGIA DI UN AGENTE SEGRETO
DAGLI ANNI ’60 AD OGGI
di Riccardo Poma
James Bond, ornitologo
James Bond nasce dalla penna dello scrittore londinese Ian Fleming (1908 – 1964) ed è protagonista di dodici romanzi e due raccolte di racconti pubblicati a partire dal 1953. Inizialmente l’agente a doppio zero avrebbe dovuto chiamarsi James Secretan, ma Fleming, appassionato di bird watching, cambiò idea e lo chiamò come un noto ornitologo inglese: James Bond. Elegante, brillante, irresistibile (soprattutto per il gentil sesso), Bond è un agente con licenza di uccidere che lavora per il servizio segreto britannico. Non uno qualunque: dispone di gadget ipertecnologici, è forte e coraggioso, beve Martini Dry e guida favolose automobili. Nonostante l’accoglienza positiva delle avventure cartacee, è solo col passaggio al grande schermo che il personaggio raggiunge fama mondiale e diventa un vero e proprio fenomeno di costume. Nel 1961 Albert R. Broccoli e Harry Saltzman, due produttori indipendenti che avevano comprato separatamente i diritti dei romanzi di Fleming, si uniscono a fondare la EON Production. Eccezion fatta per gli apocrifi “James Bond 007 – Casino Royale” del 1967 e “Mai dire mai” del 1983 (in cui un ormai anziano Connery torna, strapagato, nei panni del personaggio), la EON produrrà tutti i film della saga. Con la scomparsa di Albert Broccoli il timone dell’azienda è passato a Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, figlia e figliastro di Albert che tutt’ora producono i film della saga. Dal 1962 di “Licenza di uccidere” al 2015 di “Spectre”, EON Pictures ha prodotto ben 24 film sull’agente segreto e ha incassato qualcosa come 14 miliardi di dollari (stima Sky Cinema). Con una struttura consolidata, personaggi ricorrenti, clichè narrativi che tornano ogni volta (ad esempio il fatto che i nemici di Bond svelino sempre il loro piano all’agente per narcisismo prima di ucciderlo), James Bond ha attraversato cinquant’anni di cinema e cinquant’anni di storia mondiale. Insomma, nell’arco di questo mezzo secolo non è cambiato soltanto il modo di fare cinema, bensì anche il mondo in cui viviamo e in cui quel cinema viene concepito: dalla guerra fredda al crollo dell’URSS, arrivando ovviamente alla paura del terrorismo, i film di Bond sono sempre stati uno specchio fedele dei tempi in cui venivano realizzati. Ovviamente senza mai rinunciare all’intrattenimento. Nell’arco di questi 53 anni Bond ha avuto il volto di sei diversi attori che, pur mantenendo i tratti principali del personaggio, hanno potuto darne un’interpretazione personale e sempre differente.
Sean Connery, ovvero l’archetipo dell’agente segreto e la creazione dell’immaginario
Dopo aver scartato Cary Grant per raggiunti limiti di età (l’attore aveva 57 anni all’epoca del primo film di 007), la scelta di EON cade su un giovane e misconosciuto Sean Connery, che esordisce nel 1962 col fortunato “Licenza di uccidere” (titolo originale: “Dr. No”, diretto da Terence Young). Il Bond dell’attore scozzese entra così prorompentemente nell’immaginario del pubblico da diventare una sorta di archetipo dell’agente segreto per tutti i film di spionaggio che verranno dopo: l’eleganza, la parlantina sciolta, il fascino, l’abilità, diventano le doti standard che una spia cinematografica deve possedere per essere considerata tale. Questo James Bond si distanzia parecchio da quello descritto da Fleming nei suoi romanzi: l’agente cartaceo aveva una personalità cupa e sfaccettata, e non sempre era moralmente ineccepibile come quello filmico; tuttavia, il pubblico pagante non si sofferma troppo sulle differenze coi romanzi e impazzisce letteralmente per questo 007 brillante e sornione. I primi due film – “Licenza di uccidere” e “A 007, dalla Russia con amore” (“From Russia with Love”, 1963, sempre Young) – introducono quegli elementi che diverranno tipici in tutti gli episodi a venire: le belle macchine e le belle donne, i gadget della sezione Q, le ambientazioni esotiche, le armi ipertecnologiche dei cattivi, I personaggi ricorrenti (M, il capo del MI6, Moneypenny, la sua segretaria, Q, capo dell’omonima sezione), ma anche trovate narrative come la sequenza “gunbarrell” prima dei titoli di testa (in cui Bond ferma un qualche cattivo minore). Pur in piena guerra fredda, la produzione sceglie la via della diplomazia: lo Smersh – il controspionaggio dell’armata rossa, grande nemico di Bond nei romanzi – lascia il posto alla fittizia e certamente meno politicizzata SPECTRE. Nonostante il buon successo dei primi due film è soltanto col terzo – “Goldfinger”, diretto nel 1964 da Guy Hamilton – che James Bond diventa fenomeno di costume. Si pensi al celebre prologo, in cui Connery sfila la muta da sub sfoggiando un impeccabbile smoking bianco, o a personaggi di contorno subito entrati nell’immaginario comune come Pussy Galore e la sua squadra di pilotesse e il muto sicario Oddjob (che lancia un cappello affilato in grado di decapitare). Il cattivo, Goldfinger appunto, è un villain affascinante e dai piani mirabolanti, mentre la sagace ironia di fondo rende il film godibile anche ai profani della saga. Due elementi – cattivo azzeccato e ironia – che ritroviamo anche nel successivo “Thunderball” (1964, con la regia nuovamente affidata a Young): ottimo l’Emilio Largo del nostro Adolfo Celi (cattivissimo con benda sull’occhio e piscina piena di famelici squali), ottime alcune trovate comiche, come l’introduzione in cui Bond vola via con un futuristico (!) jetpack e, atterrato, esclama con la solita flemma che “un uomo di mondo non dovrebbe esserne mai privo”. Il budget di EON, anche grazie ai successi precedenti, comincia ad aumentare notevolmente, e lo si riscontra soprattutto negli ottimi effetti speciali e nelle straordinarie (per l’epoca, ma non è che oggi siano mediocri) sequenze subacquee. EON ingaggia alcuni specialisti di prim’ordine che prenderanno parte a molte pellicole della saga: il grande scenografo Ken Adam, il compositore Monty Norman (suo il celeberrimo tema di Bond), il titolista Maurice Binder. Altro elemento tipico diverranno proprio i titoli di testa stilisticamente raffinati e sempre accompagnati da canzoni appositamente scritte per artisti di fama mondiale: Shirley Bassey, Paul McCartney, Louis Armstrong Duran Duran, Madonna, Chris Cornell, Adele, Sam Smith, sono solo alcuni dei grandi nomi che, negli anni, hanno cantato le title-track dei film.
Il quinto Bond interpretato da Connery lo troviamo in “Si vive solo due volte” (1967, “You only live twice”), diretto da Lewis Gilbert e sceneggiato nientemeno che dallo scrittore Roald Dahl, noto per aver concepito “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”. Molti elementi datati – come un Connery inguardabile col taglio alla orientale e alcune trovate a dir poco risibili (su tutte il tremendo elicotterino con cui Bond tiene testa a cinque elicotteri da guerra) – lo rendono uno dei meno amati dai fan, anche perchè è palese che l’attore scozzese è svogliato e vorrebbe lasciare la saga. Un addio annunciato subito dopo l’uscita del film ma che, tuttavia, non sarà definitivo: dopo aver passato per un turno il testimone a George Lazenby (che vedremo tra poco), Connery tornerà – strapagato – in “Una cascata di diamanti” (“Diamonds are forever”), uscito nel 1971 per la regia del richiamato Guy Hamilton. Il film è un successo ma non convince particolarmente – i soldi non sembrano aver reso Connery più contento di riprendere il ruolo – e alla fine le uniche cose che si ricordano sono le grazie di Jill St. John, sempre molto generosa davanti alla macchina da presa, e una coppia di sicari decisamente naif. Il nuovo rifiuto a proseguire di Connery (anche stavolta non definitivo, in quanto tornerà nel 1973 nell’apocrifo “Mai dire mai”) spinge la EON a cercare un nuovo James Bond, sperando che il pubblico lo apprezzi più di quanto avesse apprezzato il povero Lazenby.
George Lazenby – L’anomalia
Il sesto film della saga, “Al servizio segreto di sua maestà” (“On Her Majesty’s Secret Service”, 1969, Peter Hunt) è anche il primo orfano di Connery, timoroso di restare imprigionato nel personaggio. Broccoli sa bene che Connery non è soltanto il primo attore ad avere interpretato l’agente segreto, bensì è anche e soprattutto colui che ha contribuito a costruire, film per film, l’immaginario legato al personaggio. La scelta del sostituto cade sul giovane modello George Lazenby, cui la produzione chiede di restare nei ranghi e di non distanziarsi troppo dal suo predecessore, imitato anche nel taglio di capelli. Il film rimane uno dei più sottovalutati della saga, se non altro perché i fan rifiutarono da subito Lazenby e gridarono alla blasfemia. In realtà è uno dei migliori: Bond cessa di essere una maschera imperturbabile diventando più umano e sfaccettato (meno gadget, più cervello), la struttura narrativa si fa più complessa e inaspettata evitando di ricalcare quella degli episodi precedenti, l’azione è da manuale e la suspense tangibile. E che dire del finale, forse il più amaro della serie, senz’altro il meno vittorioso o scontato. Ironico, brillante, pieno di divertenti guizzi meta-cinematografici (memorabili le prime parole di Bond che, riferendosi al rifiuto di una ragazza, esclama rivolto allo spettatore “questo non era mai successo a quello di prima!”), ma anche di audaci allusioni erotiche (quando una donna gli tocca una gamba sotto al tavolo e la sua espressione si fa sbarazzina, Bond esclama “ho solo una leggera rigidità alle membra”). Molte sono le sequenze memorabili, quasi tutte condensate nei 40′ in cui Bond fugge dal ristorante Piz Gloria: la reclusione nel motore della teleferica, il salto su una di esse, la fuga con gli sci, quella in auto con tappa su un circuito da rally, quella a piedi che termina sotto una valanga. La regia di Hunt, già montatore dei primi quattro e aiuto regista del quinto, ha il difetto di abbondare un po’ troppo con gli zoom (un tempo molto di moda, oggi molto datati), ma anche il pregio di essere scattante e ritmata, soprattutto nelle mirabolanti scene d’azione, tra le migliori della serie. Ma, come spesso accade al cinema, non sono né i critici né i produttori a prendere le decisioni: l’unico vero capo è il pubblico. E dunque se il pubblico non vuole Lazenby, allora Lazenby non sarà. E così, dopo appena un film, al modello viene dato il ben servito e tutti gli sforzi tornano a concentrarsi su un solo obiettivo: convincere Connery a tornare, costi quel che costi. E così, nel 1971, uscì “Una cascata d diamanti”, in cui tutto tornò (tristemente) come prima.
Roger Moore – verso la farsa
All’addio (in teoria definitivo) di Connery la EON si trova davanti ad una scelta difficile: cercare un nuovo Lazenby che tenti in tutto e per tutto di imitare il Bond di Connery o scritturare un attore conosciuto col rischio che “snaturi” (o semplicemente muti) il personaggio secondo la propria storia attoriale pregressa? Le ire del pubblico in seguito al film “Al servizio segreto di sua maestà” portano Broccoli e Saltzman a rischiare e a prendere quindi la strada dell’attore affermato. La scelta cade su Roger Moore, di tre anni più vecchio di Connery ma sulla cresta dell’onda grazie a due serie televisive di successo, “ll Santo” (1962-1969) e “Attenti a quei due” (1971-1972). I produttori lasciano quindi che l’attore londinese si allontani – entro certi limiti, ovviamente – dai Bond di Connery. I sette film con Moore protagonista (che veste I panni dell’agente dal 1973 al 1985) segnalano infatti alcuni grossi cambiamenti. Ci si trova davanti ad un Bond forse meno affascinante ed elegante di quello di Connery, ma con una verve ed un’autoironia che il pubblico apprezza. I film con Moore virano spesso verso la farsa, con l’inserimento di personaggi che paiono uscire direttamente dal cinema slapstick (si pensi allo sceriffo redneck J. W. Pepper, che appare nei primi due film) e di dialoghi pieni di allusioni sessuali e battute da commedia sofisticata. Si parte nel 1973 con “Vivi e lascia morire” (“Live and let die”, Hamilton), trascinato dall’omonima canzone di Paul McCartney, e si prosegue nel 1974 con “L’uomo dalla pistola d’oro” (“The man with the golden gun”, di nuovo Hamilton), con Christopher Lee nei panni del perfido Francisco Scaramanga, Britt Ekland in quelli della sexy agente Mary Goodnight e Hervé Villechaize alle prese con l’indimenticato nano Nick Nack. Tre anni dopo si passa a “La spia che mi amava” (“The spie who loved me”, Lewis Gilbert) in cui Barbara Bach interpreta una bella agente del KGB che aiuta Bond a sventare un diabolico piano di distruzione. Evidenti, in maniera maggiore rispetto ai Bond di Connery, i primi cenni di disgelo tra superpotenze: i russi non sono tutti cattivi e seriosi, bensì possono essere anche leali e, come in questo caso, sexy. Nel successivo “Moonraker – Operazione spazio” (“Moonraker”, Gilbert) la comicità sbraga nella farsa e, più che in un romanzo di Fleming, pare di essere in una comica di Stanlio e Olio. Broccoli volle girare prima “Moonraker” del preventivato “Solo per I tuoi occhi” per cavalcare il successo di “Guerre Stellari”, ma qualunque accostamento col film di Lucas, eccezion fatta per l’ultima mezz’ora ambientata nello spazio, è assolutamente inadeguato. “Solo per I tuoi occhi” (“For your eyes only”, 1981) si fa notare per l’esordio registico del montatore John Glen, perfettamente a suo agio con le sequenze d’azione, e per essere il primo film della saga a non essere tratto da un romanzo ma da un racconto. Dopo il clima farsesco di “Moonraker” la produzione sembra voler tornare ad una certa sobrietà, scelta confermata dal successivo “Octopussy – Operazione Piovra” (“Octopussy”, Glen) in cui un ormai anziano ma sempre autoironico Moore se la deve vedere con un’isola popolata di sole donne. La settima ed ultima esperienza dell’attore nei panni di 007 è del 1985, anno in cui esce “Bersaglio mobile” (“A view to kill”, Glen). A 58 anni Moore è decisamente fuori età per interpretare Bond, ma il film convince grazie ad un cattivo credibile (interpretato da Christopher Walken), a personaggi di contorno riusciti (la sicaria androgina di Grace Jones, il soldato del KGB di un giovanissimo Dolph Lundgren), a una trama che cerca di adeguarsi ai tempi (il piano del villain è quello di distruggere la Silicon Valley per poi avere il monopolio sul silicio con cui si costruiscono I circuiti dei computer). Dopo sette film Moore lascia dunque per raggiunti limiti d’età. Con lui va in “pensione” anche l’attrice Lois Maxwell, che dal primo film interpretava la segretaria di M, Miss Moneypenny.
Timothy Dalton – Tornando alle origini (letterarie)
“007 – Zona Pericolo” (“The Living Daylight”,John Glen) esce nel 1987 e segnala l’esordio del gallese Timothy Dalton nei panni dell’agente segreto. In linea coi lineamenti spigolosi e la sobria recitazione dell’attore, questo quarto Bond è quello che più si avvicina a quello letterario ideato da Fleming, notoriamente più duro e introverso di quelli di Connery, Lazenby e soprattutto Moore. Anche i film mutano di conseguenza: totalmente aboliti i siparietti comici e farseschi, si aspira ad un certo realismo (quasi del tutto banditi I gadget di Q) e si affrontano temi più attuali del solito. La caduta del muro è oramai alle porte, I cattivi sono russi ma sono rinnegati, le donne sedotte da Bond pochissime (colpa anche della nascente paura dell’AIDS), il personaggio non è l’emblema del politicamente corretto (riprende addirittura a fumare!) e la sua personalità è sfaccettata e più credibile. Addirittura, nel successivo “007 – Vendetta privata” (“Licence to kill”, 1989, John Glen), il personaggio conosce sentimenti umani per lui inediti come quelli della rabbia e della vendetta: l’obbiettivo primario di Bond, che per la prima volta disobbedisce a M, è quello di eliminare il villain che ha ferito l’amico Felix Leiter e ucciso la sua signora. Il pubblico non grida allo scandalo ma nemmeno riesce ad affezionarsi a Dalton, che dopo appena due film – e, si dice, diversi diverbi con la EON – lascia definitivamente il ruolo. Il suo Bond, almeno fino alla comparsa di quello di Craig nel 2006, resta comunque il più vicino a quello ideato dal suo creatore Ian Fleming.
Pierce Brosnan – Tornando alle origini (cinematografiche)
Sei anni dopo l’addio di Timothy Dalton (si tratta della pausa più lunga mai avvenuta tra due film della saga), la EON ingaggia Pierce Brosnan, già preso in considerazione per il ruolo in passato ma costretto a rinunciare per altri impegni. Il regista John Glen lascia dopo cinque film e la produzione, questa volta, opta per il ricambio: i quattro Bond con Brosnan sono diretti da quattro registi diversi, e solo uno di essi – Martin Campbell, regista di “Goldeneye” – tornerà a lavorare sul personaggio (suo è infatti “Casino Royale”, il primo Bond con Daniel Craig). Con il suo sguardo sornione e la sua indubbia eleganza, Brosnan sembra ispirarsi direttamente al Bond di Connery, di cui amplifica in maniera esponenziale le caratteristiche tipiche: l’infallibilità, l’invincibilità, la capacità di proferire battute da screwball comedy in qualsiasi situazione e, quella, spudorata, di conquistare donne di qualunque professione, ceto, nazionalità ed età con un semplice sguardo. Se a livello di scrittura del personaggio la saga sembra dunque fare un passo indietro verso la bidimensionalità degli esordi, a livello tematico i quattro Bond di Brosnan hanno il merito di affrontare temi attuali e “reali”, soprattutto in seguito alla fine dell’URSS e del clima di paranoia della guerra fredda. Se in “Goldeneye” (1995, Martin Campbell), il più amato del quartetto, i cattivi sono ancora una volta dei russi rinnegati e l’arma è di nuovo un satellite da guerra, a partire dal successivo “Il domani non muore mai” (“Tomorrow never dies”, 1997, Roger Spottiswoode) si assiste ad un notevole cambiamento di rotta: il cattivo megalomane, questa volta, non è uno scienziato pazzo o un terrorista dichiarato ma un magnate dell’informazione (interpretato da un grande Jonathan Pryce) che vuole controllare gli equilibri mondiali attraverso il potere dei media. Il successivo “Il mondo non basta” (“The world is not enough”, 1999, Michael Apted) affronta un altro tema caldo degli anni ’90, ovvero le furberie occidentali in merito al controllo petrolifero, così come decisamente attuali sono i temi che fanno capolino in “La morte può attendere” (“Die Another Day”, 2002, Lee Tamahori), quarto ed ultimo della saga con Brosnan: si parla infatti di pericolo koreano (riferito alla Corea del Nord) e dei cosiddetti “blood diamonds”. A ben vedere questi quattro film, si deduce che il ricambio registico è un’arma a doppio taglio: se il regista è talentuoso come Campbell ci si ritrova dinnanzi ad un buon film, se invece si tratta di un mestierante “medio” come Tamahori il risultato è deludente (il suo film è pieno di inutili rivelocizzazoni, movimenti di macchina a schiaffo, insomma, pare uno spot pubblicitario). Tirando le somme, comunque, il Bond di Brosnan rimane uno dei più amati ed apprezzati. Anche se è difficile difenderlo dall’accusa di essere “fuori dal tempo”: se infatti i temi sono più attuali che mai, la realizzazione, le strutture narrative, le logiche produttive rimangono troppo simili a quelle degli 007 precedenti. Il problema è che, nel frattempo, il mondo è parecchio cambiato. Bisognerà attendere quattro anni, con l’arrivo del Bond di Daniel Craig, per assistere a qualcosa di radicalmente diverso, forse più maturo.
Daniel Craig – Ovvero, ha ancora senso James Bond nel mondo di oggi?
Nel 2006 esce il 21esimo film della serie ufficiale, “Casino Royale”. Tratto dal primissimo romanzo di Fleming con Bond protagonista, non fu mai preso in considerazione dalla EON perché già portato sullo schermo, seppur in chiave comica, nel 1967 (il film, diretto da John Huston, Val Guest, Ken Hughes, Joseph McGrath e Robert Parrish, vede la partecipazione, tra gli altri, di Peter Sellers, David Niven, Woody Allen, Orson Welles e, nel ruolo di Vesper Lynd, la prima bond girl della serie ufficiale Ursula Andress). La regia viene affidata all’esperto Campbell, già responsabile di “GoldenEye”, mentre il ruolo di Bond è affidato al roccioso Daniel Craig. Si riparte – ovviamente – dalle origini, con un Bond ancora inesperto, non sempre impeccabile, che sembra abusare dell’appena ottenuta licenza di uccidere. Rispetto agli illustri precedenti, quello di Craig è un Bond più impetuoso e arrogante, meno elegante e più sfacciato, ma anche più umano e credibile. L’attore inglese gli dà una fisicità estrema, quasi animalesca, ma gli garantisce anche uno scavo psicologico convincente che sfida la bidimensionalità dei Bond precedenti. La trama – Bond segue le tracce di un banchiere che finanzia organizzazioni terroristiche e che, sprovvisto di capitale, cerca di raccogliere fondi attraverso una partita di poker al cui tavolo siederà anche Bond – rivela diversi collegamenti all’attualità, come ad esempio l’idea di un cattivo supremo impalpabile, sfuggente e faticosamente identificabile che utilizza i metodi tipici del terrorismo. L’atmosfera sbarazzina tipica della serie, ancora presente nei quattro film con Brosnan, è assolutamente bandita in nome di un cupo realismo che riflette questi tempi instabili, mentre le scelte narrative (come il finale in cui muore la Bond girl) si dimostrano assolutamente inaspettate.
“Quantum of Solace” (2008, Marc Forster) rivela che la continuità col film precedente non è solo nelle scelte di casting (confermati Craig, la Dench e Jeffrey Wright come Felix Leiter), ma anche negli sviluppi e nei temi: Vesper non è stata la solita vacua Bond girl che viene dimenticata tra un episodio e l’altro e, anzi, la sua morte spinge 007 a rintracciare i vertici della misteriosa organizzazione responsabile della sua dipartita per cercare vendetta. “Quantum” è il Bond più breve (appena 107 minuti), il più girovago (si passa da Messico, Panama, Cile, Inghilterra, Austria, Italia, Bolivia, Russia), il più antiamericano (la CIA sostiene il dittatore che più le va a genio). Non uno dei migliori: il cattivo è poco affascinante, le bond girl prive di spessore, lo stile abbastanza convenzionale. L’intrattenimento è comunque garantito: le belle sequenze non mancano – strepitoso il montaggio alternato durante La Tosca in un teatro viennese – e alcune trovate, come la citazione di “Missione Goldfinger” (Gemma Atherton muore come moriva Jill Masterson, solo che al posto dell’oro, sul suo corpo, c’è l’oro nero) riescono a raccontare come i tempi siano cambiati dal Bond di Connery a quello di Craig. Ovviamente in peggio, e infatti è cambiato anche 007, sempre più cinico e violento, già disilluso, come se oramai il mondo fosse impossibile da salvare.
Il 2012 è l’anno di “Skyfall”. Colpito dal fuoco amico e dato per morto, 007 si gode qualche mese di meritato relax (a base di sesso e alcol) vivendo su una spiaggia sperduta. Quando il quartier generale dell’MI6 viene attaccato e M rischia di essere destituita, Bond torna a Londra pronto per affrontare un nuovo nemico. Si tratta di Raoul Silva, ex agente dell’MI6 che M accettò di sacrificare e che, a distanza di molti anni, vuole vendetta. La presenza di Sam Mendes dietro la macchina da presa attua una sorta di rifondazione nella rifondazione: “Skyfall” non è solo molto diverso dai Bond di Connery, Moore, Dalton, Brosnan e (una tantum) Lazenby, è addirittura molto diverso da quelli di Craig. È, innanzitutto, uno dei pochissimi blockbuster della storia del cinema ad essere anche un film d’autore, estremamente originale e soprattutto personale: si pensi all’eleganza formale della regia di Mendes, alle magistrali sequenze notturne di Shangai e Macao (ispirate al teatro delle ombre), al finale allucinato tra le fiamme rossastre (un plauso va anche alla fotografia del grande Roger Deakins); ma anche al fatto che il fulcro della trama non sia l’azione – come in TUTTI i Bond precedenti – ma il racconto di una situazione familiare complessa, tema tipico del cinema di Mendes: qualcuno ha parlato di Caino e Abele, qualcuno della parabola del figliol prodigo, altri hanno scomodoato Shakespeare e Edipo; certo è che Bond e Silva sono figli della stessa M(adre) e dello stesso (M)ondo, due facce della stessa (M)edaglia che, forse in modo del tutto casuale, hanno scelto in maniera diversa per chi (o per cosa) combattere. Quello di oggi, sembra dirci Mendes, è un mondo in cui o si ha il potere di sacrificare o si è sacrificati, ma non sempre la divisione è manichea: tutti e tre i protagonisti – 007, M e Silva – pur in momenti diversi, si ritrovano in entrambi i ruoli. È lo 007 in cui, in maniera maggiore rispetto ad altri, si ha il coraggio di ammettere che il mondo è cambiato. La sequenza del primo incontro tra Bond e Q al museo sembra normale amministrazione, in realtà nasconde il senso del film: il quadro che Bond osserva è “La valorosa Téméraire” di Turner, in cui una vecchia nave da guerra viene ingloriosamente trainata verso la demolizione; proprio come M, grande combattente ora costretta ad andare in pensione perché considerata obsoleta (è lei stessa a dirsi spaventata perché “non sa più chi sono i nemici né dove si trovino”). Ecco perché ”Skyfall” è lo 007, a livello geografico, più statico (è quasi tutto ambientato nel Regno Unito): il nemico non è più nascosto in qualche remota isoletta esotica, ma è già in casa nostra e, 9 volte su 10, lo abbiamo creato noi. Ovvero, benvenuti nell’epoca del terrorismo. Per questo è anche il più politico e cupo, attuale e disperato. Una riflessione, quella sul cambiamento, che diventa anche mirabile sottotesto meta cinematografico: quando a Bond viene chiesto quale sia il suo hobby egli risponde “la resurrezione”; non rinascita, resurrezione, ovvero ritorno in altre vesti ma con lo stesso spirito. E infatti, nel finale, il Bond di Craig incontra metaforicamente il Bond di Connery (la casa dei genitori, l’Aston Martin, la Scozia), ed è in questo modo che sconfigge il villain di turno. Tutto ciò, unito alla presenza di personaggi storici della serie (come Q o Eve Moneypenny) perfettamente aggiornati, ribadisce che anche nel rinnovamento non vanno scordate le tradizioni. Come dire, il cinema sarà anche computer grafica ma è prima di tutto racconto. Anche il lavoro fatto sul personaggio (mitizzato e demistificato allo stesso tempo) è qualcosa di davvero travolgente (c’è addirittura una scena in cui si arriva a minare la sua maschera di sfacciata eterosessualità). Tra i molteplici meriti di Mendes (e dei suoi sceneggiatori Neal Purvis, Robert Wade e John Logan), c’è anche quello di aver seguito alla lettera la lezione del grande Alfred Hitchcock: azzecca il cattivo (un grande Javier Bardem) e avrai azzeccato il film.
Il Bond numero 24 è “SPECTRE” (2015), il quarto (e forse ultimo) con Daniel Craig nei panni di 007 e il secondo diretto dal talentuoso Mendes, già responsabile del precedente “Skyfall”. Rispetto a quest’ultimo è meno ambizioso, meno denso di significati e più convenzionale negli sviluppi, ma il film convince ed è capace di un messaggio – troppo spesso siamo il frutto di scelte altrui – tutt’altro che banale. Spronato dalla “vecchia” M (Judi Dench) James Bond si mette sulle tracce dell’organizzazione criminale che gli dà filo da torcere sin dai tempi di “Casino Royale”. Scoprirà che si tratta della famigerata SPECTRE, società occulta radicata ovunque che agisce con l’obiettivo di controllare ogni singolo essere umano convogliandone le paure più profonde. Mendes torna ancora una volta sul racconto di un rapporto familiare difficile, opprimente, irrisolto. Si scava nel passato di Bond, si cerca di capire quali sono le ragioni che lo hanno reso ciò che è. Altro tema forte, stavolta “politico”: la tendenza dei governi a spiare tutto e tutti con la scusa della sicurezza. Memorabile la sequenza prima dei titoli, ambientata a Città del Messico durante il dia de muertos e introdotta da uno strepitoso piano sequenza, e geniale la scena ambientata nella clinica austriaca, omaggio al sottovalutato “Al servizio segreto di Sua Maestà”. L’apparizione della Bellucci è davvero (come hanno scritto molti) così inutile? Può darsi, ma come quella di mille altre bond girls che appaiono e scompaiono in un attimo. Il film chiude il cerchio narrativo iniziato nove anni prima con “Casino Royale”: Bond riesce a vendicarsi di chi gli portò via l’amata Vesper e, anche grazie alla bella Madeleine, a voltare pagina. Interessante notare come sia mutato il ruolo della donna all’interno della saga: da un ruolo marginale o negativo (le donne furbe, in passato, erano tutte cattive, e dunque le accuse di misoginia alla serie non erano poi così pretestuose o infondate) ad un ruolo attivo che diventa, nei quattro film con Craig, il motore delle azioni di Bond: per ben quattro film le sue gesta sono dettate dal bisogno di giustizia rispetto alla morte dell’amata Vesper e accompagnate dall’affetto materno di M. Due donne forti e protagoniste, così come forte è la bella Madeleine che alla fine resterà al suo fianco. Anche le locandine dei film sono mutate seguendo questa logica di emancipazione femminile: nei poster degli anni ’60 Bond era perennemente circondato da bellissime (e spesso svestite) ragazze sorridenti, in quelli dell’ultimo ciclo è rimasto solo l’agente segreto, come se si volesse dichiarare che lui, e le sue scelte, e nient’altro, sono il vero fulcro delle storie. E infatti, guardando i quattro film con Craig, ci si accorge che – finalmente – è proprio così. James Bond è cresciuto, maturato. Si è adattato ai nostri tempi. Gliene siamo grati.
LA FABBRICA DELL’INVISIBILE
La censura cinematografica in Italia, dalle origini a oggi (1913 – 2017)
Prima parte (1913-1962)
di Alfredo Baldi
L’espressione “la fabbrica dell’invisibile” indica in maniera un po’ provocatoria quella istituzione statale la cui attività – spessissimo in passato, più raramente oggi – crea entità invisibili, o meglio, trasforma il visibile in invisibile. Un film che viene proibito, diviene un “invisibile”. Un brano che viene tagliato da un film, il cosiddetto “taglio di censura”, si trasforma anch’esso in “invisibile”: pur esistendo, resterà per sempre precluso alla nostra visione. L’organismo capace di tanto, di un’azione così straordinaria, quasi miracolosa, è appunto la censura cinematografica, definita ufficialmente, e più pudicamente, “Revisione dei film”.
La ragione dell’esercizio della censura è soprattutto morale. Si tratta di una questione antica, molto anteriore alla nascita del cinema. Da una parte vi sono coloro che sostengono la necessità di tutelare la moralità pubblica – con un’azione di controllo preventivo – dai pericoli che possono derivare da potenziali eccessi nocivi delle forme di espressione, siano pure esse artistiche. Karl R. Popper, famoso filosofo ed epistemologo, è uno di questi; egli sostiene che ogni libertà deve essere limitata, principio che non è affatto in contrasto con il liberalismo, anzi ne è parte integrante: se una persona mette in pericolo qualcun altro attraverso l’espressione di sé, è necessario che vi sia un potere organizzato in grado di limitare il potere della persona pericolosa. Dall’altra parte troviamo i molti che sostengono che la censura è sempre un abuso, anche se esercitata dalle persone più aperte e illuminate. Per Norberto Bobbio, uno tra i maggiori intellettuali italiani del secolo scorso, «la censura è l’esercizio di un abuso certo e incorreggibile quale rimedio a un abuso eventuale e correggibile».
L’attività di revisione dei film nasce nel 1913 con la “legge Facta”, durante il governo Giolitti. Il Regolamento per l’applicazione della legge è approvato nel 1914, ma subito si assiste a un progressivo affinamento degli strumenti della censura cinematografica: i membri delle commissioni incaricate della revisione diventano più numerosi e “specializzati”; la tipologia delle scene vietate aumenta e diviene sempre più dettagliata; la severità dei censori si appunta maggiormente su determinati generi di film e non su altri; iniziano i divieti ai minori di 16 anni. Meno di un anno dopo l’insediamento del fascismo, il governo comincia a occuparsi della censura cinematografica e, su proposta dello stesso Mussolini, il 24 settembre 1923 approva un nuovo Regolamento di esecuzione della legge, rimasto sostanzialmente invariato fino alla nuova legge del 1962. A iniziare dal 1934, con la nascita del Sottosegretariato alla Stampa e Propaganda – divenuto poi Ministero della cultura popolare, il famigerato MinCulPop – il regime fascista rivolge nuova attenzione al cinema. Da una parte si adottano varie forme di incentivo statale alla produzione di film, dall’altra comincia un nuovo modo di approccio preventivo alla loro realizzazione, vale a dire che le commissioni di revisione entrano in azione durante il periodo di ideazione del film, prima che esso venga prodotto.
I brani dei film “tagliati” durante il ventennio fascista non sono arrivati fino a noi, anche perché i “tagli” effettivamente apportati alle pellicole sono stati pochi: la censura vera e propria avveniva in un momento precedente. Tuttavia, se osserviamo – visionando i film del periodo 1913-1945 – cosa era consentito vedere durante quel trentennio, rileviamo che sia la censura laica e liberale di Giolitti, così come quella illiberale ma in buona parte laica di Mussolini, erano più permissive, sotto alcuni aspetti, della censura democratica – ma democristiana – del dopoguerra, ad esempio in materia di argomenti e immagini a contenuto sessuale.
Nell’ottobre 1945 vengono abolite le norme che prevedono l’esame preventivo dei soggetti e la concessione del nulla osta preventivo alla lavorazione dei film, ma rimane in vigore l’istituto della revisione preventiva delle pellicole, disciplinato ancora dal Regolamento del 1923. Anche la legge n. 379/1947 approvata dall’Assemblea Costituente, che definisce l’ordinamento della cinematografia e, quindi, la revisione dei film, lungi dall’essere più democratica, si richiama ancora una volta al decreto del 1923. Non basta: l’art. 21 della Costituzione, promulgata l’1 gennaio 1948, afferma: «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.» Quindi l’unico motivo per cui un’opera può essere sottoposta a restrizioni è che essa sia contraria alla morale. Appare allora palesemente contraddittorio il comportamento dell’Assemblea costituente che, nel momento in cui è in fase di avanzata discussione la Carta costituzionale, approva una legge sulla revisione dei film che rinvia, per i criteri di applicazione, al regolamento fascista del 1923 e non tiene conto del principio costituzionale del “buon costume” che essa stessa stava per approvare.
Nel febbraio 1952 l’on. Giulio Andreotti, trentatreenne ma da cinque anni sottosegretario allo Spettacolo – carica che ha rivestito dal maggio 1947 al luglio 1953 – pubblica su Libertas, settimanale della Democrazia Cristiana, un articolo che diverrà famoso, dal titolo Piaghe sociali e necessità di redenzione. Ne riporto qualche stralcio che spiega efficacemente l’atteggiamento nei confronti del cinema dei governanti, e quindi della censura, di quel tempo.
«Se nel mondo si sarà indotti – erroneamente – a ritenere che l’Italia del film “Umberto D.” sia l’Italia della metà del secolo ventesimo, De Sica avrà reso un pessimo servigio alla Patria, che è anche la Patria di Don Bosco, del Forlanini e di una progredita legislazione sociale. Nessuno si scandalizzi. Non chiediamo a De Sica di ispirare la sua produzione agli scritti di Don Sturzo o alle vicende del Partito Popolare. Domandiamo solo all’uomo di cultura di sentire la sua responsabilità sociale, che non può limitarsi a descrivere i vizi e le miserie di un sistema e di una generazione ma deve aiutare a superarli. De Sica ha voluto dipingere una piaga sociale e l’ha fatto con valente maestria, ma nulla ci mostra nel film che dia quel minimo di insegnamento che giovi nella realtà a rendere domani meno freddo l’ambiente che circonda le moltitudini di quanti in silenzio si consumano, soffrono e muoiono. Non dispiaccia a De Sica se noi lo preghiamo di non dimenticare mai questo minimo impegno di un ottimismo sano e costruttivo che aiuti veramente l’umanità a sperare e a camminare.»
Tra il maggio 1947 e l’aprile 1962 sono revisionati dalle commissioni di censura circa 35.000 film italiani e stranieri, tra lungometraggi, cortometraggi, cinegiornali, film pubblicitari, ecc. 1570 di questi, pari al 4,5%, sono respinti o approvati “con condizione”, vale a dire con tagli o con divieto ai minori di 16 anni. Potrebbe sembrare una percentuale relativamente modesta, ma non lo è se si pensa che: a) dei 35.000 titoli revisionati solo poco più di 5.000 sono lungometraggi, mentre gli altri 30.000 sono cortometraggi: cinegiornali, documentari, pubblicità; b) dei 1570 film censurati, oltre l’80%, cioè 1270, sono lungometraggi. In definitiva, un quarto dei lungometraggi passati per la censura in quegli anni (1.270 su 5.000) viene censurato.
In principio le norme sulla revisione non sono applicate in maniera vessatoria. La minore severità si deve al clima di quegli anni caratterizzati da un governo di unità nazionale tra tutti i partiti e dallo sforzo unitario della ricostruzione del paese. Dopo il ventennio buio e opaco del fascismo si respira, nel campo culturale e intellettuale, un’aria di euforia, di libertà, un desiderio di conoscere e di sapere, un’apertura famelica alle novità culturali provenienti dagli altri paesi democratici. In tale atmosfera anche un’istituzione quale la censura cinematografica deve essere tollerante. Dopo il viaggio del Presidente del consiglio Alcide De Gasperi negli Stati Uniti, tuttavia, il clima politico muta radicalmente e nel maggio 1947 la Democrazia Cristiana estromette comunisti e socialisti dal governo. Alle elezioni dell’aprile 1948 la DC conquista la maggioranza relativa dei seggi del Parlamento e va al potere. Anche la censura ne risente, poiché l’attenzione dei governanti torna a rivolgersi al cinema, ritenuto in grado di diffondere ideologie eterodosse e valori antitetici, o comunque diversi, rispetto a quelli della religione cattolica, la religione di stato. Il cinema in quel periodo, oltretutto, è il principale mezzo di intrattenimento degli italiani. Nel 1948 vengono venduti in Italia 587 milioni di biglietti su una popolazione di 46 milioni, con una media di 13 biglietti per abitante, compresi i neonati e i centenari; oggi i biglietti venduti sono dieci volte meno di 70 anni fa!
L’attività repressiva delle commissioni di revisione è contestata da gran parte degli autori di cinema e degli uomini di cultura che ricorrono a proteste sempre più frequenti e accese, accusando il governo di reprimere ogni tentativo di realizzare opere di denuncia, di impegno sociale, di avanguardia, per indirizzare invece la produzione filmica sui binari dell’evasione, della commedia leggera e quindi, in definitiva, del cattivo gusto e della diseducazione morale. I censori si dimostrano severi soprattutto in materia di erotismo, tagliando senza risparmio ovunque vi siano allusioni un po’ troppo scoperte o si veda qualche centimetro di pelle di troppo.
Quanto all’accusa rivolta al governo di boicottare i film d’impegno, ricordiamo che la legge prevede la possibilità di sottoporre la sceneggiatura all’esame preventivo dell’ufficio centrale per la cinematografia. Tale possibilità è sfruttata da tutti i produttori i quali – e non si può dar loro torto – non intendono rischiare di investire ingenti capitali in pellicole che poi alla revisione possono essere bocciate o comunque pesantemente sforbiciate. Molti interventi si svolgono quindi in sede preventiva. I censori invitano a modificare parti della sceneggiatura, a sopprimerne altre, a dare più o meno rilievo ad alcuni personaggi o addirittura, caso non raro, a cestinare il soggetto. Tanto condizionante diviene questo passaggio quasi obbligato del film che, a detta di molti autori, la fase più importante della lavorazione consisteva allora nel “vaglio del progetto”, cioè nello stabilire, da parte del produttore, prima, degli autori del soggetto e della sceneggiatura, poi, cosa potesse passare attraverso le maglie ferree delle commissioni di revisione e cosa invece no. Si noti, poi, che di tali interventi, frequenti e spesso ampiamente pubblicizzati sulla stampa, non si trova alcuna traccia nei provvedimenti ufficiali delle commissioni di revisione. Una volta concesso il nulla osta alla proiezione e uscito il film nelle sale, altri interventi repressivi possono aver luogo. La pellicola può essre sequestrata per iniziativa di magistrati che spesso agiscono a seguito di denunce di associazioni di benpensanti o di semplici cittadini scandalizzati. Ma l’iniziativa può essere assunta anche dalle autorità di pubblica sicurezza, questure e commissariati, che possono sequestrare il film o imporre arbitrariamente all’esercente della sala il taglio di qualche sequenza per riammettere la pellicola in programmazione: cosa, quest’ultima, che normalmente l’esercente si affretta a fare per non perdere il suo guadagno, senza curarsi della lesione dei diritti dei proprietari morali e materiali del film. È quindi evidente che gli interventi comunque esercitati sono assai più ampi, incisivi e numerosi di quanto può essere testimoniato dall’attività ufficiale delle commissioni di revisione, attività che costituisce solo la punta dell’iceberg.
Voglio ora rilevare alcuni comportamenti delle commissioni che appaiono più significativi, sconcertanti, incomprensibili, se non addirittura ridicoli. A metà degli anni Cinquanta il neorealismo da tempo è stato definitivamente archiviato, soffocato dalla censura ufficiale e dalla burocrazia ministeriale. Il governo tuttavia persegue nel proibire tutto ciò che possa avere sapore di riforma, di novità, di progresso e nell’ostacolare quelle opere in cui le istituzioni o i suoi rappresentanti sono raffigurati in maniera non convenzionale. “Totò e Carolina” di Mario Monicelli, prodotto nel 1953, narra le vicende di un poliziotto incaricato di riportare al paese d’origine una ragazza scambiata per una prostituta. Il film è bocciato sia in primo che in secondo grado, tanto che il produttore Carlo Ponti acconsente a tagliare centinaia di metri di pellicola e a riscrivere i dialoghi, pur di fare uscire il film. Quando la pellicola va nelle sale, nel 1955, i risultati appaiono a volte comici, come nel caso di un camion carico di lavoratori che si recano a un comizio sventolando bandiere e vessilli e dai quali, anziché Bandiera rossa, si leva il canto della Montanara. Non pochi i tagli di carattere razzista. Da “Eva nera”, 1954, di Giuliano Tomei, viene tagliata una breve scena con un bacio tra un bianco e una ragazza nera.
Nel 1957 la commissione di revisione di primo grado boccia “Il grido” di Michelangelo Antonioni. Nonostante le proteste del regista e la sua opposizione a qualunque manomissione, il produttore accetta di tagliare due scene. Anche i manifesti dei film incappano nelle maglie della censura, o meglio del sequestro giudiziario. Per offesa al buon costume è tolto dalla circolazione il manifesto di “Poveri ma belli”, 1956, di Dino Risi, che evidenzia eccessivamente le curve posteriori di Marisa Allasio. Lo stesso accade a “Miss spogliarello”, 1956, di Marc Allégret, troppo esplicito nel disegnare le forme della Bardot e che, oltretutto, pubblicizza un film il cui tema, lo “spogliarello”, è condannato dalla morale cattolica e non tollerato dalle commissioni di censura.
Il 5 febbraio 1960 ha luogo a Milano la “prima” de “La dolce vita”, vietato ai minori di 16 anni. Le proteste di alcuni spettatori interrompono più volte la proiezione; il regista Fellini all’uscita della sala è addirittura insultato. I giornali conservatori e la stampa del Vaticano, dell’Azione Cattolica e dei gesuiti condannano senza appello il film.
Ma la popolarità del regista e il successo della pellicola sono tali che il ministro democristiano, Umberto Tupini, non ha il coraggio di richiamare la pellicola in censura, sicché dopo qualche settimana le polemiche si placano. Il 14 ottobre dello stesso anno, ancora al cinema Capitol di Milano, si svolge la serata di gala per “Rocco e i suoi fratelli”, di Luchino Visconti. Le reazioni del pubblico e della critica sono, anche stavolta, contrastanti. Ma il giorno successivo il procuratore capo di Milano, Carmelo Spagnuolo, visiona privatamente il film insieme ad altri magistrati e impone al distributore di tagliare entro tre giorni alcune scene, pena il sequestro della pellicola con l’accusa di spettacolo osceno. Visconti si oppone decisamente, sostenendo l’illegittimità della procedura. Il produttore Goffredo Lombardo temporeggia e cerca di guadagnare tempo. A questo punto il ministro dello Spettacolo, il democristiano Alberto Folchi, richiama in censura il film per eliminare le scene ritenute lesive dal procuratore Spagnuolo: la notte d’amore di Simone e Nadia, la violenza a Nadia, la lotta tra i fratelli Simone e Rocco, l’uccisione di Nadia.
Spagnuolo prosegue nei suoi interventi repressivi. Sequestra, per grave offesa al comune sentimento del pudore, “Dolci inganni” di Alberto Lattuada, peraltro già ampiamente espurgato dalla commissione di revisione che vi ha apportato tagli per 305 metri, oltre 11 minuti! Analoga sorte, e per gli stessi motivi, tocca a “Una giornata balorda”, per il quale sono denunciati l’autore del soggetto Alberto Moravia, lo sceneggiatore Pier Paolo Pasolini e il regista Mauro Bolognini
Concludo questa prima parte con un’affermazione di un’eminente personalità della vita culturale italiana del Novecento che dimostra come l’ostilità e il pregiudizio nei confronti del cinema siano rimasti radicati anche in intellettuali al di sopra di ogni sospetto di autoritarismo. Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura nel 1975, nel 1961 dichiara al Corriere della sera: «Ho sempre pensato che il cinema (anche il cinema in apparenza privo di fatti o situazioni immorali) sia inevitabilmente fonte di prostituzione e di delinquenza. E d’altra parte mi ripugna ogni forma di costrizione o di censura. La cosa migliore sarebbe che si andasse meno al cinema, che i giornali ne parlassero meno e che questo enorme pallone gonfiato moderno si sgonfiasse da solo. Ma non c’è da sperarlo.»
Finalmente, dopo mesi di estenuanti discussioni, il 29 aprile 1962 entra in vigore la nuova legge sulla censura, legge n. 161, “Revisione dei film e dei lavori teatrali”, approvata dal Parlamento al termine di oltre un decennio di polemiche roventi, di discussioni accanite e di confronti durissimi. La legge nel suo impianto fondamentale, pur con molte modifiche, è stata in vigore fino a pochi mesi fa.
INCONTRI
INCONTRO RAVVICINATO CON UN GRANDE REGISTA:
DAVID LYNCH
di Paola Dei
A darci un assaggio del regista statunitense definito l’uomo del Rinascimento, noto a tutti per gli indimenticabili capolavori della filmografia internazionale, è Nanni Moretti, uno d di più apprezzati registi italiani. Con ironia e la solita capacità affabulatoria che lo contraddistingue alla Festa del Cinema di Roma descrive quando incontrò David Lynch al Festival di Cannes che minacciò di ucciderlo. “Vidi un ciuffo di capelli bianchi e poi riconobbi lui. Era il 2001 e a Cannes presentai “La stanza del figlio”. In quell’occasione c’era anche David Lynch che vedendomi passare disse che un giorno o l’altro mi avrebbe ucciso! Se una cosa del genere te la dicono i fratelli Coen ti fa pure ridere ma detto da David Lynch…….Gli ho detto che non sapevo nemmeno che premio avessi vinto. Lui mi ha risposto: ‘Ti ammazzerò comunque'”.
Lynch non ha mai ucciso nessuno, anzi, come ha raccontato alla Festa del Cinema di Roma, pratica meditazione da moltissimi anni e la sua serenità è palpabile oltre che visibile a tutti i partecipanti all’incontro. In questa sede racconta di aver studiato arte prima di dedicarsi al Cinema e di aver amato Filadelfia per le sue follie, per la sua architettura, per i suoi colori improbabili e i mattoni coperti dalla fuliggine a causa delle fabbriche.
Mentre ci racconta questa sua attrazione per la città della Pennsylvania, evoca anche la sua infanzia passata nei boschi ed è inevitabile l’accostamento a “Velluto blu”, inconfondibile opera del 1986 il cui titolo originale è tratto dalla canzone omonima di Bobby Vinton, cantata nel film da Isabella Rossellini in un locale notturno, lo Slow Club. Del film Lynch è stato regista e sceneggiatore, mentre De Laurentis ne è stato il produttore.
Come scrive anche Wikipedia, il cineasta passava molto tempo nei boschi di Spokane, una zona del nord-ovest statunitense simile a quella del film. Per Lynch c’era un “livello autobiografico molto preciso nel film”. «Kyle è vestito come me. Mio padre era un ricercatore del Dipartimento di Agricoltura di Washington. Eravamo sempre tra i boschi. Ne avevo in qualche modo abbastanza degli alberi in quel periodo, ma ancora oggi, il legname e i boscaioli per me sono l’America così come la staccionata e le rose della scena di apertura del film. È così radicata, questa immagine, e mi fa sentire molto felice».(op. cit, Chute, David, Ottobre 1986) Se i ricordi d’infanzia di Lynch ispirarono l’ambientazione di “Velluto blu”, l’effettiva storia del film fu originata da tre idee che si cristallizzarono nella mente del regista a partire dal 1973 anche se all’inizio egli aveva “solo una sensazione e un titolo” (Bouzereau, Laurent, 1987). Lynch ci racconta che quando girò il film impose a Dino De Laurentis di accettarlo come lui lo avrebbe scritto e realizzato, altrimenti non lo avrebbe fatto. “La sceneggiatura nasce da frammenti di idee. A volte si cercano ma poi arrivano all’improvviso”.
Il secondo film che il regista ricorda intervistato da Antonio Monda è “Mulholland Drive” del 2001, un grande film su Los Angeles, altra città dalla quale si è fatto affascinare.
“Sono andato a vivere a Los Angeles di notte e non la apprezzai molto, ma poi la mattina dopo al risveglio vidi la sua luce e me ne innamorai. La amo anche per la mancanza di conflitto che dà un grande senso di libertà e ha segnato l’era d’oro del Cinema. Io spero che torneranno a fiorire i ciclamini.”
Con due occhi che sembrano catturare tutte le suggestioni che l’ambiente sprigiona Lynch ci dice di aver lavorato molto anche per la TV e di amare molto il digitale perché schiude un mondo meraviglioso e fa assomigliare i film alla pittura.
Monda gli ricorda di aver assistito ad un incontro in cui il cineasta statunitense si confrontava con Bertolucci, altro grande regista italiano, ed entrambi concordavano nel ritenere che con l’alta definizione si vede troppo mentre è bene lasciare un pò di mistero.
“Amo Bertolucci ma non ricordo questa conversazione. So che molti pensano che il digitale sia poco plastico, ma ora questo mezzo permette di avvicinarsi anche alle sensazioni che si possono immaginare”.
Quando gli viene chiesto di scegliere dei pittori ci parla di Bacon per la sua capacità di distorcere i personaggi. “È uno dei più grandi artisti nella storia dell’arte e amo il modo in cui esplora la fenomenologia organica.”
Ci parla poi delle sue Mostre istallazioni e ci spiega come questo faccia parte della sua genesi espressiva.
“Mi piace dipingere le idee, si possono dipingere idee che entusiasmano e poi portarle sullo schermo. In questo momento in particolare mi piace la pittura brutta e un po’ infantile. Quando preparo una mostra c’è un filo narrativo o sono solo sequenze di opere. A volte è così e sembrano solo sequenze di linee ma a volte esploro una linea e vado avanti. Amo anche esplorare i frammenti organici, mi piace esplorare le superfici e poi aggiungere qualcosa per far emergere qualcos’altro.”
Fra i grandi maestri del Cinema che ama, Kubrick è il primo con “Lolita”.
“C’è un mondo letterario molto scettico su questo film. Sinceramente si potrebbe dire la stessa cosa di chi lo critica. Io lo trovo un film straordinario da tutti i punti di vista. Amo gli umori che evocano i luoghi, come si evolve la storia, non ha importanza come si arriva a questa bellezza ma lo amo molto.”
Il secondo film scelto è “Viale del tramonto” di Billy Wilder. “Alcuni vedono questa opera come un film dell’orrore, io lo vedo solo come un film triste, di desideri non realizzati.”
Ci racconta un aneddoto su due strade e dei nomi scelti dal regista, poi aggiunge: “Billy Wilder era straordinario per il suo senso dei luoghi. Ne è un esempio la casa che è bellissima anche se sta crollando. La bellezza è insita nella casa, negli arredi, nella musica e questo fa riemergere l’epoca d’oro degli anni 50.”
Gli viene chiesto poi il legame fra Cinema e sogno. “Amo i sogni e amo il Cinema. A volte sappiamo le cose ma non riusciamo a dirle, con il cinema si può. Amo anche le storie che permettono di mettere insieme concretezza e astrazione. Il mio film che meglio esprime questo concetto è “Mulholland Drive” e Fellini, che è uno dei grandi Maestri del Cinema mi ha sicuramente ispirato.
Ad una cena con Mastroianni a base di funghi che fu molto bella, dissi a Marcello che amavo Fellini e lui mi mandò a prendere da una macchina per portarmi a Cinecittà dove trascorsi una giornata intera con Fellini. All’epoca a Cinecittà Fellini girava e direttore della fotografia era Tonino dello Colli. Ricordo una donna con un seno gigante. Anni dopo facevo uno spot per la Barilla con Depardieu, il direttore della fotografia era ancora Delli Colli. Fellini era ricoverato e lo trasferirono a Roma, era presente solo la nipote io entrai nella stanza di ospedale e in mezzo vidi Fellini nella sedia e rotelle, con lui c’era anche Vincenzo Mollica. Fellini raccontò quello che accadeva nel mondo del Cinema, e di come l’entusiasmo si fosse trasferito alla televisione e tutti si fossero dimenticati di lui.
Vincenzo alludendo a me, dopo che lasciai la stanza gli disse: “questo è un bravo ragazzo. Questo accadde il venerdì, la domenica Fellini entrò in coma e due settimane dopo morì.”
Ascoltare Lynch e una grande fascinazione, qualcuno gli chiede della meditazione, lui spiega quanto questa tecnica e questa filosofia di vita lo abbia aiutato nella vita, poi arriva Sorrentino per premiare David Lynch e sul palcoscenico si incontrano due monumenti della Storia del Cinema. Un racconto indimenticabile per arrivare a quell’ignoto che si nasconde dentro di noi.
Bibliografia
- Chute, David (Ottobre 1986). “Out to Lynch”. Film Comment, p. 35.
- Bouzereau, Laurent (1987). “An Interview with David Lynch”. Cineaste, p. 39.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
 FILMMAKER ALLA RIBALTA:
FILMMAKER ALLA RIBALTA:
LAURO CROCIANI
di Paolo Micalizzi
Poco più che sessantenne, Lauro Crociani ha un’intensa attività di filmmaker ed una quarantina di cortometraggi al suo attivo. Determinanti per la sua attività di regista è stato per Lauro Crociani , come lui dichiara, l’esperienza di pre-morte durante un incidente per il primo periodo di attività e la lettura di due filosofi bulgari per la parte successiva. Ha iniziato a realizzare cortometraggi nel 1993, privilegiando corti comici dove, per lui, il divertimento era, ed è, materia per stare insieme e giocare. Un grande gioco, dichiara, in cui coinvolge tante persone facendo riscoprire il “bambino che è dentro ognuno di noi”. Con il gioco, prosegue, arriva il sorriso che preventivamente tiene lontano i disordini e le malattie facendoci vivere con maggiore serenità. Per questo, nei suoi lavori predilige attori improvvisati, cittadini comuni, coinvolgendo cosi la collettività a vivere un’esperienza insieme, non sottovalutando l’aspetto dell’autostima che aiuta i più insicuri portandoli alla ricerca della loro naturale forza interiore. “Alla base del mio ragionamento, sottolinea, c’è come esempio pratico di funzionalità, il sistema solare, tutto si deve dirigere verso il centro”. Per Lauro Crociani, ogni cosa ha un suo equilibrio e un suo posto, e pertanto è questa la base giusta di ogni ragionamento per arrivare a un buon fine.
Ha iniziato a realizzare cortometraggi con “Il vero Omo delle crete senesi”(1993), un corto di 6 minuti incentrato sulla nascita di un personaggio per far divertire bambini ed anziani, un “vero uomo” di campagna con la maglietta a strisce inconfondibile davanti al quale tutti hanno la stessa età, dopo, peraltro maglietta che dopo 25 anni nei corti comici continua ancora a indossare. Un gioco, con delle divertenti vignette come risposta, che continua con i propri figli in “Il moroso” (1997) in cui protagonista è una famiglia in difficoltà a pagare le bollette. Un’opera, dichiara Crociani, che proiettata all’auditorium dell’università Cattolica di Milano ha riscosso gli applausi con metà platea in piedi, un pubblico che lo ha considerato, sono sue parole, il regista più iconoclasta di quel decennio . Grande successo anche per “Eh…la Madonna!”, andato in onda ben sei volte a “Blob” di Rai Tre, il programma cult di Enrico Ghezzi.
Un corto di piccole vignette di esclamazioni toscane, e non di imprecazioni come si potrebbe pensare di primo acchito, rivolte a Maria con lo stesso amore con cui ci si rivolge in casa alla madre. Un pazzo è poi il protagonista del corto “La Scatola del Pane” ( 2000), un pazzo fuoriuscito che gira per la città con uno scatolone che ogni tanto mette in testa. Chi lo incontra si chiede cosa mai contenga quello scatolone. Soltanto un bambino capirà subito di cosa si tratti. Un apologo per Lauro Crociani per indicare il valore della purezza e della spontaneità. E’ il primo dei cortometraggi di un periodo In cui tende a sviluppare cortometraggi con tematiche filosofiche/spirituali. Pur rendendosi conto che siano di difficile impatto con il pubblico, in esse “crede fermamente con stabilità, fuori da strutture murarie e mentali, cercando la fratellanza tra esseri umani”. Tematiche filosofiche/spirituali che derivano da continue letture. Afferma, infatti, che ha scoperto che il più grande dei santoni indiani, Ramana Maharshi, in una rarissima intervista a un giornalista inglese che gli aveva chiesto quale fosse il significato della vita rispose: “Siamo in un grande giardino dove il Creatore gioca con noi”. Una frase che gli ha chiarito come “in questa nostra leggerezza sta l’elevarsi verso la conoscenza dell’anima e dello spirito, con tutto ciò che ne segue” aggiungendo “che guardando dall’alto cosa ci accorgiamo della miseria e del totale sprofondamento materialista in cui siamo purtroppo piombati in questi ultimi decenni pieni di egoismo, senza più rispetto per elementi basilari”. Qual è la vera strada che conduce allo spirito, si chiede il protagonista di “Fir Fun Feen” (2005) e la sua risposta è che “solo la cultura ci salverà da questa decadenza, in cui anche la Dea dell’Acqua è privata della sua energia”. Un grido che però non sarà ascoltato dai cittadini del paese in cui vive. Anche in “Uasnaladiù” ( 2006), il protagonista lotta per essere salvato dall’interno di un bagno chimico ( un water close) di plastica in cui è rimasto bloccato. Ma la situazione è difficile malgrado gli speciali TG dell’emittente “Uasnaladiù”.
Si tratta, per l’autore, di una rabbiosa satira sulla giungla Italiana dell’emittenza, senza regole, la cui informazione è manipolata. Riflessioni filosofiche/spirituali anche in “E mi viene da pensare” (2008). Protagonista un disegnatore che con la sua arte pensa di creare, ma la gente è del parere che tutto si dissolve e non rimane più nulla. Invece, secondo l’autore, in alto tutto viene registrato e qualcosa rimane per sempre, indelebile. La dignità è ciò che salva un anziano in quest’epoca di profondi cambiamenti dove impera il materialismo più cinico. E’ quanto viene sostenuto in “Grano giallo sole” (2008), una storia di terra, di vita e d’amore. Ed è grazie agli anziani che rimane il ricordo di un cantastorie amato da bambini e grandi. Lo ricorda anche Lauro Crociani in “Pietro Carbonetti, vagabondaggio” (2010). E’ un personaggio che passava, tra paesi e campagne, con un tamburello al collo: d’inverno dormiva nei forni dove le contadine cuocevano il pane. E questo elemento è il protagonista di “Ecce Panis Angelorum”2012), dove costituisce un momento di riconciliazione tra poveri contadini che lo dividono con altri più poveri ancora, con semplicità ed umiltà. Un altro elemento della natura è l’acqua. In “Alma Mater Acqua” (2013), Lauro Crociani sviluppa un racconto che ha per protagonista un uomo che rivive le sue origini, il fallimento della sua vita lontana dai genitori e dalla cittadina termale (Chianciano Terme).
Sarà una lettera della madre, trovata in soffitta, che lo salva dal male di vivere. Favole antiche e moderne nei lavori più recenti. Del 2014 è “Re di tutto Re di niente” che tratta un tema millenario: quello dell’insoddisfazione malgrado si abbia successo e potere. Accadeva ai Re, accade oggi agli uomini. Avendo, come punti di riferimento i suoi Maestri spirituali bulgari Peter Deunov e il suo allievo Omraam Mikhael Aivanhov , ( Lauro però specifica che si ritiene solo un pessimo studente), Il nostro filmmaker immagina un racconto in cui l’Uomo Arcobaleno è un raggio di Sole che con la sua danza unisce e dà corpo alla Fratellanza tra gli esseri umani. Alla ricerca di fari- guida lungo il cammino di crescita morale e spirituale, Lauro Crociani le individua nelle” Sefirot, centri d’irradiamento di un’energia superiore, puro riflesso della coscienza Divina”.
Sono nel corto “La terza Sefirà”(2017) dove il protagonista fa un percorso di vita in mezzo a cambiamenti, paure e trasformazioni “per raggiungere infine se stesso bambino, abbracciando cosi la propria Anima e donare speranza a tutti”. Nella filmografia di Lauro Crociani ci sono anche diversi Videoclips musicali. In uno di questi, “Nudo”, il protagonista è un padre che causa divorzio incontra la figlia ogni quindici giorni. E gioca con lei per alcune ore con tante foglie attorno. Il suo desiderio sarebbe che una foglia salga in cielo per dire tutto il suo dolore per un destino che non ha scelto. L’ambiente di questo poetico racconto è quello della Val d’Orcia, in terra di Siena. Sono cortometraggi, questi di Lauro Crociani, che s’avvalgono di sue esperienze in campo culturale. Dal 1995 al 2000 è stato Direttore Artistico del “Bettole in …Musica e Immagine” e nel 2000 ha fondato l’Associazione “Immagini e Suono” per la quale ha ideato e costruito “Corto Fiction Chianciano Terme” , curandone anche la Direzione Artistica con aspetti più “umani” che puramente tecnici. E’ un Festival dei migliori corti prodotti da case cinematografiche e da autori indipendenti, che nel 2018 festeggia la 18.ma edizione. Per fare conoscere le potenzialità positive dell’Audiovisivo ha poi organizzato centinaia di proiezioni di cortometraggi in piazze, pub e scuole.
E’, il suo, un impegno continuo nella comunicazione, essendo convinto che l’arte e la cultura siano il mezzo per la crescita personale e collettiva della società. Dal 1994, poi, dirige “Corti Corsari”, in onda su Tele Idea sul canale regionale 190, una trasmissione che si occupa di cortometraggi e di tutto ciò che fa parte del mondo dell’arte e creatività: ricorre quest’anno il venticinquennale e sono in atto i preparativi per festeggiare le nozze d’argento. E’ anche ideatore e regista della trasmissione “Vera Musica” con band di genere “Progressive, Jazz e Blues” del territorio. In questi ultimi anni è nato poi il programma “Ho scelto un libro per Amico” dove trovano spazio scrittori locali. Con l’Associazione Culturale “Immagini e Suono” che , creata nel 2000 conta oggi una cinquantina di soci, svolge corsi di audiovisivi, realizzazione di cortometraggi che partecipano a festival nazionali, registrazione di programmi televisivi. Per il prolifico Lauro Crociani un progetto di crescita e di autostima per molte persone, di cui va fiero.
Filmografia
1993 IL VERO OMO DELLE CRETE SENESI (VHS, 6′)
1995 UNA NOTTE VERA (VHS, 5)
1995 SIFONEIDE (VHS, 9)
1997 IL MOROSO (VHS, 5)
1998 EH…LA MADONNA! (VHS, 6′)
2000 LA SCATOLA DEL PANE (DV, 4′)
2002 ALLEGRO ALLORO (Mini DV, 12’)
2004 CANTO NOMADE PER UN PRIGIONIERO POLITICO (Mini DV,7’)
2004 FIR FUR FEEN LA VERA STRADA DELL’UOMO (Mini DV, 6’)
2004 CANTO NOMADE PER UN PRIGIONIERO POLITICO (Mini DV,7’)
2006 UASNALADIÙ (Mini DV, 8’)
2007 POLVERE BIANCA (Mini DV, 2’)
2007 DUE PIÙ (Mini DV, 4’)
2007 NIÙ ECONOMI (Mini DV, 2’)
2008 GRANO GIALLO SOLE (Mini DV, 12’)
2008 E MI VIENE DA PENSARE (Mini DV, 5’)
2008 LIEVI NOVELLE IN BASSA TOSCANA (Mini DV, 9’)
2010 PIETRO CARBONETTI, VAGABONDAGGIO (Mini DV, 12’)
2010 SONEANIMA (Mini DV, 5’)
2011 DOPO…NIENTE È PIÙ LO STESSO (Mini DV,10’)
2011 L’IDEA MIGLIORE (Mini DV, 9’)
2012 ECCE PANIS ANGELORUM (Mini DV, 14’)
2013 ALMA MATER AQUA (DV, 12′)
2013 PINO SILVESTRE (Mini DV,5’)
2014 RE DI TUTTO RE DI NIENTE (Mini DV,8’)
2014 NO PE VANTAMMI, MA OGGI È UNA BELLA GIORNATA (Mini DV,10’)
2015 KYRIE ELEISON (Mini DV,4’)
2016 OTTOBRE BILANCIA (Mini DV,8’)
2016 POI TI FÒ LA GIUNTA (Mini DV,9’)
2017 LA TERZA SEFIRÀ (Full HD, 10’)
2017 NUDO (Full HD, 5’)
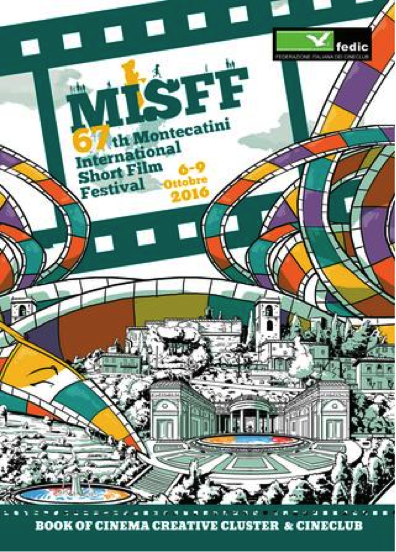 GIANCARLO GIANNINI MATTATORE AL MISFF 68
GIANCARLO GIANNINI MATTATORE AL MISFF 68
di Paolo Micalizzi
Punto di forza dell’edizione 2017 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival- dedicato al cortometraggio, è stata la Masterclass dell’attore Giancarlo Giannini, protagonista da cinquant’anni del cinema italiano e internazionale. Alla presenza del Presidente del Festival Marcello Zeppi e del Direttore Artistico Giovanni Bogani, il prestigioso attore ha calamitato l’attenzione del pubblico partendo dalle sue esperienze iniziali con un teatrino di legno dove animava i pupazzetti di argilla colorati e, successivamente, con la costruzione di un proiettore con una scatola di legno con il quale proiettava pellicole fatte col cellophane delle sigarette del padre: rivelava già il suo istinto al racconto teatrale e cinematografico. Il rapporto con il cinema avvenne, si era già diplomato perito elettronico, iscrivendosi all’Accademia d’Arte drammatica nella quale, grazie ad una borsa di studio, fece esperienze che poi gli saranno utili per la carriera futura. Una carriera che conta oggi interpretazioni in oltre centosettanta film, e la conoscenza di registi come Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni con i quali doveva fare dei film che poi non furono realizzati. Molti dei suoi film sono oggi dei cult movie, “Travolti da un insolito destino in un azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmuller, in testa. Ma anche “Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca”(1970) di Ettore Scola in cui rivela quella sua carica di istrionismo continuata poi in altri film della Wertmuller. Al suo attivo anche film con Dino Risi, Mauro Bolognini, Mario Monicelli, Nanni Loy e Luchino Visconti per il quale è protagonista in “L’innocente”(1976). Film che l’attore ricorda bene e di alcuni dei quali ha parlato nella sua Masterclass svolgendo una panoramica che ha fatto rivivere momenti importanti della storia del cinema italiano, ma non solo perché ha ricordato anche miti del cinema che ha conosciuto come Billy Wilder, Marlon Brando, Steven Spielberg ed ha raccontato aneddoti , trucchi e segreti del momdo del cinema.

Giancarlo Giannini durante la sua Masterclass affiancato da Giovanni Bogani (a sin.) e Marcello Zeppi
Nella sua Masterclass, Giancarlo Giannini ha anche parlato, tra l’altro, di cucina, del doppiaggio e della sua attività di inventore , tra cui l’ideazione della famosa giacchetta rossa piena di gadget indossata da Robin Williams nel 1992 nel film “Toys”. Il poliedrico e prestigioso attore, dopo la Masterclass è stato ricevuto in Comune dal Sindaco Giuseppe Bellandi che gli ha consegnato l’Airone d’oro “ per il suo grande contributo alla storia del cinema”. Nel ringraziare, Giancarlo Giannini ha dichiarato che gli era piaciuto essersi trovato a fare scuola di cinema di fronte a tanti giovani appassionati e ai talenti del futuro poiché l’entusiasmava l’idea di trasmettere le sue conoscenze, e di lasciare qualcosa a quei ragazzi che possano aiutarli a costruire la strada per realizzare i loro sogni, come a lui è stato possibile farlo.
Erano 155 i cortometraggi provenienti da 57 paesi del mondo, rappresentativi di tanti generi, commedie, fantascienza, horror, romantici, fiction e sperimentali, la cui selezione è stata svolta dalla Commissione artistica coordinata da Antonella Santarelli. La sezione competitiva del Festival ha visto vincitore dell’”International Contest” il cortometraggio russo “I can see you” di Denis Kudryavtes che racconta di un furto d’auto che porterà una ragazza orfana ad incontrare sul sedile posteriore un ragazzo cieco. E la sua vita cambierà. Best Italian Short Film a “Gionatan con la G” di Gianluca Santoni. Un cortometraggio ambientato nella periferia di Roma che coglie il piccolo Gionatan deciso ad uccidere il padre perché è violento con la madre. Uno spaccato di vita molto triste, che ricorda l’universo borgataro pasoliniano. Nella categoria documentari vittoria di “50 X Rio” di Francesco Mansutti che racconta la storia di Alex Zanardi, l’ex pilota professionista che, dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente conquista l’oro sulla handbike diventando un simbolo di riscatto e di voglia di vivere. Nell’altra sezione competitiva, la “Vetrina Fedic”, il premio della giuria va invece a “Uno di noi” di Max Nardari . Il cortometraggio afronta il tema delle adozioni e dei pregiudizi razziali.
Importante per il MISFF il rapporto con la Scuola che ha consentito a moltissimi studenti delle scuole della Toscana, tramite il progetto Alternanza Scuola-Lavoro di assistere alla proiezione di alcuni cortometraggi: un momento molto utile per la formazione dei giovani. Nell’ambito del MISFF ha anche avuto luogo la premiazione del Concorso “Scuola Video Multimedia Italia”, da parte di Laura Biggi, responsabile Fedic-Scuola, alla presenza del Presidente Fedic Lorenzo Caravello.
Anche quest’anno si è svolta poi l’iniziativa “The Authors’ Day” coordinata da Antonella Santarelli con la supervisione artistica del regista e sceneggiatore Alessandro Grande: sono stati presentati oltre settanta progetti cinematografici proposti da sessanta autori. Tra le tante iniziative del Festival, da sottolineare la presentazione, in anteprima nazionale, del film “Zoroastro” di Giuseppe Ferlito , realizzato con gli allievi della Scuola di Cinema “Imagina” da lui diretta, avvenuta alla presenza del regista e del cast, ed in particolare dei due protagonisti Lorenzo Provvedi e Letizia Toni .
La vicenda ruota attorno alla figura di Tommaso Masini, detto Zoroastro da Peretola, l’inserviente di Leonardo Da Vinci che sperimentò il volo con le ali progettato dal grande genio del Rinascimento. Il film si svolge è ambientato ai giorni nostri e il protagonista moderno della vicenda(Lorenzo Provvedi) si identifica fortemente con il personaggio storico di Zoroastro con il quale ha molte cose in comune, oltre alla straordinaria omonimia. Un ruolo di rilievo ha anche la sua fidanzata Carlotta(Letizia Toni). “ Zoroastro” ,ha dichiarato Il regista, è un sognatore moderno che costruisce con le sue mani il suo sogno. E’ un uomo spinto dalla voglia di conoscenza perché è la curiosità che rende magica la realtà che ci circonda”.
Premiati con l’Airone d’oro al MISFF 68 anche l’attrice Sarah Maestri e l’attore Sebastiano Somma. Sarah Maestri ha anche presentato il cortometraggio, sua opera prima di regista, “Il mondo fuori da qua” che mostra alcuni bambini, tra cui sua figlia adottiva, ospiti del più grande orfanotrofio della Bielorussia per documentare il progetto di accoglienza che dopo la catastrofe di Cernobyl ha portato in Italia oltre settecentomila bambini bielorussi adottati da famiglie italiane attraverso vari progetti di accoglienza.
L’attrice ha realizzato quel cortometraggio per sensibilizzare la gente su questo problema che sta vivendo momenti di difficoltà ed ha tempi d’attesa per l’adozione di bambini molto lunghi : lei stessa per vedere la sua bambina deve spesso recarsi in Bielorussia. In chiusura di Festival, Leone d’oro all’attore Sebastiano Somma “per il suo impegno a favore dei ragazzi disabili”. L’attore, infatti, ha portato in scena una rappresentazione della “Medea” assieme ai ragazzi disabili del Teatro Patologico diretto da Dario Ambrosi . Nell’occasione è stato proiettato il trailer del film “Mare di grano” di Fabrizio Guarducci che ha nel cast , oltre a Sebastiano Somma, Ornella Muti e Paolo Handel.
FESTIVAL ED EVENTI
 GIOVANI AUTORI E MAESTRI AL FESTIVAL DEL CINEMA
GIOVANI AUTORI E MAESTRI AL FESTIVAL DEL CINEMA
DI PORRETTA TERME CHE HA ANCHE OMAGGIATO
UN’ATTRICE DIMENTICATA
di Paolo Micalizzi
Il film di Sebastiano Riso “Una famiglia” è stato il vincitore della XVI edizione del Festival del Cinema Libero di Porretta Terme( 5 – 10 dicembre) aggiudicandosi il Premio del Pubblico nella Sezione “Fuori del giro” che annoverava cinque opere di giovani autori. Per lo stesso film Micaela Ramazzotti è stata giudicata miglior attrice con il Premio giovani “Acqua Cerelia” perché “con drammatica passionalità ha dato ‘corpo e anima’ a uno dei personaggi più intensi di questa stagione cinematografica”. Il film di Sebastiano Riso affronta un tema spinoso. Quello della vendita dei neonati che vede coinvolta Maria(Micaela Ramazzotti) legata ad un compagno senza scrupoli. La vicenda si complica quando l’uomo viene a contatto con una coppia di omosessuali disposti a pagare molto bene pur di avere un bambino. Ma Maria non ci sta.
Un Festival, quello di Porretta Terme, che rappresenta un appuntamento importante per il cinema italiano ed una manifestazione di prestigio per l’Appennino bolognese che, come ha sottolineato in chiusura di manifestazione il Presidente di quest’Associazione di volontari Luca Elmi, è in grande crescita e ha visto quest’’anno la partecipazione di oltre 2.500 persone.
Il Festival ha dedicato un’ampia Retrospettiva a “Il cinema clandestino di Silvano Agosti”, personaggio singolare conosciuto anche nel mondo della FEDIC per essere stato anche giurato in alcuni suoi Festival. Un cinema clandestino quello di Silvano Agosti perché non programmato nelle sale cinematografiche, ma in apposite “personali” in cinema d’Essai e nei Festival, ma anche in altre occasioni volte a far conoscere il suo cinema. Un autore, Silvano Agosti, che è anche un “esercente” cinematografico , avendo fondato a Roma l’Azzurro Scipioni”, caratteristico per le lunghe programmazioni dei suoi film ma anche di altri autori indipendenti.
Un “esercente” che vi accoglie nel suo cinema, in zona Prati a Roma, con un “Benvenuto all’Azzurro Scipioni, l’unico cinema che vi ama”, accompagnato dall’immancabile vassoietto di caramelle che personalmente distribuisce in sala. La mia conoscenza di Silvano Agosti avvenne nel 1967 quando alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro fu presentato il suo primo film “Il giardino delle delizie” che colpi la critica presente per il taglio di carattere psicoanalitico dato ad un racconto che ruotava attorno ad un’ educazione cattolica repressiva. Ebbe molti guai con la censura, cosi come non facile è stata la realizzazione degli altri suoi film, alcuni dei quali visti( o rivisti) anche a Porretta. Film che lui ha prodotto, convinto che sia possibile produrre qualsiasi film senza problemi di denaro come continua a sostenere nel suo interessante libretto “Come fare un film”, edizioni “L’immagine”, cioè la sua Casa editrice. Al Festival di Porretta Terme, Silvano Agosti ha ricevuto un Premio alla Carriera “Per il cinema e per il suo ostinato desiderio di libertà di pensiero”.
Uno dei film proiettati al Festival del Cinema di Porretta è stato, appunto, “Il giardino delle delizie” in cui era protagonista l’attrice Ida Galli, in arte Evelyn Stewart, omaggiata nel Festival della Comunità dell’Appennino bolognese. Che ha consentito la riscoperta di un’attrice , vista a suo tempo come protagonista di molti western-spaghetti, ma non solo come è testimoniato dall’altro film proiettato, “Una farfalla con le ali insanguinate”, un giallo di Duccio Tessari del 1971. L’omaggio a questa attrice ha consentito di ricostruirne il suo percorso cinematografico che annovera una ventina di film, tra cui “La dolce vita” di Federico Fellini e“Il Gattopardo” di Luchino Visconti che la voleva anche in “Morte a Venezia” ma non fu possibile perché era impegnata in Inghilterra sul set di “Concerto per pistola solista” di Michele Lupo con la sceneggiatura di Fabio Pittorru, da lei particolarmente apprezzata.
Omaggio anche a Roberto Rossellini, padre del neorealismo, una figura di regista e di intellettuale che non può non essere presente nella memoria di cinefili ed appassionati di cinema che dovrebbero operare continuamente per farlo conoscere alle nuove generazioni. Bene ha fatto , quindi il Festival del Cinema di Porretta Terme ad inserire nel programma della sua sedicesima edizione, nel quarantennale della sua scomparsa, il film “ Era notte a Roma”, realizzato nel 1960, effettuando nel contempo un omaggio alla Mostra del Cinema Libero di Porretta Terme che proprio nella sua prima edizione, svoltasi nel 1960, lo presentò in anteprima italiana.
La versione presentata nell’ambito della XVI edizione del Festival è quella originale, restaurata dalla Cineteca Nazionale, ed è stata introdotta da Andrea Morini. “Il film in Italia, come ricordano Alessandro Borri e Fabio Marchioni nel Catalogo del Festival, non ebbe un’accoglienza calorosa e fu spesso relegato ai margini da una critica troppo severa, perché gli addetti ai lavori non seppero cogliere la profondità dello sguardo dell’autore, capace di raccontare, in modo assolutamente originale e libero dai filtri della militanza ideologica, la tragedia di una nazione e di un popolo a partire da un dramma privato”. Il riferimento è alla critica comunista che lo accusava di una visione eccessivamente clerico- centrica, per essersi arreso alle istanze dei gesuiti che tramite Padre Angelo Arpa lo avevano finanziato. Fu difeso, invece, da Morando Morandini che scrisse che Rossellini con questo film aveva saputo mostrare la partecipazione veramente popolare alla Resistenza. Al Festival , anche l’anteprima italiana, nell’ambito di “Uno sguardo al nuovo cinema europeo”, del film “Wilde Maus” di Josef Hader. Racconta la storia di Georg, un critico musicale che viene improvvisamente licenziato. Da qui il desiderio di vendetta innesca una escalation di azioni che sfuggiranno di mano in una catena di situazioni comiche. Una commedia divertente interpretata dallo stesso regista.
La XIV edizione del Festival del Cinema Libero di Porretta Terme si è conclusa con la proiezione di “Asteroidi” di Germano Maccioni, ambientato in una provincia emiliana a tinte fosche. Racconta la storia di giovani in conflitto con la famiglia, con la scuola e con la società. E’ l’opera prima di Germano Maccioni, attore con una lunga esperienza teatrale. Un buon esordio con interpreti Alessandro Tarabelloni, Chiara Caselli e Pippo Delbono.
UN FESTIVAL BEN RADICATO NEL TERRITORIO DI TREVISO
IL “SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL”
di Paolo Micalizzi
Un Festival “Sole Luna Doc Film Festival” , fondato e presieduto da Lucia Gotti Venturato, il cui obiettivo è di volere essere un ponte tra le culture. Un Festival che ha preso origine nel 2006 a Palermo, dove in luglio si è svolta la dodicesima edizione, e che da quattro anni fa tappa anche a Treviso, con la direzione scientifica di Gabriella D’Agostino e la direzione artistica dei registi Chiara Andrich e Andrea Mura, ben radicandosi con il territorio, come è testimoniato dalla grande affluenza di pubblico alle proiezioni. Il “Sole Luna Doc Film Festival” costituisce anche un laboratorio permanente di formazione ed educazione che offre ai giovani l’occasione di conoscere da vicino la professionalità in ambito culturale, coinvolgendoli nell’organizzazione e promozione dell’evento. In tale senso è stato attivato, sviluppando il loro volontariato, un progetto di alternanza scuola-lavoro con studenti degli istituti superiori di Treviso che ha portato anche alla realizzazione di un Diario giornaliero del Festival che ne ha ripercorso le tappe più significative della sua quotidianità. Ed altri studenti sono stati chiamati a dare la loro valutazioni in alcune giurie.
Iniziato con la proiezione del documentario “La Chana” di Lucija Stojevic in cui è tracciato un ritratto dell’artista di flamenco Antonia Santiago, il Festival si è chiuso con una chicca cinefila: la proiezione di “Nanook from the North”( Nanuk l’eschimese) realizzato nel 1922 da Robert J. Flaherty, film muto musicato per l’occasione al pianoforte dal Maestro Roberto Ceselli. Il film costituisce il ritratto di una famiglia esquimese di stampo patriarcale colta nella sua vita quotidiana, sempre alla caccia di foche ed altri animali da uccidere per la propria sopravvivenza e con le intemperie del tempo che la costringe a rifugiarsi in igloo dove una tempesta di neve la ridurrà a statue di ghiaccio in mezzo alla bufera.
Un film in cui il senso di drammaticità che proviene dallo scontro tra uomo e natura ha toni di grande poesia. Ed in cui vengono esaltati il coraggio quotidiano, la capacità di adattamento, la nobiltà d’animo di quella gente.
Miglior documentario della Sezione “Human Rights” è stato giudicato “Dove vanno le nuvole” di Massimo Ferrari. Lo ha scelto la Giuria Città di Treviso con la seguente motivazione: “Le paure, gli stereotipi, le strumentalizzazioni sulle migrazioni cancellati in 72 minuti di racconti e testimonianze che partono da Treviso e percorrono l’Italia da nord a sud. Il film veicola un forte messaggio educativo e di controinformazione rivolto ad una società impaurita, che sta vivendo una allarmante deriva razzista e xenofoba”. Il film, infatti, è incentrato su un viaggio attraverso l’Italia e l’Emergenza Migranti evidenziando intensamente un’umanità in movimento.
Assegnata poi una Menzione ad un documentario che, attraverso interviste odierne e materiali d’archivio, sottolinea la presenza di attori neri nel cinema italiano . “Un messaggio originale, una ricerca accurata presentata con una sapiente regia, per la Giuria, che contiene anche una denuncia ferma, ma senza rancore, della fatica per uscire dagli stereotipi”. A “Il segreto delle calze” di Nicola Contini il premio per il miglior documentario della Sezione “The journey”( Il viaggio) perché, secondo la giuria, è “Una vicenda umana complessa raccontata con levità e ironia. Il documentario ha al centro del racconto due piccoli imprenditori toscani che dopo il fallimento della loro impresa di produzione di calze femminili, emigrano da Empoli a Yiwu nella Repubblica popolare cinese diventando protagonisti dell’economia più fiorente del mondo. La loro sfida è ora di trovare il coraggio di tornare a casa: ha ricevuto anche il Premio del pubblico.
Una menzione è stata assegnata al documentario “Ama-San” di Claudia Varejao con protagoniste le donne del mare di una piccola città giapponese che raggiungono le rive dell’Oceano immergendosi nel segreto delle sue acque alla ricerca di alghe, crostacei e molluschi.
Apprezzato dalla Giuria per la fotografia, un ritmo e uno sguardo straordinario ma anche perché è “ Un ritratto poetico di una tradizione millenaria che ha ispirato in passato artisti e scrittori e che ancora oggi esiste grazie alle Ama San, le donne del mare, protagoniste di questo affascinante racconto”. L’altra Sezione, “Premio Soundrivemotion”, la cui Giuria era composta anche da un gruppo di studenti del dipartimento di musica del Collegio Vescovile Pio X di Treviso, ha riconosciuto come miglior colonna sonora quella di Jan Majo per il documentario “the black sheep” di Antonio Martino perché” la musica riesce ad arricchire ed amplificare le emozioni trasmesse dalle immagini. In armonia con il tema trattato”. Studenti anche nella Giuria della Scuola: hanno premiato “See you in Chechnya” di Alexander Kvatashidze della Sezione “The Journey” per “l’approccio fortemente personale con cui l’autore indaga, a partire dalla propria esperienza, sulla figura del reporter di guerra e sulle sue motivazioni più profonde, più potenti dello stesso attaccamento alla vita”. Per il Premio del Video contest / creare legami” , rivolto agli allievi delle scuole di secondo grado di Treviso e finalizzato a elaborare un video di riflessione sul tema del dialogo tra culture, la Giuria di studenti insieme a docenti e rappresentanti del Festival unitamente al Lions Club “Eleonora Duse” la scelta è caduta sul corto “Legami” di Patrycja Maria Bariasz per l’originale ideazione dei contenuti, la qualità tecnica e la visione poetica con cui viene trasmesso il concetto di legame con la speranza che possa fungere da incoraggiamento per una carriera artistica futura. Menzione speciale per “Il legame della forza” di Samuel Corenti. Coinvolti nel Festival anche otto richiedenti asilo per valutare il miglior cortometraggio della Sezione “Shorts”. A loro giudizio il vincitore è stato “L de Libertad” di Javier Hernandez e Marc Guanyabens incentrato su un ragazzo della comunità di Aragon che nato senza braccia vuole comunque ottenere la patente di guida con le dita dei piedi, attraverso sacrificio e perseveranza. Nella motivazione viene anche sottolineato che “Nonostante la disabilità, il protagonista del film va oltre i limiti per cercare di essere indipendente” e viene anche evidenziato che “ vuole essere di esempio per altri che si trovano in difficoltà, dando una speranza per il futuro, anche con il prezioso supporto concreto e mai pietistico della comunità”. Un premio anche dalla Presidente Lucia Gotti Venturato “in memoria dell’indimenticato fondatore del ”Sole Luna Doc Film Festival” Rubino Rubini. Lo ha attribuito a “Vuelo Nocturno” di Nicholas Herzog, opera dedicata alle muse di Antoine de Saint-Exupéry, il creatore de “Il piccolo principe”.
Per Lucia Gotti Venturato, di cui bisogna apprezzare la squisita ospitalità nell’organizzazione del Festival e la capacità di coinvolgere nel volontariato tantissime persone , “ un documento prezioso e raffinato, un racconto colto e di stile che avrebbe saputo toccare l’animo del nostro caro amico Rubino”.
 TRIESTE FILM FESTIVAL 2018:
TRIESTE FILM FESTIVAL 2018:
PREMI, NUOVI TALENTI DELL’EUROPA CENTRO ORIENTALE,
CINEMA DEL ‘68
di Paolo Micalizzi
Il Trieste Film Festival, nato nel 1989 come Alpe Adria con la direzione artistica di Anna Maria Percavassi, a cui è intitolata la Casa del Cinema, diretto oggi da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo, è il primo e più importante appuntamento italiano dedicato al cinema dell’Europa centro-orientale e continua ad essere da quasi trent’anni un osservatorio privilegiato su cinematografie e autori spesso poco noti – se non addirittura sconosciuti- al pubblico italiano, e più in generale a quello “occidentale”. Nove i film, tutti in anteprima italiana, al Concorso Internazionale lungometraggi, dove è emerso il russo Boris Chlebnikov che con “Aritmija” si è aggiudicato il Premio Trieste (5.000 euro). Il film è incentrato sulla crisi personale e sul lavoro di un giovane e bravo paramedico e della moglie infermiera presi dal lavoro che devono trovare la forza di rimanere insieme. In questa Sezione tanti altri i temi ed i film interessanti.
Due storie sono collocate all’interno dei conflitti politici di due paesi: nel polacco “Zgoda”(Riconciliazione) di Maciej Sobiieszczanski e nello sloveno “Rudar”( Il minatore) di Hanna Slak. Nel primo, ambientato in un campo di concentramento nell’Alta Slesia(Polonia) del 1945 dove, nelle zone liberate dai Nazisti, il servizio sicurezza del Partito Comunista elimina i nemici con il pretesto di punire i traditori della Nazione, assistiamo ad un dramma intimo che contrappone due amici, entrambi innamorati di una prigioniera polacca. Nel secondo, un minatore sloveno di origini bosniache scopre nel 2007, all’interno di una miniera, una fossa comune in cui erano stati sepolti almeno 4.000 corpi di profughi della Seconda Guerra Mondiale. Vicende autobiografiche di un omosessuale in “Soldati. Una storia da Ferentari” di Ivana Mladenovic ispirato alla vita dell’antropologo Adrian Schiop. La vita di un uomo anche nel rumeno “Breaking news”(Edizione straordinaria) di Julia Rugina che racconta la vita del suo cameraman, Alex Mazilu, morto tragicamente, attraverso gli occhi inquieti della figlia. Dall’Albania proviene “Le prime ore del giorno” di Gentkian Koci, ritratto di una donna sfrattata che è costretta a trasferirsi con il figlio neonato nell’appartamento di un’anziana signora ormai immobile a letto . Dovrà mantenere a tutti i costi in vita la vecchia signora per difendere il lavoro e la nuova casa. Nel Concorso internazionale lungometraggi anche tre “road movie”: dal croato “Una breve gita” dell’esordiente Igor Bezinovic che racconta come il tentativo di un gruppo di ragazzi di raggiungere un monastero nella campagna istriana si trasforma in un viaggio allegorico verso l’ignoto ad “Out” dello slovacco Gyorgy Kristof con il protagonista che attraversa l’Europa dell’Est nella speranza di trovare lavoro e realizzare il sogno di tutta la sua vita, ma anche “Frost” di Sharuna Bartas in cui due giovani impegnati a guidare un furgone di aiuti umanitari da Vilnius all’Ucraina saranno coinvolti nella tragedia della guerra.
Nel Concorso Documentari il Premio Alpe Adria Cinema(2.500 euro) è stato attribuito a “Wonderful Losers: A Different World” di Arunas Matelis , un’opera imperniata sui ciclisti che corrono in fondo alla gara, i cosiddetti gregari colti dal regista in sette anni di “Giro d’Italia”, evidenziando cosi le vicende dei “Sancho Panza” del ciclismo professionale che sacrificano le loro carriere per aiutare i compagni di squadra.
Nove erano i titoli in Concorso e ben quattro affrontavano il mondo dello sport: tra essi, “Over the limit” della polacca Marta Prus, un interessante ritratto della ginnasta russa Margarita Mamun in cui è evidenziata la fatica fisica e mentale richiesta da una disciplina rinomata per la sua bellezza estetica. Nel cortometraggio, che annoverava 15 opere in Concorso, ha vinto (2.000 euro) il polacco Piotr Domalewski con “60 chili di nulla” imperniato sulla storia di un dirigente di una cava, al suo primo giorno in tale ruolo, che dovrà accorgersi come i rigidi principi disciplinari mal si conciliano con i problemi della sicurezza.
Altri i riconoscimenti attribuiti, tra i quali ci piace segnalare il Premio Corso Salani 2017(2.000 euro), intitolato ad un valido regista indipendente prematuramente scomparso, che è stato assegnato a “L’uomo con la lanterna” di Francesca Lixi, che racconta un capitolo poco conosciuto della storia del XX secolo, quella di un bancario sardo nella Cina degli anni ’20 all’epoca delle Concessioni internazionali e dei Trattati ineguali. Ma anche il Premio Cinema Warrior a Livio Jacob e Piera Patat, tra i fondatori e tuttora colonna portante della Cineteca del Fiurli che organizza a Pordenone le prestigiose Giornate del Cinema Muto.
Importante anche il Premio InCE( Iniziativa Centro Europea) 2017( 3.000 euro) alla produttrice rumena Ada Solomon che sostiene da anni giovani autor e dimostra particolare attenzione per il cinema del reale e la memoria storica. Premiato anche con l’”Eastern Star” l’attore croato Rade Serbedzija che rivelatosi con “Prima della pioggia” del macedone Milco Mancevski, Leone d’oro alla Mostra di Venezia 1994, ha avuto un prestigioso percorso interpretando una quarantina di film anche con autori come Francesco Rosi, Giuseppe Bertolucci, Stanley Kubrick, Clint Eastwood, John Woo, Phillip Noyce, Christopher Nolan e Antoine Fuqua.
E’ stato “L’altrove più vicino” di Elisabetta Sgarbi a chiudere la 29.a edizione del “Trieste Film Festival”. La scrittrice e regista ferrarese, in questo suo ultimo lavoro, accompagna lo spettatore in un viaggio in Slovenia, alla conoscenza di una terra, un popolo, una cultura che è appena oltre una soglia mobile, fatta per essere attraversata e cancellata milioni di volte dalle trasmigrazioni di persone, lingue, abitudini. E lo fa attraverso le parole e gli occhi del giornalista Paolo Rumiz, un’intervista ,la prima dopo moltissimi anni, al grande poeta Alojz Rebula ormai cieco ma che continua a scrivere; nei ricordi dello scrittore Claudio Magris e nei versi della scrittrice Marisa Madieri, che fu sua moglie, esula istriana. Ma anche nella musica della giovanissima e vivace orchestra diretta dal Maestro Igor Coretti-Kuret e nei brani dello scrittore Boris Pahor, interpretati da Toni Servillo.
La ventinovesima edizione del Trieste Film Festival” ha dedicato la sua Retrospettiva al cinema del ’68. All’insegna del titolo “ Rebels’68.East ‘n’ West Revolution”, curata da Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri, sono stati riproposti alcuni film per indagare quell’anno cruciale del secondo Novecento da un doppio punto di vista: quello dell’ovest con autori come Godard, Antonioni, Roeg e Bertolucci, e quello dell’est, con nomi come Pintilie, Dezsò,Nemec, Zilnik. Senza dimenticare titoli e personalità che – da Bellocchio a Makavejev a Garrell –hanno anticipato il 68, o che del 68 si sono nutriti, prolungandone lo spirito nelle stagioni a venire. Quindi si sono visti( o rivisti) sullo schermo per il punto di vista East film , tanto per citarne alcuni, come “Oratorio for Prague”(1968) di Jan Nemec, “Reconstruction”(1968) di Lucian Pintilie , “Sweet Movie”(1974) di Dusan Makavejev. Il film di Nemec è un documento eccezionale dell’invasione sovietica sovietica a Praga , una efficace testimonianza della repressione che deluse le speranze dei cecoslovacchi per il “socialismo dal volto umano” di Dubcèk. Quello di Pintilie racconta come un’indagine su un fatto di cronaca si trasforma in un tragico episodio di abusi ed umiliazioni. “Sweet movie”, è un film sulla liberazione sessuale e sulla politica, tipiche della sinistra post-sessantottina il cui potere sovversivo è ancor oggi attuale: a suo tempo, fu censurato e tagliato per la presenza di oscenità, pornografia e violenza. Il sessantotto visto dall’ovest ha invece un carattere di ribellione. Al Trieste Film Festival era rappresentato da “Sympathy for the Devil”(1968), dal titolo di una celebre canzone dei Rolling Stone, che è un’opera che tende a rivoluzionare il linguaggio cinematografico, cosi come fa Michelangelo Antonioni nel suo “Blow-Up”(1966) ambientato nella Swinging London rinnovando anche i contenuti del trhiller.
E’ un pre-sessantotto, cosi come “I pugni in tasca”(1965) di Marco Bellocchio che rappresenta l’inizio di una follia liberatoria contro ogni repressione istituzionale. Sui picchi dell’erotismo cinematografico si colloca “Performance”( Sadismo) di Donald Cammell e Nicolas Roeg con interpreti Mick Jagger e Anita Pallemberg.
Il Festival ha proseguito anche quest’anno la collaborazione con il SNCCI –Sindacato Nazionale Critici Cinematografici- che ha premiato il film “A Ciambra” di Jonas Carpignano come miglior film italiano del 2017.
DIMMI DELL’INDIA …
di Maria Pia Cinelli
Non è certo facile addentrarsi nella cinematografia contemporanea di un’unione di 29 stati e 7 territori con più di 1,3 miliardi di abitanti diversi fra loro per razza, lingua, religione, quadro di per sé già ampio che non può tuttavia non allargarsi idealmente al Pakistan e al resto del sub-continente indiano[1], così come agli indiani della diaspora che mai recidono il cordone ombelicale con le proprie radici.
In un paese dal panorama produttivo articolato, con quasi un’industria filmica per stato, espressione ciascuna di un’appartenenza linguistica e una cultura regionale[2], non si può identificare il suo cinema odierno – come spesso avviene fra i non addetti – solo con Bollywood o meglio con il suo filone più commerciale basato su melodrammi, romcom e masala movies[3] interpuntati dalle tipiche scene di canto e ballo. Se anche in India l’investimento maggiore dei vari stabilimenti è diretto a prodotti assimilabili da una vasta platea – che in ogni caso risentono dei cambiamenti socio-culturali in corso – e pur restando il film d’autore propriamente detto molto ai margini, a fianco del mainstream più popolare si consolida un cinema medio di qualità, attento alle difficoltà del vivere quotidiano, agli aspetti politici e ai contrasti religiosi, andando incontro alle maggiori esigenze di una middle class in veloce crescita, più scolarizzata, aperta all’esterno e svezzata da internet.
Il programma del 17° River to River Florence Indian Film Festival (Firenze – 7/12 dicembre 2017) ha dato conto della scena attuale con diversi film che confermano questa tendenza, a iniziare da “Newton”, lungometraggio d’apertura dal pedigree festivaliero di tutto rispetto con in testa la Berlinale, nonché candidatura ufficiale indiana per la nomination in lingua straniera agli Oscar 2018.
In relazione al fisico inglese Newton non ha che i tre atti della sceneggiatura paragonabili ai tre principi della dinamica e una citazione, mentre l’eponimo protagonista dell’opera seconda di Amit Masurkar è un giovane impiegato statale inviato a condurre le elezioni generali nello stato di Chhattisgarh, in un villaggio in piena giungla sotto continua minaccia di attacchi da parte dei ribelli Naxal[4]. Onesto, ingenuo e poco duttile è intenzionato a raccogliere in maniera corretta il voto di 76 sprovveduti aventi diritto nonostante il pericolo dei Naxal e gli attriti con le forze di polizia che presidiano il seggio[5]. Una commedia nera che satireggia sull’effettiva messa in atto della democrazia evidenziandone i punti deboli e rimarcando la lontananza del potere dalle fasce ultime della società, con il piccolo burocrate Newton, non una figura eroica ma una persona normale in circostanze eccezionali, alle prese con la necessità di cambiare lo statuts quo e la difficoltà di farlo.
Più forte dal punto di vista politico il film di chiusura della manifestazione fiorentina, “Omertà” di Hansal Mehta, regista spesso coinvolto in soggetti legati all’attualità che inducano alla riflessione[6]. Del tutto estranea all’omonimo romanzo di Puzo, la sua ultima fatica – che con “Newton” condivide l’interprete principale Rajkummar Rao, uno dei talenti più versatili della sua generazione, qui alla sua quarta volta con Mehta – è un biopic su Ahmed Omar Saeed Sheikh, terrorista anglo-pakistano assurto agli onori dei media nel 1994 per il sequestro di turisti occidentali in India e nel 2002 per il rapimento e l’uccisione del giornalista del Wall Street Journal Daniel Pearl, reato per il quale è in carcere dal 2007. Percorrendo il cammino verso l’estremismo di Sheikh sulla falsariga del thriller, senza trascurare le implicazioni dei vari poteri l’autore mira in primo luogo a comprendere le ragioni profonde e personali che portano giovani di formazione occidentale ad abbracciare il radicalismo, certo che l’unica via possibile per contrastare il fenomeno sia rompere il muro di omertà che lo avvolge e non rispondere agli attentati con i bombardamenti.
Siamo invece prossimi a un cinema più consueto ma audace nei contenuti con “Shab” (The Night) – in concorso – dove il regista Onir fa muovere in un intreccio complesso un giovane provinciale arrivato a New Delhi per affermarsi come modello, una donna dell’alta società che ne fa il suo amante, una ragazza con un passato imbarazzante e un ragazzo omosex reduce da una delusione amorosa.
Girato lungo un anno per catturare la luce di tutte le stagioni – ciascuna delle quali corrisponde a ognuno dei protagonisti – Shab mette a fuoco le difficoltà di relazione in un contesto metropolitano, attraverso le aspirazioni, le delusioni e il lato oscuro di esseri umani in situazioni non convenzionali, sul confine o oltre la cosiddetta ‘morale comune’. Fra i pochi cineasti di Bollywood a dichiararsi apertamente gay, Onir è avvezzo a trattare temi scomodi per il mainstream indiano fin dal suo esordio “My brother… Nikhil” (2005), incentrato su omosessualità e Aids.
Cospicua nel festival toscano anche la presenza di sguardi per così dire all’indietro, di autori non residenti nel sub-continente indiano, ma con il quale mantengono un forte legame, come l’anglo-pakistano Sarmad Masud, nato e cresciuto in Inghilterra, che per il debutto nel lungo ha scelto di portare sullo schermo un fatto di cronaca avvenuto nella terra dei suoi avi, da girare in urdu e in loco.
“My pure land” [7] – una produzione britannica candidata dal Regno Unito per la nomination in lingua straniera ai recenti Oscar e vincitrice del 17° River to River – è ispirato alla storia vera della coraggiosa Nazo Dhajero, eroina suo malgrado in una vicenda di soprusi. L’esordio di Masud descrive infatti la resistenza di una giovane ragazza costretta, con madre e sorella, a fronteggiare a colpi d’arma da fuoco ben 200 mercenari assoldati da uno zio che senza alcun diritto rivendica pretese sulla loro proprietà, approfittando dell’incarcerazione del capofamiglia. Generalmente definito un western al femminile, se non addirittura femminista, il film porta alla ribalta casi di prevaricazione piuttosto frequenti in Pakistan – durante le riprese un episodio analogo si svolgeva a breve distanza dal set – in particolare a scapito di donne rimaste sole o vedove, che in un sistema di stampo patriarcale non possono contare in pratica neppure sul sostegno della legge.
Ancora un ambiente pakistano fa da sfondo ad “Abu” – premiato a Firenze come miglior documentario – opera prima di Arshad Khan, che assembla i molti filmati familiari[8] a spezzoni di pellicole bollywoodiane e inserti animati per costruire un racconto di formazione autobiografico toccante. Originario di Islamabad e canadese di adozione, il regista rivisita negli anni il rapporto con il padre (tale è il significato del titolo in urdu), segnato dalla sua omosessualità e dal bisogno di accettazione, ancora più difficile in una famiglia musulmana strettamente osservante.
Prodotto in Canada e realizzato dopo la scomparsa del genitore, il film è così personale da ingenerare nello spettatore un senso di colpevole intrusione negli home video che scandiscono l’evolversi della relazione padre/figlio fino al letto di morte, ma l’accento sincero fa escludere l’escamotage e pensare piuttosto all’elaborazione di un lutto e all’urgenza di guardarsi dentro.
Benché di centrale importanza, le problematiche legate all’essere gay non sono tuttavia il solo fattore di disagio: il trauma del distacco dalla madrepatria – momento topico per Khan quanto il coming out – il senso di emarginazione per lo stato di emigrato e per l’appartenenza religiosa dopo l’11 settembre hanno ugualmente peso nella formazione di un’identità.
Impegnato quanto a soggetto ma leggero e divertente nei toni è “Ask the sexpert” – un altro documentario in competizione, co-prodotto da India e Usa – che ricalca il titolo di una famosa rubrica della carta stampata. La regista Vaishali Sinha, nativa di Mumbai e residente a New York, dopo l’esordio Made in India sugli uteri in affitto torna di nuovo alle origini e segue per quattro anni il titolare della rubrica, il ginecologo Dr. Mahinder Watsa, che dal 2005 elargisce dalle pagine del quotidiano Mumbai Mirror consigli e chiarimenti in materia sessuale, in replica ai quesiti di migliaia di lettori.
Nonostante il parlare di sesso sia ancora un tabù in India, l’ultranovantenne Watsa ha acquisito un’ampia notorietà, grazie anche alle sue risposte dirette e ironiche, svincolate da ogni moralismo. Ancora attivo a dispetto dell’età e delle minacce di denuncia per oscenità, da oltre 40 anni lavora per diffondere già dalla scuola una corretta informazione sessuale che aiuti a vivere bene l’eros e superare i pregiudizi. Nel tratteggiare una figura ormai di culto, il film fornisce uno scenario esaustivo della sfera intima dell’indiano medio, diviso fra desideri di esplorazione e paure di anormalità, evidenziando una certa ignoranza di fondo anche su questioni basilari.
NOTE
[1] Oltre al Pakistan, è formato da Bangladesh (resosi indipendente dal Pakistan nel 1971), Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Maldive.
[2] Le industrie cinematografiche indiane sono classificate in base alla lingua di distribuzione dei film; oltre all’ Hindi cinema (Bollywood) nello stato del Maharashtra – sede anche del Marathi cinema – citiamo, limitandoci agli studios principali: Tamil cinema (Kollywood) nel Tamil Nadu; Kannada cinema (Sandalwood) nel Karnakata; Malayalam cinema (Mollywood) nel Kerala; Bengali cinema (Tollywood) nel Bengala Occidentale.
[3] Film caratterizzati da una mescolanza di generi.
[4] Con Naxal si intendono i comunisti radicali di ispirazione maoista, movimento sorto inizialmente nella città di Naxalbari nel Bengala Occidentale – da cui deriva il nome – quindi sparsosi nelle aree rurali dell’India sud-orientale, fra cui Chhattisgarh.
[5] “Newton” presenta molte affinità con “Il voto è segreto” di Babak Payami, film iraniano del 2001, cosa che ha dato adito a molte polemiche, in particolare dopo la candidatura per la nomination all’Oscar.
[6] Fra i suoi film anche “Shahid” (2013), storia di Shahid Azmi, avvocato difensore dei diritti umani morto assassinato.
[7]Il titolo “My pure land” si ispira alla parola Pakistan, il cui significato letterale in urdu corrisponde a “Land of the pure”.
[8] Appassionato di fotografia prima e di videocamere in seguito, il padre di Khan amava riprendere ogni momento della vita familiare, ragion per cui il figlio dispone di un vasto archivio.
 IL FERRARA FILM FESTIVAL 2018
IL FERRARA FILM FESTIVAL 2018
di Maurizio Villani
Si è tenuto a Ferrara dal 16 al 25 marzo 2018 il Ferrara Film Festival, diretto da Maximilian Law. Arrivato alla terza edizione, il Festival è cresciuto sia per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei film presentati, sia per l’efficienza dell’organizzazione, che ha aperto sempre di più il Festival alla vita della città.
Americano di adozione, ma ferrarese di origine, Law, ha inteso, fin dall’inizio di questa avventura, perseguire l’obiettivo di portare nella città estense un “pezzo” di Hollywood. «Da Los Angeles, patria del Cinema mondiale, dove vivo e lavoro – ha detto il direttore –, ho avuto la possibilità, grazie alle Istituzioni della Città di Ferrara, di dare a filmmaker da tutto il mondo l’opportunità di mostrare i loro film in questa meravigliosa città. La mia idea di Festival del cinema va oltre le semplici proiezioni, la mia visione è di creare un sistema creativo e industriale interconnesso e totalmente finanziato dal settore privato. Attraverso il “Sistema Hollywoodiano” metteremo il pubblico al centro di questa “avventura” attraverso una serie di eventi speciali ed eventi a tema cinematografico».
Il programma del Festival prevedeva la proiezione di 25 film in concorso, sia lungometraggi, sia cortometraggi (suddivisi in una sezione di film prodotti negli Stati Uniti d’America e in un’altra di film prodotti in tutto il resto del mondo). A questi si sono aggiunti 2 film “fuori concorso”, proiettati nella serata inaugurale del Festival: il lungometraggio statunitense “9/11”, del regista Martin Guigui (drammatica storia di cinque persone intrappolate l’11 settembre in un ascensore di una delle Torri gemelle), e il corto “Sing”, dell’ungherese Kristof Deàk.
Le proiezioni dei film sono state accompagnate da una serie di eventi collaterali, ben coordinati dal vicedirettore del Festival Giorgio Ferroni. Via Carlo Mayr si è trasformata in “Via del Cinema” e alla libreria IBS+Libraccio si sono tenuti incontri con autori e presentazione di libri collegati al cinema.
Al termine delle proiezioni, che hanno visto una crescente partecipazione di pubblico, la Giuria, composta da Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV di Roma; Max Calò, compositore trapiantato da oltre vent’anni negli Stati Uniti; Roy Geraci, produttore cinematografico; Jessica LaMalfa; Anna Maria Quarzi, Presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e Giorgio Serafini, regista, ha assegnato undici Dragoni d’oro ai vincitori delle varie categorie.
- Dragone d’oro al miglior lungometraggio USA a “In dubious battle”, regia di James Franco; interpreti: James Franco, Robert Duvall, Ed Harris, Brian Cranston. Il film racconta la storia di un attivista di un Movimento politico che lotta in forma drammatica e violenta per il riscatto dei lavoratori nella California degli Anni ’30 del Novecento.
- Dragone d’oro per il miglior lungometraggio WORLD a “Contro l’ordine divino”, regia di Petra Volpe; interpreti: Rachel Braunsch Weig, Marta Zoffoli. Film ha per protagonista Nora, che guida la battaglia socio-politica per il riconoscimento del diritto di voto alle donne nella Svizzera degli anni ’70.
- Dragone d’oro per il miglior documentario a “Above the drowning sea”, regia di Nicola Zavaglia e Rene Balcer. È l’epica storia di come all’alba della Seconda Guerra mondiale decine di migliaia di ebrei riuscirono a scappare da Vienna verso Shanghai.
- Dragone d’oro per il migliorcortometraggio USA a “Hyena”, regia di Luca Elmi; interpreti: Abi Van Andel, Joshua Loren, Timoty Bates. Un uomo nel braccio della morte incontra la madre del babbino che aveva uccisi diesi anni prima: la conversazione ha esiti inaspettati.
- Dragone d’oro per il migliorcortometraggio WORLD a “Stella 1”, regia di Gaia Bonsignore e Roberto D’Ippolito; interpreti: Cecilia Dazzi, Andre Chimenti. Questo corto italiano racconta la storia di Stella, una bambina astronauta impegnata in una difficile e rischiosa impresa spaziale, e della mamma che trepida per lei.
- Dragone d’oro per EFFETTO HOLLYWOOD (film con il contributo primario di effetti visivi, effetti speciali e/o effetti pratici) a “The recall”, film di fantascienza prodotto negli USA per la regia di Mauro Borrelli e interpretato da Wesley Snipes e R.J. Mitte. Cinque amici in vacanza subiscono un’invasione di alieni; un veterano di guerra interviene a soccorrerli per dare loro una speranza di sopravvivenza.
- Dragone d’oro per EMILIA ROMAGNA FILMMAKERS (film prodotti o filmati nella Regione Emilia Romagna) a “Axioma”, regia di Elisa Possenti; interpreti: Daniele Rienzo, Marco Cacciapuoti, Mili Cultrera Di Montesano. Il film affronta il delicato tema della disabilità motoria e del difficile periodo post-traumatico raccontando la storia di un ragazzo, paralizzato in seguito ad un incidente, che riscopre se stesso grazie all’intervento di amici.
- Dragone d’oro per la categoria YOUNG UNICEF (film con temi sensibili sui minori) a “Sing”, regia di Kristóf Deák; interpreti: Zsófia Szamosi, Dorka Hais, Dorka Gáspárfalvi. Cortometraggio ungherese che mostra un dramma infantile ambientato nella Budapest degli anni ’90, ispirato ad una storia vera. Una bambina con una grande passione per la musica ha problemi con la direttrice della sua nuova scuola che le proibisce di cantare a voce alta nel coro.
- Dragone d’oro al miglior regista di lungometraggi a Mauro Borrelli (“The recall”)
- Dragone d’oro al miglior Attore Protagonista nelle categorie FEATURE USA e FEATURE WORLD a Vincent Lacoste (“Victoria”)
- Dragone d’oro alla Miglior Attrice Protagonista nelle categorie FEATURE USA e FEATURE WORLD, sponsorizzato dall’ARCHIVIO VITTORIO CINI in ricordo di Lyda Borelli, a Rachel Braunsch Weig (“Contro l’ordine divino”).
CINEMA! STORIE, PROTAGONISTI, PAESAGGI
A proposito della Mostra sul cinema del Polesine
di Maurizio Villani
Il delta è un altro mondo.
Io al cinema non ho mai visto il delta.
Il cinema cerca di trasformarlo in un racconto.
No, il delta inventa lui.
Tu sei là, e lo guardi incantato.
Gian Antonio Cibotto
Christian Norberg-Schulz (1926 – 2000) – grande architetto e teorico della lettura dei luoghi, intesi come spazi articolatati in termini formali e strutturali – ha scritto che «la formazione di un senso del luogo (…) rimane puramente illusoria fintanto che coloro che desiderano partecipare non sviluppino intendimento ed empatia per quello a cui dovrebbero prendere parte». Ora la mostra di cui stiamo per parlare si propone di prender parte con “intendimento ed empatia” al racconto di un “luogo” – il Polesine – di cui il linguaggio cinematografico ha saputo cogliere nell’arco di molti decenni la ricchezza delle valenze estetiche e antropologiche.
L’ampia rassegna, curata da Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è aperta a Rovigo, a Palazzo Roverella, dal 24 marzo al 1 luglio. «L’esposizione – spiega il curatore – si propone di ricostruire la storia del rapporto intenso, profondo e originale che si è instaurato in oltre ottant’anni di intensa frequentazione fra un territorio dalle caratteristiche pressoché uniche e i cineasti italiani, dando vita a opere indimenticabili destinate a rimanere nella storia del cinema».
Secondo i dati d’archivio almeno 500 tra film, documentari, fiction televisive, sono stati girati nell’area attraversata dal Po nel suo corso terminale, là dove, tra acqua e terra, il Grande Fiume si confonde con l’Adriatico.
Molti tra i maggiori registi del cinema italiano hanno lavorato nel Polesine: tra questi Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Giuseppe De Santis, Alberto Lattuada, Mario Soldati, Florestano Vancini, Pupi Avati, Ermanno Olmi e Carlo Mazzacurati. La Mostra dedica sale monografiche alle opere più significative di questi autori.
Si inizia con l’esordio cinematografico di Antonioni: esso avviene con il documentario “Gente del Po”, progettato già nel 1939, girato nel ’43 e proiettato nel 1947, privo di quattro quinti del materiale perduto durante la guerra.
Antonioni tornerà più volte a girare nell’area del Delta: vi ambienterà “Il grido” del ’57; sarà poi a Ravenna per “Il deserto rosso” (1964) e a Ferrara per l’ultimo episodio di “Al di là delle nuvole” (1995) codiretto con Wim Wenders.
Nel 1943 Luchino Visconti gira “Ossessione” nel Delta del Po. Il catalogo della Mostra, nella presentazione di questo film, parla di “alba del neorealismo” e aggiunge: «Scegliendo di ambientarvi “Ossessione”, girato fra l’estate e l’autunno del 1942, il regista non cerca soltanto un luogo geograficamente distante dal rigido controllo esercitato a Cinecittà dalla censura fascista, ma anche l’equivalente nostrano di quella profonda provincia americana che fa da sfondo al romanzo noir cui si ispira (Il postino suona sempre due volte, di James M. Cain). Il suo film d’esordio riesce nel duplice intento di offrire una rappresentazione autentica e credibile della realtà profonda di un territorio, prefigurando nel contempo la nuova estetica neorealista, che segnerà le principali esperienze artistiche del dopoguerra».
Il tema della guerra e della Resistenza è largamente documentato. In Polesine Roberto Rossellini ambienta l’episodio conclusivo di “Paisà” (1946). Girato fra Porto Tolle e Scardovari, il film «sa portare a un grado altissimo d’incandescenza espressiva e di autenticità tragica la materia della cronaca recente, in una straordinaria, naturale continuità fra il film e la realtà vera che lo circonda» (Gianni Volpi).
L’anno successivo (1947) Giuseppe De Santis gira “Caccia tragica” (1947), ambientando nel Delta padano una storia dell’Italia del secondo dopoguerra, in cui l’aspirazione alla redenzione sociale si scontra con la violenza e il banditismo.
Ritorna al tema della Guerra partigiana Giuliano Montaldo, che nel 1976 traspone per lo schermo il romanzo di Renata Vigano L’Agnese va a morire, offrendo una rappresentazione antiretorica e accurata della Resistenza nel Delta padano.
Dal romanzo di Riccardo Bacchelli Il mulino del Po, che racconta la storia delle quattro generazioni della famiglia Scacerni, mugnai del Po, dall’età napoleonica alla battaglia del Piave, sono tratte tre opere. Nel 1948 Alberto Lattuada mette in scena l’ultimo volume della saga. Anni dopo, nel 1963 e nel 1971, il regista televisivo Sandro Bolchi gira, a distanza di tempo, una versione del primo e del secondo volume della trilogia.
Su Florestano Vancini, che è autore, a partire dal 1951 di vari documentari ambientati sul Po (“Delta padano”, “Uomini della palude” e “Tre canne e un soldo”), scrive Barbera nel saggio introduttivo del Catalogo della Mostra: «In questo quadro di articolate rappresentazioni, fra le quali si contano nomi di autori apprezzati come Gillo Pontecorvo, Renzo Ragazzi, Folco Quilici, Giulio Questi, Renzo Renzi, Lino Micciché, Massimo Sani, Ermanno Olmi e Carlo Lizzani (per non citarne che alcuni), spicca la figura di Florestano Vancini, forse il più importante cantore del Delta negli anni del secondo dopoguerra. I numerosi cortometraggi realizzati prima di passare ai film di finzione (alcuni dei quali ambientati lungo il Po ferrarese, come “Le stagioni del nostro amore”, 1966), non sono soltanto “prove di regia”, ma s’impongono come le testimonianze più alte di indagini appassionate, capaci di coniugare impegno civile, qualità estetica e approfondita conoscenza del territorio, dei suoi abitanti e delle loro traversie.
Vancini è nel 1954 aiuto regista di Mario Soldati che, con “La donna del fiume”, lancia definitivamente Sophia Loren nell’olimpo internazionale delle star. La scheda di presentazione del film fa rilevare come «il dosaggio calcolato degli ingredienti – la prorompente sensualità della protagonista, la colorita descrizione dell’universo femminile occupato nella marinatura delle anguille, la deriva fotoromanzesca della vicenda che contrasta con la credibile ricostruzione del mondo della Bassa, diviso fra arretratezza sociale e sogni d’impossibile riscatto individuale – sembra voler traghettare il cinema italiano dal Neorealismo della rinascita postbellica verso nuove forme di spettacolo. Senza rinnegarne l’originaria vocazione all’autentica ricostruzione di ambienti e situazioni, queste ne ibridano il linguaggio con l’innesto di convenzioni provenienti da altri generi, come il melodramma e, soprattutto, la commedia».
Molto opportunamente la Mostra rende omaggio ad Antonio Cibotto, sensibile cantore del fascino del Polesine, autore del romanzo Scano Boa, nome di un paesino di pescatori sul delta del Po dove vivono un padre e una figlia accusati di portare disgrazia. Nel 1961 si ha la trasposizione del racconto nell’omonimo film ad opera del regista Renato Dall”Ara, cui fa seguito nel 1996 “Scano Boa-Dannazione” di Giancarlo Marinelli.
La scoperta delle “potenzialità fantastiche” del Polesine porta Pupi Avati una prima volta a girarvi “Casa dalle finestre che ridono” (1976) e a ritornarvi più volte successivamente.
In anni più vicini, di rilievo sono le opere di Carlo Mazzacurati, per il quale il Polesine si identifica come un “territorio dell’anima”, in cui ambienta quattro film (“Notte italiana” (1987), “Il toro” (1994), “L’estate di Davide” (1998) e “La giusta distanza” (2007).
Nel 1992 Ermanno Olmi realizza “Lungo il fiume” un documentario lungo l’intero corso del Po, dalle sorgenti alla foce.
In anni recenti “Il pesce rosso dov’è” di Elisabetta Sgarbi (2015) ci racconta la storia degli uomini che vivono nel Delta del Po, tra fiume e mare e che rimpiangono i pesci che non vedono più, perché, forse, sono scomparsi per sempre.
Il catalogo è una fonte preziosa per l’inquadramento storico e critico del tema della Mostra. Vi compaiono scritti di Alberto Barbera, Gian Piero Brunetta, Adriano De Grandis, Roy Menarini e Marco Bertozzi. Ma il contributo più ricco per lo studioso e l’appassionato è costituito dall’apparato di immagini, di locandine, di foto di scena e di tutto l’altro materiale documentario che consente di immergersi nel mondo del cinema polesano. A conclusione del suo scritto, Barbera osserva che «benché non molto conosciuta dal pubblico in generale, la storia dei rapporti fra il cinema e il Delta del Po è tutt’altro che poco indagata. Studiosi, critici e collezionisti appassionati si sono a lungo e vantaggiosamente prodigati per raccogliere una messe di informazioni storiche riguardanti i film, i documentari e le location di volta in volta utilizzate, che sono servite come riferimento essenziale anche per la mostra di cui questo catalogo è un complemento. Al loro lavoro, confluito in testi che costituiscono un repertorio critico e informativo imprescindibile, si rimanda chi voglia approfondire la conoscenza di queste appassionanti vicende. Precursore delle ricerche storiche sul cinema del territorio è Paolo Micalizzi, i cui libri sono la fonte a cui hanno spesso attinto molti dei ricercatori successivi».
OCCHIO CRITICO
DREAM IS OVER: “TONYA”
E “UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA”
di Marco Incerti Zambelli
“Tonya” di Craig Gillespie e “Un sogno chiamato Florida” di Sean Baker arrivano in contemporanea sui nostri schermi a raccontare, accomunati da una attenzione al racconto della realtà dai tratti documentaristici pur nella diversità dei toni, di un’America nella quale le aspirazioni al successo e la possibilità di affermarsi che hanno segnato la mitologia statunitense appaiono infrangersi contro lo scoglio di una società insensibile e chiusa.
In “Tonya” gli ingredienti ci sono tutti per un perfetto sogno americano: umili origini, un grande talento, una indomita volontà di successo, l’incontro con una saggia allenatrice, le occasioni per dimostrare la reale grandezza. Ma Tonya Harding, pattinatrice artistica sul ghiaccio, è ricordata non tanto per il suo strepitoso ‘triple axel’ ( vertiginoso svolazzo che fu la prima a realizzare) ma per essere stata coinvolta nello spregevole boicottaggio nei confronti di una rivale, azzoppata da una bastonata infertale dalla guardia del corpo della stessa Tonya. Poco importa che la giustizia abbia riconosciuto che in fondo la Harding non era mandante diretta dell’aggressione, la sua carriera è stroncata e mestamente decaduta in improbabili esibizioni come boxeur.
Craig Gillespie, autore dell’interessante “Lars ed una ragazza tutta sua” (2007), ricostruisce la vicenda come una sorta di mockumentary dai toni di dark comedy, mettendo in scena quella piccole corte dei miracoli intorno alla pattinatrice, che pare uscita da una sceneggiatura dei Cohen, raccontata in ricostruite e fantasiose interviste che costellano la vicenda. A partire dalla madre tremenda, anaffettiva eppure tenacemente tesa a coltivare (e sfruttare) le qualità della figlia, mirabilmente interpretata da Allison Janney che per questo ruolo ha vinto l’Oscar, e poi il marito, manesco e imbroglione, a cui Sebastian Stan conferisce la giusta miscela di umorismo e violenza, primo ed unico amore, nella vana ricerca di un riparo dalla madre e disastrosa controfigura di un padre affettuoso e presto scomparso, ai quali si aggiungono il demenziale bodygard, vero responsabile del misfatto, e il cinico giornalista alla perenne ricerca di retroscena scandalosi.
Ma la vera ‘colpa’ di Tonya, alla quale dà il volto e il corpo un’appena imbruttita eppur meravigliosa Margot Robbie, sta nelle origini proletarie, nella mancanza di cultura e di buon gusto, nelle unghie laccate di blù , negli sgargianti costumi cuciti a mano, stridenti e inaccettabili nel raffinato e azzimato ambiente del pattinaggio artistico. A nulla portano quindi le portentose esibizioni della talentuosa “american girl”, per mostrare le quali è stato necessario utilizzare tutte le possibilità del digitale, nell’amara constatazione che anche nello sport, una volta privilegiato strumento di riscatto, può infrangersi il sogno americano.
In “Progetto Florida” il “Magic Castle” che fa da sfondo alle scorribande di Mooneee e dei suoi compari, un rat pack di scatenati, sboccati, irrefrenabili bambini, di magico in realtà non ha che l’improbabile colore lavanda e la vicinanza con la Disneyland di Orlando. Motel lowcost che ambirebbe ad ospitare i visitatori del vicino parco è in realtà il rifugio di una umanità dispersa e marginale, che oscilla pericolosamente sull’orlo della illegalità e tuttavia amorevolmente custodito da Bob, manager della struttura, interpretato da un William Dafoe in stato di grazia, che avrebbe ben meritato l’Oscar per il quale era stato candidato (per altro unica nomination per un film che sarebbe stato giusto tenere in maggior considerazione). Il regista Sean Baker passa dall’Iphone 5 utilizzato per il notevole “Tangerine”, al 35 mmm, mettendo la camera a poco più di un metro da terra, per meglio seguire le peripezie degli infantili protagonisti.
Episodi ed avvenimenti si inanellano in un’opera di fiction che si pone al confine con il cinema della realtà, sorretta da una serie di accadimenti legati da una trama esilissima pur tuttavia coinvolgente ed emozionante. Lo sfrenato andirivieni dei bambini li porta soprattutto dove non dovrebbero andare, nell’ufficio di Bob mentre tenta di fare i conti, sulle passerelle dell’albergo per lordare le macchine degli ospiti o svillaneggiare un anziana signora che vorrebbe esibirsi in topless in piscina. Scorrazzano nei centri commerciali , elemosinano qualche moneta per comprarsi un gelato, in una rincorrersi eccessivo e sgraziato eppure venato di poesia, che rimanda ora a Huck Finn ora ad Alice. Gli adulti rimangono sullo sfondo, se non per le figure di Bob, affettuosamente burbero, e la improbabile, tatuata, single, ventiduenne madre dai capelli azzurri di Moonee, che si arrabatta tra la vendita di profumi low cost ai turisti, l’esibizione come stripper in un squallido club, il prostituirsi in occasionali incontri che diventano pretesto per piccole truffe, il cui amore per la figlia è, ciò nonostante, profondo e sincero, forse più da sorella maggiore che da genitore, capace comunque di infonderle sicurezza e fiducia. Quando irrompono i ‘cattivi’, che in un efficace corto circuito sono rappresentati da coloro che dovrebbero essere i ‘buoni’ ( assistenti sociali, i servizi a tutela dei bambini), Moonee scappando infrange il muro che la separa dall’effimera magia di Dinseyland, l’immagine vira al digitale, in quello che si può leggere come svolta realistica ma anche come fantasia irrealizzabile.
Altalene d’autore: “Ore 15.17 – Attacco al treno”
e “A casa tutti bene”
di Francesco Saverio Marzaduri
“Ore 15.17 – Attacco al treno”
Ciò che del vecchio Eastwood stupisce ogni volta è la capacità, propria del più consumato mestiere, di rimettersi in gioco sfidando canoni, regole, attese per meglio definire quella posizione che i media – a torto – valuterebbero come ambigua. Quel che conta (c’è ancora bisogno di dirlo?) non è affatto la scelta politica; ma se il cimento su temi delicati non fosse sufficiente, e anzi ne ribadisse la personale posizione, è la restituzione per immagini a focalizzare l’idealismo di un autore individualista sino al paradosso. Ancora ricordiamo la battuta di “American Sniper” relativa alle tipologie in cui il mondo si scinde – le pecore, i lupi, i cani da pastore – dove la terza riguarda chi si vota a difendere il gregge con denti e artigli. Aforisma che contiene il senso della politique eastwoodiana e che negli ultimi lavori meglio chiarisce la tesi sull’America, i suoi eroi presunti (“J. Edgar”) o reali (“Sully”), responsabilità e fardelli: ingredienti ogni volta posti in discussione, la cui contraddittorietà, analizzata su ambedue i fronti, trova il miglior equilibrio.
In “Ore 15.17 – Attacco al treno” – trentasettesimo lungometraggio di Clint e ancora una volta un biopic – il senso di tale volontà americana, illuminata dalla Fede, si ritrova nei californiani Spencer e Stone, e nel primo, sin dall’infanzia, impellente è il bisogno di riuscire nella vita. Dopo una breve introduzione in voce off del terzo protagonista (il nero Anthony), il film si apre con un prologo in flashback che rinvia a “Mystic River”, sulla restituzione di un’amicizia deragliata dall’incedere degli eventi. Etichettati come buoni a nulla nella scuola cristiana che li vede iscritti, Spencer e Stone finiscono regolarmente in presidenza per le note di ritardo. Qui fanno la conoscenza di Anthony, modello di rivalsa per il primo, benché dei due non condivida aspirazioni e illusioni (infatti, una volta cresciuti, resta a casa mentre gli amici combattono). Dopodiché si procede sui consumati binari dell’Eastwood più noto allo spettatore, e non occorre tornare a “Gunny” (o al kubrickiano “Full Metal Jacket”, il cui poster campeggia nella stanza di Spencer insieme a quello di “Lettere da Iwo Jima”): l’addestramento militare discende dal citato “American Sniper”, ma, come “Leggenda” Kyle, anche Spencer è pervaso da una brama di riscatto. Un difetto di vista nella percezione di profondità, però, lo obbliga a rinunciare agli aerosoccorritori e optare per il SERE, riponendo frustrazione e orgoglio.
C’è dell’aspra ironia nella dissertazione sulla volontà di eroismo – pardon, di auto-realizzazione – ad ogni costo, in qualche veste e in qualche luogo, fosse pure il Fato a decidere di nuovo su sorti e pedine (“Non se lo fila più nessuno l’Afghanistan – recita una battuta – il nemico oggi è l’ISIS”), prima che queste si tramutino in paladini della giustizia. Se improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo è consolidata norma, eroismo è un concetto ormai sospetto, ridotto a grama cosa quanto l’esaltazione di un atto che ne riesumi la sostanza: a ricordarlo, il gesto da spavaldo di Spencer ridotto a cialtronata, durante un’esercitazione in classe con finto allarme. E nell’affidare a tre corpi comici di estrazione televisiva (tra cui un maturo Jaleel White, lo Steve Urkel di “Otto sotto un tetto”) i ruoli di preside e docenti della scuola cristiana, Eastwood pare mettere alla berlina un’America di antico spirito nel vano tentativo di far rispettare regole e dogmi. La stessa che, per aiutare ragazzi con lacune di apprendimento, consiglia ai genitori di somministrare pasticche.
Se si considerano le recenti opzioni politiche (da non confondere con l’endorsement trumpiano) nulla più che un cicaleccio gettato in pasto al tamtam, il conscio Eastwood se ne infischia di paradigmi a Stelle e Strisce, archetipi e contraddizioni, ridiscutendone persino la storia a fronte di possibili equivoci (il tour tedesco in bicicletta al memoriale della morte di Hitler). Come Anthony è presenza (extra)diegetica dell’assunto, nonché figura-mentore dietro cui si avverte l’alter ego del cineasta, così lo smembramento dell’odierno Paese, la cui visione d’insieme è possibile riesumare rammucchiandone i brandelli, è anche – se non soprattutto – studiata linea di un racconto a blocchi che raduna teen movie, film bellico, on the road e confezione tv. Lo scampato attentato del titolo sul treno per Parigi fa capolino in fugaci inserti, atti a scandire le tappe d’una formazione esistenziale, seguendo un viaggio all’estero semi-documentarista che riunisce i tre amici – e pazienza se la parte girata in Italia utilizza più obsoleti cliché della Roma di Woody Allen. E torna protagonista nel patch conclusivo, solvendosi in una palpitante manciata di minuti: sicché i semplicioni Spencer, Alek, Anthony sgominano un terrorista ISIS – Parigi è sconsigliata, secondo una turista loro compaesana – trovando la grande occasione, coronata dal salvataggio in extremis di un ferito grave. Qui Spencer può finalmente mettere in pratica quanto l’esperienza gli ha impartito.
Prodotto volutamente diseguale, action movie anomalo nell’opera di Eastwood, “Ore 15.17 – Attacco al treno” è invece parte di un teorico quanto complesso trittico. Come in “Sully”, del quale serba l’identica durata di un’ora e mezza, s’interroga sull’aura eroica dovuta al Fato o semplicemente al fatto di trovarsi lì in mezzo alla gente, senza ricorrere alle mimetiche indossate da bambini. E si conclude con l’immagine dell’eroe in carne e ossa, moltiplicato per tre, fotografato nella propria euforica sublimazione durante il discorso di Hollande, ripreso dal vero e inserito nella finzione. Se nel titolo precedente l’autore restituiva una visione del problema mediante un riverbero d’ipotesi teso a leggere la realtà e (attraverso) il cinema, nel caso specifico si opta per una riviviscenza attigua alla lezione di Zavattini, che fa “recitare” i veri protagonisti dell’episodio. Più facile che Eastwood, da competente filmologo, si ricordi di esempi come l’Arlo Guthrie di “Alice’s Restaurant”, e ancor prima l’Audie Murphy di “All’inferno e ritorno”: l’assunto resta però quello dello straniero senza nome, dall’oscuro trascorso, in cerca di quell’espiazione resa qui possibile senza morti né vittime sacrificali. In chiusura di un cerchio fatto anche di inusuali sperimentalismi, chi meglio di Clint sa che questa è la sola accertata vérité?
“A casa tutti bene”
Senza andar troppo indietro nel tempo, c’è stato un momento in cui Gabriele Muccino e Ferzan Özpetek erano considerati i più promettenti della nostra nuova produzione. Poi s’è inceppato qualcosa, a rivincita di coloro che dichiarando da subito il proprio scarso apprezzamento risultarono, intellettualmente, più onesti di chi prima accolse e poi snobbò. Basta una dozzina di film al tirar delle somme? Vero è che se i nomi in oggetto non cessano di dividere attese e giudizi, forse è colpa di uno stile fattosi gradualmente maniera, incapace di evitare ridondanze e, in qualche caso, un’invadente presenza autoriale.
Muccino – al suo undicesimo lungometraggio, alla soglia dei cinquanta, con “A casa tutti bene” – mira a un bilancio della propria opera con un affresco familiare, che suo”na come una riflessione sulla formula del cinema italiano meglio indovinata (in quanto studiata a tavolino) e sulla sua riuscita. Circostanza deputata, il classico pranzo di famiglia in cui si celebrano le nozze d’oro di una coppia di benestanti ristoratori, a Ischia (un tempo meta cinematografica e ormai non più). Con relativo stuolo di parenti, collaudato campionario di assortita umanità: una nevrotica Sabrina Impacciatore, coniuge tradita che tenta disperata di tenere in piedi un’unione a pezzi; un Pierfrancesco Favino messo a dura prova da un’oppressiva, isterica consorte, impegnato a tener buoni i rapporti con la ex e il figlio avuto da lei. E i ritratti più amari di un Gianmarco Tognazzi finto estroso, che la dolce attesa della compagna spinge a elemosinare un posto nel ristorante degli zii (e far fronte alle resistenze di chi non lo vede di buon occhio), e una dolente Claudia Gerini, moglie di un misurato Massimo Ghini minato dall’Alzheimer, il cui amore non sembra scalfito da sofferenze. C’è anche il topico amore pulito di due giovani, in ricordo del Muccino degli inizi; e non manca il feticcio Stefano Accorsi, cui è delegato il ruolo di narratore (“La famiglia è il nostro luogo di partenza, di fuga e di ritorno”), impenitente Peter Pan e scrittore di successo invidiato dal fratello Favino, pur non esente da colpe (e infatti, cacciato dalla moglie e disprezzato dal figlio a causa di un tradimento, finisce a letto con la cugina).
Non è facile condensare un’ora e quaranta di caratteri intrecciati, vicende sentimentali, psicologie, cui forse avrebbe giovato un metraggio più lungo. Ma Muccino non è Scola, anche se ineludibile è il modello, del quale impiega uno dei volti-simbolo, la Sandrelli. Benché non esplichi la cattiveria che del genere, in analoghe situazioni, ci si aspetterebbe da un Monicelli o un Risi, in “A casa tutti bene” nessuno del mosaico è veramente innocente, né si parteggia per alcuno: tutti hanno scheletri nell’armadio, e il proprio bravo schizofrenico fagotto di inquietudini. Eppure – e qui sta la ricattatoria riuscita del film – ognuno è patetica vittima di labilità e sofferenze, incastonata tra disagi, ipocrisie e paraventi, che un epilogo accomodante pone di fronte al fattore-sorpresa. Fin troppo svelato è l’escamotage della mareggiata che obbliga l’assortita compagnia a trattenersi sull’isola e confrontarsi l’un l’altro, rivoltando il finto idillio dei festeggiamenti e denudando conflitti (nemmeno troppo) latenti e vecchi rancori. Ma proprio nell’isola si può individuare l’ultimo avamposto di un’azzardata serenità, tutta abbracci e sorrisi di circostanza: la ricerca di una felicità dalla limitata durata, pronta a una rimessa in discussione tipica di altri più fortunati lavori: chi non ripenserebbe, difatti, a “Il grande freddo”, al suo riadattamento “Compagni di scuola” e, più di recente, allo scandinavo “Festa in famiglia”?
A Muccino si riconosce l’indubbia capacità di muovere la macchina, conciliando carrelli su figure e segmenti in un identico quadro a primi piani dediti allo scavo psicologico dei personaggi, in attesa d’una verità che non tardi a manifestarsi. Il problema si presenta quando la congiunzione dei vari anelli si risolve nell’espediente, caro al regista, di una recitazione gridata e sopra e righe, qui oltre i limiti di maniera, quale unica irritante modalità. Specie nella seconda parte (si veda il tentativo di un esasperato Favino di uccidere l’oppressiva moglie) si ha un’impressione più di veridicità che di spontaneità, che limita le facilonerie e banalità incipienti in certi dialoghi (in stile Moccia, tipo le battute di Accorsi). La rivisitazione della commedia à la Muccino è tutta in quest’operazione, come se la sfera dei sentimenti, da “L’ultimo bacio” in avanti, non fosse mutata: il che fa di “A casa tutti bene” un prodotto (medio) più onesto dell’ambizioso estro di un Özpetek, perché più sincero e coerente alla propria cifra stilistica. Strano poi come, nel novero della tragicommedia urlata, nessuno abbia individuato un parallelo con Lina Wertmüller, che come Muccino ha tentato la fortuna in America senza il risultato sperato (e “La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia”, guarda un po’, raccontava di un ménage in crisi).
Dopodiché il film non si esime da usuali trovate, dalla scelta di un cast variopinto che raduna molti noti nomi della recente produzione sino alla presenza del maestro Piovani, che firma una peraltro enfatica colonna sonora. Da segnalare a tal proposito le canzoni che interrompono un’atmosfera di tensione in vista d’una finta conciliazione (di nuovo Jovanotti!), se non di un girotondo a sdrammatizzare (Cocciante strillato à gogo). Salvo che, come afferma la compagna di Tognazzi, finché si fanno i burattini di corte tutto è accettabile ma, se si tratta di tornare alla realtà, è l’esatto inverso (vedasi il patriarca Marescotti che tuona alla moglie Sandrelli il proprio punto di vista sul concetto di “famiglia”). E in un’alcova di bugie e infelicità, per qualcuno destinata al cambiamento, è inaccettabile l’espediente del volemose bene nonostante stracci e cocci disseminati, in cui solo i compromessi concretizzano duraturi affetti (la battuta-leitmotiv recita “E fattela ’na risata”): ingrediente vetusto, ormai inconcepibile, per l’esito di un prodotto che sembra non abbandonare il ruffiano folklore di un Paese assurto a potenziale bersaglio, ribadendone anzi l’assioma. E influenza il giudizio su un lavoro in cui discreti passaggi si affiancano ad altri più scontati: un lavoro riuscito, forse. Ma non bello.
FAMIGLIE: “CHIAMAMI COL TUO NOME” DI LUCA GUADAGNINO
E “LOVELESS” DI ANDREY ZVYAGINTSEV
di Tullio Masoni
“CHIAMAMI COL TUO NOME”
Prima del film onorato dall’Oscar e da un lusinghiero consenso di pubblico, conoscevo di Guadagnino “Io sono l’amore” (2009) e “A bigger splasch” (2015).
Vorrei dire subito che, rispetto a quelli, “Chiamami col tuo nome” è probabilmente più equilibrato sul piano dello stile, lavora con maggiore coerenza sul luogo e da questo, in parte, si “lascia guidare”.
Da un romanzo di André Aciman e sceneggiata da James Ivory, la storia si svolge nella campagna cremasca negli anni settanta. Qui una ricca famiglia ha la propria villa di vacanze e per iniziativa del padre – un illustre professore di archeologia – ospita studenti stranieri che vogliono perfezionarsi.
Una famiglia della borghesia alta e democratica, quindi, nella quale sta crescendo Elio, che a diciassette anni esibisce una raffinatissima creatività musicale.
Lo studente che arriva nell’estate di cui si tratta è Olivier, un giovanottone americano: bello, vigoroso, anche “saputo” – con una lettura etimologica del termine albicocco spiazza ed entusiasma il professore: « Trenta!», grida questi arrendendosi al sapere dell’allievo – che subito crea un certo scompiglio nella casa, fra le ragazze dei dintorni, e soprattutto in Elio.
Poco a poco il ragazzo si innamorerà di Olivier, passando da disagio, bagni e corse in bicicletta per la campagna, a una vera iniziazione.
Qualcuno ha paragonato l’Olivier di Guadagnino all’Ospite del pasoliniano “Teorema”. Al di là di ogni considerazione estetica (a mio parere il film del ’68 non è fra i più riusciti del poeta) la somiglianza è solo superficiale: in Pasolini la crisi provocata dall’Ospite era “distruttiva”, nel film di Guadagnino è invece morbida, ben assimilata, anzi incoraggiata da una famiglia che nell’occasione può e vuole dimostrare tutta la propria liberalità. Anche troppo, aggiungerei, perché levigatezza e valori di paesaggio aiutando, l’impressione è che ogni angolo sia sempre smussato, ogni possibile disturbo assorbito e fatto prezioso.
Con qualche debito verso Rohmer e più segnatamente Ozon – si ricordi “A bigger splash”, un po’ suggerito da “Swimming Pool”, che a sua volta riprendeva l’unità di luogo de “La piscina” di Deray – Guadagnino vorrebbe assecondare la delicatezza dell’iniziazione affidandosi, nel finale, a un composto indugio melodrammatico.
Un buon intento ma, direi, inficiato da certa prolissità, da qualche scomposta ricerca di effetto (la masturbazione con la pesca) e da una gradevolezza di immagine sempre sul limite, quando va bene, della “calligrafia”.
Come dicevo all’inizio, “Chiamami col tuo nome” sembra stilisticamente migliore di “Io sono l’amore” (dove la calligrafia si estendeva alla gratuità virtuosistica dei movimenti di macchina) e “A bigger splash”, ma soffre, per le ripetizioni, di un fatale appiattimento. Poi: era proprio necessario aiutare il sorgere del nuovo desiderio con la lezione del professore sul concetto ellenistico di bellezza che contempla l’armonia di maschile e femminile in un’unica forma? Anche questo è smussare, ammorbidire…Come accade, alla fine, con tutti i personaggi: sopra la media nei talenti, è ovvio, radical e anticraxiani (la breve parentesi “di costume” del pranzo con gli amici) e privi di assillo.
“LOVELESS”
“Senza amore”, è il titolo.
Una giovane donna, Zhenya, corre sul tapis-roulant appena fuori da casa. Una casa simile ad altre in cui vive la classe agiata; simile a quelle di tutto l’occidente. La donna indossa una felpa su cui è scritto: Russia.
Zenya si è appena separata da un marito, Boris, col quale aveva un figlio di 12 anni: Alyosha. Aveva, perché scomparso chissà come e dove, il ragazzo mai amato dai genitori non farà ritorno.
«…è la storia – dice il regista – di un penoso divorzio di una ordinaria famiglia appartenente al ceto medio di Mosca (…) All’improvviso tra queste persone benestanti che conoscono la vita, vediamo che il figlio è diventato un peso (…) Questi eventi hanno luogo su uno sfondo storico ben preciso. Il film comincia nell’ottobre del 2012, quando la gente era piena di speranze ed era in attesa di cambiamenti nel clima politico, quando pensavano che lo Stato li ascoltasse. Ma il 2015 è il climax del loro disappunto: la sensazione che non ci sia speranza per cambiamenti in positivo, l’atmosfera caratterizzata dall’aggressività e la militarizzazione della società…»
Nel potente “Leviathan” (2014) Zvyagintsev aveva denunciato la corruzione politico-religiosa della Russia post-sovietica; con “Loveless” l’ambiente che mette in scena è privato ma, se possibile, più fosco.
Per raccontare la crisi coniugale il regista, nella prima parte, indulge a scene di letto (dei coniugi coi rispettivi amanti) eccessivamente ripetute e convenzionali ( pur nell’intenzione di rappresentare con crudezza una insuperabile noia amorosa) ma poi riesce ad allestire un crescendo drammatico di notevole forza e, al tempo stesso, ambiguità.
La militarizzazione della società di cui il regista parla si forma man mano allargando il cerchio nello squallido paesaggio delle periferie, con l’attività dei volontari civili che si sono assunti l’impegno di cercare il ragazzo. Il cerchio si allarga sempre più, le squadre si fanno sempre più numerose e, metaforicamente, si stringe. Ossia mostra una presenza para-statuale (ma potrebbe in altra situazione diventare para-militare) “sostitutiva”, cioè con funzioni di Stato senza essere Stato; una presenza dai poteri e dalle dimensioni imprevedibili. Il crescendo dell’azione – nel ritmo proprio del racconto filmico – lascia attoniti; perché se da un lato crea l’attesa del ritrovamento di Alyosha, dall’altro fa sospettare una violenza ulteriore, un mistero sempre più insondabile.
Del ragazzo scomparso, per tutta la visione del film, ci resta la muta smorfia di dolore dell’inizio, quando nascosto nella semioscurità, e dietro un battente, egli ascolta le voci rabbiose dei genitori che litigano. Con quella smorfia Alyosha guarda noi, e guarda in faccia il proprio destino.
DUE FILM DI ADRIAN SITARU:
“ILEGITIM” E “FIXEUR”
di Paolo Vecchi
Adrian Sitaru, classe 1971, regista, sceneggiatore e produttore rumeno, è stato dedicatario di una personale nell’ambito del trentaseiesimo Bergamo Film Meeting. La Lab80, che del Meeting è il braccio distributivo, ha fatto uscire in seguito nelle sale italiane “Ilegitim” e “Fixeur”, entrambi del 2016, i più recenti tra i cinque lungometraggi da lui diretti. Come scrive Lorenzo Rossi nel saggio pubblicato sul catalogo del festival orobico, i due film segnano uno scarto rispetto a quelli che li hanno preceduti, rappresentando “un marcato cambio di prospettive, idee, sguardi che è anche un modo differente di osservare le cose e di dirle attraverso il cinema”. Scarto comunque parziale, perchè “Pescuit sportiv”(2008), su una coppia che investe casualmente una prostituta survoltando nell’incubo una situazione già di crisi, “Din dragoste cu cele mai bune intentii” (2011), sull’ansia nevrotica di un trentenne per la madre malata, e “Domestic”(2012), che potremmo definire scene di condominio con animali, sono altrettante tappe del percorso di un autore con una concezione già matura della messa in scena, grazie anche all’appoggio di una casa di produzione indipendente, la 4 Proof Film, una sorta di factory con collaboratori fedeli come il direttore della fotografia Adrian Silisteanu e attori di vaglia come il formidabile, onnipresente Adrian Titieni. In lunghi piani sequenza localizzati prevalentemente in interni, due o più personaggi parlano del banale quotidiano ed espongono le proprie ragioni quasi sempre dandosi sulla voce, con un’ironia che sconfina talora nel sarcasmo anche se la pietà non manca mai verso i protagonisti di questa mediocre commedia umana, in cui la presenza delle istituzioni, dal governo nazionale all’Europa, è avvertibile solo come sfondo mediato.
“Ilegitim” inizia ancora una volta con un’occasione conviviale in cui i discorsi si sovrappongono, ma quasi subito assumono una piega inaspettata. Sasha chiede a Victor, il padre, se è vero che durante il regime si era adoperato a impedire l’aborto di molte donne, se la madre, ora defunta, avrebbe voluto a sua volta abortire lei e il gemello Romeo. Un altro giro di vite e assistiamo a un rapporto sessuale molto realistico tra i due e veniamo a sapere che la ragazza é incinta del fratello. Come in “4 mesi, 3 settimane e 2 giorni”,il tema dell’interruzione della gravidanza si intreccia con la rievocazione degli anni bui di Ceausescu e le responsabilità individuali di chi li ha vissuti. Ma Sitaru va oltre il film di Mungiu e affronta con una lucidità aliena da ogni compiacimento morboso e senza implicazioni moralistiche il tema dell’incesto, della reazione violenta dell’ambito familiare ma anche della sua ricomposizione più o meno ipocrita.
Altro tema forte, la prostituzione minorile e la “tratta delle bianche” verso l’opulenta Parigi, quello di “Fixeur”. Ma Radu, incaricato da un network francese di fare da tramite per rintracciare la ragazzina da intervistare per una trasmissione televisiva sull’argomento, è appunto un giornalista, sia pure praticante.
Più che l’argomento dell’inchiesta in corso di realizzazione, a Sitaru interessa dunque l’aspetto etico, e per altri versi teorico, della questione. Da un lato, infatti, il regista mette in scena personaggi senza scrupoli, sia rumeni che francesi, ai quali l’unica lezione di comportamento, tantopiù dura in quanto garbatamente irremovibile, viene dalla madre superiora del convento che ha in custodia la minorenne. Dall’altro, si interroga sulla stessa liceità del proprio ruolo professionale, della violenza che sempre comporta registrare l’ altrui intimità, e non solo nel cosiddetto cinéma – vérité, o vita in diretta televisiva che dir si voglia, ai quali peraltro riserva un divertente sberleffo quando il cameraman chiede a un contadino che sta spalando letame di non guardare in macchina. “Durante la lavorazione mi sono trovato ancora una volta assalito da vecchi demoni: mi sono accorto di quanto io stesso, spinto dal desiderio di raggiungere la perfezione e accecato dal principio per cui sono autorizzato a mettere l’arte prima della vita, abbia sempre maltrattato i miei attori, i miei collaboratori e persino gli animali dei miei film”, ha infatti dichiarato Sitaru. Ma “Fixeur” è in qualche modo anche un road movie sulla Romania profonda, lontana da Bucarest cento chilometri e cento anni, illustrata da due impressionanti panoramiche, una urbana e una agreste, luogo indefinito dove si possono ancora trovare carretti a trazione animale e ristoranti in cui una cantante d’altri tempi improvvisa “Je ne regrette rien” ad uso dei clienti francesi.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
LA STORIA DIETRO LA PORTA CHIUSA
“The Other Side of Everything (Druga strana svega)” di Mila Turajlić
e “When Pigs Come (Kada dodu svinje)” di Biljana Tutorov
di Marcello Cella
Il recente Balkan Florence Express di Firenze, giunto alla sua sesta edizione, ci ha proposto, fra le altre cose, questi due bellissimi documentari serbi che ci hanno colpito per le cose che hanno in comune, pur partendo da punti di vista diversi, e perché, parlando del loro Paese, le due giovani registe serbe consegnano agli spettatori anche una riflessione che riguarda in realtà tutti gli europei alle prese con speranze di cambiamento deluse e pericolosi nazionalismi risorgenti. Due film profondamente politici nel senso più alto del termine.
“The other Side of everything” di Mila Turajlić, già autrice del fortunato documentario “Cinema Komunisto” sul cinema nella Jugoslavia di Tito, è forse il film più intimo e personale fra i due perché coinvolge direttamente la regista in un confronto appassionato e tormentato con la propria madre, Srbijanka Turajlić, singolare figura di studiosa e attivista politica, sulla scena pubblica del suo Paese fin dagli anni Sessanta. Coprotagonista del film una porta chiusa che da 70 anni divide il suo appartamento da quello accanto, quando nel 1946 le autorità comuniste di Tito, nazionalizzando le proprietà borghesi, decisero che l’appartamento di 240 mq della sua famiglia, acquistato dal bisnonno della regista nel 1929 quando Belgrado faceva parte del Regno di Serbia, Croazia e Slovenia, venne giudicato troppo grande per il suo nucleo familiare e diviso in due, assegnando l’altra parte ad un’altra famiglia.
E’ la stessa Srbijanka Turajlić, ex professoressa dell’Università di Belgrado ed implacabile oppositrice del dittatore serbo Slobodan Milošević, a raccontare la sua storia e quella della sua famiglia alla figlia filmaker in fuga dal proprio Paese. Ma la storia intima e personale di Srbijanka si trasforma in uno specchio in cui vediamo riflessa la Storia della ex Jugoslavia e delle speranze che aveva suscitato al suo interno e sulla scena internazionale questo Stato federale nel cuore dell’Europa in cui convivevano pacificamente persone di culture e nazionalità molto diverse fra loro all’interno di un sistema che si proponeva la giustizia sociale come suo orizzonte ideale. Sono i ricordi dell’anziana e lucidissima protagonista del film a tracciare il suo percorso narrativo a partire dalla liberazione di Belgrado nel 1945 e passando attraverso le rivolte studentesche del 1968, ma anche i materiali d’archivio della stessa Srbijanka, in prima fila negli anni ’90 contro il nazionalismo aggressivo di Milošević e le guerre jugoslave che le costarono il posto di lavoro e l’emarginazione, fino ai bombardamenti della NATO nel 1999 e la caduta del dittatore nel 2000 che la ritrovarono in piazza con i manifestanti e con un ruolo politico di primo piano quando divenne per un breve periodo ministro dell’educazione e dello sport nel primo governo serbo del dopo Milošević. Proprio gli anni ’90 assumono un peso narrativo particolare all’interno del film perché i filmati della Belgrado di quegli anni mostrano come l’opposizione interna contro l’attacco da parte dell’esercito jugoslavo alla Croazia e alla Bosnia fosse molto forte e partecipata, ma anche come le proteste studentesche e civili e le manifestazioni si protrassero per tutto il decennio nell’indifferenza colpevole delle cancellerie europee. Sono impressionanti le manifestazioni in cui Srbijanka parla davanti a decine di migliaia di persone e fa pensare il silenzio che ha circondato questi eventi nel “democratico” Occidente. Ma i ricordi di Srbijanka non sono mai attraversati dall’amarezza e dal rancore, anzi, incalzata dalla figlia, colpiscono la sua lucidità, la sua forza e la consapevolezza che, per quanto perdente, il suo impegno non è stato vano ed è stato speso per una causa giusta, per la libertà, la democrazia e la giustizia per tutti nella ex Jugoslavia come nella Serbia. Il film di Mila è infatti il frutto di cinque anni di conversazioni e di confronto serrato con la madre, cinque anni in cui le domande iniziali di Mila a Srbijanka, “cosa è successo?”, “cosa hai fatto?”, trascolorano in un più intimo “cosa avrei dovuto e potuto fare?” per concludersi in un interrogativo ancora una volta rivolto al futuro, “cosa posso fare?” che come in uno specchio si riflette anche sul percorso esistenziale di Mila, in dichiarata fuga dal proprio Paese (“Non si può vivere in Serbia”, confessa alla madre). Ma poi c’è quella porta chiusa che divide l’appartamento di famiglia, dietro la quale si nasconde forse un’altra parte della storia privata e pubblica della famiglia di Mila e Srbijanka. Essa compare a più riprese durante il film e nei ragionamenti della protagonista, ma non assume mai un ruolo centrale fino a quando, durante una riunione di famiglia, si decide di aprirla. Non un’operazione facile, e non solo per la difficoltà tecnica di aprire una serratura rimasta intonsa per 70 anni. Ma la scena che si apre ai loro sguardi nel momento in cui questa porta dischiude i suoi segreti è per tutti loro un tuffo nel passato della ex Jugoslavia con le immagini di Tito e gli oggetti di quell’epoca conservati e come ibernati dall’anziana signora che ancora vi abitava fino a poco tempo prima. Tracce di un passato che continua in vario modo ad attraversare il presente di Srbijanka, di Mila e forse dell’intera ex Jugoslavia con il suo carico di riflessioni storiche e di malinconie esistenziali, ma anche di rinnovate strategie di resistenza ai conformismi, ai nazionalismi e alla chiusura di muri e porte al mondo e al futuro. In questo senso la casa di Srbijanka diventa una casa/metafora non solo di un percorso esistenziale declinato al passato, ma anche di una riflessione che coinvolge più direttamente la generazione della figlia regista, tormentata tra la sua voglia di fuga e la consapevolezza che una donna come sua madre è riuscita con fatica a cambiare in parte il suo Paese lottando al suo interno e senza essere mai sfiorata dall’idea di abbandonare le sue lotte e le sue difficoltà. Forse le riprese video che Mila realizza delle proteste di piazza e degli scontri dei manifestanti con la polizia nelle vie del centro di Belgrado in cui si trova la casa della madre sporgendosi dalle sue finestre sono anch’esse una promessa silenziosa e attiva di resistenza.
Anche Dragoslava Aleksic, protagonista di “When pigs come” di Biljana Tutorov, attua a suo modo una propria strategia di resistenza contro i pericolosi conformismi nazionalistici della nuova Serbia.
L’anziana Dragoslava ha quattro televisori sempre accesi e sintonizzati sui canali di informazione, tre simpatici nipoti a cui non racconta mai favole, ma storie della vita reale appena trasfigurate dalla sua fantasia per renderle più comprensibili ai suoi giovani interlocutori, due amiche del cuore con cui discute più di politica che di pettegolezzi familiari. E poi un marito silenzioso, ma attento e partecipe, con cui litiga per il possesso del telecomando e per la scelta dei programmi televisivi visto che l’uomo preferirebbe il calcio ai telegiornali propagandistici che esaltano le imprese politiche del nuovo uomo forte di Belgrado, il nazionalista Aleksandar Vučić, amato dall’Occidente, ma con un passato politico macchiato dalla sua collaborazione con Slobodan Milošević e il suo governo negli anni ’90. Dragoslava, sempre vissuta nella sua piccola città di confine in Serbia, ha vissuto in molti Paesi diversi, senza mai spostarsi di un metro, ma vive costantemente immersa nella politica e nei media che la raccontano, con determinazione, ma anche con umorismo corrosivo. Dotato di una fortissimo senso etico, per lei ogni singolo gesto è un atto di responsabilità che contribuisce a cambiare il mondo. Quello di Dragoslava è una singolare forma di attivismo che nella sua apparentemente neutra quotidianità non perde mai il contatto con il mondo e coltiva, insieme alle sue amate piante, lo spirito critico verso il risorgente nazionalismo serbo incarnato dal presidente Vučić, e la speranza di un futuro migliore attraverso i racconti che fa del suo passato e di quello del suo Paese ai nipoti. Le sue televisioni sempre accese sono, insieme ai giornali, le sue finestre sul mondo, ma il suo sguardo non è mai passivo e questi strumenti non costituiscono mai per lei quella specie di sedativo audiovisivo che ben conosciamo nella nostra società. La sua attenzione ai fatti del mondo è pari a quella che lei pone per quello che accade sotto le sue finestre. Dragoslava, come è stato detto, è la tipica donna comune dei periodi di transizione nell’est europeo, quella che mantiene in piedi l’instabile baracca familiare e statale quando gli uomini giocano pericolosamente con il nazionalismo, l’unico punto fermo, anche geografico si potrebbe dire, mentre il territorio in cui vive cambia continuamente bandiera e padroni. Si occupa della dignitosa sopravvivenza familiare ma contesta le autorità, il potere e i media al loro servizio, i ruoli sociali e familiari, praticando e incarnando un ideale civico apparentemente démodé, lontano dagli attuali giochi della politica su internet, sui social. Dragoslava discute di politica con le amiche disilluse, direttamente, faccia a faccia, con passione e humour, per nulla scoraggiata dalle dimensioni minime della situazione in cui si trova a vivere ed operare. Ma con il suo impegno politico e culturale “lillipuziano”, il suo attivismo civico periferico e lontano dai luoghi dove si prendono le decisioni importanti, Dragoslava, esattamente come Srbijanka Turajlić, assume un importante ruolo di specchio rispetto alla società in cui vive ed un esempio vitale e coraggioso di cosa ognuno di noi può o potrebbe fare quotidianamente per cambiare il mondo e cancellare le sue brutture.
“The other Side of everything”
Titolo originale: “Druga strana svega”
Regia: Mila Turajlić
Soggetto: Mila Turajlić
Sceneggiatura: Mila Turajlić
Interpreti: Mila Turajlić e Srbijanka Turajlić
Musica: Jonathan Morali
Produzione: Dribbling Pictures (Serbia)
Co-produzione: Survivance (Francia), in associazione con ARTE-WDR e il supporto di Serbian Film Center, CNC-Aide aux Cinémas du monde, EURIMAGES, Doha Film Institute
Nazionalità: Serbia
Anno: 2017
Durata: 104’
Web: https://www.othersideofeverything.com
https://www.facebook.com/theothersideofeverything/
https://www.youtube.com/watch?v=OJvB6VgVlY4
“When Pigs Come”
Titolo originale: Kad dodju svinje
Regia: Biljana Tutorov
Sceneggiatura: Biljana Tutorov
Fotografia: Orfea Skutelis
Montaggio: Thomas Ernst
Interpreti: Dragoslava Aleksic, Dragan Aleksic, Dusan Bosnjak, Natasa Bosnjak
Produzione: Biljana Tutorov (Wake Up Films), Dijana Mladenovic (Kinematograf)
Distribuzione italiana: Archfilm (http://archfilm.it)
Nazionalità: Serbia, Croazia, Bosnia-Herzegovina
Anno: 2017
Durata: 72’
Web: http://whenpigscome.com/en/synopsis/
https://www.facebook.com/whenpigscome/
https://www.youtube.com/watch?v=_przdivYXOE
TERRITORI DI CONFINE:
“QUARTIERE PABLO” DI PIETRO MEDIOLI
di Marco Incerti Zambelli
Il confine è luogo privilegiato, permette allo sguardo di spaziare in territori diversi, di cogliere analogie e differenze, di avvertire continuità e fratture, di individuare un campo nel quale fertilmente possono ibridarsi mondi dissimili.
Il quartiere Pablo di Parma, intestato ad un comandante partigiano, è terra di confine, tra la campagna e la città, tra il passato e il presente, tra la continuità della tradizione e le contraddittorie innovazioni dell’adesso, tra il radicato ripetersi di consuete abitudini e la dirompente frattura dell’inarrestabile mutamento dell’attuale, tra il nostalgico, emozionante ricordo dei ‘bei tempi che furono’ e lo spaesamento inquieto della modernità.
“ Quartiere Pablo” di Pietro Medioli, regista e Antonio Benassi, autore del soggetto e protagonista come guida, è un partecipato viaggio in quel luogo, una narrazione che si colloca nel fecondo territorio del cinema del reale, probabilmente la più innovativa evoluzione del raccontare per suoni e imagini del panorama contemporaneo. La agile camera a mano, alternata a rigorose carrellate, mette in scena preziose testimonianze, dall’ultimo contadino che prosegue testardamente il suo lavoro alle accurate ricerche di Minardi, direttore dell’istituto Storico della Resistenza, che traccia l’evolversi della urbanizzazione, dalla costruzione dei “Capannoni”, sorta di lager in cui venivano collocati gli abitanti dell’Oltretorrente da “risanare” nel periodo fascista, al proliferare delle abitazioni per gli sfollati di guerra. I ricordi di chi partendo da quei luoghi ha incontrato il successo, come Franco Nero e Stefano Pioli, si affiancano ai racconti di chi non si è mai allontanato come la lattaia Teresa od i colombofili in attesa del ritorno dei loro piccioni, ed alle parole degli immigrati africani che lì cercano una speranza.
 Un sottile ma tenace velo di rimpianto accompagna la rivisitazione di paesaggi una volta gloriosi, come l’abbandonato diamante del baseball che vide campioni internazionali calcarlo e il campo da rugby, sul quale è sorto l’avveniristica sede della Agenzia Europea per l’Alimentazione, foriera, negli auspici, di un prodigioso sviluppo della città, oggetto di un ironico contrappunto canoro dello stesso Benassi.
Un sottile ma tenace velo di rimpianto accompagna la rivisitazione di paesaggi una volta gloriosi, come l’abbandonato diamante del baseball che vide campioni internazionali calcarlo e il campo da rugby, sul quale è sorto l’avveniristica sede della Agenzia Europea per l’Alimentazione, foriera, negli auspici, di un prodigioso sviluppo della città, oggetto di un ironico contrappunto canoro dello stesso Benassi.
Allo sgretolarsi del passato, simbolicamente rappresentato dalle immagini della demolizione della scuola elementare Recagni, edificio emblematico della vita del quartiere, fa da contrasto la commossa tenacia nella cerimonia di ricordo delle stragi della guerra.
Antonio Benassi è un Virgilio capace di individuare con efficacia percorsi e personaggi, guida attenta e mai invadente, pur non rinunciando a suggerire chiavi di lettura ed interpretazioni. La cinematografia di Pietro Medioli, che vanta un ricco curricolo di produzioni audiovisive e teatrali accanto a importanti collaborazioni ( Werner Schoeter, Werner Herzog) sa dipingere con amorevole partecipazione luoghi ed eventi, toccando le corde del lirismo come nelle poetiche sequenze iniziali sul fiume o nel pennellare le evoluzioni in un cielo corrusco dell’aeroplano nel finale, e pur sempre con un rigore narrativo che colloca “Quartiere Pablo” in quel prezioso ‘confine’, appunto, tra narrazione e documento, chi si pone come felice e necessario antidoto sia al superficiale e narcisistico cicaleccio dei social , sia alle nevrotiche, roboanti esplosioni supereroiche.
QUALITA’ IN SERIE
 TRUMP: AN AMERICAN DREAM
TRUMP: AN AMERICAN DREAM
di Giancarlo Zappoli
Serie di 4 documentari prodotta da Channel Four e Netflix. Diretta da Barnaby Peel con Daniel Bogado (1 episodio) e Natasha Zinni (1 episodio). Messa in onda su Channel Four il 9 novembre 2017 e presente su Netfkix dal 30 marzo 2018.
Episodio 1. Manhattan
New York nel 1975 è una città in cui il degrado si sta manifestando con evidenza. Il giovane costruttore Donald Trump, inserito nell’azienda paterna, inizia a ristrutturare lo Hyatt Hotel ottenendo consistenti sgravi fiscali. Decide quindi di costruire la Trump Tower scontrandosi con il sindaco della città.
Episodio 2. Il giocatore d’azzardo
Il desiderio di emulare e superare la figura paterna lo spinge a costruire a Las Vegas prima il Plaza poi il Castle e infine si fa prendere dal desiderio di portare avanti la costruzione del Taj Mahal che dovrebbe essere il casinò più grande in assoluto che invece segna l’inizio di una parabola discendente.
Episodio 3. Cittadino Trump
All’inizio degli anni ’90 la moglie Ivana, che è stata la suo fianco come manager, scopre la sua relazione con Marla Maples e chiede il divorzio. Sul piano finanziario Trump è sull’orlo della bancarotta e i tabloid ora sono interessati più alla sua vita privata che al suo ruolo di imprenditore straricco.
Episodio 4. Politica
Dopo che l’ex wrestler Jesse Ventura conquista la carica di Governatore del Minnesota l’entourage di Trump comprende che prima o poi potrebbe correre per la carica di Presidente degli Stati Uniti. Lui però intende farlo solo se riterrà di avere la possibilità di vincere.
A un primo sguardo si potrebbe pensare che una serie di impronta documentaria su Donald Trump con tutto quello che già si vede e si legge quotidianamente di e da lui sia poco più che inutile. Non é così. Perché se la parafrasi del manzoniano “Carneade, chi era costui?” non gli può essere applicata (tutti sapevamo vagamente chi fosse già dieci, venti, trenta anni fa) la struttura di questo prodotto di origine britannica acquisito da Netflix e quindi costantemente disponibile, ci apre nuovi orizzonti. Perché l’intenzione non è quella di costruire un pamphlet antitrumpiano ma quello di fare emergere il ritratto di una personalità attraverso le testimonianze di chi gli è stato a fianco e non solo di chi lo ha avversato. E’ interessante talvolta osservare le espressioni di coloro che si rivedono in immagini del passato mentre accompagnavano o intervistavano il giovane e rampante Donald. A partire dal suo autista (un poliziotto afroamericano che aveva perso il lavoro) fino a chi gli ha fatto conoscere Twitter (che ora utilizza a proposito e non) è un susseguirsi di testimonianze che prende le mosse dalla New York del 1975 in cui Donald si inserisce nell’azienda del padre Fred, descritto come uomo duro fino alla crudeltà ma anche legato alla concretezza del mondo del lavoro. Fin da allora mostra caratteristiche precise: sa essere simpatico e gentile (anche troppo, ripetendo di anno in anno la stessa domanda a cui ha già avuto risposta) ma anche molto aggressivo con chi percepisce come debole o quando si sente messo con le spalle al muro. E’ capace di promuovere grandi progetti come la ristrutturazione dello Hyatt Hotel o la costruzione della Trump Tower che sovraccarica di arredi kitch e di rubinetti d’oro. Pretende però di avere detrazioni sulle tasse che raggiungono cifre iperboliche e quando il sindaco Koch lo contrasta gli scaglia contro Roy Cohn, un avvocato legato a filo doppio con la mafia che riesce a fargli vincere la causa. Sa come muoversi per attribuirsi meriti altrui (come quando fa sistemare la pista di ghiaccio in Central Park promettendo a chi compirà l’opera a titolo gratuito di fargli avere una valanga di pubblicità ma ‘dimenticando’ poi di averli al fianco quando inaugurerà l’opera). D’altronde è già il boss che quando si festeggia la tradizionale copertura del tetto di un edificio in costruzione chiede perché si debbano invitare gli operai.
Quando si orienta verso Las Vegas (intanto ha sposato Ivana a cui affida incarichi operativi) non si rende conto di non avere le competenze necessarie e si lascia attrarre dall’apparentemente facile guadagno lanciandosi in spese folli e utilizzando posate d’oro da 24 carati. Un giornalista che lo intervistò all’epoca ricorda come avesse volutamente inserito in 4 domande altrettanti dati sbagliati e come Donald, senza scomporsi, li avesse fatti propri (“Come fanno i truffatori” è il commento di oggi). Il suo ghostwriter dell’epoca lo definisce legato alla logica binaria che offre solo le alternative dell’essere o predatore o vittima e incapace di distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è. Compra il Plaza Hotel per il semplice motivo che è bello e non può accettare che venga acquisito da altri ma intanto non paga i fornitori e dopo il Venerdì Nero di Wall Street continua a negare di essere sull’orlo della bancarotta per gli investimenti sbagliati di Las Vegas. Di fronte a contestazioni attacca o abbandona l’intervistatore. Afferma però di avere un film preferito e scopriamo che si tratta inaspettatamente di “Quarto potere”. La motivazione? Il film parla del bisogno di accumulare beni che è negativo e ti ricorda che la ricchezza non è tutto. Detto da lui… Nota però anche che Kane e la moglie si allontanano e il consiglio che gli darebbe è: trovatene un’altra. Cosa che lui sta facendo con Marla Maples arrivando al punto di spacciarsi al telefono come un proprio immaginario PR e di millantare una relazione con Carla Bruni. E’ però anche il manager capace prima di querelare chiedendo una cifra da capogiro e poi di assumere un analista finanziario che aveva messo in discussione i dati da lui presentati mentre le banche chiedono la restituzione di oltre un miliardo di dollari. L’ultimo episodio ci mostra come la conquista del governatorato del Minnesota nel 1992 da parte di un campione di wrestling dai metodi spicci apra a Trump gli occhi sulla possibilità di puntare in alto nel mondo della politica. La massima che apprende e che lo guida è: “La gente non si ricorda quello che dici ma come lo dici”. La Casa Bianca gli aprirà le porte dopo che avrà condotto la campagna sul certificato di nascita di Obama e avrà avuto anche il coraggio di dire che si è perso del tempo sull’argomento solo perché il Presidente non ha voluto esibirglielo subito. In definitiva questa serie si presenta come un utile viaggio in una personalità capace di manipolare la realtà ai propri fini.
PANORAMA LIBRI
a cura di Paolo Micalizzi
A cura di Carlo di Carlo
Edizioni Cineteca di Bologna , Istituto Luce-Cinecittà, 2018
Pagg.390, Euro 18.00,
E’ l’edizione italiana di un volume in inglese che era stato pubblicato l’anno scorso in occasione di una Retrospettiva organizzata a New York al MOMA, dal 7 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Un libro in cui Carlo di Carlo, come scrive Enrica Antonioni nella presentazione, “ha voluto trascorrere gli ultimi anni della sua vita fra le parole scritte e dette da Michelangelo durante tutta la sua vita e ritrovando la sua voce ne ha fatto un montaggio per lui ideale”. Un suo percorso, aggiunge, accanto all’artista e all’uomo che ha più ammirato diventando cosi il suo Antonioni, offrendo la possibilità di farlo diventare ancora nostro e per quanto la riguarda “ancora mio, leggendolo ancora, ammirandolo ancora, amandolo ancora”. Il libro, infatti, ricostruisce la biografia artistica di Michelangelo Antonioni, la verità più vera sul segreto della sua arte attraverso le parole del regista ferrarese( saggi critici, riflessioni e note di carattere teorico sulla visione cinematografica, colloqui nei quali il regista riflette e dialoga sul proprio percorso e sulle proprie scelte relative alle forme o ai contenuti dei suoi film, appunti, “illuminazioni”, sul cinema, sull’arte e sull’esistenza. Leggendolo ci si immerge nell’universo di Antonioni, sulle idee all’origine dei suoi film, sulle fasi realizzative, irte spesso di ostacoli, delle sue opere più importanti. Ma consente di conoscere anche, qui raggruppate, i contenuti delle opere che avrebbe voluto realizzare. Testi già pubblicati in varie occasioni ma che in quest’ultimo libro di Carlo di Carlo ( su Antonioni ne ha scritti una quindicina), come scrive Lorenzo Cuccu, “rinascono come racconti, come narrazione di un pensiero e di una passione in continuo divenire”. Un’operazione che solo Carlo di Carlo poteva fare avendo seguito l’iter artistico del regista ferrarese per oltre cinquant’anni consecutivi. Nel libro vi sono anche notizie inedite sul documentario “Gente del Po”, grazie alla pubblicazione delle lettere che Michelangelo Antonioni durante la fase di realizzazione inviava alla moglie Letizia Balboni, ma anche lettere che inviava durante altri periodi della sua attività. Il volume è corredato da una completa filmografia e dalle fonti di riferimento ai testi di cui Carlo di Carlo si è avvalso per questa monografia molto preziosa per gli studiosi e per gli appassionati di cinema.
 DA OLTRE CONFINE. CINEBREVIARIO 1950 – 2000
DA OLTRE CONFINE. CINEBREVIARIO 1950 – 2000
di Alberto Pesce
Libere edizioni,2017
Pagg. 265, Euro 17.00
Alberto Pesce, critico di lunga data, dopo averci dato le sue opinioni sul Cinema italiano, raccogliendo in 5 volumi le sue recensioni dagli anni ”Sessanta al Duemila” attraverso questo Cinebreviario ci offre una panoramica sulle opere, a ,livello internazionale, di “grandi firme” o che più l’hanno incuriosito e interessato per un verso o l’altro, per tematica e/o poetica dagli anni Cinquanta al Duemila. Scegliendo per ogni anno almeno un “poker d’assi”, quattro recensioni di film. Un escursus che parte dalla recensioni di film del 1950 come “Dio ha bisogno degli uomini” di Jean Delannoy , “Rashomon” di Akira Kurosawa, “Giungla d’asfalto” di John Huston e “Diario di un curato di campagna” di Robert Bresson per arrivare a quelle del 2000 relative a “Dancer in the Dark” di Lars von Trier, “In the Mood for Love” di Wong Kar-Wai, “Grazie per la cioccolata” di Claude Chabrol e “Il cerchio” di Jafar Panahi. Si trovano citati oltre 210 film di 135 registi, opere ed autori di particolare significato negli ultimi cinquant’anni del cinema che Alberto Pesce ripropone alla nostra attenzione consentendoci di riflettere su quanto hanno significato nel panorama del cinema mondiale.
 ANTON GIULIO MAJANO. IL REGISTA DEI DUE MONDI
ANTON GIULIO MAJANO. IL REGISTA DEI DUE MONDI
di Mario Gerosa
Edizioni Falsopiano 2016,
Pagg. 280, Euro 20.00
Anton Giulio Majano è stato un regista televisivo che dagli anni 50 ai 70 ha firmato alcuni dei grandi capolavori di quel periodo:” Piccole donne”,” I figli di Medea”, “Delitto e castigo”, “La cittadella”, “David Copperfield”,” La freccia nera”, “E le stelle stanno a guardare”, tanto per citare i più noti, meritandosi l’appellativo di Re del teleromanzo. Prima si era dedicato al cinema, realizzando 11 film passando dalla commedia all’horror. A lui Mario Gerosa dedica questo volume in cui ne ripercorre la carriera artistica mettendo in evidenza anche le sue grandi qualità di scopritore di talenti. “Aveva, scrive Mario Gerosa nella presentazione, la capacità di orchestrare enormi narrazioni, di concertare decine di personaggi, centinaia di comparse, padroneggiando set complicati che comprendevano decine di ambienti, migliaia di metri quadrati. Le sue ricostruzioni erano accurate, rese amorevolmente, con perizia e meticolosità d’altri tempi. Il pubblico adorava queste grandi opere che mobilitavano poderose maestranze oltre a cast stellari con i più bei nomi del teatro e del cinema di allora”. E aggiunge che Luchino Visconti lo apprezzava al punto da non perdersi nessun sceneggiato da lui diretto. Li accomunava, precisa, il neorealismo e la passione per il cinema francese: Visconti aveva fatto il suo apprendistato con Jean Renoir, mentre Majano era più sensibile al Realismo poetico di René Clair e di Marcel Carnè, “ a un immaginario onirico e evanescente governato dai sentimenti e dal sentimentalismo. Entrambi, poi, avevano una certa affinità con il mondo di Marcel Proust.” Informazioni che sottolineano come Majano fosse un uomo colto che trasferiva il suo sapere negli sceneggiati televisivi. Il titolo del libro fa riferimento poi ad un Majano “regista dei due mondi. Cioè, quello del mondo del cinema e quello della televisione. Majano ne ha riversato, nelle storie raccontate, le tensioni drammatiche e le soluzioni spettacolari che avrebbe adottato se avesse potuto realizzare dei kolossal, visto che pensava in grande e i suoi lavori sono kolossal in potenza. Non a caso veniva definito “il Cecil B. De Mille italiano”. Sono indicazioni che evidenziano alcuni contenuti di questo volume per meglio inquadrare la figura di questo grande narratore televisivo.
a cura di Paola Dei
Edizioni Lulu,2017
Pagg. 141, s.i.p.
Paola Dei è Presidente del Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Pscoterapie Espressve da alcuni anni dedica un volume ai grandi temi che ogni anno attraversano la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, ma anche cui si sono aggiunti poi quello di Roma ed altre manifestazioni. In questo volume affronta il tema del male partendo dal film “Hannah” di Andrea Pallaoro, interpretato da Charlotte Rampling, che evoca Hannah Arendt e la banalità del male, iniziando con una frase di Charles Baudelaire “Il male viene fatto senza sforzo. Il bene è sempre il prodotto di un’Arte” e terminando con una poesia di Alda Merini che richiama la frase d’apertura di Baudelaire come antidoto e unica forza positiva capace di trasformare gli eventi e di unire etica ed estetica Nel libro vengono anche analizzati con specifici interventi “Il male come menomazione fisica: Leopardi un genio della penna”, ma anche “ come anatomia comparata: Sociologia, teologia, Letteratura, Psicologia, Arte, Musica”, “ Il male e letteratura al femminile” e “ Il male nella filmografia internazionale. Una revisione critica”. Il libro comprende una Prefazione di Nicola Borrelli(Direttore Generale Cinema MiBACT) che sottolinea come “Il male nella sua accezione più ampia fa parte dell’esperienza di vita di ciascuno di noi”.
 SANDRO DE FEO FRA TEATRO, CINEMA, LETTERATURA
SANDRO DE FEO FRA TEATRO, CINEMA, LETTERATURA
a cura di Vito Attolini – Alfonso Marrese
Edizioni dal Sud -2017
Pagg. 170, Euro 15.00
E’ un volume che prosegue la riscoperta di protagonisti pugliesi del cinema nel Novecento. E Sandro DeFeo, la cui famiglia è di antica estrazione spagnola, è nato a Modugno( alle porte di Bari) nel 1905 ed ha all’attivo un’intensa attività di giornalista, critico cinematografico e teatrale, scrittore e sceneggiatore. Diventando una delle personalità del mondo culturale che a Roma aveva eletto come luogo d’incontri alcuni caffè ormai mitici , metà di molti intellettuali del tempo, ma anche di attori e cineasti. Nel cinema inizia a lavorare negli anni Trenta , inizialmente nella Cines diretta da Emilio Cecchi dove insieme ad altri operava per il superamento del cinema dei telefoni bianchi. Nel 1933 scrive il soggetto del film “Ragazzo” di Ivo Perilli , ambientato sui pontoni del Tevere, che anticipava i pasoliniani “ ragazzi di vita”: fu ritirato per motivi di censura. Nonostante ciò continua la sua attività di soggettista e sceneggiatore fino agli anni Cinquanta. Della sua intensa attività ne dà conto questo libro, che costituisce l’ultimo lavoro del compianto Vito Attolini, che insieme ad Alfonso Marrese ha dato vita ad alcune significative pubblicazioni relative al rapporto Cinema-Puglia. Contribuiscono a tracciare questo Ritratto di Sandro De Feo alcuni saggi di studiosi attenti alle varie discipline artistiche cui egli si è dedicato lasciando un contributo significativo.
CREDITS
Carte di Cinema 16
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com )
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 16 della rivista online: Alfredo Baldi, Marcello Cella, Luisa Ceretto, Mariapia Cinelli, Paola Dei, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Riccardo Poma, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Marco I. Zambelli, Giancarlo Zappoli.