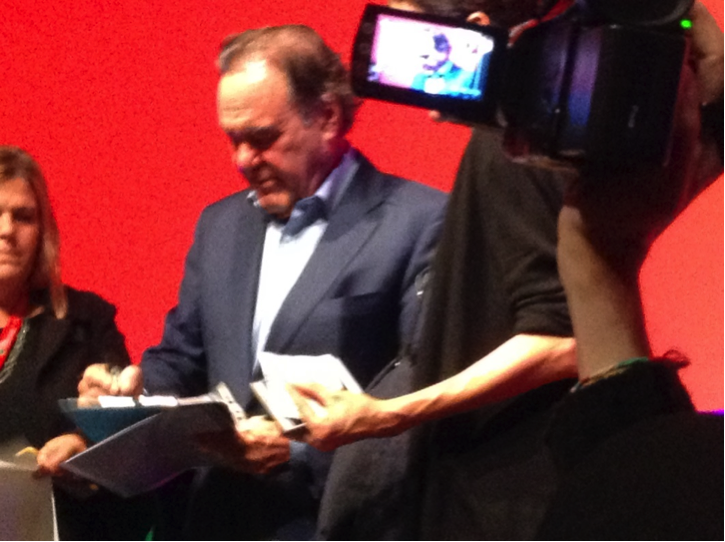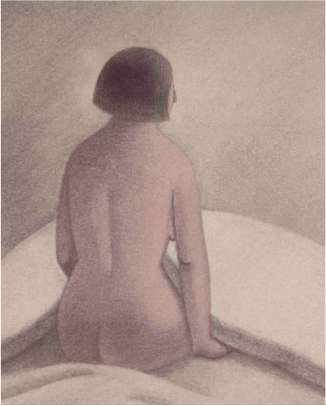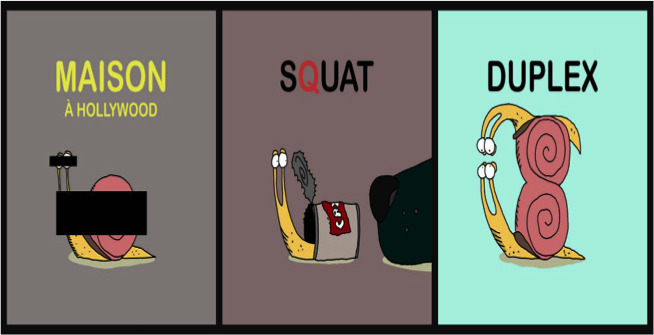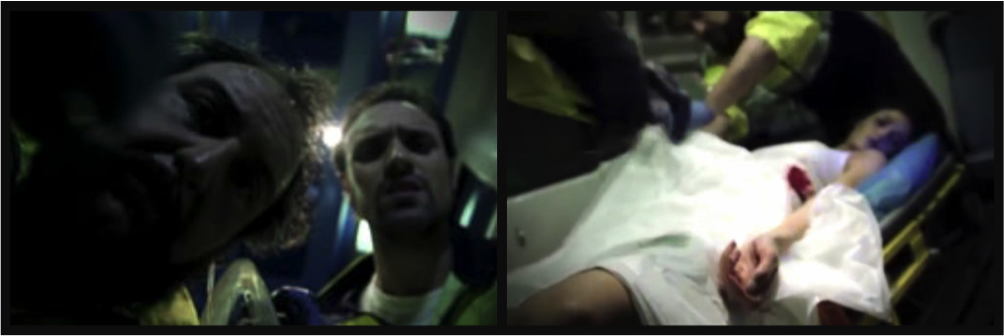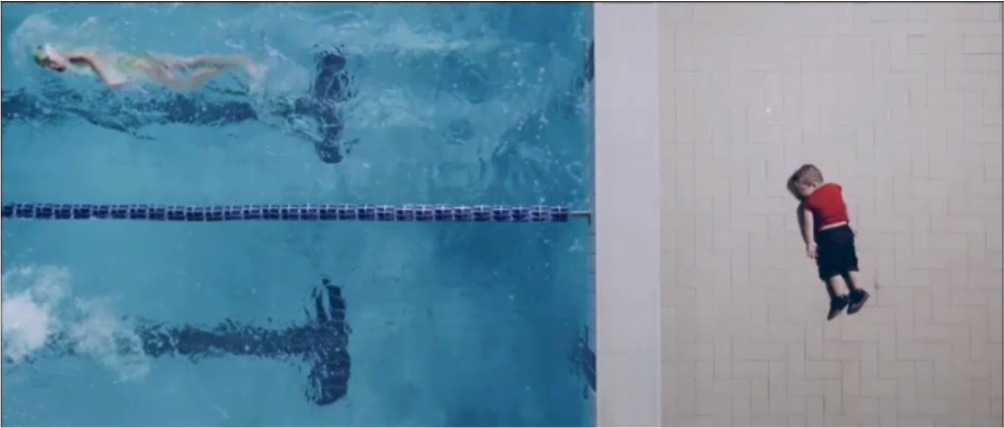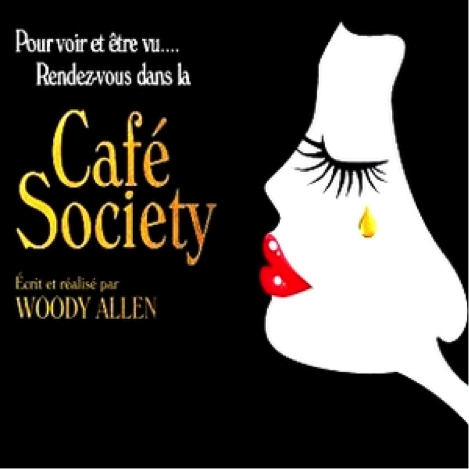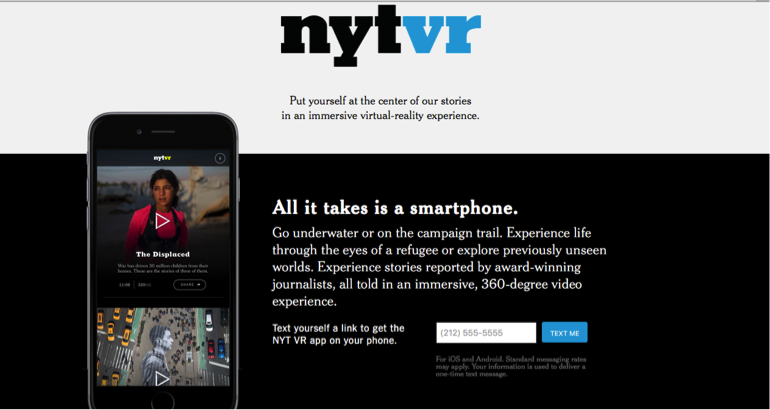Sabato 12 novembre 2016 Paolo Micalizzi, direttore di Carte di Cinema on line ha ricevuto a Cinecittà Studios (Sala Fellini) il “Premio Domenico Meccoli-ScriverediCinema”, destinato a quanti si sono distinti nell’arco dell’anno nel promuovere il Cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione, attribuito al “Magazine on.line di cinema” Carte di Cinema con la seguente motivazione: “Per l’efficacia di uno stile chiaro e rigoroso con il quale riesce a stabilire un dialogo proficuo con un pubblico vario ed eterogeneo quale quello del web”. Il Premio gli è stato consegnato dall’attore Enrico Lo Verso.
“È stato per me un onore ricevere il Premio Domenico Meccoli-Scriveredicinema, intitolato ad un grande critico che ho avuto il piacere di conoscere e frequentare in alcune occasioni importanti, una persona squisita, un gran Signore”.
Queste le dichiarazioni di Paolo Micalizzi, nel ricevere il Premio per il quale ho ringraziato la FEDIC, che lo edita, che gli ha dato fiducia nell’affidargli nel 2015, con il numero 4, la Direzione della Rivista on line. Ed ha ringraziato, oltre ai promotori del Premio ed alla Giuria, anche tutti i collaboratori, da chi cura la parte informatica ai colleghi che con il loro contributo danno prestigio alla Rivista, augurandosi, con la continuità della loro collaborazione, di poter raggiungere risultati sempre più positivi.
In relazione al conferimento del premio a Carte di Cinema on line il Presidente FEDIC Giorgio Ricci ha scritto per il numero 36 (ottobre 2016) di “nuovo FEDIC Notizie”:
Professionalità è la parola che mi è venuta in mente quando Paolo Micalizzi mi ha comunicato l’assegnazione a “Carte di Cinema” per il 2016 del premio “ Domenico Meccoli-ScriverediCinema” che è attribuito da una qualificata Giuria e nell’assegnarlo prende in considerazione la qualità delle opere che si sono distinte nello scrivere di Cinema. Indubbiamente a concorrere a rendere qualitativamente rilevante un’opera che viene edita on line concorrono diversi fattori ciascuno dei quali riveste una importanza rilevante. Senza uno di questi fattori è difficile che si possa ottenere un riconoscimento di questa portata. “Carte di Cinema” racchiude in sé l’eccellenza di questi fattori espressa da pochi uomini che hanno in comune l’amore per il Cinema, la capacità, serietà, rigore nell’agire, carattere e spirito professionale con l’aggiunta di un particolare non trascurabile: appartengono ad una Federazione che raggruppa ed unisce persone che sono motivate a stare insieme in un interesse comune che è quello di fare Cinema e poter dar sfogo alla necessità di comunicare attraverso le immagini. È uno spirito puro quello che li anima, privo di interessi personali che mette al servizio degli altri le proprie capacità insieme con il proprio tempo, proprio delle iniziative del volontariato… Credo quindi che sia motivo di orgoglio per tutti noi poter constatare che il team coordinato da Paolo Micalizzi all’interno della FEDIC abbia raggiunto una vetta così alta dando una dimostrazione che anche in una attività di volontariato si possono esprimere ad alto livello tante professionalità se coordinate con altrettanta professionalità. A nome mio ed a nome di tutta la FEDIC ringrazio e stringo la mano a tutto il team coordinato da Paolo Micalizzi pensando così di esprimere loro i sensi della nostra grande riconoscenza.
PREMIO MECCOLI – SCRIVERE DI CINEMA 2016: Il resoconto
di Paola Dei
Nella Sala Fellini degli spazi di Cinecittà Studios il 12 novembre 2016 si è svolta la XXXV edizione del Premio “Domenico Meccoli-Scrivere di Cinema”. Un appuntamento che l’Associazione Culturale Amarcord porta avanti con grande passione e che ha realizzato quest’anno in collaborazione con il Comune di Spoleto e il SNGCI per rappresentare tutti coloro che si adoperano per diffondere la cultura cinematografica nel mondo. Alle 10 si è svolto il Convegno “Tradizione e modernità: 8 e ½ incontra i protagonisti del nuovo cinema italiano” coordinato da Marco Spagnoli, con la partecipazione di attori e registi che ci hanno offerto la loro personale visione del cinema oggi e delle difficoltà incontrate. A presenziare la serata di chiusura in onore di Domenico Meccoli, illustre storico, critico, giornalista cinematografico e Direttore di importanti Festival Internazionali, è intervenuto per Primo Piano sull’Autore, Pasquale Squitieri, con la partecipazione di Claudia Cardinale, Ottavia Fusco Squitieri e le figlie del regista. La rassegna con il titolo: “Pasquale Squitieri- Il piacere della libertà” ha attraversato la vita e l’opera del Maestro che con un fuori programma ha modificato la scaletta attesa dai partecipanti ed ha fatto proiettare un documentario-monologo dedicato ad Edda Ciano e interpretato da Ottavia Fusco ed a seguire “L’Altro Adamo” con la partecipazione di Lino Capolicchio. Un pezzo di storia ed una storia surreale per raccontarci la vita, le paure, i sogni del regista partenopeo che ci aveva abituati ad altri generi. Il cineasta non ha però abbandonato tematiche a lui molto care come la giustizia, il potere nei suoi effetti positivi e negativi, la sfida, l’inganno, la solitudine, la libertà, pur declinandole in maniera diversa e a tratti caustica. Lui che da sempre ama sbatterci in faccia il suo pensiero usando tutte le armi a sua disposizione, non ha perso la propria energia neppure dopo aver combattuto contro un tumore al polmone. Accompagnato da Valerio Caprara, che ha condotto la serata fra momenti di grande intensità, il regista è stato salutato da amici, colleghi, critici e studiosi di cinema.
In un’atmosfera evocativa delle più belle immagini del Cinema Internazionale sono stati poi assegnati i Premi 2016.
Premio alla Carriera: Giorgio Gosetti
Premio speciale alla carriera per i 70 anni del SNGCI: Mario Di Francesco
Critico cinematografico: Paolo Mereghetti
Giornalista cinematografico per la televisione: Daniela Bisogni
Giornalista cinematografico: Stefano Stefanutto Rosa
Giornalista cinematografico Radio Pubblica: Franco Dassisti
Giornalista cinematografico Radio Privata: Luca Pellegrini
Periodico Specializzato: Mario Mazzetti per Vivilcinema
Magazine on-line: Paolo Micalizzi per Carte di Cinema
Libro sul Cinema di Autore Italiano: “Attraverso lo schermo – Film visti e film fatti”, di Corrado Farina
Opera prima: “Ho amici in paradiso” di Fabrizio Maria Cortese
Giornalista o testata emergente, in ricordo di Luca Svizzeretto (in collaborazione col SNGCI): Quinlan.it
Opera prima di contenuto civile o sociale, in ricordo di Carlo Tagliabue (assegnato dal CSC): La pelle dell’orso di Marco Segato
Inoltre sono stati insigniti di menzione speciale le seguenti monografie sui più grandi rappresentanti del cinema italiano:
“Lo specchio dipinto – Ettore Scola e dintorni” a cura di Paola Dei,
“I film di Aldo Fabrizi” di Enrico Lancia e Fabio Melelli,
“Gabriele Ferzetti” di Massimo Giraldi.
A conclusione della serata, Pasquale Squitieri, protagonista della rassegna, insieme a Claudia Cardinale, ha ricevuto dal sindaco di Spoleto Fabrizio Cardarelli e dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Spoleto, Camilla Laureti, la targa onorifica della città di Spoleto.
Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 4 INCONTRI
- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 6 FESTIVAL ED EVENTI
- 7 OCCHIO CRITICO a cura di Marco Incerti Zambelli, Tullio Masoni, Paolo Vecchi
- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 9 NEO-CINEMA a cura di Elio Girlanda
- 10 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
- 11 PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
- 12 CREDITS
ABSTRACT
LA NOUVELLE VAGUE: CONVINTI ACCORDI E VIOLENTI DISACCORDI di Marino Demata
Lo scritto parte dalla considerazione che la Nouvelle Vague non è un fenomeno isolato, ma ha dei corrispettivi in America, in Inghilterra, in Italia ed anche in altre parti del mondo. E non è un fenomeno semplicemente interno al cinema, ma trova le sue radici nelle profonde trasformazioni politiche e sociali della realtà di quel tempo nei vari Paesi. Il saggio si concentra essenzialmente su tre personaggi, Bazin, il teorico e saggista, Truffaut e Godard, due registi e due personalità agli antipodi tra i quali scoppia una violenta lite epistolare, forse la più violenta della storia del cinema. Il saggio si conclude con alcuni esempi di influenza della Nouvelle Vague nel cinema di oggi.
I SAMURAI DEL CINEMA NOIR-RIFLESSIONI SUL CINEMA E SUGLI EROI DI MICHAEL MANN di Riccardo Poma
Michael Mann è considerato uno dei maestri del cinema d’azione odierno. Nonostante sia considerato, a ragione, uno degli ultimi registi a fare un cinema orgogliosamente “di genere”, è indubbio che Mann abbia saputo concepire un percorso estremamente personale che lo ha reso a tutti gli effetti un autore, figura sempre più rara nel cinema di genere e soprattutto nel cinema poliziesco. Pur restando fortemente ancorato alla tradizione del poliziesco/noir americano, il cinema di Mann si colloca tuttavia molto più vicino a quello di cineasti europei ed asiatici come Melville, Woo, Kitano, il primo Kurosawa.
IL CERCHIO È CHIUSO, GOD BLESS MICHAEL! di Francesco Saverio Marzaduri
Un ritratto di Michael Cimino, il grande cineasta statunitense scomparso lo scorso luglio, che ripercorre una parabola artistica e umana costituita da trionfi clamorosi e da brucianti insuccessi, nei quali emerge lo sguardo senza tempo, toccante e profondo, di un’America di fronte alle proprie ferite.
RICHARD LESTER. A CIASCUNO IL SUO SUPERMAN di Roberto Lasagna
Il cinema di Superman realizzato da Richard Lester è un’occasione per ritornare ai primissimi anni Ottanta e ragionare sui macro-sistemi attraverso una parodia del fumetto, ovverosia di un mondo che siamo soliti veder tratteggiato come una comic strip. Il fumetto permette di sperimentare situazioni e di manipolare il reale affidandosi, nel caso specifico, alla base fantastica di un retroterra che l’appassionato del personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster difficilmente avrà dimenticato prima di andare al cinema.
OLIVER STONE E LA DIMENSIONE NARRATIVA di Paola Dei
Le opere di Oliver Stone sono caratterizzate da una continua ricerca della verità attraverso la quale il cineasta coniuga perfettamente gli aspetti storici e quelli creativi. Fra soluzioni registiche e una indubbia conoscenza della materia filmica azzarda, sperimenta, si diverte, cerca le motivazioni profonde degli accadimenti e l’essenza delle persone con il coraggio di chi dà del tu allo spettatore.
IL SENSO DI BROWNING PER IL DIVERSO di Giorgia Pizzirani
Anni Trenta. Nel circo di Madame Tetrallini si mescolano storie umane, troppo umane. L’attrazione principale sono loro, i freaks, che del circo sono i fenomeni veri, i fenomeni da baraccone: donne barbute e uomini focomelici, gemelle siamesi e nani, ermafroditi e cerebrolesi. Gruppo tanto unito da diventare famiglia. Si trasformeranno da innocui reietti della società a temibili vendicatori giusti e intransigenti quando uno di loro, il nano Hans, sarà ingannato dalla trapezista Cleopatra che mirava al suo patrimonio economico. Sarà proprio Cleopatra a subire la beffa suprema, e a scoprire – a caro prezzo – cosa significa essere freak, entrando definitivamente e irreparabilmente nella famiglia.
LA MANO DI TAROCCHI CHE NON SAI MAI GIOCARE: “KNIGHT OF CUPS” di Francesco Saverio Marzaduri
A quasi due anni dalla sua presentazione a Berlino, arriva nelle sale italiane “Knight of Cups”, il settimo lungometraggio di Terrence Malick, che insieme ai due precedenti lavori, “The Tree of Life” e “To the Wonder”, suggerisce un’ideale trilogia mistica. Rick è uno schiavo del sistema hollywoodiano che, assuefatto al successo, allo stesso tempo si dispera per il vuoto della propria esistenza. A suo agio nel mondo delle illusioni, è alla ricerca della vita vera. Al pari del Cavaliere di Coppe dei tarocchi, l’uomo si annoia facilmente e ha bisogno di stimoli esterni, perseguendo la propria natura di artista, romantico e avventuriero.
L’OCCHIO (E LA MEMORIA) DI ELSA PHARAON di Marina Ruiz
Focus sul ruolo di Casting director, il responsabile della scelta degli attori.
SEDICICORTO INTERNATIONAL FILMFESTIVAL 2016
Quattro articoli relativi allo svolgimento del “SediciCorto” di Forlì, tra cui le recensioni dei CORTIinLOCO
MISFF 67th MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
Iniziative e recensioni di cortometraggi in concorso e Vetrina FEDIC relative al MISFF 67
73 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
Resoconto panoramico della Mostra e dei “Classici” proiettati nell’edizione 2016
AMERICAN JEWS di Marco Incerti Zambelli
La cultura ebraica, sempre centrale nel mondo statunitense, è il cuore della ambiziosa rilettura di “Pastorale Americana” dell’esordiente, alla regia, Ewan McGregor e di “Cafè Society”, quarantasettesimo film, per la prima volta in digitale, di Woody Allen.
“SULLY”, OVVERO: DISUBBIDIENZA E SAGGEZZA di Tullio Masoni
L’impresa, realmente compiuta, di un ex-pilota militare che in 200 secondi decide di ammarare – inverno 2009 – nelle acque dell’Hudson, salvando 155 persone. Un nuovo eroe dell’individualismo eastwoodiano, che si scontra con la freddezza dei regolamenti.
DUE NOBEL: “NERUDA” DI PABLO LARRAIN; “EL CIUDADANO ILUSTRE” DI GASTON DUPRAT, MARIANO COHN di Paolo Vecchi
Due Nobel, uno reale e l’altro immaginario. “Neruda” racconta la latitanza del poeta cileno, ricercato con accanimento da un commissario della polizia politica; “El ciudadano ilustre” descrive il poco felice ritorno al paese natìo dello scrittore argentino Daniel Mantovani, fresco reduce da Stoccolma, dove ha ricevuto il prestigioso riconoscimento.
”FUOCOAMMARE” E L’ESTETICA DEL SELFIE di Marcello Cella
Una riflessione su “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi e sull’estetica del selfie dominante nel mondo attuale dei media.
CAMERE SFERICHE E NUOVO RACCONTO di Elio Girlanda
Si torna a parlare di “camere sferiche” ovvero di microcamere di ripresa immersiva a 360° sia perché il mercato offre nuovi dispositivi sia perché si moltiplica la produzione di corti d’autore, disponibili online. Ma quali sono le conseguenze sul piano estetico e creativo? E come cambierà il racconto nel futuro?
TIMELESS (USA/2016) di Luisa Ceretto
Giunge sugli schermi della Fox “Timeless”, la nuova serie sui viaggi nel tempo, forse con qualche naiveté, eppure efficace e non priva di fascino.
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
Segnalazione-recensione di libri relativi a Lattuada, Calopresti, Fleischer e allo “Schermo immaginario”.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
LA NOUVELLE VAGUE: CONVINTI ACCORDI E VIOLENTI DISACCORDI
di Marino Demata
Premessa
In questo breve saggio sulla “Nouvelle Vague” ho scelto di parlare innanzitutto della “Sincronia perfetta” tra il movimento che nasce e si sviluppa in Francia e analoghe correnti o autori in altri Paesi. A tal proposito qualche critico anglo-sassone ha usato il plurale per unificare i movimenti (traducendo letteralmente il termine Nouvelle Vague/Nuova Onda) con l’espressione New Waves.
Segue un inquadramento storico che ho reputato necessario, partendo dalla premessa che le New Waves non possono essere considerate fatti cinematografici avulsi dalla realtà politica e sociale del tempo.
Come autori mi sono limitato a considerare soltanto lo “scrittore di cinema” (come amava chiamarsi) Bazin, e i registi Truffaut e Godard, soffermandomi poi sulla furibonda e singolare lite fra i due personaggi.
Mi sembrava infine doveroso concludere con un accenno alla influenza della Nouvelle Vague, che ancora oggi è presente in tantissimi autori e film, illustrando qualche esempio che ritengo veramente illuminante.
Mi rendo conto che restano fuori da questa illustrazione della Nouvelle Vague grandissimi registi come Alain Resnais, Claude Chabrol, Luis Malle, Jacques Rivette, Eric Rohmer ed altri ancora. Mi scuso per questa notevole omissione, ma la dimensione che doveva avere questo Saggio non consentiva una sia pur breve, ma almeno dignitosa, esposizione di quelle grandi personalità. Mi riservo nel caso di intervenire successivamente per colmare tali vistose lacune,
Coutard
Durante la stesura di queste note è morto Raoul Coutard, celebre direttore della fotografia del periodo della Nouvelle Vague, prediletto da alcuni dei più importanti registi del movimento. Godard lo ha voluto per il suo film d’esordio, “Fino all’ultimo respiro” e Truffaut per uno dei suoi capolavori in bianco e nero, “Jules et Jim”.
Quella di Coutard è in certo senso una morte emblematica, perché è un degli ultimi tasselli della Nouvelle Vague che viene meno.
Questo non significa però che la Nouvelle Vague sia un movimento a sua volta morto, perché chi voglia ritrovare novità rivoluzionarie nella storia del cinema, chi ama l’anticonformismo, la ribellione contro le regole, nella vita come nel cinema e nella sue strutture, deve necessariamente avere quel movimento come punto di riferimento. E inoltre non è morto perché continua ad ispirare tanti autori ancora oggi, come vedremo più avanti.
Una sincronia perfetta
Nel 1959 un giovane regista americano, John Cassavetes, dopo avere con grande passione filmato una serie di interviste e di colloqui per strada con giovani di New York, matura l’idea di fare di quel materiale la base su cui costruire un film. Nasce “Shadow”(”Ombre”), come pellicola di assoluta rivoluzione e rottura all’interno del cinema americano. Si tratta di un film “professionale”, ma indipendente al tempo stesso, capace di esprimere genuine e non artefatte emozioni e soprattutto capace di lanciare un messaggio al mondo intero che cioè Hollywood non poteva più essere considerato l’unico cinema americano. A New York Cassavetes diventa l’antesignano di un nuovo modo di fare cinema: gira in 16 mm, budget bassissimo, attori non professionisti, scenografie reali e non realizzate in maniera artefatta negli studios, cinema inteso come lavoro di equipe, camera che pedina letteralmente i personaggi. Forma una scuola, l’Actor’s Studio Workshop e considera “Shadows” come lavoro collettivo della sua scuola. Ma più in generate si forma una vera e propria corrente newyorkese di cinema (di cui farà parte anche il regista Jonas Mekas), di rottura con i “canoni “ hollywoodiani.
Poco dopo in Inghilterra nasce qualcosa di simile: il cosidetto “Free Cinema”. Il più duro dei cineasti di quel movimento fu senza dubbio Tony Richardson, che, grazie all’aiuto di un direttore della fotografia dello spessore di Walter Lasally, con la sua capacità di confezionare immagini contrastate e fortemente realistiche, diventa uno dei grandi innovatori del cinema britannico. In verità già Karel Reisz e Lindsay Anderson nel 1956 avevano già presentato pubblicamente il “Free cinema”, inteso come cinema militante e strumento di lotta per una società diversa, ponendo al primo posto nei loro film il tema del grande disagio sociale che vive l’Inghilterra in quegli anni accompagnati alla contestazione e alla rabbia.
Nel 1959 vengono presentati al Festival di Cannes due film diversi fra loro ma parimenti fortemente innovativi: “Hiroshima mon amour” di A. Resnais e “Les quatre cents coups “ di F. Truffaut. Anche in questi casi il messaggio che veniva lanciato era di forte polemica nei confronti del cinema tradizionale, quello per intenderci girato negli studios, che seguiva schemi e canoni in qualche modo prefissati, sui quali ritorneremo più avanti.
Pochi mesi dopo quel festival di Cannes, Michelangelo Antonioni, dopo esperienze cinematografiche che lasciavano più che intravvedere volontà e capacità innovative, sceglieva, rispetto alla comodità degli studi di Cinecittà’, la ‘scomodità’” di un’isola sperduta, Lisca Bianca, una delle più piccole delle Eolie, poco più che uno scoglio, per affrontare le “avventurose” riprese de “L’avventura”. Naturalmente non si trattava solo di una scelta di location, ma di qualcosa di molto più profondo. “L’avventura infatti ribalta completamente le cosiddette “regole” tradizionali del fare cinema e dei generi, capovolgendo completamente i canoni tradizionali della struttura narrativa, de-strutturando il racconto e talvolta addirittura rovesciandolo come un guanto. Il film presenta nella prima parte un evento misterioso: uno dei membri della comitiva che aveva organizzato la gita alle Eolie scompare nella piccola isola, Lisca Bianca, appunto. Sembra un mistero assoluto. Solo congetture: nessuno riesce a capire come Anna sia potuta svanire nel nulla e perché. Ebbene il film in luogo di presentarci un accumulo di dati che facciano concentrare lo spettatore sulla possibile soluzione del mistero (come ogni altro regista avrebbe fatto fino a quel momento)), lascia al contrario decantare lentamente il mistero, scaricare la tensione, fino al punto che ciascun personaggio finirà col convivere con esso senza più preoccuparsi della sua soluzione, anzi finendo col trovare perfino “imbarazzante” una possibile soluzione.
Tentando di unificare (con l’ovvio rischio di semplificazioni e schematizzazioni), si potrebbe dire che sul banco degli imputati, per i giovani ribelli, Cassavetes, Richardson, Truffaut e Antonioni c’era il cosiddetto “film perfetto”, lo stereotipo del film che riproduce in un certo senso lo schema del teatro classico: un primo momento (il primo atto nel teatro classico) in cui si presentano al pubblico i personaggi in atteggiamenti e incontri che facciano capire le loro personalità e assieme si presentano gli ambienti in cui si svolge la storia e le problematiche da cui nascono poi gli intrecci della trama. In un secondo momento (il secondo atto) viene presentato l’intreccio della storia nella sua complessità e gli incontri/scontri drammatici tra i personaggi. In un terzo e finale momento (terzo atto) abbiamo di solito lo scioglimento dei nodi della vicenda, la soluzione dei passaggi più intricati, e generalmente il lieto fine. Il tutto girato negli ambienti artificiosi degli ‘studios.
I mutamenti politici
Il cambiamento rispetto al cinema classico da parte delle suddette nuove correnti fu così radicale e impetuoso e così simultaneo in tanti Paesi e realtà diverse, che non può essere spiegato, come invece alcuni fanno, come un movimento tutto interno al cinema stesso e che trova le sue origini e le sue ragioni esclusivamente nella voglia, nata quasi simultaneamente in parti così diverse del mondo, di fare un cinema diverso. La verità invece è che in quegli anni andavano maturando profondi mutamenti sulla scena politica di ognuno dei Paesi citati (basti pensare negli Stati Uniti al successo di Fidel Castro a Cuba nel 1959 e allo svilupparsi della guerra del Vietnam).
Per focalizzarci sulla Francia, ove nacque e si sviluppò la Nouvelle Vague, il più vasto e duraturo tra i movimenti sopra accennati, non si può non ricordare cosa ha significato nell’immaginario popolare la guerra d’Algeria, malgrado l’oscurità nella quale veniva tenuta in gran parte l’opinione pubblica da un pesante atteggiamento censorio delle autorità. Lo stesso Partito Comunista Francese, ideologicamente portatore di una politica anti-coloniale, fu esitante e in qualche caso isolato. Il ritorno sulla scena del Generale De Gaulle nel 1958, se da un lato portò a successi sul piano militare, portò anche alla prefigurazione di soluzioni politiche che non escludevano i principi dell’autodeterminazione. L’Algeria raggiunse l’indipendenza e quindi la definitiva separazione dalla Francia nel 1962. Dunque gli anni nei quali cominciò a svilupparsi la Nouvelle Vague, furono anche anni di grande trepidazione per i francesi, che vedevano i loro giovani spediti a combattere una guerra che molti sentivano destinata ad essere perduta.
Impossibile che un tale scenario non avesse una profonda influenza e reazione nel pensiero di tanti intellettuali. Vanno ricordate due circostanze: il manifesto degli intellettuali contro la guerra d’Algeria, che fu firmato senza esitazioni da Alain Resnais e Chris Marker e il fatto che una parte consistente degli intellettuali era orientata verso idee decisamente di sinistra.
Andrè Bazin e Jacques Doniol-Valcroze, i fondatori di quella che sarà la più importante rivista di cinema negli anni ’50 e ’60, “Les Cahiers du cinèma”, erano decisamente di sinistra. E proprio dall’interno dei “Cahiers” emergeranno, dopo un lungo apprendistato fatto di articoli e recensioni, i più importanti registi della Nouvelle Vague.
Bazin non ha scritto un’opera specifica di estetica cinematografica, e tuttavia la sua concezione sul cinema è facilmente rintracciabile nella miriade di articoli, saggi e recensioni che ha scritto e che furono raccolti e ordinati da lui stesso nei quattro volumi dal titolo complessivo “Cos’è il cinema?” In essi troviamo chiaramente espressa la concezione che il cinema deve necessariamente interessarsi della realtà e investigarla. Il cinema diviene dunque per lui “un’investigazione sull’Essere attraverso la vita e captato, rivelato, dall’occhio della cinepresa per esaltare ciò che Godard chiamerà Lo splendore del vero.”(1)
A partire da queste affermazioni molte sono le conseguenze teoriche e pratiche che scaturiscono. Per brevità ci fermiamo solo su due di esse:
1 – L’amore per il piano sequenza. Il montaggio per Bazin rappresenta la frammentazione del cinema e quindi l’infedeltà alla realtà. Un film ove prevale il montaggio è un film che tradisce la realtà, che la frantuma, la seziona in pezzi che poi vengono incollati in una sequenza di immagini che costituiscono una realtà fittizia. Il piano-sequenza invece riproduce la realtà così come è in un dato momento e in un dato spazio, senza stacchi e senza artificiose eliminazioni di parti di realtà. Esemplare per lui, sotto questo riguardo, è “La terra trema” di Visconti, perché è un film “composto quasi esclusivamente di piani sequenza, ove la preoccupazione di abbracciare la totalità dell’avvenimento viene tradotta nella profondità di campo e in interminabili panoramiche”(2)
2 – La grande ammirazione per il neo-realismo e soprattutto per Roberto Rossellini, sul quale pubblicherà un famoso articolo sul numero 65 del 1955 di “Cinema nuovo”, difendendo dai detrattori soprattutto italiani film come “Europa 51” e “Viaggio in Italia”, ove si manifesta un “realismo di anima e coscienza” , e cioè il suo neo-realismo come “conoscenza globale della realtà”.
Bazin ha esposto inoltre la sua famosa teoria detta “politique des auteurs”, in base alla quale il regista viene considerato “un autore, quando, come lo scrittore, riesce ad infondere nell’opera la sua personalità artistica, anche se alla costruzione del film partecipano molti coautori e un grande spiegamento di mezzi tecnici.” (3)
Bazin morì giovanissimo, a soli 40 anni, nel 1958, e quindi non riuscì a vedere il grande sviluppo che avrebbero avuto le sue idee attraverso i film di registi che avevano collaborato con lui ai “Cahiers” o che ne avevano subito il fascino e l’influenza. Ma non è mai stata messa in dubbio la sua influenza, pur nella reciproca diversità dei registi che a lui si richiamano e che costituiscono il mondo della Nouvelle Vague.
Uno di questi è Francois Truffaut, che nel 1983, cioè 25 anni dopo la sua morte scrive la prefazione al libro di Dudley Andrew “Andrè Bazin”, intitolata “Bazin ci manca”. Si tratta di un lucido e a un tempo affettuoso omaggio al suo maestro, senza alcuna retorica, che è sempre in agguato in occasioni come questa.
Di Bazin Truffaut ricorda innanzitutto la grande onestà intellettuale che lo porta a rivedere i sui stessi giudizi su alcuni film e alcuni autori. Per alcuni si è trattato forse di incoerenza, ma per Truffaut questo ritornare sui propri giudizi è indice innanzitutto di grande onestà e personalità. Un modo di rivedere le sue idee su un film soprattutto in occasione di una seconda visione o di una rimeditazione alla luce di nuovi elementi e riconsiderazioni.
Truffaut giudicava Bazin un “cattolico di sinistra”. Cosa voleva intendere con questa espressione? Eco quello che dice: “Bazin era un intellettuale cattolico di sinistra, e nessuno di quelli che l’hanno conosciuto potrebbe contestare il perenne accordo che riusciva a creare tra i suoi pensieri e le sue azioni. Quando partiva in viaggio con Janine e telefonava agli amici che avevano problemi di alloggio per prestargli la casa, quando a Vincennes fermava la macchina per far salire tre persone che aspettavano l’autobus sotto la pioggia e portarle fino a Parigi, era il Bazin cattolico o il Bazin di sinistra? Non lo so, era Bazin, ma a volte mi dico che due buone ragioni per credere all’uguaglianza degli uomini valgono più di una.” (4)
François Truffaut
Una disamina di alcuni registi della Nouvelle Vague non può non cominciare da Truffaut, soprattutto dopo che si è parlato di Andrè Bazin, che lo ha quasi adottato durante il periodo dell’adolescenza non proprio felice, in parte descritto autobiograficamente nel suo capolavoro “I quattrocento colpi”. Ma a parte la riconoscenza, è indubbia anche l’influenza che Bazin esercitò su Truffaut. Molti degli aspetti che sopra abbiamo cercato di illustrare del grande critico, sono presenti anche in lui.
Tra i tanti citiamo l’ammirazione per Roberto Rossellini. Tra l’altro non mi sembra un caso che Truffaut affermi che Rossellini e Bazin sono le persone più intelligenti mai conosciute!
Truffaut riconobbe sempre come sua grande fortuna quella di essere stato “adottato” da Bazin e poi di aver trascorso circa tre anni in compagnia quotidiana di Rossellini, come assistente, autista e allievo, dal quale ha appreso che non si inizia un film con una scena messa prima dei titoli di testa, che occorre demistificare la macchina da presa, che non ha importanza superiore a quella che può avere una forchetta, che occorre concentrarsi sempre su un personaggio e seguirlo minuziosamente. Ma soprattutto l’influenza di Rossellini su di lui e sull’intero movimento della Nouvelle Vague si manifesta nei giudizi sul cinema americano, fino ad allora ammirato dai “Cahiers”. Certo Rossellini aveva anche dei motivi personali di vero e proprio astio verso l’America; in ogni caso i giudizi molto positivi verso quel cinema sembravano esagerati e comunque influenzati da una critica molto forte nei confronti del cinema classico francese. Dopo Rossellini la Nouvelle Vague corresse il tiro nei confronti di quella cinematografia anche se in modo, logicamente non uniforme. Lo stesso Truffaut, da giornalista, fece una severa selezione degli autori americani e tra questi un posto di rilievo per lui aveva Hitchcock, bistrattato in patria e ammirato invece in Europa e soprattutto in Francia.
L’ammirazione per il regista americano lo portò a costruire la famosa lunga intervista del 1962 realizzata a Los Angeles, che poi divenne il capolavoro in assoluto della letteratura cinematografica: “Il cinema secondo Hitchcock”, ovvero la cronaca registrata del colloqui tra i due registi, arricchita dalle numerose lettere che successivamente si sono scambiati.
E alcuni aspetti positivi che Truffaut riconosce ad Hitchcock sono anche la prova del ridimensionamento dell’intero cinema americano operato dalla Nouvelle Vague, a seguito della lezione di Rossellini. Infatti nell’introduzione a “Il cinema secondo Hitchcock”, Truffaut afferma che Hitchcock era così radicato nel cinema muto, che anche col sonoro “si trova ad essere praticamente l’unico a filmare direttamente, cioè senza ricorrere al dialogo esplicativo, dei sentimenti come il sospetto, la gelosia, il desiderio, l’invidia”. Lasciando al dialogo il solo compito di esprimere i pensieri dei personaggi. E su questo versante, per Truffaut, il cinema americano, dopo l’avvento del sonoro, “non ha prodotto la nascita di nessun grande temperamento visivo, ad eccezione di Orson Welles”. Il che significa un giudizio molto negativo sul cinema americano, incapace di valorizzare la lezione sulla visività esclusiva del “muto”.
Truffaut ha cercato di valorizzare gli insegnamenti di Bazin, di Rossellini, di Hitchcock, di Orson Welles e di Renoir, per citare solo alcuni degli autori da lui più ammirati, nei suoi film. Abbiamo posto Bazin al primo posto perché a Bazin deve molto sul piano umano e su quello delle concezioni filosofico-cinematografiche. E di Truffaut tutto potemmo dire, tranne che non sappia cosa è la riconoscenza. Ad Andrè Bazin e a nessun altro Truffaut dedica il suo primo capolavoro, “I quattrocento colpi”!
Potremmo per comodità suddividere la sua filmografia in due parti: film tratti da romanzi e film i cui soggetti sono integralmente creati dal regista. Sì perché una delle caratteristiche di Truffaut è avere spesso come riferimento dei romanzi come soggetti o fonte di ispirazione dei suoi film. Per inciso la cosa non piaceva affatto a Godard e questo fu solo uno degli elementi di frizione fra i due. A Truffaut invece sembrava del tutto naturale trasformare un romanzo in film: ricordiamo che Truffaut era un grande lettore e amante di romanzi. Uno dei suoi motti era “vedere un film al giorno e leggere un romanzo a settimana.” E quando leggeva un romanzo provava ad immaginarne la possibile resa nella trasformazione in film.
Nascono così alcuni capolavori dai suoi autori preferiti: innanzitutto Henri-Pierre Roché (“Jules et Jim”, uno dei suoi film capolavoro e poi anche “Le due inglesi” tratto dal romanzo “Le due inglesi e il continente”), poi Cornell Woolrich sotto lo pseudonimo di William Irish (due film: “La sposa in nero” e “La sirene du Mississippi”), David Guddis (“Tirate sul pianista”) e Charles Williams (“Finalmente domenica”) e ancora Ray Bradbury (“Fahrenheit 451”) e Henry James (“La camera verde”). Aggiungiamo in questa categoria anche “Adele H”, tratto dai diari di Adele, figlia del grande Victor Hugo e “Il ragazzo selvaggio”, tratto dalle memorie del medico e pedagogista Jean M.C.Itard.
Dunque quasi la metà dei film realizzati da Truffaut ha una matrice letteraria, il che è una prova sufficiente per il suo amore per la letteratura e per la lettura, secondo solo a quello per il cinema.
Alcuni preferiscono però i film creati integralmente da Truffaut, a partire da “I quattrocento colpi” e l’intera serie dedicata all’infanzia e poi agli amori del suo alter ego Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud:), e i film de l’amour fou, come “La signora della porta accanto”.
Ma non si può dimenticare, in queste brevi note, il Truffaut attore, diretto da se stesso (“Effetto notte”, “Il ragazzo selvaggio”, “La camera verde”) o diretto da altri registi, come Spielberg, che una volta tanto ebbe una felicissima intuizione: assegnargli un ruolo fondamentale in “Incontri ravvicinati del terzo tipo” del 1977.
Tra le caratteristiche più significative del cinema di François Truffaut ricordiamo il modo veramente delicato e ricco di rispetto col quale tratta i problemi dell’infanzia ne “I quattrocento colpi” ma anche ne “Il ragazzo selvaggio”. Una caratteristica che gli deriva innanzitutto dalla sua esperienza personale di infanzia infelice, per essere stato sostanzialmente non compreso dai suoi genitori. Ma anche dalla lezione cinematografica rosselliniana. Truffaut infatti dichiarò di aver ammirato moltissimo il modo col quale Rossellini disegna il personaggio del bambino in “Germania anno zero” e afferma che se il personaggio di Antoine Doinel è riuscito ne “I quattrocento colpi” in quel modo che tutti i critici hanno ammirato, il merito va unicamente a Rossellini che gli ha dato un grande esempio di come trattare l’infanzia in un film.
Jean-Luc Godard
L’altro personaggio di spicco nella Nouvelle Vague è Godard, che è stato recentemente definito il più importante e rivoluzionario regista degli ultimi 50 anni. (5) La sua giovinezza, proprio come l’infanzia di Truffaut, è caratterizzata da aspri dissidi con la propria famiglia.
Nel 1951 diventa collaboratore occasionale dei “Cahiers du cinema” e scrive alcuni articoli con lo pseudonimo di Hans Lucas, tra i quali ricordiamo la recensione di “Strangers on a train”/”Delitto per delitto” di Hitchcock, a dimostrazione di come il regista americano fosse amato dall’intero schieramento della Nouvelle Vague, e un articolo sulla difesa della costruzione filmica classica, nel quale prende le distanze per la prima volta da Bazin.
Dopo tre anni di assenza da Parigi, ritorna armato da grande entusiasmo, e riprende l’abitudine, già sperimentata prima, di esprimere giudizi precipitosi e assoluti, come quando definisce Gerard Philipe un pessimo e noioso attore, o quando paragona “India” di Roberto Rossellini alla nascita del mondo, o quando annuncia che “il cinema è Nicolas Ray e per converso Nicolas Ray è l’intero cinema, niente altro che il cinema”. Importante è l’articolo “Montage “, nel quale pur riconoscendo la validità della teoria di Bazin sulla necessità per il cinema di ancorarsi alla realtà, ritiene però che il regista debba strategicamente intervenire attraverso il montaggio, per sottolineare le parti più significative della stessa realtà e per esplicitare la verità.
La prima vera applicazione di questa teoria è “A’ bout de souffle” (”Fino all’ultimo respiro”), in cui Godard si avvale della essenziale collaborazione del Direttore della fotografia Raoul Coutard nel compito non facile di filmare, tra le prime volte in assoluto, in location naturali e sostanzialmente per strada.
Ne viene fuori un film che ha vistosi difetti tecnici ai quali Godard cerca di ovviare in quella che oggi chiameremmo “fase di post-produzione”. Riuscendovi in gran parte, bisogna dire.
Fatto sta che il film risulta uno dei capolavori indiscussi della Nouvelle Vague, un film ove nessuna sequenza è superflua o riempitiva, perché esso va diritto all’obiettivo come una freccia che raggiunge direttamente il suo bersaglio. Felicissima anche la scelta di due protagonisti: Jean Paul Belmondo è semplicemente strepitoso in una interpretazione quasi irripetibile. E Jean Seberg non è da meno.
Godard finì questo film, che fu un grande successo anche al botteghino, con una serie di ulteriori convinzioni su come correggere alcuni inconvenienti che il suo modo di fare cinema da strada e per strada gli avevano procurato. Per prima cosa comprese la necessità di avere un monitor costantemente acceso durante le riprese. Poi realizzò che il film è una impresa e come tale aveva bisogno di collaboratori fissi e di valore. Ingaggiò pertanto una editor di grande spessore come Suzanne Schiffman, amica e già collaboratrice di Truffaut. E soprattutto comprese – estremo strappo dalle teorie di Bazin – che il cinema era merce, era un insieme di cose, di elementi. Il cinema per lui ormai non è più il mondo che magicamente appare e si rispecchia sullo schermo in forma di immagini e neppure una simulazione della realtà. Il cinema è fatto di tante cose, tanti pezzi, fondamentalmente il cinema è celluloide e nastro magnetico sui quali le cose della realtà hanno lasciato le loro impronte, ma che hanno bisogno di essere coordinate e organizzate nel modo che il regista ritiene più appropriato per le finalità dl racconto cinematografico. Delle teorie di Bazin resta però in lui la ferma convinzione che la realtà che lascia le proprie impronte sulla pellicola è quella del mondo reale, naturale, della strada e non quella costruita negli studios o peggio attraverso effetti speciali.
Godard rimase sempre fedele a questi principi e dunque la grande importanza di “A’ bout de souffle” non consiste solo nello straordinario film in sé, ma nell’essere stata l’occasione per mettere definitivamente a punto le nuove tecniche e le teorie sul cinema alle quali non abdicherà mai.
Sicuro di queste conquiste ottenute col suo primo film Godard divenne un lavoratore instancabile della macchina da presa. Cominciò a realizzare film a ripetizione, mantenendosi sempre su ottimi livelli, fino a periodi nei quali riuscì a girare quattro film all’anno, sorretto anche da una ferma ideologia marxiana, attraverso la quale trovava lo spunto anche per storie che avevano per protagonisti “eroi” e “eroine” della classe oppressa (è il caso ad esempio di “Due o tre cose che so di lei” e di “Vivre sa vie” ove il tema centrale,la prostituzione, è la trasparente metafora dell’oppressione e dello sfruttamento capitalista). Questo non gli impedì di spaziare su altri “generi” (ma forse il termine nel caso di Godard è veramente improprio), e realizzare altri film destinati a divenire “culto”, come “Pierrot le fou”, interpretato dalla sua musa, Anna Karina e Jean Paul Belmondo.
La lite Truffaut – Godard
La violenta discussione, che per fortuna rimase su un piano strettamente epistolare, tra i due massimi esponenti della Nouvelle Vague, fu sicuramente uno dei fatti più sconcertanti e singolari della storia del cinema. E dico “storia del cinema” perché di questo si tratta: del mondo del cinema e delle opinioni che ruotano attorno ad esse. Certo molta parte della virulenza delle accuse reciproche è data dai caratteri così diversi dei due personaggi. Truffaut era più pacato e riflessivo, eppure nella sua lettera viene come preso per i capelli in una polemica inusitatamente per lui assai virulenta, cadendo anche in alcune provocazioni tese dall’avversario. Godard era a quei tempi un impulsivo ed esprimeva, come abbiamo visto in precedenza, giudizi tagliati con l’accetta, dicendo diritto quello che pensava, senza ombra di mediazione né tanto meno di diplomazia.
Fu lui ad iniziare con la lettera del maggio 1973. Fin dall’inizio Godard apre le ostilità che subito diventano insulti: “Ho visto ieri “Effetto notte”. Probabilmente nessuno ti dirà che sei un bugiardo, così lo faccio io. Non è affatto un insulto fascista, è una critica.” Come motiva Godard questa dura affermazione iniziale? “Sei un bugiardo, perché la tua inquadratura con Jacqueline Bisset, da Francis, l’altra sera, nel film non ci sarà, e ci si chiede come mai il regista sia l’unico che non scopa in “Effetto notte” (come è noto, la parte del regista in “Effetto notte”, film su un film che si sta girando, è auto-assegnata allo stesso Truffaut).
Godard comunica quindi di stare lavorando attorno ad un film intitolato “Un simple film”, con l’intenzione di far vedere tutti quelli che lavorano attorno ad un film, dunque non solo gli attori, ma anche la “manovalanza”, i proletari del cinema.
Infine Godard si lamenta del fatto che finanziamenti che erano stati destinati al suo film siano stati dirottati sul film di Ferreri, “La grande abbuffata”,lasciandolo praticamente a secco. Di qui una proposta che ha il suono di una provocazione: “Il film costa circa 20 milioni…. Puoi entrare in coproduzione per 10 milioni? per 5 milioni? Visto Effetto notte, dovresti aiutarmi, perché gli spettatori non credano che i film si fanno solo come i tuoi…
Se vuoi parlarne, d’accordo.” Firmato Jean-Luc.
No, Truffaut non ci pensa neppure a parlane. Ma scrive una lettera molto più lunga, piena di violenti insulti fin dall’inizio: “Jean-Luc. Per non costringerti a leggere fino in fondo questa lettera sgradevole, vado subito al sodo: non entrerò in coproduzione nel tuo film.
In secondo luogo ti restituisco la lettera che hai mandato a Jean-Pierre Léaud: l’ho letta e la trovo disgustosa. È per questo che sento arrivata l’ora di dirti, a lungo, che secondo me tu ti comporti come una merda.”
In realtà Jean-Pierre Leaud, l’attore/alter ego di Truffaut da “I quattrocento colpi” in poi per la serie di Antoine Doinel, aveva lavorato anche con Godard, al quale Truffaut rimprovera poco tatto nel trattarlo come attore per giunta mal pagato. E inoltre “Non ho mai formulato la minima riserva nei tuoi confronti davanti a Jean-Pierre che ti ammirava tanto, ma so che tu gli hai buttato lì più di una volta delle porcate sul mio conto, come se uno dicesse a un ragazzo: “E allora, tuo padre, trinca sempre di gusto?”.
E circa la critica di Godard al film “Effetto notte” ecco la piccata risposta: “Me ne strasbatto di quel che pensi di “Effetto notte”, quel che trovo penoso da parte tua è il fatto di andare, ancora oggi, a vedere un film come quello, film di cui conosci in anticipo il contenuto che non corrisponde né alla tua idea del cinema né alla tua idea di vita.”
La lettera di Truffaut prosegue ancora a lungo sulla medesima lunghezza d’onda. In breve Truffaut rimprovera al suo ex amico una odiosa doppiezza nei comportamenti e una sostanziale supponenza elitaria verso chi non la pensa come lui, che contraddice le sue idee politiche. Lo definisce più volte “dandy”: “Vendi fumo. Dandy. Sei sempre stato un dandy, come quando mandavi un telegramma a De Gaulle per la sua prostata…”
E dopo una serie di altri improperi sul rapporto di Godard con le sue attrici (“Hai fatto girare in “Les Carabiniers” Catherine Ribeiro che ti avevo mandato io, e poi ti sei buttato addosso a lei come Charlot sulla sua segretaria ne “Il Grande Dittatore””), la lettera vira più apertamente sulla parte politica: “Oggi sei forte, ti si crede forte, non sei più l’innamorato che soffre, tu sei in possesso della verità sulla vita, la politica, l’impegno, il cinema, l’amore, è tutto molto chiaro per te e chiunque la pensi in modo differente è un porco, anche se tu stesso non pensi in giugno la stessa cosa che in aprile.”
E c’è un episodio, a proposito della politica, che sembra non essere andato giù a Truffaut: fu chiesto a personalità di sinistra dello spettacolo di scendere per le strade e distribuire un giornalino intitolato “La cause du people”. Truffaut lo distribuì (e ne abbiamo le foto), Godard no.
E per finire questa lunghissima lettera di risposta arriviamo all’ironia: “Tu sei come Ursula Andress, un’apparizione di quattro minuti, il tempo di far scatenare i flash, due o tre frasi a sorpresa e via, di ritorno a un comodo mistero. Dalla parte opposta rispetto a te, ci sono i piccoli uomini, da Bazin a Edmond Maire, e poi Sartre, Buñuel, Queneau, Mendès France, Rohmer, Audiberti, che chiedono notizie degli altri, li aiutano a riempire il modulo della previdenza sociale, rispondono alle lettere, hanno in comune una cosa: si dimenticano facilmente di se stessi e si interessano di più di quel che fanno che di quel che sono o di quel che sembrano.”
E prima della firma: “finisco come te: se vuoi parlarne, d’accordo, François”
Nessuno dei due contendenti raccolse l’invito dell’altro, “se vuoi parlarne, d’accordo”. Non si parlarono mai più. Personalità troppo distanti e soprattutto solchi troppo profondi erano stati scavati tra i due. Ciascuno proseguì per la propria strada e ciascuno, per nostra fortuna, continuò a fare film meravigliosi che sono rimasti nella storia del Cinema e che piacquero alla maggior parte degli spettatori e ancor oggi sono generalmente amati. Tranne allo spettatore Truffaut, per ciò che riguarda i film di Godard e tranne allo spettatore Godard per i film di Truffaut…
L’influenza della Nouvelle Vague oggi.
Potremmo riempire decine, forse centinaia di pagine, se volessimo declinare tutti i registi che, in un modo o nell’altro, volontariamente o spontaneamente, si sono rifatti ai principi della Nouvelle Vague. La cosa migliore, a mio giudizio è invece, come sempre, il metodo esemplificativo, consistente, in questo caso, nell’indicare poche opere, tra le tante, nelle quali sembra evidente il debito verso quel movimento.
Vorrei limitarmi a due film che tra l’altro non sono mai arrivati in Italia, pur essendo film di grande valore (fenomeno purtroppo niente affatto inconsueto!). Entrambi i film si ricollegano ad aspetti delle teorie di Bazin e ne sono sicuramente un trasparente omaggio.
Il primo è un film giapponese, del bravissimo Hirokazu Koreeda, dal titolo “Nobody Knows” del 2004.
La storia è ispirata a fatti realmente accaduti. Una madre col suo figlio dodicenne si trasferisce in un piccolo appartamento alla periferia nord di Tokio. In realtà, all’insaputa del proprietario, nell’appartamento arrivano anche i tre figli minori della donna, avuti da diverse relazioni. Essi sono condannati a vivere un’esistenza di segregazione perché neppure dichiarati all’anagrafe e quindi legalmente non esistenti: niente scuola, niente sanità, niente vita riservata comunemente ai bambini. La madre presto si stancherà di questa situazione e abbandonerà i figli e la casa per non fare più ritorno, lasciando al primo figlio una piccola somma che presto si esaurirà e tutte le responsabilità dalle quali fugge definitivamente.
E’ un bellissimo film ricco di citazioni tratte da film italiani del neorealismo. In particolare il film ricalca intenzionalmente, nello stile, nel modo di girare e nel contenuti (Il degrado a cui la miseria può portare) i capolavori di De Sica, “Ladri di biciclette” e “Umberto D”. Ma soprattutto emergono le teorie di Bazin sul cinema specchio della realtà ovvero realtà esso stesso. A me sembra del tutto evidente che l’ottimo regista giapponese non solo si ispira intenzionalmente al neorealismo, ma è un buon conoscitore di Bazin e sicuro lettore dei quattro volumi di “Cos’è il cinema?”
Un secondo ed ultimo esempio di influenza della Nouvelle Vague riguarda un film ancora più recente, “Victoria”, del 2015, del talentuoso regista tedesco Sebastian Schipper.
Victoria (Laia Costa) è una ragazza spagnola venuta da poco a Berlino. Non conosce ancora, se non superficialmente, la vera essenza della città e pensa di aver trovato le guide ideali in quattro ragazzi che conosce fuori del locale dove lei stessa aveva trascorso la serata. A Victoria i quattro giovani si presentano come “veri berlinesi” in grado di mostrare gli aspetti più autentici della città. Ma la gaia notte, che include anche la nascita improvvisa di un amore tenero tra Victoria e uno dei quattro giovani, ben presto si trasformerà in un incubo: uno dei quattro amici deve pagare un debito con un malvivente che lo aveva aiutato durante il suo soggiorno in galera: c’è da fare alle prime luci dell’alba una rapina in una piccola banca. Il tutto finirà in tragedia. Il film è fortemente ispirato alla Nouvelle Vague, e non solo nei contenuti descritti. Infatti esso consiste in un lungo piano sequenza di oltre due ore (shot in only one take, dicono in America). Il precedente del russo Alexander Sokurov nel 2002, che ha girato “Russian Ark” con la medesima tecnica, viene polverizzato, perché esso dura “solo 70 minuti contro le oltre due ore di “Victoria”. Nessuna taglio, dunque, nessuna interruzione e l’operatore al montaggio è rimasto disoccupato. Nessun taglio nascosto neppure quando si chiude una porta. Noi conosciamo, attraverso le parole dello stesso Schipper i tempi esatti della straordinaria ripresa: è il 27 aprile 2014 nel cuore di Berlino alle ore 4.30 del mattino. Schipper ripete per tre notti di seguito l’unica sequenza dell’intero film, per poi scegliere la migliore. Certo una menzione particolarissima merita l’operatore alla macchina da presa, il norvegese Sturla Brandth Grøvlen che è bravissimo nel puntare la camera sempre al punto e al momento giusto , spessissimo con camera in spalla, talvolta appiccicato agli attori, come nelle sequenze in auto o in taxi.
Bazin avrebbe gioito di questa grande prova di virtuosismo. Certo un piano sequenza di oltre due ore implica una preparazione accuratissima, perché non si tratta di un piano sequenza di un documentario, ma di una fiction con 5 attori perennemente in scena, oltre naturalmente agli attori secondari, e dove ci sono da sincronizzare due ore di movimenti e di dialoghi in presa diretta, che tra l’altro sono molto concitati.
Forse i due film che abbiamo citato sono due casi limite di totale adesione alle teorie della Nouvelle Vague e in particolare a quelle di Bazin. Ma, casi limite o meno, oggi chi vuole semplicemente girare in strada, chi cerca la realtà della vita quotidiana per le proprie sequenze, chi rifiuta gli schemi del cinema classico e vira verso la totale indipendenza, lo voglia o meno, deve rifarsi a quel grande innovativo movimento che è stato la Nouvelle Vague. Che dunque ancora vive.
_________________________________
(1) Renzo Gilodi: “Nouvelle vague: il cinema, la vita”-Effatà Editrice – pag. 41
(2) A. Bazin: “Cos’è il cinema?” – Garzanti Libri – pag. 89
(3) Fernaldo Di Giammatteo: “Dizionario universale del cinema – vol 2 – Tecnica, Generi, Istituzioni – Autori” – Editori Riuniti – pag. 380
(4) François Truffaut: “Bazin ci manca” – Prefazione a “Andè Bazin” di Dudley Andrew – Ed. de L’Etoile – 1983.
(5) Geoffrey Nowell-Smith: “Making waves. New cinema of the 1960s”- Ed Bloomsbury – pag 195.
I SAMURAI DEL CINEMA NOIR
RIFLESSIONI SUL CINEMA E SUGLI EROI DI MICHAEL MANN
di Riccardo Poma
Nato nel 1943 a Chicago, Michael Kenneth Mann è considerato uno dei maestri del cinema d’azione odierno. Nonostante sia considerato, a ragione, uno degli ultimi registi a fare un cinema orgogliosamente “di genere”, è indubbio che Mann abbia saputo concepire un percorso estremamente personale che lo ha reso a tutti gli effetti un autore, figura sempre più rara nel cinema di genere e soprattutto nel cinema poliziesco. Pur restando fortemente ancorato alla tradizione del poliziesco/noir americano, il cinema di Mann si colloca tuttavia molto più vicino a quello di cineasti europei ed asiatici come Melville, Woo, Kitano, il primo Kurosawa. Questo lo ha reso un regista molto amato dalla critica, anche (o forse soprattutto) in ambito europeo.
Il codice del Samurai – Gli (anti)eroi di Michael Mann
Si sente spesso dire che più delle storie contano per Mann le atmosfere notturne e sospese, e più delle atmosfere contano i personaggi, le loro scelte, la loro etica. Il cinema di Mann è, come pochi altri, un cinema imprescindibile dagli eroi che lo popolano: prima ancora che nelle vicende che attraversano i film, la poetica del regista traspare dai personaggi che decide di raccontare. Come nei vecchi polar di Melville (film imperniati su personaggi che, prima ancora che ai cowboy americani, si ispiravano abbastanza esplicitamente ai Samurai d’oriente), i personaggi di Mann sono uomini duri e dal carattere forte che antepongono agli interessi personali e agli affetti cose demodé come il senso dell’onore e il bisogno di giustizia. Personaggi dalla profonda impronta etica alle prese con un mondo in cui l’etica è un valore in via d’estinzione. Le loro azioni, le loro scelte, i loro gesti pagano a livello morale ma li relegano ad una profonda, inconsolabile solitudine. Ecco perché, spesso, acquistano una statura tragica: nonostante il dolore che questo comporta (perdita di persone care, perdita della libertà, impossibilità di vivere serenamente), essi continuano imperterriti a perseguire un obbiettivo “soltanto” perché reputano che sia giusto farlo.
In “Heat – La sfida”, da molti considerato il capolavoro di Mann, il ladro McCauley rinuncia a fuggire con la dolce Eve nonostante la fuga sia senza ombra di dubbio ciò che desidera. Ciò nonostante, non può fuggire con lei perché deve sistemare i suoi conti in sospeso, perché il suo profondo senso di giustizia (pur essendo un criminale) lo costringe a restare. Avrebbe potuto fuggire e vivere serenamente? Certo, ma così non sarebbe più riuscito a guardarsi allo specchio. Da “Manhunter” a “Insider” passando ovviamente per “Heat”, i personaggi di Mann si lasciano dietro una scia di familiari e affetti in lacrime che li vorrebbero più presenti in casa e un po’ meno dediti alla causa, anche perché la causa è sposata con tale abnegazione da non lasciare spazio per nient’altro. Una caratteristica che non appartiene esclusivamente a chi ha scelto di lottare tra le fila dei buoni: i film di Mann hanno spesso raccontato che il senso dell’onore è un qualcosa che può trascendere le convenzioni di bene e male e – in rari casi – appartenere anche a chi ha scelto di NON servire la legge. Pensiamo al ladro Frank di “Strade Violente”, primo film di Mann, al già citato ladro Neil di “Heat – La sfida”, pensiamo a John Dillinger in “Nemico Pubblico”, rapinator cortese che il popolo americano devastato dalla grande depressione elesse a novello Robin Hood. La loro lealtà verso il nemico, il loro codice quasi cavalleresco, la loro riluttanza a uccidere, sono elementi che portano il regista ad osservarli se non con stima quanto meno con rispetto. Rispetto che, tuttavia, non diventa mai ammirazione o, peggio, apologia: gli antagonisti dei film di Mann, anche quelli mossi da un profondo senso etico, sono destinati a finire vittime di loro stessi.
Un’ineluttabilità che arriva direttamente dal cinema noir: quanti personaggi di Mann vorrebbero cambiare vita? Quanti di loro sognano il classico “ultimo colpo” per poi ritirarsi? Quanti ci riescono davvero? Praticamente nessuno. Non vi riesce Frank in “Strade violente”, non vi riesce Neil in “Heat”, non vi riesce Dillinger in “Nemico Pubblico”. Ecco la profonda (e cristallina) moralità di un regista che, pur affezionandosi (e affezionandoCI), se non al cattivo, a colui che nei suoi film compie talvolta azioni criminose, non esita un secondo a schierarsi sempre comunque dalla parte del bene. In “Heat” c’è un rispetto assoluto per il microcosmo criminale come per quello poliziesco, per il ladro Neil di De Niro come per il poliziotto Vincent di Pacino, eppure nemmeno per un secondo Mann pensa che il primo possa approdare ad una qualche catarsi o vincere la sua battaglia. Un concetto riassunto perfettamente nella celeberrima scena della tavola calda. Vale la pena trascrivere alcune delle battute che si scambiano il ladro e il poliziotto, per la prima volta insieme:
VINCENT: – Allora (se non vuoi finire di nuovo in prigione, ndr.) è meglio che cambi lavoro…
NEIL: – È quello che mi riesce meglio, organizzare colpi. A te quello che riesce meglio è fermare la gente come me.
…
VINCENT: – Io non saprei che altro fare…
NEIL: – Ah, io neanche.
VINCENT: – E nemmeno vorrei fare altro.
NEIL: – E io neanche.
…
VINCENT: – Eccoci qui, seduti qui, io e te, normali, come due vecchi amici, ma tu fai quello che fai e io faccio quello che devo fare. E ora che ci siamo conosciuti, se quando sarà dovrò toglierti di mezzo, potrà non piacermi, ma ti avverto: se mi troverò a scegliere fra te e un poveraccio che per colpa tua rischia di lasciare una vedova, scelgo te, senza neppure esitare.
NEIL: – È vero, ci siamo conosciuti, ma nemmeno io esiterei, nemmeno un istante.
Vincent non nasconde la sua stima per il rivale, e sa bene che hanno molto in comune – in primis, la totale abnegazione verso ciò che fanno (e che causa ad entrambi solitudine e vite private burrascose), ma come ribadisce alla fine del dialogo non c’è nulla che potrà mai farlo desistere dalla propria missione. La stima è reciproca e, alla fine, Vincent prende la mano di un Neil morente dopo avergli sparato. Il poliziotto è scosso, visibilmente dispiaciuto, ma sa di aver fatto – bene – il suo dovere al servizio della giustizia. Con le sue scelte, giuste o sbagliate che siano, rimane l’uomo il fulcro del cinema di Mann. Questo sguardo umano e impregnato d’umanesimo porta ad un altro elemento tipico del suo cinema, ovvero un elogio al professionismo inteso come abilità (potremmo dire in senso “hawksiano”), ma anche e soprattutto come apoteosi di uno spiccato senso del dovere che va di pari passo con una profonda umiltà.
Anche quando questi personaggi sembrano anteporre il sentimento all’etica, non è difficile accorgersi che le cose sono ben più complesse di come appaiono. Nel finale di “Miami Vice” Sonny lascia fuggire la trafficante Isabella perché la ama, ma subito dopo averle detto addio corre all’ospedale dalla collega ferita. Ovvero, abbandona il “male” (anche se è un male che vorrebbe con se) e corre “dove dimora il bene”. Egli acquista una statura tragica: sta rinunciando all’amore perché non può rinunciare alla sua morale. Quella di lasciarla fuggire è una scelta sbagliata? Certo, ma è una scelta. È Sonny l’artefice del proprio destino, con tutto ciò che ne deriva. Mann lo rispetta perché, correndo immediatamente dalla collega che lotta tra la vita e la morte e rinunciando a Isabella, fa ancora una volta la scelta giusta.
È forse “Collateral” il film di Mann con i personaggi meno inscrivibili in questa logica. Non a caso rimane la sua opera più filosofica, la più ampia a livello tematico, la più ambiziosa per quanto riguarda le riflessioni che dipinge. I due protagonisti sono un tassista nero e un implacabile sicario bianco, e il secondo obbliga il primo a fargli d’autista tutta la notte mentre lui cerca di portare a termine il suo “lavoro”. Mann non perde di vista l’ago della bilancia che separa il bene dal male, ma sottolinea anche una certa affinità tra i due, simili nel loro continuo e disperato bisogno di giustificarsi per ciò che fanno o per ciò che non fanno: il sicario Vincent giustifica il suo lavoro dicendo che tanto siamo tutti insignificanti, che lui uccide solo i cattivi, che un morto in più o in meno non cambierà nulla all’interno delle logiche che governano questo pazzo mondo; Max giustifica il suo continuo rinvio ad aprire l’attività dei suoi sogni (un servizio di Limousine) perché non è ancora il momento, perché servono i soldi, perché tanto ha ancora tempo. Alla fine Max, spinto più da interessi personali che da un profondo senso di giustizia, trova il coraggio di agire e fermare Vincent, ma la scena finale (con il sicario morto, sulla metropolitana, e Max a chiedersi se qualcuno si accorgerà di lui o del fatto che sia morto), rivela che forse il cattivo aveva ragione: siamo davvero insignificanti. Perché “Collateral”, si è chiesto qualcuno. Perché tutto ciò che facciamo, anche se non ce ne accorgiamo, ha delle conseguenze. E dove sta la novità, si chiede qualcuno. Nel fatto che ha delle conseguenze anche ciò che NON facciamo.
Il cinema di Mann ridefinisce dunque le caratteristiche dell’eroe del cinema d’azione, che non è più un essere sovrumano e privo di conflitti interiori quanto un uomo che, consapevole dei propri limiti, cerca soltanto di fare – bene – il suo lavoro. Le sue gesta non sono mai amplificate o enfatizzate dalle armi della retorica, i suoi trionfi non sono mai celebrati. Questo perché da un lato la celebrazione cozzerebbe con l’umiltà che lo contraddistingue, dall’altro perché è ben conscio di aver vinto una battaglia, non la guerra: arrestare McCauley o Dillinger, eliminare lo spietato assassino Dente di Fata in Manhunter o il sicario gentile Vincent di “Collateral”, riuscire a trasmettere un servizio contro l’impero del tabacco in “Insider”, non sono che piccole vittorie in un mondo sempre più in preda al caos che fatica ad essere salvato. Ma, ripartendo proprio da questi uomini che agiscono seguendo valori alti come l’altruismo, la giustizia, la lealtà, la solidarietà, si può forse cominciare a provarci.
Attimi sospesi nel tempo e nello spazio – Lo stile
Pioggia, notte, fumo. Metropoli, tante luci, molta solitudine. Mann, l’abbiamo detto, è figlio del noir, e a partire dalle prime inquadrature del suo primo film – “Strade Perdute” – gli elementi tipici del genere si presentano come un qualcosa di imprescindibile rispetto alla sua idea di cinema e di racconto. Ma così come le tipologie di eroi che decide di raccontare, anche lo stile cinematografico di Mann è molto, molto diverso dallo stile della stragrande maggioranza dei polizieschi d’azione o dei noir che si girano oggi. Innanzitutto a livello tecnico: a partire da “Collateral” (2004), Mann ha infatti spesso affiancato all’uso della pellicola quello del digitale. Una scelta molto espressiva sia a livello cromatico – i personaggi salgono sui tetti delle città/gironi infernali del terzo millennio e si stagliano su cieli rossastri tanto veri quanto irreali che promettono tempeste terribili – che a livello di stile: fortemente ancorato ad un’idea di realismo, Mann usa il digitale per dare a molte scene un tono da docu-film, da reportage giornalistico “sul campo”, tono che, coadiuvato da una grande abilità nel coreografare l’azione, garantisce alle immagini una veridicità e una plausibilità rare. Ottenendo anche effetti mai visti, come ad esempio nelle scene d’azione di “Nemico Pubblico” in cui, per la prima volta nella storia, anche le sparatorie tra gangster degli anni trenta assumono livelli di realismo molto alti. Scene accadute ottant’anni fa girate con il realismo con cui assistiamo oggi alle guerre, agli attentati terroristici, alle barbarie più scioccanti. La cosa forse più interessante di questo stile è il fatto che, nonostante questo realismo esasperato, il cinema di Mann non sia mai solo documentazione del reale: ogni singola inquadratura di Mann, anche quella girato col tono di un video amatoriale fatto da un testimone che passava per caso, possiede una bellezza, un rigore, un lirismo unici. Insomma, si parla sempre e comunque di (grande) cinema e mai di servizi di stampo televisivo.
È interessante notare come l’ossessione realistica di Mann sbrachi talvolta in inaspettate pennellate oniriche, pennellate che negli ultimi anni il digitale ha rafforzato nella loro espressività. Pensiamo a Gong Li che va verso Colin Farell nel bel mezzo della sparatoria finale di “Miami Vice”; l’ingresso di Johnny Depp/Dillinger nella stazione di polizia senza che nessuno lo noti, o meglio, senza che nessuno comprenda la sua identità; il finale di “Heat” all’aeroporto in cui il duello finale raggiunge dilatazioni temporali che ricordano quelle di Sergio Leone; la scena in cui un lupo grigio attraversa la strada al Taxi con a bordo i protagonisti in “Collateral”, a sottolineare il senso dei film e dei personaggi; l’arrivo di Alì nelle periferie povere dello Zaire, la battaglia finale de “L’ultimo dei Mohicani”. Il tempo si dilata, la grana delle immagini si fa ruvida e ampollosa. Attimi sospesi nel tempo e nello spazio che sanno di quiete PRIMA della tempesta o, nel caso si trovino vicini all’epilogo, prima di una NUOVA tempesta che non tarderà ad arrivare. Sono anche le scene più simboliche del cinema di Mann, quelle che raccontano in maniera più o meno velata un senso, un messaggio, una presa di coscienza, una riflessione particolare. Alì e Dillinger comprendono il loro incredibile potere mediatico, il sicario Vincent si specchia nella sua solitudine e nel suo grigiore, l’ultimo Mohicano riflette sulla sua condizione tragica e di isolamento. Interessante come questo stile particolare accompagni spesso anche quelle afose scene di sesso che, a ben guardare, sono una costante del cinema di Mann: amplessi veloci, disordinati e sudati ma stranamente irreali, ovattati, come se si trattasse di placidi sogni notturni in attesa di bruschi risvegli sulla cruda realtà. Certo sarebbe scorretto sostenere che il merito di queste atmosfere – che, senza ombra di dubbio, sono l’elemento che più di tutti identifica il cinema di Mann – sia esclusivamente del regista. O meglio, pur trattandosi di farina del suo sacco, pur essendo da lui fortemente volute e ricercate affinché siano concepite in un certo modo – il suo – queste atmosfere sono il frutto di una combinazione perfetta di regia, fotografia (spesso curata dal nostro Dante Spinotti) e musiche, queste ultime sempre composte in maniera sobria da artisti della scena elettronica o da compositori che spesso si sono ispirati all’elettronica (Elliot Goldenthal, John Murphy, James Newton Howard). Uno stile allo stesso tempo epico e intimista, in cui il tempo sembra fermarsi e chi racconta si sofferma su chi è raccontato, su ciò che egli sente, su ciò che prova.
Ma Mann resta anche, a modo suo, un regista classico, sostenitore dell’andamento narrativo lineare e vicino a Hitchcock nel tratteggiare quel meraviglioso rapporto tra il particolare e l’universale: il cinema di Mann passa da primissimi piani dei volti – una vicinanza che suggerisce il tentativo di comprendere i personaggi e (ovviamente) le loro scelte – a vertiginose inquadrature dall’alto delle città, punti di vista lontanissimi dai personaggi che tuttavia in quei personaggi sono destinati a cadere. Ecco perché il suo rimane un cinema profondamente intimista, anche quando s’arrischia a raccontare delle comunità o, in rari casi, intere città.
Icone americane – un discorso politico
Nonostante l’appartenenza cercata e dichiarata ad un genere preciso – il poliziesco d’azione – il cinema di Mann non è mai stato esente da sostanziose riflessioni politiche, e spesso le storie di questi eroi raccontano, velatamente ma senza peli sulla lingua, le aberrazioni della società americana. Tuttavia, sarebbe scorretto non identificare nel suo cinema una manciata di film più spiccatamente “politici” di altri. Si pensi a un film come “L’ultimo dei Mohicani” (1992), in cui Mann racconta alcuni episodi poco conosciuti della storia americana come la rivalità coloniale tra Francia e Inghilterra in tempi di “pre-west”. È l’unico film di Mann ambientato lontano dalla metropoli, ma anche quello in cui maggiormente si irridono la guerra e i riti militari, l’unico basato su un personaggio che non fa altro che correre, contro i nemici ma soprattutto contro il tempo: a breve quelli come lui non esisteranno più. Il regista racconta un uomo bianco stupido e guerrafondaio, mentre non nasconde una forte stima per gli indigeni e per il loro profondo senso dell’onore (come abbiamo visto, un tratto tipico dei suoi personaggi).
Del 1999 è invece “Insider”, un thriller politico ispirato ad un articolo di Marie Brenner apparso su Vanity Fair col titolo L’uomo che sapeva troppo. È – vuoi anche l’assonanza con titolo dell’articolo – un robusto thriller drammatico di sapore hitchcockiano, in cui tuttavia i cattivi non hanno volto perché i veri cattivi sono il potere, silenzioso e strisciante, la corruzione morale, l’assenza di etica nel giornalismo come nel capitalismo. “La stampa è libera per chi la possiede!”, sostiene il regista attraverso le parole del giornalista Lowell Bergman, interpretato da Al Pacino. Una frase forte che riassume il senso di questo film così sottilmente anti-americano: tutto, oramai, è soggettivo e soprattutto “acquistabile”, anche la verità.
Due anni dopo è il momento di “Alì”, un bio-pic sul celeberrimo pugile afroamericano. Mann si rivela grande maestro nel coreografare i combattimenti, ma ciò che gli interessa davvero è l’incredibile “consapevolezza mediale” di Alì, che auto-crea il proprio personaggio plasmando i mezzi di comunicazione secondo il suo volere. È un biopic anomalo, non agiografico (si racconta l’impegno di Alì a favore dei diritti civili, ma anche la sua cieca adesione alla setta della Nazione Islamica), molto più vicino a “Toro Scatenato” che a “Rocky”. Nella seconda parte esce il suo sotto testo politico: Alì combatte in Zaire convinto di poter dare una speranza ai neri d’Africa, ma non si accorge di essere usato come una sorta di mascotte dal dittatore Mobutu. Ecco perché la sconfitta di Foreman, alla fine, non possiede nulla di davvero vittorioso: come ai tempi dei gladiatori, si dà al popolo un contentino per tenerlo buono. Pessimista? Forse, ma è anche una delle più riuscite metafore dello sport d’alto livello di oggi.
Questo discorso sulle “icone americane” prosegue con “Nemico Pubblico”, del 2009. Già dal titolo originale – “nemici pubblici” – si comprende che l’intenzione di Mann è quella di raccontare, attraverso le gesta di un bandito feroce ma mai spietato, un’America distrutta dalla crisi economica che somiglia molto a quella di oggi: incerta, impaurita, e disperatamente bisognosa di qualche nuovo eroe che sfidi i potenti e un ordine costituito in cui non viene posta più alcuna fiducia. Non c’è dubbio che quello di Dillinger sia un personaggio affascinante che meritava una trasposizione cinematografica adeguata. A Mann, tuttavia, sembra interessare di più la sua incredibile “consapevolezza mediatica” (“noi dobbiamo piacere alla gente”, dice il bandito ad un membro della sua gang) piuttosto che il suo messaggio “politico” (si dice che bruciasse i registri delle banche per annullare i debiti dei piccoli risparmiatori): una scelta che da un lato evita le trappole dell’agiografia, dall’altro svela l’intenzione di un ritratto più ampio che scavalca i confini del personaggio e mira all’affresco socio- culturale di un’intera nazione. Ma la storia di Dillinger, nelle mani di Mann, funziona anche come allegoria meta-cinematografica sul potere “circolare” (e quindi “totale”) della settima arte. La vita del bandito termina davanti ad un cinema in cui è appena stato trasmesso un film gangster, genere ispirato dalle gesta dei Dillinger, dei Baby Face, degli Al Capone, che a loro volta erano “strumenti mediali” nati DAI e GRAZIE ai media. Mann cerca di scoprire come nasce la leggenda attraverso il concepimento di un antieroe che è allo stesso tempo “onnipresente” e “invisibile”, è ovunque ma nessuno lo vede mai: frequenta posti così poco adatti a nascondersi che nessuno lo pensa così stupido da trovarsi lì, come dimostra la strepitosa sequenza in cui entra – per scommessa con se stesso – in una stazione di polizia riuscendo a raggiungere la sala operativa (tappezzata di sue foto) e addirittura a scambiare quattro parole con gli agenti senza che nessuno lo blocchi. Ed ecco come nasce un’icona che “vende” ancora oggi.
Il regista maschilista (?) – La donna dell’eroe
Cantore (e sostenitore) di temi come il professionismo e l’amicizia virile, Mann è stato spesso definito un regista “da uomini”, critica spesso sfociata in accuse di misoginia e maschilismo. Se è vero che il pubblico di Mann è, per affinità tematiche, un pubblico prevalentemente maschile, è scorretto affermare che il suo cinema sia un cinema “uomo-centrico” in cui le figure femminili si limitano a fare da contorno. Anzi. Non è difficile accorgersi che le figure femminili nel cinema di Mann siano tutt’altro che protagoniste passive della storia o semplici “first-lady” del protagonista – uomo – di turno. Spesso sono donne forti e decise che acquistano una statura tragica nella loro dedizione verso la famiglia e verso i loro uomini “ingombranti”: pensiamo alla moglie di Graham in “Manhunter”, costretta a badare al figlio e alla casa mentre il marito si perde in una nuova spirale di follia dando la caccia al killer Dente di Fata, o alla moglie di Vincent in “Heat”, sulle cui spalle poggia il peso di una famiglia disgregata che patisce le troppe assenza del padre-detective. Pensiamo, esulando una volta tanto dal genere dell’hard boiled, alle bellissime figure femminili presenti ne “L’ultimo dei Mohicani”. Le sorelle Munro potrebbero limitarsi a nascondersi dietro le spalle del padre, colonnello inglese, e invece diventano protagoniste attive delle vicende: la maggiore, Cora, si innamora del protagonista Occhio di Falco e prende coscienza della barbarie cui sono sottoposti i nativi in nome di un ipocrita desiderio di civilizzazione, mentre la seconda, Alice, ha una storia con Uncas ed è protagonista della scena più carica di pathos di tutto il film, quella in cui, prigioniera del perfido Magua, si getta nel vuoto per evitare un destino di sottomissione.
Eccola, la donna artefice del proprio destino che si costruisce un futuro suo indipendentemente dalle direttive che vorrebbero affibbiarle gli uomini che la circondano. Una scelta che, nel cinema di Mann, non avviene per forza di cose in direzione del bene: si pensi alla Isabella di Gong Li in “Miami Vice”, spietata boss del narcotraffico che sceglie gli uomini con cui stare a seconda del SUO interesse, sa essere senza scrupoli, non fa (quasi) mai la figura della donzella in pericolo. L’unica che fa davvero la donzella in pericolo è probabilmente Jadah Pinkett Smith in “Collateral”, ma nonostante questa posizione passiva rispetto alle vicende del film, il mestiere che fa – pubblico ministero – rivela che non si tratta affatto di una donna debole. Gli esempi sono infiniti: dalle mogli di Alì alla Billie Frechette amante di Dillinger, dalle collaboratrici di Bergman in “Insider” fino alle poliziotte di “Miami Vice”, il cinema di Mann si conferma un cinema incline a bellissimi ritratti femminili che, per spessore e profondità, non hanno nulla da invidiare alle loro controparti maschili.
L’imprevedibile fisicità del male
Un’altra figura che nel cinema di Mann si distanzia dalle convenzioni del poliziesco è senza dubbio quella del villain, dell’antagonista. Il cinema d’azione ci ha spesso abituati a “cattivi” molto caratterizzati, sopra le righe, cattivi fino all’osso che sfiorano la caricatura o la deriva fumettistica tanto sono malvagi. Il cinema di Mann, da sempre, rifugge agli stereotipi concependo una serie di ritratti di villain tanto memorabili quanto insoliti, spesso raccontati in tutta la loro “non-tipicità” e la loro fisicità anomala (soprattutto se si parte dal presupposto che si tratta di “cattivi”). Partiamo da “Manhunter”, uno dei primi film del regista: il perfido assassino Dente di Fata è alto, magro, e possiede il volto di un mite – e non più giovanissimo – impiegato. In un qualunque altro poliziesco d’azione il serial killer avrebbe avuto le fattezze di un mostro, il fisico di un campione di wrestling, le movenze di un selvaggio. Nulla di tutto questo: l’assassino – interpretato da Tom Noonan – è un uomo terribilmente normale, spaventoso nelle gesta e nel modo di porsi ma mai davvero nell’aspetto fisico. I cattivi di Mann sono spesso diversi da come li immaginiamo, e per questo ancor più terribili: se il male cessa di avere l’aspetto del male, chi è in grado di riconoscerlo? Saltiamo avanti di sette anni, arrivando a “’L’ultimo dei Mohicani”. Qui abbiamo un cattivo apparentemente tipico, il Magua di Wes Studi, guerriero indiano che possiede senza ombra di dubbio la fisicità e la crudeltà del villain. Tuttavia, man mano che si prosegue con la visione, ci si accorge che Magua è il prodotto di una guerra tra bianchi, che la sua cieca vendetta è figlia di terribili soprusi perpetrati da coloro che dovrebbero essere i buoni. E infatti, alla fine, il personaggio che il regista osserva con maggior disprezzo è proprio il colonnello inglese, un uomo che non possiede minimamente la fisicità del cattivo e, anzi, è in qualche modo una rappresentazione visiva perfetta di ciò che dovrebbe essere il bene.
Pensiamo a “Insider”, film sul potere in cui il potere è incarnato da una massa di anonimi vecchietti, ben vestiti e incartapecoriti; pensiamo al boss di “Miami Vice”, un uomo assolutamente normale nell’aspetto e nel modo di comunicare, ben lontano da quei boss del narcotraffico cui ci ha abituati il cinema d’azione (e anche la TV: nella stessa serie TV “Miami Vice” i cattivi erano molto più stereotipati). Il cattivo dei film di Mann non è mai un personaggio che lascia il segno, come invece accade nei film di Tarantino, nei noir dei fratelli Coen, nei “Die Hard” di Bruce Willis. Come se al regista interessasse molto di più il COSA quel personaggio rappresenta, e non il COME. L’essenza piuttosto che l’apparenza. E che dire del sicario Vincent di “Collateral”, probabilmente uno dei personaggi più riusciti del cinema di Mann? Talmente normale e grigio che anche i suoi capelli e i suoi vestiti sono intinti in quel colore, talmente ordinario da essere sottovalutato da tutti (chi potrebbe sospettare che si tratti di un assassino a sangue freddo?). Eppure, ancora una volta, il male si presenta in maniera imprevedibile, rendendosi difficilmente identificabile da chi lo combatte. Pochi uomini sono ancora in grado di riconoscerlo e quindi affrontarlo. Forse, solo più gli eroi di Mann.
APPENDICE: Recitare per Mr. M – Il lavoro sugli attori
Una delle caratteristiche più interessanti del cinema di Mann è senza dubbio il lavoro che il regista, da sempre, svolge con gli attori che prendono parte ai suoi film. A partire da Gabriel Byrne nel ruolo di un nazista ne “La fortezza” (secondo film di Mann, un horror ambientato in Romania durante la seconda guerra mondiale), non è difficile accorgersi che il regista abbia spesso giocato con i players delle sue opere nel tentativo di smontare tutta una serie di clichè. Non che il cinema di Mann sia sempre impermeabile al divismo in maniera tutto sommato classica (Foxx e Farrell rudi ma leali, Depp simpatica canaglia), ma in linea di massima il modus operandi del regista rispetto ai suoi attori non è mai scontato. Pensiamo al modo in cui, ad esempio, si diverte a smontare i cliché di un genere: in “Heat”, per esempio, abbiamo un buono particolarmente antipatico e sgradevole (“lo sai perché ti scopavi la moglie di Shiherlis? Te lo dico io, perché ha un culo da sballo!”) e un cattivo simpatico e riflessivo. Mann porta alle stelle la recitazione sopra le righe di Pacino e mette in sordina il carattere già di per se più sobrio di De Niro, creando un effetto straniante che porta spesso a patteggiare per il cattivo. Una cosa che del resto accadeva già in “Manhunter” e che accadrà nuovamente in “Collateral”: il detective Graham non è particolarmente simpatico mentre il suo avversario dottor Lektor ha modi eleganti e una verve innata, così come il tassista Max non è (o non sembra) una persona capace di profondità come invece appare il sicario Vincent. Apologia del male? No, avvertimento: il male è spesso più affascinante del bene, dunque è più difficile riconoscerlo ed evitarlo.
Smontare i clichè, ma anche smontare il concetto stesso di divismo: si vedano tutti quegli attori che, negli anni, hanno prestato a Mann la loro immagine di divi belli e dannati lasciando che il regista la spogliasse di qualsiasi aurea mitica e la trasformasse in qualcosa di molto diverso. Si pensi al Russell Crowe vecchio e ingrigito di “Insider” (l’attore aveva appena 35 anni e ne mette almeno 10 in più); a Will Smith ingrassato, caricato di muscoli e dal volto sformato in “Alì”; a Tom Cruise, sex symbol per ben più di una generazione di spettatrici, tramutato in un travet dell’omicidio grigio nei capelli, nei vestiti e nell’anima, lontano anni luce (sia visivamente che concettualmente) dai personaggi solari e positivi che aveva interpretato fino a quel momento. Ecco che, anche negli elementi apparentemente più ovvi, il cinema di Mann non smette di riservare sorprese.
IL CERCHIO E’ CHIUSO, GOD BLESS MICHAEL!
di Francesco Saverio Marzaduri
Sullo scomparso Michael Cimino è stato detto e scritto, in termini ovviamente elogiativi, più dopo la sua morte che durante la sua attività di cineasta, valutata invece in modo altalenante. Hollywood ne aveva osannato e premiato il talento per poi massacrarlo poco dopo, senza troppo interrogarsi su uno sguardo che, nonostante insuccesso e tracollo finanziario, manteneva intatta la propria visionaria lucidità. Ora che non c’è più, e ha ragione Davide Turrini nel constatarlo, vi sarebbe corposa materia per realizzare un biopic o un lavoro documentaristico su di lui. Ma anche questa, va da sé, è mitologia, e che l’operazione non sia fattibile potrebbe testimoniarlo ogni spettatore cinematografico appena appena evoluto, non necessariamente un fan della sua opera, nel vedere o rivedere una qualsiasi delle sue sette fatiche da regista.
L’occasione, ghiotta, si è realizzata lo scorso settembre a Bologna, dove la Cineteca, non nuova a dedicargli una personale, ha ricordato l’oriundo cineasta newyorkese con un’ulteriore rassegna, benché incompleta di un paio di titoli, le cui pellicole, con la sola eccezione della copia in 35 mm. di “Verso il sole,” sono state quasi tutte presentate in digitale. A cominciare dal restauro “definitivo” de “I cancelli del cielo,” realizzato da Criterion e supervisionato da Cimino in prima persona – quello che in genere viene definito con l’abusato appellativo di director’s cut. Eppure, al di là della sfolgorante bellezza fotografica di ineccepibili professionisti del colore quali Vilmos Zsigmond, Frank Stanley, Alex Thomson o Douglas Milsome, c’è qualcosa in tali lavori che va oltre la qualità estetica e colpisce più di qualunque nitore figurativo. E nonostante sia quasi sempre ingiusto e svilente ridurre un’opera cinematografica a una striminzita manciata di pattern caratteristici, sorprende che dopo la morte dell’autore non poche firme della critica cinematografica abbiano preferito concentrarsi sulla débâcle in seguito a cui Cimino fu ostracizzato dagli studios per circa un lustro, incappando in mille difficoltà produttive nel faticoso tentativo di tornare alla regia o di far uscire un film non manomesso. Altri, fortunatamente, hanno focalizzato l’attenzione sulla maestosità dello scenario paesaggistico, elemento di primo piano nella produzione di Cimino e nelle cui fondamenta – intrise della mitologia propria dei grandi classici nordamericani, letterari e cinematografici – occorrerebbe ritrovare la possibile guarigione tesa a lenire le piaghe di un paese lacerato da contraddizioni e storture.
Volendo però, si diceva, ricondurre la filmografia di Cimino a un denominatore comune, in ciascuno dei suoi sette film da regista – escludendo a priori quelli da screenplayer – lo si potrebbe individuare tra le figure al centro, naturalmente maschili, nel più antico dei valori tradizionali a stelle e strisce: quello dell’alleanza, da leggersi come complicità, che non sempre e non necessariamente si muta in amicizia ma che il Caso provvede a innescare o a traslare nel suo rovescio. Tale alleanza è focalizzata dentro e fuori il proprio assioma, nella primigenia concezione di lealtà, che la malaugurata sorte, inerente un bottino misteriosamente scomparso o l’imponente fardello della guerra, si tratti di Vietnam o del conflitto tra ricchi allevatori di bestiame e immigrati europei, finisce per marchiare indelebilmente. E se il tempo, altro leitmotiv ricorrente in Cimino, ci mette lo zampino finendo per dividere sorti e destini, a fungere da contrappunto è sempre però la sfolgorante bellezza dello sfondo, volto a rammentare a individui corrotti da sangue e profitto, violenza e tumulti, come quel senso di poetico celato tra le pieghe di una natura incontaminata non può scalfirne il ricordo di ciò che sono, prima ancora di ciò che credono e/o credono di essere.
Il battesimo dietro la macchina da presa, “Una calibro 20 per lo specialista,” da questo punto di vista contiene già i topoi e le connotazioni che, passando da “Il cacciatore” sino al conclusivo “Verso il sole,” permettono d’individuare questa personalissima cifra stilistica: è il Fato a volere che due dropout, un giovane sbandato al volante di un’auto rubata e un maturo signore in abito da prete, s’incontrino-scontrino sullo sfondo di uno scenario naturale che pare uscito, come molte pellicole della New Hollywood, da una tela di Hopper. E fino a che non giunge il risvolto action a spiegare la fuga di uno dei protagonisti, la prima parte del film si può riassumere con l’intrecciarsi di due esistenze solitarie che, per l’uno o per l’altro motivo, finiscono per stringere amicizia. Quando poi uno degli inseguitori, il pel di carota Leary, uscito di galera, si rifà vivo e non vede l’ora di sistemare i conti con chi pensa di averlo tradito, quello che potrebbe degenerare in una sfida a morte si risolve in una grottesca scazzottata, senza spari ma condita di starnuti allergici. Al biondo Caribù (il “Lightfoot” del titolo originale) che gli chiede perché abbia scelto di non uccidere l’Artigliere (“Thunderbolt”) quando gli si è presentata l’occasione, lo stesso Leary chiosa “Perché siamo amici.” Ma è il tornaconto personale a mostrare l’altra faccia di questa lealtà: sicché quando il secondo colpo si rivela fallimentare, Leary palesa il proprio attaccamento al gruzzolo e pesta i due protagonisti, prima di andare incontro alla morte. Tanto all’Artigliere quanto a Caribù, il destino riserva una duplice sorpresa: il bottino della prima rapina, che sembrava perduto, ricompare dietro la lavagna di una scuola nel frattempo spostatasi, e con quello i due potrebbero iniziare una vita a base di amichevoli scorribande a bordo di una Cadillac, se l’improvvisa morte di Caribù non lasciasse l’Artigliere solo e incerto, a fronte di un avvenire che la maestosità di un paesaggio soleggiato, nell’ultimo freeze, sancisce come un grembo. “Where Do I Go From Here” (“Dove vado da qui,” appunto), intonato da Paul Williams, è il commento musicale che funge da contrappunto.
Ebbene: dietro l’apparente scorza di una commedia d’azione on the road, picaresca e condita di soluzioni iperrealiste anche nell’impianto narrativo, la tragedia arriva inattesa. Il senso di alleanza, qui mostrato da una lealtà solo presunta da parte di Leary, è macchiato da una sete di denaro per ottenere il quale si è disposti a violenza e tradimento. Altresì, la complicità tra l’Artigliere e Caribù, che sempre più si cementifica durante il film, è premiata dall’inaspettato ritorno del bottino. Ma è la mannaia del Fato a concludere lo spirito di un’avventura, che persino eleva un outsider al rango di eroe, riportando una situazione da western lieto fine su un imprevisto binario di realismo e di tragedia. I protagonisti di “Una calibro 20 per lo specialista” preludono a Mike e Nick nel senso di complicità unilaterale, d’impronta paterno-filiale, che induce il primo, colui che immette il concetto di lealtà anche nella battuta di caccia al cervo (“Un colpo solo”), ad affermare che se Nick non lo accompagnasse preferirebbe andare da solo. “Mi piace perché hai qualcosa dentro,” sono le parole con cui Mike confessa il proprio fraterno affetto a chi considera il preferito della compagnia. Nell’ottica d’insieme e in quei ragionamenti da maniaco idealista, che pur sempre conserva l’aura americana tradizionalista e conservatrice, e che parte per la “sporca guerra” insieme a Nick e a Steven, lo spettatore – a cominciare dal nome anagrafico, come futuri altri personaggi della filmografia di Cimino – coglie nel personaggio di Mike lo sguardo a un tempo lucido e disincantato, megalomane e sincero, dello stesso cineasta. Il solo, al pari del Clint Eastwood che gli concesse di dirigere, gli produsse e interpretò “Una calibro 20,” capace di scavare nel profondo di un’ideologia politica di destra restituendone ambiguità e contraddizioni senza esser tacciato di disonestà intellettuale, lungi da qualsiasi dissertazione retorico-trionfalistica. Il rovescio di una medaglia, proprio in quel “Cacciatore” che avrebbe fatto incetta di statuette, mostra come la lealtà di un solo proiettile, da utilizzare contro un animale indifeso, diventi qualcos’altro nelle mani di chi gioca con la vita dei prigionieri al tavolo della roulette russa, ogni volta sotto forma di sfida affidata al tamburo di una rivoltella o a un beffardo destino. L’allegoria non potrebbe essere più cristallina. Una volta tornato a casa, resosi conto che l’idealista ottica americana è solo l’insulsa particella di un discorso bigger than life, che ha trasceso finendo per ledere irrimediabile la sua esistenza e quella degli amici, Mike non può che impiegare l’unico colpo del fucile sparandolo in aria nell’ultimo incontro col cervo. Pure, nell’estremo tentativo di riportare con sé l’amico, che l’orrore del Vietnam ha trasformato nella sua ombra antagonista, rischia di morire per dimostrare la propria intatta lealtà. Ma è il Fato, in tutto il proprio sinistro corredo di presagi, ad averla vinta spezzando Mike nella psiche, rendendo Steven un paraplegico e decretando la morte di Nick: si tratti della macchia rossa da vino su un vestito da sposa, o dei fenomeni solari che ammutoliscono gli amici mentre vanno a caccia, si tratti di un brano di Chopin che uno di essi suona al pianoforte interrompendo pian piano la baldoria dei compagni ubriachi, o la presenza di un reduce che inattesa si staglia al bancone del bar mentre nei pressi si celebra una festa nuziale, e solo, gustando il suo cicchetto, risponde a monosillabi come uno appena tornato da un altro mondo, senza raccogliere lo scherno di chi, ignaro, non sa cosa lo aspetta.
A pensarci bene – e si tratta qui di un altro luogo canonico cui pochissimi hanno accennato – il cinema di Cimino è attraversato da figure spettrali, anacronistici residui di un’altra epoca indotti a misurarsi con periodi al di fuori della loro comprensione. L’Artigliere in primis enuncia di avere molti più anni di Caribù, e, trattandosi di un ruolo su misura per Eastwood, non dovrebbe apparire casuale come la spettralità che contrassegna gli antieroi silenziosi e solitari del cinema di quest’ultimo abbia comune origine o ideali discendenze con le figure di Cimino. Fantasmatica, ne “Il cacciatore,” è la sinistra icona del reduce in un momento di euforia, chiamata ad assurgere a quella taciturna ombra che l’ubriaco Mike, che si diverte a schernirla, riveste a sua volta (e a sue spese) nel drammatico impatto con la realtà e le proprie conseguenze. Un fantasma è il personaggio di James Averill, che nel difendere gli immigrati ucraini dai ricchi allevatori di bestiame – lui che in un certo senso è figlio di quel ceppo – prosegue la propria idealistica missione inaugurata da Mike. E “I cancelli del cielo” è un’opera nel quale splendori figurativi ed episodi di danza, fotografati con romanticismo e passione, obbligano la classe di Harvard dell’incipit a fare una scelta dolorosa e consapevole. Averill sa di non poter tornare indietro (“Detesto invecchiare,” gli sentiamo dire), e quel poco di meraviglioso che la vita gli concede non è possibile riesumarlo tornando agli amori della giovinezza: la tragedia ha lasciato il posto a malinconia e tristezza.
Se poi è vero che l’America non ama riconoscersi in pessimismi né in livide metafore, si aggiunga che non meno imperdonabile è il talento di qualcuno che, incensato dagli Oscar, si permette di grattare nel fondo della Storia (prima ancora di mistificarla in base a un proprio disegno, come ne “Il siciliano”) mettendo a nudo le ignominiose operazioni terriere degli americani nei confronti degli ucraini. Le etnie e i conflitti razziali sono un ulteriore chiodo fisso nella filmografia ciminiana, e non è solo il Vietnam a testimoniarlo. Ne “L’anno del dragone,” che per molteplici aspetti costituisce un dittico con “Il cacciatore” e n’è un continuum, la crociata di uno sbirro pluridecorato e reduce di guerra non è l’usuale crociata razzista di un eroe macho à la John Wayne versus i nativi americani, semmai qualcosa di molto più complesso. Sullo sfondo di una degradata Chinatown newyorkese di sapore fantascientifico memore di “Blade Runner,” e che sostituisce di peso la wilderness dei film precedenti, Stanley White è un altro fantasma messo di fronte alla propria anima antagonista: il mafioso cinese Joey Tai, per sgominare il quale, consapevole dell’impossibilità dell’impresa, chiama ad aiutarlo due “musi gialli,” un giovane collega e una giornalista tivù. Il chiodo fisso di White si misura col proprio caparbio concetto di giustizia (e la propria sete di vendetta personale) entro un Sistema garantista e contraddittorio, prettamente a stelle e strisce, ma sempre sul punto di crollare anche a detrimento degli affetti. Ma tale ostinatezza, che potrebbe essere tipica di un wasp, ce l’ha invece un polacco, ossia un altro oriundo. E la solennità che ammanta le esequie di cui “L’anno del dragone” è costellato, si tratti del funerale di un boss della malavita cinese o di una moglie barbaramente uccisa durante un agguato, conservano il medesimo piglio tragico degli antieroi fordiani (Stanley è presente e piange in entrambi i casi), e riportano alla mente quelli di Nick che gli amici salutavano intonando accorati “God Bless America”. Quasi che il tempo, nonostante il disguido, minimamente avesse intaccato la finestra di Cimino sul mondo, ma l’abbiano resa ancora più palpabile: di nuovo, l’America non può far altro che piangere su sé stessa e sui suoi morti.
Amicizie tradite, soffiate e conflitti sono al centro del controverso “Il siciliano” (la mafia italiana, dopo quella cinese), come pure nel rifacimento di “Ore disperate” la lealtà fra malviventi e sgherri è un ciclico farsi le scarpe a costo della sopravvivenza. L’ideale pre-chiusura di un cerchio. Quel cerchio così insistentemente presente ne “I cancelli del cielo,” astratto nella simbologia narrativa e concreto nelle unità spazio-temporali: il cortile di un college ripreso dall’alto mentre i personaggi si abbandonano alle danze, una pista di legno sotto un tendone mentre si balla e si suona il violino sui pattini, il buco in un lenzuolo prodotto da un colpo di fucile, o anche il valzer di Strauss, paralleli si accostano alla figura di Averill negli anni della giovinezza ad Harvard e in vecchiaia, abbigliato esattamente come da studente e infelicemente accasato, a bordo di uno yacht che la cinepresa immortala a 360°, sul quale abbandonarsi ai ricordi. Ma il cerchio è la figura geometrica che meglio di ogni altra, forse, sintetizza l’attività artistica di Cimino, il cui viscerale amore per i grandi sentieri e la natura in toto si rivelano il baluardo conclusivo ove trovare la guarigione da un ambiente putrefatto da frenesia, corruzione e diffidenza. Oltre le montagne sacre, i deserti, i laghi, si nascondono quelle origini che l’America sembra aver dimenticato, verso le quali tornare per ottenere la redenzione. Un po’ il contrario del nichilista Peckinpah, col quale è facile intuire il comune ostracismo con produttori che ne hanno ostacolato l’opera, Cimino pare condividere il fervente desiderio di ritorno alla wilderness con Malick, giacché la poetica di una rinascita, a un tempo naturale e spirituale, cinge un profondo comune sentimento filosofico. Non è un caso che in “Ore disperate” l’agonia di Albert, sgherro del ricercato Michael Bosworth, abbia luogo in un grande lago sotto un’enorme montagna, prima di essere finito dai colpi della polizia. Non meno casuale, nell’ultimo lungometraggio “Verso il sole,” girato una ventina d’anni fa, sono un medico yuppie, figlio dell’inquinamento, e un giovane delinquente navajo, malato terminale, gli estremi prototipi maschili del testamentario saluto di Cimino al grande schermo. Ed esattamente come nella pellicola d’esordio, anche qui è presente un itinerario on the road, che, come declama la frase di lancio sul manifesto, da rapimento si tramuta in un viaggio di speranza. Il dottor Mike Monroe è anch’egli un’icona turbata dagli spettri del passato, che individua in quel piccolo avanzo di galera, n’è turbato e lo tallona come un’ombra (un’altra corrispettiva dark inside). Ma proprio il viaggio che malvolentieri il medico bianco è obbligato a condurre lo pone di fronte al fallimento del progresso americano, e gli permette di riscoprire le radici incantate che sono l’unico toccasana atto a concedere la purificazione. E l’iniziale incomprensione, a base di minacce e insulti, ridiventa poco a poco complicità e lealtà.
Un lavoro, “Verso il sole,” che è stato sbrigativamente etichettato come operazione commerciale senza infamia né lode, ma che è la summa dell’ottica ciminiana. Come giustamente ha osservato Alessandro Cappabianca, “il paesaggio è cornice, motore e meta dell’azione, luogo magico, reale e sognato, prodotto di concrezioni millenarie, davanti al quale deve deporre le armi lo scetticismo più radicato. La terapia è la Luce.” Pure, la montagna racchiude il senso di quella politique che Cimino ha imparato, senza presunzione di voler superare, dai grandi come Ford: anche se la concezione della montagna, da intendersi come la bellezza femminile (“Se ti avvicini troppo non vedi nulla, se ti allontani troppo la perdi”), è eredità di Clint Eastwood. Ma andrebbe scrutato da vicino il significato nascosto nei titoli di una produzione troppo breve – che il tempo ha reso enigmatica e preziosa – in cui il plausibile accesso ai “Cancelli del cielo” fissa le figure della sfera ciminiana in una sfera di alterchi, soprusi, efferatezze, e il percorso verso la vittoria transita da una scena di massacro a una romantica parentesi di danza. E se amara non è, non si può definire vittoria. Questo, dentro le pagine di Cimino come fuori dalla finzione, ché gli allori del successo hanno finito per traslarsi nel rancido olezzo della difficoltà artistica. I citati cancelli, trascendendo la fantasia, cedono il posto a un inferno (metropolitano sullo schermo e produttivo nella realtà) da cui poter uscire tornando a ricercare la Luce (“Sunchaser” è il bellissimo titolo originale di “Verso il sole”), infischiandosi dei dettami di produzione e dei gusti di un pubblico volubile. In tal senso, l’ultima pellicola di Cimino è il coronamento di un cerchio che equivale a una vittoria, morale e artistica, seminata nel cuore e nella mente dello spettatore. È forse nei languidi giri di chitarra che fungono da leitmotiv per le due opere principali di Cimino, nel successo e nell’insuccesso, che si può comprendere come il paradiso, ancorché utopico, sia ritenuto possibile. Sia pure a prezzo di un paio di manette che, dai polsi del navajo, scattano a quelli del bianco, onesto eppure ugualmente colpevole. E se la “lurida guerra” del poliziotto Mickey Rourke (interprete che con Cimino offrì le sue prove migliori, prima di smarrirsi) sconfina in un Golgota interminabile e prossimo alla sconfitta, quella artistica dell’alter ego Cimino, benché amara e postuma, è una vittoria. Questa, sì. What A Diff’rence A Day Makes!
SAGGI
RICHARD LESTER. A CIASCUNO IL SUO SUPERMAN
di Roberto Lasagna
Dopo l’esito di “Superman”, per la regia di Richard Donner, e di “Superman II”, realizzato da Donner e ultimato da Lester, quest’ultimo riprese il timone della serie cinematografica e i produttori gli affidarono il compito di continuare il discorso esattamente nel punto in cui era rimasto. La situazione, all’apparenza facile, non risultava invece delle più rosee. “Superman” di Richard Donner fu un notevole successo e il suo sequel raddoppiò l’impatto sul grande pubblico. I due film furono realizzati uno dopo l’altro, con una prassi che ritroviamo in ogni produzione prevalentemente seriale in cui i registi sono chiamati di volta in volta a prendere in mano le fila del racconto. Ci sono dei set produttivi, per così dire, aperti e in divenire, pronti ad essere ripercorsi incessantemente nell’era della serialità; il caso di “Superman” è emblematico di una dimensione in cui i produttori investono ma non sempre riescono a prevedere gli sviluppi delle vicende nemmeno quando tutto sembrerebbe sotto controllo. Come noto, Richard Lester sostituì Richard Donner a riprese in stato di elevato avanzamento di “Superman II”, e Donner, per motivi che oggi possono apparire un controsenso (l’“overbudget” di un film destinato a scalare i piani alti del box-office), venne costretto alle dimissioni e sostituito. I produttori non avevano forse compreso appieno il successo che sarebbe stato riconosciuto alla formula peraltro richiesta al regista uscente, e soprattutto non avevano compreso che quel risultato sarebbe stato in buona parte l’esito di una tenuta drammatica, di una coerenza classica ed epica; tratti che il lavoro di Lester, regista sbilanciato sulla modernità e attratto dalla sperimentazione, avrebbe in buona parte ridimensionato con il suo lavoro. Esistono due edizioni di “Superman II”, e quella che porta la regia di Lester uscì nel 1980 incontrando un grande successo, a tal punto che alcuni furono pronti a parlare di un sequel migliore dell’originale, dopo il caso de “Il padrino-parte seconda” che aveva fatto incetta di riconoscimenti quasi più del primo film (comunque beneficiando del consolidamento di un successo anch’esso serial-divistico-autoriale). Donner avrebbe poi rivendicato il suo lavoro in un “final cut” di “Superman II” uscito nel 2006 che cancellava il lavoro ultimativo di Lester ripristinando anche alcuni momenti con Marlon Brando girati durante la realizzazione del primo film (il leggendario attore, nel frattempo, avrebbe fatto causa alla produzione). “Superman III” comparve dunque al seguito dei due grandi successi, e mise in mostra per la prima volta il lavoro del solo Lester, alle prese con uno dei miti della cultura di massa e del fumetto. Ci furono altri problemi, non secondari. Margot Kidder litigò con la produzione dopo l’abbandono di Donner e rimase nel film solo per un cameo. Loise Lane, la collega amata da Clark Kent ma innamorata del solo Superman, appare così sostituita, e non solo simbolicamente, dalla neoassunta Lana, la compagna di scuola di Clark Kent ritrovata dal medesimo durante un viaggio nostalgico al paesello Smalleville. Mario Puzo, lo scrittore de Il Padrino la cui epicità drammatica aveva restituito respiro e solennità ai primi due film, venne anch’egli sostituito. “Superman III”, apparso nel 1983, finì allora per essere, almeno nelle premesse, un film, a tratti, “post-superman”, un’operazione post-moderna affidata ad un regista attento più all’ironia e ai ribaltamenti di situazioni (alle “mutazioni”) che all’epica, alla solenne creazione di miti. Dal regista di “Mani sulla luna”, dopo tutto, non era legittimo attendersi quel “rispetto della verosimiglianza” che Donner aveva assicurato al suo lavoro. Le premesse sembrarono anche quelle di un film che cercò di fare il punto sui tempi moderni, sull’ipercontrollo informatico nella vita delle persone; inoltre, il super-eroe si trovò per la prima volta a confronto con il proprio “lato oscuro”, secondo una voga ribadita in quegli anni dalla saga di “Star wars”, e il confronto tra un Superman incattivito e un Superman generoso può dirsi uno dei momenti più attesi e riusciti del film (complici il volto e l’espressività di Christopher Reeve, che si rivelò come l’interprete più efficace, suadente, sottile ed empatico, per il ruolo), mentre il leitmotiv della doppiezza e la non univocità dei caratteri vennero ribaditi a più riprese lungo il racconto (era involontariamente doppio Gus, che da disoccupato impenitente si scopriva genio del computer, ma era doppio nei modi anche Ross Webster, elegantissimo e garbato criminale pronto a rimpiazzare temporaneamente Lex Lutor, ed era una figura doppia davvero enigmatica l’assistente di Webster, Lorelei, bionda fatale nonché insospettabile lettrice di Immanuel Kant!).
Lester recò al progetto molto della sua impronta, della sua verve icastica; elementi sempre evidenti negli esiti espressivi di “Superman III”. Quello che manca, complessivamente, è lo smalto, anche nella decostruzione che non è mai portata davvero fino in fondo. Al di là dell’innegabile simpatia che il racconto può ispirare al cultore del periodo, il film sconta varie battute d’arresto e alla sua uscita non funzionò, oltre che per la risposta tiepida del pubblico, soprattutto per la critica che si aspettava, anch’essa, un nuovo episodio epico con il personaggio degli amati fumetti, mentre quello che si trovò di fronte fu un lavoro che lavorava nei riferimenti intertestuali (qualche volta con gusto), e non indovinava sequenze davvero divertenti o ispirate (troppa poca grazia per un atteso block-buster). Il regista di “Help!”, tuttavia, non aveva dimenticato una delle condizioni tipiche dei suoi personaggi, lo stato di fuga permanente in cui si trovano i protagonisti, per così dire, nell’occhio del ciclone. “Superman III” è allora, in questa prospettiva, un’ottima occasione per ragionare sui macro-sistemi e per rendere legittima una parodia del fumetto, ovverosia di un mondo che siamo soliti veder tratteggiato come una comic strip. Il fumetto permette di sperimentare situazioni e di manipolare il reale affidandosi, nel caso specifico, alla base fantastica di un retroterra che l’appassionato delle prodezze del personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster difficilmente avrà dimenticato prima di andare al cinema. Ma la vocazione post-moderna di Lester si scontrava, diffusamente, con le grandi attese della saga, che ebbe un sontuoso avvio per via della difesa solennità, dell’edificazione di una verosimiglianza mai così rappresentata al cinema per un personaggio dei fumetti. Nelle mani di Donner e Puzo, Superman appare infatti come l’edificazione fluente di un mito dell’America. Un lavoro in cui ritrovammo la costruzione favolosa del pianeta Kripton e Marlon Brando, padre siderale e archetipico di un giovane eletto che avrebbe raggiunto la Terra per portarvi unicamente il bene. La musica radiosa di John Williams e i titoli di testa – tuonanti invasività emotiva – avevano trionfato il ritorno dell’immedesimazione, nonché della possibilità di vedere, sul grande schermo, quello che il giovane lettore di fumetti aveva solo immaginato: l’immagine verosimile e persuasiva di un immaginario fantastico. Lester veniva da tutta un’altra storia. La sua esperienza a fianco dei Beatles lo fece partecipe di una vicenda di condivisione, di partecipazione reale. Il suo passato televisivo fu un grande apprendistato e il suo iniziale confronto con Peter Sellers fomentò l’acquisizione di un’irriverenza dai tratti sottili ma sconcertanti. Straniato e brechtiano, il suo cinema non poteva non risentire di una cultura e di una vicenda artistica non convenzionale, e un film come “Superman III” parve al regista come l’occasione ghiotta per giocare, ancora una volta, con gli stereotipi e con il determinismo sociale. Coerentemente, il film prende avvio nel modo più lesteriano, cioè con un reiterato e funambolico incrocio tra persone e sihouettes nelle strade di Metropolis, dove, tra un capitombolo e un dipinto lacerato impunemente e simbolicamente da un non vedente, tra una folla di pinguini automatizzati e la sventata caduta in un cantiere, gli abitanti sembrano assecondare una danza meccanica che in Lester rammenta la passione del regista per l’amato Buster Keaton. Qui mancano, a onor del vero, la poesia e l’imprevedibilità del grande cineasta americano. A tratti, in “Superman III”, il lavoro di Lester può rammentare quello di Peter Bogdanovich per l’intento di rivisitare situazioni e grandi aspettative del cinema e dell’America che furono. Ma in Lester non c’è nostalgia. C’è invece, prevalentemente in “Superman III”, il tono astratto che non sempre riesce a mascherare il condizionamento produttivo. Ad esempio, la rappresentazione del grande nemico, cioè il sistema cibernetico che condurrà il cattivo di turno a tentare di dominare il mondo ovverosia il mercato del petrolio dopo quello del caffè, piega il film in una direzione scontata, e Lester deve così mostrare planimetrie di controllo dei pozzi petroliferi esibendo ambienti e situazioni da kolossal iper-convenzionale. Kolossal perlustrato, più che dominato e rivisitato con pungente controllo espressivo. In effetti, gli elementi per un film più interessante e bello ci sarebbero stati tutti. Immerso in una produzione importante, con attori all’apice del loro successo (Richard Pryor), il regista sperimentatore avrebbe potuto giocare in modo frizzante, recando soluzioni espressive di effetto spiazzante. Il tono, al di là di frequenti note colorite e farsesche, pare un po’ opaco, quasi che Lester avesse voluto evocare una sorta di rivelazione funeraria. L’anti-epica non è dissacrante come avrebbe potuto. Eppure il discorso del regista è chiaro. Attraverso il fumetto, o una sua rivisitazione, si può parlare di uno scenario in cui si sono perse le redini dell’etica. Superman, ubriaco, si sente per la prima volta autorizzato ad uscire, per così dire, dal suo ruolo. Fa dispetti e non arriva puntuale nel suo compito di paladino degli indifesi. Raddrizza la torre di Pisa e falsifica la Storia (ma cambia anche i quadri ordinari e sbeffeggia chi lucra sui monumenti). Il grande eroe combatte contro se stesso e può farlo solo nel modo espressivamente più pleonastico. Lo spettacolo si mostra e si smaschera e così assistiamo ad una sorta di funerale dell’intrattenimento. Una mascherata che si offre come tale e si mimetizza. Nello stesso tempo, i personaggi, come già sottolineato, paiono doppi, doppiamente inquadrabili, imprevedibili ad un primo sguardo. Lorelei, quando si trova dinanzi al gigantesco videogioco contro Superman, incita all’eroe di spostarsi, e per giustificarsi con il suo capo Webster dice: “altrimenti non ti colpiamo”. Gus e Lorelei, non fanno paura ma non hanno nemmeno intenzioni malvagie. Sono individui senza qualità, ovverosia con qualità nascoste o inconfessate. Gus non sa di essere un genio del computer fino a quando non scopre una pubblicità commerciale sopra una scatola di cerini. Lorelei è una musa affascinante che somiglia a Marilyn e più di Marilyn pare misteriosa e incapace di scegliere un destino in piena autonomia. Questi individui bizzarri sono in pieno stile lesteriano, figure umane impotenti e inglobate in quell’affabulazione detonante che in “Superman III” si mostra costitutivamente in bilico tra le esigenze della produzione e le intemperanze d’autore. Gli accenti personali paiono avvertibili soprattutto nel disegno dei personaggi, negli accenti sugli individui per contrastare una rappresentazione “da video-clip” presto in auge. Il film non riesce ad essere pienamente elaborativo-riflessivo, ma ci restituisce un Clark Kent come il vero “superman”, l’individuo apparentemente ingenuo e buffo che in realtà si distingue dagli automi sociali, dagli “yes men” e dai pinguini impazziti che appaiono in apertura. E’ nel segno che coglie individualità eccentriche e fuori dal coro che si fa strada il vero “cinema delle mutazioni”, del contagio e delle differenze, di cui Lester ci aveva anticipato un frammento aspro sul finire degli anni Sessanta, con l’omonimo film “Mutazioni”. In “Superman III”, come richiesto dalla produzione, tutto deve essere limpido e non chiassoso, non urtante. Perfino Richard Pryor, comico conosciuto per essere sovente irriverente verso tematiche come discriminazione e razzismo, qui è molto trattenuto. Viene perdonato subito da Superman che addirittura lo raccomanderà come il miglior collaboratore per chi volesse assumerlo. Pur con i suoi evidenti limiti, “Superman III” rimane come un film lucidamente lesteriano; un ritratto, con qualche momento genuinamente dolce, dell’incanto della provincia e del disincanto degli individui, smarriti in epoca di grave discriminazione sociale (il povero Gus contro il magnate Webster); anime solitarie in cerca di un contatto, di una nuova possibilità; personaggi che si ritrovano nella grande città dove tutto è affidato al caso (la lotteria dentro la sede del Daily Planet) ed è in vendita, e dove Superman, dopo tutto, è un uomo come tutti gli altri. Per concludere, un block-buster che non fu tale ma che si sorreggeva su premesse intelligenti, e che parve, quando uscì, come tutt’altro.
OLIVER STONE E LA DIMENSIONE NARRATIVA
di Paola Dei
Giunto alla Festa del Cinema di Roma 2016 per presentare la sua ultima pellicola: “Snowden”, il cineasta newyorkese pluripremiato premio Oscar, ha messo in evidenza ancora una volta il desiderio di fare luce sulla verità dando dignità a personaggi avvolti da un alone di ambiguità.
Come non ricordare in proposito “The Doors”, un’opera biografica dedicata alla vita di Jim Morrison, impetuoso poeta della libertà e poeta maledetto. Il film fu accolto freddamente dalla critica e dai fan dello stesso cantante, ma Stone in una delle scene più significative riesce a realizzare quello che in russo viene definito “Obraz” e che in italiano potremo tradurre con “immaginità”, capacità di rendere un concetto attraverso le immagini.
Con una soluzione registica in una delle scene finali riesce in modo preciso e brillante a realizzare una struttura compositiva completa, che come un filo rosso collega tutti gli avvenimenti fino a farci comprendere che il cantante dei Doors è entrato a pieno titolo fra i grandi artisti con uno spazio tutto suo al cimitero di Père Lachèse. Un sogno che si realizza e che Stone ci mostra con una inquadratura con piani diversi di profondità avvicinando e allontanando con la macchina da presa le tombe di grandi artisti fino ad arrivare a quella di Morrison, ad oggi una delle più visitate.
I cantanti sono finalmente inscritti fra i poeti, anticipazione di quanto successivamente, proprio nel 2016 diverrà palese con il Nobel assegnato a Bob Dylan, che, come nel suo stile, non si è recato a Stoccolma per ritirare l’ambito riconoscimento.
Stone nell’intervista realizzata durante la festa del Cinema di Roma racconta le difficoltà incontrate per girare la storia di Snowden, per la quale non ha avuto finanziamenti negli Stati Uniti.
«Non credo che gli americani abbiano compreso il vero significato […], Snowden non è solo cellulari […], è stato interessante esplorare cosa ha fatto. […] Abbiamo girato in molte nazioni e abbiamo cercato di capire come narrare la storia in maniera cinematografica pur rispettando gli accadimenti. La musica che accompagna le scene aggiunge una sorta di bellezza, come elemento d’interiorità»
Quell’interiorità che il regista nel 2003 e 2004 cercò anche in Fidel Castro, il Leader di Cuba, riuscendo ad intervistarlo per ben due volte e traendo dai due avvenimenti i documentari: “Comandante” e “Looking for Fidel”, molto apprezzati da pubblico e critica. Nello stesso anno uscì nelle sale cinematografiche anche l’opera “Persona non grata”, dove viene trattata la tematica dei conflitti arabo-israeliani in Palestina.
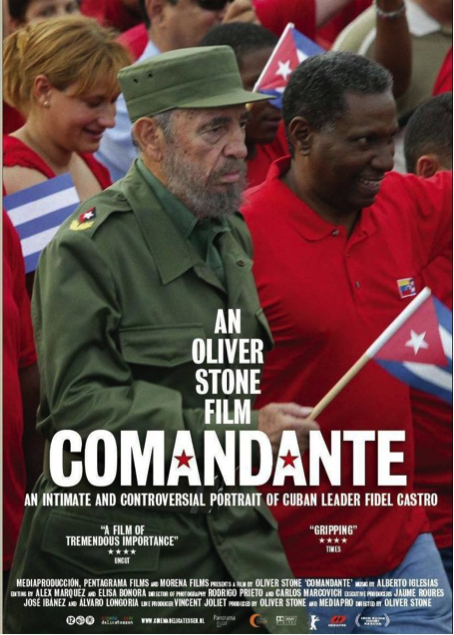 Film che hanno seguito” Assassini nati- Natural Born Killers” tratto da una sceneggiatura di Quentin Tarantino acquistata da Stone e modificata con grande gioia dallo stesso Stone che affermò di essersi divertito a sperimentare nuove tecniche registiche per ottenere il fine che si era prefissato di “elaborare la violenza per ottenere un effetto satirico”. Il cambiamento di sceneggiatura sembra però aver portato all’epoca ad una rissa epocale fra i due cineasti dalla quale Stone ne uscì con il setto nasale rotto. Anche in questo caso Oliver Stone affronta il tema dei media e di quanto rincorrano la violenza per fare audience.
Film che hanno seguito” Assassini nati- Natural Born Killers” tratto da una sceneggiatura di Quentin Tarantino acquistata da Stone e modificata con grande gioia dallo stesso Stone che affermò di essersi divertito a sperimentare nuove tecniche registiche per ottenere il fine che si era prefissato di “elaborare la violenza per ottenere un effetto satirico”. Il cambiamento di sceneggiatura sembra però aver portato all’epoca ad una rissa epocale fra i due cineasti dalla quale Stone ne uscì con il setto nasale rotto. Anche in questo caso Oliver Stone affronta il tema dei media e di quanto rincorrano la violenza per fare audience.
Anni dopo racconta i fatti dell’11 settembre 2001 nel suo film “World Trade Center” e ancora analizza la violenza da lui ben conosciuta durante la guerra del Vietnam dove fece parte della 25a Divisione di Fanteria e poi della 1a Divisione di Cavalleria, rimanendo anche ferito. La terribile esperienza ha influenzato certamente le sue scelte registiche e la sua coscienza ha avuto il ruolo di materiale ausiliario nella scelta delle tematiche da trattare oltre che nel modo in cui le ha trattate.
In mezzo agli accadimenti storici e alle innovazioni registiche Stone non si è fatto mancare neppure 6 nomine al Razzie Awards, fra cui quella per il peggior regista con il film “Alexander” che non permise ai produttori di rientrare con le spese.
Nel suo terzo film sui Presidenti americani dedicato a George W. Bush, non si fa scrupolo di disegnare la figura di quest’uomo come meschina e superficiale, affetto da una forma di bassa autostima per il continuo confronto con il padre. Il film, bandito in molti paesi venne presentato al London Film Festival. L’anno dopo Stone affronta un altro capitolo della storia del mondo con un documentario dedicato a Hugo Chavez con il titolo “A sud del confine”. Questa volta, pur in mezzo a controversie, fa centro. I suoi film riescono indubbiamente ad unificare esperienze storiche ed esperienze creative trovando soluzioni ai problemi di ritmo, movimento e montaggio e trasmettono il coraggio, per non dire la faccia tosta che il regista ha sempre usato dando del “tu” allo spettatore e mostrando una non trascurabile conoscenza della materia.
Parafrasando una frase di Jim Morrison che recita: «Se la mia poesia cerca di arrivare a qualcosa, è liberare la gente dai modi limitati in cui vede e sente.», potremo affermare che Stone ne segue la filosofia e attraverso scene indimenticabili cerca di far luce su quanto di poco chiaro ancora si nasconde nelle pieghe della storia.
IL SENSO DI BROWNING PER IL DIVERSO
di Giorgia Pizzirani
Prima dei titoli di coda del film “ Il Gobbo di Notre Dame” (1996) prodotto dalla Disney, quando Frollo è punito per la sua malvagità, Febo ed Esmeralda si ritrovano felici e Quasimodo è riabilitato agli occhi del mondo alto e basso di Parigi, il burattinaio che narra la storia invita lo spettatore a ragionare su chi sia il mostro e chi l’uomo.
Essere brutti o malati è spesso stato, storicamente, sinonimo di sbagliato e biasimevole, perché l’esteriorità si riteneva propagazione e prolungamento dell’interiorità di un uomo o donna, della loro anima: brutto significava “male”, bello significava “bene”.
Colpa di uno storpio o colpa della superstizione?
I bambini deboli o con difetti fisici venivano destinati al dirupo, nella Sparta della Grecia antica: per loro non c’era posto. Lombroso ne fece una ragione di essere nella sua datata e informale antropologia criminale.
Sul dizionario dei sinonimi e dei contrari alla parola vengono tutt’ora associati termini quali “cattivo”, “moralmente riprovevole”, “offensivo” e “sconveniente” “ripugnante”, “biasimevole”; che meglio si adatterebbero a caratteristiche morali e antropologiche piuttosto che fisiche.
E allo voce freak, chi troviamo?
Troviamo il circo di Madame Tetrallini, che ospita una umanità varia, dolente, gioiosa.
Giocolieri, trapezisti, clown, uomini forzuti, equilibristi.
E poi loro: i fenomeni da baraccone, nati, a causa di anomalie genetiche, con gravi deficienze fisiche o psichiche: i freaks, termine dispregiativo che tutt’ora nel dizionario resta sinonimo di eccentrico, strano, stravagante, diverso. Uno fuori dagli schemi comuni. Eccoli allora i superhumans della generosa signora del circo: uomini focomelici, donne barbute, nani, tronchi umani, ermafroditi, gemelli siamesi, donne dalla testa a punta.
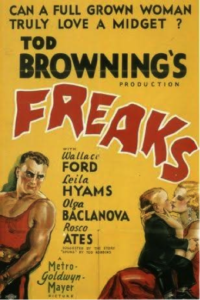 È il circo raccontato da Tod Browning del suo “Freaks” (1932), la cui ispirazione arrivò da un racconto di Tod Robbins del 1923, dal titolo Spurs (“protuberanza fisica”, “anomalia”… o magari “spurgo”, “rifiuto”, come forse potremmo leggere in un romanzo di Irvine Welsh).
È il circo raccontato da Tod Browning del suo “Freaks” (1932), la cui ispirazione arrivò da un racconto di Tod Robbins del 1923, dal titolo Spurs (“protuberanza fisica”, “anomalia”… o magari “spurgo”, “rifiuto”, come forse potremmo leggere in un romanzo di Irvine Welsh).
Nato per proporre un giocattolo più invitante e altrettanto d’effetto del Dracula di Bela Lugosi girato dallo stesso Browning per la Universal, il film fece parecchio arrabbiare la Metro Goldwyn Mayer che lo rinnegò, lo censurò distruggendo alcune parti originali. Questo il curriculum spettacolare di un capolavoro riproposto nelle sale cinematografiche il 24 ottobre scorso nella versione restaurata, originale e sottotitolata conservata nella Cineteca di Bologna.
Semplice e lineare la storia: all’interno del variopinto circo, la bellissima trapezista Cleopatra, con l’aiuto dell’amante, l’uomo forzuto Ercole, raggira il nano Hans per farsi sposare ed ereditarne tutti gli averi. Verrà però scoperta, e la vendetta sarà terribile, oltre ogni immaginazione.
Browning non applica una lente pietosa né analitica nei loro confronti, anzi si limita a riprenderne i comportamenti e la vita quotidiana all’interno del circo.
Il circo è la vita di ogni giorno, panni stesi ad asciugare tra una roulotte e l’altra, e confidenze e sfoghi tra amiche, le cose semplici e belle di ogni giorno che scaldano il cuore a chiunque. Così si assiste al mattino che vede gli artisti prima e dopo uno spettacolo, e alla nascita della figlia della donna barbuta, lieto evento che raccoglie nella tenda tutta la famiglia dei freaks per il nuovo arrivato. Ma allora, cosa c’è esattamente di diverso tra me (normale) e loro (diversi)?, viene da chiedere a te che guardi il film. Questo è uno dei grandi pregi del regista, che per la sua scelta coraggiosa di avvalersi di veri artisti circensi freaks ha pagato il prezzo di vedersi mettere alla porta del cinema nonostante abbia realizzato un capolavoro. Incoscienza o coraggio, Browning sperimenta infatti un realismo che gela lo spettatore per la sincerità toccante di ogni scena, in cui non ci sono scuse, né possibilità di chiudersi dietro al rassicurante “tanto è tutto finto”. Non c’è trucco e non c’è inganno, e trovare oggi un altro prodotto altrettanto reale al cinema, più di ottanta anni dopo, è chiedere troppo. Altro discorso per la televisione, che rende grazia a Freaks con “American Horror Story”, in cui Freaks diventa il titolo dedicato a un capitolo della serie mentre canali come Real Time propongono nel palinsesto trasmissioni dedicate a persone con particolarità fisiche importanti e gravi (Vite al limite) e nel filone dei reality cosiddetti disability shows (“Beauty and the Beast”, “Miss Ability”, “Dancing on Wheels” per citare alcuni format): ma comunque lontani dalla mostruosa umanità descritta da Browning, scevra di struttura politicamente corretta o patinata.
Compiangerli, al pari di deriderli o impietosirsi, significherebbe cadere nel tranello di una loro giustificazione o martirizzazione, ma non è questo lo scopo della storia.
Ognuno di loro è responsabile intenzionalmente delle proprie azioni, quale pezzo insostituibile di un ingranaggio umano e ancestrale che si basa sulla capacità istintiva e dell’essere umano all’interno di un sistema riconosciuto che i due avventati colleghi circensi “normali” hanno avuto l’idea avventata di sporcare. I freaks accolgono nella famiglia la bellissima Cleopatra come fidanzata di Hans: il ritornello della canzone di benvenuto con cui la accolgono alla loro tavola (“We accept her, One of us!) è epica e già contiene in sé la profezia che si avvera: è una di noi, cosa che effettivamente diventerà dopo la notte in cui viene acciuffata e resa dai freaks come una di loro, letteralmente. Finalmente si compie la piena trasformazione, finalmente Cleopatra rientra a pieno titolo – anche e soprattutto fisicamente – nella grande famiglia dei fenomeni da baraccone. Marcando in maniera neppure troppo sottile che, paradossalmente, l’esteriorità ha la sua forte ragione d’essere e va rispettata – sì, anche per un freak.
Sono vendicativi, questi mostri: passionali, esposti ma capaci, teneri ma col pugno di ferro. Potrete arrecargli un danno, mai una beffa. Sono una famiglia che si protegge e che fa pagare molto cara una mancanza di rispetto, di onore, di amore. Perché mostro, alla fine, siamo un po’ tutti quando ridiamo di qualcuno che per un millimetro esce dal cerchio di gesso che ci disegniamo (o ci disegnano?) fin da bambini. Chi deride la nostra famiglia di appartenenza o la nostra storia; è chi è convinto passerà sempre impunemente una sua mancanza di rispetto, almeno fino a quando non troverà qualcuno che gliela farà pagare con gli interessi.
Come non sentirsi uno di loro?
Oggi siamo talmente abituati alle maschere e alle immagini da non farci scioccare alla vista di un circo fatto da umani con mancanze fisiche e psichiche enormi, quali erano i reali attori del film – spesso circensi di fama internazionale, con carriere bene avviate: tra questi Daisy e Violet Hilton, Schlitzie, Johnny Eck, i fratelli Harry e Daisy Earles, Frances O’Connor, Prince Randian.
Ma il film resta tutt’ora una visione forte e un pugno nello stomaco, che veicola una superba lezione di onore e giustizia. Anche il giusto non prende la piega dolce del cosa buona e giusta, quanto in realtà della mano offensiva che viene tagliata e gettata lontano dal proprio corpo (dal Vangelo secondo Matteo), perché così è giusto. Resta un capolavoro che merita la visione di un pubblico che sia in grado di apprezzare la storia, a tratti tenera e struggente e a tratti cruenta, per le lezioni che racconta: giusto è che chi sbaglia con intenzione paghi, giusto è vedersi riconosciuti per i propri meriti, per quanto eccentrici o fuori dalla norma o soprattutto per questi stessi meriti. È giusto dare a tutti una possibilità, ed è giusto che per entrare nel cerchio di gesso si debba dimostrare di meritarlo. Alzi la mano chi, di là dallo schermo, non ha sentito che giustizia era fatta quando l’ultimo fotogramma mostrava impietoso e chirurgico cosa ne era stato di una donna un tempo bellissima… forse solo chi non ha mai provato la sensazione di sentirsi, almeno per una volta nella propria vita, un freak.
LA MANO DI TAROCCHI CHE NON SAI MAI GIOCARE:
KNIGHT OF CUPS
di Francesco Saverio Marzaduri
“O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia.
Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale,
la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare.”
FRANCESCO GUCCINI, Canzone dei dodici mesi
Con Knight of Cups, Malick prosegue una riflessione iniziata con The Tree of Life e proseguita col successivo To the Wonder, con il quale compone un dittico in attesa della prossima già annunciata opera, prevista in uscita a marzo, che realizzerà e completerà una trilogia dedicata all’umana fragilità morale, allo smarrimento di quei valori che l’evoluzione del pensiero ci ha consegnato come fondativi e universali. In “To the Wonder,” l’incantamento del titolo era dato dall’innamoramento, che sia pure intenso e avvertito come vero non reggeva al tempo e ai cambiamenti di situazione, di luogo, di condizione. Era dato dalla passione, anche interiore, che il mutare degli anni e il crescente vissuto s’incaricano di sciupare; dall’uomo che ama ma il cui amore si perde, che sciupa l’amore altrui e con ciò pecca mortalmente, condannato a ricominciare, ad amare ancora e ancora suscitando amore, poi di nuovo disastri affettivi e rancore; era il sacerdote che milita fra gli ultimi e che, schiacciato dall’immanità della disperazione che lo circonda, perde non solo la fede ma ogni possibile via di salvezza. La perdita dei valori, ci diceva Malick già in quel film, produce degrado anche fuori di noi, nel mondo stesso, con l’avvelenamento delle acque, dell’aria, del diritto stesso alla vita e alla speranza.
“Knight of Cups” ne amplia il discorso, e più che portarlo avanti sembra allargarlo, cercando altri possibili punti di partenza, trovandoli facilmente e ancora puntando da essi lo sguardo. Il risultato, sembra dirci, resta il medesimo. Osservazioni e riflessioni sono le stesse, e identiche le conclusioni. In un mondo dominato da apparenza, successo e denaro, o si sta a galla o si affonda, ci si adegua se si può e, se non si può, è la fine. E la fine è peggio della morte, perché si resta testimoni del proprio disastro personale. La Morte infatti, tredicesimo arcano nel mazzo dei tarocchi che Malick scopre una carta alla volta, può non fare paura, come non ne fa al laico che come un monaco medita nel silenzio d’un icastico giardino; sopravvivere al totale fallimento ne fa al padre del protagonista, sconfitto in tutto ciò che credeva: lavoro, dignità, sicurezza, affetti, famiglia. La sua ditta è chiusa, gli interni sono squallidamente semivuoti, lavarsene le mani con brocca e catino serve solo a sporcare l’acqua di sangue. La madre dei suoi figli non è più al suo fianco, non le è stato concesso altro che accettare senza opposizione vita e decisioni del marito, ma allontanarsi da lui e dai figli non le ha, s’intuisce, restituito serenità.
Quanto ai figli, di tre, uno è morto, forse il più promettente agli occhi del padre, e i due che restano posson dire uno dell’altro “gli voglio bene, molto, ma lo odio.” Il vuoto in cui i due fratelli interagiscono, punteggiato di mobili abbandonati qua e là, evoca il comune deserto interiore, i sentimenti sembrano non trovare altro modo di esprimersi che non sia mimesi di scontro. Non sembra esservi quiete possibile tra padre e figli, né fra costoro: non vi è ostilità ma nemmeno pace, solo frustrazioni che sfociano in rabbia: stoviglie e sedie che s’infrangono, televisori che cascano al suolo, rimandano a ben altre e insanabili rotture.
Il protagonista si muove in una Los Angeles di set cinematografici deserti, di teatri di posa come scatoloni inquietanti, di mega-party nelle ville lungo Ocean Boulevard, di studi fotografici affollati di modelle, assortite per tipologie che vanno dalla brunetta, languida, alla culturista che la direttrice di scena invita, quando posa, a immaginarsi immersa in amplessi lesbici. Galleggia in una realtà contingente indefinita, sfiora grandi ricchezze il cui riflesso lo gratifica senza includervelo, vive in luoghi dove – evangelicamente – il ladro penetra e deruba, anche se ciò che i malviventi gli portano via nella loro irruzione non è che poco, irredimibile denaro.
È stato sposato, lei era medico ma non aveva clienti glamour, esercitava in ambulatori colmi di poveracci, persone di colore, gente afflitta dalle patologie più gravi e repellenti; lo ha lasciato perché i gesti di lui, le parole di lui, i silenzi di lui non erano più gentili: “Le tue intenzioni erano ancora buone,” gli dice, “ma non venivano più dal cuore.” Dopo, ci sono state stelline e attricette, anche a coppie; poi la fotomodella conosciuta sul set, la ballerina osé incontrata in un locale di lap dance, la donna sposata a un altro che resta incinta e non sa se di lui o del marito; fino all’ultima in ordine di tempo, chissà se definitiva o meno, perché sembra esservi qualche possibilità in tal senso, ma non più che nei precedenti ménage, e dunque perché illudersi?
Questo siamo, alla fine? Fuoco? – si domanda la voce interiore – Fuoco che incenerisce nel suo procedere? Difficile osare credere il contrario quando, intorno, uno schizofrenico mondo impone differenze visibili e inquietanti, homeless a decine sparsi ovunque, a volte unica offerta umana su marciapiedi altrimenti negletti, e altrove figures of beauty che camminano sapendosi ammirate (forse però anche impaurite), un’umanità residuale disseminata lungo perimetri di opulenza e al di fuori di essi. Le feste eleganti ed esclusive dove ogni presenza femminile sembra essere pura offerta di consumo, corpo abbordabile declinato – come sostiene un anfitrione – in base a vari gusti e qualità, disponibili al desiderio e all’estro del momento. Interni in vetro e acciaio tanto più luminosi quanto disumananti, camere d’albergo vista mare, con balcone mai sprovvisto di nudità femminile tanto più folgorante nella sua bellezza quanto più lontana dalle verità dell’anima, proiettate altrove in telefonate viste e non udite, o ripiegate in sé stesse, a occhi bassi, nell’affollato interno d’un ascensore. Una realtà fatta di non luoghi, siano essi i boulevard coi filari di palme e gli edifici istituzionali e inaccessibili, o i set cinematografici in scala uno-uno di quartieri metropolitani, deserti in quanto inutilizzati, o l’opulenza della Roma imperiale ricostruita che Las Vegas, tra statue, mosaici e colonne marmoree, sbatte in faccia ai suoi visitatori.
Il mondo osservato e restituitoci da Malick è un presente felice per pochi e infernale per i più, ma sembra non recare speranza alcuna di futuro neppure a chi, come in un racconto di Poe, si chiude all’interno delle proprie fortezze escludendone la miseria altrui. La miseria è in noi, o molto vicina. Troppo vicina perché possa esservi salvezza. Dove il ladro deruba, evangelicamente, anche il tarlo corrompe e decompone. Le mega-feste, l’opulenza sfacciata, la droga e il sesso onnipresenti, non permettono nulla che non sia consumo. Sono il biblico convitto di Baldassarre, la festa sul ponte del Titanic, sono l’attimo fuggente di chi sa che non esiste un domani. Restano i sentimenti devastati, sconvolti, restano le macerie interiori. Ben pochi altri film, e forse nessun altro cineasta, ci ha dato finora un quadro più implacabilmente, dolorosamente esatto di cosa sia il presente e di cosa ci attenda. La vittoria di Trump alle presidenziali americane, e dei valori di cui si è fatto portavoce e araldo, sono la triste conferma che la capacità visionaria dei poeti altro non è, a volte, che preveggenza.
INCONTRI
L’OCCHIO (E LA MEMORIA) DI ELSA PHARAON
di Marina Ruiz
In occasione del primo riconoscimento alla figura professionale di Casting Director, l’European Casting Director Award, incontro al Festival di Locarno 2016 Elsa Pharaon, la giovane ma veterana vincitrice (insieme alla collega Antoinette Boulat) per il casting di “A testa alta” (“La tête haute” di Emmanuelle Bercot). L’interpretazione del protagonista è valsa al giovane Rod Paradot il premio César per la migliore promessa maschile e a Benoît Magimel quello per il migliore attore non protagonista, a Cannes l’anno scorso.
Passione ed entusiasmo, sono i tratti più evidenti che emergono immediatamente. In più Elsa è una persona incredibilmente amichevole. Si scusa per il suo inglese, che evidentemente non le è indispensabile: vive e lavora a Parigi, il cinema viene da lei e non il contrario. Fa la casting director da più di 20 anni, ha lavorato con una quindicina di registi, da Kurismaki (Le Havre) a Farhadi (Le passé). Poche hanno la sua professionalità e la sua energia. Elsa ha la passione della fotografia che alimenta e nasce dal suo lavoro, vuole organizzare delle esibizioni in gallerie nei prossimi mesi con delle foto di casting e creare un’applicazione per facilitare il “quick but right” casting. Ed è molto attiva in seno ad ARDA, l’associazione di Arte gestori di distribuzione in Francia.
Un lavoro che nasce dal dialogo
Ritengo che lei rivesta un ruolo fondamentale per la riuscita di un film, e lei mi dice sì con la testa ma aggiunge è anche male organizzato. Le altre figure della macchina cinema (cameramen, scenografo, costumista per esempio) si occupano di cose più concrete, mentre il casting ha a che fare con qualcosa di sfuggente: è pensiero, conversazione e riconosce che per i registi è difficile condividere le loro idee in merito alla scelta degli attori. È qualcosa che immaginano e che non è facile comunicare ad altri.
L’attore è per l’80% un prodotto del regista, ed è comprensibile la difficoltà a cedere se pure in parte la responsabilità, non della scelta, ma anche solo dell’individuazione dell’interprete. Di solito i ruoli principali sono affare del regista e del produttore (o dei produttori), i ruoli di supporto invece sono di prassi delegati al casting director.
Intuito, occhio, memoria
Le chiedo quali doti siano indispensabili per il suo lavoro. L’intuito, l’occhio e la memoria, afferma. Nonostante il suo sia ancora un ruolo che qualcuno fatica a riconoscere, ne parla sempre con il sorriso perché le piace il lavoro che fa, e come lo fa. Ha una specializzazione in street casting, che la differenzia da altri e la spinge verso terreni sconosciuti.
La sua professione è in crescita, ma non nega le difficoltà presenti e passate. Passate per vedere riconosciuto un ruolo professionale alla figura del casting director (che personalmente reputo di grande rilievo) e ad essere quindi pagati per la propria consulenza. Presente, in relazione soprattutto al lavoro con registi giovani che hanno più difficoltà a fidarsi di questa figura professionale rispetto a registi più affermati. Tuttavia le crescenti restrizioni dei budget di produzione hanno acuito l’importanza dei casting director che sono in grado di ottimizzare i costi andando a reclutare attori (o non attori, dipende dal progetto) nei posti più impensati.
Alla ricerca della grazia
A questo proposito parliamo di “A testa alta”, che le è valso l’award a Locarno. Il giovane Rod Paradot è stato trovato in una scuola professionale per falegnami, nei sobborghi di Parigi. Le scuole dove le famiglie mandano i figli come alternativa ai licei quando non vogliono studiare, che insegnano un mestiere. Nel caso specifico per fortuna che esistono! Non sarebbe mai nata una stella altrimenti. Secondo la mia interlocutrice, le facce non devono solo avere quel quid che persone come Elsa sono in grado di intuire, ma anche essere fotogeniche, qualità non banale, spesso difficile da trovare.
Le chiedo quanto conti la bellezza per un attore e quanto sia influente sulle sue scelte e quelle del pubblico. Indubbiamente è importante, ma non la bellezza “manniquin” (da modello), non piatta, ma con asperità. Questa bellezza è dappertutto, soprattutto dove non ti aspetti di trovarla. Mi parla della ricerca della grazia. È questa la sintesi magica di carisma, personalità, bellezza, fotogenia, capacità di muoversi, voce. Elsa va alla ricerca di questa sintesi ovunque, nessuna porta rimane chiusa: scuole, teatri, strada, film naturalmente.
Marion Dougherty
È lei a parlarmi di Marion Dougherty, la donna che ha creato e imposto la figura e il ruolo del Casting Director nella Hollywood degli anni ‘50. È lei che ha introdotto sulla scena “mostri” come Dustin Hoffman o Al Pacino: mostri di bravura. È lei che ha chiarito la differenza tra “bello” e “attraente”, che possono essere due cose molto lontane. La Dougherty è celebrata in un documentario del 2012 dal titolo “Casting by” di Tom Donahue e per i casting director di tutto il mondo è (o dovrebbe essere) una reference essenziale.
Sono interessata a chiederle della parte più dinamica del suo lavoro, quella di scoperta. Quindi quanti film vede all’anno, quante nuove facce scopre? Un film al giorno di media, afferma, quante scoperte è impossibile dirlo, dipende dal lavoro. Da dove vengono? Dalle scuole, dalle accademie, da Facebook, da Instagram. Le chiedo la situazione delle scuole in Francia e mi segnala il CNSAD, Conservatoire di Parigi, L’Ecole Florent e l’ESAD-TNS- École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National di Strasburgo. Ma molte altre scuole valide si trovano fuori Parigi e sono utili, anche se non indispensabili. Quando le chiedo come vede il futuro della sua professione, mi dice che le cose si stanno complicando per via della riduzione dei budget di produzione, che si riflette naturalmente anche sul lavoro del casting director. Ma la sua conclusione è: “Abbiamo meno soldi ma più esperienza, quindi il futuro è in equilibrio.”.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2016
SEDICORTO DI FORLÌ: LA TREDICESIMA EDIZIONE
di Francesco Saverio Marzaduri
Anche l’edizione di quest’anno, la numero tredici, del “Sedicicorto International Film Festival” ha riservato interessanti novità, accanto a sezioni abituali come gli immancabili incontri con gli autori, “EuroShort,” “Italian Short Film,” il workshop, quest’anno dedicato alla lavorazione di uno spot sulla città di Forlì e allo storico cinema Apollo, edificato nel 1914 e non più in attività, e “Campus Award,” riguardante il miglior progetto pitching. Ancora, conferenze e masterclass condotti da professionisti del settore come Andrea Martignoni, Jacopo Chessa, il cineasta Luigi Cozzi; si è tenuta, inoltre, una lezione per ricordare il maestro Krzysztof Kieślowski nel ventennale della scomparsa, occasione per uno sguardo a raggio sull’ultimo rappresentativo esponente della produzione polacca, dagli inizi in teatro e nel cortometraggio fino al quadro d’insieme della “Trilogia dei Colori,” suo testamentario capolavoro.
A coronamento del tutto, il progetto “S.E.I. – Scuola Educazione Immagine,” il consueto concorso fotografico “Cliccorto” e quello di critica cinematografica, quest’anno diviso in “Storie di Cinema Senior” – dove gli adulti potevano scegliere qualsiasi short proiettato durante il festival – e “Storie di Cinema Young,” che comprendeva venti cortometraggi di durata non superiore ai due minuti, appartenenti appunto alla sezione “NO+D2,” il cui vincitore era decretato da diverse scuole del comprensorio forlivese. Le recensioni più meritevoli, insieme a quella vincitrice, sono poi apparse su “Il Resto del Carlino”, edizione di Forlì. Altra novità è stata “Visegrad Animation Forum,” in collaborazione con l’omonimo evento dedicato al pitching di animazione nell’Europa centro-orientale, il cui focus è stato curato dal suo cofondatore, Michal Procházka. Infine, sono state ospitate in diverse serate del festival associazioni ed enti quali Avo, Fotocineclub, Cesena Comics, Bikers in Moto, Ior e Croce Rossa. Ghiotti i focus dedicati allo spazio cosmico, alla casa di produzione “Madrid en corto,” all’Ungheria e alla Repubblica Ceca, due retrospettive inerenti il cinema d’animazione dei rispettivi paesi, un focus sul regista Vito Palmieri e uno su “Atrium” (sezione che annovera opere di alcuni tra i dieci paesi appartenenti all’omonimo progetto internazionale, dedicato alle architetture dei totalitarismi). E ancora, la mostra-mercato “CineworkER” dedicata a dieci operatori professionisti dell’industria cinematografica emiliano-romagnola.
Per quanto concerne le sei sezioni competitive e le dieci fuori concorso, la rosa dei film è stata composta da 243 cortometraggi in cartellone, rappresentanti di 61 paesi, selezionati su oltre 5000 opere iscritte provenienti da 119 paesi. Tra gli shorts in programmazione non sono mancati nomi illustri dell’area cinematografica quali Ridley Scott e Michael Fassbender, in veste di produttori del corto di fantascienza spagnolo “Zero,” Vincent Cassel interprete del film d’azione “Violence en Réunion,” Ambra Angiolini ne “L’essenza” e Brando De Sica, nipote di Vittorio, che ha firmato la regia per “Non senza di me”.
La serata di premiazione ha visto vincitore della sezione “Movie” lo spagnolo “El adiós,” diretto dalla sceneggiatrice Clara Roquet, vicenda di una domestica boliviana che cerca di onorare le ultime volontà della donna per cui ha prestato servizio.
La menzione speciale è andata all’ungherese “Átváltozás” di Zoltán Nagy: due gemelli di dieci anni, Béla e Pistisono, vivono in un circo, e la loro specialità è il lancio dei coltelli; il padre ama solo uno di loro e, quando il figlio prediletto muore per un incidente, alla madre viene l’idea di scambiare i figli in modo da offrire al meno benvoluto l’amore sin lì negatogli.
“Audience Award” a “Hasta que la celda nos separe” di Mariana & Joserro Emmanuelli, Porto Rico: qui, l’amore e il profondo credo religioso portano il duo criminale Joseph e Liza a rapire un prete affinché li unisca in matrimonio prima che la polizia li rintracci.
Il film d’animazione francese “The Empty,” diretto da Jeong Dahee, si è aggiudicato la sezione “Animalab”. Nella stanza di una donna, i ricordi si accumulano costanti e scompaiono come polvere: un uomo trascorre del tempo in questa stanza creando inutili giochini con le memorie della donna.
Altra opera d’animazione ad avere la menzione speciale, e diretta da Liu Xin Xin, “At the Mouth of Summer” racconta di un improvviso acquazzone che obbliga la gente di un resort cinese, mentre si gode l’estate su una spiaggia, a fuggire disordinatamente. Rimanendo tra i lavori d’animazione, un altro “Audience Award” è andato al tedesco “Trial & Error,” firmato da Antje Heyn, in cui fanno capolino un bottone smarrito, alcune zie perfezioniste, gatti indaffarati, pappagalli sorpresi e un’amicizia persa da lungo tempo. Per la sezione “Animare” ha vinto “Alike,” diretto dagli spagnoli Rafa Cano Méndez e Daniel Martínez Lara, al cui centro è un padre che, costantemente preso dagli impegni, cerca di mettere sulla buona strada il figlio.
Il “Luminor Cortitalia” è stato conseguito da “Bellissima” di Alessandro Capitani, e una menzione speciale è andata a “Né leggere né scrivere” di Edoardo Ferraro. Il primo è la storia di una ragazza sui vent’anni, Veronica, imprigionata in un corpo enorme, che durante una festa in discoteca subisce a causa del suo aspetto lo scherno di un ragazzo. Il secondo narra le vicissitudini di Italo, che nell’Italia del ’63 torna nel suo paese natale, sperduto tra le montagne marchigiane, dove insieme al suo capo deve organizzare un casting televisivo, essendo a caccia di analfabeti per un nuovo format didattico. Infine, l’Italia ha conquistato un “Audience Award” con “Polchinski” di Astutillo Smeriglia, satirico short animato dove una voce fuoricampo obbliga il riluttante protagonista del titolo a dire la verità.
Vincitore della sezione “Cortinloco-Oscar Emilia Romagna,” da quest’anno aperta anche all’Emilia, è per la seconda volta quell’Alessandro Tamburini che tre anni fa aveva vinto con “Ci vuole un fisico”. Tra gli undici lavori finalisti, a fronte delle ventitré richieste di partecipazione, trionfatore è stato il suo “Camper,” girato a Barbiano di Cotignola, in provincia di Ravenna: sul veicolo del titolo vivono i tre anziani protagonisti, che, maltrattati dai compaesani e dalle autorità comunali, tirano avanti a modo loro in completa autonomia, iniziando a fantasticare su un viaggio verso destinazione ignota. Secondo posto per “Il sentimento” del forlivese Leo Canali, e terza moneta per un altro forlivese, Alessandro Benedetti, con il corto “#IBambiniSperduti”.
Nella sezione “NO+D2” ha vinto un altro italiano, “One Day in July” di Hermes Mangialardo, dedicato ai bambini di Gaza uccisi da una bomba nel 2014, mentre giocavano su una spiaggia. Il premio “Corte Tripoli” è stato assegnato a “Il sarto dei tedeschi” di Antonio Losito: nella San Miniato occupata dai tedeschi, nel luglio del ’44, il sarto del paese Paolino riceve la visita dell’ufficiale delle SS Rudolf Schmidt, che nientemeno gli commissiona un frack. Si tratta di un episodio della Resistenza realmente accaduto, giacché il sarto protagonista era il nonno dell’autore. Il premio per la miglior commedia è andato all’uruguayano “Espagnol Niveau 1” di Guy Dessent: dopo aver completato gli studi in Uruguay, il giovane Victor torna in Belgio e, per ricevere i sussidi familiari, s’iscrive al corso di spagnolo del titolo fingendo di non sapere una parola della propria lingua madre. Il premio “Euroshort” se l’è aggiudicato l’italiano “Per Anna” di Andrea Zuliani, protagonisti due bambini in uno sperduto paesino della Sardegna alle prese con un magico incontro che non dimenticheranno mai. Miglior documentario è il turco “Water Bedouins,” diretto da Ömer Güneş e da Pullucku Yavuz, in cui si racconta delle paludi lungo il corso centrale del Tigri, in Iraq. La diga di Ilisu è un progetto turco che, una volta completato, distruggerà le paludi: l’operina narra di come cambieranno le esistenze e la cultura dei beduini d’acqua del titolo, una volta ultimato il progetto. Istituito lo scorso anno, il “Pitching Euroshort” è stato assegnato al bulgaro Emil Denev.
“Water Bedouins”, di Ömer Güneş e Pullucku Yavuz
Il pubblico, che ha partecipato numeroso a tutte le serate, ha manifestato le proprie preferenze anche per altri shorts: tra gli esempi, il canadese “Beat Around the Bush” del montatore Brianne Nord-Stewart, in cui una vecchietta malata di Alzheimer decide di provare per la prima volta un orgasmo; l’italiano “Nur,” diretto da Andrea Brusa e da Marco Scotuzzi, che racconta di una rifugiata siriana che tenta di raggiungere la famiglia in Svezia; “Amal” di Aïda Senna, storia di una giovane marocchina che sogna di diventare medico e la cui aspirazione rischia d’infrangersi a causa di una violenza sessuale; “Farfalle,” firmato da Lisa Riccardi, che illustra quel che accade nella giovinezza quando ci s’innamora.
Nella sezione “NO+D2” dedicata alle scuole, i ragazzi hanno apprezzato “Beyond” di Manuele Mandolesi, inerente il soccorso prestato a una giovane incinta colpita da un colpo d’arma da fuoco, e lo svizzero “Habitat” di Marcel Barelli, che fotografa le diverse possibilità di abitazione da parte di una lumaca.
RECENSIONI
“CORTOinLOCO”
Francesco Saverio Marzaduri
Poesia – Declaration at Didong di Vittorio Nava. Il poeta e scrittore Vittorio Nava è autore a tutto tondo (regia, sceneggiatura, disegni, voce narrante) di un cortometraggio d’animazione in cui emerge il ritratto autobiografico di un artista inquieto, la cui paura del buio e della solitudine, fin dall’infanzia, hanno condotto a una politique offuscata da un ideale di bellezza ossessivamente ricercato, solo in ultima analisi idealizzato dall’estro creativo. Sei minuti in cui il verso poetico, contrappuntato dal simbolismo di illustrazioni visionarie, è sublimato dal tono di volta in volta impiegato dall’autore nel declamarlo – delicato, enfatico, intimista – dalla cui conclusione addirittura sembra scaturire qualcosa di mistico. Il risultato è incerto, talvolta sopra le righe, ma ugualmente affascinante. Bell’utilizzo di Paolo Fresu, ringraziato negli ending credits, nell’esecuzione di Chat Pitre.
Il sentimento di Leo Canali. Introdotto da una citazione di Peter Handke, questo piccolo film diretto da Leo Canali segue curiosità e pulsioni, disgusti e fantasie di un addetto alle pulizie, introverso e solitario, di un albergo: l’obiettivo ne scruta sguardi e azioni ogni volta che il giovane, trovandosi a riordinare le stanze, ricostruisce il rapporto d’amore avvenuto qualche ora prima – il misterioso sentimento del titolo – grazie a un’icastica serie di dettagli. La curiosità lascia il posto all’eccesso e al feticismo, senza ricorrere a tinte forti, attraverso una doppia parentesi, quando il protagonista fantastica d’intrufolarsi nella camera dove alloggia una coppia e qui, in un sogno a occhi aperti, abbandonarsi a una maliziosa danza à trois in stile Godard.
Un taglio nuovo di Luca Sartini. Ripetuti fondu scandiscono incessanti lo stato d’animo di un barbiere di mezz’età, e la sua grigia esistenza al fianco dell’anziana madre, in quel di Pennabilli. Adamo è afasico da quando la moglie gli ha portato via la figlia, e i giorni, anche nella bottega da lui gestita, si susseguono vuoti, monotoni, uniformi. Le persone che inutilmente cercano di sviare l’uomo dalla depressione, dal barista al postino, sono sempre le stesse; tuttavia, parafrasando una battuta del postino, una bellissima giornata si concretizza inattesa quando questi, per un errore, salva in extremis il barbiere da un insano gesto. Il taglio nuovo cui il titolo allude sottintende il possibile ritorno a una nuova vita carica di speranza, destinata al premio nel fotogramma conclusivo, laddove i viadotti di Pennabilli, attraverso i quali seguire il muto pellegrinaggio di Adamo, delineano un allegorico dedalo mentale, apparentemente senza uscita, nel quale l’uomo sembra non trovare risposte. Bella prova di Pietro Guerrini, suggestiva fotografia di Lu Pulici.
Ulisse di Silvia Bigi. Il film di Silvia Bigi è un breve documentario incentrato sulla figura dell’agricoltore e fotografo novantenne Ulisse Bezzi, intervistato nella propria abitazione di campagna insieme alla moglie Giulia. Gli inizi quasi per caso e la carriera, lo sguardo sul mondo e il punto di vista a un tempo ironico e modesto, sono narrati da Ulisse con disincantata lucidità senza celare qualche perplessità, culminando, in una punta d’orgoglio, nell’aneddoto della telefonata del gallerista Keith De Lellis, intenzionato a dedicargli una personale. Panoramiche sui campi di San Pietro in Vincoli, nel Ravennate, sono introdotti e conclusi fuoricampo da una voce femminile che, a mo’ di allegorica chiosa, declama passi da Lo zen e il tiro con l’arco di Herrigel.
Paolo Micalizzi
Il segreto della nascita dei nodi di Werther Germondari e Maria Luisa Spagnoli
Cortometraggio di carattere scientifico che vuole spiegare il segreto della nascita dei nodi. Un problema la cui risoluzione è affidata ad un mago dell’illusione. Ne nascono situazioni dal piglio umoristico che coinvolgono lo spettatore, incuriosendolo, nell’ inusuale racconto. Punto di forza l’interpretazione, e singolare presenza, del mago Bustric. Si ha notizia che il cortometraggio è un episodio di un film dal titolo “Sex Equo”. Sarà curioso vedere come esso s’inserirà in questo progetto più ampio.
Solitudine on demand di Luca Zambianchi
Cercare la solitudine è come cercare la morte. Questo potrebbe anche essere il significato di questo cortometraggio di Luca Zambianchi in cui un uomo fugge dal caos della città, quindi dal suo tempo, e va a cercare la solitudine in una collina, tra l’altro silenziosa e dolce. Che si materializza nelle vesti di un tipo vestito eccentricamente. L’uomo di città dice di essere stanco della sua quotidianità fatta di risposte al cellulare, di lavoro, delle esigenze sociali del vivere moderno. Una società impegnata che l’uomo si è costruito, rimanendone vittima. Ma anche la solitudine ha da lamentarsi perché “il silenzio è silenzioso”. Dopo un lungo dialogo i due si allontanano insieme verso l’infinito. Un’opera che porta lo spettatore a riflessioni sulla vita odierna e sulla ricerca della solitudine. Che quando la troverà, forse sarà eterna. Ipotesi avvalorata dalla atmosfera e dai dialoghi surreali.
Camper di Alessandro Tamburini
La vita va vissuta liberamente, lontana dalla famiglia e dai rapporti sociali. Cosi pensano tre amici ,ormai anziani, che cercano di trovare la felicità vivendo in un camper e scorazzando per la provincia , con puntate sulla spiaggia di una città turistica romagnola, dando sfogo a comportamenti e parole che in famiglia e in società non si permetterebbero. E a nulla vale il tentativo di un’autorità comunale a distorglieli dai loro propositi offrendo loro un appartamento. Loro insistono nella loro scelta di vita e continuano a scherzare goliardicamente rivangando anche episodi d’infanzia, arricchendoli di spacconate. Ma un incidente di percorso, il serio malore di uno di loro, li riporta alla realtà. E dovranno ripensare alla loro “avventura”. Ma poi, tranne la persona ammalata, gli altri due pensano di proseguirla o, almeno, aspettare che l’amico si riprenda.
Una storia di vita paesana intrisa di battute, a volte volgari, che fanno parte del loro humus, sanguigno e libero. Una storia arricchita di situazioni comiche che la rendono gradevole, raccontata in maniera coinvolgente.
Maurizio Villani
La fola dal tre uchini di Claudio Tebaldi
Catone animato che racconta la “Fola” (favola) di tre piccole oche che desiderano andare a vedere il mare. Il corto è recitato in dialetto romagnolo e rappresenta la storia con una particolare tecnica di composizione delle immagini, ottenute componendo le figure con un mosaico, costituito da piccole tessere di marmi colorati. Le protagoniste incorrono in varie avventure tragicomiche e si imbattono in animali e persone che ostacolano la riuscita del viaggio, che alla fine si conclude felicemente.
Oltre all’originalità della composizione dei movimenti delle figure, il corto si segnala per la brillante policromia delle immagini e per l’appropriatezza del commento sonoro.
Il sogno di Giulia di Luca Schiavoni
Il cortometraggio si apre con immagini che immettono lo spettatore in un’atmosfera favolistica, resa graficamente dai disegni delle siluette nere che si muovono su fascinosi sfondi policromi. Quando il racconto passa dal momento del sonno a quello del sogno, la scena si popola di figure inquietanti e di eventi drammatici che turbano la piccola Giulia, profondamente turbata dal sogno d’angoscia che sta facendo. La conclusione del film inserisce, dopo il cartone animato, una sequenza con immagini realiste di una giovane protagonista. Ben studiata la scelta dalla colonna sonora che si adatta ai vari registri narrativi della storia rappresentata.
Il Centro Barca okkupato. La mediazione di Adam Selo
Il Centro Barca è un centro sociale di Bologna, autogestito da anziani legati da ricordi politici e da valori solidaristici. Il film racconta la storia dell’occupazione della sede, messa in atto dai soci che si oppongono allo sfratto minacciato dal proprietario dei locali. In parallelo vediamo le attività che si svolgono nel centro – i momenti di socializzazione, il ballo, il gioco delle carte e delle bocce – e lo scontro tra il giovane proprietario e gli anziani: è uno scontro dapprima aspro che poi, alla fine, trova una soluzione che rilancerà la vita del centro e gli permetterà di finanziarne le attività. Lo stile è quello dell’inchiesta giornalistica, con interviste in presa diretta, condotte da una giovane nipote di una socia del centro.
# I bambini sperduti di Alessandro Benedetti
I bambini sperduti (ma anche gli adulti) sono illusi di poter volare nel mondo di Neverland, un non-luogo virtuale che intende sostituirsi al mondo reale. Si credono “bambini speciali” che vivono in una realtà perfetta, immune dai difetti del nostro universo quotidiano. In verità essi sono l’espressione dell’ultima forma di alienazione che la potenza del web ha introdotto nelle nostre esistenze. Tema arduo, che il cortometraggio affronta adottando un linguaggio filmico originale, caratterizzato da veloci movimenti di macchina e da un montaggio molto dinamico.
I (QUASI) MILLE DI SEDICICORTO
di Barbara Grassi
La sezione NO+D2 s’inserisce nell’ambito del progetto Scuola Educazione Immagine, che l’Associazione Sedicicorto porta avanti durante l’anno attraverso laboratori e iniziative rivolte a bambini e ragazzi. La kermesse, composta da venti cortometraggi della durata di due minuti, divisi tra animazione, fiction e film sperimentali, provenienti da Italia, Francia, Cina, Iran, Inghilterra, America, Svizzera, India, Spagna, Germania e Olanda è stata giudicata da un migliaio di studenti forlivesi, nel corso di dieci proiezioni mattutine divise in cinque giornate.
Oltre al ruolo di giurati, gli studenti si sono cimentati in quello di critici. Oltre duecento sono state le recensioni inviate al concorso di critica cinematografica “Storie di Cinema Young,” indetto dal Sedicorto International Film Festival in collaborazione con “Il Resto del Carlino”, edizione di Forlì.
Il quotidiano ha pubblicato le migliori recensioni nell’arco di quattro giornate: vincitrice è risultata una ragazza della Scuola Secondaria di Primo Grado “Marco Palmezzano”.
Divertiti, commossi, in alcuni casi obbligati a prendere atto di ciò che li circonda, i ragazzi hanno apprezzato in particolare il cortometraggio d’animazione svizzero “Habitat” di Marcel Barelli, che illustra le numerose tipologie abitative riadattate per il dorso di una lumaca (duplex, villa, condominio, albergo, museo, tenda, roulotte e via dicendo). Riflessione semiseria che ruota attorno al concetto di abitazione e all’amara conclusione che la casa è un guscio protettivo senza il quale si è destinati a soccombere.
Ancora, “Beyond” di Manuele Mandolesi, dove due paramedici dell’ospedale Saint Mary soccorrono una donna (l’attrice Roberta Mattei, vista in “Non essere cattivo” del compianto Claudio Caligari), ferita da un uomo inseguito dalla polizia. Girato in soggettiva, lo short mostra soltanto i brandelli di quanto accade: si odono suoni ovattati, respiri affannosi e colmi d’angoscia, oltre ai concitati dialoghi dei soccorritori. Nell’epilogo si ascoltano i vagiti di un bimbo mentre vediamo la giovane, colpita a morte da un colpo di pistola attraverso gli occhi del figlio.
“Border” di Paolo Zucca evidenzia il contrasto tra la vita in Occidente, dove i bambini possono frequentare corsi di nuoto e gareggiare per dimostrare la propria bravura, e l’esistenza dei rifugiati che, costretti ad imbarcarsi per sfuggire alla guerra, rischiano di morire in alto mare. Proprio com’è accaduto ad Aylan, un bambino siriano trovato morto su una spiaggia turca nel settembre 2015. La foto della sua tragica scomparsa ha fatto il giro del mondo, e il regista l’ha voluta ricordare ricreando la scena a bordo piscina, mentre altri bambini sono impegnati in una gara acquatica.
Infine, il corto sperimentale “Zusammen Eins,” firmato da Markus Wende, ha suscitato molta curiosità tra i ragazzi dell’istituto artistico-musicale, di ragioneria e del liceo scientifico. Mediante elementi quotidiani, come l’arredo di un parco o il paesaggio urbano, l’autore è riuscito a creare un montaggio omogeneo e ossessivo, vertiginoso e al limite dello psichedelico, dove le immagini si fondono con altre immagini affini, danzando al ritmo di suoni, rumori, musica. E non si può non ripensare ai risultati delle avanguardie tedesche, il cui apice è raggiunto dal documentario sperimentale “Berlino – Sinfonia di una grande città,” diretto da Walter Ruttmann nel 1927.
Nel corso dei dibatti seguiti alle proiezioni sono emersi dubbi, interpretazioni, opinioni discordanti sull’eventuale riuscita di alcuni lavori, ma anche reazioni emotive. Inoltre, ai ragazzi è stata illustrata per sommi capi la storia del cinema breve in Italia.
La giornata conclusiva della sezione è stata arricchita dalla presenza di Frank Dorren, produttore del corto olandese “Zoet Slapen” di Andries Wijnker, che ha risposto ai numerosi quesiti del giovane pubblico. Prodotto dal cortese ospite, il film narra di un bimbo desideroso di festeggiare i pesci dell’acquario di casa, nel giorno della festa degli animali. Dal momento che la madre era solita utilizzare uno sciroppo a base di frutta per guarnire i dolci, il piccolo decide di versarlo nell’acqua dei pesci, che muoiono. Il desiderio innocente di festeggiarli getta il protagonista nello sconforto.
Le domande rivolte a Frank Dorren nell’ambito del cortometraggio, e del cinema in generale, si sono rivelate le più disparate: quale fosse il significato della storia in “Zoet Slapen,” in cosa consiste la realizzazione di uno short, quanti passaggi di lavorazione occorrono, quanto costa realizzarlo, se la storia fosse vera o meno, in cosa consiste il lavoro del produttore, come fosse nata in lui la decisione d’intraprendere tale mestiere, se fosse molto remunerativo. E, ancora, se fosse più facile lavorare con adulti o bambini, e se si possa essere attori senza frequentare scuole di recitazione.
Il pubblico è stato però concorde nel decretare la vittoria al film d’animazione “One Day in July” di Hermes Mangialardo, dedicato a Ismail, Mohammed, Zakaria e Ahed, quattro bambini in età compresa tra i dieci e gli undici anni, rimasti uccisi il 16 luglio del 2014 durante un bombardamento mentre giocavano sulla spiaggia di Gaza. Per le autorità israeliane si trattò di un errore d’identità, in quanto i militari li avevano scambiati per miliziani di Hamas, e non vi fu processo. Più in generale, l’opera è dedicata alle vittime innocenti.
CINEWORKER E INCONTRI CON GLI AUTORI
di Tommaso Valente
Dal 12 al 15 settembre la Sala Borsa di Forlì è diventata il punto di incontro tra numerosi professionisti nel campo del cortometraggio provenienti da tutto il mondo. Durante la 13a edizione del Sedicicorto International Short Film Festival si sono infatti svolti in quel luogo sia la prima edizione dei CineworkER che i consueti incontri con gli autori ospiti del festival.
In questo modo gli organizzatori del festival hanno cercato di creare una zona franca dove la creatività, la tecnica e la componente commerciale trovassero un terreno comune nel quale confrontarsi.
Il progetto CineworkER nasce per favorire la circolazione delle opere e valorizzare progetti di alfabetizzazione e di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Sedicicorto è ormai da tempo un punto di riferimento importante per il mondo del cortometraggio anche a livello internazionale, per numero e qualità di ospiti e film in programmazione. Trovare il modo di coinvolgere diverse realtà della Regione mettendo a disposizione spazi di confronto dove professionisti del settore possono trovare nuove idee, affrontare nuove tecnologie, creare sinergie e dialogare con il pubblico e gli ospiti del Festival per migliorare e stimolare la formazione culturale è stata da subito la principale ambizione.
In questo senso CineworkER è stato un evento unico finora nei Festival di corti. Ciascuna azienda ha avuto la possibilità di presentare la propria attività pubblicamente e i giorni scelti per le presentazioni sono stati gli stessi di maggiore affluenza di ospiti stranieri e di autori, intervenuti per presentare i loro film nel concorso.
Sono quindi state create tutte le opportunità affinché ciascuno fosse a proprio agio e potesse sfruttare al meglio il tempo a disposizione. In linea con la scelta di mantenere l’ambiente quanto più informale possibile anche i pranzi e le cene sono diventati occasione di confronto.
Il mondo del cinema è solitamente molto competitivo e particolarmente spietato, soprattutto oggi, in uno scenario difficilissimo da un punto di vista del mercato e con innumerevoli forme creative che le nuove tecnologie mettono in campo. In quei giorni invece si è creata una atmosfera di condivisione e di curiosità, di confronto e di opportunità di collaborazione. Le realtà più giovani come “Human Reels”, “Ce l’ho corto – Kinodromo” e “Studio Chroma”, tutti ventenni e tutti provenienti da Bologna, hanno avuto modo per la prima volta di raccontare la loro attività ma anche e soprattutto di attingere da professionisti più esperti. Sempre da Bologna arrivano Adam Selo e Olga Torrico di ElenFant, una realtà ormai consolidata che si occupa di distribuzione. Matteo Santi da Cesena presentava invece la sua attività di montatore e ha raccontato l’esperienza del montaggio di “Mine”, un film lungometraggio dal respiro internazionale che ha montato recentemente. E così ogni realtà si è raccontata, “L’atelier del Cartone Animato” con Stefano Tedaldi; “3D production” da Parma; “22 s Productions” di Pennabilli; “Cesena Comics”; “Filmaremonti” di Ravenna e “Sunset” di Forlì. Molti tra loro non si conoscevano, sia pur operando nella stessa regione e nello stesso mercato: quindi il primo vantaggio della manifestazione è stato quello di avvicinare le realtà contigue di una regione molto “lunga” e dalle anime variegate. Ma ancora di più lo hanno fatto le occasioni di incontro con il mondo del cortometraggio internazionale e con i migliori registi di corti contemporanei sul mercato italiano.

Convogliando infatti nello stesso luogo ad orari alternati gli incontri con gli autori, si è creato un alto grado di partecipazione tra le attività del Festival e quelle dei CineworkER. Quest’anno gli incontri con gli autori sono stati particolarmente informali e sono stati moderati cercando di aprire quante più possibilità di dialogo tra i partecipanti. Si è parlato di storie e sentimenti, di personaggi e di racconto. Insomma, si è cercato di trovare un minimo comune denominatore dal quale partire per creare quanti più punti di contatto tra gli ospiti.
Sicuramente la parte fondamentale di un Festival e la sua qualità si basano sulla programmazione ma le possibilità di incontro hanno la capacità di proporre occasioni speciali a chi quei film li crea e li promuove. Si pone come anello importante di una catena che si sta costruendo in un panorama sempre più globalizzato dove locale e internazionale devono diventare due elementi caratterizzanti di uno stesso percorso. È stata una prima edizione e tante ancora sono le cose da migliorare e gli spunti da seguire ma una cosa è certa, era un tassello di cui si sentiva la mancanza.
MISFF 67th MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
RICCO DI INIZIATIVE IL MISFF 67
di Paolo Micalizzi
Il MISFF 67 ha premiato con l’”Airone d’Oro” alla carriera il regista Neri Parenti, “re” dei cinepanettoni avendo alle spalle vent’anni di film natalizi che, spesso, si sono classificati tra i primi tre campioni d’incasso. Un autore, quindi, i cui film, non amati in generale dalla critica, hanno però dato ossigenato alla produzione italiana consentendo che si siano potute realizzare altre opere. Altro “Airone d’Oro” alla carriera all’attrice Federica Vincenti, fondatrice della Goldenart e moglie di Michele Placido. Sono stati questi i momenti più popolari del MISFF 67, presieduto da Marcello Zeppi, che ha come direttore artistico il critico cinematografico Giovanni Bogani. Un Festival ricco di iniziative, come si può anche constatare dagli articoli pubblicati in questo numero di Carte di Cinema relativi al MISFF67 che riguardano: il concorso Internazionale con film di fiction, d’animazione, documentari e sperimentazioni , categorie che troviamo anche nei corti per le scuole, la “Vetrina FEDIC”, i corti sull’handicap. Ma anche un bilancio della prima edizione di “The Autor’s Day” curato da Alessandro Grande e Antonella Santarelli che del Festival è stata anche la direttrice della Commissione artistica che ha selezionato le opere del Festival: centocinquanta, provenienti da 29 paesi. Il Concorso Internazionale ha visto vincitore il cortometraggio di Andrea Zuliani “Per Anna”, che racconta l’incontro in Sardegna tra due bambini provenienti da realtà e ambienti molto diversi: Nicola, un bambino di Gergei, e Anna, una bambina milanese, nel giorno che precede San Biagio, la festa più sentita del paese; i due bambini passano insieme una giornata unica e indimenticabile alla scoperta di un mondo che per Anna è totalmente sconosciuto.
Premiato come “Best Italian Short Film” il corto “Djinn tonic” di Domenico Guidetti con protagonisti un giovane precario senza più aspirazioni essendo scappato da una crisi economica e un genio della lampada ( interpretato da Francesco Pannofino) in crisi d’immaginazione che lavora in uno squallido ufficio nella periferia. I premi sono stati attribuiti da una Giuria internazionale presieduta dallo spagnolo Alfonso Palazon e composto da Rita Capucho(Portogallo), Edoardo Tabasso(Italia), Javier Venturi(Italia-USA), Roberto Valdes(Messico), Marina Fomenko(Russia), Patrick Hadjadj(Francia), Flavia Vargas(Francia) e Anastasia Poloiakova(Russia), che ha anche giudicato migliore Opera Prima “The silence” del romeno Artur Borusz che ha anche ricevuto il premio “Best Film Schools Fiction Film”: un’opera che ha saputo riprendere dall’interno una crisi di coppia e che ha interessato pubblico e giuria per l’originalità e la profondità del soggetto. Per il miglior documentario la scelta è caduta sul siriano “Shakespeare in Zaatari” di Maan Mouslli che racconta la toccante ed estremamente attuale esperienza di un gruppo di bambini siriani che, in un campo di profughi in Giordania, hanno messo in scena due drammi di Shakespeare, “Amleto” e “Re Lear” prima che le loro vite prendessero direzioni diverse, e per qualcuno drammatiche. Per la Giuria “un’opera che ci ricorda che apparteniamo alla stessa umanità”. Altri i Premi assegnati. Tra essi: Per il “Best soundtrack”, premiato “Rough cut” in quanto “il film abbraccia le polifoniche voci della società multiculturali” e per il “Best Fiction Film” il corto del francese Romain Quirot “L’ultimo viaggio dell’enigmatico Paul WR” , incentrato su un’astronauta che potrebbe salvare l’esistenza umana sulla terra dalla minaccia della luna rossa, che però scompare poche ore prima della grande missione. Un corto che la Giuria ha premiato “per la potenzialità di diventare lungometraggio pieno di segreti e rivelazioni”. Premi anche nella “Vetrina FEDIC” la cui Giuria era composta da collaboratori della Rivista on line “Carte di Cinema”: Paolo Micalizzi (Presidente), Maurizio Villani, Marco Incerti Zambelli. Primo premio, ex aequo, a “Medee” di Carlo Allorio e Giorgio Sabbatini(Cineclub Piemonte) ed a “Si deve morire” di Roberto Merlino(Cineclub Corte Tripoli Cinematografica- Pisa). Al primo “per la complessa struttura del film, in cui s’intrecciano il mito classico, il teatro tragico e una vicenda contemporanea. Il conflitto dei sentimenti di amore e odio, di gelosia e vendetta è rappresentato con sicuro controllo del linguaggio cinematografico. Efficace la recitazione e suggestive le riprese dell’ambientazione”.
Il corto di Roberto Merlino è stato invece premiato “per la sarcastica ironia di Achille Campanile che ispira un’opera che si muove con equilibrio tra il surreale e il satirico, ruotando attorno agli atteggiamenti che suscita il lutto di una persona. L’opera ,sorretta da una felice interpretazione, mette in scena un’acuta e brillante rappresentazione dell’ipocrita e vana ritualità del senso comune”. La Giuria ha poi ritenuto di attribuire una Menzione speciale al corto “Graszie” di Antonella Santarelli intendendo cosi “ valorizzare la capacità dell’autrice di rappresentare in una estrema sintsi un’idea originale con grazia e umorismo”. Un’idea che ruota attorno all’incontro tra un bambino italiano ed uno Rom. Particolare valore ha assunto al Festival la sezione “Handicap”. Ne riferisce in questo numero della Rivista Sara Riccobono, il cui sguardo è particolare essendo essa una portatrice di handicap.
RECENSIONI
ALFREDO BALDI
Concorso internazionale
Blind Seam di Eric G. Du Bellay, (Islanda)
Si sta girando un film. La giovanissima regista, china davanti al monitor, istruisce gli attori sul comportamento che dovranno tenere nella scena d’amore che stanno per recitare; fa anzi ripetere la scena perché l’interpretazione, a suo parere, non è stata abbastanza passionale. Alla fine dà lo stop, saluta la troupe, si alza, prende un bastone che aveva accanto a sé ripiegato e se ne va via tranquillamente, da sola: ma il suo bastone è bianco, la regista è cieca! Brevissimo film con un’idea originale di grande forza espressiva che illumina il finale di una luce folgorante, ricordandoci che la disabilità non ci rende necessariamente “disabili”, ma può essere spesso una risorsa per arricchire la nostra vita e quella del nostro prossimo.
Per Anna di Andrea Zuliani, (Italia)
Anna, bambina di città, fa amicizia, al paese natale di suo padre, con Nicola, un bambino muto che gli altri bambini evitano. Terminata la vacanza, Anna riparte per la città con il padre. Nicola, nonostante che insegua a lungo per le viuzze del paese l’auto che sta portando lontano Anna, non riesce a raggiungere l’amichetta e a consegnarle un regalo. Molti anni dopo Anna torna al paese, ma apprende che Nicola è morto tre anni prima, nel generoso tentativo di salvare vite umane. Profondamente turbata, Anna si reca nella casa dove Nicola abitava e lì trova il regalo che, nel tempo lontano, il bambino aveva preparato per lei. Mentre il colpo di scena finale è forse un po’ prevedibile, tutta la narrazione è leggermente velata da un tono nel quale il lirismo si accompagna al melodramma, provocando un leggero disorientamento nello spettatore. L’ambientazione (scene, costumi, fotografia) è di ottimo livello e illustra efficacemente i sentimenti che agitano i protagonisti. Gli attori, sia i piccoli che gli adulti, offrono una buona interpretazione, in un film che ci vuole ricordare ancora una volta che, se la disabilità toglie qualcosa, da un altro lato rende più ricco chi ne è portatore e coloro che ne vengono in contatto.
The Silence (Silenzio) di Artur Boruzs, (Romania)
Un film senza parole, con dialoghi solo mentali che si alternano tra un lui e una lei di una giovane coppia in crisi. Lui ha perso tutto al gioco, anche la casa, lei non lo sa ancora, lui non sa come dirglielo. Si seguono nella casa da una stanza all’altra, quasi come in un inseguimento, quasi gomito a gomito, ma senza mai incontrarsi veramente. La loro prossimità è solo fisica, materiale, mentre ciascuno è intento alle proprie occupazioni, e i loro discorsi mentali proseguono incessantemente, senza un attimo di pausa. Trovata originale, all’inizio spiazzante, poi lo spettatore entra nel gioco e vorrebbe quasi gridare ai personaggi di fermarsi un momento, di rompere l’isolamento reciproco e di parlarsi non solo con il muto pensiero, ma anche materialmente, di fermare quella specie di gioco al massacro. La solitudine non è quella fisica, materiale, ci dice il film, ma è quella di due anime che non si incontrano più, che “pensano” solo al proprio io e hanno smesso di cercarsi e di capirsi nella vita reale.
The Ravens (Corvi) di Jennifer Perrott (Australia)
Madre e giovanissima figlia vivono in una casa in campagna, in mezzo alla natura quasi intatta. Per andare a scuola, da sola, la bimba attraversa un grande bosco, senza alcun timore degli esseri che lo abitano. Il padre torna a casa dopo una lunga assenza, forse è stato in guerra, ma il suo stato psichico è disturbato; pretende infatti di insegnare alla piccola come affrontare i corvi che vivono nel bosco senza farsi attaccare da loro. Quando la bimba attraversa di nuovo il bosco da sola seguendo le istruzioni del padre, i corvi l’attaccano e la feriscono. Il padre per vendetta, contro la volontà di sua moglie, ammazza a fucilate gli uccelli. La piccola Ruby, da sola per esorcizzare la paura, torna sul posto dove i corvi sono stati uccisi. Poi va al mare con il padre e fanno il bagno insieme, serenamente. Si tratta in sostanza del racconto di una famiglia che entra in crisi per il sopraggiungere di un corpo ormai estraneo (il padre), del conseguente, progressivo precipitare verso la tragedia – evitata però per merito della componente più giovane (la bambina) – e del graduale ritorno alla normalità familiare. La trama non è sempre chiarissima ed evidenzia con qualche lacuna di sceneggiatura, e quindi di raccordi, tra una sequenza e l’altra. Una storia declinata tra horror e “Gli uccelli” di Hitchcock che a volte tiene con il fiato sospeso, altre volte si rivela banalmente prevedibile. Gli attori tuttavia sono strepitosi, soprattutto la bambina, nella loro recitazione asciutta, essenziale, a sottrazione, favoriti nella loro performance da un paesaggio affascinante, quasi selvaggio, che ben si adatta al tono, ora idillico, ora drammatico, del racconto.
Rough Cut (Montaggio preliminare) di Asmael El Moudir (Marocco)
Un anziano proiezionista che gestisce una sala in crisi nella campagna desertica del Marocco (lo spettatore è sempre uno solo), per invogliare il pubblico taglia le scene noiose delle pellicole. Il giovanissimo nipote che sta imparando il mestiere dal nonno, vuole evitare la chiusura del cinema: assembla un film con scene madri da molti film famosi e pubblicizza il nuovo spettacolo per tutto il villaggio. Grande è il successo di pubblico; il nonno si entusiasma nuovamente e aiuta il nipote, ancora inesperto, nella proiezione. Il futuro della sala cinematografica – una baracchetta in muratura eretta nel nulla del deserto – è salvo. Metacinema, semplice e sentito, anche se al limite del prevedibile, che racconta una storia che conosciamo bene, la chiusura delle sale cinematografiche per mancanza di spettatori. Ma la freschezza delle giovani generazioni, e delle popolazioni non ancora disincantate (come invece siamo noi europei), vince le difficoltà oggettive che un paese arretrato e una natura non amichevole frappongono. E se anche noi “occidentali” ci spogliassimo per un momento (o, magari, per sempre) della nostra superiorità, del nostro disincanto, del nostro distacco, e provassimo ad affrontare i nostri giganteschi problemi affidandoci alla forza dell’entusiasmo?
Everything’s fine (Va tutto bene) di Laurent Scheid (Francia)
Raphael fa l’amore con la sua ragazza, la quale subito dopo esce di casa per andare alla prova generale dello spettacolo di cui è protagonista. Lui invece si reca al carcere, dove si aspetta che gli venga sistemato il braccialetto elettronico (ha in sospeso con la giustizia un vecchio conto, di lieve entità), invece è trattenuto lì. La fidanzata lo aspetta allo spettacolo e lui cerca in tutti i modi di avvertirla del suo arresto. Dopo molte insistenze con le guardie riesce a telefonarle, ma non ha il coraggio di confessarle la verità. Opera prima che risente di inesperienza di sceneggiatura che rende la trama poco chiara e, soprattutto, poco contestualizzata. Il pregio maggiore del film sta nella recitazione degli attori, tutti efficaci, essenziali e senza sbavature interpretative.
Giochi di ruolo di Francesco Colangelo (Italia)
In un parco passeggia una giovane che donna si porta dentro un matrimonio in crisi, a causa di un lui che parte spesso e torna dopo troppo tempo. Ma nel parco c’è un altro lui, giovane come lei, che la consola, l’abbraccia, sembrano due amici, quasi due innamorati. Ma al momento di separarsi lei gli consegna del denaro: “quando ci vediamo?” dice lei; e lui: “quando vuoi, io sono sempre qui”. Siamo di fronte a un breve numero zero (forse sarebbe più esatto dire un promo) per una serie TV di ben 50 puntate scritta da Francesco Colangelo, presentato già nel 2014 al Bovino Independent Short Film Festival e, nel 2016, a Valdarno Cinema Fedic. La serie è imperniata su un gigoló (Andrea Napoleoni) che “incontra” giovani donne (qui è Valeria Solarino, ma ci sono anche Giulia Michelini, Antonia Liskova, Carolina Crescentini) e diventa loro amico e confessore, psicologo e consulente sessuale. Il brano proposto è troppo breve e criptico per comprendere, senza altri riferimenti, di cosa si tratti e quali siano i possibili sviluppi della storia (delle storie, in questo caso). Il solo titolo, in fondo, ci spiega molto di più di quanto non riescano a raccontarci le immagini e i dialoghi. Senza contare che presentare un prodotto altamente professionale a un festival di cortometraggi indipendenti è un’operazione che lascia perplessi.
Sottoterra di Federico Olivetti (Italia)
Il bimbo Michele va a trovare la bimba Lisa nella sua grande villa in campagna, dagli interni completamente spogli e inquietanti. Lei lo conduce nel parco a vedere una grande buca, stretta e profonda, dove lui scende, per poi emergerne dopo poco. Ma Michele è terrorizzato e fugge verso la casa. Lei gli chiede cosa abbia visto dentro, lui non risponde. Michele riparte con i genitori. Lisa va a controllare la buca e la trova chiusa da grossi massi. Film di assenze: di trama, di movimento, di immagini, ma anche di recitazione, quest’ultima essenziale e lentissima. È un prodotto realizzato in maniera professionale più che dignitosa, ma troppo criptico per poter azzardare un’ipotesi sul messaggio che il regista ha da raccontarci.
Sole di Stefano Valentini (Italia)
Una donna che vive sola, anziana e un po’ fuori di testa, telefona alla figlia. Lei non risponde; ma alla seconda telefonata che le arriva di lì a poco la giovane alza il ricevitore e accondiscende a parlare con la madre, la quale si inoltra in un lungo e sconclusionato soliloquio che la ragazza ascolta in silenzio. Ritratto di due solitudini; la prima più evidente, quella dell’anziana madre; la seconda, quella della figlia che rifiuta in un primo momento il colloquio, più sottile e nascosta, ma non meno effettiva e reale. Storia di grande malinconia, ritratto tristemente veritiero di tante esistenze dei nostri tempi nei quali le “modernità”, e in particolare i mezzi di comunicazione sempre più efficienti e a portata di tutti, non hanno favorito e prodotto una reale “comunicazione” tra gli esseri umani, neppure tra quelli che i legami di sangue dovrebbero rendere più vicini e in sintonia tra loro.
Bellissima di Alessandro Capitani (Italia)
Siamo in una discoteca del napoletano. Veronica, una giovane ragazza bruttissima più che obesa, si è chiusa disperata e piangente in un gabinetto della toilette dei maschi (dove è fuggita per suo errore) perché il ragazzo che le piace ha baciato un’altra. Le amiche che sono con lei e tentano di consolarla alla fine l’abbandonano, stanche di aspettare che lei esca. Entra nella toilette un giovane spacciatore di coca, con due altrettanto giovani clienti che si fanno un tiro. Usciti i ragazzi, lo spacciatore sente sommessi singhiozzi provenire dal gabinetto chiuso e inizia una conversazione surreale, tutta imperniata su un narcisismo d’eccesso, con Veronica. Lui le chiede come sia fatta, lei risponde di essere bionda e con gli occhi azzurri (in realtà è bruna e ha gli occhi neri); lui di rimando le dice che assomiglia a Brad Pitt (in realtà è brutto e di carnagione scura). Lui cerca di convincerla a uscire perché vuole vederla a tutti i costi, ma lei resiste alle lusinghe. Intanto la toilette si è riempita di altri 4 o 5 ragazzi. Alla fine, vinta dalle insistenze, Veronica, ripetendo tra sé e sé “sono bellissima”, apre la porta del gabinetto. Lui la vede, ma fa finta di niente (lei non lo ha mai visto, ha solo sentito la sua voce) e se ne va di soppiatto e in silenzio. Ma un altro dei ragazzi che sono nel bagno rimane folgorato da lei e le fa un grande sorriso, conquistato. Veronica è convinta che sia lui quello che le parlava, ed è conquistata anche lei.
Vincitore del “Marzocco 2016” alla XXXIV edizione di “Valdarno Cinema Fedic” come migliore opera in assoluto tra le 27 in competizione, “Bellissima” si presenta come un piccolo film geniale nella semplicità della sua idea. Giusy Lodi è la ragazza che impersona Veronica, sgradevole quanto si vuole nel suo corpo sgraziato che il regista oltre tutto ci restituisce con immagini tutt’altro che benevole, ma di una bravura che sfiora il virtuosismo nell’essenzialità e nell’asciuttezza della sua recitazione. Così come bravissimi sono tutti gli altri e tutte le altre interpreti. Anche se recitato in napoletano stretto, quasi incomprensibile a chi non parla quel dialetto, nessuna sfumatura e nessun significato dei dialoghi va perduto. Nel pieno rispetto delle tre unità aristoteliche di luogo, di tempo e di azione, il racconto si svolge in un solo ambiente, la toilette dei maschi, in tempo reale e descrivendo un’unica azione. Ma non solo: all’eccellenza dell’interpretazione si sommano uno straordinario ritmo, un magistrale montaggio, nonché – qualità rara e altamente apprezzabile – una fulminante sintesi di racconto: 11 soli minuti.
Without (Senza) di Paola Sinisgalli (USA)
Il film è ambientato in Basilicata ed è stato girato nel piccolo paese contadino di Vaglio (PZ), in un paesaggio brullo e assolato, tipicamente meridionale. Compare Vincenzo, un anziano che la solitudine e le ristrettezze hanno ridotto un ubriacone, è morso da una vipera mentre si reca al cimitero. Soccorso da un paesano, poi dal prete, giunge in ospedale con la macchina di quest’ultimo attraverso circostanze tragicomiche. Ma la gamba offesa sta andando in cancrena e i medici tentano una difficile operazione chirurgica che ha successo. Dimesso dall’ospedale, Vincenzo non sarà più solo: il suo giovane soccorritore lo porterà a casa sua e ne farà il nonno dei suoi figli. Opera prima di Paola Sinisgalli, regista di origini lucane ma trasferitasi da molti anni negli Stati Uniti per lavoro, il film è la storia di una solitudine e di come questa venga ingigantita dall’isolamento geografico e psicologico dei piccoli borghi rurali. Allo stesso tempo, però, in queste realtà si celano forti legami umani, creati dall’inevitabile vicinanza tra gli abitanti, che sono in grado di rompere le condizioni sfavorevoli e di restituire vita e speranza. Lodevoli intenzioni, supportate da una trama originale, pur se con una recitazione e un montaggio tradizionali. Protagonista nel ruolo di Vincenzo è Massimo Bonetti, affiancato come co-protagonista dal giovane attore lucano Giuseppe Ragone.
Asphyxia di Alessandra Angeli (Italia)
In un futuro distopico, tutto l’ambiente della Terra è fortemente inquinato: aria, terra, piante, acqua. All’esterno bisogna indossare sul viso una maschera per respirare. Non si può circolare con auto private, la polizia e l’esercito sono dappertutto per far rispettare i divieti. Tra gruppi di giovani, ragazzi e ragazze, si succedono scontri, anche mortali, per la sopravvivenza, sotto un cielo minaccioso oscurato da giganteschi tornado e spaventose trombe d’aria, pronti a spazzare via quello che resta della civiltà. Previsione apocalittica di quanto potrebbe accadere al nostro pianeta se non verrà fermata al più presto la produzione di sostanze inquinanti e il conseguente riscaldamento globale, questo lungo corto (mezz’ora) non convince appieno. Infatti le lodevolissime intenzioni – mostrare a quali terribili conseguenze stia andando incontro la Terra a causa dell’incosciente modello di sviluppo perseguito dalla razza umana – non vengono però completamente sostenute dalla realizzazione che, pur presentando momenti di grande drammaticità e immagini di potente impatto visivo, sconta il difetto di una sceneggiatura non perfettamente risolta e quindi di una trama piuttosto involuta che, unita a una fotografia dai toni cupi o addirittura bui che rende difficoltoso il riconoscimento dei personaggi, non aiuta la comprensione.
Solitudine on demand di Luca Zambianchi (Italia)
Un uomo che vaga su colline deserte incontra un personaggio in abiti ottocenteschi che afferma di essere la Solitudine. L’uomo gli risponde che è proprio ciò che cercava, poiché desidera fuggire via dalla frenetica vita di città, e instaura con la Solitudine un dialogo filosofico su cosa sia la solitudine e dove la si possa trovare. La Solitudine asserisce che la solitudine, se la si cerca bene, è dappertutto, anche in mezzo alla folla. L’uomo allora gli chiede una solitudine “on demand”, per poterla gestire a proprio capriccio, quando e come vuole. Ed ecco che la Solitudine gli consegna un televisore, tutto ciò di cui hanno bisogno gli uomini moderni, uno strumento che ti dà tutto ciò che vuoi senza chiederti nulla in cambio. Quanto a dire il massimo della solitudine e dell’incomunicabilità. L’uomo si allontana allegramente, saltellando e portando gelosamente tra le braccia il “suo” apparecchio. È questa, allora, pare che ci chieda il regista, la condizione a cui ci costringe la nostra vita di “teledipendenti”, di persone che passano ore, ogni giorno, davanti allo schermo televisivo? Parabola surreale e grottesca su un tema peraltro non nuovo, la pericolosità della Televisione, di un mezzo di comunicazione a senso unico, che ti comunica ciò che vuole ma non permette a te di comunicare con lei.
Domani smetto di Monica Dugo- Marcello Di Noto (Italia)
Imma Mondello (Monica Dugo, attrice di straordinaria spontaneità e travolgente simpatia, anche coregista del corto) è un’attrice non più giovanissima che ha fatto una carriera faticosa e di non grandi soddisfazioni, sempre in attesa della telefonata – la ben nota “ossessione” di ogni attore – che non arriva quasi mai e, spesso, arriva al momento meno opportuno. Imma quindi ha deciso di smettere di recitare e si reca dagli “Attori anonimi” dove racconta al direttore dell’agenzia (uno stralunato, narcisista ed efficace Giuseppe Piccioni, qui nelle vesti inedite di attore), in una specie di seduta psicanalitica liberatoria, la sua carriera, con le molte umiliazioni, le non poche delusioni e gli scarsi successi. In numerosi flashback ripercorriamo anche noi la carriera di Imma, che inizia come “ragazza coccodè” (“teatro d’avanguardia”, afferma Imma), per poi passare alla pubblicità (“acciughe, molto salate” precisa lei), per finire con il cinema, dove i provini sono sfibranti e le attese non finiscono mai, per il quale ha girato una scena nella quale aveva il ruolo di un rapinatore con il casco (“ma alla fine me lo toglievo” puntualizza Imma). Al termine della sua confessione Imma viene promossa: può entrare a far parte degli “attori nonimi” e può liberarsi finalmente del telefonino gettandolo nell’acquario. Ma proprio in quel momento arriva una chiamata: Imma non esita, ripesca il cellulare dall’acqua ed esce di corsa con il telefono incollato all’orecchio per afferrare, ancora una volta, la speranza, l’eterna illusione di ogni attore. Scrittura di alto livello, che gronda ironia e autoironia, e recitazione di classe, da parte sia dei protagonisti che dei comprimari, è un divertente apologo sull’incrollabile capacità degli esseri umani – esemplificati in questo caso dalla categoria degli attori – di non perdere mai la speranza in un futuro che possa riservare alla propria vita maggiori soddisfazioni.
Aspettando Harry di Antonio Benedetto (Italia)
Giulia arriva a New York, con solo uno zainetto per bagaglio, per incontrare Harry, il suo fidanzato americano, l’amore della sua vita, che lei non ha avvertito del suo arrivo per fargli una sorpresa. All’aeroporto naturalmente lui non c’è, lo vediamo a casa intento a preparare una cenetta per due. Giulia arriva a casa di Harry, suona il campanello ed entra. La vediamo poi giungere in un pub, dove beve una birra e dà in escandescenze, gridando. I clienti del pub pensano a una recita e applaudono, ma alla simpatica cameriera che socializza con la ragazza, Giulia racconta di essere andata a casa del fidanzato e di aver scoperto che sta con un’altra. La cameriera cerca di consolarla: l’amore vero non muore mai. Giulia le fa aprire lo zaino: dentro c’è la testa mozzata di lui. La cameriera sviene, lei si allontata , tranquilla, con il suo zainetto in spalla. A mali estremi estremi rimedi, recita il proverbio. In fondo il senso di questa divertente tragicommedia è (solo) tutto qui, per cui anche l’eccesso estremo le si perdona facilmente, sorvolando su una trama forse un po’ improbabile e accontentandoci di quello che questo divertissement è in grado di darci: un sorriso, e forse non è poco.
Finalmente fine di Simone Cardali-Michele Taverni (Italia)
Il giovane Martino si reca al cimitero e si confessa davanti a una tomba dietro alla quale c’è (il fantasma di) una giovane ragazza che lo ascolta: è stato licenziato dal lavoro. Dopo qualche tempo Martino torna al cimitero a visitare nuovamente la tomba (la ragazza è sempre lì accanto) e confessa di aver perso il borsello con la ricevuta di una grossa vincita al “gratta e vinci”. Per disperazione ha ingoiato una scatola intera di sonniferi, ma non è riuscito a farla finita, i sonniferi erano scaduti. A poco a poco apprendiamo da Martino che lei è morta in un incidente di moto perché non indossava il casco, che lui ha tentato ancora una volta di uccidersi mettendo il phon acceso nell’acqua, ma il salvavita… infine che è stato sfrattato da casa. Martino lascia il cimitero, il fantasma di lei lo segue e gli fa cadere in testa dall’alto un pesante vaso. Finalmente è finita, lui può raggiungerla. Opera prima della sezione “Film school”, nella quale il finale inaspettato e la piccola trovata di farci vedere, nascosta dietro la tomba, la ragazza morta con cui Martino parla, ci mostrano che i due giovani registi non sono privi di idee né di stoffa. Nulla da dire sul montaggio, di stampo classico tradizionale, e sul commento musicale, composto da musica pop moderna, in sintonia con la confezione giovanile del prodotto.
The Third Dad (Il terzo papà) di Theresa Moerman Ib (Regno Unito)
Opera prima di Theresa Moerman Ib. Una giovane donna, la stessa regista, va a cercare, in un luogo lontano da dove essa vive, la tomba di suo padre morto del quale non aveva più notizie da molto tempo. Infatti sono passati dieci anni da quando aveva rotto tutti i ponti con il genitore, ormai divenuto un alcolista. Ora il suo viaggio a ritroso nel tempo e nello spazio non è altro che un commosso e coraggioso tentativo di risarcimento, di riconciliare se stessa con la memoria del padre. Sulla tomba finalmente trovata Theresa si commuove, rivivendo, come in un filmino sfocato di altri tempi, i momenti felici della sua infanzia e della sua giovinezza con il genitore. Felice intreccio di riprese attuali e di materiali di repertorio – a cui forse nuoce un eccesso di preziosismo – il corto è stato presentato in anteprima mondiale al Film Festival Internazionale di Edimburgo nel 2015 e ha vinto numerosi premi, il più prestigioso dei quali è certo il BAFTA Scotland New Talent Awards nel 2016.
Dust & Resin (Polvere & resina) di Stephen Parker (Regno Unito)
Simone, una bella ventenne, si reca a casa dell’anziano Francis che le consegna subito una busta con denaro. Lei va in bagno a spogliarsi e riappare in costume da ballerina, tutù e scarpette. Francis accende un vecchio magnetofono e, mentre lei balla lentamente sulle punte, lui rivede in lei sua moglie. Francis l’applaude, è stata perfetta, e le dona le scarpette della moglie. Ma una voce di donna da sopra chiede chi ci sia lì sotto. Simone si spaventa, credeva che fossero loro due soli. Francis tenta di tranquillizzarla, ma lei scappa impaurita. La voce di donna chiede ancora: “Chi c’è lì sotto?” Sponsorizzato dall’associazione per la lotta contro l’Alzheimer, “Dust & Resin” è il racconto di un momento intenso vissuto da due persone che provengono da ambienti molto diversi, un incontro non convenzionale che si dipana a base di equivoci. L’interesse del film sta nel fatto che l’equivoco non è solo all’interno della storia (Simone crede che Francis sia un vecchio solitario, nostalgico di una persona morta), ma anche all’esterno, per noi spettatori, che pensiamo da subito che Francis voglia da Simone prestazioni di tutt’altro genere. Infine il colpo di scena finale, sia per la protagonista che per noi: Francis non è solo in casa, ma ha una moglie malata di alzheimer, immobilizzata al piano di sopra. Storia di due solitudini che riescono a incontrarsi per qualche breve momento di sincera emozione, ma poi, fatalmente, sono costrette a separarsi bruscamente, per sempre.
“Tre storie d’Italia” proiezione di documentari italiani
Concorso internazionale – documentario
Avellino – Rocchetta, sospensione di viaggio di Michele Citoni (Italia)
Costruita nel 1895, la tratta ferroviaria Avellino – Rocchetta Sant’Antonio si snoda tortuosamente nell’estesa provincia di Avellino lungo le valli dei fiumi Calore e Ofanto e attraverso le aspre montagne dell’Irpinia, per terminare in provincia di Foggia, appunto a Rocchetta Sant’Antonio. La realizzazione fu fortemente voluta dal grande letterato Francesco De Sanctis, irpino di nascita, che voleva strappare questo territorio dal suo secolare isolamento. Ormai improduttiva, secondo i criteri delle Ferrovie dello Stato, la linea nel 2009-2010 ha tuttavia trasportato migliaia di passeggeri, grazie all’associazione “In-loco-motivi” che l’ha pubblicizzata. Ma le FS hanno deciso, la linea va “sospesa”; termine ambiguo che non significa “soppressa”, ma che di fatto pone termine all’esercizio della tratta, e mette in serie difficoltà i pendolari che la utilizzano giornalmente. È l’ultimo viaggio, siamo sui due vagoni del convoglio. Si raccolgono offerte tra i passeggeri per stampare i manifesti che tenteranno di prolungare la vita della ferrovia. L’atmosfera è festosa, si brinda e si canta: la fine sarà, si spera, propiziatrice di un nuovo inizio.
Borgo Vecchio Factory di Claudio Esposito (Italia)
Borgo Vecchio è un quartiere povero e disagiato nel centro di Palermo. Dimenticato. Sembra impossibile, ma molti di coloro che abitano a Borgo Vecchio non ne sono mai usciti. Se devono andare in altre zone di Palermo, gli abitanti di Borgo Vecchio ne parlano come di un viaggio: “Vado a Palermo”. Viene intervistato uno dei pochi artigiani rimasti nel quartiere, Enzo il puparo, che costruisce pupi siciliani e che lamenta di essere rimasto pressoché solo. Nel campo teatrale, culturale, a Borgo Vecchio non c’è più nulla; oltretutto vi si registra una grande dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo, il 30%. Ma qualcuno è venuto e ha iniziato a dipingere i muri delle case dirute. L’intenzione era di farlo in periferia, ma lì non era stato possibile, e allora sono andati a farlo nel centro di Palermo, appunto a Borgo Vecchio; almeno lì si vede cosa fai e ti chiedono cosa stai facendo. È nato così un laboratorio di pittura che ha coinvolto alcuni tra i più importanti artisti europei di graffiti. Ma anche bambini con grandi difficoltà di comunicazione trovano un mezzo nuovo e originale per esprimersi attraverso il disegno. Il quartiere sta diventando a mano a mano un museo all’aperto, un museo del quartiere, grazie in particolare ai bambini che sono stati coinvolti nel dare un nuovo volto colorato al loro quartiere, a Borgo Vecchio. E ne sono molto felici e orgogliosi. “Borgo Vecchio Factory” è il racconto di una rinascita, di come si può, dal basso e con semplici mezzi, ma coinvolgendo direttamente i cittadini, soprattutto i più piccoli, ricostruire con successo un’identità culturale e sociale di una comunità che si era dispersa e frantumata, fino a cessare di esistere.
ELEONORA SFORZI
Vetrina FEDIC
L’invito di Alessandro Tassi (Cineclub Firenze)
Una casa di campagna dove abita una signora dai modi cortesi e affabili sembra proprio il posto migliore per una sosta tranquilla e rigenerante durante un viaggio in auto. Questo il punto di partenza del cortometraggio di Alessandro Tassi, che nel cortometraggio interpreta uno dei due amici protagonisti di un’insolita tappa all’insegna di capovolgimenti ironici tipici della commedia.
Non appena assaggiato il liquore offerto dalla padrona di casa, infatti, gli uomini iniziano ad avere strane allucinazioni, al punto da cedere, ammaliati, alle profferte di due giovani belle e provocanti che li invitano nelle proprie stanze. Il risveglio e il recupero della lucidità, tuttavia, porta i protagonisti a scontrarsi con una realtà ben diversa da quella immaginata ore prima.
Jobs Attack – Che fortuna un posto di lavoro! di Simone Bianchi (Cineclub Corte Tripoli Cinematografica – Pisa)
Il cortometraggio di Simone Bianchi, di professione macchinista ferroviario, dà voce, attraverso una vicenda iperbolica, alla difficoltà di far valere i propri diritti nell’ambiente lavorativo. Lo spunto è costituito dal colloquio tra il nuovo rappresentante sindacale dei lavoratori, il signor Fenzi, e il direttore dell’azienda in cui lavora: il compito del protagonista consiste infatti nel far presente alla dirigenza le richieste e i problemi dei colleghi che, tuttavia, rischiano di compromettere la sua stessa posizione.
Il film si propone come emblema di uno iato tra la classe operaia e quella dirigente messo in scena mediante una vicenda in cui i riferimenti al contesto reale si mescolano con una forte esasperazione della debolezza e dell’alienazione del lavoratore.
La stanza di cartone di Franca Elisabetta Ianucci (Cineclub Cagliari)
Tra le quattro mura di una spoglia stanza da bagno, una donna parla di sé agli spettatori, raccontando la propria storia e, in particolare, le delusioni ricevute dalla società esterna: mentre aspetta una visita, la protagonista femminile, il cui nome d’arte non a caso è Bijou, dà voce al percorso di disillusione che l’ha portata a concentrarsi sull’autocelebrazione dopo essere stata costretta a rinunciare alla propria carriera di insegnante.
Il cortometraggio, tratto da un racconto scritto quasi dieci anni fa dalla stessa regista, sembra recuperare nella sua impostazione una messa in scena basata sul disvelamento della finzione dove si intrecciano una scenografia visibilmente artificiale e un’esplicita tendenza all’interpellazione dello spettatore tipiche del cinema delle origini. Al di là di tale suggestione, il film si propone come una riflessione sulla difficoltà di conciliare sogni e aspettative personali con una realtà lavorativa che troppo spesso impone compromessi e inversioni di rotta.
Io sono di Nicola Raffaetà (Cineclub Corte Tripoli Cinematografica – Pisa)
Nella routine quotidiana scandita dai continui spostamenti dalla propria casa al lavoro e ritorno, un uomo alterna periodi di fatica fisica in cantiere a momenti di silenziosa quiete e distensione vissuti fuori dall’ambiente urbano in stretto contatto con la natura: qui, attraverso lunghe camminate nei sentieri di montagna, pare risiedere la serenità e la comunione con la terra e i suoi elementi.
La macchina da presa di Nicola Raffaetà segue da vicino il diverso scorrere del tempo connaturato a tali differenti attività, invitando lo spettatore ad apprezzare gli istanti privi di azione in cui dominano suoni e immagini interpreti del ciclico ritmo del mondo naturale. In questo senso il protagonista, interpretato da Roberto Panichi, sembra condensare su di sé il desiderio di un legame quasi spirituale con paesaggi solitari e di una bellezza sublime che, con le dovute proporzioni, ricorda il viandante della tradizione romantica.
Oliva di Lauro Crociani (Cineclub Immagini e Suono – Chianciano Terme)
Ambientato in una tipica trattoria toscana, il brevissimo cortometraggio di Lauro Crociani – ideatore del festival del Cortometraggio di Chianciano Terme – esalta, in un contesto di vita quotidiana, la tendenza alla battuta faceta fortemente radicata nella regione. Una tradizione dell’irriverenza di cui alcune pellicole della commedia all’italiana degli anni ’50’70 rappresentano l’espressione più brillante oltre che nota al grande pubblico, come ricorda il celeberrimo caso di “Amici miei” di Mario Monicelli.
GraSZie di Antonella Santarelli (Cineclub Firenze)
Una mattina un bambino rom e uno italiano si incrociano per caso nel viavai urbano: un elementare errore grammaticale diventa motivo di dialogo e confronto tra i due, attraverso il quale viene messa in evidenza l’influenza dell’educazione nelle loro opposte condizioni di vita.
Il cortometraggio della regista Antonella Santarelli, premiato con una menzione speciale al termine del Festival, esprime come un diretto confronto tra diversi modi di vivere possa essere trattato brevemente mediante un episodio semplice ed estemporaneo, in grado anche di far riflettere su diffusi luoghi comuni.
Bad Conscience di Al Bettini (Cineclub Firenze)
Come agisce la coscienza nel dar forma alla memoria e ai ricordi? Qual è il confine tra ciò che è giusto e le ragioni del cuore?
Girato interamente nella città di Prato, il cortometraggio dell’attore toscano Al Bettini – oltre che regista anche autore e interprete principale – ci conduce nella stanza più profonda dell’interiorità umana, dove si condensano e si intrecciano immagini e schegge del vissuto: nonostante sia stato licenziato dal lavoro, Leonardo, il protagonista, è determinato a garantire alla moglie le spese mediche per le cure necessarie alla sua salute, costi quel che costi.
Contraddistinto da alcune scene che riportano alla mente reminiscenze fumettistiche quasi fantascientifiche, il cortometraggio affronta temi fortemente legati a problematiche attuali facendo uso di un’orchestrata struttura narrativa frammentata e circolare.
MAURIZIO VILLANI
Concorso
The wake (Il risveglio) di Oonagh Kearney (Irlanda)
Il film, tutto recitato da donne, indaga i sentimenti e le pulsioni profonde dell’animo femminile attraverso il linguaggio dei corpi espresso nella danza. Le protagoniste vanno alla ricerca di sé soprattutto evocando le atmosfere della vita domestica, in cui le gioie e i dolori, le tenerezze e le violenze scandiscono i destini delle persone. La gestualità delle ballerine ricorda la ritualità propria della cultura sciamanica, in cui si fa sempre più evanescente il confine che distingue la realtà dal sogno.
The skull of summer (Il teschio d’estate) di Masakazu Kikuchi (Giappone)
In un caldo giorno d’estate il giovane Yamada riceve un pacco all’interno del quale trova un teschio e una lettera della sua ex moglie, che gli dice che il teschio è il suo e di portarlo sempre con sé. Il giovane cerca in tutti i modi di liberarsi di questo cranio, che però ricompare sempre nei luoghi più impensati, come una maledizione da cui è impossibile sfuggire. L’inquietudine che attraversa tutto il corto è ben resa dalle suggestive immagini della natura dei paesaggi orientali.
Beyond the water (Al di là dell’acqua) di Marco Rizzo
Il film racconta di una donna misteriosa, armata di una pistola, che aspetta sulla battigia qualcosa o qualcuno e fissa con sguardo interrogativo il mare. Arriva una schiera multietnica di naufraghi: uomini, donne , bambini che cercano, nuotando, di raggiungere la spiaggia. Ne fa strage, uccidendoli tutti. Ma viene a sua volta ammazzata da un uomo che poi si allontana, piangendo per la morte di una delle donne assassinate sulla spiaggia. Una nota di speranza chiude il film, che vuole essere una metafora della violenza che esplode verso chi ci è estraneo, venendo da lontano.
Mannequin di Rick Niebe (Italia)
Il cortometraggio presenta una storia misteriosa che ha per protagonista una mannequin, usando un linguaggio filmico attento alla sperimentazione nel montaggio e nell’impiego alternato del colore e del bianco e nero. Il racconta si dipana attraverso un collage di immagini che variano tra ricordi del passato, spezzoni di film trasmessi dalla tv, sorsi di vino, suoni di vecchie canzoni, raccolte di riviste patinate, per poi mettere in scena manichini trasformati in esseri viventi, fino al finale, che si chiude con una inversione di ruoli. Gli incubi che attanagliano la protagonista rimandano ad atmosfere di film di Hitchcock, espressamente citato in una sequenza trasmessa in tv.
Johnny Physical Lives di Joshua Neuman (USA)
Il film è l’omaggio che il regista rende alla memoria del fratello, astro nascente della musica rock, morto a vent’anni di leucemia. La struttura narrativa del cortometraggio è costruita ad incastro: vi sono, da una parte, le scene che mostrano la cruda cronaca della malattia e dell’agonia della rockstar nell’ultimo anno di vita, e dall’altra varie sequenze di disegni animati che rappresentano le performance musicali del gruppo dei Physical. L’impianto narrativo del racconto filmico si regge sulla contrapposizione tra le crude immagini che documentano il tragico destino di morte che incombe sul protagonista e l’energia vitale espressa dagli inserti musicali che accompagnano il vivace cromatismo delle animazioni.
Oro blu – Conversazioni dal mare di Andrea Ferrante-Marco Gernone
Il film ricostruisce l’inchiesta giornalistica, fatta da un reporter che indaga sui retroscena della richiesta di una società petrolifera straniera per avviare trivellazioni nel mare di fronte alla costa del Salento. Alla richiesta si oppongono i sindaci dei comune salentini e la popolazione dei luoghi interessati. Attraverso interviste agli amministratori locali, ad ambientalisti, a pescatori e a cittadini, l’inchiesta vuole dare conto delle ragioni di tutti coloro che sono contrari a queste perforazioni, che mettono a rischio una della coste più affascinanti del litorale italiano.
Vetrina FEDIC
Medee di Allorio Carlo – Giorgio Sabbatini (Cineclub Piemonte)
Il film ha una struttura complessa, ben equilibrata nelle sue parti, in cui si intrecciano tre piani narrativi: quello del mito greco (girato in bianco e nero), quello della messa in scena teatrale della tragedia di Seneca e quello della vicenda personale contemporanea che vede il fallimento dell’unione sentimentale tra la prima attrice e il regista della compagnia teatrale (entrambi girati a colori). Questi tre piani sono uniti dalla rappresentazione, portata all’estremo, del sentimento di odio, di amore, di gelosia e di vendetta. Appezzabili sono l’ambientazione, la nitida fotografia e l’intensa recitazione della protagonista.
Si deve morire di Roberto Merlino (Cineclub Corte Tripoli Cinematografica – Pisa)
Il film è una trasposizione cinematografica di un testo letterario; è, infatti, liberamente tratto da Il povero Piero, un romanzo scritto da Achille Campanile nel 1959, adattato successivamente dallo stesso autore in commedia teatrale. Il Cortometraggio rappresenta, in forma di apologo, le reazioni dei parenti del defunto, chiamati a vegliare la salma del caro estinto. Le scelte espressive del regista e l’efficacia degli interpreti hanno bene colto la grazia, l’ironia e la paradossalità del testo.
Opere frattali di Pompeo di G. Mito Possemato (Cineclub San Giovanni Valdarno)
Il film è un documentario che prende spunto dalle opere sui frattali dello scultore e pittore Pompeo Massaro per indagare, attraverso interviste e riprese nello studio dell’artista, i motivi ispiratori del suo fare arte. La rassegna delle opere rappresentate nel cortometraggio va da quelle pittoriche realizzate con colori acrilici alle sculture in creta e in pietra. L’osservazione delle geometrie frattali è condotta seguendo le linee contenute nella materia scolpita e i movimenti della camera assecondano la ricerca dei significato di queste misteriose linee, mentre le voci fuori campo portano avanti le considerazioni sull’arte.
Il futuro incerto di Giorgio Sabbatini (Cineclub Piemonte)
Un video-collage che rappresenta il “futuro incerto” del mondo attraverso una serie di brevi sequenze introdotte dalle immagini di una bambina e di un’altalena in un parco. Seguono scene di combattimenti. La trama mette in scena una bambina, un’altalena e un uomo che vive in un “suo mondo” tra libri, musica, ricordi e con una certa regola per l’ordine. I problemi che affliggono il mondo si intersecano tra loro in un continuo tentativo di riflessione per non dimenticare una realtà che tutti subiscono incondizionatamente.
Offerta di Ettore Di Gennaro (Cineclub 3D Production – Parma)
L’offerta è quella dell’acqua che un uomo e una donna si scambiano in un ambiente bucolico come segno di condivisione e di purezza. Questo breve corto, della durata di tre minuti, intende valorizzare il bene prezioso dell’acqua attraverso un gesto che vuole essere un atto di comunione tra tutti gli uomini e le donne del pianeta.
Along the river di Daniele Nicolosi (Cineclub Firenze)
Un western ambientato nel New Mexico del 1905 (ma girato nella campagna piemontese), dove le compagnie petrolifere iniziano a speculare sui territori degli Indiani. A compromettere le trattative intervengono la violenza e l’omicidio di una giovane pellerossa. Timothy Suffolk, l’avvocato della Compagnia, si rivolge perciò allo sceriffo locale Frank De Ville (interpretato da Franco Nero) per risalire al colpevole, offrendogli 10.000 dollari. Dopo il ritrovamento del responsabile – la cui identità costituisce un colpo di scena – lo scontro a fuoco finale ristabilisce una sorta di giustizia.
MARCO INCERTI ZAMBELLI
Concorso
Blind Seam di Eric G . du Bellay (Islanda)
Un ragazzo ed una ragazza, seduti su un misero divano, sono alle prese con i turbamenti sessuali dell’adolescenza, ma il loro confronto si rivela essere il set di un film, diretto con precisione e sicurezza da una giovanissima regista, che solo alla fine si rivelerà essere cieca. Elegante e delicato, con una deliziosa protagonista, mette in scena con leggerezza la relatività dell’handicap.
Per Anna di Andrea Zuliani (Italia)
Premio come miglior corto con la motivazione “ per l’atmosfera che ci fa pensare alle infinite possibilità della vita”, ambientato nel piccolo villaggio sardo di Gergei, racconta di un bambino muto che incontra un coetanea di Milano, in vacanza con i genitori e insieme vivranno una intensa ed emozionante giornata. Anni dopo Anna ritornerà nel paese e ritroverà le tenere tracce di quell’incontro. Una fotografia accurata e le indovinate interpretazioni giustificano ampiamente il riconoscimento ottenuto.
Una bellissima bugia di Lorenzo Santoni (Italia)
Un ragazzo che soffre della distrofia muscolare di Duchenne, incontra un uomo che afferma di essere guarito da una patologia simile. Da lì nasce un fitto dialogo, dal quale emerge la vita del protagonista, in tutte le sue sfaccettature. Dal canto suo, lo sconosciuto gli rivelerà una sconvolgente verità. Girato in massima parte nelle belle sale del Museo Archeologico di Grosseto, impreziosito dalla recitazione di Paolo Sassanelli (Nastro d’argento 2014) e di Beniamino Marcone, l’opera di Santoni riesce ad affrontare senza retorica e con convincente partecipazione la difficile situazione del giovane.
Story of Taiwan (Storia di Taiwan) di Minwoo Song (Corea).
Momenti di una ragazza sola. Le preziose inquadrature, la raffinata fotografia, la musica evocativa ritraggono poeticamente lo smarrimento della fanciulla, impeccabilmente interpretata da Lin Yan-Shin. Un poco invadente e pleonastica la voce fuori campo.
Hidden (Nascosto) di Launay – Franceschini Vincent (Francia).
A Parigi un trombettista russo clandestino non trova un luogo dove provare la sua musica e ruba la chiave di un appartamento al cugino fabbro per cui lavora. Si ritrova così a suonare nell’appartamento di una donna sola da poco lasciata dal fidanzato. Realizzato con grande professionalità sconta in parte un eccessivo affastellarsi di vicende.
The call (Chiamata) di Ethan Jahan (Gran Bretagna)
Un uomo rinchiuso nel suo appartamento, alle pareti centinaia di ritagli di giornali che raccontano attacchi terroristici e guerre, il televisore rimanda ossessionanti proclami di catastrofi, poi suona il telefono: le notizie fanno la realtà o la realtà fa’ le notizie? Un’idea indovinata servita da una messa in scena accurata e convincente.
Djinn tonic di Domenico Guidetti (Italia)
Commedia surreale nella quale un giovane precario incontra un decaduto genio della lampada dei tempi antichi. L’interpretazione di Francesco Pannofino impreziosisce il grottesco racconto fino ad un sorprendente finale.
Shooting star (Stella cadente) di Lyubo Yonchev (Bulgaria)
Lily è una madre divorziata con due figli, il giovane Martine e la piccola Alexandra. Una fredda sera d’inverno Martin sta riportando a casa in macchina Alexandra dalla scuola ed è coinvolto in un tragico incidente. La famiglia deve prendere una decisione, le cui conseguenze cambieranno le loro vite. Al centro del film l’ottima performance di Stefka Yanorova, supportata da una solida sceneggiatura ed una accurata messa in scena.
Three People Find a Car (Tre persone trovano un auto) di Max Lunter (Olanda)
Un’auto vuota si muove di notte senza conducente lungo una strada di campagna, scatenando tra tre persone una serie di scontri. Un’opera prima girata con sicurezza, ben interpretata, con una sceneggiatura che oscilla tra il grottesco e il sarcastico.
Va tutto bene di Laurent Scheid (Francia)
L’inaspettata, un poco kafkiana, discesa verso il carcere di un giovane. Costruito sui dettagli, sugli sguardi, sui silenzi racconta con coinvolgente angoscia il banale precipitare in una situazione terribile.
The Seedlings (Le piantine) di Christina Yianni (Inghilterra)
1905: una giovane adolescente vive in una dorata segregazione con la madre vedova. L’arrivo della zia, cortigiana in ritiro, e della coetanea figlia, le cambierà la percezione della vita e il rapporto con il mondo. Raffinate scenografie, fotografia preziosa, recitazione professionale per un film a tratti criptico, ma di indiscutibile fascino.
Cracks (Crepe) di Koen Van Sande (Belgio)
Per una coppia borghese su di un’auto di lusso, la necessità di parcheggiare in un quartiere di immigrati provoca equivoci imbarazzanti. Tra ironia e denuncia, una messa in scena professionale, con bravi protagonisti.
Shakespeare in Zaatari di Maan Mousili (Siria)
Un bel documentario che narra la straordinaria esperienza della rappresentazione teatrale di due opere di Shakespeare da parte di bambini rifugiati nel più grande campo profughi della Giordania: dalla scommessa iniziale alla felice realizzazione fino al triste abbandono dell’esperimento.
Fellow Travellers (Compagni di Viaggio) di David Tomlin (Inghilterra)
Il monotono e alienato viaggio quotidiano di tre pendolari si trasforma, nei sogni notturni, in un favoloso mondo magico. La documentaristica narrazione della realtà evolve in un’animazione colorata e affascinante nella poetica rappresentazione onirica.
Vetrina FEDIC
Un cuore dolce nel cappuccino di Marco Daffra (Cineclub Firenze)
Un bar elegante, una elegante signora, un elegante cappuccino con il cuore di latte, un barman elegante: l’atmosfera è pesantemente incrinata dall’arrivo di un clochard che chiede un caffè, corpo estraneo che provoca una prevedibile azione di rigetto. Eppure un inaspettato e spiritoso colpo di scena rovescia le aspettative. Bravi attori al servizio di una intelligente idea, girata con sicurezza.
Terra promessa di Francesco Colangelo (Cineclub Roma)
Una giovane sposa ( la meravigliosa Valeria Solarino) separata dal marito si reca dall’Inghilterra alla Puglia con il malaticcio figlio e riscopre le sue radici e una nuova vita. Seppure a tratti prevedibile, una solida sceneggiatura , un taglio di sicura professionalità ed una buona fotografia confezionano un piacevole film.
Si deve morire di Roberto Merlino (Cineclub Corte Tripoli Cinematografica – Pisa)
La sarcastica ironia di Achille Campanile ispira un’opera che si muove con equilibrio tra il surreale e il satirico, ruotando attorno agli atteggiamenti che suscita il lutto di una persona. L’opera, sorretta da una felice interpretazione, mette in scena un’acuta e brillante rappresentazione dell’ipocrita e vana ritualità del senso comune.
Cattiveria gratuita di Antonietta Tognino (Cineclub 3D Production – Parma)
Un normale incontro in cucina tra donne. Amiche in apparenza, traspare una inutile e mascherata crudeltà. Girato con la tecnica del cinema verità che non sempre riesce a catturare l’attenzione dello spettatore.
Vuoto a perdere di Stefano Vannelli (Cineclub Corte Tripoli Cinematografica – Pisa)
Più donne in stanza bianca, vittime di violenza, riflettono su quello che hanno subito, arrivando ad una tragica conclusione. Vannelli riesce a sintetizzare in poco più di un minuto una delle tragedie più assurde che avvengono quotidianamente tra le mura domestiche.
LE SCUOLE DI MONTECATINI TERME & PISTOIA AL MISFF67
di Marcello Zeppi
Il rapporto della Fedic e del Festival del Cinema MISFF con i giovani con le Scuole, con i Musei, con le Biblioteche della Provincia di Pistoia, parte da lontano.
Nel 2006 la FEDIC presentava il seminario-laboratorio per docenti sul tema: “Il cinema come strumento di educazione ambientale”, a cura di Massimo Maisetti e Maria Teresa Caburosso e la partecipazione del regista Nedo Zanotti, realizzato in collaborazione con ARPA Toscana e Provincia di Pistoia.
Tenendo presente le passate iniziative FEDIC, il MISFF sin dal 2012 ha sviluppato un innovativo rapporto di collaborazione e partneraiato con la Provincia di Pistoia. I cambiamenti intercorsi nell’uso quotidiano dei linguaggi dell’universo giovanile ( social e nuovi media), la costante evoluzione delle attrezzature tecnologiche e la loro facilità di trasporto e posizionamento ci hanno consentito di sviluppare e potenziare le attività di Laboratori nelle Scuole, nella fascia di età 9-13 anni. Dal punto di vista organizzativo abbiamo ricevuto supporto dalle associazioni no-profit che sostengono i Laboratori e il Festival. Oltre al Misff-Filmvideo, hanno collaborato Fedic Scuola, Cineclub Gruppo Cineamatori delle Apuane, Cineclub Firenze Fedic, AVIS, Croce Rossa Italiana, Lions, Leo Club.
Grazie al lavoro di squadra intercorso nella più recente edizione del Festival del Cinema di Montecatini Terme si è collaudato un modello di educazione al linguaggio audiovisivo, cinematografico, interattivo che ha saputo e potuto miscelare diversi apporti nel Laboratori di cinema iniziati nel mese di Gennaio e organizzati nelle Scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo del Comune di Montecatini Terme e Comuni limitrofi, con la partecipazione dei giovani Autori e dei Registi che hanno trasmesso le loro esperienze ai giovani. I nominativi di alcuni docenti, esperti e volontari dei moduli frontali e On line sono: Laura Biggi, Docente, Responsabile Nazionale Fedic Scuola; Lorenzo Caravello responsabile del Gruppo Cineamatori delle Apuane; Alessandro Grande responsabile delle Giornate dedicate ai Giovani Autori; Rita Capucho, Javier Venturi, Joao Antunes, Marina Fomenko, Flavia Vargas, Anastasia Poliakova, Roberto Valdes, Alfonso Palazon, Edoardo Tabasso ed altri.
Per la prima volta , nel marzo 2016, è stato organizzato un festival (MISFF4YOU) dedicato ai giovani delle Scuole di Montecatini Terme, Paesi limitrofi, Comune di Pistoia. Durante il Festival sono intervenuti anche i ragazzi dei Licei di Montecatini Terme e Pistoia. Durante il Festival è stato organizzato un Convegno dedicato ai Giovani e l’Europa ( Cluster Creativi Europei ) con la Presidente della Commissione Cultura e Politiche Giovanile del Parlamento Europeo On.le Silvia Costa, il cui ruolo testimonia l’alto livello delle proposte che vengono riservate ai “ Giovani Cittadini Europei” di Montecatini-Pistoia.
L’ esperienza della edizione MISFF 67 è stata veramente eccezionale e le Giurie popolari formate dagli Studenti dell’ Istituto Comprensivo G.Chini di Montecatini e di alcuni Licei di Montecatini e Pistoia hanno potuto consentire uno sguardo su opere provenienti da diversi Paesi e con generi completamente diversi ma con linguaggi comprensibili per le fasce di età alle quali venivano rivolte. Sono stati proiettati circa 150 film, costituendo così un panorama cinematografico veramente generoso di cui ci piace sottolineare alcune opere:
Animazione realizzata nelle Scuole di Cinema
“Obsolescenza” di Andrea Cristini (Canada); – “Agrinoui” di Alexis Chavarias (Cipro)
Film School Experimental
“Raccontami la Storia del Piccolo Principe” di Jad Makki (Belgi0)
International Competition Animation
“Ciao Renna” di Ors Bàrczy (Ungheria); “Karouma” di Boubakr Boyikhari (emirati Arabi Uniti); “Taxi Spaziale” di Juras Krumpolec (Slovacchia); “Piccolo Shimajiro” di Isamu Hirabayashi (Giappone);”Danza degli occhi” di Eric Lee Ka Yin (Honk Kong)
International Competion Fiction
“Per Anna” di Andrea Zuliani (Film vincitore della 67 edizione MISFF).
Per il futuro si terrà presente l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato dai Ministri Stefania Giannini e Dario Franceschini che vuole promuovere il linguaggio e la cultura del cinema e del teatro nella scuola e che segna un nuovo capitolo della collaborazione fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e quello dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Con la legge Buona Scuola, infatti, sono partite diverse attività congiunte fra i due dicasteri nel segno della promozione dello studio dell’arte, della diffusione della conoscenza del nostro patrimonio culturale e della promozione della lettura.
“Finora la scuola è sempre andata al teatro o al cinema. Ora vogliamo portare il cinema e il teatro a scuola. La scuola deve farsi carico dell’osservazione passiva, da spettatori, di queste due forme di arte, ma deve anche promuovere un ruolo attivo dei ragazzi, consento loro di di esprimersi attraverso questi linguaggi partecipando con copioni e video inediti”.
Il nuovo Progetto del MISFF (che è già iniziato nel corso del 2016), segue il Protocollo Nazionale e prevede:
La oramai consueta organizzazione di laboratori di Cinema in Classe, la realizzazione di cortometraggi scritti e realizzati con i ragazzi, la proiezione di film per ragazzi nei Cinema della città, anticipati da introduzioni di registi, attori, autori di Cinema, la partecipazione a Campus di Cinema .
Da quest’anno verranno organizzati stage formativi con i ragazzi più grandi ovvero dal terzo anno del Liceo e/o Istituti a indirizzo Tecnico e Professionale. La creatività è un diritto di ogni essere umano , coltivarla ed educarla è un preciso dovere, per coloro che sentono questa responsabilità.
Nel 2016 saranno creati in partecipazione con Avis Regionale nuovi corsi di animazione non solo a Montecatini Terme anche in altre Provincie Toscane. Le proiezioni di Film MISFF saranno realizzate anche in altre Scuole della Provincie di Firenze, Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo, Grosseto e ovunque siano richieste le nostre competenze ed esperienze.
THE AUTHOR’S DAY: IL BILANCIO
di Alessandro Grande e Antonella Santarelli
Nell’edizione del MISFF67 (Montecatini International Short Film Festival), che si è svolto dal 5 al 10 ottobre 2016 a Montecatini Terme, è stato inaugurato un nuovo appuntamento: “The Author’s Day”, che si è svolto il 7 e 8 Ottobre all’interno del Festival. L’evento è stato un punto di incontro tra produttori cinematografici e autori in possesso di un soggetto per film lungo, breve o documentaristico in cerca di produzioni per poterlo realizzare. “The Author’s Day” è stato un successo sia in termini di partecipazione, sia di collaborazioni nate tra produttori e autori. Da Direttore Artistico dell’evento il regista Alessandro Grande ha selezionato i progetti da sottoporre ai produttori invitati e ha coordinato le due giornate con l’aiuto dell’architetto e regista Antonella Santarelli che ha allestito l’evento all’hotel Plaza e si è occupata insieme alle volontarie Giulia Siciliano e Alessia di Stefano, dell’accoglienza di produttori e autori.
Ventotto gli autori selezionati (25 provenienti da tutta Italia, 2 dal Portogallo e 1 dalla Francia) e nove i produttori cinematografici indipendenti preposti a valutare i progetti: Angelo Bassi e Pierfrancesco Campanella per Mediterranea film, Rodolfo Martinelli e Isabel Russinova per Ars Millennia, Alessandro Riccardi per Vargo Film, Viviana Panfili per Imago Produzioni, Alessandro Amato e Luigi Chimienti per Disparte, Adam Selo per Elenfant Film.
La presentazione dei progetti, è avvenuta alla presenza di tutti gli autori, che hanno così potuto assistere al dibattito e ai consigli che i produttori hanno dato ad ognuno per potenziare il proprio progetto. E’ stato un momento importante di condivisione e di crescita professionale per ognuno di loro, arricchito poi da diverse masterclass tra cui “La produzione cinematografica” tenuta da Federica Vincenti, titolare della Goldenart (tra i vari film realizzati: “Prima di andar via”, “la scelta” e “7 minuti”, tutti di Michele Placido).
I due giorni si sono svolti con la piena partecipazione di tutti: i produttori si sono messi al servizio dei giovani autori per qualsiasi chiarimento, e anche tra gli autori non c’è stato spirito di competizione, ma voglia di imparare e crescere anche condividendo tra loro, idee e opinioni.
Dopo aver attentamente approfondito i 28 progetti, 4 produttori hanno deciso di portarne avanti non uno, bensì 4 (3 cortometraggi e 1 documentario). Altri progetti inoltre, sono ancora in fase di particolare interessamento.
Lo svolgimento di “The Author’s Day” è stato preceduto da un lavoro preparatorio da parte di Antonella Santarelli. Il suo ruolo nel festival è stato principalmente di coordinare la Commissione Artistica con la quale è stata effettuata la preselezione dei 150 film in concorso su più di 600 film pervenuti.

Alcuni partecipanti al Convegno: da sinistra, il produttore Luigi Chimienti, il regista Alessandro Grande e l’attrice-produttrice Isabel Russinova.
Quest’anno si è avuto, in contemporanea alla proiezione dei 150 film in concorso, 4 masterclass: “Giovani e Cinema: Lo sguardo sui conflitti di Javier Venturi “(USA); Lezione “Costume e Cinema” di Monica Gallai e Marcello Zeppi (ITALY); “Following The Music” di Marina Formenko (RUSSIA); “Audiovisual Mapping- Expanded Cinema” di Marcello Arosio. Le Masterclass sono state integrate ad un evento alla prima edizione, che ha avuto un grande successo in fatto di presenze e argomenti trattati.
Gli autori, sono stati aiutati nelle settimane precedenti all’evento, a presentare da un punto di vista grafico e sinottico i propri lavori per dare ai produttori una sorta di promemoria di ogni autore, da poter eventualmente consultare dopo gli incontri. E’ stata una esperienza che andrà sicuramente ripetuta: fin dalla prima giornata si è creato un ambiente amichevole tra organizzatori del Festival, autori e produttori.
“The Author’s Day” quindi, oltre ad essere stato un importante evento di condivisione, formazione e crescita professionale per ogni autore, è stato anche un momento importante di visibilità per il cinema del futuro, e proprio grazie a questo evento, alcuni autori potranno realizzare il proprio film, mentre altri hanno avuto la possibilità di ottenere un contatto diretto e un feedback immediato da parte dei professionisti presenti, per il proseguimento della loro attività.
Come organizzazione della sezione “The Author’s Day”, non possiamo che essere soddisfatti di questa prima edizione, come si più facilmente vedere anche dalle tante mail ricevute e commenti di ringraziamenti che tutti gli autori partecipanti hanno postato dopo l’evento sulla pagina facebook del MISFF – Montecatini International Short Film Festival. Dopo questi ottimi risultati, auspichiamo di diventare sempre di più, un riferimento importante per tutti i registi del domani.
L’EVOLUZIONE NEL CINEMA
di Sara Riccobono
Ho conosciuto Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, quest’anno, alla prima edizione del Festival International du Film sur le Handicap a Cannes. Il MISFF è arrivato alla sua 67esima edizione, con centocinquanta proiezioni di ogni genere che hanno riempito le giornate dal 6 al 9 ottobre. La ricchezza di questo festival deriva da molti temi, tutti importanti e in egual misura: la partecipazione dei più piccoli (con il coinvolgimento delle scuole), la voglia di sperimentare, il rispetto per il lavoro, l’impegno e la collaborazione di tutti per la realizzazione dell’evento e l’apertura a qualsiasi tipo di forma di linguaggio, immagine e pensiero.
Pensieri accolti e in continua evoluzione, come lo dimostrano le tante collaborazioni che il MISFF conquista negli anni. La FEDIC, compagna fedele da molto tempo, affianca e sostiene il lavoro del MISFF contribuendo anch’essa alla ricerca continua di nuovi talenti e future promesse; e poi il FIFH di cui ho parlato all’inizio, che è stato il punto di contatto tra me e il mondo del cinema di Montecatini.
Quello con Zeppi è stato un incontro fortuito e fortunato, visto che entrambi abbiamo notato del potenziale nelle rispettive persone. Si è creata una forte intesa, una sintonia naturale, e il resto è venuto da sé. Mi ero recata a Cannes perché finalmente stava accadendo quello che aspettavo da tempo: il cinema si stava prendendo la responsabilità di parlare seriamente di disabilità.
Lo aspettavo perché sono in carrozzina da dieci anni, e ho sempre pensato che le disabilità sono viste in negativo solo se non sono conosciute, se non sono capite e indagate. Per questo aspettavo l’arrivo del cinema, aspettavo questo passo in avanti da un mondo che sa come prendere un soggetto, trasformarlo in una storia e svelarlo ai tanti che l’hanno sempre ignorato o sottovalutato.
Al MISFF quest’anno sono state infatti proiettate tre storie che raccontano di disabilità, ed una di queste ha anche vinto come miglior cortometraggio.
“Per Anna”, di Andrea Zuliani, è un concentrato di bellezza senza parole, venti minuti di film che mostrano la forza comunicativa di un ragazzo che pur non parlando perché muto, vive la vita, la quotidianità e l’amore come tutti fanno. E’ semplice mostrare con un video come le emozioni non sono vincolate da parole o movimenti, ed è invece molto più complicato spiegare a qualcuno come una persona con disabilità, di qualsiasi tipo, possa vivere e sentire l’amore e le altre bellezze della vita come le sentono gli altri. E’ in questo che il cinema mostra tutta la sua potenza, ed è in questo che io confidavo da tempo e che ora inizio a vedere delinearsi in immagini, suoni e colori.
Il Miglior Film Vetrina FEDIC è invece stato “Si deve morire”, di Roberto Merlino (ex-aequo con Medee di Giorgio Sabbatini e Carlo Allorio). Una visione sarcastica e pungente sulla morte, destino che accomuna tutti noi dal giorno in cui nasciamo, e che scardina tutti quei comportamenti e quelle frasi di circostanza che diventano protagoniste nel momento di un lutto.
Il cinema è tutto questo.
E’ parlare di vita, di morte, di disabilità. Il cinema è stupire chi aveva sempre tenuto gli occhi chiusi, non perché cieco, ma perché privo degli strumenti giusti per saper osservare il mondo.
FESTIVAL ED EVENTI
73. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
 ANCORA UNA MOSTRA
ANCORA UNA MOSTRA
VIVACE E RICCA DI PROPOSTE
di Paolo Micalizzi
Anche nel 2016 la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con la direzione di Alberto Barbera, ha fatto centro. Anche lo staff della Mostra funziona e ne è scaturita una manifestazione vitale, ricca di proposte sia nelle varie sezioni che la costituiscono che nelle altre iniziative che le fanno da corollario. Non trascurando anche il contributo , a rendere la Mostra vivace, dell’aspetto mondano che si dica quello che si vuole, in un Festival cinematografico come quello che si svolge nella laguna veneta è necessario a dargli splendore e ad attirare l’interesse dei fans, cosi come è testimoniato dalla presenza ai bordi del red carpet di persone che sin dal mattino vi si “accampano” per poter vedere al momento dell’ingresso in sala i divi amati. Dal punto di vista artistico, poi, anche quest’anno la Mostra ha annoverato nomi famosi e nuovi talenti. In Concorso, registi come Wim Wenders(Le beaux jours d’Arajuez), Francois Ozon (Frantz), Andrei Konchalovsky (Paradise), Pablo Larrain (Jackie), Terrence Malick (Voyage of Time), Emir Kusturica( On the Milky Road), ma ad avere il “Leone d’Oro” è stato un regista defilato dallo Star system, il filippino Lav Diaz, il cui film “The woman who left” (La donna che partì) sin dalla proiezione alla Stampa è stato indicato come meritevole del “Leone d’Oro”.
E cosi è stato su decisione della Giuria presieduta dal regista Sam Mendes e composta da Laurie Anderson, Gemma Arteron, Giancarlo De Cataldo, Nina Hoss, Chiara Mastroianni, Joshua Oppenheimer, Lorenzo Vigas e Zhao Wei. Il fluviale(tre ore e quarantasei minuti, molto meno di altre opere del regista filippino) film di Diaz ha subito entusiasmato la critica per il suo racconto umano e geografico. Protagonista, una donna rimessa in libertà dopo trent’anni di carcere scontati ingiustamente. Il regista la segue nel suo peregrinare raccontando criminalità e corruzione, paura e crudeltà del suo Paese. Un’odissea umana,” un’allegoria dell’umanità in lotta” come l’ha definita il regista nel ricevere l’ambito Premio che ha dedicato al popolo filippino. Un’opera dalla qualità elevata, impreziosita di uno splendido bianco e nero. Meritato quindi il massimo riconoscimento della Mostra. Per il “Leone d’Argento-Gran Premio della Giuria” il verdetto ha premiato il film “Nocturnal Animals” dello stilista Tom Ford, un thriller incentrato sull’amore e la vendetta. Avremmo preferito fosse stato attribuito a “Jackie” di Pablo Larrain che racconta l’assassinio di Kennedy attraverso il punto di vista della moglie Jacqueline: l’hanno accontentato con il premio alla migliore sceneggiatura a Noah Oppnheim, e potevano anche premiarlo con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile assegnandola a Natalie Portman
invece che alla seppur brava Emma Stone per “La La Land”, film di Damien Chazelle che avrebbe potuto essere preso in considerazione nel Palmares ufficiale: film che ha inaugurato brillantemente la Mostra, dal carattere di kolossal. Cosi come spettacolare è stato il film di chiusura, presentato “fuori concorso”, “The magnificent seven” con cui Antoine Fuqua ripropone, però in stile più violento, l’omonimlo western di successo del 1960 di John Sturges. Premiato con il “Leone d’Argento” per la migliore regia Andrei Konchalovsky, autore di “Paradise” film contro gli orrori dell’Olocausto ispirato a storie vere di Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. Peccato l’abbia dovuto condividere con un ‘opera che non lo meritava affatto, “La regione salvaje” di Amat Esacalante, anche se il tema è importante trattando della condizione delle donne in una società maschilista. Come non meritava il “Premio speciale della giuria “The Bad Batch” di Ana Lily Amirpur, opera sul cannibalismo ambientata nel deserto texano dove i reietti della Terra sono costretti a mangiare carne umana. Perfetto il Premio per la migliore interpretazione maschile a Oscar Martinez, mattatore del film argentino “El ciudadano illustre”( Il cittadino onorario) incentrato su un Premio Nobel che torna al suo paese natio, in Argentina, per avere un riconoscimento: ma , pian piano, esso si trasforma in un boomerang. Va segnalato che in Concorso il cinema italiano non ha ricevuto alcun premio, mentre poteva meritarlo con un film come “Spira mirabilis” di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, una sinfonia visiva di grande fascino sui quattro elementi naturali Aria, Acqua, Terra e Fuoco per arrivare all’Uomo. In uno degli episodi è protagonista Marina Vlady, una presenza ammirata già negli anni 50 che si rivede sempre volentieri. Prestigiosi poi i due “Leone d’Oro” alla Carriera. Un “mostro sacro” d’attore come Jean-Paul Belmondo i cui personaggi di gangster e avventuriero hanno riempito d’emozioni e avventure lo schermo,
ad iniziare dalla mitica interpretazione in “A Bout de souffle” (1960) di Jean-Luc Godard. Ma anche un singolare autore polacco come Jerzy Skolimowski ,ritornato alla ribalta nel 2015, proprio alla Mostra dj Venezia, con l’intrigante film sperimentale “11 minuti”. In tema di Omaggi, ci piace segnalare il “Premio Pietro Bianchi” al regista Ugo Gregoretti, attribuito dai Giornalisti Cinematografici alla Sala Pasinetti del Palazzo del Cinema insieme alla proiezione del documentario “Con Ugo” di Gianfranco Pannone e del rarissimo film “Maggio musicale” diretto da Gregoretti nel 1989: opera introvabile, recuperata dalla Cineteca Nazionale, che è interpretata da Malcom McDowell nel ruolo di un regista teatrale che affronta le difficoltà di una messinscena della “Boheme” durante il “Maggio Fiorentino”.
Quest’anno la Sezione “Orizzonti” della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata rafforzata dandole maggiore importanza. Diciannove i film in Concorso, ma anche 16 cortometraggi. Ha vinto come miglior film emergente, scelto dalla Giuria, presieduta dal regista Robert Guèdiguian ( e composta da Jim Hoberman, Nelly Karim, Valentina Lodovini, Moon So-ri, José Maria (Chema)Prado e Chaitanya Tamhane)” Liberami” di Federica Di Giacomo, unico film italiano premiato nelle Sezioni ufficiali a Venezia. Si tratta di un documentario che costituisce un’inquietante indagine sulla pratica dell’esorcismo.
Per la migliore regia premiato il film belga “Home” di Fien Troch che racconta di alcuni giovani e degli adulti che vivono accanto a loro che hanno difficoltà a comunicare e comprendersi a vicenda, perché chiusi nei loro mondi. Un premio speciale della giuria per il turco “Big Big World”( Un grande mondo) di Reha Erdem , incentrato su due giovani che usciti dall’orfanotrofio trovano difficoltà a vivere tra la gente e si rifugiano in un bosco che per loro diventa un’isola deserta. In “Orizzonti” anche l’italiano “Il più grande sogno” di Michele Vannucci, che ha ricevuto alcuni premi collaterali tra cui la Menzione speciale della giuria del Premio Fedic. Racconta di un uomo della periferia romana che uscito dal carcere viene eletto, a sorpresa, Presidente del comitato di quartiere sognando cosi un’esistenza diversa non solo per sé e per la propria famiglia, ma per tutta la borgata in cui vive. Anche quest’anno la Mostra ha proposto alcuni classici restaurati, ed un giuria di studenti universitari, presieduta dal regista Roberto Andò, ha premiato il film di Marco Ferreri “Break up- L’uomo dei cinque palloni” con protagonista Marcello Mastroianni. Un film sul tema dell’irrazionale che irrompe nell’ovvietà della civiltà dei consumi. Un film sperimentale restaurato dalla benemerita Cineteca di Bologna. Ma sui “classici” alla Mostra di Venezia 2016 rimando all’articolo di Vittorio Boarini pubblicato su questo numero della Rivista. La novità di quest’anno alla Mostra di Venezia è stata la nuova sala “Cinema nel giardino” ubicata nel posto dove sorgeva lo “scandaloso” buco.
Un’operazione di ristrutturazione della Mostra che ci voleva , cosi come altre operazioni la Direzione ha in mente per poter dargli una maggiore efficienza. E bisogna dargli merito.
Una Mostra vitale, cui hanno dato come sempre un valido contributo anche “Le Giornate degli Autori” e la “Settimana della Critica” dove il panorama del cinema contemporaneo ha offerto opere che fanno riflettere sugli aspetti problematici della vita odierna. A “Le Giornate degli Autori” è stato laureato, da una Giuria presieduta dal regista Bruce LaBruce, il film “The War Show” di Andreas Dalsgaard e Obaidah Zytoon (Danimarca. Finlandia, Siria) : un road movie di una conduttrice radiofonica ( Obaidah Zytoon) che coglie momenti della guerra civile in Siria ed il suo destino. Un’opera divisa in sette capitoli, visti da uno sguardo intimo e da alcuni amici che diffondono delle storie umane attraverso le quali emerge un ritratto politico e sociale della drammatica situazione siriana.
Il Premio del pubblico è andato invece al film del filippino Eduardo Roy Jr. “Pamilya ordinaryo”, un ritratto di una famiglia formata da una sedicenne e dal suo fidanzato che vivono per le strade caotiche di Manila derubando i passanti. Alla nascita del loro bambino la situazione cambierà, ma il rapimento del figlio li indurrà a scelte disperate. Una vita di strada colta nella sua drammaticità.
“Los Nadie” del colombiano Juan Sebastian Mesa è il vincitore della 31^ Settimana della Critica. E’ un film, girato nelle strade più dure di Medellin, che coglie cinque adolescenti nella loro fase di fine dell’adolescenza, caratterizzata da irrequietezza, stupore, tenerezza inespressa e rabbia. Ma il loro obiettivo è il desiderio di credere nel futuro.
Ad un film della SIC è stato poi assegnato, da una Giuria (Kim Rossi Stuart- presidente-Rosa Bosch, Brady Corbet, Pilar Lopez de Ayala, e Serge Toubiana) il Premio “Il Leone del Futuro- Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis” dotato anche di un di 100.000 USD. Se l’è aggiudicato il film “Aker Wahed Fina” (The Last of US) di Ala Eddine Slim (Tunisia, Qatar, E.A.U., Libano) che racconta il viaggio di un uomo senza nome che si sposta dal deserto per raggiungere il Nord Africa onde compiere una traversata illegale verso l’Europa. Si troverà in Tunisia ad affrontare un viaggio in mare da solo, rubando una barca che presto però affonda. Gli incontri che farà lo faranno diventare un altro uomo. Una tragedia del Mediterraneo, raccontata in modo nuovo.
Una grande importanza stanno assumendo da alcuni anni i “Premi Collaterali” assegnati da Associazioni, Festival, Circoli del Cinema. In fondo, completano i Palmares ufficiali indicando opere che meritano una giusta attenzione.
Premi assegnati anche dalla FEDIC. Tre i riconoscimenti attribuiti. Al tradizionale Premio FEDIC destinato “all’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore” quest’anno si è aggiunta una Menzione Speciale FEDIC, poiché la Giuria ha ritenuto che il film “Il più grande sogno” di Michele Vannuci meritasse di essere premiato, anche se non vi è stato alcun dubbio che il massimo riconoscimento dovesse andare a “ Indivisibili” di Edoardo DeAngelis ( presentato alle “Giornate degli Autori). “Indivisibili” , che tra l’altro è uno dei migliori film italiani presentati alla Mostra, racconta la storia di due sorelle siamesi di Castelvolturno che cantano ai matrimoni e durante le manifestazioni popolari, mantenendo con questa loro attività la strana famiglia. Fino a quando, a 18 anni, non scoprono che potrebbero essere separate chirurgicamente conquistando una propria indipendenza.
La Giuria FEDIC, presieduta da Ugo Baistrocchi( e composta da Marco Asunis, Alfredo Baldi, Roberto Barzanti, Lorenzo Bianchi Ballano, Carlotta Bruschi, Mario Di Francesco, Giuliano Gallini, Ferruccio Gard, Carlo Gentile, Fausto Ghiretti, Franco Mariotti, Paolo Micalizzi e Giancarlo Zappoli) glielo ha attribuito “ per aver diretto, avvalendosi di un cast di interpreti bravi e intensi, una storia originale, surreale e visionaria di emancipazione e di ricerca della libertà”. Il regista Edoardo De Angelis nel ritirare il Premio, alla cerimonia svoltasi all’Hotel Excelsior nello Spazio Ente dello Spettacolo , ha dichiarato: “Questo è un riconoscimento che ha un valore tangibile oltre che simbolico. Siamo felici di come ‘Indivisibili’ è stato accolto durante la Mostra, siamo felici delle emozioni che ci avete restituito che sono molte di più di quelle che noi abbiamo profuso in questo lavoro. Condivido il premio con il mio socio, amico e Produttore Pier Paolo Verga che è qui presente. Insieme, da tre anni ormai, facciamo film con libertà cercando di ricercare sempre di più il linguaggio di quest’arte. Grazie! “. Meritava, come detto, di essere premiato, sostenuto fortemente da alcuni giurati, anche “Il più grande sogno” di Michele Vannucci( era nella Sezione Venezia-Orizzonti), film incentrato su Mirko che torna nel suo quartiere dopo essere uscito dalla galera.
A sorpresa sarà eletto presidente di un Comitato di circoscrizione: ci metterà tutto l’impegno per assolvere tale incarico che per lui costituisce una nuova vita. E’ stato premiato perché trattasi di “ un’opera prima che ha i suoi punti di forza nell’ambientazione realistica, nell’interpretazione del protagonista Mirko Frezza che mette in scena se stesso, negli interpreti anche loro non professionisti, nella comicità dei dialoghi, nella messa in scena che è sempre addosso ai personaggi, nei colori caldi in sintonia con la vivacità del film stesso”. La “ Menzione FEDIC – Il Giornale del Cibo”, giunta alla 3^ edizione, che è destinata “all’opera che propone la scena più significativa legata al cibo e alla alimentazione” è stata attribuita al film “Orecchie” di Alessandro Aronadio. E’ un’opera nata nell’ambito del Progetto Biennale College” che aiuta lo sviluppo e la produzione di opere audiovisive a micro-budget.
Racconta di un uomo(un fantastico Daniele Parisi) che si sveglia una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie. Ha cosi inizio per lui una tragica giornata capace di cambiare la sua vita”. La motivazione della Giuria FEDIC recita che è stato premiato “ per la scena nella quale un cameriere vuole imporre un menù comp0leto immodificabile, con relativo premio, che sembra apparentemente surreale ma coglie esattamente la realtà”. Alla cerimonia di premiazione, svoltasi nello Spazio dell’Ente dello Spettacolo, erano presenti tutti e tre i registi, oltre ad alcuni collaboratori : per la FEDIC, un motivo di soddisfazione, perché è una significativa testimonianza del fatto che il Premio riscuote sempre interesse nel cinema italiano.

Giurati e premiati: da sinistra, Baldi, De Angelis, Vannucci, Gard, Aronadio, Gallini, Gentile, Micalizzi, Bruschi, Asunis. (Foto di Anna Marcoleoni)
Il Forum FEDIC , che ha avuto luogo all’Hotel Excelsior nello Spazio Incontri Venice Production Bridge, era quest’anno incentrato sul tema “Produrre il cortometraggio”. Ha aperto il Forum un saluto di Luigi Cuciniello, Direttore organizzativo della Mostra. Nel corso del suo intervento ha sottolineato come nella scelta dei temi e dei dibattiti che la FEDIC organizza a Venezia, c’è attenzione e una certa puntualità su questioni che effettivamente sono all’ordine del giorno nella discussione del mondo del cinema, aggiungendo come il cinema italiano nel momento che stiamo vivendo è in perenne evoluzione. In quanto al cortometraggio, ha sottolineato Cuciniello, la Mostra mantiene uno spazio dedicato agli autori che sempre più si affacciano nel mondo del cinema, augurandosi che l’evoluzione nel cinema che si sta avendo a livello tecnologico e in termini produttivi possa portare ad una maggiore visibilità e ad una maggiore attenzione a livello di comunicazione. Questa, ha concluso, può essere la strada per ottenere quell’attenzione e quegli spazi che ingiustamente il cortometraggio italiano finora non ha avuto. Dopo le introduzioni di Paolo Micalizzi, che cura entrambe le iniziative FEDIC che si svolgono alla Mostra di Venezia, e l’intervento del Presidente FEDIC Giorgio Ricci relativo alla “FEDIC Oggi” si è entrato nel vivo dei lavori con il produttore Gianluca Arcopinto che si è soffermato sul tema “Perché produrre cortometraggi”.

Il tavolo dei relatori al Forum FEDIC: da sinistra, Arcopinto, Giusiani, Micalizzi, Ricci, Polpettini, Di Gennaro. (Foto di Anna Marcoleoni)
Hanno fatto seguito gli interventi di Francesco Giusiani (Corte Tripoli Cinematografica-Pisa) dal titolo “Aspettando l’Opera Prima”, di Ettore Di Gennaro (Cineclub 3d Production-Parma) sull’essere “Filmmaker Selfmademan”, e la testimonianza di Fabrizio Polpettini (Film Caravan FEDIC) che è diventato “Da Autore a Produttore”. Un Forum che è stato un momento significativo di conoscenza e riflessione sulla situazione produttiva del cortometraggio italiano relativamente ai filmmakers, le cui opere qualitativamente sono di alto livello come testimoniato dalla proiezione di “ Culurzones” di Francesco Giusiani che si avvale dell’interpretazione del noto attore Carlo Delle Piane e di “Offerta” di Ettore Di Gennaro.
A VENEZIA IL PASSATO DEL CINEMA NE INTERROGA IL FUTURO
di Vittorio Boarini
La 73. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ci ha offerto, fra le sue numerose sezioni, la V edizione di Venezia Classici,la prestigiosa rassegna di film restaurati accompagnati da una serie di documentari sul cinema, le sue tendenze e i suoi protagonisti. Proprio da uno dei dieci documentari, tutti meritevoli di ampi commenti che purtroppo questo articolo non può ospitare, inizieremo il racconto dello straordinario viaggio nella storia della Settima Arte che questa rassegna ci ha consentito di fare (i film presentati coprono un arco di tempo compreso fra il 1931, “The Brat”, una deliziosa commedia di John Ford, e il 1990, anno dell’opera di Makhmalbaf, sulla quale ci soffermeremo più diffusamente in seguito).
“Cinema Futures”, dell’austriaco Michael Palm, ripropone con la forza delle immagini e delle autorevoli testimonianze (non solo Martin Scorsese, ma anche noti storici e tecnici del cinema, nonché archivisti di sperimentata competenza) il tema del destino che attende la Decima Musa nell’epoca del digitale.
Il cinema che ha riempito gli schermi per più di cento anni ha certamente concluso la sua vita analogica, ma la rivoluzione delle tecnologie digitali potrà assicurargli una nuova vita, se non migliore almeno altrettanto ricca? L’interrogativo posto drammaticamente da Palm, pur venato di nostalgia per il supporto foto-chimico, riguarda un problema ineludibile per molti aspetti, in particolare per quanto riguarda il patrimonio filmico in pellicola avventurosamente giunto fino a noi (si stimava negli anni ottanta che fosse il 50% di tutte le opere prodotte dal 1895 nel mondo). Ecco perché, senza sottovalutare le altre dimensioni della questione, iniziamo di qui il nostro percorso tra i ventuno film restaurati, tutti numericamente, che abbiamo potuto vedere o rivedere con gioia e con la speranza che abbiano un’ampia circolazione, ma non senza una certa inquietudine che cerchiamo subito di motivare. Premesso che i restauri erano complessivamente di buon livello, alcuni straordinari perché restituivano anche la “grana” della pellicola originale, resta il fatto che ora questi film li abbiamo su un supporto digitale, del quale non conosciamo ancora la resistenza all’usura del tempo. In altri termini, mentre abbiamo sperimentato che la pellicola, se trattata con la cura necessaria, si conserva integra per oltre cento anni, non conosciamo ancora quanto tempo può mantenersi intatto il supporto sul quale oggi vengono registrati i film (un nastro magnetico che porta incise le informazioni digitali). Per la conservazione del nostro patrimonio filmico sarebbe opportuno che di ogni opera restaurata se ne stampasse anche una copia sul supporto tradizionale, cosa che ora non avviene dato l’alto costo della pellicola, che sempre più difficilmente si trova sul mercato. Inoltre, quand’anche si reperissero i fondi per questa operazione, come garantire nel tempo un procedimento analogo per tutti i film accumulati nei depositi, che costituiscono la storia universale del cinema?
Seduti sull’orlo di questo abisso, abbiamo superato la vertigine del vuoto ammirando incondizionatamente il capolavoro di Gillo Pontecorvo, girato nel 1966, “La battaglia d’Algeri”, assistendo cioè, come ebbe a dire lo stesso regista, alla “nascita di una nazione”, l’Algeria, che si riscattava dal colonialismo.
In uno straordinario bianco e nero, calibrato sapientemente per rendere un effetto di realtà colta all’istante, la vicenda, interpretata da Saadi Yacef, un autentico protagonista del Fronte di Liberazione Algerino, si snoda in un crescendo di passione, perfezione formale e verità storica, la verità profonda dei popoli oppressi che lottano per la libertà. Continuando con i film italiani, ben rappresentati nella selezione, passiamo a “L’uomo dei cinque palloni”, di Marco Ferreri, un’opera, poi ribattezzata “Break Up” dal produttore Carlo Ponti, rimasta finora praticamente invisibile per un’incredibile censura del mercato. Terminato nel 1964 e passato indenne in censura, il film fu bloccato dallo stesso produttore che, non credendo nel suo valore commerciale nonostante la presenza di Marcello Mastroianni e Catherine Spaak, lo ridusse a un episodio, 35’, di “Oggi, domani, dopodomani”, film di scarso successo. Nel 1967 Ponti chiede a Ferreri di rimettere mano a “L’uomo dei cinque palloni”, cosa che avvenne con l’inserimento magistrale di tre nuove scene, fra le quali il lungo episodio a colori della discoteca.
Così rimontato, il film venne distribuito in Francia con il nuovo titolo, ma in Italia non ebbe mai una vera e propria uscita pubblica. Qui sarebbe finita la vicenda di una delle più interessanti opere del nostro Ferreri se la Cineteca di Bologna e il Museo del Cinema di Torino non avessero deciso di restituircelo con un restauro così felicemente riuscito da vincere il “Leone d’oro” istituito quattro anni fa dalla Biennale per il miglior restauro. Ora il film arriverà alle sale, il pubblico e la critica potranno finalmente prendere visione di questo straordinario antecedente di “Dillinger è morto” (1969), il capolavoro in cui Ferreri rappresenta esemplarmente l’intollerabilità esistenziale per la società moderna che affligge coloro i quali si accaniscono a trovare in essa una qualche ragionevolezza.
A proposito di censura, questo mostro dalle molte facce che sul cinema ha particolarmente infierito, andiamo subito all’eccezionale evento offertoci dalla Mostra con la proiezione di “Shabba-Ye Zayandeh-Rud” dell’iraniano Mohsen Makhmalbaf, venuto a Venezia per l’occasione. Qui si tratta della tradizionale censura politico-amministrativa che ridusse, in due successivi interventi, il negativo dell’opera a 63’ rispetto ai 100’ d’origine. Ma ciò non bastò al governo fondamentalista, che perseguitò il regista, anche con il carcere, e sequestrò il negativo chiudendolo negli archivi censori, da dove, dopo 26 anni, è stato avventurosamente sottratto, potendo così tornare nelle mani dell’autore, che ha reso possibile la presentazione del film a un pubblico internazionale.
Finalmente possiamo conoscere quest’opera, notevole nonostante i tagli feroci, il cui titolo potremmo tradurre con “Le notti sullo Zayandek-Rud”, il principale corso d’acqua dell’Iran centrale, che attraversa la città di Isfahan, dove è ambientata la storia. Questa si svolge prima, durante e dopo la presa del potere di Khomeini e ha per protagonisti un professore di antropologia, inviso al potere, e sua figlia, che lavora in un reparto d’ospedale dedicato ai suicidi per ingestione di sostanze tossiche. Grazie alla pacata forza delle immagini e al rigore del linguaggio, emerge un inquietante contesto sociale, dove, come dice il professore stesso a lezione, il totalitarismo è il risultato di una tradizione culturale.
Torniamo ai film italiani, ai quali purtroppo non abbiamo spazio sufficiente per dedicarci come meriterebbero, a partire dalla migliore opera di Luigi Zampa, il giudizio è suo e lo condividiamo, “Processo alla città”, del 1952, con Suso Cecchi D’Amico e Francesco Rosi fra gli sceneggiatori. Ispirato a uno storico processo alla camorra, svoltosi a Napoli all’inizio del Novecento, il film, girato in presa diretta, conserva un tono di viva attualità che ci emoziona ancora oggi. Intensa emozione ha suscitato anche la rievocazione di uno degli eventi più drammatici della nostra storia, l’8 settembre 1943, magistralmente attuata da Luigi Comencini con “Tutti a casa”. La catastrofe della sciagurata guerra fascista ci appare in tutta la sua tragica realtà fino alla conclusione del racconto, che coincide con le quattro giornate di Napoli, cioè con la prima vittoriosa affermazione della lotta di popolo sul nazifascismo. Di un altro rilevante protagonista del cinema italiano, Dino Risi, non sottolineiamo uno dei suoi film più fortunati, “Profumo di donna”, ma una rarità, “1848”, un prezioso cortometraggio sulle cinque giornate di Milano,girato nel 1949, che meriterebbe di essere proiettato in tutte le scuole italiane.
Italiano per metà è anche “Oci Ciornia”, una coproduzione italo-sovietica diretta da Nikita Michalkov nel 1987, che fu ben accolto anche grazie all’interpretazione del nostro Marcello più famoso. In questa occasione, i 20 anni dalla scomparsa di Mastroianni, abbiamo potuto vedere la versione lunga del film (144’), versione inedita con molte varianti d’autore e un inaspettato finale,il tutto, ovviamente, autorizzato dal regista. Italiano almeno a metà è anche “Zombi”, la versione europea di “Down of the Dead”, dell’arcinoto regista horror americano George A. Romero, versione montata da Dario Argento, che del film era coproduttore e lo aveva arricchito di una colonna sonora commissionata ai Goblin.
Della produzione statunitense, oltre al citato “The Brat”, dobbiamo segnalare un altro imperdibile reperto degli anni trenta, “Twentieth Century”, di Howard Hawks, nonché “Manhattan”, girato in un affascinante bianco e nero da Woody Allen nel 1979, e il film di culto “Pretty Poison” (Dolce veleno), opera prima, del 1968, di Noel Black.
In tema di reperti storici va segnalato “Opfergang”, film del 1943 di Veit Harlan, tristemente famoso per avere diretto nel 1940 “Suss l’ebreo” (Jud Süss), la più significativa opera nazista di propaganda antisemita. Il regista tedesco era un abile confezionatore di suggestivi melodrammi e questo, girato in agfacolor e circolato in Italia col titolo “La prigioniera del destino”, ne costituisce un buon esempio.
Molte le opere di alta qualità,come abbiamo visto, e fra queste dobbiamo annoverare uno dei capolavori di Andrej Tarkovsky, l’ultimo film di Robert Bresson e il mitico “I sette samurai”, tutti egregiamente restaurati. “Stalker” (1979) è un viaggio nella “Zona”, terra abbandonata e proibita, dove si avventurano due intellettuali con una guida, uno Stalker appunto, alla ricerca dell’Essere.
Non osando spingersi fino in fondo, torneranno indietro, ma con la consapevolezza dell’estrema difficoltà che si incontra nel mondo reale a salvare la dignità della condizione umana. Con “L’Argent” Bresson, Leone d’oro alla carriera, conclude coerentemente la sua straordinaria vicenda cinematografica. Girata senza attori professionisti, l’opera, come preannuncia il titolo, rappresenta la realtà profonda del denaro elevato a feticcio e le sue possibili (o inevitabili?) conseguenze. Infine, “Shichinin No Samurai”, con il quale Akira Kurosawa vinse il Leone d’argento nel 1954, dopo quello d’oro nel 1951 con “Rashomon”. Nulla ci sentiamo di aggiungere a quanto è già stato detto di questa opera maestra, che ha ispirato un’infinità di remake, alcuni anche dignitosi, ma sempre lontani dalla sua perfezione formale, probabilmente irraggiungibile.
Per completezza, aggiungiamo che Venezia Classici annoverava anche un altro interessante film giapponese; una pellicola di Hong Kong, fra l’altro restaurata nel laboratorio di Bologna; il piacevolissimo “Un lupo mannaro americano a Londra”, unica opera della Gran Bretagna; ma soprattutto il notevole film di Louis Malle, “Il ladro di Parigi” (Le Voleur,1967), con la sceneggiatura di Carrière e la portentosa interpretazione di Belmondo.
OCCHIO CRITICO
a cura di Marco Incerti Zambelli, Tullio Masoni, Paolo Vecchi
AMERICAN JEWS.
di Marco Incerti Zambelli
Non manca l’ardire a Ewan McGregor, attore dal corposo curriculum al servizio di eccellenti autori e vincitore di numerosi premi, nel cimentarsi, per la prima volta come regista, con il poderoso capolavoro di Philip Roth, vincitore del premio Pulitzer nel 1998, definitiva consacrazione de “il più grande scrittore americano vivente” e proprio per questo non (ancora) insignito del Nobel, anche in tempi nei quali gli Accademici Svedesi paiono ricordarsi degli Usa con il meritatissimo riconoscimento a Bob Dylan. Per chi avesse la (s)fortuna di non avere letto il romanzo, “American Pastoral” si presenta come un dignitoso prodotto, tipico di un buon cinema medio americano, quello che adesso pare essere migrato nelle serie televisive.
La storia dello Svedese, punto di riferimento e modello per la comunità ebraica ai confini della grande metropoli immediatamente dopo la seconda guerra mondiale (e l’Olocausto), che da esemplare dimostrazione della praticabilità dell’american dream si trasforma nel progressivo, inarrestabile sfaldarsi in tragedia, è apprezzabile, a tratti decisamente coinvolgente; la messa in scena è attenta e curata, gli attori abbastanza in parte, tutti gli elementi del raccontare cinematografico, dalla fotografia alla colonna sonora, adeguati. Certo i temi affrontati sono tanti, forse troppi, e rimangono spesso sullo sfondo, impliciti: il senso di colpa che pare attanagliare la cultura ebraica, la crisi della perfetta famigliola, l’ambiguità del rapporto padre figlia, lo sconvolgimento degli sessanta e settanta. E si intuisce che ben altro spessore sottende la vicenda. In fondo il limite di Mc Gregor e del pur valido sceneggiatore John Roman è la troppo diligenza nella trasposizione cinematografica ed allora il pregio maggiore dell’operazione potrebbe essere quello di invitare alla lettura del libro, ad immergersi in quegli abissi nei quali Roth magistralmente ci accompagna e sui quali il film si limita a galleggiare.
Non rischia invece Woody Allen con “Cafè Society”, quarantasettesima opera cinematografica, la prima girata interamente in digitale, ritornando ai suo temi più classici: l’amore, la famiglia ebraica, New York versus Los Angeles, il cinema, cuciti da un umorismo a tratti lievemente surreale ed impreziositi dalla proverbiale sagacia nello sfornare fulminanti battute.
Delega a Jesse Eisenberg ed alla sua azzeccata interpretazione il ruolo di protagonista, gli affianca una luminosa Kristine Stewart, li circonda di una serie di caratteristi degni della grande tradizione della commedia americana, senza rinunciare al ruolo di demiurgo: è sua, infatti, nell’edizione originale, la voce del narratore. Ricostruisce con partecipata nostalgia gli anni 30 del secolo scorso, dalla dignitosa periferia della metropoli agli sfavillanti panorami californiani, ai luccicanti decor dei luoghi di ritrovo della High Society, immergendoli in una accattivante e raffinata colonna sonora, illuminandoli con le lussuose immagini di Vittorio Storaro. Il prestigioso cinematographer italiano, che debutta anche lui qui per la prima volta in digitale ( a parte il pionieristico corto di Giuliano Montaldo “Arlecchino a Venezia”, nel 1983) imbastisce una sorta di sinfonia in 4 movimenti, come ha dichiarato: il Bronx lunare della vita di una modesta famiglia ebrea, con i colori desaturati, ispirato alle foto di Alfred Stieglitz; la calda esplosione dell’assolata Hollywood che rimanda alle opere di Edward Steichen ed all’Espressionismo tedesco; il rientro in una raffinata New York che ricorda i quadri di Tamara De Lempicka; nel finale il breve ritorno sulla West Coast rimanda all’alternarsi di luce ed ombra di Edward Hopper. Allen confeziona con sicuro mestiere una complessa, romanzesca storia in poco più di novanta minuti (e basterebbe questo a farcelo apprezzare, in tempi nei quali la sempre maggior lunghezza, dal cinema alla letteratura, sembra essere diventata la cifra necessaria) che si muove leggera tra romanticismo e ironia. Le vicissitudini di Bobby, che fugge dalla “perfetta” famiglia ebraica alla ricerca di se stesso nel fantasmagorico mondo di Hollywood, dove trova sorprendentemente il vero amore ma sperimenta anche la sua impossibilità, il convinto ritorno a New York in cui brillantemente farà la sua fortuna personale fino all’inaspettato reincontro con Vonnie, sono tratteggiate con elegante finezza, segnate dal sentore dolce amaro del malinconico rimpianto di ciò che poteva essere e non è stato.
SULLY, OVVERO: DISUBBIDIENZA E SAGGEZZA
di Tullio Masoni
Come noto, e ripreso dalle cronache in occasione dell’uscita del film, Eastwood racconta “una storia vera”: quella dell’ex-pilota militare Chesley Sullenberger, e dell’ammaraggio impossibile nelle gelide acque dell’Hudson, dopo che uno stormo di uccelli aveva mandato in avaria i motori dell’aereo. Era il gennaio del 2009, e tutte le 155 persone a bordo dell’ Us Airways si salvarono.
Mi pare di dover subito dire che il regista, come ciclicamente ha fatto nella sua prestigiosa carriera, sceglie in quest’ultima occasione uno spunto adatto al film “di genere”: episodio di cronaca, azione, aggancio a certa consuetudine spettacolare, dove il tema del disastro si presta all’esaltazione delle abilità tecniche e degli effetti speciali.
Ciò premesso, “Sully” ripropone con difetti e pregi l’ideologia dal regista spiegata in occasioni più autoriali. I difetti? Il primo, credo, di sceneggiatura, cioè in uno dei punti di forza su cui Eastwood ha costantemente fondato il proprio lavoro. Quando il “processo” intentato dalla National Transportation Safety Board contro il pilota già entrato nell’immaginario del paese come eroe – e nonostante ciò ritenuto responsabile di scelte fuori regola – giunge al momento decisivo, la quadratura del cerchio sembra sia affrettata e troppo artificiosa. In altre parole, basta un niente – sul piano squisitamente filmico/drammaturgico – perché la coltivata antipatia degli “inquisitori” si rovesci ed entri nel clima programmatico dell’happy ending. Un difetto non da poco: di sceneggiatura, come dicevo, e di concezione dei tempi drammatici.
E i pregi? Intanto l’operare in scioltezza nell’uso della scenografia a effetti speciali (era già felicemente accaduto con lo tsunami di “Hareafter” – un film forse sottovalutato – e, a mio avviso, meno felicemente nel paesaggio distrutto di “American Sniper”), poi il riaffermare, fra le modalità di genere, un’idea “tradizionalmente provocatoria”. Ha ragione Goffredo Fofi quando, ricordando le sue dichiarate simpatie per Trump, osserva che: « Eastwood, ottimo regista, non è ugualmente un’ottima mente e un ottimo cuore…», e tuttavia questa ennesima celebrazione dell’individualismo non lascia indifferenti: «Voi cercate l’errore umano – dichiara il pilota inquisito -…Allora siate umani». Ossia: invece di affidarvi alle certezze della simulazione elettronica, rispettate chi in 200 secondi si è preso il rischio di scegliere.
Un altro pregio mi sembra vada attribuito al montaggio; penso alla prima parte, quando gli incubi dell’eroe mostrano, per flash-back ossessivi, un’avventura che si chiude in tragedia: invece che ammarare nel grande fiume, l’aereo precipita su New York ed evoca, per l’ennesima volta, l’attentato dell’11 settembre 2001.
Qualcuno ha detto che la costante di Eastwood è la disubbidienza. Per gli eroi che mette in campo – reazionari o meno – egli si ispira sempre a una tradizione rigida, e talvolta spregiudicata, dove la disubbidienza alle leggi, al politically correct, e alla codardia del luogo comune, vorrebbe affermare un “umanismo superiore” e più saggio.
Lontano dalla primaria violenza del western, e da quella che soffoca la moderna società urbana, Sullenberger/Hanks rivendica per sé un’umanità di antiche radici e, nel medesimo tempo, risponde a un bisogno collettivo. Così, nel bene e nel male, egli incarna un carattere fondamentale dell’America; la sola che – come autore di cinema e uomo pubblico – Eastwood vuole servire.
DUE NOBEL: “NERUDA” DI PABLO LARRAIN;
“EL CIUDADANO ILUSTRE” DI GASTON DUPRAT,
MARIANO COHN
di Paolo Vecchi
“Neruda”, sesto lungometraggio di Pablo Larrain, è il primo biopic del regista cileno, che si è ripetuto poco dopo, passando a Hollywood, con “Jackie”. Se “Tony Manero”, “Post Mortem”, “No – I giorni dell’arcobaleno” e “El Club” vanno a comporre una sorta di tetralogia che ha sullo sfondo il regime di Pinochet, “Neruda” prende di petto uno dei personaggi chiave del Paese andino. In effetti, non di biopic in senso classico si tratta. L’azione si concentra infatti nel 1948, anno in cui il poeta e uomo politico cerca di espatriare dopo che il presidente Videla ha messo fuori legge il Partito Comunista, ma la vicenda è screziata da salti temporali che lo vedono in altri contesti, talvolta a fianco di personaggi famosi come Picasso. Dell’autore di “Canto General”, inoltre, non vengono risparmiate le innumerevoli contraddizioni dell’intellettuale borghese agiato, fideisticamente devoto all’URSS di Stalin, che si compiace di un facile populismo, oltre che, nel privato, un gaudente, un erotomane frequentatore di bordelli e dedito alle partouzes. Il punto di vista e la voce fuori campo, poi, sono quelli di Oscar Peluchonneau, un commissario della polizia politica che pretende di essere figlio naturale del fondatore del Corpo al quale appartiene, un piccolo uomo che ambisce a dare un senso alla propria squallida esistenza perseguitando un grande, secondo le modalità sadomasochistiche di un consolidato archetipo, letterario prima che cinematografico.
Ancora la storia del Cile, dunque, questa volta, come in “No”, più in primo piano, nella consapevolezza che in questo periodo di fascismo strisciante e incipiente dipendenza dagli USA è già in incubazione quel tragico golpe del 1973, poco dopo il quale Neruda morì in circostanze ancora da chiarire. Non essendo quello di Larrain un cinema a tesi, o declamatorio che dir si voglia, la complessità e l’ambiguità ne rappresentano ancora una volta le costanti. Non stupisce dunque che tra i brani di musica preesistente della raffinatissima colonna sonora venga più volte ripetuto l’inquietante, magnifico “The Unanswered Question” di Ives. Perché quasi sempre la Storia è appunto una domanda senza risposta.
Come è noto, Pablo Neruda è stato insignito del Nobel nel 1971. Nessun poeta o scrittore argentino si è mai potuto fregiare di quella prestigiosa onorificenza, compreso il grandissimo Borges, che commentava con un elegante e serafico <<Non lo conosco, ma sono contento perché così lo leggerò>> ogni volta che veniva attribuito a un carneade o giù di lì. L’autore di “Finzioni” è un po’ lo spirito guida di Daniel Mantovani, che Gaston Duprat e Mariano Cohn, registi di “El ciudadano ilustre”, sembrano avere immaginato vincitore del premio per una sorta di sberleffo nazionalistico.
Il film parte bene, con il discorso all’Accademia di Stoccolma di un Mantovani che, pur non arrivando al rifiuto di Sartre (e alla maleducazione di Dylan), sottolinea con pacatezza la contraddizione dello scrittore laureato da quello stesso establishment al quale per natura e funzione dovrebbe contrapporsi. Poi, quando il protagonista arriva all’aeroporto di Buenos Aires per recarsi al paese natale dove è stato invitato per i festeggiamenti di rito, il registro cambia bruscamente. Ad attenderlo, una vettura ammaccata, senza un faro e la ruota di scorta, guidata da un autista sgarbato, fanno presagire il giro di vite nel senso di un facile grottesco, di uno sgangherato libro delle caricature dove sono disegnati tutti gli abitanti di Salas e nel marasma del quale finisce per passare in secondo piano anche l’interpretazione misurata del bravo Oscar Martinez, Coppa Volpi a Venezia. Da dimenticare, poi, l’incontro finale con la stampa di Mantovani, il cui discorso, in fin troppo evidente parallelo con quello dell’incipit, va a impantanarsi, con una presunzione pari alla sua banalità, in argomenti rifritti come il rapporto dello scrittore con la realtà, i suoi personaggi e così via.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
“FUOCOAMMARE” E L’ESTETICA DEL SELFIE
di Marcello Cella
“I viaggi moltiplicano le vite degli uomini”
Banana Yoshimoto, “Un viaggio chiamato vita”
“Fuocoammare” di Gianfranco Rosi è un film di viaggio girato come un documentario oppure un documentario girato come un film di viaggio, a seconda di come lo percepisce lo spettatore. Un film di viaggio all’interno di un’isola, Lampedusa, sembra una contraddizione in termini. Eppure la narrazione di Rosi si struttura per accumulazione di momenti visivi, incontri, dialoghi, divagazioni apparentemente laterali che stanno tutti sullo stesso piano, come se il regista si mettesse nei panni di un viaggiatore che nulla sa di Lampedusa e della sua drammatica attualità di approdo per migranti che arrivano dall’Africa in fuga da guerre e miseria, e che scoprisse questa realtà, la vita dei migranti e di chi li accoglie, ma anche molte altre storie, per la prima volta. E per la prima volta riflettesse su ciò che accade sull’isola, sul suo passato fatto di dura vita da pescatori, di storie di fatica e di mare, e sul suo posto nel mondo esattamente come accade a Samuele, il ragazzino-viaggiatore che in qualche modo unisce con la sua presenza, ma soprattutto con il suo sguardo indagatore e incantato di bambino i vari momenti narrativi di cui è costituito il film.
Questo è lo stesso sguardo che assume Rosi per raccontare la sua storia-non storia, fuori da qualsiasi cliché televisivo o giornalistico, di cui la vicenda di Lampedusa è inevitabilmente intrisa con le sue scorie di attualità stracciona che tutto pretende di spiegare e catalogare e tutto ciò che non rientra nelle categorie pre-definite, pre-masticate lo lascia nell’ombra. Rosi invece procede in modo inverso. Parte dalle ombre, dai momenti apparentemente morti, dalle situazioni che sembrano far parte di una realtà misteriosa, atavica e forse magica per poi emergere all’attualità dei migranti in fuga e di chi li accoglie senza giudicare e senza usare le immagini per costruire il classico menù pietistico che da troppo tempo serve solo a mascherare la falsa coscienza di chi non vuole fare i conti con le proprie contraddizioni culturali, economiche, politiche e sociali.
Uno sguardo apparentemente vuoto, ma che lascia allo spettatore il tempo per riflettere su ciò che vede e su ciò che non vede, ma che Rosi lascia immaginare, e che disegna spazi che non hanno sempre bisogno della presenza umana per essere significativi.
Tutto il contrario di quanto avviene nell’estetica dominante attualmente nel cinema e su tutti i media, mutuata direttamente dall’individualismo autoreferenziale tipico dei social network, quella che potremmo definire “l’estetica del selfie”.
Come è noto il selfie, termine derivato dalla lingua inglese, è un “autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta, uno smartphone, un tablet o una webcam puntati verso se stessi o verso uno specchio, e condiviso sui social network”, come recita la Bibbia Wikipedia. E’ quindi per sua natura uno spazio pieno, occupato dall’ossessiva presenza umana che sovrasta qualsiasi elemento paesaggistico o ambientale relegandolo in secondo piano.
Inoltre è il contrario del tempo vuoto della vita che scorre nel suo flusso naturale, ma sottintende un tempo pieno in cui deve essere presente, in modo altrettanto ossessivo, una qualche azione umana, per quanto priva di significato essa sia, purchè sia visibile e “rumorosa”. Infatti anche i silenzi o il suono naturale delle cose, quello che pervade gli ambienti, naturali o artificiali, sono nemici del selfie che presuppone anche a livello sonoro un suono che riempie tempi e spazi, che annulla qualsiasi fonte sonora esterna all’esibizione della presenza umana, all’esibizione di sé, come succede quando si usa l’ipod, parente stretto del selfie, e si sovrappone ai rumori, alle voci, ai suoni del mondo esterno la propria individuale colonna sonora. Ma anche a livello narrativo l’estetica del selfie si esprime con la negazione dell’orizzontalità della narrazione, quella seguita dal film di Rosi, in cui si alternano momenti e situazioni ugualmente importanti sul piano esistenziale, per prediligere una verticalità narrativa artificiale e standardizzata che considera inutile tutto ciò che non fa progredire (“produrre”) la storia secondo una logica che tiene conto solo delle azioni umane, spesso decontestualizzate e del tutto gratuite, ma che danno allo spettatore un senso di stordimento e di apparente partecipazione emotiva alle situazioni del film, per poi lasciarlo vuoto e disorientato come dopo un rave party. Ciò che lascia poi lo spettatore dopato da overdose di selfie completamente stupefatto di fronte ad un film come “Fuocoammare” è l’assenza della voce narrante che in genere orienta (e spesso manipola) l’interpretazione dei fatti narrati da parte dello spettatore in questo genere di film o di documentari secondo una pessima abitudine televisiva che prevede appunto la presenza ossessiva della voce narrante e la stessa esibita presenza fisica del “narratore interno” (giornalista-conduttore) che sovrasta la semplice immagine audiovisuale di tali fatti, la loro profondità (di campo) e quindi la stessa possibilità del formarsi nella mente dello spettatore di interpretazioni alternative a quella sostenuta dal narratore interno. L’estetica del selfie che un film come “Fuocoammare” contraddice platealmente è quindi un’idea del cinema (e dei media) e quindi del mondo come luogo del cambiamento, come luogo del movimento fisico e mentale (motion-emotion, come rileva spesso un regista come Wim Wenders) libero da pre-giudizi, da mercanzia preconfezionata, da mappe pre-masticate e aperto agli imprevisti della realtà, agli incontri non pre-visti, agli infiniti incroci esistenziali. Come nel viaggio raccontato dalla scrittrice giapponese Banana Yoshimoto nel suo romanzo “Un viaggio chiamato vita”: “La sola cosa che non cambia mai è una sensazione che precede ogni viaggio: non tornerò uguale a prima. Credo che sia la sensazione più importante, quando ci si mette in viaggio”. Anche Samuele, il bambino protagonista di “Fuocoammare”, alla fine del suo personalissimo viaggio nel passato e nel presente della sua isola, della sua Lampedusa, non sarà più uguale a prima, ma più forte, più consapevole, più maturo e forse, a sua volta, pronto per un nuovo viaggio.
Fuocoammare
Regia: Gianfranco Rosi.
Attori: Samuele Pucillo, Mattias Cucina, Samuele Caruana, Pietro Bartolo, Giuseppe
Fragapane, Maria Signorello, Francesco Paterna, Francesco Mannino, Maria Costa
Soggetto: Carla Cattani
Sceneggiatura: Gianfranco Rosi
Produttori: Gianfranco Rosi, Paolo Del Brocco e Donatella Palermo
Fotografia: Gianfranco Rosi
Montaggio: Jacopo Quadri
Musiche: Stefano Grosso
Durata; 107 minuti
Produzione: Italia-Francia
Anno: 2016.
NEO-CINEMA
a cura di Elio Girlanda
CAMERE SFERICHE E NUOVO RACCONTO
di Elio Girlanda
Nel n. 6/2015 di “Carte di Cinema” s’è scritto di “camere sferiche” ovvero di nuovi modelli di telecamere, piccole e molto economiche, che consentono riprese “immersive” a 360°. L’argomento merita un’altra riflessione perché nel frattempo il mercato si è esteso e molte produzioni professionali stanno investendo nel settore, realizzando corti di nuova concezione in combinazione con visori e app di realtà virtuale. Quindi si rafforza un fenomeno nell’audiovisivo commerciale e consumer che è insieme tecnologico ed estetico, commerciale e sperimentale, collegato, altresì, alle narrazioni del futuro. Ricordiamo infatti, come nota Simone Arcagni (Visioni digitali, Einaudi, Torino 2016), che l’audiovisivo online è un “mutante genetico” le cui forme sono riconoscibili ma di cui poi il sistema digitale trasforma le strutture profonde, come accade per i video amatoriali e per i game per esempio girati con minicamere GoPro.
Nel caso delle camere sferiche valga innanzitutto l’esempio dell’azienda Advanced Technology and Projects (Atap) che lavora nel campus di Google a Mountain View in California. Qui, sotto la guida di Jan Pinkava, animatore e regista di Ratatouille (2008), oltre ad altri progetti e invenzioni, sono stati prodotti nove corti d’animazione d’autore a 360°, disponibili gratuitamente attraverso un’app su YouTube, per la serie 360 Google Spotlight Story. Tra gli altri, ci sono i raffinati Pearl di Patrick Osborne,(https://www.youtube.com/watch?v=WqCH4DNQBUA), Oscar nel 2015 per il corto Feast, Special Delivery dello studio Aardman, lo stesso di Galline in fuga (2000) e Wallace & Gromit (Oscar 2006), oppure il fantascientifico Help di Justin Lin (https://www.youtube.com/watch?v=G-XZhKqQAHU), un mix di animazione e action live, e altri ancora.
Lo strumento principale resta lo smartphone con cui inquadrare liberamente quel che avviene attorno a noi. Quindi lo spettatore, a sua volta, altrettanto liberamente, con un visore di realtà virtuale potrà scegliere cosa guardare, decidendo di seguire la storia principale oppure le sottotrame che si moltiplicano. È la “narrazione immersiva” che, assieme alla visione panoramica della realtà o della fiction di cui si diceva nell’articolo succitato, quindi precinematografica, s’aggiunge alla moltiplicazione dei punti di vista o delle scelte a disposizione dello spettatore. Lo stesso Pinkava parla di “flessibilità delle storie” che si adattano allo sguardo dello spettatore e che a volte lo attirano per far continuare la trama principale. Analogamente avviene per la colonna sonora. La conseguenza estetica? Scompare il fuori campo, dichiara sempre Pinkava, o, meglio, se ne creano di infiniti. Le ricadute sono molteplici sia per l’estensione del mercato con visori, app e prodotti audiovisivi sia per l’utilizzo nei vari campi dell’entertainment e dell’informazione. È il caso del New York Times che ha rilasciato un’app (NYT Vr) per poter vedere numerosi documentari e corti di attualità e cronaca. Similmente hanno prodotto documentari a 360° anche BBC, Huffington Post, Sky Tg24 ecc., con reportage su casi di disastri (scontro di treni, alluvioni, terremoti ecc.), esattamente come ai tempi dei Lumière.
Altre conseguenze, però, riguardano la nuova concezione del “corto”, finora considerato tale per la durata in senso letterale, rispetto al medio e lungometraggio, almeno secondo i criteri della tradizionale “narratività orientata”. Come spiega uno dei massimi studiosi dei nuovi media, Derrick de Kerckhove, a proposito della scrittura multimediale che tende all’iconicità piuttosto che alla sequenzialità, nel nostro continuo dialogo ipertestuale con la rete lo sviluppo delle nuove tecnologie <<annuncia la fine della “narratività orientata” e del destino individuale. La linearità delle cose — l’esistenza di un inizio e di una fine — è un’invenzione occidentale successiva all’alfabeto, come la tragedia e la commedia. […] Più si scrive, più si guadagna casualità di controllo sul destino. Né possiamo negare che la scrittura, ampliando in una direzione particolare la nostra intelligenza, abbia fatto di noi dei personaggi d’invenzione, che inventano la vita e il proprio destino. Allo stato attuale, dunque, questa narratività non è più orientata ma multimediale, ipermediale, transmediale. Anche la struttura del destino, che è stata ancorata al nostro essere dai greci, dev’essere perciò ripensata nella sua dimensione individuale>> (La rete ci renderà stupidi?, Castelvecchi, Roma 2016, pp. 29-30). Quindi con la realtà virtuale e la ripresa a 360° dovremo abbandonare la dizione convenzionale di “racconto finalizzato a” e di “corto”, come è già avvenuto per le app e i videogame, poiché la durata “fisica” o “lineare” del prodotto si può estendere all’infinito, grazie alla moltiplicazione dei punti di vista e dei racconti possibili. Un “corto” a 360°, cioè, può risultare molto ma molto più lungo di un cosiddetto lungometraggio, compresa la durata degli stessi processi di produzione, tipica nel cinema d’animazione.
E ancora. Nel rinnovamento della narratività, da “orientata” a ipermediale, cambia radicalmente, come già detto, o scompare del tutto la nozione di fuori campo che costituisce, prima in pittura, poi in fotografia, quindi nel cinema, uno dei caposaldi di incorniciatura del visibile e visuale, oltreché del sonoro, e allo stesso tempo uno stilema importante dalle tante potenzialità retoriche e narratologiche (ellissi, metonimia, invisibile, fuori schermo, voce off ecc.). Riprendere una scena più o meno affollata dove, comunque, il fuori campo può essere sempre “visto” o ricompreso dall’osservatore, trasforma, oltreché la regia, la messa in scena, anche il dispositivo schermico dei media audiovisivi (che si modificano, appunto, in visori personalizzati), e la stessa condizione epistemologica e psicologica dello spettatore, fin qui consolidata. Sono importanti trasformazioni che riguardano l’ambito della fiction e quello della non fiction dove, allo stesso modo, l’empatia dello spettatore è facilitata dall’immersività realistica della visione. Come avviene nel caso del giornalismo umanitario, testimoniato per esempio dal recente documentario di Susan Sarandon sugli sbarchi di migranti in Grecia per l’Huffington Post.
In tal senso una riflessione accurata viene dallo studioso Ruggero Eugeni a proposito di un particolare tipo di soggettiva, oggi molto usata nell’audiovisivo: il first person shot o first person perspective. Il termine sta a indicare quello che classicamente era lo sguardo in prima persona, ma che ora si moltiplica nei film soprattutto horror, nei video virali, nei video tutorial o girati con piccole telecamere di sorveglianza, magari situate sulla propria testa, e soprattutto nei videogiochi. Esso esprime ciò che <<vediamo quanto il personaggio centrale vede e sentiamo quanto egli sente mano a mano che avanza, si guarda intorno, coglie un riflesso sospetto e spara a un potenziale nemico; ma non lo vediamo mai in faccia — così come non vediamo mai la nostra faccia nella vita ordinaria (a meno di non trovarci davanti a uno specchio, il che talvolta accade anche nei videogiochi). […] Possiamo dire dunque che il first person shot viene caratterizzato da due aspetti: il costituire la trascrizione immediata di una esperienza soggettiva di prensione incorporata del mondo, e l’implicare una relazione di simbiosi e ibridazione tra un soggetto umano e una macchina da ripresa>>. È un’ ”ipersoggettiva”, secondo la definizione di Eugeni, o, meglio, <<esso realizza l’utopia di una soggettiva infinita e in grado di trascrivere perfettamente l’esperienza personale del mondo e del racconto, che il regime classico e moderno del racconto audiovisivo avevano inseguito, a tratti preconizzato, ma mai realizzato perfettamente per vincoli tanto tecnologici quanto culturali>> (La condizione postmediale, La Scuola, Brescia 2015).
Con questa riflessione di Eugeni anche la visione sferica può costituire una “figura espressiva radicalmente postmediale” e, al contempo, esprimere al meglio, proprio come il first person shot, il sistema epico centrale della condizione postmediale: “la soggettivizzazione dell’esperienza”. A tutto ciò, ricorda ancora Eugeni, siamo arrivati dopo una lunga storia di innovazioni tecnologiche, segnata dapprima dalla steadicam; poi dalle videocamere digitali portatili con le riprese sporche, “rubate” ecc.; le videocamere digitali miniaturizzate ovvero dalle helmet cameras del 1987 alle GoPro Hero montate sui droni dei giorni nostri; le microcamere di sorveglianza e controllo; la realtà virtuale; infine dallo sviluppo di videogiochi giocabili in prima persona. Ricordiamo che il concetto di postmediale si applica al first person shot, come alle videocamere sferiche, perché tutti i dispositivi sono soggetti a “de-individuazione” mediale in quanto sono alle stesso modo cinematografici, televisivi, medici, militari, polizieschi, legali, ecc., e perché interagiscono strettamente tra loro, ibridandosi costantemente.
La possibilità di avere a disposizione sul mercato software dedicati e videocamere a costi accessibili, come la LG 360 Cam con cattura sferica, la Gear 360 di Samsung, la ALLie della IC Real Tech o quella della Ricoh, compatibili con i social media, non solo amplia a dismisura la platea di autori semiprofessionali ma, molto più che nei casi del 3D e della realtà virtuale, potrà consentire sperimentazioni quanto mai numerose e innovative a più livelli e in ambiti diversi.
QUALITA’ IN SERIE
a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
TIMELESS (USA/2016)
di Luisa Ceretto
Un’agenzia governativa sta ultimando i lavori su una macchina del tempo. Un potente criminale, l’anarchico Garcia Flynn, riesce a rubarla. Il suo intento è quello di alterare la Storia e il passato per distruggere gli Stati Uniti. Il governo americano affiderà ad una squadra composta dallo scienziato Rufus Carlin, dalla professoressa e storica Lucy Preston e dal soldato Waytt Logan il compito di viaggiare nel passato per salvare il futuro dell’umanità. Ma è fondamentale evitare di alterare il corso degli eventi. Grazie al prototipo della macchina, i tre riusciranno a mettersi sulle tracce del fuggitivo…
Scritta da Eric Kripke (“Revolution”, “Supernatural”) e Shawn Ryan (“The Shied”) e prodotta da NBC, “Timeless” è la nuova serie action-thriller a tinte sci-fi, presentata su Sky Fox. Per quanto non sia ancora stata programmata nella sua interezza, sono infatti soltanto quattro gli episodi finora presentati, la serie ha già suscitato numerose critiche. “Timeless” sembra difatti non aver ricevuto l’attenzione auspicata, tanto da metterne in forse una seconda stagione, se non addirittura la cancellazione della prima serie dal palinsesto televisivo.
Dei dodici episodi previsti, soltanto dieci risultano ultimati, anche se recentemente pare ne siano stati programmati altri quattro, per un totale complessivo di sedici puntate. Tra le accuse maggiori mosse a “Timeless”, una trama alle volte piuttosto confusa e personaggi stereotipati.
Eppure, malgrado alcune carenze, crediamo che la serie non sia priva di interesse e possa sicuramente suscitare la curiosità di un pubblico legato ad un certo tipo di scrittura, forse più classico e meno immediatamente riconoscibile. Anche se è lontano dall’essere impeccabile, “Timeless” – come del resto ormai la maggior parte delle produzioni televisive di questo genere – vanta un ottimo livello qualitativo, una fattura che deve molto e guarda più che mai alla narrazione, ai tempi e agli stili del grande schermo.
 E’ ormai un dato di fatto che sempre più spesso l’universo della settima arte e le sue maestranze, in particolare i registi, si cimentino nella scrittura seriale del piccolo schermo, talvolta nella realizzazione anche solo di una puntata pilota. Basta sfogliare o consultare sulla rete i programmi televisivi per rendersene conto.
E’ ormai un dato di fatto che sempre più spesso l’universo della settima arte e le sue maestranze, in particolare i registi, si cimentino nella scrittura seriale del piccolo schermo, talvolta nella realizzazione anche solo di una puntata pilota. Basta sfogliare o consultare sulla rete i programmi televisivi per rendersene conto.
Sul piano della ricostruzione storica e degli effetti speciali, non v’è dubbio sulla qualità di “Timeless”. Ciascuna puntata conduce i suoi personaggi in un determinato momento della Storia ricreandone l’ambientazione. Nella prima puntata lo spettatore si trova catapultato nel giorno in cui l’Hindenburg (6 maggio 1937), il famoso dirigibile tedesco, ha preso fuoco nel New Jersey. Nell’episodio successivo l’azione si sposta nel teatro dove il sedicesimo presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, è stato assassinato (14 aprile 1865).
 Un’attenzione che è esplicitata anche nella sceneggiatura, a partire dalla scelta di servirsi di una studiosa di storia e antropologia che aiuti il resto dell’equipaggio a muoversi con maggiore agio tra le pieghe del tempo, negli usi e costumi delle varie epoche.
Un’attenzione che è esplicitata anche nella sceneggiatura, a partire dalla scelta di servirsi di una studiosa di storia e antropologia che aiuti il resto dell’equipaggio a muoversi con maggiore agio tra le pieghe del tempo, negli usi e costumi delle varie epoche.
Se il tema del viaggio nel tempo non è certo nuovo nel mondo del cinema, “Ritorno al futuro” costituisce ancora un cult in questo senso, ben presto si è rivelato un argomento interessante anche per l’universo della scrittura seriale. Ricordiamo, ad esempio, “Outlander”(2014), una produzione britannico-statunitense creata da Ronald D.Moore, tratta da un ciclo di romanzi della scrittrice Diana Gabaldon, dove si raccontano le disavventure di una viaggiatrice nel tempo, l’infermiera Claire Randall, che dalla seconda guerra mondiale si ritrova nella Scozia della metà del diciottesimo secolo.
Se “Timeless” per quel dover riportare indietro le lancette della Storia, costituisce una sfida per i suoi sceneggiatori, è anche un’ulteriore conferma di quanto ormai la produzione cinematografica rappresenti un terreno di confronto per il mondo delle serie tv. E di come la Storia e alcune delle sue pagine più o meno note siano una fonte inesauribile cui attingere.
Del resto anche la scelta dei suoi autori di avvicinarsi alla Storia in maniera per così dire scolastica – come si trattasse di scorrere velocemente l’indice di un volume di Storia, e di scegliere alcuni momenti salienti, come per memorizzarli – forse in un contesto complesso come quello odierno, che sembra troppo spesso dimenticare e fare tabula del proprio passato e di cosa è avvenuto, non è poi così sbagliata.
Cast:
Abigail Spencer (Lucy Preston), Matt Lanter (Wyatt Logan), Malcolm Barrett (Rufus Carlin), Sakina Jaffrey (Denise Christopher), Paterson Joseph (Connor Mason), Claudia Doumit (Jiya) , Goran Višnjić (Garcia Flynn)
PANORAMA LIBRI
di Paolo Micalizzi
 VENGA A PRENDERE IL CAFFE’…DA NOI
VENGA A PRENDERE IL CAFFE’…DA NOI
a cura di Angelo Zanellato
Quaderni di CinemaSud
Pagg. 261
Euro 18
Angelo Zanellato è da molti anni, e tra i primi, studioso del cinema di Alberto Lattuada. Esce ora, per le edizioni dei “Quaderni di CinemaSud”, un volume dal titolo “Venga a prendere il caffè … da noi” in cui viene raccontata la realizzazione di questo film del 1970, tratto da “La spartizione” di Piero Chiara ambientato a Luino, viene pubblicata la sceneggiatura ed un’Antologia critica relativa al film. Il tutto impreziosito da un inedito carteggio Chiara-Lattuada. Apre il volume un’introduzione del prestigioso storico del cinema Orio Caldiron” che sottolinea come” l’incontro di Alberto Lattuada con la narrativa di Piero Chiara con la sua polifonica attitudine a variare all’infinito le storie del lago tra anteguerra e dopoguerra, non poteva essere più felice. Il protagonista c’è tutto sulla pagina con i suoi vizi, le sue manie, le sue abitudini, le sue letture(…) ma rivive di vita veramente vissuta solo nel momento in cui s’incontra con la sanguigna volgarità padana di Ugo Tognazzi, con lo sguardo vacuo e penetrante del grande attore cremonese affacciato sull’abisso della carne, sul mistero flagrante della donna, brutte comprese. Quando al ristorante con uno stecchino si pulisce le unghie, le orecchie, i denti, un piccolo e disgustoso dettaglio che non c’è nel libro ma è stato aggiunto di proposito dal regista, lo vediamo muoversi come se ce l’avessimo davanti, come se l’avessimo sempre conosciuto sullo sfondo di quella provincia meschina con i suoi segreti e le sue ipocrisie, ”un piè in ciesa e l’altro in casin”, come diceva Delio Tessa, che è l’anima segreta del film, una delle ragioni della sua permanente attualità”. Orio Caldiron sottolinea anche che “la sorpresa maggiore viene dal quaderno di appunti steso all’epoca della lavorazione in cui il critico diventa scrittore”. E’ un diario che Angelo Zanellato aveva steso, avendo partecipato alla lavorazione del film su invito di Lattuada che aveva apprezzato la tesi di laurea che aveva scritto su di lui. Diario che adesso Zanellato ha ritrovato fornendoci aneddoti e curiosità del set. Ad esso si aggiunge il carteggio tra il regista e lo scrittore che Federico Ravegnani, curatore dell’archivio Piero Chiara, gli ha messo a disposizione “ con liberalità tanto generosa quanto disinteressata”. Ne scaturisce un apparato documentario-critico sul film che c’immerge nel clima della sua realizzazione che Angelo Zanellato come da dedica alla troupe artistica e tecnica, ricorda che essa “con talento, professionalità e allegria ha realizzato il film”. Il libro si avvale di un corredo fotografico sul film e sulla “Luino,ieri e oggi” d’indubbio interesse.
 MIMMO CALOPRESTI.LA PAROLA CINEMA ESISTE
MIMMO CALOPRESTI.LA PAROLA CINEMA ESISTE
di Ignazio Senatore
Edizioni Falsopiano,2016
Pagg. 161
Euro 20
Un libro di Ignazio Senatore, critico cinematografico di formazione psichiatrica e psicoterapeutica, che dedica particolarmente la sua attenzione saggistica ai registi italiani: adesso, Mimmo Calopresti dopo “Roberto Faenza. Uno scomodo regista”(2011), “Conversazione con Giuseppe Piccioni”(2013),”Daniele Luchetti racconta il suo cinema”(2014) e “Alessandro D’Alatri. Il mio cinema”(2015). Quello sul regista calabrese s’intitola “Mimmo Calopresti. La parola cinema esiste” mutuando il titolo da quello di un film importante dell’autore del 1998 “La parola amore esiste”. Un libro che ripercorre la vita e la filmografia di Mimmo Calopresti attraverso una lunga intervista. Iniziando dalla sua passione per il cinema grazie all’aver ascoltato all’Università di Torino, dove era iscritto a Scienze Politiche, una lezione di Gianni Rondolino (“che mi ha affascinato”) e l’incontro con Steve Della Casa con il quale iniziò poi a frequentare e fare attività nei Cineclub , l’amore per il Neorealismo, Rossellini, De Sica, la Nouvelle Vague, il western, la frequentazione dei Circoli di Lotta Continua, e la collaborazione con l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e la realizzazione del documentario “A proposito di sbavature” che vince il primo premio al Festival Cinema Giovani di Torino, a cui fecero seguito altri documentari d’impronta politica allo scopo di fare contro-informazione. La sua è una concezione del documentario come ricerca, conoscenza della realtà, caratteristiche che contraddistingue anche i suoi documentari d’oggi. La conversazione poi s’incentra sui lungometraggi, dal primo “La seconda volta” del 1995 fino a “Uno per tutti” del 2015, ma anche sul suo pensiero sul cinema, sugli attori, sulla sceneggiatura. Il suo è “Il vero cinema resistente” afferma Roberto Lasagna nell’introduzione del libro sottolineando che il suo cinema “gravita e si avviluppa, con imprevedibile disincanto e amore per il cinema, attorno a nodi e situazioni esemplari di una ben riconoscibile cartografia del sociale. Le fabbriche, gli scioperi, il terrorismo, il disagio femminile, l’integrazione tra Nord e Sud, la shoah, le onte di una dimensione lavorativa sempre più precaria, le trasformazioni sociali che si riflettono e si impongono nella vita di individui osservati con umana e disillusa partecipazione. Cinema da vedere e rivedere con curiosità e ricerca del dettaglio introspettivo, nel segno di titoli enigmatici e dal sapore umanista; titoli come pensieri sospesi, allusivi e sottili”. Aggiungendo infine che quelle di Calopresti sono sovente scelte coraggiose. Il libro è arricchito da alcune significative fotografie, una documentazione sui suoi film con “frasi cult” e Antologia della critica compresa quella online, ed una completa filmografia.
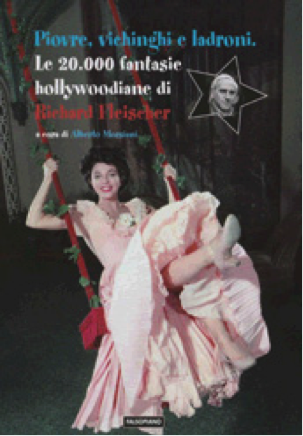 PIOVRE,VICHINGHI E LADRONI
PIOVRE,VICHINGHI E LADRONI
LE 20.000 FANTASIE HOLLYWOODIANE DI RICHARD FLEISCHER
a cura di Alberto Morsiani
Edizioni Falsopiano
Pagg. 171
Euro 19
Un libro che il curatore. Alberto Morsiani, dedica a tutti i veri cinefili(tra cui le figlie), “gli unici che possono davvero capire e godere dei film eccitanti e fantasiosi di Richard Fleischer”, e alla Hollywood che non c’è più. Apre il volume un suo saggio su “Il più grande regista sconosciuto del mondo” dove subito afferma che a questo regista siamo debitori, come cinefili, di alcun maggiori divertimenti della nostra infanzia e giovinezza. E aggiunge: “come dimenticare tra i tanti momenti eccitanti o spassosi dei suoi film, la lotta con la piovra gigante e gli interni vittoriani del sottomarino di “20.000 leghe sotto i mari””, la protervia di Kirk Douglas guercio da un occhio in “I Vichinghi”, Anthony Quinn ottuso ladrone redento in “Barabba”, l’amabile dottor Dollittle, il corpo umano come pianeta alieno in “Viaggio allucinante”, il colosso nero Ken Norton sessualmente eccitato dalla piccola venere bionda Susan George in “Mandingo”… “ . Morsiani vorrebbe continuare con altri personaggi di altri film di Fleischer che ci hanno emozionato, “ sottolineando “il senso del meraviglioso presente nei suoi film che definisce “autentiche fantasie hollywoodiane”, facendole dipendere, forse, dal fatto che il regista è figlio di Max e nipote di Dave Fleischer, due fratelli, tra i più inventivi creatori hollywwodiani che hanno dato vita a personaggi come Betty Boop ed ai cartoni animati di Popeye. Per elaborare il suo saggio Alberto Morsiani ha recuperato( e scoperto) anche i suoi primi film, in bianco e nero, ”i magnifici gioiellini noir” degli anni Quaranta e Cinquanta riportando alla luce ed alla nostra memoria di spettatori titoli come “Squadra mobile 61” il cui soggetto è cofirmato da Robert Altman, “Sterminate la gang!”(1950) e “Le jene di Chicago”(1952): opere che si distaccano dalla media del genere noir, ben costruiti, ricchi di suspense, ben recitati, piccoli gioielli del cosiddetto cinema di serie B. Arriva poi la notorietà con film come “20.000 leghe sotto i mari” e, oltre a quelli già citati da Morsiani, “Frenesia del delitto”, “Dramma nello specchio”, “Tora! Tora! Tora!”. Una cinquantina i titoli della sua filmografia che attraversa, si può dire, tutti i generi. Un autore il cui talento è riconosciuto soprattutto dalla critica francese mentre in Italia, sottolinea Morsiani, Richard Fleischer è sempre stato trattato dalla critica alla stregua di un anonimo regista commerciale, fatte alcune eccezioni che hanno portato alla riscoperta di questo regista attribuendogli uno stato autoriale. Anche se in Fleischer, come ammette Morsiani, l’ultima parte della carriera è stata contraddistinta da film non certo eccelsi, tranne che “Mandingo” del 1975. Ma ciò, a nostro avviso, non giustifica che sia un autore da dimenticare. Oltre all’accurata e appassionata ricostruzione della sua carriera ed alla profonda analisi del suo cinema effettuata da Alberto Morsiani seguono altri saggi che esaminano profondamente alcuni film dovuti, oltre che a Morsiani, a Roberto Chiesi, Massimo Lastrucci, Leonardo Gandini, Paolo Vecchi, Fabio Zanello, Emanuela Martini, Mario Gerosa. Completano il volume alcuni Incontri-interviste a Richard Fleischer dovute a Bertrand Tavernier e al duo Michel Ciment- Lorenzo Codelli che sono anche gli autori di un ”Dossier Fleischer” pubblicato nel giugno 2006 su “Positif”. Che insieme a una “Bibliografia selezionata” costituiscono materiali per un utile approfondimento su un regista che non merita di cadere nell’oblio.
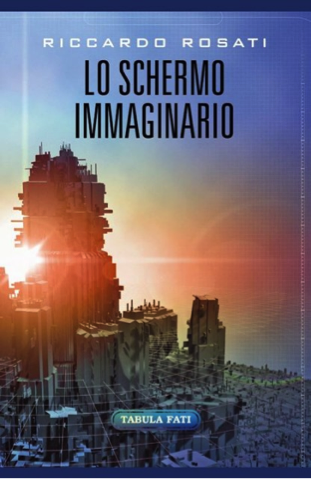 LO SCHERMO IMMAGINARIO
LO SCHERMO IMMAGINARIO
di Riccardo Rosati
Edizioni Tabula Fati
pagg. 183
euro 14
Un libro sul cinema fantastico(fantascienza, fantasy e horror) che raccoglie scritti cinematografici di Riccardo Rosati che l’autore definisce “fuori dal coro” entrando volutamente in polemica con la critica che, secondo lui, considera il genere come qualcosa di deteriore. Il libro raccoglie quattordici anni di scritti, tra recensioni e saggi, che testimoniano “come si siano sempre sostenute determinate idee, persino quando scomode e impopolari, il che porta inesorabilmente a essere controcorrente”. Queste le premesse indicate dallo stesso autore con le quali il lettore potrà leggere saggi su “George Pal, il padre del cinema commerciale di fantascienza”, “Scienza e fede nel cinema di fantascienza: Star Trek e Star Wars a confronto”, “Lovecraft e il cinema, tra forzature e misinterpretazioni”, “Le navi indistruttibili di Ishiro Honda: la fantatecnologia giapponese” e numerose recensioni di film del passato e del presente, poco meno di quaranta.
CREDITS
Carte di Cinema 11
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com )
Direttore editoriale: Giorgio Ricci
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 11 della rivista online: Alfredo Baldi, Vittorio Boarini, Marcello Cella, Luisa Ceretto, Paola Dei, Marino Demata, Elio Girlanda, Alessandro Grande, Barbara Grassi, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Giorgia Pizzirani, Riccardo Poma, Sara Riccobono, Marina Ruiz, Antonella Santarelli, Eleonora Sforzi, Tommaso Valente, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Marco I. Zambelli,