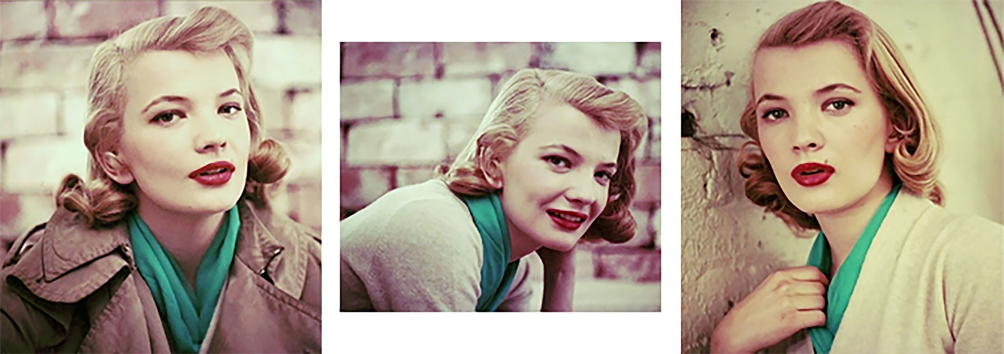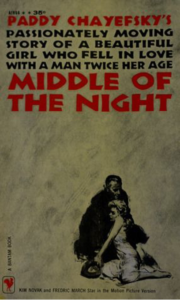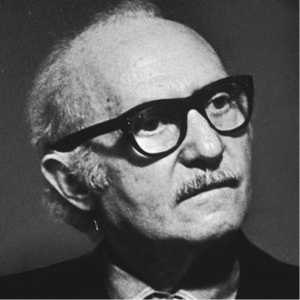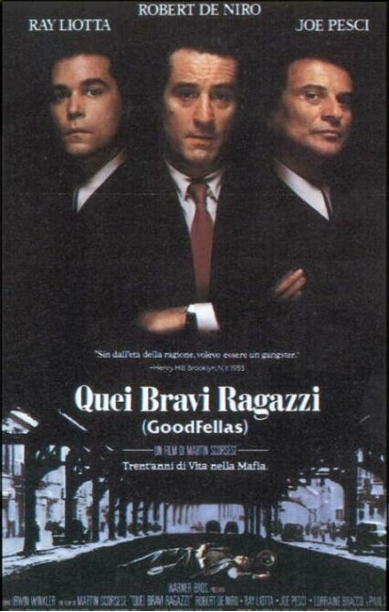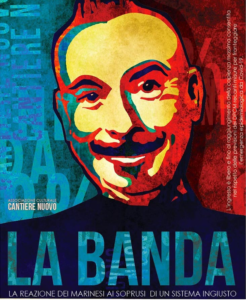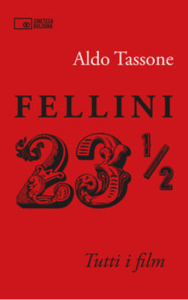Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 3.1 CINEMA E SESSANTOTTO: BELLOCCHIO, BERTOLUCCI E GLI ALTRI di Roberto Lasagna
- 3.2 QUESTA VOLTA PARLIAMO DI LINA di Francesco Saverio Marzaduri
- 3.3 ADRIAN: IL TEMPO (NON) SE NE VA… di Francesco Saverio Marzaduri
- 3.4 “CARO DOMANI” DI MARIANTONIA AVATI di Roberto Baldassarre
- 3.5 UN PALCO AL CINEMA. IL FILM D’OPERA ITALIANO NEGLI ANNI TRENTA-CINQUANTA DEL NOVECENTO – SECONDA PARTE di Mario Giunco
- 3.6 GUSTAVO LOMBARDO, IL “TORINESE” DEL CINEMA NAPOLETANO di Mario Galeotti
- 3.7 “MISSION TO MARS”LA VITA SOGNATA NEL VUOTO di Danilo Amione
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 4.1 UNA RILEVANTE PRESENZA FEDIC ALLA MOSTRA DI VENEZIA di Paolo Micalizzi
- 4.2 17° SEDICICORTO FORLÌ – FORMULA IBRIDA VINCENTE di Gianluca Castellini
- 4.3 PER STARE INSIEME IN TEMPO DI COVID di Roberto Merlino
- 4.4 SUCCESSO DEL 70. ITALIA FILM FESTIVAL ORGANIZZATO DALLA FEDIC A MONTECATINI TERME di Paolo Micalizzi
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 5.1 77. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
- 5.2 PESARO 56 di Paolo Vecchi
- 5.3 IL GEORGIANO BEGINNING E’ STATO IL GRANDE TRIONFATORE DELLA 68° EDIZIONE DEL SAN SEBASTIAN FILM FESTIVAL di Alessandra Pighi, Xoxan Villanueva
- 5.4 “LUNANA: UNO YAK IN CLASSE” VINCE LA 26a EDIZIONE DEL FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
- 6 OCCHIO CRITICO
- 7 QUALITÀ IN SERIE
- 8 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 9 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
IL FREE CINEMA INGLESE di Marino Demata
Il saggio si sofferma sulla oggettiva esigenza, avvertita da molti intellettuali inglesi degli anni ’50 del secolo scorso, di un profondo rinnovamento e svecchiamento della cultura britannica, incapace, fino a quel momento, di cogliere i movimenti innovativi che agitavano il Paese, anche sull’onda di problemi non risolti dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi. I primi a muoversi furono gli innovatori in campo cinematografico, che diedero vita al movimento del Free cinema. Quattro furono i leader del movimento: Lindsay Anderson, Karol Reisz, Tony Richardson e l’italiana Lorenza Mazzetti.lI saggio segue gli eventi che determinano il nascere del movimento anche attraverso la stesura di un manifesto e attraverso sei sessioni di cinema innovativo nazionale e internazionale, organizzate in soli 3 anni, dal 1956 al 1959. Il saggio passa quindi in rassegna i quattro registi, seguendoli anche dopo il sesto e ultimo incontro al National Film Theatre in Londra, nel loro passaggio dal documentario al film di finzione, anche grazie alla sollecitazione e all’aiuto degli scrittori di romanzi e di teatro, che crearono la corrente dei giovani arrabbiati. I quattro registi vengono seguiti attraverso le loro più significative opere di esordio.Nell’ultima parte il saggio si sofferma brevemente su due tra i registi che seppero raccogliere nel modo migliore l’eredità del Free cinema: John Schleisinger e Ken Loach.
JOHN CASSAVETES: VITA E OPERE DI UN “GENIO” DELL’IMMAGINE CINEMATOGRAFICA di Giorgio Sabbatini
John Cassavetes è sicuramente un Regista innovatore, ricco di spunti creativi e, soprattutto, il protagonista principale della nascita del Cinema Indipendente americano. Sempre in contrasto con le dure regole produttive hollywoodiane è stato un grande sperimentatore dando la massima importanza ai rapporti con gli Attori che ha sempre considerato “linfa vitale” per la realizzazione di un buon film.
Questo articolo, che tenta di raccontare la vita del grande Regista e le difficoltà incontrate per affermare il proprio Cinema, si ispira al noto libro “JOHN CASSAVETES UN’AUTOBIOGRAFIA POSTUMA” di Ray Carney (edizione: minimum fax) che, oltre ad essere un critico cinematografico, è il massimo studioso dell’opera di Cassavetes.
Ho sempre amato il lavoro e lo studio delle immagini di questo grande Regista per la sua continua ricerca di uno stile semplice e puro, dove l’improvvisazione è fonte di libertà espressiva, in sintonia con la realtà che ci circonda e lontano dagli artifici degli Studios.
SAGGI
CINEMA E SESSANTOTTO: BELLOCCHIO, BERTOLUCCI E GLI ALTRI di Roberto Lasagna
Il Sessantotto è stato per il cinema un momento di grande intensità espressiva, con i giovani in grado di sentirsi rispecchiati nella vicenda di cui erano improvvisamente i protagonisti e le contraddizioni di un’epoca finalmente portate in scena grazie all’onda lunga di una rivoluzione estetica prima ancora che politica
QUESTA VOLTA PARLIAMO DI LINA di Francesco Saverio Marzaduri
Quarantatré anni dopo la “nomination” per “Pasqualino Settebellezze”, l’Oscar onorario conseguito a 92 anni è occasione per ripensare alla produzione di un’autrice discontinua, la cui carenza di misura e gusto, perlopiù, ne ha sminuito talento e fantasia.
ADRIAN: IL TEMPO (NON) SE NE VA… di Francesco Saverio Marzaduri
Radiografia del più clamoroso flop televisivo dello scorso anno – una gigantesca “summa” del Celentano-pensiero – e occasione per riesaminare un personaggio il cui tempo, dopo oltre sessant’anni di poliedrica carriera, sembra essersi fermato.
“CARO DOMANI” di Roberto Baldassarre
Il giorno successivo la conferenza stampa per la presentazione della soap opera Caro domani, i giornali hanno messo facilmente in rilievo, con un pizzico di perfidia, lo smaccato familismo che vi gravita intorno. Giusto per riportare il “gossip”: “Caro domani” nasceva da un’idea di Tommaso Avati (figlio di Pupi); era diretta da Mariantonia Avati (figlia di Pupi); venne prodotta dalla Duea di Antonio e Pupi Avati (fratelli); e fu accolta ben volentieri nel palinsesto di Sat2000 da Pupi Avati, che a quel tempo era il Direttore artistico del canale creato dalla CEI. È palese il conflitto d’interesse che c’è stato, ma tutto questo familismo è di poco interesse a distanza di vent’anni, mentre è più utile, ripescando dal passato questo prodotto televisivo, analizzare alcuni aspetti che si possono desumere da esso, che sebbene sia una soap quasi dimenticata, diviene un vivido documento di un’epoca televisiva italiana di fine Novecento. Prima di tutto perché è stata una delle prime “sperimentazioni” produttive di soap opera all’italiana; in secondo luogo per come “Caro domani” si inserisce nell’opera di Pupi Avati, in questo caso in veste solo di produttore; infine, il profilo del canale televisivo che la programmava, che sin dalla sua nascita si era proposto un determinato modo di concepire il palinsesto televisivo. Senza dimenticare la descrizione di Caro domani, con dati e trama, e un breve profilo di Mariantonia Avati.
UN PALCO AL CINEMA. IL FILM D’OPERA ITALIANO NEGLI ANNI TRENTA-CINQUANTA DEL NOVECENTO – Seconda parte – di Mario Giunco
Seconda, ed ultima parte, del ricordo di Mario Giunco sul Film d’Opera iniziato nel numero 22. Un Saggio in cui ripercorre registi e relativi film dedicati all’argomento, che è di utile promemoria per quanti amano il cinema.
GUSTAVO LOMBARDO, IL “TORINESE” DEL CINEMA ITALIANO di Mario Galeotti
Napoli ha avuto un ruolo importantissimo nella nascita dell’industria cinematografica in Italia, basti ricordare alcune figure di napoletani nella fase pionieristica del cinema italiano: gli esercenti Mario Recanati e Menotti Cattaneo, l’impresa dei fratelli Troncone, la prima regista donna Elvira Coda Notari. Napoli è stata anche la città che per prima ha dato maggiore impulso al commercio di film nei primi anni del Novecento, con meccanismi assai diversi da quelli che comunemente associamo all’odierna distribuzione. E proprio in questo settore, prima ancora di diventare un produttore di successo e il fondatore della gloriosa Titanus, si è distinto il napoletano Gustavo Lombardo. Ugo Gregoretti lo ha definito “il torinese del cinema napoletano”.
“MISSION TO MARS” DI BRIAN DE PALMA (USA – 2020) – LA VITA SOGNATA NEL VUOTO di Danilo Amione
Il cinema è forse una delle forme della (fanta)scienza. Per questo un film di fantascienza è un film per eccellenza, intendendo per “film” tutto ciò che, dal linguaggio al contenuto, ci dà la possibilità di accedere ad una verità. Come per Kubrick e Tarkovski, anche per De Palma approcciarsi per la prima volta alla fantascienza ha significato approfondire, in forme diverse, il discorso sull’essenza stessa dell’Uomo, che egli ha sempre affrontato attraverso i tanti generi cui si è accostato.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
PRESENZA FEDIC ALLA MOSTRA DI VENEZIA di Paolo Micalizzi
Un resoconto sulla presenza Fedic all’annuale appuntamento con Forum e Premio alla prestigiosa Mostra di Venezia, un appuntamento che coinvolge sempre di più i Soci della Federazione Italiana dei Cineclub che sono accorsi numerosi anche nel 2020 malgrado il Coronavirus.
17° SEDICICORTO FORLÌ – FORMULA IBRIDA VINCENTE di Gianluca Castellini
L’intenso programma della diciassettesima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival svoltosi con successo malgrado le forti restrizioni dovute al Covid-19. Concorsi e nuove iniziative come il “Cinebook” e le Mostre virtuali di pittura realizzate come se fossero dei cortometraggi, premi alla carriera e a nuovi autori di Cortoinloco. Ed altro ancora che è possibile leggere in questo resoconto del Direttore Artistico Gianluca Castellini.
PER STARE INSIEME IN TEMPO DI COVOD di Roberto Merlino
Il Cineclub Corte Tripoli Cinematografica non si è arreso al Covid-19 e durante la pandemia e si è inventato un gioco da portare avanti quotidianamente con Internet. Ne parla in questo articolo Roberto Merlino.
ITALIA FILM FEDIC di Paolo Micalizzi
Resoconto sul 70. Italia Film Fedic con cui la Federazione Italiana dei Cineclub è ritornata a gestire direttamente, con il coinvolgimento di tutti i Cineclub associati, il suo Festival storico che dal 1950 ha luogo nella città Termale di Montecatini Terme. Ed è stato un successo come da testimonianza anche del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura nonché dei numerosi soci Fedic presenti alcuni dei quali lo hanno frequentato, a partire dagli anni Sessanta e ne hanno salutato con entusiasmo il ritorno ad *un Festival di qualità.
FESTIVAL ED EVENTI
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
VENEZIA 77: LA MOSTRA DEL CORAGGIO di Paolo Micalizzi
Premi e film della Mostra del coraggio, non solo quelli di “Venezia 77” ma anche delle Sezioni autonome della Sic e delle Giornate degli Autori e dei Premi collaterali. Una Mostra sulle “Divine del Cinema” ed iniziative culturali come il Premio Bresson dell’Ente dello Spettacolo. Ma anche alcuni film sul mondo del lavoro.
APPUNTI DI UN SOCIO FEDIC, GIORNO PER GIORNO di Luciano Volpi
La Mostra, giorno per giorno, secondo le impressioni e i giudizi di un cinefilo Fedic, che da alcuni anni la segue con molta attenzione.
IL CINEMA, ANCHE QUELLO DEL PASSATO, VINCE IL CORONA VIRUS di Vittorio Boarini
La imperdibile sezione VENEZIA CLASSICI della Biennale cinema si è svolta nell’anno della pandemia a Bologna, ospitata dal Cinema Ritrovato. Così i film restaurati, scelti dalla 77. edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, li abbiamo potuti ammirare nell’appassionante confronto con i tanti RITROVATI E RESTAURATI della 34. edizione del festival bolognese.
Abbiamo in tal modo avuto un ampio contesto entro cui valutare criticamente i diciotto film di Venezia, i quali spaziavano dalla cinematografia americana, presente con ben quattro film, fra i quali uno del maestro anche di restauro Scorsese, a quella del Mali, con una sola pellicola, ma di grande rilievo nell’ottica della riscoperta del passato. Non è mancato il Giappone, due opere rare e molto significative, né la vecchia Unione Sovietica, un film di Michalkov da rivedere assolutamente. Poi l’Ungheria. la Francia e Cuba, quest’ultima con un film fra i meno conosciuti del grande Alea. Non è mancata, ovviamente, l’Italia, con il primo lungometraggio di Antonioni e il secondo film della famosa trilogia girata da Pietro Germi.
Complessivamente un panorama straordinario, un pezzo di storia del cinema, grazie anche ai restauri, mediamente di livello alto, che ci hanno restituito importanti opere del patrimonio mondiale.
PESARO 56 di Paolo Vecchi
La 56a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, pur nelle limitazioni imposte dalla pandemìa, ha saputo offrire un programma di tutto rispetto. Nell’ambito del concorso, la giuria ha attribuito il premio Lino Miccichè a “A metamorfose dos pàssaros”, opera prima della portoghese Catarina Vasconcelos. L’applausometro della sezione “Cinema in piazza” ha scelto “Il caso Braibanti” di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese. L’evento speciale era dedicato allo splendido novantenne Giuliano Montaldo. Per l’occasione è uscito un corposo volume edito da Marsilio, “Giuliano Montaldo: una storia italiana”, a cura di Pedro Armocida e Caterina Taricano, e sono stati proiettati sei film del regista genovese, tra i quali la copia restaurata della sua pellicola di esordio, “Tiro al piccione”, che a suo tempo fece discutere ma oggi ci appare come un classico.
IL GEORGIANO “BEGINNING” E’ STATO IL GRANDE TRIONFATORE DELLA 68° EDIZIONE DEL SAN SEBASTIAN FILM FESTIVAL di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
Un Festival, giunto alla 68.ma edizione, inaugurato con il nuovo film di Woody Allen “Rifkin’s Festival”, presentato fuori concorso e vinto da Viggo Mortensen con “Falling”. Tutti gli altri premi.
“LUNANA: UNO YAK IN CLASSE” VINCE LA 26° EDIZIONE DEL FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
Premi e film dell’unico Festival Internazionale italiano dedicato alla produzione di materiale multimediale riguardante la vita e la storia delle popolazioni montane. E’ alla sua ventiseiesima edizione.
OCCHIO CRITICO
CINEMA E STORIE VERE di Marco Incerti Zambelli
Due diversi film prendono spunto da due diverse storie reali, ‘una piccola storia ignobile’ di Roubaix, provincia francese e lo storico processo ai 7 di Chicago in seguito alla rivolta che accompagnò la convenzione democratica del 1968. Con stile, modalità, obiettivi differenti le due opere ci rassicurano sulla capacità del cinema di continuare a essere lo straordinario dispositivo narrativo capace affrontare la realtà e raccontarla con impegno e poesia.
RISCOPERTE PREZIOSE di Francesco Saverio Marzaduri
Riscoperta di due grandi titoli, diversi per genere e forma: uno è il secondo lungometraggio della compianta Agnès Varda, pioniera della Nouvelle Vague, e l’altro una macabra farsa, di perfido umorismo nero, firmata Douglas Hickox.
“VOLEVO NASCONDERMI” DI GIORGIO DIRITTI di Tullio Masoni
Un nuovo, impegnato approccio cinematografico alla figura di Antonio Ligabue, pittore nella marginalità poi consacrato dalla critica più autorevole. Un mondo piccolo diventato grande, un’arte misteriosa e inconsapevolmente ascetica. Una vita che ha sfidato il costume. le cronache dell’Italia del boom economico, la cultura sua contemporanea e del dopo.
DUE NON FICTION: “PAOLO CONTE – VIA CON ME” DI GIORGIO VERDELLI E“GENESIS 2.0” DI CHRISTIAN FREI E MAXIM ARBUGAEV di Paolo Vecchi
Paolo Conte parla di sé con precisione, disincanto e una neppure tanto sottesa malinconia: parla di canzoni ma anche di enigmistica e di grafica, discipline che conosce piuttosto bene e continua a praticare assieme alla musica e alla poesia ad essa strumentale, nonostante abbia girato proprio quest’anno la boa degli ottanta, puntando forse a continuare per un altro decennio.
La ricerca di zanne di mammut da vendere ai mercanti cinesi nelle isole della Nuova Siberia di pari passo con quella, con finalità scientifiche, dei loro corpi il più possibile integri. Ad essa si alternano immagini rubate all’iGEM di Boston e alla Harvard Medical School, dove gli studi sulla clonazione puntano a ridare vita ad animali estinti, oltreché alla coreana Sooam Biotech, dove pagando potete ricreare copia conforme del vostro defunto cane da compagnia.
QUALITÀ IN SERIE
LA BANDA
IL PROGETTO di Luca Serasini e Nico Malvaldi
I pensieri e le sensazioni degli autori e di alcuni non-attori di una commedia simpatica e in qualche modo anche di spessore.
Partendo da un progetto artistico bensì che cinematografico, “La Banda” è stata realizzata al contrario: gli sceneggiatori hanno scritto la storia su misura dei personaggi che si sono offerti a partecipare al progetto, piuttosto che cercare gli attori per la loro storia.
L’ANALISI CRITICA di Marcello Cella
Una web serie di Luca Serasini e Nico Malvaldi, prodotta dall’Associazione Culturale “Cantiere Nuovo” di Marina di Pisa, con l’assistenza tecnica di un’altra associazione culturale pisana, “Corte Tripoli Cinematografica” di Roberto Merlino, aderente alla Fedic, racconta in maniera ironica il modo per opporsi alle diseguaglianze determinate da una certa idea totalizzante di globalizzazione economica. In sette puntate e con l’aiuto di un’intera comunità.
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
Segnalazione-recensione dei seguenti libri:
FELLINI 23 ½. TUTTI I FILM di Aldo Tassone; IL VERO FELLINI. UNA VITA PER IL CINEMA di Virgilio Fantuzzi;
LE MUSE AL CINEMA di Gian Piero Brunetta; IL MIO CINEMA di Claudio G. Fava; LUIGI ZAMPA, a cura di Orio Caldiron e Paolo Speranza; PENSARE MONDI TRA REALTA’ E IMMAGINAZIONE, VIAGGI LETTERARI IN ITALIA E NELLE CULTURE DEL MEDITERRANEO di Rita Castaldi, a cura di Maurizio Villani.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
IL FREE CINEMA INGLESE
di Marino Demata
Breve introduzione
Truffaut era solito ripetere una battuta, dopo averla sentita da Hitchcock nel corso della sua intervista al grande maestro americano: “ci si può chiedere se non ci sia incompatibilità tra la parola cinema e la parola Inghilterra”, se Insomma, cinema e Inghilterra non stanno bene insieme. Questa battuta giovanile del grande maestro della Nouvelle Vague non va, ovviamente, presa alla lettera. Ma con ogni probabilità voleva manifestare, già nel pensiero di Hitchcock, le difficoltà che il cinema inglese ha trovato in passato a discostarsi da vecchie regole non scritte, da certi schemi e certi modi di fare cinema. Insomma, era come chiedersi appunto se esistesse un vero e proprio cinema inglese o se esso non fosse solo la succursale del cinema di Hollywood. Questo forse è un po’ troppo perché sono tanti, comunque, i capolavori usciti dagli studios inglesi. Ma, probabilmente, non era questo in discussione. Quello che era in discussione è la mancanza di capacità e di voglia di discostarsi dalle tradizioni e da certe tipologie di storie, che avevano come protagonisti, quasi sempre, personaggi delle classi più altolocate. Non a caso, proprio per opporsi a questa tipologia di personaggi e di storie, uno dei modi con il quale viene battezzato il nuovo movimento che ufficialmente si presenta il 5 febbraio del 1956 a National Film Theatre di Londra, è working class realism. Quasi a voler dire: basta con i drammoni degli aristocratici, esiste anche la classe operaia e gli emarginati, che sono la maggioranza della popolazione. Dunque, bisogna cambiare registro.
Un pugno di giovani registi diede vita ad un movimento di rinnovamento del cinema britannico, che si espresse in una sorta di convenzione andata in scena, con grande emozione dei partecipanti e del pubblico, il 5 febbraio del ’56. Essa comprendeva tre film di media lunghezza (oggi diremmo tre mediometraggi). Il primo era un documentario firmato da una coppia di registi che presto diverranno tra i più importanti del movimento e del cinema inglese in generale: Karol Reisz e Tony Richardson, dal titolo “Momma don’t allow”, su un Jazz club situato al nord di Londra. Il secondo, “O Dreamland”, firnato da Lindsay Anderson, su un parco dei divertimenti situato in un resort sul mare in Margate. Il terzo era un film di fiction di 50 minuti firmato da una giovane regista italiana, Lorenza Mazzetti, “Together”, basato su una storia di Carson McCullers.
L’italiana che inventò il Free cinema inglese
Non ci sembrava possibile trovare un titolo migliore per introdurre l’incredibile storia di Lorenza Mazzetti, che prendere a prestito il titolo di un piccolo grande libro di Giorgio Betti, che, tra i tanti pregi, vanta anche una breve ma assai significativa prefazione di Alberto Crespi.
Dopo un’infanzia molto travagliata, che include la morte della madre nel dare alla luce lei e la sua gemella Paola, la piccola Lorenza vive una tragedia che le resterà sempre impressa nel suo animo. La tragedia si consuma nella sua nuova famiglia adottiva, a Rignano, vicino Firenze, a casa della zia Mina sposata col cugino di Albert Einstein, Robert Einstein. Questo, per il cognome che porta, ha su di sé una sorta di condanna a morte: siamo nel 1944, quasi alla fine del periodo dell’occupazione tedesca in Toscana. Amici e parenti sanno che Robert Einstein è segnato e lo convincono a rifugiarsi lontano dalla propria villa e ad unirsi ai partigiani. I tedeschi arriveranno e uccideranno zia Mina e le due figlie, risparmiando però Lorenza e la sorella perché non portavano quel fatidico e, per i tedeschi, odiato cognome. Conosciamo tutti i particolari di questa storia che culmina col suicidio di Robert Einstein proprio dal racconto che ne fa Lorenza nel suo romanzo “Il cielo cade”.
Terminati gli studi anche grazie ai fondi lasciati in eredità dagli Einstein e curati da un tutore, Lorenza, alla metà degli anni ’50, decide di andare in Inghilterra con un gruppo di amici a raccogliere patate. L’impresa sarà un fallimento. Le patate non sono precisamente la sua vocazione. Decide di andare a Londra in autostop e lì si innamora delle opere di Francis Bacon esposte in una mostra e decide di iscriversi nella famosa Slade School of Fine Arts. E lì viene affascinata da un cineclub, che le fa comprendere quali miracoli possono compiersi con una cinepresa in mano. Ad esempio, realizzare la messa in scena de Le metamorfosi di Kafka, un libro da lei sempre amato. Il personaggio principale, Gregor Samsa viene affidato ad un su amico Michael Andrews, che accetta di buon grado la parte. Dopo essersi procurata con rocambolesche avventure e furti di materiale, quanto serviva per girare, Lorenza, finalmente, finisce di montare il film al quale darà il titolo di “K”. Un film girato senza alcun patrimonio di nozioni cinematografiche, ma seguendo solo la propria ispirazione. Non è un prodotto che preannunci in qualche modo il Free Cinema, perché è prevalente l’assunto psicologico della storia, data anche la sua fonte; mentre, come vedremo, nelle storie del Free Cinema saranno prevalenti gli eventi esterni, dei quali le riflessioni interiori ed esistenziali sono una conseguenza e quasi mai il prius.
Per una serie di circostanze rocambolesche che il lettore di queste note potrà trovare nella gradevolissima lettura del libro che dà il titolo a questo paragrafo, la nostra piccola eroina, dopo aver assaporato la gioia della trasposizione cinematografica da Kafka, suo mostro sacro letterario, si ritrova finalmente alle prese con una storia tutta sua: il film si chiamerà “Together”, ed è una sorta de “I ragazzi della via Pal”, con l’aggiunta però di due protagonisti sordomuti e appartenenti, con tutte le difficoltà che la menomazione comporta, a quella working class alla quale il cinema britannico non si era quasi mai rivolto. Nel frattempo, Lorenza era riuscita anche ad entrare nelle grazie del British Film Institute, che, consapevole delle difficoltà della giovane regista, le procura l’aiuto di un personaggio “chiave” per lei e poi, di lì a poco, per l’intero movimento innovativo che nascerà. Parliamo di Lindsay Anderson, che a quell’epoca non ha ancora girato un film di finzione, ma è stato capace di vincere un Oscar al miglior documentario con “Thursday Children”, ed ha inoltre partecipato ad una rivista di critica cinematografica, Sequence, molto seguita dagli amanti del cinema. Sequence chiuse i suoi battenti nel 1952, ma Anderson continuò a scrivere articoli di cinema sulla rivista Sight & Sound, proprio del British Film Institute, nelle cui grazie era entrata Lorenza. Le strade degli “innovatori” cominciano ad incrociarsi!
In “Together” manca sicuramente un piglio politico consapevole, che poteva venire solo dalla rabbia accumulata dai cineasti inglesi aspiranti al nuovo e al diverso. Una rabbia che Lorenza Mazzetti non aveva ancora potuto assimilare e consapevolizzare. Eppure, nel film sono presenti almeno due elementi che fanno gridare al miracolo non solo Lindsay Anderson, ma anche altri due suoi amici registi, Karel Reisz e Tony Richardson. Ci riferiamo al fatto che Together è ambientato in una realtà operaia e i personaggi sono membri della working class, e, in secondo luogo, con i due sordomuti come protagonisti, il film apre al mondo dei diversi. Un mondo quasi ignoto al cinema inglese classico. Come vedremo avanti, quello della diversità sarà un tema molto caro al Free cinema, che si spingerà fino a smantellare vari tabù del cinema inglese, come quello della omosessualità e quello della presenza in Inghilterra di tanti gruppi etnici, con le loro culture e costumi che permangono vivi, malgrado si innestino nel corpo di una robusta tradizione British.
Dunque la nostra eroina aveva formato, con i tre registi, Anderson, Reisz e Richardson, un quartetto inscindibile di amici, che costituiranno l’ossatura teorica e pratica del nuovo movimento. Tra i quattro, Lorenza era la più stimata ed osannata. “Together”, per gli altri tre, costituiva, come abbiamo detto, un vero miracolo: una sorta di esplicitazione di tutte le aspirazioni consapevoli o inconsapevoli portare avanti dai tre registi. In più “Together” era il primo film di finzione del nascente movimento, visto che Anderson e gli altri due amici si erano fermati al documentario, sia pure in forme estremamente apprezzabili per i fini che si ponevano. Questo ragionamento ed una sorta di leadership conferita tacitamente a Lorenza e al suo “Together” spiegano e rendono plausibile il titolo del piccolo libro al quale ci siamo riferiti, “L’italiana che inventò il Free cinema inglese”.
Appuntamenti al NFT
Dunque l’appuntamento è fissato per il 5 febbraio 1956 al National Film Theatre in Londra. Il programma prevede la proiezione di un documentario di Reisz e di Richardson, quello di Anderson e del mediometraggio di Lorenza Mazzetti, “Together”. Giorni prima della fatidica data, i quattro discussero a lungo su come promuovere l’evento, se con semplicità, o con un vero e proprio manifesto di intenti che spiegasse il significato di quell’incontro e i propositi immediati e futuri. Fu Anderson, il più intellettuale e, in certo senso, il teorico del gruppo, a far prevalere la tesi di un vero e proprio, sia pur succinto, manifesto.
Senza tanti preamboli, il breve manifesto va subito al dunque, Viene infatti chiarito in esso che i film che vengono presentati non sono stati realizzati insieme, né con l‘idea che dovessero essere poi rappresentati insieme. Eppure, questi film, così dissimili, hanno un atteggiamento (“attitude”) in comune.
“Implicito in tale atteggiamento, è il credere nella libertà, nell’importanza del popolo e nel significato della vita di ogni giorno.
Un film non deve essere troppo personale.
L’immagine parla.
Il suono amplifica e commenta.
La dimensione è irrilevante.
La perfezione non è nei nostri propositi.”
Sono parole molto significative, Più esplicito ancora è il prologo del Manifesto, nel quale si afferma che “gli autori offrono queste loro opere come una sfida all’ortodossia”.
Dunque la sfida era lanciata. Se ci soffermiamo un attimo su alcuni passaggi più significativi del manifesto, rileviamo innanzitutto un aspetto spiccatamente politico, dove esso sottolinea i principi della libertà, dell’importanza del popolo e della vita quotidiana. Di queste grandi tematiche, dunque, il movimento deve occuparsi attraverso un nuovo tipo di cinema che parli del quotidiano, dei problemi di tutti i giorni, che affliggono la stragrande maggioranza della popolazione.
L’affermazione che il film non deve essere troppo personale sembra voler rimarcare l’importanza di un cinema dove le storie vanno avanti attraverso i fatti, gli accadimenti oggettivi, dove la riflessione soggettiva e personale su di essi sembra trovare uno spazio meno rilevante.
Nel complesso il manifesto è una dichiarazione di guerra all’ortodossia del vecchio cinema inglese tradizionale, che aveva come grandi assenti il popolo, la working class, i diversi, le donne, considerate solo come mogli o madri e quindi esclusivamente in funzione dei mariti o dei figli.
Il vero autore del manifesto è, senza alcun dubbio, l’intellettuale del quartetto, Lindsay Anderson. È a lui che viene in mente l’espressione “Free cinema”, che è in realtà un’espressione utilizzata in un articolo pubblicato cinque anni prima sulla sua rivista Sequence, a firma di Alan Cooke, che si riferiva ai nuovi movimenti di avanguardia cinematografica in America.
Il volantino viene distribuito in sala prima della proiezione dei film. L’evento è un grande successo, di cui parlerà tutta la stampa il giorno dopo. E non c’è dubbio che l’elemento trainante della serata è costituito dalla proiezione di “Together”.
Non a caso è proprio il film della Lorenza Mazzetti a rappresentare l’Inghilterra al Festival di Cannes. Lì Lorenza si ritrova con l’inseparabile Anderson, presente in qualità di critico della rivista Sight & Sound
Anche a Cannes è un successo e “Together” viene premiato come Migliore opera di avanguardia e l’Autrice sembra all’apice della felicità. Le recensioni del film sono unanimemente positive se non, in molti casi, eccellenti, sia in Francia che in Italia e in Inghilterra.Eppure, purtroppo, fu un successo senza un gran seguito. Perché, evidentemente, Lorenza era fatta così. Improvvise infatuazioni, colpi di fulmine, che poi svaniscono. La sua vita è cadenzata da questi episodi. E “Together” non sarà l’inizio di una brillante filmografia, ma uno dei tanti episodi della sua vita ricca di fatti e personaggi significativi. Dopo Cannes, Lorenza impiegherà 40 anni per rivedere Londra. Ritorna in Italia, a Firenze, per rivedere la sorella e poi si stabilisce a Roma, in una bella casa che sarà meta di incontri e di serate piene di intellettuali, di gente di cinema e di scrittori. Zavattini amava moltissimo “Together” e la sua regista, per la quale organizza una proiezione con la presenza di De Sica, Pasolini e Bertolucci che danno tutti un giudizio entusiasta dell’opera.
E sempre Zavattini vuole che venga affidato alla Mazzetti un episodio del film “Le Italiane e l’amore”. Siamo nel 1963 ed è il periodo nel quale sono di moda i film ad episodi diretti da vari registi. Alla Mazzetti viene affidato l’episodio “I bambini-L’educazione sessuale dei figli”, che rappresenta uno degli episodi più provocatori dell’intero film.
Ma la carriera cinematografica così folgorante della Mazzetti finisce qui. Si dedicherà alla scrittura di un libro autobiografico, alla sua nuova famiglia, ai suoi amici del mondo del cinema dei quali amava circondarsi e finalmente alla seria attenzione e cura dei traumi patiti nella sua tremenda infanzia.
Ci sono due diverse accezioni del termine “Free cinema”, che vanno tenute presenti per non crear confusioni. Per molti critici, anche inglesi, il termine “Free cinema” è ascrivibile alle sole manifestazioni che si tennero al National Film Theatre in Londra. Tutto quello che accade dopo il periodo di quegli eventi viene già considerato fuori dal Free Cinema. In questa accezione, l’espressione Free Cinema stava a significare l’ufficialità di quei sei appuntamenti. L’accezione invece più ampia e, secondo noi più corretta, è quella che connota, con tale espressione un vasto movimento che prende inizio dai sei appuntamenti al FTL, e che comprende tutto il lavorio teorico preparatorio, ma che poi ebbe modo di sprigionarsi nelle forme più ampie, attraverso le opere di numerosi registi che, consapevolmente o inconsapevolmente si richiamavano ai concetti emersi nelle sei manifestazioni citate, che si svolsero dal 1956 al 1959. Insomma, anche se il Free cinema finisce ufficialmente con l’ultimo appuntamento al FTL, esso continuerà a vivere sotto altre forme, all’interno di altri movimenti e col lavoro dei singoli registi. Vedremo più avanti che sarà il critico italiano Mino Argentieri ad offrire una sistemazione logica e cronologica al movimento.
D’altra parte almeno tre delle sei iniziative ebbero un carattere internazionale e vi furono invitati registi che già nei propri Paesi, avevano mostrato tendenze verso l’innovazione. Ad una di esse fu invitato Truffaut, che portò il suo unico film corto,”Les Mistons”; vi partecipò anche un film studentesco di Roman Polanski dal titolo “Two men and a Wardrobe”, e inoltre autori dalla Svizzera (Claude Goretta) e dall’Ungheria (Robert Vas). L’ambizione era insomma quella di fare degli appuntamenti al National Film Theatre una sorta di Festival internazionali del film innovativo. E anche in questo caso si manifestavano quelle “attitudes in common” di cui esplicitamente parla il manifesto del primo degli incontri.
L’idea di una rassegna del cinema innovativo, lanciata di fatto a Londra con l’arrivo di registi di altre realtà europee, fu ripresa anche altrove. In Italia nasce, nel 1960, il Festival del cinema libero, con lo scopo di mostrare lavori nuovi ed indipendenti provenienti da ogni parte del mondo. Il Festival trovò sede in Porretta Terme ed ebbe grande fortuna grazie all’appoggio di grandi nomi del cinema italiano, da Zavattini, sempre attento alle novità ovunque si manifestassero, ad Antonioni, Blasetti, De Sica, Fellini, Lizzani, Pratolini, Ungaretti, Visconti e moltissimi altri. Il Festival si pose in antagonismo col Festival di Venezia, al quale rimproverava una ufficialità che aveva sapore di regime, soprattutto nella scelta dei premiati e nelle scelte dei “patriocini”. E, in linea con i tempi della contestazione, questo Festival criticava anche il carattere selettivo e competitivo di Venezia, assumendo presto la bandiera della eliminazione dei premi e della propria trasformazione da Festival a premi in rassegna del meglio del cinema internazionale. La fortuna di Porretta Terme durò per dodici edizioni, ma fu poi incorporata nella annuale manifestazione di Bologna, che sarà chiamata Festival del cinema ritrovato, nel cui titolo troverà spazio anche la meritoria attività di restauro delle vecchie pellicole.
Intanto in Inghilterra, dopo la sesta edizione della “convention” del cinema innovativo, ciascuno dei registi più attivi, Anderson, Richardson e Reisz, prese la propria strada, pur mantenendo quelle famose “attitudes in common”. Essi saranno presto affiancati da altri filmmakers come Schleisinger, Ken Loach e poi autori che, magari con minore “attitude in common”, riusciranno a portare una ventata di novità e di unicità come il transfuga americano Joseph Losey.
Ma è tempo di guardare da vicino alcune opere che sono, in certo senso, esemplari a comento e illustrazione di quanto è stato generato dal Free Cinema .
Tony Richardson
Una delle più interessanti novità del Free Cinema fu il sodalizio, che gradatamente andò realizzandosi, tra i nuovi giovani cineasti e gli scrittori “arrabbiati”. Questi ultimi erano capaci di “sfornare” idee, soggetti e poi sceneggiature, che costituirono ben presto la materia che volentieri presteranno ai registi per i loro film innovativi. Infatti “questa nascita, ancora incerta e fragile, del Free Cinema coincise con l’affermazione, nel campo della letteratura e del teatro, di una nuova generazione di scrittori e drammaturghi, i cosiddetti young angry men … che vollero abbattere criticamente i vecchi miti, proporre un nuovo rapporto con la contemporaneità, magari soltanto nella sfera della rabbia, dell’invettiva, della contestazione verbale.” (2)
Il primo nome che viene in mente è quello di John Osborne, uno scrittore a cui il cinema di questo periodo deve moltissimo. Al suo nome è legato quello di Tony Richardson, non solo perché alla fine tradusse alcune sue opere in film tipicamente free, ma anche perché, inizialmente, si creò un felice collegamento tra i due e George Devine, finalizzato a creare una vera e propria compagnia teatrale di avanguardia, la English Stage Company, di cui primo travolgente successo fu “Look back in anger” (in italiano “I giovani arrabbiati”)), rappresentato al Royal Court Theatre in Londra, con recensioni molto positive.
Dopo mesi di impegno per mantenere il carattere libero del nuovo cinema, e preservarlo da interferenze di produttori e distributori tradizionali, Tony Richardson si collegò al giovane produttore Harry Saltzman per creare una società chiamata Woodfall Films. L’obiettivo di fondo è che il regista abbia la completa libertà creativa e realizzativa del film. L’obiettivo immediato è la trasposizione cinematografica del lavoro di Osborne “I giovani arrabbiati””. Per il ruolo di protagonista viene scelto il già molto noto Richard Burton.
Ci volevano , secondo Richardson, film che avessero come “personaggio” principale un’entità astratta e concreta insieme: la rabbia. Era infatti arrivato il momento – diceva – di passare dalle tante parole e dai tanti manifesti alle storie concrete da portare sullo schermo, nelle quali prendessero finalmente vita quei principi per i quali lui, assieme ai suoi compagni di cordata (Andesrson, Reisz, e poi Schlesinger e via via tutti gli altri) si erano battuti: passare insomma dal piano delle affermazioni teoretiche a quello della loro visibilità sullo schermo.
L’indipendenza ottenuta da Richardson da ogni interferenza produttiva, grazie agli accordi con Saltzman, furono un suo grandissimo successo, capace di far sentire lui, il regista, veramente free, cioè libero e indipendente da tutti, unico creatore della propria opera. Un grandissimo punto a favore di imprescindibile portata. Richardson si sentì in tal modo alla pari con gli Autori della Nouvelle Vague, che in gran parte questo risultato avevano già ottenuto. Ma per l’Inghilterra fu qualcosa di nuovo e di straordinario: ridisegnare la figura del produttore e del regista, codificare la reciproca indipendenza e soprattutto la libertà e responsabilità creatrice di quest’ultimo.
E, anche se dopo i primi due film “arrabbiati”, il sodalizio tra Saltzman e Richardson si interruppe, quest’ultimo non rinuncerà mai a porre, come clausola base per qualsiasi accordo commerciale, il principio della assoluta indipendenza del regista.
I primi film, tratti da altrettante plays di Osborne ebbero un successo dirompente. Proprio quello che ci voleva in quel momento per tradurre i principi più estremi del free cinema in storie, nelle quali i ragazzi, gli operai delle fabbriche, gli intellettuali, gli insoddisfatti, si riconoscessero pienamente. Tuttavia, le prime opere di Richardson costituiscono ancora un necessario folgorante cinema di protesta, un autentico working class cinema. Ma non siamo ancora al capolavoro. Dopo aver, in certo senso, sfogato la sua rabbia con l’aiuto di Osborne, Richardson aveva bisogno di una storia che mostrasse in filigrana tutti i principi del free cinema, ma con spirito maggiormente meditativo: non solo rabbia, ma riflessione, ragionamento, sentimenti, malinconia anche se lontana dalla rassegnazione. A questo punto Richardson prese tra le mani il testo teatrale di “A taste of honey” (“Sapore di miele”) di un’Autrice di teatro, Shelagh Delaney, e ne fece un film indimenticabile, un capolavoro sul quale, più di ogni altro film di questo fantastico regista, conviene soffermarsi.

Il film è ambientato in un quartiere povero di Salford, esattamente dove l’Autrice, la Delaney, era cresciuta. Salford è una cittadina sul mare a pochi km ad ovest da Manchester. Jo (Rita Tushingham) vive in una povera casa con la madre, Helena (Dora Brian), molto più dedita all’alcool e agli uomini che non alla propria figlia. D’altra parte, Jo si rende presto conto che la madre ha trovato probabilmente, nel concedere il proprio corpo agli uomini della zona, o a quelli provenienti dal mare, l’unico possibile modo di sopravvivere in una realtà poverissima come quella nella quale si trovava. Ora la donna, Helena, si rende conto di essere sulla via del tramonto e quindi investe ogni sforzo nella ricerca dell’uomo giusto che possa fare compagnia a lei e a sua figlia per il resto della vita. Riuscirà a trovarlo, ma questi non sarà però disposto a fare casa con entrambe le donne: Jo dovrà cavarsela da sé.
Jo però incontra Tommy, un marinaio nero, col quale si intrattiene con sempre maggiore amore e trasporto. Ritiene di aver trovato l’amore della sua vita. Ma un giorno il marinaio va via per mare, e dopo poco, Jo scopre di essere rimasta incinta. Il mondo le crolla addosso. Si sente sola per le tristi strade di Salford. Ma una svolta della sua vita sarà la fortuita conoscenza di Geoff, un vagabondo omosessuale, che diventa prima il suo compagno di stanza, e poi il suo più grande amico, e il suo vero e proprio tramite col resto del mondo. Geoff si affeziona a Jo e promette di aiutarla in tutto quello che possa servire per farla stare meglio. Jo porterà avanti la sua gravidanza.
Se riflettiamo un attimo non possiamo non reputare fantastico, anche solo da questa sommaria descrizione della trama, la rivoluzione operata da “Sapore di miele” nell’universo cinematografico inglese. I motivi completamente innovativi sono numerosi e sono quelli fondamentali nella storia del film. Jo ha avuto una relazione con un marinaio nero, dal quale è rimasta incinta. L’unica persona che si impegna seriamente per aiutarla è un omosessuale. Già da queste due scarne affermazioni emerge che Richardson ha toccato le corde sensibili sventolate dai manifesti del Free cinema: l’ambiente operaio ghettizzante, le famiglie monoparentali, l’unione e la gravidanza al di fuori del matrimonio, il “diverso”, l’omosessuale vagabondo, che è l’unica persona dalla quale la protagonista riesce ad ottenere aiuto, considerazione, affetto. Ci sono in questo film mirabilmente condensate tutte le tematiche del Free cinema. E, in tutto questo, Richardson rifugge da un quadro totalmente buio. Al contrario, il film, nel suo finale offre una indicazione di speranza, di possibilità, di vita e non di morte, Tutto questo fa di “Taste of honey” un film che, assieme a pochi altri, si stacca nettamente dalla media dei film innovativi dell’epoca. Non a caso, uno storico inglese del cinema, Geoffrey Nowell-Smith afferma: “A taste of honey” è il film più “Free cinema” ed anche il più “new wave” (nel senso francese dell’espressione) tra tutti film realisti inglesi. È il film che ha il tocco più leggiero, il più vicino all’improvvisazione e il meglio radicato nell’ambiente scelto dagli Autori.” Tra l’altro, aggiunge, Shelagh Delaney, la scrittrice del libro, era giovane, dell’Inghilterra del Nord, appartenente alla working class e, per giunta, donna.”(3)
“The taste of honey” più ancora di essere una storia di working class, della quale forse l‘unico autentico rappresentate è l’uomo che la madre di Jo riesce a trovare, è storia di emarginati della società: emarginati in sé ed emarginati perché come tali sono sentiti e tenuti “ai margini” dal resto della società, che preferirebbe continuare ad ignorare, al cinema come nella realtà, i ceti più miserabili, oltre agli operai e ai diversi di ogni sorta.
E che dire, infine, della protagonista, Rita Tushingham? Anche lei rappresenta un elemento di rottura e di innovazione: col suo volto angoloso e decisamente bruttino (mai nel cinema classico una protagonista poteva essere meno che bellissima!) , diventa ben presto la vera musa del Free cinema, perché scelta decisamente per incarnare la quotidianeità femminile di quell’epoca coi i suoi problemi di tutti i giorni e con la decisa affermazione della identità della donna nel lavoro, nella famiglia e nella società nel suo complesso. Per “Sapore di miele” Rita Tushingham vinse a Cannes il premio quale migliore attrice.
Karel Reisz
Abbiamo visto come i personaggi di “A taste of honey” sono in realtà degli emarginati e che l’unico esempio di membro della working class è un personaggio, dopotutto, secondario, l’uomo trovato dalla madre di Jo. Al contrario, per il suo esordio al lungometraggio col film “Saturday night and Sunday morning” (“Sabato sera e domenica mattina”), Karel Reisz presenta la vita della working class così come tipicamente si svolge sul posto di lavoro e nella società.
Karel Reisz proviene dalla Cecoslovacchia e da una famiglia ebrea agiata. In Inghilterra si dedica a vari lavori, ma soprattutto al campo cinematografico, nel quale si appassiona in particolare all’arte del montaggio e scrive un ottimo trattato sull’argomento, che sarà punto di riferimento per molti autori innovativi, tra i quali Truffaut.
Il film è tratto dal romanzo di Alan Sillitoe, che sarà anche lo sceneggiatore dell’opera e, successivamente del film di Richardson “Gioventù, amore e rabbia”. In entrambi i film abbiamo una grande interpretazione del protagonista: Albert Finney nel film di Reisz e Tom Courtenay in quello di Richardson. Entrambi gli attori si sono formati ed hanno esordito nel clima del Free cinema, e ne hanno conservato, in molti aspetti della loro recitazione, i caratteri fondamentali.
L’interpretazione dell’operaio Arthur da parte di Albert Finney, che dal film di Reisz in poi si manterrà sempre su standard tali da meritare la qualifica di grandissimo attore, è veramente. per così dire, “da urlo”! Tanto da far dichiarare allo storico del cinema, l’inglese Geoffrey Nowell-Smith, che la sua “prodigious performance as Arthur made him A star overnight!”(4)
In un’intervista del 1982 Finney ricorda due aspetti particolari del film: innanzitutto di aver infranto uno storico tabù, le linee guida sul sesso nel cinema inglese; in secondo luogo di aver imparato ad usare un tornio per la prima volta proprio durante le riprese.
Sì, perché il film ci porta all’interno e all’esterno del luogo di lavoro della classe operaia: in questo caso una fabbrica di biciclette a Nottingham (siamo, come sempre al nord: altra costante del freecinema). La città è un labirinto quasi soffocante di case in mattoni che si somigliano tutte. Per la strada, nel corso del week end, sfrecciano motorini e biciclette, e i motivi di un juke box si sentono anche a qualche metro dal bar. Uno dei tanti operai di cui è piena la cittadina, inveisce innanzitutto contro la fabbrica, ma anche contro i padroni, la famiglia e il mondo intero. Una rabbia anarcoide si è impadronita di lui. Va a letto con la moglie di un compagno e la mette incinta. Ma va più volentieri dietro ad una ragazza con la quale si fidanza.
La classe operaia metalmeccanica viene in questo film presentata al di fuori di ogni schema prestabilito. Il merito di Reisz, che per qualche critico dell’epoca è invece un demerito, è quello di rifiutarsi di costruire un personaggio che possa rientrare in schemi prefabbricati, e che possa avere una coscienza d classe che in realtà non poteva avere. La coscienza di classe di Arthur comincia a farsi luce solo in modo primitivo e contraddittorio e con modalità anarcoidi. E questo modo di presentare il personaggio, lontano da schemi di comodo, fanno di Reisz un regista sincero, che dimostra di conoscere benissimo i problemi della classe operaia, le sue contraddizioni e la necessità di una crescita morale e politica che si intravede solo nella parte finale del film, allorché, ad esempio, Arthur, accettando di sposare la sua nuova fidanzata, fa una affermazione che sembra preconizzare un salto di qualità rispetto al suo atteggiamento anarcoide: “i sassi che d’ora in poi lancerò, non si limiteranno a sfasciare le vetrine di qualche esoso e antipatico negoziante”.
Soprattutto in Italia, una parte della critica più militante storse un po’ il naso di fronte a questo quadro un po’ compiaciuto e assolutorio dei modi anarcoidi della protesta che emerge da “Sabato sera e domenica mattina. Il film ebbe così, tra i suoi meriti, anche quello di suscitare un ampio dibattito. A prendere le difese del film di Reisz furono prevalentemente i critici francesi. Tra questi Morvan Lebesque , recensendo l’opera per L’Express si domanda: “Qual è l’immenso merito di questo film? Prima di tutto quello di presentarci degli operai che sono degli uomini con le loro passioni, le loro debolezze, i loro vizi, e non degli esseri a parte idealizzati per le loro condizioni… Qui nessun mito del proletariato… ”Sabato sera e domenica mattina” ci costringe a riflettere, a trovare la spiegazione in noi stessi. Questa impietosa tranche de vie ha sollevato parecchi strascichi in Inghilterra. Chi se ne stupirà? È un’opera autenticamente rivoluzionaria” (5)
In Italia sarà, col suo solito equilibrio, Mino Argentieri a mettere a tacere le critiche di coloro che volevano trovare in Arthur delle qualità, che in realtà non avrebbe potuto avere. “Si obietterà – dice Argentieri – che questo personaggio appartiene a una schiatta di ribelli senza precise prospettive e senza consapevolezza ideologica; e. se vi è del vero nell’osservazione, è altresì tanto certo che sarebbe un errore confondere la protesta di Arthur, venata di anarchismo, con un atteggiamento romantico (…)E’ in realtà un bel film, che contiene indubbiamente germi innovatori, vi si riconoscono i fermenti, nati all’insegna del free cinema”(6)
Anche le opere successive del regista confermarono i suo talento e la sua indubbia capacità di creare personaggi radicati nel proprio ambiente, nel bene e nel male, e visti nella loro complessità psicologica. E sarà attraverso questi personaggi, reali, così come provenienti da ambienti reali, che Reisz continuerà a portare avanti il suo discorso di opposizione al sistema politico e sociale del suo tempo. Anche se con venature che si faranno, col passare degli anni, più malinconiche e pessimistiche.
Lindsay Anderson
Anche Anderson compì, con un po’ di ritardo rispetto agli altri tre amici di cordata del Free cinema, il passaggio dal documentario al cinema di finzione. Per farlo, così come avevano fatto Tony Richardson e Karel Reisz, si collega ad uno scrittore a sua volta esordiente, come lo era lui nel lungometraggio: David Storey, autore di “This sporting life”. La storia si svolge, come sempre con gli autori del Free cinema, in una cittadina del nord dell’Inghilterra, dove il nord è simbolo dell’opposizione a Londra, sede dell’establishment in tutti i campi.
Il film si apre in maniera cruda e brutale: Frank Machin (Richard Harris), astro nascente della locale squadra di rugby è impegnato in un’azione di gioco che lo vede, come sempre, generosamente lottare in prima linea: ma, nel corso dell’azione, un avversario lo colpisce violentemente con la spalla sulla bocca rompendogli sei denti. Il film, dunque, inizia con una scena di violenza da parte dei giocatori delle due squadre, i quali, tutti, per inciso, si considerano dei privilegiati, perché il rugby consente loro di non scendere quotidianamente in miniera o di lavorare nelle fabbriche. La sequenza successiva vede Machin sulla sedia del dentista, mentre gli viene somministrato del gas anestetico per poter procedere all’estrazione dei denti. Nell’assenza di lucidità causata dall’anestetico, vengono alla mente di Machin scene del suo recente passato: la sua abilità nel conquistare il posto nella squadra locale, il suo impegno, con scarso successo, nel tentare di conquistare la proprietaria della camera nella quale vive, la signora Hammond (Rachel Roberts).
Dunque, registriamo un inizio di film scuramente non convenzionale, ma decisamente spiazzante per i numerosi flashback e per le scene di violenza. Ma la violenza nel giocare a rugby si ripeterà anche nel resto delle azioni quotidiane di Machin. Il suo vero problema è che lui considera l’intera vita come una partita di rugby, nella quale o si vince o si perde: non c’è via di mezzo.
C’è un po’ di pausa dalla violenza solo nelle scene nelle quali Machin si intrattiene con i due figli della padrona di casa, la vedova Hammond, giocando con loro, anche con lo scopo di diventarle gradito, visto che lui desidererebbe conquistarla. Ma si tratta di una parentesi di breve durata.
Ma anche quando Machin cerca, in atteggiamento sempre più ravvicinato, di conquistare la signora Hammond, non sembra uscire dal campo di rugby. Il rapporto che si instaura tra i due è decisamente violento e la scena del primo serio approccio tra i due è più simile ad uno stupro che ad un atto d’amore. In generale, aggiungiamo che la relazione violenta tra i due protagonisti, disvelata dalle pagine del romanzo di David Storey, viene commentata da Anderson come una “cupa relazione nordica di emozioni potenti e inarticolate, frustrate o deformate dal puritanesimo e dall’inibizione. Non c’è spazio qui per il fascino o il proletariato sentimentale. Quando la frase ti amo finalmente sfugge dalle labbra di Machin, Mrs. Hammond gli sputa in faccia.”
Nel 2008 il critico e studioso di cinema Neil Sinyard ha scritto una bella recensione su questo film per Criterion, nella quale rifà un po’ la storia del personaggio Anderson, fin dai tempi nei quali aveva fondato la rivista di cinema Sequence nel 1947, dove aveva esaltato il cinema di Jean Vigo, di Humpherey Jennings e John Ford, i cui film sono carichi di impegno, coraggio e convinzione, che divennero vere e proprie parole d’ordine del suo cinema.
Come abbiamo visto in precedenza, Anderson è stata la guida intellettuale del movimento del Free cinema. Una guida ben riconosciuta dagli altri membri del movimento, che si affidavano volentieri alle sue intuizioni e alle sue dichiarazioni nelle quali si riconoscevano in toto. E in gran parte sua è la stesura di quel manifesto per il Free cinema, che fu prima propagandato e poi distribuito agli spettatori prima delle proiezioni nelle sei sessioni del movimento tenutesi al NFT. Ora che anche lui era passato dal documentario al lungometraggio di finzione, riteneva che il suo compito centrale fosse quello di portare sullo schermo il realismo sociale e la ribellione contro l’ottuso conservatorismo della cultura britannica.
Su un binario parallelo, nel frattempo, andava sviluppandosi, come già abbiam notato in precedenza, un analogo movimento con analoghe istanze ed obiettivi in campo artistico e, segnatamente, letterario. Si stava formando una nuova leva di scrittori ribelli e i nuovi registi, reduci dai tre anni militanti di Free cinema, attinsero a piene mani ai loro romanzi come soggetto e materia dei loro film. Ne abbiano già incontrato qualcuno, in particolare Osborne (”Sapore di miele”) e Alan Sillitoe (“Sabato sera e domenica mattina”). Dobbiamo ricordare ancora Harold Pinter, Stan Barstow e appunto David Sorey, autore del romanzo “This sporting life”, che divenne, come film, il prodotto più forte e più violento dell’intero movimento.
Anderson aveva seguito con buona fedeltà il testo del romanzo a partire dall’ambientazione: la cittadina di Wakefield e utilizzato anche alcuni giocatori della locale squadra di rugby, ricercando così ulteriori elementi di realismo. Siamo, naturalmente, nel famoso nord, vero e proprio mito del Free cinema. Ma aveva seguito soprattutto lo spirito del romanzo. C’era una reale simbiosi tra il racconto e la realizzazione del film, che nasce dall’ammirazione di Anderson verso lo scrittore: “Storey cerca di penetrare nell’anima, ma non dimentica mai l’importanza del mondo sociale in cui le anime si incontrano, entrano in conflitto e lottano. Si sforza di bilanciare le ambiguità della nostra natura: maschio e femmina, tenerezza e violenza, isolamento e amore.”
All’interno del bellissimo quadro che ci fornisce Sinyard del film e del suo autore, c’è solo un punto che ci lascia con qualche perplessità. Esso riguarda il rapporto di Anderson col suo attore protagonista, Richard Harris. Sinyard si è sempre dimostrato, nei suoi oltre 25 libri di cinema e nei suoi articoli, un attento conoscitore del cinema nel suo complesso, e, in questo caso, definisce Anderson, con una certa convinzione, “un omosessuale infatuato del suo attore protagonista e, forse per questo, empatico con la repressa signora Hammond, che è alternativamente intimorita e sconvolta dalla mascolinità opprimente di Machin”.
Francamente non sappiamo quali elementi avesse Neil Syniard a sostegno di queste affermazioni (che. per la verità, abbiamo letto ripetute anche da qualche altro criticoi), espresse nel suo commento del 2008, cioè quasi 50 anni dopo l’uscita del film stesso.
E, peraltro, quando il film è stato girato, Siniard aveva appena 18 anni e probabilmente il cinema non era ancora la sua attività prevalente. Pertanto, risulta un po’ difficile pensare che avesse in merito informazioni di prima mano. Informazioni che aveva invece sicuramente la grande amica e confidente di Anderson, Lorenza Mazzetti, che lo conosceva bene e che ha anche confessato di esserne stata innamorata per un lungo periodo. Ma la Mazzetti ne ha parlato sempre come di persona riservatissima, che difficilmente lasciava trasparire i contenuti della sua vita privata e i suoi sentimenti. Lorenza aveva sì il dubbio che Aderson fosse omosessuale, “ma a modo suo, sublimato. Col tempo Lorenza si creerà la convinzione che , semplicemente, egli non abbia avuto rapporti né con le donne, né con gli uomini. Mostra un atteggiamento diffidente e serenamente conflittuale verso la sessualità.”(7)
In ogni caso, questi dubbi sulle fonti possibili di Synard, non inficiano la cristallina bellezza e la positività della ampia recensione che scrisse il critico nel 2008 e che rappresenta una delle cose migliori che sono mai state scritte su questo bellissimo film.
Il film fu acclamato ovunque. Fu presentato al Festival di Cannes ove Richard Harris vinse il premio quale miglior attore. Sempre Harris e Rachel Robert furono candidati all’Oscar per le loro interpretazioni. La Roberts ebbe il riconoscimento quale migliore attrice britannica dell’anno.
Dopo il Free cinema
I quattro autori che abbiamo trattato, anche attraverso i quattro film che maggiormente esprimono i caratteri portati avanti dal movimento del Free cinema, sono gli unici che hanno vissuto il passaggio, senza soluzioni di continuità, dai tre anni e dalle sei sessioni del Free cinema (febbraio 1956/marzo 1959) fino alla realizzazione delle loro prime opere. Sono trascorsi oltre 50 anni dalle loro prime opere ed anche dalle discussioni critiche che le hanno accompagnate, alcune delle quali abbiamo ritenuto di dover riferire, per completare il quadro del cinema del momento. E’ evidente che una parte delle stesse critiche, in senso positivo o negativo, risentono della cultura dell’epoca e delle sovrastrutture ideologiche dei singoli critici.
A distanza di tanto tempo, per il critico di oggi, l’impegno più serio che si possa prendere è quello di descrivere oggettivamente quelle discussioni e di contestualizzare il tutto: il movimento, la cultura dell’epoca, i film prodotti e le riflessioni critiche dei giornali e delle riviste dell’epoca.
In questo senso, una riflessione, come quella di Mino Argentieri del 1961, all’interno della citata recensione su “Sabato sera e domenica mattina”, il quale si incarica proprio già di contestualizzare il film nel suo particolare momento storico, ci aiuta moltissimo. A distanza di oltre due anni dall’ultima sessione del Free cinema al National Film Theatre in Londra, Argentieri afferma che esso è “purtroppo già sepolto”, individuando, in tale espressione, che il lavoro collettivo dei quattro registi, che lo avevano creato dando vita in soli tre anni a ben sei “festival” di cinema innovativo con presenze internazionali di grande rilievo, era terminato. E dunque dai primi di marzo del 1959 ciascuno aveva preso la propria strada, pur mantenendo reciproci collegamenti e interessi in comune. Per Argentieri era nato, nel frattempo, qualcosa di nuovo che, rispetto al Free cinema, usciva al di fuori dell’ambito strettamente cinematografico, ma interessava anche la letteratura, per non parlare della società in generale. Ci riferiamo, dice Argentieri nel 1961, “alla discussa corrente dei cosiddetti arrabbiati, che ha smosso le placidi e stagnanti acque di una letteratura e di un teatro quasi pietrificati nel tempo.” (8)
La verità, che il nostro critico ha la lucidità di cogliere nel momento stesso in cui si verifica, è che il movimento dei giovani arrabbiati, che coinvolge soprattutto letteratura e teatro, è la diretta filiazione e attualizzazione di quanto affermato nelle varie giornate dei tre anni del Free cinema. La cosa più nuova e straordinaria è la collaborazione che nasce tra il cinema e la letteratura, cui già abbiamo accennato. E’ un fenomeno mai registrato prima di allora e che fu tipico della new wave inglese e pressoché sconosciuto in altre realtà (in Francia solo Truffaut si rivolgerà alla letteratura per i suoi film, ma solo raramente chiederà la diretta collaborazione degli autori). Nel movimento inglese, invece, si era appena ripulito il National Film Theatre dopo l’ultima sessione del Free cinema del marzo 1959, che Tony Richardson era già in compagnia di Osborne per curare la regia teatrale de “I giovani arrabbiati” e per poi tradurla in un film che ebbe grande successo anche per l’interpretazione di Richard Burton.
Abbiamo visto sopra le collaborazione tra i giovani scrittori arrabbiati e i nostri registi fondatori del Free cinema. Se ne potrebbero citare molte altre che testimoniamo di un sodalizio, quello tra cinema e letteratura (romanzo e teatro), che durerà a lungo con risultati veramente eccellenti.
L’onda lunga di questo movimento, dunque, coinvolse numerosi scrittori e registi. Molti di questi ultimi si richiamarono esplicitamente al Free cinema, quasi riconoscendo un debito di gratitudine e in ogni caso di primogenitura. Sarebbe interessante analizzare il contributo del nuovo cinema inglese nato dopo il Free cinema al rinnovamento della società o almeno di alcuni strati di essa. Certo è che molti problemi dagli anni ’60 in poi saranno visti sotto una diversa luce.
Ad esempio, un film come “Sunday, bloody Sunday” (“Domenica, maledetta domenica”), girato da John Schleisinger nel 1971, appena otto anni dopo “This sporting life”, tratta di un triangolo amoroso che comprende una donna, un omosessuale e un giovane bisessuale.
Ebbene, un film del genere non avrebbe mai potuto vedere la luce se non ci fosse stato il movimento del Free cinema e quello che ne seguì. E soprattutto se si pensa, inoltre, che la legislazione britannica prevedeva i lavori forzati per chi si fosse macchiato del “crimine” dell’omosessualità! E, per inciso, il film rappresenta uno dei capolavori dei più interessanti registi inglesi del post Free cinema, quel John Schleinsinger al quale si devono altri film di grande rilievo come “Una maniera di amare” (1962) con un altro mito nascente del cinema inglese, Alan Bates, e inoltre “Billy il bugiardo”(1963) con Tom Courtenay, fino ad arrivare al capolavoro girato negli USA, “Un uomo da marciapiede” (1969).
Si sono necessariamente ispirati al Free cinema tutti quegli autori che vedono il cinema come strumento di denuncia e di polemica nei confronti delle politiche dei Governi che si sono succeduti. Infatti, i problemi in Inghilterra, dal dopoguerra in poi sono diventati, in alcune fasi, molto acuti e sono tanti gli intellettuali e i registi che si sono fatti portavoce dell’insoddisfazione o della rabbia delle classi meno abbienti. Uno dei più sensibili a queste problematiche è senza dubbio Ken Loach. Il quale nasce come regista televisivo, e infatti riceve un contratto dalla BBC per la regia di un gruppo di film/documentari a sfondo sociale e politico sui problemi della società britannica. Tutti i suoi documentari suscitano grande interesse nel pubblico, perché affrontano problemi spesso sommersi o comunque mai pienamente conosciuti nella loro drammaticità. Uno di questi è il problema della endemica mancanza di abitazioni per il proletariato e sottoproletariato. Col film TV “Cathy come home” Loach porta all’attenzione del pubblico inglese la grande difficoltà, ad oltre venti anni dalla fine della guerra, a trovare una casa soprattutto da parte delle giovani coppie. La mancanza di case popolari costringe le giovani coppie ad affittare camere in famiglie o a piegarsi ad umilianti coabitazioni o a dividersi per alloggiare in maleodoranti dormitori pubblici. Precedentemente si era molto criticata la politica per la casa dell’Unione Sovietica e le sue difficoltà a risolvere il problema delle abitazioni se non in termini di coabitazioni. Loach dimostra che il problema delle coabitazioni in Inghilterra è percentualmente ben più grave.
In questo modo, pochi anni dopo il Free cinema, e con la stessa forza contestativa, nasce il cinema di denuncia, strettamente ancorato ai problemi più gravi del Paese e delle classi meno agiate. Una denuncia che Loach in prima persona continuerà ad agitare per oltre un cinquantennio, con grandissima tenacia e coerenza, attraverso un lavoro instancabile, una filmografia ricca di 27 film di finzione, 23 film inchiesta per la TV, 4 documentari e 3 film corti. L’onda lunga del free cinema aveva colpito ancora…
Note:
(1) – Giorgio Betti: L’italiana che inventò il Free cinema inglese
(2) – Gianni Rondolini: Storia del cinema III, pag. 255
(3) – Geoffrey Nowell-Smith: “Making waves” ed. Bloomsbury -pag 134
(4)– Geoffrey Nowell-Smith: op. cit. pag. 135
(5)– Morvan Lebesque, in L’Express, 1/VI/61
(6) – Mino Argentieri, in L’Unità, 25/VIII/61- Riportato poi in “Il nuovo spettatore cinematografico” n°25 di ottobre 1961 , pag. 10
(7)– Mino Argentieri – ibidem
(8) – Mino Argentieri – ibidem
JOHN CASSAVETES
di Giorgio Sabbatini
vita di un “genio” dell’immagine cinematografica
e analisi della sua prima opera “Shadows”
Chi ama il Cinema non può non avere visto, almeno una volta nella sua vita, un’opera di John Cassavetes, Regista Indipendente e innovatore, vero “genio” dell’immagine cinematografica.
Non ha realizzato numerosi film, dodici in tutto, ma il suo occhio critico appoggiato alla loupe della m.d.p. (macchina da presa), ha sempre saputo dare vita ad inquadrature intense e originali, trasmettendo le sensazioni percepite dalla sensibilità dei personaggi, ideati e resi reali nella finzione, attraverso la scelta di piani ravvicinati, movimenti avvolgenti e semplici angolazioni, in significativi momenti dello sviluppo del racconto filmico.
Un estro artistico libero dai condizionamenti hollywoodiani, interessato alla sperimentazione e alla ricerca espressiva dei volti dei suoi attori per diffondere le proprie idee su un sentimento universale: l’amore.
È stato, indubbiamente, il protagonista principale della nascita del Cinema Indipendente americano e oggi resta uno degli Autori di riferimento per l’innovazione apportata nel linguaggio cinematografico in genere e specialmente nel Cinema statunitense che ha profondamente influenzato Registi della “New Hollywood” come Coppola, Scorsese, Forman, Altman ed Arthur Penn che emersero nel decennio compreso tra gli anni ’60 e ’70.
È riuscito a realizzare con grande abilità un Cinema particolarmente equilibrato tra lo stile della produzione sperimentale e le dure regole hollywoodiane considerando di grande importanza i rapporti con gli attori e dando vita ad una felice intesa tra Cinema e Teatro.
VITA
Newyorkese di nascita (9 dicembre 1929), trascorre la sua infanzia nella terra di origine della sua famiglia: la Grecia. Infatti, la famiglia Cassavetes, con non pochi problemi economici per crescere i figli, soprattutto nel periodo della “Grande Depressione” durante la quale tutti erano poveri, decide, agli inizi degli anni Trenta, il ritorno in Grecia per affrontare una situazione particolarmente difficile e complessa. Il piccolo John ha soltanto due anni.
Quando la famiglia torna definitivamente negli Stati Uniti, John ha già otto anni.
Trova qualche difficoltà nella frequentazione scolastica poiché non sa l’inglese e parla soltanto greco. Ma per il piccolo John le difficoltà linguistiche non sembrano creargli troppi problemi poiché convinto che il linguaggio sia soltanto un insieme di simboli e che le vere emozioni siano espresse nello stesso modo in ogni Paese. Questo suo pensiero lo aiuta ad integrarsi facilmente nella società di quel tempo.
Il padre, Nicholas Cassavetes, amante della lettura e grande sognatore, segue gli ideali della civiltà greca classica. Conservatore e tradizionalista, critica gli americani per non essere all’altezza degli ideali sui quali si fonda la loro cultura. È convinto che l’America sia combattuta all’interno da grandi divisioni sociali e che abbia bisogno di recuperare gli ideali tradizionali di disciplina, patriottismo e valore morale che, nel tempo, si sono infinitamente attenuati.
È un intellettuale in rivolta ma anche un appassionato studioso della storia, passione che cerca di trasmettere al giovane John, attraverso l’interesse e l’amore per i classici, leggendogli Platone e Sofocle in greco. Queste letture sono molto importanti per John e, grazie alla sua eccezionale memoria, lo accompagneranno sempre durante tutta la sua vita.
Katherine Cassavetes ha circa quindici anni meno del marito ed è una donna molto bella, brillante ed estroversa che nutre un profondo amore per il piccolo John. Appartiene all’alta aristocrazia greca di Park Avenue e parla facilmente greco, italiano, inglese e yiddish. Donna elegante e raffinata ama la vita e possiede un gran senso dell’umorismo.
Coltiva anche un sogno che tiene chiuso nel “cassetto dei desideri”: quello di fare l’attrice e di provare le emozioni di interpretare personaggi diversi che affrontano le problematiche della vita. Questo sogno si realizzerà circa trent’anni dopo, quando suo figlio John la coinvolgerà facendola recitare in “Minnie e Moskowitz”, “Una moglie”, “L’assassinio di un allibratore cinese” e “La sera della prima”.
Il giovane John è sempre stato un entusiasta dello sport che segue con passione avendo i propri idoli sia nel basket che nel baseball o nel football. Tutti sport che pratica con particolare grinta e che segue nelle pagine sportive dei giornali, le uniche che legge con interesse. Inizia, però a seguire anche il Cinema e ad appassionarsi ad alcune storie dove i cattivi sono i potenti mentre i poveri rappresentano gli uomini giusti che vincono sempre anche se in certi casi qualche cattivo può diventare buono. Frank Capra è un importante riferimento con i suoi film dove la parola “giustizia” acquisisce un importante valore.
Ma l’attenzione di John si rivolge anche verso gli Attori che interpretano personaggi di grande spessore ai quali è concesso esternare le proprie idee di fronte ad una cinepresa e dire cose che possano avere un significato mirato per un pubblico attento, capace di trarre ragionamenti e riflessioni importanti. American Academy of Dramatic Arts
James Cagney diventa il suo Attore preferito e lo segue nei film che interpreta con ammirata convinzione sicuro che i personaggi interpretati possano esprimere nella finzione una realtà celata nella vita quotidiana e, quindi, porre problemi che tendenzialmente restano assopiti nelle persone comuni.
Nonostante il totale disinteresse di John allo studio, condotta che amareggia sia il padre che la madre, nel giugno del 1947 si diploma al Liceo di Port Washington. Non ha certamente desiderio di andare al College ma decide di seguire il fratello maggiore che, congedatosi dall’esercito, si iscrive al Mohawk College. John resta solo un anno fino alla chiusura del College. Decide, quindi, di frequentare il Champlain College ma dopo soli sei mesi è respinto.
Questa uscita dal College provoca amarezza e delusione nei genitori di John che, ormai, non hanno più speranze per un futuro sognato fatto di studio e con la possibilità di frequentare l’Università di Harvard. Considerano il figlio un perditempo che si diverte a giocare a basket e a flirtare con le ragazze.
John subisce la tensione della famiglia specialmente a causa del fratello Nicholas, persona seria e volenterosa, che da due anni presta servizio militare e che studia chimica come aveva fatto il padre da giovane. A questo punto, insieme ad alcuni amici John prende un’importante decisione.
A 19 anni, l’8 febbraio 1949, accompagnato dalla madre fa un’audizione per l’American Academy of Dramatic Arts. Gli insegnanti dell’Academy concentrano il proprio lavoro quasi esclusivamente sul teatro approfondendo le capacità interpretative di ogni singolo Allievo.
Lo studio comprende un primo anno dedicato ad un Corso per Principianti e nei sei mesi successivi ad un Corso Avanzato che mette alla prova gli Allievi nella realizzazione di una compagnia teatrale in grado di recitare lavori di repertorio in diverse produzioni pomeridiane presso i Teatri Carnegie Lyceum o Empire.
Con grande soddisfazione dei genitori John è ammesso all’Academy. La madre appare molto stupita, probabilmente non si aspettava questo successo del figlio, mentre il padre lo incoraggia ad intraprendere una via attraverso la quale potrà vestire i panni della gente comune e potere affermare alcune idee che affronteranno interessanti problematiche.
All’inizio di questo percorso il giovane appare piuttosto distratto dalle ragazze che frequenta e dalla grande libertà che regna in quell’ambiente. Durante il primo semestre non si impegna come dovrebbe e questo non piace a suo padre che lo responsabilizza rifiutandosi di pagare la retta richiesta per la frequentazione della scuola. Il padre crede nelle capacità di John poiché è convinto che possa fare l’Attore e la sua decisione di metterlo di fronte ai problemi reali della vita costituisce uno sprone per la futura carriera del figlio.
John è costretto a lavorare in un drugstore, durante l’estate, per raccogliere i soldi necessari a pagare la retta della scuola. Esuberante e un po’ ribelle, con un temperamento comunicativo forte e il desiderio di apprendere l’Arte dell’Eloquenza è convinto di sapere tutto sull’Arte della Recitazione.
Gli insegnanti dell’Academy sono tutti all’altezza del loro compito, ma John non riesce ad intendersi con tutti e questo gli crea qualche problema nell’apprendimento. Comunque, ammira molto il docente Charles Jehlinger che considera un uomo fantastico e l’insegnante migliore in assoluto. Ci sono tre parole che l’insegnate ripete spesso: pensare, parlare ed ascoltare. Parole che John comprenderà meglio in seguito e che al momento lo lasciano sorpreso e incuriosito.
Crescendo, il giovane Cassavetes comprenderà il significato di quelle tre parole alle quali Charles Jehlinger faceva spesso riferimento. Tre parole per una continua analisi introspettiva che l’Attore deve fare su sé stesso per comprendere la psicologia del personaggio che deve interpretare pensando alle azioni ed alla gestualità da utilizzare e parlando secondo i toni che meglio possano esprimere la personalità da gestire, senza mai dimenticare l’importanza di sapere ascoltare per apprendere importanti consigli.
Durante il primo semestre John abita dai suoi genitori poi decide di trasferirsi, insieme ad alcuni compagni di Corso, in un modesto appartamento a Manhattan. Un breve periodo dove John inizia a dedicarsi allo studio della propria voce usando un registratore a nastro. Incide e risente la fonetica usata nella registrazione di parole e frasi, cerca di modificare le intonazioni che reputa inesatte e annota le frasi sentite tra i compagni per compiere una ricerca sulla costruzione dei dialoghi provando a sperimentare, ripetutamente, toni e ritmi nella costruzione autentica di un parlato credibile.
Cassavetes prende coscienza di quanto sia importante analizzare la propria personalità per trovare la forza di affrontare gli ostacoli e le delusioni della vita. È necessario credere in ciò che si vuole fare per avere la capacità di esprimere tutti i sentimenti che soggiornano nel profondo del proprio animo. È convinto che la preparazione dell’Attore sia un continuo studio e perfezionamento dell’Arte della Recitazione che deve farci raggiungere le vette impossibili della perfezione alle quali, però, dobbiamo sempre tendere senza mai accontentarci dei risultati mediocri. Recitare, scrivere una sceneggiatura o essere Registi implica di non tradire la propria identità che John considera “… la visione di sé stessi attraverso l’occhio della mente”, un modo per cercare di manifestare i propri pensieri nella quotidianità della vita dando risalto al carattere interpretativo di ogni personaggio.
Nel 1950 John Cassavetes si diploma e inizia una ricerca disperata per lavorare come Attore. La situazione non è semplice e inizia a “fare il giro” che significa bussare alle varie porte dei Direttori del Casting, dei Produttori, degli Agenti, dei Registi e degli Sceneggiatori. In ogni ufficio porta una sua fotografia e con ostinazione continua a bussare a tutte le porte possibili portando nuove fotografie per cercare di ottenere una scrittura.
Ottiene piccole parti nei teatri regionali che, comunque, gli servono per fare esperienza e acquisire ciò che si definisce “la padronanza della scena”, indispensabile per un bravo Attore. Sono anni difficili che John affronta con perseveranza cercando di farsi conoscere attraverso atteggiamenti stravaganti guadagnandosi la reputazione di “pazzo”.
La sua vivacità che si scatena durante le feste con amici contrasta con il lato personale piuttosto “chiuso”, non disposto a parlare di sé stesso. Da persona estroversa e ironica assume un atteggiamento protettivo nonostante la facilità di colloquiare con battute ed essere disposto a fare scherzi. John riesce sempre a trasmettere agli altri una propria innata sicurezza che, però, nella realtà non possiede poiché è una persona insicura che ha bisogno di validi punti di riferimento. Ritiene, infatti, di non avere le capacità necessarie per esprimersi correttamente, ad esempio, durante un’intervista. Inoltre, il suo modo di vestire, molto criticato dalla madre, lo mette a disagio puntualizzando un problema al quale non ha mai dato molta importanza.
Il desiderio di fare l’Attore si scontra con la dura realtà che gli permette unicamente la possibilità di fare la comparsa in due film: “La quattordicesima ora“ di Henry Hathaway (1951), film nel quale la scena interpretata da John è stata eliminata nella versione definitiva e “Taxi” di Gregory Ratoff (1952), dove interpreta un venditore di hot dog.
John sfrutta l’amicizia con Ratoff proponendosi come trovarobe per la serie televisiva “Cradle of Stars” e ottiene due piccole parti, quindi, accetta di seguire Ratoff a Broadway per fare l’assistente del Direttore di Scena nella produzione teatrale “The fifth Season” al Cort Theater. Un lavoro che non lo soddisfa, e che rappresenta una vera sconfitta per chi vuole esercitare la professione dell’Attore, ma che deve fare per guadagnare il necessario per vivere.
La vita riserva sempre numerose sorprese e, talvolta, anche validi incontri. Durante una rappresentazione teatrale John, in attesa di fare il suo lavoro di Direttore di Scena, passa il tempo a declamare poesie agitandosi come un giullare facendo una serie di capriole. Sam Shaw, noto fotoreporter, sta fotografando parte dello spettacolo e vede il giovane Cassavetes impegnato in strane evoluzioni che lo impressionano favorevolmente.
È l’inizio di una straordinaria amicizia e collaborazione con John. Sam come fotogiornalista segue numerosi eventi artistici e introduce John in un mondo tutto da scoprire, come le Arti Classiche, la Pittura, la Poesia e la Musica Jazz
È un periodo di grande formazione artistica per John che si dedica, con grande interesse, all’attività di Shaw il quale, per il lavoro che esercita, è costretto a seguire e documentare quanto accade nelle varie gallerie d’Arte. Ma il principale desiderio di John è quello di fare l’Attore nel Cinema e Sam gli procura subito un contatto con l’agente Robert Lang che permette al giovane di interpretare qualche piccolo ruolo nel campo televisivo.
Per oltre trent’anni Shaw sarà uno dei collaboratori più fedeli di Cassavetes attraverso un’amicizia indelebile e costruttiva che darà modo a John di prendere maggiore coscienza delle varie Arti che compongono il bagaglio culturale di un vero Artista.
Ma nella vita di John c’è un incontro molto importante che darà una svolta decisiva al suo carattere e alla sua attività di Attore e Regista. Un anno dopo avere frequentato l’American Academy of Dramatic Arts, nel 1951, conosce una giovane e promettente Attrice di nome Virginia Cathryn Rowlands che, però, dopo sei mesi di frequentazione lascia l’Academy. In varie occasioni John incontra la Rowlands e la corteggia con una certa insistenza comprendendo il carattere non facile della giovane decisa a non concedersi distrazioni, poiché la sua mèta da raggiungere è quella dell’Attrice professionista.
La possessività di Cassavetes costituisce un ulteriore scoglio da affrontare nei rapporti con Gena. Non mancano litigate, discussioni e incomprensioni che rendono l’ambiente piuttosto infuocato. I loro caratteri sono completamente diversi, non hanno punti di contatto se non il desiderio di recitare ma questo non basta e le loro personalità così differenti alimentano un continuo scontro di idee. Gena cresciuta in campagna, senza problemi finanziari, raffinata e cordiale nei rapporti sociali, ha studiato musica e possiede un temperamento artistico di indubbio valore. John è piuttosto grossolano e impulsivo e, a differenza di lei, non tiene conto delle opinioni delle persone. Due caratteri opposti in ogni cosa destinati a produrre innumerevoli attriti.
Gena Rowlands, nata il 19 giugno 1930 a Cambria, nel Wisconsin, proviene da una famiglia benestante, senza problemi finanziari e socialmente introdotta nella vita cittadina.
I suoi genitori mostrano forti personalità ed uno spiccato senso di indipendenza l’uno dall’altro dando sfogo ad interessi personali che costituiscono un importante esempio di vita nei confronti della figlia.
Edwin Myrwyn Rowlands, padre di Gena, tra il 1924 e il 1940 è vicepresidente della banca locale e membro dell’Assemblea statale del Wisconsin e in seguito sentore.
Tra il 1941 e il 1948 lavora a Washington partecipando a diverse cariche governative. La famiglia Rowlands, durante alcuni di questi periodi vive ad Arlington, in Virginia e Gena, tra i dieci e quindici anni, si appassiona alla recitazione amatoriale partecipando a diverse rappresentazioni presso il liceo Washington and Lee e frequentando un piccolo teatro locale, il Jarvis Repertory Company, prima di ritornare nel Wisconsin.
La madre di Gena, Mary Allen (Neal) Rowlands, è una casalinga con particolari interessi artistici come la musica, la recitazione e la pittura a olio, quest’ultima, un’arte che anche la figlia pratica da giovane con grande interesse. Alcuni quadri appesi alle pareti di casa Cassavetes, visibili sullo sfondo dei film girati al suo interno, sono opera della madre di Gena che reciterà in cinque film del genero sotto lo pseudonimo di “Lady Rowlands” (un soprannome suggerito dai figli del Regista).
Gena ha un fratello, David, che da adulto vive a San Diego come ufficiale e pilota della marina e che interpreterà piccole parte in sei film di Cassavetes.
Gena, prima bambina e poi adolescente, è molto viziata dalla sua famiglia. Subisce la paura di ammalarsi o di essere malata trovandosi più volte costretta a stare a letto. È timida e riservata e anche se lo studio non rappresenta, per lei, un particolare modo di sviluppare le sue conoscenze, la madre, nel 1947 la obbliga ad iscriversi all’Università del Wisconsin.
Nei tre anni successivi la famiglia di Gena attraversa un periodo particolarmente difficile, segnato da varie crisi personali che nel 1950 sfociano in un vero e proprio “crollo”. Gena si ritira dall’Università e la madre, nell’estate successiva, la porta a New York per iscriverla all’American Academy of Dramatic Arts ed aiutarla a trovare un pensionato per studentesse.
Per Gena questo è un periodo di grandi difficoltà, è costretta ad affrontare i problemi della vita con ristrettezze economiche non indifferenti. È una ragazza molto sensibile ed emotivamente vulnerabile e, quindi, esposta ai rischi di una vita travagliata.
Fortunatamente, trova un lavoro part-time, come “maschera”, al cinema Little Carnagie Cinema cercando di raggranellare qualche soldo per la sopravvivenza.
La visione di vari film crea in lei un certo interesse per questo tipo di spettacolo, specialmente dopo avere visto “L’angelo azzurro” (1930) con Marlene Dietrich che, improvvisamente, diventa un suo idolo. Gena resta affascinata dalla femminilità dell’Attrice e nello stesso tempo da una certa durezza ed arroganza che la Dietrich esibisce con gestualità quasi maschili. La giovane, dopo avere visto il film numerose volte, sceglie di utilizzare alcuni gesti e vezzi propri della grande attrice.
Dal 1951 al ’53, Cassavetes cerca di entrare in contatto con il mondo della Televisione e del Cinema mentre la Rowlands tenta una strada parallela cercando di farsi strada sul palcoscenico. Per lei il Teatro rappresenta un sogno da realizzare nel modo migliore e più completo. Purtroppo, le sono affidate piccole parti fatte di brevi battute dove non riesce a rappresentare la propria personalità e la sua capacità di interpretare un personaggio complesso.
Ma la vita è fatta di combinazioni inattese e George Hall, Attore statunitense, ha l’occasione di vedere Gene interpretare alcune brevi parti. Colpito dalla presenza scenica della giovane donna, la invita ad un’audizione per una nuova piccola parte che potrebbe interpretare con grande efficacia. La soddisfazione di Gene nell’ottenere un piccolo ruolo di narratrice, nella rivista musicale di David Axelrod ‘All About Love’, provoca l’immediato allontanamento dall’American Academy of Dramatic Arts non portando a termine il secondo anno.
Purtroppo, questa nuova esperienza non le apre nuovi orizzonti.
Nel 1953, Gene Rowlands dopo aver ottenuto nuovamente una minuscola parte di poche battute torna a New York e inizia la non facile relazione con Cassavetes. Una relazione, certamente, inquieta per i sospetti e la grande gelosia da parte del Regista che si trova di fronte ad una donna dal carattere forte e con la consapevolezza di non volere sottostare alla possessività di un uomo abituato alla più sfrenata libertà con le sue conquiste femminili.
Due caratteri diametralmente opposti. Lei, vissuta in campagna in un ambiente economicamente sereno senza grosse problematiche di vita, ha studiato musica che le ha permesso di acquisire una certa dignità artistica. Lui, ragazzo abituato a vivere in città, cresciuto nelle strade, tendenzialmente spaccone, impulsivo e rozzo, il suo carattere contrasta notevolmente con una donna affascinante, sensibile che tiene in grande considerazione il pensiero della gente che, invece, a lui non interessa!
Un rapporto non semplice per le grandi differenze di opinioni totalmente contrastanti che, tuttavia, nel tempo hanno affinato le loro anime!
Cassavetes sviluppa la propria carriera di Attore in modo veramente casuale attraverso la conoscenza di James O’Connor, figliastro di McCaffrey, un importante e potente agente televisivo, che trova, nel giovane Regista, una brillante dialettica intelligente con forte senso dell’umorismo. James presenta al patrigno Cassavetes che nel giro di poco tempo ottiene una parte importante, tra non poche difficoltà dove licenziamenti ed assunzioni fanno parte di un gioco inevitabile per iniziare una carriera promettente. Ed è proprio il ruolo di Attore che permette a Cassavetes di raggiungere il successo e di trovare una certa indipendenza economica tale da poter pensare alla produzione di alcune sue opere e di sperimentare il suo modo di “fare Cinema” improntato alla “improvvisazione”, all’utilizzo di una “troupe ridotta” e costituita da persone di sua fiducia, lontano dagli schemi produttivi rigidi hollywoodiani, per proporre un nuovo linguaggio d’immagini basato sull’interpretazione degli Attori, veri protagonisti delle storie raccontate. Ma per Cassavetes l’”improvvisazione” ha un significato particolare e non propriamente letterario, infatti, si riferisce ad una continua analisi dei personaggi ed agli innumerevoli suoi consigli che integrano tale analisi per modificare i testi, le azioni, e rendere tutto più simile alla realtà che si vuole rappresentare. Un lavoro minuzioso, che richiede pazienza e capacità di critica sia da parte dell’Attore che del Regista.
McCaffrey diventa una persona essenziale per lo sviluppo della carriera di Attore che Cassavetes sta intraprendendo. Dopo alcuni inevitabili ostacoli da affrontare e superare con caparbia volontà, finalmente, il giovane Regista riesce a raggiungere il successo televisivo che gli permette una certa serenità economica.
A questo punto McCaffrey propone a Cassavetes una vera e propria “lezione di vita” per come comportarsi nei confronti della stampa. Se gli anni del successo di Attore sono dovuti principalmente, alle amicizie, al duro lavoro svolto con attenzione maniacale, dal giovane Cassavetes, nel documentarsi sul significato delle singole parole per interpretare al meglio le parti che gli sono offerte, non si deve dimenticare la quantità di “comunicati stampa”, fotografie e interviste che McCaffrey realizza per promuovere la carriera del suo cliente. Un’esperienza che Cassavetes tesorizza e saprà utilizzare nel corso di tutta la sua vita.
Per oltre due anni, Cassavetes e, in seguito, la Rowlands rilasciano ogni settimana interviste, corredate da fotografie realizzate dai più importanti fotografi di New York, a pubblicazioni specialistiche, riviste, e rubriche di gossip con il preciso scopo di diffondere la loro immagine per favorire le loro carriere in continua crescita.
McCaffrey, con grande astuzia, utilizza una tattica vincente convincendo Cassavetes e la Rowlands a scrivere alcune lettere adulatrici alla cronista mondana Edda Hopper nelle quali si evidenzia l’importanza del ruolo svolto dalla cronista promuovendo la loro attività attraversi i progetti proposti.
La Hopper s’interessa alla vita artistica svolta da Cassavetes e nei successivi cinque anni sviluppa, nella sua rubrica, con toni favorevoli, il percorso che il giovane Regista sta realizzando. Inoltre, lo invita, nel 1960, a partecipare al suo programma televisivo Hedda Hopper’s Hollywwod.
Il marzo del 1954 segna un momento molto importante per la vita artistica di Cassavetes. Infatti, con l’aiuto della Hopper che, usando la propria influenza, propone a Darryl Zanuck di far fare un provino al giovane Cassavetes per la parte, appena rifiutata da Marlon Brando, di “Sinuhe l’egiziano”, si apre un’occasione particolarmente felice. La parte, purtroppo, è assegnata a Edmund Purdom ma McCaffrey sfrutta con grande abilità e tempistica il fatto che a Cassavetes sia stata proposta una parte rifiutata da Marlon Brando! Nei primi giorni di marzo iniziano ad arrivare offerte televisive importanti e convincenti da prendere in seria considerazione.
Cassavetes si sente pronto a compiere un passo decisivo valido per lo sviluppo del suo futuro. Lascia il posto di Assistente Direttore di scena e si dedica alla carriera di Attore impegnandosi in un continuo studio dei personaggi che gli sono proposti.
Il mese di marzo del 1954 segna anche una svolta essenziale nella vita del giovane artista. Infatti, il venerdì 19 marzo, Cassavetes e la Rowlands con una breve e modesta cerimonia, si sposano alla Little Church Around the Corner al centro di Manhattan.
Questo “traguardo” sentimentale lo raggiungono dopo un breve corteggiamento di soli quattro mesi di convivenza! Gena, appena sposati, mette in chiaro, rivolgendosi a John, una proposta che le sta particolarmente a cuore: “Senti, c’è una cosa che ti devi mettere bene in testa. Io ho il complesso della madre, si tratta di mia madre e tu devi sempre essere gentile con lei.”, e John non perde tempo per risponderle dicendo: “Ok. Tu però devi essere gentile con mia madre – e forse per te sarà ancora più difficile!”.
Nei mesi successivi del 1954, Cassavetes, riceve scritture in oltre ventisei produzioni televisive, ventitré nel 1955 e dodici nel 1956. Le sue apparizioni diminuiscono gradatamente per i vari impegni nel campo cinematografico e anche perché le reti televisive decidono di ridurre le trasmissioni drammatiche. Per John è un momento particolarmente fortunato poiché riesce ad interpretare importanti ruoli nelle migliori serie drammatiche dell’epoca come Omnibus, Playhouse 90, Kraft Theater, Goodyear Playhouse, The Elgin Hour, Alcoa Theater, The American Tobacco Theater, Studio One, Pond’s Theater, Armstrong Circle Theater, The United States Steel Hour, Alfred Hitchcock Presenta, Twentieth Century Fox Hour e The Philco Television Playhouse.
Meno felice è il periodo artistico di Gena Rowlands, costretta ad interpretare piccole parti teatrali in compagnie estive o secondarie che non le permettono di esprimere le proprie capacità interpretative. A questo punto, John cerca di convincere Gena a lavorare con lui in televisione. Gena è piuttosto riluttante a questa idea poiché non ama la televisione. L’insistenza del marito convince la donna a fare una partecipazione congiunta, il 25 giugno 1955, nell’episodio “Time for love”, durante il programma, prodotto dalla NBC, Armstrong Circle Theater. Il 9 ottobre Gena, insieme al marito, appare nella trasmissione di un episodio di The Goodyear Television Playhouse scritto da Reginald Rose “The Expendable House”.
Gena appare piuttosto contrariata di dover interpretare una breve parte di pochi minuti ma l’unica cosa che desta in lei un certo interesse è la crisi isterica che il personaggio ha in scena! Una vera e propria sfida da interpretare con convinzione e, soprattutto, con la realtà emotiva di una grande attrice!
Nella vita, oltre alle proprie capacità ci vuole sempre un po’ di fortuna! Infatti, accade che Josh Logan, Regista, produttore cinematografico e drammaturgo, stia guardando, casualmente, la trasmissione dove la Rowlands interpreta il personaggio isterico. Logan ha da poco ricevuto il rifiuto da parte di Eva-Marie Saint ad interpretare una produzione che ha in cantiere per essere presentata a Broadway, “The Middle of the Night” di Paddy Chayefsky. Sorpreso per l’intensa interpretazione della Rowlands, la convoca per un provino di lettura della parte.
Gena descrive il primo incontro con grande semplicità soffermandosi sull’impegno che Logan esprime nell’ascoltare la lettura da parte delle attrici convocate. Con meticolosa attenzione il Regista si sofferma sulle parole lette e sull’intonazione che ogni attrice riesce a dare secondo la propria interpretazione.
La Rowlands è richiamata “venticinque” volte prima di ottenere quel ruolo! Per l’attrice è un momento molto importante poiché dopo quattro anni di piccole parti in lavori teatrali frequentando fatiscenti alberghi, l’apparizione televisiva le permette di modificare radicalmente la sua vita. Recita in coppia con Edward G. Robinson che diventa intimo amico sia dell’attrice che di suo marito e che in futuro si adopererà per presentare alla coppia autorevoli personaggi.
Le prove di “The Middle of the Night” iniziano a dicembre e le prime rappresentazioni di rodaggio sono realizzate fuori New York nel Delaware e a Philadelphia. L’impegno di Gena nell’interpretare il personaggio assegnatole è davvero molto intenso e degno di una grande professionista. Lo spettacolo esordisce l’8 febbraio 1956 all’Anta Theater di New York (oggi, il Virginia Theater), sulla Cinquantaduesima Strada Ovest, con un successo strepitoso di pubblico e di critica.
Lo spettacolo è replicato 477 volte fino al 25 maggio 1957. Segue una breve tournée che riunisce l’intero cast di Broadway allo Shubert Theatre di New Haven e al Curran di San Francisco tra l’ottobre del 1957 e marzo del 1958.
Mentre Gena recita con successo a Broadway, Cassavetes sta attraversando un periodo dove il lavoro televisivo si modifica, con una certa gradualità, in impegno cinematografico. In questo periodo è piuttosto semplice realizzare in Cinema ciò che viene proposto in televisione mantenendo anche la presenza dello stesso protagonista.
La carriera cinematografica di Cassavetes subisce un sicuro incremento nel momento in cui Martin Baum, un agente della Newborn Agency e talent scout a New York per Max Arno della Columbia (uno studio molto piccolo privo di un “ufficio talenti”!), si interessa al giovane Attore fino dalle prime apparizioni del 1955 iniziando a raccomandarlo per alcuni ruoli cinematografici. La ricerca del “lavoro” da parte di John riveste sempre grande importanza e il suo carattere alquanto “focoso” e, talvolta, “violento” lo porta a protestare nei confronti di produttori, agenti e funzionari degli Studios con l’intento di provocare in loro una reazione. Cassavetes cerca in vari modi di apparire come un “artista” altamente creativo e capriccioso, un’immagine che ama e che coltiva con ricercatezza e impegno.
Baum invita nel suo ufficio il giovane Attore e con semplicità e naturalezza gli chiede se sa recitare. Questa domanda inaspettata provoca una reazione piuttosto violenta in Cassavetes che sporgendosi oltre la scrivana afferra la camicia di Baum strappandogliela e urlando “Se so recitare?! Mi chiede se so recitare?!”. Il talent scout resta interdetto e nudo dalla cintola in su mentre John non si scusa per il gesto smisurato.
Questo episodio segna, comunque, per Cassavetes, l’inizio di una buona collaborazione con Martin Baum che sostituisce McCaffrey e rappresenterà l’Attore, come suo agente, fino agli anni ’70.
I primi ruoli cinematografici sostenuti da John, gli fruttano non più di 500 dollari e le apparizioni televisive ancora meno, ma nel 1957 la cresciuta popolarità dell’Attore porta ad un’insperata crescita del suo cachet salito alla fantastica cifra di 25.000 dollari! Considerando, inoltre, gli assegni che Gena incassa per la sua interpretazione in “The Middle of the Night”, finalmente, la coppia raggiunge un’invidiabile tranquillità economica.
Entrambi firmano un contratto con la MGM con l’intento di potere lavorare anche insieme. Un momento fortunato dove i maggiori guadagni dovuti al loro successo si traducono in un totale rinnovamento della loro situazione immobiliare. Infatti, si spostano dal modesto appartamento, preso appena sposati, al 36 della Trentaseiesima della Strada Est, al 162 della Cinquantaquattresima Strada Ovest e in un secondo momento in un attico al 40 della Settantacinquesima Strada Est, non troppo lussuoso ma con un piccolo terrazzo con relativo giardino pensile.
Nel 1957, la Rowlands era molto soddisfatta della sua carriera anche se non era ancora riuscita a portare a termine il desiderio di formare una vera e propria famiglia.
Nonostante il successo economico raggiunto, Cassavetes, comprende che in America l’intrattenimento è un’industria che non ha nulla in comune con l’Arte. Questo non permette all’Attore una sua vera libertà interpretativa poiché deve sempre sottostare ai registi legati ai metodi usati dall’industria cinematografica di Hollywood. Per John, l’Attore è, quindi, costretto ad una recitazione ipocrita, non naturale e tantomeno creativa poiché costretto a seguire canoni che lo fanno sembrare un semplice impiegato che cerca di svolgere, al meglio, un classico lavoro di “routine”.
Cassavetes non è soddisfatto delle parti che gli sono offerte sia in Televisione che al Cinema. Teme di essere finito in una “gabbia” che non gli permetta di dare il meglio di sé! Il forte desiderio di esprimere la propria personalità, attraverso l’interpretazione dei vari personaggi, subisce notevoli restrizioni dai registi che non gli permettono di modificare le battute e lo costringono a seguire il copione prestabilito. L’infelicità di John appare evidente e il lavoro di Attore inizia ad essere meno coinvolgente e più noioso. Il suo pensiero inizia a focalizzarsi su un nuovo progetto che, con il tempo, modificherà la sua vita.
I casi della vita sono molteplici e certe volte gli incontri casuali comportano importanti modifiche nella propria vita. John, a New York, in attesa di prendere l’autobus incontra un vecchio amico: Burt Lane. La loro amicizia dura da vari anni durante i quali hanno realizzato alcuni progetti non sempre portati a termine. Quando John, in passato, aveva ottenuto la parte in “Paso doble”, Lane si era prodigato ad insegnargli come recitare al meglio le battute. Inoltre, avevano scritto insieme una sceneggiatura che, per ampi disaccordi sull’impostazione di una scena, non fu portata a termine. Tra le varie attività svolte non dobbiamo dimenticare quella che ha costituito l’embrione del “futuro laboratorio” che avrebbero realizzato. Si trattava di riunioni serali con amici Attori per la lettura informale di alcune pagine tratte da importanti drammi teatrali.
L’inatteso incontro fa scattare ad entrambi il desiderio di riprendere il vecchio progetto di dare vita ad un “laboratorio formativo” per insegnare ai giovani Attori una recitazione naturale, veramente vissuta con il personaggio interpretato, priva di cadenze artefatte e ipocrite tipiche degli Studios.
Cassavetes e Burt Lane affittano una stanza ai piani alti del Variety Arts Building, al numero 225 della Quarantaseiesima Strada Ovest, e invitano alcuni amici a partecipare alle loro letture. Dopo pochi mesi, si trasferiscono al piano terra in un locale che si è reso libero al costo mensile di 800 dollari. Il locale non è usato da vari anni e appare piuttosto fatiscente. Con l’aiuto di volenterosi studenti-Attori il locale assume una nuova fisionomia con la creazione di piccoli uffici, un’aula di dimensioni contenute, trenta o quaranta posti, ed un piccolo palcoscenico destinato alle prove. Le luci di scena sono costituite da un unico riflettore frontale che illumina l’Attore. Inoltre, la sala non è insonorizzata e i rumori delle lezioni di danza provenienti dal piano superiore sono piuttosto fastidiosi. Nasce così il gruppo “The Cassavetes-Lane Drama Workshop”.
La gestione del “laboratorio” non è semplice e, soprattutto, con responsabilità burocratiche ed economiche che Lane deve affrontare e risolvere. Cassavetes, Attore di successo e popolare, è seguito con grande interesse dai giovani che sperano di intraprendere una futura carriera artistica ricca di promesse e sbocchi professionali. John, si occupa degli Allievi-Attori che hanno già avuto qualche esperienza teatrale e imposta il suo metodo di insegnamento sulla naturalezza della recitazione, sulla capacità di entrare in sintonia con le caratteristiche del personaggio da interpretare cercando di rendere reali le emozioni provate e di viverle in prima persona. Inoltre, unica nota in comune con l’Actors Studios, sviluppa negli Allievi la capacità personale che ognuno di loro possiede nell’improvvisazione per approfondire ed esplorare un testo.
John, molte volte, deve assentarsi per impegni di lavoro lasciando la gestione del “laboratorio” ad alcuni Allievi più preparati e disposti ad insegnare ai principianti. Con il passare del tempo questo modo di agire di Cassavetes provoca malumori ed incertezze negli stessi Allievi che restano delusi anche dalle varie promesse di lavoro, purtroppo, mai realizzate.

Ormai, nella mente di John è da parecchio tempo che si sta formando il desiderio di diventare un Regista Indipendente, lontano dagli schemi adottati da Hollywood che non accetta e che disprezza fortemente. Il “metodo” Strasberg, proposto dagli Studios, rappresenta la recitazione seria, sofferta e scrupolosa che l’Attore deve seguire per immergersi nel carattere del personaggio da interpretare. Se per Strasberg il Teatro rappresenta una “chiesa”, per Cassavetes assomiglia ad un “parco giochi”. Due filosofie opposte dove la recitazione degli Studios è improntata alla sofferenza, e all’elaborazione del pensiero nell’esistenza triste della vita, mentre per John si trasforma in un’esplosione di gioia e incontenibile esuberanza.
Un’ulteriore differenza tra la filosofia di Strasberg e del “laboratorio” è spiegata da Lane ad un intervistatore nel 1958 sostenendo che il “metodo” utilizzato si focalizza sulle “emozioni di base” che tolgono la “maschera” ai personaggi privandoli della loro personalità. Sostiene, inoltre, che gli Attori che si concentrano solamente sulle loro capacità non riescano ad interagire con gli altri sul palco, poiché la maggior parte dei conflitti drammatici dipende, quasi sempre, dal tentativo dei singoli personaggi di vedere dietro la “maschera” indossata dagli altri.
Cassavetes ama ogni forma di libertà espressiva che gli permetta di mettere a nudo le proprie emozioni e i sentimenti più sinceri della sua anima. Il suo massimo desiderio è quello di essere in grado di controllare il completo processo creativo e produttivo di un film e potere elaborare in un’opera cinematografica la sua struttura narrativa, senza costrizioni dettate da leggi di mercato. È un “sogno” che Cassavetes vuole realizzare e rendere “reale”. Il “laboratorio” gli permette di incontrare tante persone che amano recitare e questa è un’occasione importante per cercare gli Allievi-Attori giusti da inserire in un film.
Gli Allievi cercano più volte di convincere John a trovare un lavoro per loro e ad instradarli nella lunga e difficile carriera dell’Attore. Nel gennaio del 1957, dopo varie promesse disattese, Cassavetes, coglie l’occasione per fare il “misterioso”, un atteggiamento che gli riesce molto naturale, e decide, durante una pausa delle lezioni, di sussurrare, all’orecchio di alcuni Allievi-Attori da lui scelti, un appuntamento per le tre del pomeriggio della domenica successiva per una “sessione speciale”.
In precedenza, non si sono mai verificati appuntamenti domenicali e, quindi, gli Allievi interpellati sono molto incuriositi da questo incontro inusuale. Naturalmente, alcuni Allievi pongono delle domande alle quali Cassavetes non risponde limitandosi a descrivere, con minuziosi particolari, una scena molto complessa. Poiché gli Allievi-Attori recitano con il proprio nome si decide di mantenerlo anche per i personaggi descritti nella scena. Cassavetes descrive la scena che fa riferimento ad una famiglia afroamericana composta da due fratelli e una sorella che vivono in un modesto appartamento.
La sorella è interpretata da Lelia Goldoni, ha una carnagione chiara e “passa” per bianca. Il fratello minore, anche lui di carnagione chiara, piuttosto indeciso sulla sua identità razziale, è interpretato da Ben Carruthers, mentre il fratello maggiore, chiaramente nero, che desidera diventare cantante è interpretato da Hugh Hurd. Cassavetes chiede ai suoi Allievi di immaginare e sviluppare la situazione che descrive il ritorno a casa della sorella, insieme ad un ragazzo bianco, interpretato da Tony Ray, dopo avere fatto sesso.
Ben è in compagnia di due amici che presto escono di scena mentre entra in casa il fratello nero in compagnia del suo manager, interpretato da Rupert Crosse. A questo punto, Tony Ray si rende conto che Lelia è una ragazza nera. Cassavetes chiede agli Allievi di improvvisare la situazione creatasi specialmente dopo che Ben ha salutato Lelia dicendole “Ciao, sorella!”, dando origine ad un’atmosfera piuttosto tesa. Cassavetes sceglie questo tipo di scena affinché gli Allievi-attori possano avere modo di reagire emotivamente attraverso un’improvvisazione credibile che possa, eventualmente, fare parte di un futuro film. L’entusiasmo dei giovani Attori sviluppa il sogno di Cassavetes di trasformarsi in un Regista indipendente, lontano dal mondo di Hollywood, con la possibilità di produrre un film usando metodi diversi da quelli che lui stesso aveva sperimentato nelle vesti di Attore. Questa “improvvisazione” richiesta agli Allievi-Attori pone le basi per la realizzazione del primo film di Cassavetes: “Shadows” (Ombre).
ANALISI DELLA PRIMA OPERA
“Shadows” (Ombre) – 1959 – Durata: 79’
Il 13 gennaio 1957, in un loft di New York, Cassavetes pone le basi per la realizzazione del suo primo film. Con grande entusiasmo cerca nei volti dei suoi Allievi i personaggi che faranno parte del film che sta elaborando. Dopo vari esperimenti e qualche cambiamento riesce ad ottenere Attori credibili, capaci di improvvisare situazioni che ognuno di loro dovrà interpretare nel modo più naturale possibile. John è convinto che si possa realizzare un film con costi molto contenuti utilizzando il passo ridotto 16mm, la cui pellicola può dare buoni risultati. John riesce a coinvolgere nel progetto l’operatore Erich Kollmar che ha da poco terminato un documentario girato in Africa.
In breve tempo rilascia un’intervista al New York Times sostenendo che il film che vuole produrre non ha scopi di “profitto” e tratta il “problema bianchi-negri”. Per realizzare questo progetto dovrebbero bastare 7.500 dollari. Purtroppo, questa intervista non porta ad alcun valido risultato finanziario e Cassavetes cerca di sfruttare un’altra occasione facendosi ospitare da Jean Shepherd, conduttore di un Talk Show radiofonico, per ringraziarlo di avere parlato della sua ultima interpretazione nel film “Nel fango della periferia”.
Durante la trasmissione radiofonica Cassavetes chiede al conduttore: “Non sarebbe fantastico se fossero le persone a fare bei film, invece degli alti papaveri di Hollywood che si interessano solo al business, degli incassi e così via?”. Jean Shepherd, chiede a John se è in grado di raccogliere i fondi necessari per la produzione di un film. La risposta di Cassavetes non di fa attendere: “Se le persone vogliono davvero vedere un film sulle persone dovrebbero versare un contributo in denaro”. Nel giro di una settimana le offerte in denaro raggiungono i 2.500 dollari.
Shepherd, nei due anni successivi, visita varie volte il “laboratorio” di Cassavetes e tiene informati i suoi ascoltatori sui progressi del “loro film”. Anche Sam Shaw si adopera per fare affluire nuovi contributi da persone facoltose, convinte dell’interessante progetto di John. Shaw, inoltre, ottiene da Spyros Skouras, proprietario del Delux Film Labs, di fornire la pellicola cinematografica necessaria e di usare il suo laboratorio per lo sviluppo. L’attrezzatura per filmare in 16mm, in parte, è affittata e in parte presa in prestito. L’operatore Erich Kollmar fornisce la propria cinepresa Arriflex.
“Shadows” (Ombre), è un film molto particolare che non nasce da una vera sceneggiatura ma si alimenta di situazioni improvvisate che crescono nel tempo attraverso incontri e discussioni che i protagonisti elaborano in una realtà reale. L’abilità e il coraggio di Cassavetes di filmare la realtà, di cogliere nei primi piani dei volti le espressioni realmente vissute in prima persona, crea un nuovo linguaggio filmico non più basato su quanto stabilito a tavolino ma in continua evoluzione con il progredire della trama.
Un Cinema nuovo che si ispira al neorealismo italiano e in particolare a Rossellini dove la sceneggiatura è posta in secondo piano mentre l’interpretazione è determinante nella creazione e credibilità dei personaggi. Una trama architettata in modo intelligente, dove ogni Attore è protagonista di sé stesso e la gestualità è il complemento necessario all’espressione della parola.
Tre fratelli afroamericani vivono a Manhattan. Lelia, di carnagione chiara, vuole fare la scrittrice mentre Ben, anche lui di carnagione chiara, tenta di superare il disagio di essere di colore. Hugh è un nero autentico che cerca la sua strada come cantante jazz. Nella stesura della trama, per giustificare la loro convivenza nello stesso appartamento, i tre personaggi decidono che i loro genitori sono morti. Cassavetes, propone agli Attori principali di approfondire il rapporto tra loro cercando di creare una “famiglia” anche fuori dalla scena per rendere più convincente la loro interpretazione. Lelia è già intima di Ben, che sposerà sei mesi più tardi, mentre è considerata da Hugh proprio come una “sorella minore”.
I tre fratelli hanno difficoltà nell’integrazione sociale. Lelia dopo un’avventura umiliante con un ragazzo “bianco” accetta la corte di un giovane della sua razza. Ben, dopo avere frequentato un gruppo di sbandati decide di condurre una vita più tranquilla. Hugh, invece, trova nella carriera di cantante il vero scopo della sua vita.
Le scene di “Ombre” sono tutte piuttosto semplici e basate sui problemi dei personaggi che sono superati dal sopraggiungere di altri problemi. L’improvvisazione degli Attori crea i personaggi che si modificano in base alle idee che Cassavetes suggerisce fino a dare vita alla struttura delle diverse scene. Un lavoro paziente e meticoloso che mette a dura prova la capacità espressiva dei singoli Attori che devono capire quando restare zitti ed accettare istanti di pausa che devono scomparire nel momento in cui il personaggio deve agire attraverso l’improvvisazione. Affinché le azioni e la recitazione possano risultare naturali e reali, Cassavetes, più volte dichiara di fare una “prova” della scena, mentre all’operatore ordina di girarla interamente.
Le riprese del film iniziate a fine febbraio terminano a metà del mese di maggio 1957 ma per il montaggio del film ci sono voluti più di diciotto mesi! Dopo meno di due anni dall’inizio delle riprese “Ombre”, finalmente, è pronto per essere proiettato. Shepherd annuncia alla radio che ci saranno tre proiezioni di mezzanotte gratuite al Paris Theater. Le proiezioni si rivelano molto scadenti per un pessimo sonoro e deludenti per un’affluenza inferiore alle cento persone per spettacolo. Inoltre, ciò che aumenta la gravità del momento è l’uscita di parte del pubblico prima che il film termini. Cassavetes cerca di discutere con il pubblico rimasto in sala e si accorge che, effettivamente, ci sono alcuni problemi riguardanti la struttura narrativa e anche problemi di stile. Questi “incontri” con il pubblico fanno riflettere John che si accorge di avere realizzato un film intellettuale lasciandosi affascinare dalla ricerca di belle inquadrature e dalla sperimentazione di particolari riprese inconcludenti. Anche se il film ha un buon ritmo ciò che manca è il rapporto con le persone. Questo determina un minore interesse da parte del pubblico per i personaggi che devono essere sempre al “centro” del racconto creando continue emozioni nello sviluppo dei sentimenti. Un film ricco di “virtuosismi cinematografici, di angolazioni ricercate che però mette in evidenza la debolezza dei personaggi e la mancanza di una vera e propria struttura narrativa che elimini l’incoerenza nello sviluppo dei personaggi.
Il film è costato circa 25.000 dollari molto più di un terzo di ciò che era stato preventivato! L’aumento dei costi è dovuto all’inesperienza di Cassavetes e a spese che si sono rivelate ingiustificate ai fini della realizzazione cinematografica dell’opera. John, conscio degli errori fatti e seguendo le giuste critiche dei suoi produttori Maurice McEndree e Seymour Cassel, che nonostante la loro rinnovata fiducia nel giovane Regista gli ricordano di essere “… comunque un dilettante”, decide di rigirare il film.
Un fatto tragico e grave come la morte del fratello maggiore Nick, nel febbraio del 1958, aumenta la determinatezza in Cassavetes di realizzare una nuova versione di “Ombre”. John è sempre stato molto affezionato a Nick e la morte del giovane trentenne lo obbliga a riflettere sulla possibile brevità della vita e, quindi, sulla necessità di impiegare al meglio il proprio tempo disponibile. Purtroppo, i problemi finanziari non mancano e John è costretto a chiedere soldi a tutti, anche ai genitori di sua moglie e a sua madre e a suo padre. Riesce a raccogliere circa 10.000 dollari e, quindi, nella primavera del 1959 iniziano le nuove riprese. John, per problemi economici, è costretto ad accettare, dalla Universal Picture, di interpretare una serie televisiva, di carattere poliziesco, intitolata Johnny Staccato, di cui curerà anche la regia di cinque puntate.

Cassavetes cerca, nel rifacimento di “Ombre”, di dare una prospettiva differente dalla versione precedente. Le azioni sono vissute da un punto vista degli Attori che sono maggiormente coinvolti nel racconto. Si girano più di diciotto ore di pellicola in quindici giorni. Le espressioni emotive dei personaggi sono esaltate dallo stile utilizzato nelle riprese e questo rende l’opera più rigorosa.
John soddisfatto del lavoro svolto decide di fare ingrandire la nuova versione dal 16mm al 35mm affittandola ad Amos Vogel per essere proiettata alle 19.15 e alle 21.30 dell’11 novembre 1959 in occasione di una Rassegna dal titolo The Cinema of Improvisation, presso il Fashion Industries Auditorium al 225 della Ventiquattresima Strada Ovest. Vogel, convinto della bontà del film, paga al Regista 250 dollari per l’affitto di “Ombre”. Questo è il primo vero guadagno che Cassavetes incassa! Il film ottiene un ottimo successo da un pubblico formato da artisti e critici.
Per lo spettatore di oggi è impossibile dare un “giudizio” sulle due versioni di “Ombre”, poiché, Cassavetes, dopo avere tenuto per tanti anni le copie in un magazzino, negli anni ’80, stanco di pagare l’affitto del locale, decide di buttare in una discarica la prima versione dell’opera. Dopo alcuni decenni Ray Carney, studioso di Cassavetes ed autore del libro JOHN CASSAVETES UN’AUTOBIOGRAFIA POSTUMA (Ediz. minimum fax), trova, casualmente in una bancarella di “oggetti ritrovati”, l’unica copia completa della prima versione di “Ombre” che, purtroppo, non è stata pubblicata!
Certamente, “Ombre”, segna un nuovo modo di “fare Cinema”, un “Cinema Indipendente”, utilizzando mezzi ridotti per produzioni dai costi contenuti, lontano dalla “macchina hollywoodiana” predisposta alla realizzazione di opere dedicate al business. Se per la parte tecnica utilizzare Hollywood risulta più semplice, certamente, gli Attori non possono avere la possibilità di essere liberi, veri e sinceri nelle emozioni e nei sentimenti, nell’interpretare i vari personaggi poiché sempre sottomessi agli obblighi di produzioni commerciali. Cassavetes ha avuto il coraggio in un momento di grande successo, come Attore di elevato talento, di rifiutare la continuazione della sua carriera per dedicarsi ad un “suo Cinema”, innovativo, libero dai marchingegni economici e capace di comunicare con un proprio pubblico. L’importanza di un primo piano sul volto di un Attore o il movimento della m.d.p per raggiungere l’espressione di un’attrice e/o la sua gestualità sono elementi indispensabili che Cassavetes utilizza per dare forza espressiva alle sue immagini. La rigorosa ricerca di un “montaggio perfetto” obbliga il giovane Regista a montare e rimontare intere scene nella continua ricerca di un racconto dove le immagini prevalgano sull’espressività della parola. Un mondo di immagini dedicate alle problematiche umane dando forza espressiva ai personaggi femminili sviluppati, quasi sempre, con la collaborazione di Gena Rowlands, unica moglie del grande Regista innovatore John Cassavetes.
TUTTE LE OPERE DI JOHN CASSAVETES
Ombre (Shadows) (1959)
Blues di mezzanotte (Too Late Blues) (1961)
Gli esclusi (A Child is Waiting) (1963)
Volti (Faces) (1968)
Mariti (Husbands) (1970)
Minnie e Moskowitz (Minnie and Moskowitz) (1972)
Una moglie (A Woman Under the Influence) (1975)
L’assassinio di un allibratore cinese (The Killing of a Chinese Bookie) (1976)
La sera della prima (Opening Night) (1977)
Una notte d’estate (Gloria) (Gloria) (1980)
Love Streams – Scia d’amore (Love Streams) (1984)
Il grande imbroglio (Big Trouble) (1985)
SAGGI
CINEMA E SESSANTOTTO:
BELLOCCHIO, BERTOLUCCI E GLI ALTRI
di Roberto Lasagna
Il Sessantotto diventa la miccia pronta a far esplodere, in Italia più che in ogni altro paese, il conflitto sociale e politico, dopo che l’entusiasmo per la fine della guerra e il benessere del boom economico avevano tenuto a bada un popolo, pronto adesso a ridestarsi e a cogliere motivi di lotte. Il desiderio di cambiamento viene accolto anche dal cinema italiano che racconta l’inquietudine borghese segnalando il conflitto in chiave generazionale. Più in là nel tempo, ”The Dreamers” di Bernardo Bertolucci farà romanticamente ritorno a quel periodo, ma quello che accadde nel Sessantotto viene accolto in anticipo dai segni impressi in un film giovanile dello stesso Bertolucci, “Prima della rivoluzione”, che esce nel 1964, l’anno d’inizio delle rivolte a Berkeley.
Francesco Barilli vi interpreta Fabrizio, che sogna la libertà nell’amore per la giovane zia (Adriana Asti) ed è tormentato dal senso di colpa per non aver salvato il suo miglior amico. Critico nei confronti del PCI, il protagonista del film di Bertolucci si apre con alcuni versi corsari di Pier Paolo Pasolini da “La religione del mio tempo” – «Eppure, Chiesa, ero venuto a te. / Pascal e i Canti del Popolo Greco / tenevo stretti in mano, ardente, come se // il mistero contadino, quieto / e sordo nell’estate del quarantatre» e tratteggia come ogni sogno del protagonista sia destinato a soccombere nella vita borghese a cui si avvierà. Bertolucci vorrà ritornare sui suoi passi regalando il ritratto dei giovani personaggi innocenti, quella dei sognatori attraversati dall’insofferenza, dal desiderio di fuga dal mondo, propria di ”The Dreamers” (2003), dove l’isolamento dovuto all’assenza dei genitori dei gemelli, sarà interrotto dall’irrompere della Storia. Il sasso lanciato contro la loro finestra una notte li ridesterà dal torpore, li assorbirà nel presente trasformandoli in cittadini del Sessantotto condiviso in piazza. Le strade di questi personaggi precipitati nell’auto-isolamento si divideranno e la protesta caratterizzerà i comportamenti di Théo e Isabelle, pronti a lanciare una molotov, mentre Matthew sarà deciso a seguire una rotta differente. L’amore per il cinema, diventa in ”The Dreamers” amore per il Sessantotto e le sue istanze, per la gioventù e le sue spinte. Ma è il film di Marco Bellocchio del 1965, “I Pugni in tasca”, il titolo che scava più nel profondo dell’inquietudine di quegli anni. A quell’epoca, sono i tormenti spirituali e le sicurezze del focolare domestico a spingere il giovane regista di Bobbio ad esordire dietro la macchina da presa con un film intenso e crudele, dove, in una villa sperduta tra i fantasmi della Val Trebbia, cinque vite si addestrano all’infelicità.
Laddove ”The Dreamers” sarà soprattutto un racconto di iniziazione sessuale, poetica e politica, i Pugni in tasca, che non tocca esplicitamente temi politici (essi saranno invece al centro del successivo film di Bellocchio, l’abrasivo La Cina è vicina del 1967), anticipa le tensioni che riguardano il tema della crisi della famiglia, diventando un capitolo fondamentale che il cinema rivolge in quegli anni come reazione alla società dell’epoca. Apprendista ribelle a contatto con le prime significative conseguenze del secondo dopoguerra in Italia, Bellocchio porta in luce una virulenza intellettuale pronta a contestare l’affermazione del potere politico e il soffocamento dei pensieri liberi. Nel suo ritratto di una casa abitata da vite miserabili è dato di cogliere il nucleo dell’accusa alla condizione illusoria del benessere quale slogan imperituro del “boom” economico. Bellocchio indirizza le sue attenzioni al disagio della famiglia, alle malsane situazioni di una simbiosi dove una madre cieca, un fratello minore – affetto da ritardo mentale ed epilessia – ed Augusto, il fratello maggiore cinico che vuole il benessere a tutti i costi, vivono con Giulia, unica sorella legata incestuosamente ad Alessandro, un Lou Castel in quello che resta il suo ruolo più celebre e probabilmente anche il più disturbante della sua singolare carriera. Alessandro cerca di risolvere a suo modo l’insostenibile situazione. Narcisista ed evitante, non sa condurre relazioni al di fuori dei rapporti familiari malati, nati nel grembo di una madre amorevolmente insensibile e dominati da una componente nichilista che affiora in più momenti del racconto. L’ossessione di Alessandro per quel nucleo di amore e di odio, di desiderio e di tormento, lo spinge alla decisione di eliminare i familiari più deboli. La condizione crea un’atmosfera grottesca e patologicamente instabile, dove Bellocchio mostra i quattro fratelli che si ritrovano uniti e al tempo stesso abbandonati nel destino reso ancora più infelice dal confronto con la pretesa normalità del mondo socializzato: uno sguardo che getta una luce di sgomento sui miti e le abitudini della provincia in cui Augusto, il più integrato, vorrebbe trovare una collocazione finalmente appagata. La critica al pensiero dominante è evidente nel folgorante esordio di Bellocchio, ed è come rappresa nel ritratto dell’inquietante personaggio di Alessandro, instabile e sgusciante nella personificazione di Castel che si atteggia a nevrotico Marlon Brando (campeggia anche un’immagine da “Fronte del porto”), facendo il verso ai miti del ribellismo ovvero dileggiandoli per la loro presa fatua sul reale (qui è evidente anche l’affondo contro la fabbrica dei miti di Hollywood). La logica sinistra di Alessandro – che studia di eliminare i rami secchi della famiglia – paventa una sconcertante aura di “normalità”, quella stessa contro cui si scaglieranno i fulgori sessantottini. Paradossalmente, lui dice di volere il bene della famiglia, vuole aiutare Augusto ad essere libero, a poter fare il passo verso l’indipendenza e una vita adulta; inoltre, egli vorrebbe emularlo, creandosi un’indipendenza con un allevamento di polli. Un’integrazione agognata che non conosce freni inibitori e contempla un retro-pensiero pericolosamente funereo. Il film di Bellocchio ci riporta dunque ad una casa di fantasmi, avvolta e occupata da misteriose entità che ne evidenziano l’aspetto cimiteriale: si pensi al ripetuto tragitto casa-cimitero compiuto dai familiari, alla camera ardente allestita per la madre e all’epilogo di Leone, morto-non morto dopo il tentato omicidio da parte di Alessandro nella vasca da bagno. L’abitazione è come un doppio del corpo, prolungamento di chi la abita e sepolcro della perdita d’identità dei protagonisti. In quel periodo i costumi, le culture e persino le istituzioni si avviano verso una rivoluzione radicale degli schemi del vissuto quotidiano e “I pugni in tasca” scuote critica e pubblico perché attacca l’incancrenirsi della corruzione delle relazioni tra le mura domestiche cogliendo la metamorfosi degenerativa in atto.
Alessandro si dimena come il capetto puerile di una protesta che non trova una collocazione in una prospettiva di rivendicazione, simbolo oscuro di una rabbia soffocata da un contesto oppressivo e da quel rapporto destabilizzante di amore/odio che lo tiene legato ai familiari. Il padre e la madre, con le loro autorità, sono sovvertiti, e il nuovo concetto di normalità possiede toni inquietanti. Successive e rivedute letture del film di Bellocchio coglieranno la pretesa liberazione di Alessandro come l’esito di una situazione malata in un contesto a sua volta decrepito. Quindi, una liberazione impossibile. La critica sottolineerà l’aspetto dell’epilessia di Alessandro, di cui soffre anche Leone. Una figura come quella di Alessandro riflette tutta la solitudine, l’inettitudine sveviana, la prigionia dell’uomo nel suo tempo. Nei riguardi dei suoi familiari manifesta un atteggiamento tutt’altro che empatico, sono percepibili in lui stati di vuoto devitalizzato e difficoltà di affrontare gli stati mentali dolorosi, tanto che finge, simula, pensa di poter farla franca ingannando il fratello Augusto dicendogli di aver preso la patente quando in realtà non ha superato l’esame di guida. Incapace di relazionarsi con il mondo esterno (si pensi alla goffaggine della sequenza della festa), Alessandro evidenzia problematiche in tutta una serie di scatti improvvisi, urla, danze e gesti infantili pronti ad enfatizzare l’aspetto di malattia sociale. Probabile che il suo atteggiamento sia dovuto almeno in parte alla percezione degli altri come non disponibili, e la mancanza di rimorso, il rifiuto delle regole sociali e la menzogna come difesa sistematica, così come l’utilizzo a fini strumentali dei fratelli, definiscono la sua anti-socialità. All’opposto, Augusto vive con apparente serenità la sfida del pragmatismo imposto dalla nuova società che sembrerebbe premiare chi risulta a tutti costi “nella norma”. In lui è dato leggere il personaggio più integrato ma anche l’unico che potrà, come Moraldo ne “I vitelloni” (Federico Fellini, 1953), andarsene dalla provincia natia. Mentre Alessandro, così duro, crudele, è il portavoce di morte (della madre e del fratello Leone), dimensione che ai suoi occhi perde drammaticità diventando un avvenimento normale (quella normalità, concetto in voga allora come oggi, che nel film acquisisce un tratto sconcertante), persino igienico, se consente di eliminare la “zavorra”. La morte del protagonista colpito da un accesso mentre ascolta La traviata è l’epitaffio di un film la cui complessità psicologica è rimandata anche da Giulia, la sorella sprovveduta e deviata, attratta da Augusto e al contempo desiderata da Alessandro, per la quale la morte della madre è un motivo di riscatto sessuale, lei così sedotta da comportamenti narcisisti e vanitosi. L’assenza della figura paterna, che destabilizza in modo compromettente le sorti del nucleo domestico, tra amore negato e abbandono, porterà Bellocchio a tornare sul tema in successivi lungometraggi. Il regista riconosce nel puritanesimo provinciale l’ennesima perversione e ipocrisia con cui dovrà fare i conti la società a venire. La macchina da presa si sofferma sui piedi di Alessandro appoggiati sulla bara della madre, profanando la sacra rappresentazione del momento, e persino lo stesso Bellocchio compare inquadrato di spalle, nelle vesti del sacerdote, mentre proferisce strane parole durante il funerale della madre, scomodando Manzoni, latino e dialetto piacentino. E per quanto concerne l’attacco religioso viene immediato pensare a Buñuel per la forza e la dissertazione in ambito politico-borghese.

Pur conservando la sua forza espressiva dirompente, anche “I pugni in tasca” e il suo regista dovranno fare i conti con gli anni a venire, con il riflusso sociale nato alla fine degli anni Settanta, poi esploso nei decenni successivi. Già con “Gli occhi, la bocca” (1982), Bellocchio comincerà a chiedersi perché quelle ribellioni, finanche espressive, stiano confluendo nella rassegnazione delle generazioni successive, nel vuoto lasciato dalla mancanza di un sentimento collettivo, soprattutto in relazione al rinnovamento del linguaggio. Alle inquietudini bellocchiane faranno eco le parole di Olivier Assayas che nel 2012 porterà in concorso alla 69° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia “Aprés Mai”, per rammentare come “La rivoluzione del ’68 ha avuto un risultato estetico, non politico”, ovvero marcando la capacità di destare un fenomeno estetico in grado di propagare il suo effetto duraturo nell’immaginazione di milioni di ragazzi in tutto il mondo, perché proprio i giovani del Sessantotto si sono sentiti finalmente al centro della Storia con tutte le sue contraddizioni. Il cinema allora avrebbe saputo cogliere molte volte i giovani del Sessantotto mentre la memoria cinematografica sarebbe ritornata a quegli anni talvolta con malcelata nostalgia. In questo senso, “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, Premio Un Certain Regard a Cannes nel 2003, è forse l’ultimo film nazional-popolare ad essere animato da uno spirito di intensa adesione, in grado com’è di fotografare molto bene un’epoca con il racconto limpido ed immediato che non nasconde l’intenzione più complessa del regista, desideroso di ritrovare, nel racconto dell’Italia del dopoguerra fino agli anni Novanta, i destini dei due fratelli Carati, Matteo e Nicola, il primo dedito all’esercito, il secondo con la sua grande passione per la psichiatria dopo l’incontro con la giovane Giorgia. Il sessantotto, nel ritratto naif dei giovani capelloni che mettono al riparo i libri delle Biblioteca Nazionale, ha un peso decisivo nel film, come momento le cui implicazioni svolgono quella traccia profonda che legherà il futuro dei protagonisti. Le belle speranze di questa gioventù che sarebbe potuta piacere a Pasolini, e che riverbera luci del suo mondo poetico, prelude all’occupazione studentesca, mentre il set è la Torino del febbraio 1968 dove a breve si intrecceranno le due anime del movimento, quella studentesca e quella operaia di Mirafiori. Nel giro di un paio d’anni, Elio Petri firmerà “La classe operaia va in paradiso” (1971), vetta della rappresentazione più scomoda dell’operaio nella grande industria: al compito di denunciare, Petri sostituisce quello di indagare le contraddizioni di una scena sociale in cui, con i toni allucinati che il film assume, si ritagliano il ruolo di caricature individui come, tra gli altri, lo studente con barbone che ogni giorno contesta davanti ai cancelli della fabbrica e incita i lavoratori a rispondere alla violenza dei padroni con la violenza rivoluzionaria (a chiedere tutto e subito, a scioperare): anche lui come altri scavalca o non considera i problemi di sopravvivenza quotidiana dei lavoratori. Personaggi descritti con ironia, eppure umanamente compresi da Petri, che non li tratteggia con ferocia ma con una certa comprensione.

Petri con il suo atteggiamento fu contestato, così come quando osserva Livia (Mariangela Melato), la compagna del protagonista Lulù Massa (Gian Maria Volonté), mentre affronta i militanti che le hanno invaso la casa e rivendica il suo diritto ad avere la pelliccia di visone perché, semplicemente, per tutte le fatiche del lavoro dice di meritarsela. La scelta del tono grottesco si unisce al desiderio di mostrare le contraddizioni sociali che plasmano la mente dell’individuo incutendo pensieri e atteggiamenti quali fonti di disagio. Così Petri porta sino in fondo la sua visione critica della società che non assiste né il lavoratore né la vita personale del medesimo. L’assioma è ribadito dall’anziano Militina, un tempo compagno di fabbrica ora ricoverato in manicomio, che saluta il vecchio amico Lulù ricordandogli che adesso “è come la fabbrica, solo che alla sera non mi lasciano uscire” e si conceda augurando “buona permanenza” allo stralunato compare. L’incidente a causa del quale Lulù perde il dito, assieme all’incontro con Militina, apre gli occhi all’operaio, che inizierà a lavorare con lentezza e sarà sottoposto a un test da parte dello psicologo dell’azienda durante il quale Petri denuncia come la psicologia scientifica, in quel contesto, abbia assunto un ruolo strumentale alla conservazione di un equilibrio sclerotizzato. La visione del periodo disegnata da Petri è anti-retorica e attraversata dal grottesco, sostenuta da un’interpretazione straordinaria del suo interprete principale, anima di un personaggio che con scoramento riconosce la sua condizione quando dice: “io sono una puleggia, io sono una vite, io sono un bullone, io sono una cinghia di trasmissione”. Una visione originale e disincantata, sicuramente scomoda, in cui il personaggio ci appare via via sempre più umano e vittima del suo ruolo, fino a contribuire all’abbandono delle linee da parte degli operai e mostrarsi come l’amara e consapevole vittima dei suoi sogni condizionati. Dove il film di Petri resta un punto fermo imprescindibile della narrazione operaia di quegli anni, “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, con una rapida iperbole, sposta l’attenzione dal Sessantotto agli anni delle successive manifestazioni, per ricordarci come, ancora nel Settantaquattro e oltre, l’onda lunga del Sessantotto è stata a volte sostenuta e a volte disperatamente difesa, perdendosi e sfilacciandosi tra le disillusioni degli anni a venire, contro le pieghe sinistre della nascita del brigatismo, sebbene anche molto tempo dopo le battaglie per i diritti civili, il rinnovamento delle università, la legge Basaglia e le battaglie femministe continueranno a tutelare il volto luminoso della passione civile nonostante le note più buie della Repubblica. La rivoluzione sessantottina come movimento di riappropriazione espressiva oltre che politica, rivive nello spirito autentico della gioventù di quegli anni grazie all’alchimia degli attori de “La meglio gioventù”, mentre il fascino del maggio francese è tratteggiato con passione da Bernardo Bertolucci che attraverso la trasposizione del racconto The Holy Innocents di Gilbert Adair realizza con ”The Dreamers” un omaggio al potere dell’immagine, alla suggestione del racconto cinematografico di quegli anni, dove il ménage a trois dei suoi giovani protagonisti prende avvio dal loro primo incontro nelle sale della Cinématèque Française, quando, a detta del regista in quel periodo: “Ero del tutto plagiato da Godard e dalla Nouvelle Vague […] C’era quasi la dipendenza da quel tipo di cinematografia, dalla Nouvelle Nague ma anche dal cinema di Renoir, Vigo, il cinema francese degli anni Trenta”. E i tre ragazzi, nell’abitazione borghese, discutono d’amore, di politica, ma soprattutto di cinema. Bertolucci ci regala così anche la sensazione che parlare di cinema, e parlarne con la consapevolezza di una rivoluzione in atto, sia anch’esso un fatto sessantottino, che riverbera la sua luce sin da quegli anni.
Mentre per Bertolucci ripensare il Sessantotto significherà, letteralmente, rivederlo attraverso i suo film, in Francia Philipp Garrel tornerà, con “Les amants réguliers” (2005), alle modalità di riprese del maggio 1968, quando realizzò un cortometraggio di tre minuti, Actua I, notiziario sulle agitazioni di cui il nuovo film riprende le medesime inquadrature con l’intendo di recuperare anche lo sguardo fedele del momento per limitare le distorsioni della memoria. Ma è indubbiamente Jean-Luc Godard ad anticipare più compiutamente i fermenti sessantottini: “La cinese” (1967), con Anne Wiazemsky presto moglie del regista, coglie un gruppo di giovani rivoluzionari maoisti che si preparano al Sessantotto esattamente come Théo in “The Dreamers”. Parlando di politica, in realtà Godard realizza una riflessione sull’arte cinematografica dove i bagliori del film di Bertolucci trovano alcuni evidenti motivi d’ispirazione: raccontando la vita e il pensiero di cinque ragazzi esposti all’influenza della Rivoluzione Culturale Cinese, Godard li ritrova al cospetto del Partito Comunista Francese e della guerra del Vietnam, pronti a vivere un movimento che li porterà al maggio francese. Le prove di rivoluzione che Veronique (Wiazemsky) e Guillaume (Jean-Pierre Léaud, Antoine Doinel nei film di Truffaut), tentano di pianificare assieme ad altri tre militanti maoisti nella casa di uno di loro mentre i genitori sono in vacanza, è un esempio di tensione in cui privato e pubblico divengono indistinguibili e la grande innovazione formale di Godard si compie nella definizione di personaggi destinati all’espulsione, al suicidio, o a raffigurare nella condizione proletaria lo spirito più autentico della ribellione, per un film che finirà per essere osteggiato in primo luogo proprio dalle autorità cinesi.
L’immaginazione al potere è comunque il grande tema sempre più in primo piano. Anche “Blow-up” (1966) di Michelangelo Antonioni, con il suo protagonista, il fotografo della Swinging London dinanzi al vuoto e alla mancanza di senso, porta sullo schermo la trasformazione della società londinese nel mondo della moda e tra gli studi fotografici, raggiungendo l’utopia dell’immaginazione nella sequenza finale dei mimi che percorrono la città. Film cruciale per un cinema verso la modernità, “Blow-Up” porta a domandarsi come sia possibile rappresentare visivamente il nulla, l’assenza, la non esistenza.
La donna che scompariva ne “L’avventura” (1960) e il deserto urbano nel finale de “L’eclisse” (1962) erano già indizi del progressivo dissolvimento del soggetto nell’universo dell’oggettività. In “Blow-Up” il fotografo Thomas (David Hammings), nella Londra modaiola di fine anni sessanta, è dibattuto tra urgenze neorealiste (le foto che documentano la vita dei senzatetto) e le soluzioni estetizzanti della metropoli, vivendo nevrosi e spersonalizzazione. La percezione soggettiva del fotografo è tutt’uno con quella oggettiva della macchina fotografica e la narrazione di Antonioni, lavorando per sottrazione (nessuno spazio ai sentimenti, al parlato), mette in discussione il concetto di verità, mentre l’ingrandimento fotografico (blow-up, appunto) porta alla luce vari livelli stessi di realtà, ma più si ingrandisce più si arriva al punto in cui la percezione si volatilizza. Il rapporto tra l’essere e il nulla non si ferma alla fotografia ma nel film di Antonioni la riflessione contempla il cinema, la musica, l’architettura. Opera che sarà spunto di tanto cinema moderno e postmoderno, è una visione scettica in cui la finzione degli esseri umani si amplifica fino a destrutturare la realtà. Antonioni continuerà la sua esperienza americana con la MGM e nel 1970 realizza “Zabriskie Point”, portando la sua attenzione alla contestazione americana.
Affresco politico e inno alla libertà, vi si racconta del giovane Mark che dopo aver partecipato a degli scontri in cui forse ha ucciso un agente, ruba un monoplano e fugge verso il deserto, dove incontrerà, proprio allo Zabriskie Point nella Death Valley Californiana, Daria, una ragazza che intrattiene una relazione con uno spregiudicato avvocato. L’omaggio alla stagione appena trascorsa della Summer of Love avviene con la sequenza dell’amore tra i due, orgia lisergica di corpi moltiplicati. Mark sarà ucciso durante un’azione della polizia americana e Daria, una volta ritornata nel lusso della casa con il suo amante, si allontanerà da quel luogo immaginando un’esplosione pulviscolare di oggetti e suppellettili del consumismo, al suono delle musiche – originali – dei Pink Floyd. Un momento altissimo del cinema sessantottino come emblema dell’immaginazione al potere, dopo che il film si era aperto con i volti degli studenti americani in una riunione di un collettivo politico durante il quale uno studente diceva: “La violenza fa parte della nostra cultura, è americana come il chewingum” (in quel momento si discuteva soprattutto il ruolo dei bianchi nel proposito di occupare The Black Panthers, movimento nato all’interno della comunità afroamericana). Come noto, sul fronte americano il Sessantotto rappresentò l’evoluzione delle lotte per i diritti civili soprattutto afroamericani, e i temi della contestazione – anti-imperialismo, anti-autoritarismo, anti-militarismo – si esprimono come sottofondo delle note dolci e tristi della canzone “The Sound of Silence” che accompagno il volto del giovane Dustin Hoffman nel famoso avvio de Il laureato, emblematico film diretto da Mike Nichols nel 1967. Nel film compare soltanto un fugace accenno ai manifestanti di Berkley eppure il racconto intercetta l’insofferenza del periodo nell’improvvisa rottura con il passato che lascerà il protagonista sul baratro. Mrs. Robinson (Anna Bancroft) sarà la seducente dama della borghesia pronta a divorare la gioventù fagocitandola nei propri retaggi di conformismo. La ribellione che viene dal cinema USA è un cambiamento di figli disposti a ribellarsi non unicamente alla politica ma anche alle regole di una società con le quali diviene insopportabile la convivenza sin a partire dalla condotta morale. Il tempo della ribellione è palesato in “Alice’s Restaurant” (1969) di Arthur Penn, dove il giovane musicista Alo è talmente innamorato della vita da voler evitare in ogni modo l’arruolamento per il Vietnam, spettro che incombe sulla sua esistenza e su quella dei suoi amici. La commedia di Penn è profonda, attraversata dalla spensieratezza che porterà il nuovo mondo americano alla nascita del movimento hippie fino alla Summer of Love. Toni da commedia anche per “Harold & Maude” (1971), film-gioiellino diretto da Hal Ashby, dove il ragazzino depresso Harold, che trascorre il tempo inscenando finti suicidi dinanzi ad una madre insopportabile, riscopre la voglia di vivere grazie agli insegnamenti e all’amicizia amorosa con la quasi ottantenne Maude, sopravvissuta allo sterminio nazista.
La chiave nera e grottesca attraversa i toni del film di Ashby, che ci regala un esempio di cinema teso a contestare le derive mortifere del conformismo. Infine, due film si stagliano come i più noti affreschi cinematografici della contestazione negli Stati Uniti: il primo, “Fragole e sangue”, diretto nel 1970 da Stuart Hagmann, segue un giovane universitario entrare nella facoltà occupata di San Francisco, dove la tensione culminerà nella sequenza dello sgombero della polizia (Linda, da cui attratto, è nei collettivi che guidano la grande occupazione), mentre i ragazzi inginocchiati in palestra cantano “Give Peace A Chance” di John Lennon e Yoko Ono; il secondo, “Easy Rider – Libertà e paura” (1969), nato da un’idea di Peter Fonda e realizzato da Fonda (alla produzione) con Dennis Hopper (alla regia) – entrambi anche attori e alla guida di motociclette – è l’esaltazione del viaggio come trip, fuga di due hippie che tentano di portare la cocaina nascosta nei serbatoi delle loro motociclette dalla California alla Florida e danno il via ad una libertà insaziabile. Dalla comunità hippie controversa di New Buffalo, alla partecipazione ad una parata di moto senza permesso (finiscono in prigione dove fanno conoscenza con un avvocato di diritti civili alcolista, interpretato da Jack Nicholson che per il suo ruolo ritrova l’entusiasmo per continuare a recitare), alla sosta in un bordello per finire in una visita collettiva in un cimitero dove sperimenteranno le visioni lisergiche dell’LSD, il viaggio lisergico e picaresco compone un film-manifesto come essenza autentica del Sessantotto in chiave di cambiamento e libertà senza condizionamenti. “Easy Rider” sarà il primo film indipendente ad essere distribuito da una major (la Columbia Pictures), sovvertendo l’idea di cosa possa essere un film di successo.
QUESTA VOLTA PARLIAMO DI LINA
di Francesco Saverio Marzaduri
Che Nanni Moretti non nutra simpatie per Lina Wertmüller è cosa nota, come mitizza il conato di bile verdastra di cui l’“alter ego” Michele Apicella, nel primo lungometraggio del cineasta, è vittima solo a pronunciarne il nome (figurarsi di fronte a un accenno di rivalutazione…). E altrettanto nota è la reazione di Nanni “in primis”, quando l’autrice per eccellenza di film dal chilometrico titolo desidera conoscerlo di persona: il poco cavalleresco rifiuto di stringere la mano alla regista, romana ma di remote discendenze svizzere, non sarà mai dimenticato dalla Nostra tanto da rammentarlo, otto anni fa, nell’autobiografia “Tutto a posto e niente in ordine”, riprendendo un altro lavoro della propria produzione. Segno che se il tempo non lenisce mai completamente certe bruciature, il “milieu” cinematografico dispone di talenti, tra alti e bassi, non sempre reciprocamente disposti su registri di empatia.
A onor del vero, la benemerita Lina – all’anagrafe Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich – non avrebbe bisogno di rivendicare torti passati alla storia, e la statuetta onoraria con cui l’Academy ne ha celebrato i quasi sessant’anni di prolifica attività, alternando prodotti in costume, trasposizioni teatrali e fiction (e conciliante con le conseguite 92 primavere), non suona in altro modo se non come riconoscimento appropriato, benché per più d’uno azzardato. La stessa Academy, si sa, è sfera contraddittoria quanto ambigua, che spesso tardivamente premia, quando non trascura di omaggiare firme ben più meritevoli optando per altre d’impronta meno profonda e non sempre destinate a perdurare; in questo caso però si tratta di (rara) scelta coerente, tesa a ricordare che proprio la Wertmüller, quarantatré anni prima, fu la prima donna ad esser candidata per quel “Pasqualino Settebellezze” sarcasticamente dileggiato in “Io sono un autarchico”. Non meno vero, e lo comprova anche la menzione del suo nome in un film di Paul Mazursky, che le qualità registiche di Lina abbiano conosciuto maggiori consensi negli States più che in Italia, dove il successo di botteghino sopperisce a una critica poco incline alla lusinga; e anche se la Wertmüller non gradirebbe che l’episodio con Moretti fosse il primo motivo per cui la si ricordi, tale circostanza, insieme all’Oscar alla carriera, è bastevole a radiografare un’opera in cui lo stile conta più dei risultati, ove gli usi e costumi sociali del decennio Settanta, a base di sovvertimenti politici e mutamenti relazionali si scontrano, ineludibili, con la formula (vincente) della farsa grottesca. Proprio la nostrana commedia iniziava l’amaro “countdown”, non potendo e forse nemmeno volendo più mettere in burla spunti e assetti che la cronaca seguiva e immortalava con marcata accentuazione; sicché il “climax” giovanile del tempo, trovando nel genere in oggetto un nemico dal quale prendere debite distanze, non le mandava a dire verso un’alterazione dei fatti che metteva in burla argomenti delicati attraverso i facili “escamotage” del nudo mercificato o della parolaccia a fior di bocca.
È ovvio che rivedendo il marinaio comunista Giannini alle prese con la “sciura” Melato, e il ribaltamento sessista di ruoli che ne sfata contrapposte classi e ideologie, l’insolito destino nell’azzurro mare d’agosto tuttora costituisca oggetto d’ilarità (cerchiobottista) sulla falsariga d’una nostalgia che il Paese avrebbe oltrepiù involgarito, persino vanificando la grevità d’uno humour eletto a fiero specchio (deformante). E un destino ancor meno insolito, nella combutta tra metalmeccanici che ammiccano a Bertinotti e parrucchiere leghiste, è dato dal rifiuto del pubblico verso una formula riproposta identica nei vezzi. Il che indurrebbe a ritenere come il cinema di Lina Wertmüller, in passato, si elevasse una spanna sopra la confezione di grana grossa così in voga, equivoci e doppi sensi permettendo, per merito d’un indovinato mix d’interpreti, laddove l’occhio dell’autrice sembrava guardare più a un Germi in salsa sbracata che a un Petri più attento all’allegoria, benché non esente da toni urlati ed altrettanto eccessivi e veementi. “Una caratteristica comune – nota Fabio Fulfaro – sono lunghe parti avulse dalla narrazione che non approfondiscono ma ripetono all’infinito il concetto”, e ciò quando non imperversa il tedio. Semmai, quel che induce al sorriso sono colpi bassi piazzati qua e là (si prenda il corpo femminile, all’occorrenza sgraziato e ingigantito a livelli inverosimili), riveriti da un insistito vernacolo coprolalico, a scapito d’idee cui non servono strilli, pesante “pochade” dove l’iperbole – senza rinunciare alla celia – in molti passaggi coglie nel segno (la Trinacria contrappuntata dai nei d’un fregoliano Turi Ferro), avviandosi verso drammatici epiloghi. Tutto il mondo è Paese: così pure la Storia, tra le riposte pieghe dell’Assurdo, funge da teatro dell’umana barbarie e del conseguente orrore, i cui protagonisti, ambiziosi vendicatori o guappetti vigliacchi, si rivelano inermi vittime della situazione di volta in volta al centro; e lo stesso Fato trasforma chi da un lato ambisce a prode leone, pur senza serbarne le caratteristiche, e a potenziale mostro dall’altro, indotto all’infame azione per salvare la pelle (o meglio, ppe’ tira’ a campa’). Luogo feticcio dell’autrice, la Napoli folkloristica popolata da sciantose e camorristi, complice l’atroce esperienza in un campo di concentramento, rimane sostanzialmente la medesima, in peggio, dove la prostituzione è indispensabile “modus operandi” per sopravvivere all’indigenza e ai bombardamenti; amore o anarchia, è tutta erba d’un univoco fascio, per il quale si può rimproverare a Lina un reazionarismo di fondo – qualunquista, si dirà – eppure disperato nel suo grido d’allarme.

L’impressione è però che la visione registica non si spinga oltre il paradigma, arenandosi al citato svolgimento anche in generi successivi quale il “mélo” (ragion per cui l’unica pellicola della Wertmüller girata in America, “La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia”, è un mezzo tonfo), mentre la satira di costume, che annovera la derisione dei miti in celluloide e delle “soap opera”, è un canovaccio ormai trito e vetusto (il trasteverino “Sotto… sotto… strapazzato da anomala passione”, protagonista la futura signora Berlusconi, Veronica Lario). Ciò non significa che la leggerezza di toni non sia nelle corde della Nostra, e, senza snocciolare il dittico di musicarelli interpretati dalla Rita Pavone da lei lanciata sullo schermo, è sufficiente ripensare al televisivo “Il giornalino di Gian Burrasca” a certificare una soavità di tocco che coniuga la pagina al teatro e alla confezione per famiglie. All’infanzia Lina sarebbe tornata nell’adattamento del “best seller” di Marcello D’Orta, anche qui senza rinunciare al parallelo tra Settentrione e Meridione, e a “Il decimo clandestino”, tratto da un racconto di Guareschi e girato a Bologna (per il quale chi scrive fece un’audizione per la scelta del “casting”). Soprattutto l’esordio con “I basilischi”, esplicito debitore dei felliniani vitelloni, ostenta a Minervino Murge la disamina d’una provincia apatica e immobile: la noia o l’occasionale svago la spuntano su pregiudizi, luoghi comuni, rituali irreversibilmente radicati nel proprio essere, rinunciando volentieri a vaghi aneliti d’evasione e maturità esistenziale; un po’ l’inverso, e un po’ no, della Sicilia fotografata una decina d’anni dopo in “Mimì metallurgico ferito nell’onore”. Segno che le notti d’estate (con profilo greco, eccetera) che satireggiano sull’Anonima Sequestri, i complicati intrighi di donne, vicoli e delitti, o il goffo tentativo di trattare l’Hiv, sempre nel solco dell’eccesso, si riducono a poca cosa verso una sensibilità capace di levitare in punta di fioretto, senza giocoforza ricorrere alla sceneggiata.

ADRIAN: IL TEMPO (NON) SE NE VA…
di Francesco Saverio Marzaduri
“Volgare è tutto ciò ch’è fuori tempo. La vita è sempre un fatto musicale.”
ADRIANO CELENTANO
“Io sono l’unico che non è cambiato”, diceva di sé stesso – ieri – il barcaiolo Felice Della Pietà in “Yuppi du”. “Non so perché ho scritto ‘Adrian’”, confessa – oggi – Celentano, “forse perché il tempo sta per scadere”. Nessuno obietta che l’ambizione di puntare alto ed estendere la propria “politique” in sfere inusuali, nella speranza che l’azzardo raggiunga livelli almeno soddisfacenti, venga posta come un’ultima scommessa della vita; e chi conosce l’eterno ragazzo della via Gluck sa molto bene che il concetto di “tempo”, espresso da protagonista in tutti i campi, lo accompagna da oltre sessant’anni di carriera.
“I tempi – nelle sue canzoni, nei suoi film, nelle sue ‘performance’ televisive – (non) rispettano i tempi. In entrambi i sensi. Siano dilatati, ricreati, manipolati; o frenati, bloccati, fermati (in un tempo). In fondo, che cosa rappresenta un ‘ralenti’ o un’accelerazione per un regista, o il rock (il funky o il blues…) per un cantante o un musicista, o l’uso delle mille diavolerie di una videocamera per un autore televisivo se non l’illusione di rendere eterni momenti che si considerano magici, fantastici, irripetibili? Allungare o restringere l’attimo fuggente: questo è il sogno segreto di ciascun artista. Che solo la finzione, la magia di una parola accompagnata da una nota, una finta realtà come la televisione possono offrire. E in cambio solo di un’ispirazione.”[1]
Ma il tempo – quello reale della vita – pare essersi arenato pure per il coerente (nel suo essere contraddittorio) “showman”. “È stato il primo, ben trent’anni fa, a parlare di smog, ambiente e cemento armato”, esclama Piero Chiambretti in presenza del Celebre, “fatti pagare i diritti d’autore, meriti anche un Nobel per la pace”. Nell’inoltrato 2020, però, l’odierno pubblico non s’accontenta più di prediche sociali che abbracciano tutto (e niente), messe insieme alla rinfusa e declamate come proiettili sparati a spaglio nella speranza di colpire un bersaglio specifico: le menti pensanti. Le reti informative di telecomunicazione e di servizio, nella fattispecie il web, sembrano aver frenato, centuplicandola, la diffusione dei guru mediatici, offrendo alternative di pensiero nell’elaborazione d’idee, preconcetti, (pseudo)ragionamenti. Il recente caso della giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, contro il cambiamento climatico e in difesa di uno sviluppo sostenibile, restituisce peraltro la volontà delle neo-generazioni, tenera e sorprendente, di scendere personalmente in campo e all’occorrenza pagar di tasca propria il contributo solidale. Altre sono le strade, e il prototipo del Re degli Ignoranti – per quanto l’ironico Chiambretti lo definisca l’antenato della citata Greta – testimonia una fede in linea con un’immagine e uno “showbiz” già sorpassati. L’ambizione è rock, l’esito lento; ma il Nostro appare più lento che Molleggiato.
“Lei è fuori tempo, amico: oggi il mondo è cambiato!”, intimava Tina Foster (Claudia Mori), caporedattrice dell’immaginario Corriere dell’Est, al predicatore Joan Lui nel film omonimo, il quarto ed ultimo diretto da Celentano; solo che era l’85 quando il costoso “kolossal” pseudoevangelico – valutato come uno dei più clamorosi tonfi al botteghino, oltreché prodotto tra i più sfrontatamente megalomani del nostro cinema – protendeva le furbesche mani inserendo la figura d’una detrattrice contraria al perbenismo, all’ecologia e agli argomenti scontati di chi li professa. Sicché non ci sarebbe da stupirsi se “Adrian” fosse interpretabile come qualcosa a mezza via tra la più sfrontata presunzione e la “boutade”, sincera a suo modo ma non priva di calcolati cerchiobottismi: fedele al “modus operandi” di una lunga ed eclettica attività artistica, il non meno dispendioso “serial” animato targato Clan mischia e rimescola le carte in tavola nei modi più disparati (e disperati) sbalordendo o irritando, tra citazioni e rimandi che si susseguono, qualche sprazzo di originalità e tanta eccentricità. Fatto sta che l’universo che da mezzo secolo contraddistingue la “naïveté” di Adriano, infarcita oltre misura di tiritere eco-evangelico-pauperistiche già all’epoca in odore di ridondanza, oggi lascia il tempo che trova e poco serve alle leve emergenti, abituate a ben diverse esemplarità a rischio d’assuefazione; e il miracolo nel passaggio dal grande al piccolo schermo, dai pulpiti di “Fantastico 8” alle tempeste di “Rockpolitik”, a lungo andare dissipa la magia senza conferire al suo ideatore quel lembo di (saggia) umiltà che navigati artisti sovente acquisiscono una volta raggiunti e superati certi traguardi. Proprio quel Fittante che anni fa dedicò una monografia, completa e appassionata, alla produzione di Celentano tra musica, cinema e televisione, scrive che l’operazione “rischia di trasformarsi in una di quelle “soap” spagnole – tanto amate da Mediaset – che da qualche stagione fanno una serrata concorrenza ai sonniferi”. Il giochino è già svelato (e, perché no?, sventrato): a cominciare dal reale protagonista, per l’appunto il tempo, che proietta la vicenda in un immaginifico 2068 – un secolo esatto dopo “Azzurro” – scandito da un enigmatico mega-ingranaggio. A rifletterci, “Adrian” non è che una trasposizione animata del “Mondo in Mi 7a” (e chissà di quant’altri brani, o “robe”, del Celebre): una caccia al tesoro – involontaria o meno, non è dato sapere – del Celentano-pensiero “tout court”, in permanente missione per conto di Dio, costantemente zeppo di riferimenti accumulati nella prolifica carriera. A detta della figlia Rosita, secondo cui “Adrian” avrebbe consegnato babbo all’immortalità, il pubblico era troppo impreparato per capirlo, meno ancora si sa se sarà oggetto di rivalutazione; ma anche se non costituisse – e non costituirà, ne siamo certi – l’opera testamentaria del Nostro, come suggerisce la didascalia in chiusura su un sole che spunta all’orizzonte, già costituirebbe una vittoria se in avvenire il palinsesto mattutino, riservato alla fascia infantile, lo annoverasse tra i “format”…
Non è il caso, qui, di spender parole sul programma tv destinato a contenere e reclamizzare l’evento, sospeso dopo quattro puntate nell’inverno dello scorso anno e ripreso il successivo autunno: frutto d’una gestazione durata oltre un decennio (l’idea risale al 2005), per la quale vengono state spese cifre da capogiro, pare dai 20 ai 28 milioni di euro. Annunciato nel 2009 e inizialmente destinato a Sky, “Adrian” è oggetto di continui posticipi a causa dei contrasti tra il Clan e le varie case di produzione scelte per la realizzazione del “cartoon” – il che spinge Sky alla rescissione contrattuale. Le animazioni sono curate da migliaia di disegnatori sparsi in tre continenti, Asia, Africa ed Europa, e comprendono oltre 10.000 scene; della serie sono girati circa 26 segmenti da 22 minuti l’uno, successivamente rimontati in nove puntate sui 55-70’ ciascuna, da trasmettere in nove prime serate. Il prodotto s’avvale di collaborazioni illustri: Milo Manara cura il “character design”; Nicola Piovani, coadiuvato da Celentano, si occupa delle musiche e della colonna sonora; alla sceneggiatura collaborano allievi della scuola “Holden” di Alessandro Baricco, laddove la supervisione dei testi è affidata a quel Vincenzo Cerami venuto a mancare anzitempo (dunque “Adrian” è il primo lavoro postumo a sei anni dalla scomparsa). Ciò non impedisce a inadempienze contrattuali e controversie tra collaboratori – soprattutto con Manara, che si dissocia dall’esito – di metterci lo zampino.
“Soggetto di serie, bibbia letteraria e sceneggiatura di Adriano Celentano”, si legge all’inizio di ogni episodio: per cui qualsivoglia obiezione si muova nella reinterpretazione più o meno apocrifa dei sacri testi (non manca neppure il tradimento dell’Iscariota di turno…), essa risulta screditata dalle arbitrarie scelte di campo dell’autore, il quale da oltre un trentennio è salito sul pulpito di Savonarola. Peccato che la confezione ostenti ancora una volta l’aspetto d’un delirio animato, più che d’una reale visione, con una mastodontica macchina spettacolare in funzione irritante di una paternale che pretende di scuotere le coscienze con argomenti sublimi, e all’occorrenza dirottamenti artistici, ripercorrendo la consueta “bagarre” di luoghi comuni e moralette semplicistiche. Né più né meno la medesima – quasi che il Tempo si fosse arenato già… a suo tempo! – esemplificata da “Joan Lui”, secondo cui gli anni che l’essere umano vive si suppongono i peggiori della storia dell’umanità: nient’altro che un avvenire distopico, fatto di violenza alle donne (“topos” già insito nelle regie cinematografiche di Adriano) e immigrazione, inquinamento e disuguaglianza sociale. Verrebbe voglia di reimpiegare le parole di Giovanni Grazzini, quando stigmatizzava che nulla è più reazionario del far d’ogni erba un fascio: tant’è che la pedestre ideologia del Re degli Ignoranti si risolve nell’ennesimo spettacolo squinternato e qualunquista, che per timore dei “tempi morti” s’inzeppa di rimandi alla cronaca nera italiana, requisitorie da piazza e cicalecci da bar, caroselli e sparatorie, scene catastrofiche e Pavarotti, e – tra un elicottero svolazzante e l’altro – irrinunciabili rimandi all’iconografia sacra (quelle fiamme dell’abisso in cui il cosmo si va incenerendo…). Sostanzialmente, una rilettura più pagana che altro, dove il cattolicesimo, anziché essere intimamente avvertito, sa di plateale maniera. Nonostante l’eccessiva e spesso esasperante lunghezza, “Adrian” serba tuttavia qualcosa d’irresistibile, e al pari dello “junk food” risulta difficile sottrarvisi, più per curiosità che per fascino. Ma il monumentale calderone – pastrocchio anziché “pastiche”, con annessa sorpresa in un’interminabile pletora di prefinali – rimane un prodotto inclassificabile in cui la sensazione è di un quaresimale videoclip animato, naturalmente corredato di inserti musicali e coreografie, dove l’ineludibile “redde rationem” tra il Bene e il Male conta assai meno delle troppe cartucce sparate (e sprecate) nei diversi segmenti. Vista la zavorra da gestire, un guazzabuglio torrenziale in cui singoli ritagli faticano a restituire omogenea unità, i tocchi di trasognata genialità non fanno da collante alla storia, né le conferiscono organicità; non è facile desumerlo ma, si sa, questo è lo straniante stile di Celentano in una produzione che costantemente rimescola il mazzo sino al (voluto?) depistaggio.
La partenza è un’“ouverture” simil-biblica, che a passo ridotto ripercorre la Storia a modo suo, con una voce “off” pomposa e magniloquente: conseguimento dell’umano potere, il consumismo è la causa della distruzione della Bellezza; da Genova a Napoli, da Milano a Ginevra, tutto il mondo è Paese in eguale “unicum”. Imminente, e inevitabile, la fine. Sfilano megalopoli semi-piramidali con immancabile elicottero minaccioso: uno stato di polizia sinistro e violento, corredato di scudi, caschi e manganelli, è costituito da onnipresenti tutori dell’ordine ad ogni angolo. Speculazione e corruzione sono irrinunciabili dogmi, perfino dove c’è lo sport (e una paternale del protagonista annullerà un evento calcistico), le donne facile oggetto di abuso e sopruso, il cibo contaminato e immangiabile (il ragazzino che addenta una mela, secondo il cliché favolistico). Malsana l’atmosfera (e nessuno ancora ipotizza un COVID-19!), bufere d’acqua sporca e schifezze… Sotto un cielo che offre spiragli di splendore a pochi, la società è in mano a una corporazione di oligarchie malavitose ribattezzata Mafia International e in odore di Spectre, legalizzata come un rispettabile marchio di fabbrica (il Capo dei Capi, abbigliato di bianco come il Tony Montana di “Scarface”, si chiama Dranghenstein). E non si può escludere la Chiesa, collusa e consenziente ai loschi traffici in cambio di favori e tornaconti.
Protetto da Anidride e Carbonica, due sagge sensei eternamente giovani nonostante l’avanzata età, il Nostro è un orologiaio (e “Orologiaio” è il soprannome affibbiatogli dai fan), invitato sul palco dall’ossigenato e borioso cantante Johnny Silver nel corso del tradizionale concerto di Capodanno voluto dal potere; la star, ovviamente organica al sistema, lo sfida a cantare, presto pentendosi di avergliene offerto occasione. Si capisce che “Adrian” è una riscrittura aggiornata (si fa per dire) del più volte menzionato “Joan Lui” la cui chiacchierata presenza, armata di chitarra elettrica, spiazzava un turbolento raggio d’azione con un musicato messaggio pacifista – qui speculare all’aiuto concesso dal protagonista a un ragazzo, nel tentativo di conquistare la morosa con due righe (con in sottofondo “Ti penso e cambia il mondo”): “La bellezza non si paga”. L’inevitabile caccia all’uomo, con annesso premio in palio per il ritrovamento del misterioso personaggio, stuzzica la curiosità d’una cricca di “teenager”; sicché Lui si fa passare per “la Volpe”, con fascia nera per gli occhi in stile Zorro, sgomina i nemici a colpi di arti marziali pronunciando bizzarre rime e danzando passi di tango tra una botta e l’altra (e questo, a lungo andare, è l’aspetto più ridondante del “format”). E ancora, per sviare tracce e sospetti, s’inventa una terza identità anagrammando il proprio nome in Darian e nascondendosi dietro una gobba posticcia, una parrucca bianca e un paio di occhiali scuri; un po’ Caronte, un po’ Virgilio (e Virgilio si chiama un prete presente nella storia), fa da traghettatore-guida per canali e sotterranei, benché il travestimento lo apparenti a una Befana – come in tal veste viene chiamato – e Gilda stessa, che inizialmente ne ignora l’identità, lo reputi un fantoccio manovrabile dal potere. Ma si tratta di un’arma ritorta contro chi il paravento lo filosofeggia, e lo pratica, in maniera legale: il pubblico, soprattutto giovane, accoglie il nuovo idolo ballandone il “leitmotiv”, non discute d’altro, si diverte a remixarne la leggenda in discoteca prima di coalizzarsi in una cellula di ribelli al sistema (“E se noi tutti insieme, in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo…”). Nel frattempo, le immagini di Lui sul palco che canta e si dimena svaniscono nel nulla, forse per supremo ordine dall’alto (e l’incredulità dell’“anchorman”, alla notizia che l’intervista a Darian-Adrian è omessa, è un “déjà vu” che rimanda a Tina Foster). Personificato da un governo che sentendosene minacciato ne esige la testa, il Male cerca di sottomettere l’Orologiaio con uno show tv purché non intralci il malaffare; ma Lui rifiuta, a dispetto di Joan che se ne serviva a proprio benefico scopo.
Nel “monstrum” si sprecano fatidiche allusioni all’attualità e alla politica, attuale e passata: si pensi all’incorruttibile onorevole Limonati, avvelenato con una tazza di caffè come Pisciotta e Sindona, e celebrato, in un parlamento analogo a quello della Rivoluzione Francese, con un’ipocrita legge che sa di tripudio per la dipartita. Ce n’è per tutti i gusti: anche per il contenitore televisivo, tacciato di creare morti viventi ignari di esserlo ancor prima della messa in onda, laddove il servizio pubblico che fiuta qualcosa e potrebbe denunciarlo è oggetto di boicottaggio e censura. L’impasto, però, non si premura di nascondere allusioni sin troppo scontate, mostrando i piani alti del potere quale interconnesso racket, alla maniera d’un Partito spia degno di Orwell (e infatti fa capolino il Grande Fratello…); i due ambigui agenti speciali che si fanno rispettare a suon di ceffoni, interrogatori e battute bislacche, prima di passare alla sponda opposta, vestono in nero al pari degli eroi di “Men in Black” (o dei Blues Brothers), e rinviano a “Matrix”. Improbabile, ma non impossibile, che Celentano si rammenti della letteraria Momo, giacché la magica bambina creata da Michael Ende – guarda caso trasposta in un bel lungometraggio animato di Enzo D’Alò – si scontra coi fumosi Signori Grigi, parassiti sovrannaturali dediti a sottrarre il tempo delle persone.
“Il tempo non è bello”, dichiara laconico il protagonista non esattamente rivolto al tempo musicale, la cui insegna declama, a mo’ di salvifica missione, “La bellezza ti salverà”. Una coloratissima grafica, in mezzo a cui ogni tanto s’insinuano spunti pittorici, sposa un montaggio computerizzato a elettroshock condito di sonoro frastornante, tra “ralenti”, stacchi, “zoom” avanti-indietro, e una più che generosa abbondanza di canzoni di Adriano, con una a fungere da “leitmotiv” (“I want to know”, tratta da uno dei vinili da lui prediletti, “Svalutation”). S’accludano fondali apocalittici gremiti di fulmini e disastri, e si assiste al solito straniante e/o straniato show del Molleggiato, dilagante tra una frase a effetto e un motivo musicale, dove la scaletta è presto ridotta a evanescente pretesto: di episodio in episodio, tutto è accentuato sino allo sfinimento, senza temere recidività o il più ovvio didascalismo, e troppe risultano le battute in cui l’intento didattico è tanto ostinatamente ricercato da rientrare nel consueto interrogativo (ci fa o ci è?) sull’autore. E la conferma su annunci a megaschermo che strizzano l’occhio a Godard, diciture esplicative in bella mostra come titoli di testate giornalistiche (tipo “il Nulla”) e al centro la sagoma del Nostro che s’incammina verso l’obiettivo, non potrebbe suonare più palese. Né buoni né cattivi ma semplicemente brutti e innocui, i dialoghi sono così surreali da sfiorare – ardua impresa! – l’umorismo involontario: una riprova si ha quando Adrian, ai piedi del Duomo milanese, spiega a una scolaresca il concetto di “bellezza” prendendo a esempio l’“amico” Leonardo Da Vinci, a sua volta eco dell’ultima apparizione cinematografica di Celentano (l’altrettanto dispendioso quanto fallimentare “Jackpot”, il cui interprete, in un’occasione, si rinominava Leonardo).
Perché, si diceva, “Adrian” è un raccozzo della filosofia semplicistica dell’artista? La via Gluck in cui abita il protagonista – il cui tratto grafico riporta alle scenografie di “125 milioni di caz..te” – è il solo spiraglio rimasto d’incontaminata purezza, nonostante la minaccia di un cielo infuocato, e i popolari Navigli milanesi l’unica parte neorealista d’inalterata pace, speculare a un monumentale grattacielo parlante (forse un albero di trenta piani?), imperante “moloch” che pare uscito dalla matita di Guido Manuli. Il ritorno all’eco(log)ismo è ribadito dalla preferenza riservata alla campagna rispetto alla metropoli, che s’insinua qua e là a mo’ di pausa onirica: fuori città è infatti il casale-rifugio illuminato al tramonto dove Adrian si ritira e amoreggia con la compagna Gilda (col vento che li spettina un po’…), in seguito raggiunto dal canterino Johnny Silver tornatogli amico. Pure, se si esclude la figura d’un giornalista con le sembianze di Gino Santercole, cui la serie è dedicata, non si può non segnalare quanto la fidanzata guerrigliera e un po’ amazzone sia ricalcata su Claudia Mori, e si chiami Gilda come l’insegnante d’inglese da lei impersonata in “Geppo il folle”. Spunta poi un facsimile dello scrittore-alpinista Mauro Corona, ribattezzato Tony, che a un certo momento accoglie l’eroe, colto da temporanea amnesia, sotto la propria ala sui monti (il che riporta alla trasferta sulle nevi dove Geppo recitava il messianico pistolotto).
Lasciamo perdere le reazioni finto-bigotte rivolte alle parentesi scabrose, che vedono il protagonista far l’amore con Gilda, in cui a tratti si ritrova lo spirito delle strisce fumettistiche “adulte”; l’idea stessa di scimmiottare gli “anime” giapponesi apparenta “Adrian” allo “stop-motion” di Corto Maltese, più che di “Akira” o affini. Nell’avveniristica mattana, tra le reminiscenze a iosa (da “L’appartamento” a “Il bacio della donna ragno” e all’immancabile “Via col vento”), spuntano archetipi fantascientifici quali “Metropolis” e “Blade Runner”; e fa capolino Welles nella boccia di vetro con la città linda e pinta in luogo della fattoria sotto la neve. Il riferimento alla carta stampata (l’immaginifica testata “Verità Quotidiana”) fa il paio con quello alle gloriose “stripes”, e un direttore con immancabile sigaro è sulle tracce del neo-Superman. Un magno mare “new age”, che sogna gli addetti agli ingranaggi del tempo mentre biascicano uno stravagante accento francese “à la” Poirot. La forma primeggia sul contenuto, non esiste la retorica se il suono è giusto: ma la conclusione, si diceva, è una “summa” del paradigma-Celentano i cui (troppi) difetti prevaricano sulle (rare) virtù; non basta citarsi addosso riesumando lo spettro del barcaiolo di “Yuppi du”, o canzonare un devoto clericalismo (lo striscione col monito “W il Papa”). Sia pur condensato, il troppo stroppia; e l’ironia, quella vera, latita.
Tanto persistente giunge il superomismo del personaggio – e da un pezzo si sospetta che il bisogno di onnipotenza sfiori la patologia – che, superato lo scoglio, quanto resta è un’impressione di patetica tenerezza: se trentacinque anni prima ci si poteva indignare per la presunzione di egolatria, ora non si può che sorriderne constatando quanto la “politique” del Celebre, convinto che la pubblica ottusità da lui spiegata sia ancora spacciabile per oro colato, s’avviluppi sui medesimi luoghi canonici. Facciamo finta che sia tutto vero, continuando a giocare coi titoli della sua discografia; anche se la situazione non è buona, tanto i mali del secolo dominano incontrastati (corrispettivi all’altra metà del cielo), la palpabile e via via irritante sensazione di autocompiacimento è rimarcata da immagini di Celentano in carne e ossa, durante la tormentata edizione di “Fantastico” condotta nel 1987, commentate da un giovane Enrico Mentana e diffuse da uno schermo al plasma. “È lui che vorrebbe essere come me”, mormora Adrian-Darian, “tra i due quello vero sono io”: e nel confidare a Johnny che l’originale Adriano vorrebbe essere come lui, emerge un addizionale “quid” narcisista che da purificante momento di chiarezza sublima nel vetusto delirio d’onnipotenza. C’è sempre un motivo (per tornare a capire); come l’animato simulacro di un originale non invecchia né muore, ma esplica la scelta di raffigurare tale “alter ego” come il fisico prestante che fu – se non più avvenente – contrapposto all’invecchiamento ostinato e precoce che il Molleggiato da sempre coltiva verso sé stesso, e alla lenta realizzazione dei progetti. Eppure, se nel “cartoon” il pubblico lo prende a modello e continua a seguirne l’indicazione di migliorare il mondo, nella realtà sembra accantonarlo pian piano o, nel caso della serie in oggetto, temporaneamente rifiutarlo. Come per l’eterno Messia con cui si sente in tal confidenza da potervisi identificare, che cade, spira, risorge. E si moltiplica, uno e trino, e tre sono infatti i ruoli che il Nostro si cuce addosso: Adrian, Darian e “la Volpe”. A qualche modello, dopotutto, bisogna pur ispirarsi. Ma laddove Adrian è un solitario, Darian ha molti seguaci, e come Cristo viene fatto prigioniero, senza bramare di evadere, nell’esultanza generale dei fedeli che l’acclamano e gli dedicano fiaccole.
Da lustri il Celentano-personaggio non necessiterebbe di prodursi quale “anchorman” messianico per accattivare il pubblico: il solo cimentarsi in un balletto tanto più disarticolato quanto più in costante equilibrio, o il “parlare” coi silenzi, restano espressioni e indici appartenenti a una tra le maschere in assoluto più vulgate (e rappresentative) del costume nostrano, e da soli valgono l’originale estro di un artista singolare, amabile o trascurabile che sia. Scrive Fittante:
“Corpo dinoccolato capace di ‘performance’ istintivo-musical-eco…iste e volto da scimmia che nemmeno tutte le Cite dell’immaginario collettivo, l’anticonformista divulgatore del rock italico è un po’ artista e un po’ no (come ama definirsi lui), un ‘er più’ dell’ironia, un urlatore che sa anche ridere di sé, un moralista involontariamente troppo sottile e dunque sovente oggetto di bordate che non meriterebbe.”[2]
Quand’anche coi silenzi e il proprio “analfabetismo” lo “showman” sembra non aver nulla da dire in apparenza, osserva Michele Serra:
“Nei suoi momenti migliori (non pochi), nelle sue possessioni più misteriose (a volte parla l’italiano come l’indemoniato il sanscrito), Celentano ha sempre saputo violare ampiamente i confini della propria macchietta. Quando è in forma ragiona come uno degli eroi rurali (e democratici) di Mark Twain, demolitori dell’ipocrisia classista e del perbenismo dei piccoloborghesi urbanizzati. Quando è fuori forma è anche meglio, una specie di ‘fool’ afasico, ingovernabile, imbarazzante, che abbiamo visto esposto nella gogna del sabato televisivo come il ‘monstrum’ in cattività, memoria vivente dello spavento da cui tutti veniamo – la fame, il freddo, la paura, la boscaglia… – eppure, dignitosissimo, sempre, come chi non deve fingere, e si sente benone nei suoi panni.”[3]
Nessuno dubita che Adriano, nel proporsi come stentoreo Messia, si convinca di ciò che proclama e trasmette al pubblico; eppure, se una parte di Lui risulta gradita perfino a chi non lo ammira, è perché sotto una patina irritante o ciarliera si nasconde un fior di cantante, entrato di forza nelle più riposte tenerezze dell’immaginario collettivo. Che risponde all’appello perché Celentano è un artista – quanto (in)consapevole? – così “fuori tempo”, così senza tempo. Che alla fin fine, come il miglior scacchista professionista, supera la partita d’una vita. Conclude Gino Castaldo:
“Se tutti perdonano tutto al Celentano dei monologhi è perché sotto sotto lo amano come cantante. E ai cantanti si concede molto, perché li si ritiene capaci di regalarci momenti preziosi, perché sono artisti e gli artisti sono per definizione sinceri, a differenza dei politici e degli ‘opinion leader’ . Dice cose su cui non siamo d’accordo? Pazienza, è il suo modo di pensare. Tanto poi attacca ‘Azzurro’ , e su questo siamo tutti d’accordo.”[4]
[1] FITTANTE, Aldo: Questa è la storia… – Celentano nella musica, nel cinema e in televisione. Milano, Il Castoro, 1997. Pagg. 71-72.
[2] FITTANTE: Sottovalutation. Contenuto in: “Duel”, n. 18, ottobre 1994. Pag. 71.
[3] SERRA, Michele: Tanto nessuno è come lui. Contenuto in: “La Repubblica”, 02/11/1997. Pag. 31.
[4] CASTALDO, Gino: Ma la musica trionfa sull’invettiva. Contenuto in: “La Repubblica”, 22/10/1999. Pag. 50.
“CARO DOMANI” DI MARIANTONIA AVATI
di Roberto Baldassarre
La prima puntata della soap opera andò in onda il 18 gennaio 1999, e veniva programmata dal lunedì al venerdì tre volte al giorno (11:30; 19:15; 23:00). Complessivamente furono realizzati 180 episodi (90 nella prima stagione e 90 nella seconda) e la durata di ogni episodio era di circa 24 minuti. Il costo di produzione di ogni episodio si aggirava sui 30 milioni di lire, ossia un’inezia rispetto alle produzioni similari tipo “Un posto al sole”.
Il titolo, semplice e conciso, è stato scelto perché rimarca la speranza per un domani migliore, e i titoli di testa mostrano sempre la matura protagonista Bianca (Angiola Baggi) sfogliare, con fare nostalgico, un album di vecchie foto di famiglia. Questo sì un marcato momento avatiano, cioè lo sguardo malinconico ai ricordi. La storia di “Caro Domani” è prettamente femminile, essendo incentrato su un piccolo pensionato a gestione familiare (la cui proprietaria è Bianca), in cui vivono tre ragazze. Gli uomini sono figure esterne, legate per amicizia o per amore ai personaggi femminili. Per tanto, “Caro domani” è un microcosmo di vite umane comuni, in cui gli spettatori (giovani o anziani) possono riconoscersi e provare finanche empatia. Ecco come si espressero gli autori sul perché vollero raccontare questo tipo di spaccato: «Siamo stufi di un mondo giovanile visto sempre come senza speranze, senza progetti. In “Caro domani” non ci sono storie pazzesche e mirabolanti, ma avventure di tutti i giorni: lo studio, la famiglia, il lavoro» (Tommaso Avati, La Repubblica, 14 gennaio 1999). Molto probabilmente Avati si riferisce a pellicole e libri che raccontano la Generazione X, fenomeno sociale molto presente negli anni Novanta. Basterebbe pensare che uno dei film italiani di maggior successo della seconda metà degli anni Novanta è stato “Tutti giù per terra” (1997) di Davide Ferrario, tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Culicchia, storia di un ragazzo indeciso sul suo futuro e pessimista nei confronti del mondo che gli sta intorno. In un’altra intervista, Mariantonia Avati aggiunse altri due stimoli che hanno modellato Caro domani: «Abbiamo scelto di ambientare la vicenda in un pensionato perché una mia nonna ne gestiva uno. Anche se mi trovo più a mio agio con i maschi ho voluto che le protagoniste fossero ragazze perché la loro capacità analitica è maggiore» (Mariantonia Avati, La Stampa, 14 gennaio 1999). Quindi, l’idea di un pensionato scaturisce dai ricordi di famiglia, come ha fatto molte volte il padre per le sue sceneggiature, mentre il focus sulle ragazze è dettato da analisi sociali, con piccolissimi accenni di femminismo. Per quanto riguarda le connessioni relazionali che si creano tra ragazzi e ragazze, è sempre la Avati che da le giuste delucidazioni: «Col passare del tempo i rapporti si concretizzano e si rafforzano e il microcosmo femminile ci permette di arrivare al macrocosmo esterno, gli uomini.» (dichiarazione desunta su Ciak marzo 1999). Per tanto, anche se gli uomini restano in secondo piano, lo sguardo dell’autrice indaga anche le figure maschili, rapportandole con il mondo femminile per fare una comparazione. Inoltre “Caro domani”, per poter adempiere alle regole di Sat2000, deve trasmettere con semplicità i valori cattolici, ed è sempre la stessa Avati che spiega come hanno dato forma a questo messaggio: «Nella sceneggiatura i valori cattolici sono nelle piccole cose» (Mariantonia Avati, La Repubblica, 14/01/1999). Perciò la fede viene trasmessa sottotraccia, per mezzo degli atti quotidiani dei personaggi, come se fossero delle parabole.
MARIANTONIA AVATI
Nata a Bologna l’11 luglio 1966, è la primogenita di Pupi Avati, ed esordì nel cinema lavorando al fianco del padre come segretaria d’edizione nel film collettivo “Sposi” (1987), prodotto dalla Duea. Ha poi continuato, lavorando spesso nei film del padre, come supervisore alle sceneggiature, come segretaria d’edizione, come assistente alla regia o nelle vesti di produttrice. “Caro domani” fu il suo esordio dietro la macchina da presa, dirigendo tutti i 180 episodi, mentre il suo primo lungometraggio cinematografico è stato “Per non dimenticarti” (2006).
Questa pellicola, sempre sceneggiata dal fratello Tommaso, è un’altra storia corale femminile ambientata però nell’immediato dopoguerra, e affronta l’emancipazione di alcune donne. La Avati, per questo film, vinse al Magna Graecia Film Festival il premio “Miglior opera prima”. Dal 2006 ad oggi ha ricoperto nuovamente i ruoli precedenti al suo esordio registico. Riguardo a “Caro domani”, e la non facile situazione di essere rampolla di un autore molto importante, la Avati ha rivelato: «Mio padre supervisiona tutto, è un po’ invadente. Ma questo controllo quotidiano mi rassicura. Ho bisogno di consigli, di una guida. Per il resto ho delle idee molto precise ma per quanto riguarda il lavoro mi fido completamente di mio padre» (Mariantonia Avati, La Repubblica, 14 gennaio 1999).
SOAP OPERA IN SALSA ITALIANA
Le radici della soap opera si possono ritrovare alle origini dell’Ottocento, quando cominciarono ad essere pubblicati i romanzi d’appendice, anche conosciuti come feuilleton. Tale tipo di letteratura, dettato da puri motivi commerciali (tenere attaccati i lettori al giornale) consisteva nel pubblicare nei giornali o nelle riviste, usualmente di domenica, un episodio di poche pagine di un romanzo di prossima uscita. Honoré de Balzac ha utilizzato ampiamente questo mezzo come funzionale marketing per le sue corpose opere, come ad esempio l’avventuroso e sentimentale Les miserables (1862). In ambito italiano I promessi sposi, sebbene sia un romanzo storico, contiene tormentate vicende amorose, conflitti, questioni di fede, e attorno alla relazione di Renzo e Lucia c’è un ampio coro di personaggi, facendone un’avvincente soap opera ante litteram. Le basi delle soap opera odierne, che raccolgono l’idea della serialità del feuilleton, trasformando il racconto di poche pagine in pochi minuti (tra i 20 e 40 minuti), si stabiliscono intorno agli anni Trenta. La soap nasce e si espande negli Stati Uniti, e originariamente era solamente radiofonica. Il termine deriva dai prodotti che venivano pubblicizzati (saponi o detersivi), essendo le ascoltatrici un pubblico composto prevalentemente da casalinghe. La prima soap fu “Painted Dreams”, che andò in onda dal 1930 al 1943, e dagli anni Quaranta, ossia dalla nascita della televisione, cominciarono ad essere prodotte “storie d’appendice” anche per il tubo catodico. Altra tipologia di soap è la telenovela, prodotta in America latina e anch’essa inizialmente trasmessa solo via radio. Dagli anni Cinquanta la telenovela passò alla Tv, e il primo prodotto di questo tipo fu la brasiliana “Sua vida me pertence” (1951-1963).
La differenza tra la soap e la telenovela risiede nello svolgimento, perché mentre i prodotti americani tendono a diluire le vicende in infiniti episodi (finché la mannaia dello share non ne decreta la fine), la telenovela ha una durata massima di circa 200 episodi, proprio per non esasperare la storia e non perdere spettatori. Le soap di maggior successo in ambito internazionale, e che hanno forgiato un certo tipo di pubblico italiano, sono: la longeva “Sentieri” (The Guilding Light, 1952-2009); le “aristocratiche” “Dallas” (1978-1991) e “Dinasty” (1981-1989); la suadente e “piccante” “Beautiful” (The Bold and the Beautiful, 1987-presente). Per quanto riguarda le telenovelas più famose, ci sono state: la messicana “Anche i ricchi piangono” (Los ricos también lloran, 1979-1980); la venezuelana “Topazio” (1984-1985); la spagnola “Il segreto” (El secreto de Puente viejo, 2011-2020), che sebbene sia una telenovela, ha seguito svolgimento lungo tipico delle soap americane (2324 puntate). Soap e telenovelas hanno creato anche un forte divismo, fenomeno giunto anche in Italia, dove l’americano Ronn Moss di “Beautiful”, la messicana Verónica Castro o la venezuelana Grecia Colmenares venivano invitate in trasmissioni o premiazioni televisive come fossero star cinematografiche. In ambito italiano le soap e le telenovelas cominciarono a riempire i palinsesti italiani dalla fine degli anni Settanta: i canali regionali acquistavano in blocco telenovelas a buon mercato, mentre Rete 4 ha costruito il suo successo con una fitta programmazione di soap e telenovelas quotidiane, aggiungendovi special inerenti al gossip sugli attori o “analisi” degli episodi. Rete 4 è divenuto il vero punto di riferimento per le massaie o per le donne di servizio, perché era un classico per una casalinga, ad esempio intenta a stirare pile di panni, guardare con trasporto questi “filmoni d’appendice” e provare empatia od odio per i personaggi delle storie. Sulla scia di questo enorme riscontro, anche in Italia, dalla seconda metà degli anni Novanta, si volle tentare questo tipo di serialità, ben diversa da quella dei telefilm o degli sceneggiati fino a quel momento realizzati. Un azzardo produttivo, perché è vero che avevano il terreno ben solcato dopo anni di tali prodotti, e che le soap e le telenovelas raccontavano storie quotidiane, ma essendo “mondi catodici” lontani e affascinanti, gli spettatori italiani si erano affezionati a un determinato tipo di stile di vita. Ad esempio “Beautiful”, per quanto voglia essere realista, è una soap iper patinata, con un cast composto solamente di belle e belli; o la telenovela “Topazio”, che per quanto intrisa di melodramma terminava con un happy end pieno.
Il primo esperimento fu “Un posto al sole” (1996-presente), prima soap ideata, prodotta e ambientata sul suolo italiano, precisamente a Napoli. Fece la sua apparizione sugli schermi di Rai 3 il 21 ottobre 1996, e ogni episodio ha una durata tra i 20 e 25 minuti. Attualmente ha superato 5500 episodi, e a distanza di anni continua a riscuotere successo. La soap è ambientata prevalentemente in un condominio sito a Posillipo, e da questo luogo si dipanano vicende, con personaggi che restano, che vanno o che entrano. Una soap corale, che non racconta solamente le classiche storie rosa (amori e corna), ma ha diversi siparietti comici, getta uno sguardo al sociale, ed entra anche nella sfera della cronaca nera. Questo mix ha creato fidelizzazione negli spettatori, e si è cercato anche di produrre degli Spin Off, che però non hanno ottenuto lo stesso esito di share. L’anno seguente la Rai produsse “In nome della famiglia” (1997), soap che durò una sola stagione, e collezionò un totale di 96 puntate, ognuna della durata di 30 minuti. La prima puntata fu trasmessa il 23 giugno 1997, e questa soap sembra quasi voglia essere una risposta nordica alle vicende meridionali esposte in “Un posto al sole”. Visto il discreto successo che queste prime due soap riscuotevano, la Rai diede il via a “Incantesimo” (1998-2008), soap trasmessa a stagioni alternate da Rai 1 o Rai 2, per un totale di 764 episodi. La prima puntata andò in onda l’8 giugno 1998, e le durate degli episodi erano molto più cinematografiche (la prima stagione durava 100 minuti ad episodio, mentre dalla 2º all’ 8º stagione 50 minuti, e solo l’ultima stagione si aggirava intorno ai 25 minuti). Il nucleo narrativo si svolgeva nella Clinica Life, altro luogo che avrebbe permesso una storia corale con andirivieni di personaggi. Tratto distintivo di “Incantesimo” è che ad ogni stagione cambiavano le coppie di protagonisti. In ordine cronologico c’è poi “Caro domani” (1999-2000), che segue l’idea di ambientare la narrazione in un determinato luogo, in questo caso un pensionato, per consentire un efficace viavai di personaggi, sebbene sia una storia meno affollata. L’ultima soap italiana di fine Novecento è stata “Vivere” (1999-2007), questa volta di produzione Mediaset, che oltre a immergersi in questo nuova “miniera” televisiva, era la pronta risposta alle produzioni Rai fino a quel momento realizzate. La prima puntata andò in onda il 1º marzo 1999, e la durata degli episodi era intorno ai 25 minuti. Le prime 9 stagioni furono trasmesse su Canale 5, e l’ultima su Rete 4, con un totale di 2130 puntate. “Vivere” è quella che ha rifatto maggiormente il verso alle soap americane “aristocratiche”, tipo “Dallas”, “Dinasty” o “Beautiful”, proprio perché erano i serial che avevano fatto la fortuna della Fininvest degli anni Ottanta e Novanta, e quindi il Biscione ha preferito offrire agli spettatori qualcosa di molto simile… in salsa italiana.
PUPI AVATI: STORIE DI NOSTALGIA E DI RAGAZZE (E RAGAZZI)
Durante la produzione e la messa in onda di “Caro domani” Pupi Avati era impegnato con la post-produzione de “La via degli angeli” (1999), e stava preparando il “kolossal” medievale “I cavalieri che fecero l’impresa” (2001). Per tanto, come si inserisce “Caro domani” nella filmografia di Avati? Il primo legame tangibile sono i sopracitati titoli di testa, imperniati sulla nostalgia della protagonista mentre sfoglia un album di vecchie foto; e il secondo legame, desunto dall’intervista di Mariantonia Avati, è dato dallo spunto del pensionato gestito dalla nonna. Moltissime pellicole di Pupi Avati attingono dal passato della famiglia oppure da fatti accaduti anni orsono nella propria città natale, cioè Bologna. Ad esempio il coevo “La via degli angeli”, ambientato negli anni Venti, si basava su aneddoti raccontati dalla madre. Tornando indietro, pellicole come “Una gita scolastica” (1983), “Festa di laurea” (1985), “Storia di ragazze e ragazzi” (1989), “Dichiarazioni d’amore” (1994) e “Il Testimone dello sposo” (1997), sono tutte pellicole che si svolgono nel passato, e ognuna trae suggerimento da un fatto capitato alla sua famiglia; in particolare “Festa di laurea” e “Dichiarazioni d’amore” sono frutto di piccoli avvenimenti occorsi ad Avati quando era adolescente. Dopo “Caro domani” e “La via degli angeli”, sul medesimo solco nostalgico desunto da ricordi familiari, ci saranno “Ma quando arrivano le ragazze?” (2005), “Gli amici del bar Margherita” (2009) e la miniserie televisiva “Un matrimonio” (2013). Altra connessione tra “Caro domani” e il cinema di Pupi Avati riguarda il mondo femminile. Nel cinema di Avati la figura femminile è fondamentale, basterebbe pensare alla devozione “grottesca” di Anteo Pellecani (Ugo Tognazzi) verso la finta Santa Girolama (Delia Boccardo), e persino nel maschile “Regalo di natale” (1986) è presente una donna, presente in un nostalgico, quanto amaro, ricordo. Senza poi addentrarci in ogni pellicola, mettendo in rilievo ogni donna o ragazza presente, per capire quante volte Avati ha affrontato e mostrato il mondo femminile basterebbe scorrere i titoli dei sui film: “Storie di ragazzi e ragazze”, “Fratelli e sorelle” (1991), “La via degli Angeli”; “Ma quando arrivano le ragazze?”, “Il papà di Giovanna” (2008) e “Il cuore grande delle ragazze” (2011). Infine, c’è il legame di Pupi Avati con il mezzo televisivo, avendo realizzato durante la sua lunga carriera differenti progetti per il piccolo schermo, tutti molto personali. Come regista ha realizzato: “Jazz band” (1978), “Cinema!!!” (1979), “Dancing Paradise” (1982), “È proibito ballare” (1989) e “Un matrimonio”. Mentre solo come sceneggiatore la miniserie, dalle atmosfere gotiche, “Voci notturne” (1996) diretto da Fabrizio Laurenti.
SAT2000 (TV2000)
Il canale televisivo SAT2000 iniziò le sue trasmissioni il 9 febbraio 1998, e venne creato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Il nome del canale deriva dal fatto che inizialmente trasmetteva solo via satellite, sebbene alcuni programmi, tramite accordi di syndication con altre reti, erano visibili anche in analogico. Il canale ha cambiato denominazione nell’estate del 2009, durante le scelte direttive di un necessario restyling, prendendo il nome di TV2000. Restyling che riguardava solamente la forma esterna, perché l’obiettivo di questo canale è stato, sin dal suo nascere, quello di poter trasmettere i valori cattolici.
La creazione di questo “particolare” canale va anche percepito come uno spazio cattolico/catodico ritenuto necessario perché sulla Rai e le televisioni generaliste privilegiano in maggioranza programmi ritenuti pochi educativi. La novità di TV2000 è quella di trasmettere il messaggio cattolico senza toni messianici tipo la più longeva Telepace, ma divulgandolo attraverso una programmazione di stampo generalista e dai contenuti didattici. I Tg, i programmi d’intrattenimento o di approfondimento e altri prodotti televisivi tipo telefilm o soap, e finanche pellicole cinematografiche, devono essere mezzi capaci di professare il cattolicesimo. Non a caso, un anno dopo l’inizio delle trasmissioni, fu messa in programmazione “Caro domani”, una soap su ragazze (e ragazzi) comuni che giornalmente scoprono i veri valori della vita. Il problema di TV2000 è lo share, che rimane sempre basso, sotto la soglia dell’1%, e l’unico successo di percentuale d’ascolto l’ottenne solamente quando trasmise la Giornata mondiale delle gioventù 2013, giungendo a un 2,16%.
UN PALCO AL CINEMA.
IL FILM D’OPERA ITALIANO NEGLI ANNI TRENTA-CINQUANTA DEL NOVECENTO – SECONDA PARTE
di Mario Giunco
Pubblichiamo la seconda, ed ultima, parte, del percorso sui “FILMOPERA” effettuato da Mario Giunco.
CARL KOCH (1892 – 1963)
Regista e scrittore, è stato assistente (non accreditato) di Jean Renoir, durante le riprese de “La grande illusione”.
1941 – TOSCA
Regia: Carl Koch. Assistente: Luchino Visconti. Soggetto: Victorien Sardou, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, Alessandro De Stefani (traduttore), Carmine Gallone, Carl Koch, Jean Renoir, Luchino Visconti. Orchestra dell’EIAR diretta da Fernando Previtali. Cast: Imperio Argentina (Magdalena Nilé del Rio), doppiata da Giovanna Scotto (Floria Tosca), Michel Simon (Scarpia), Rossano Brazzi (Mario Cavaradossi), Carla Candiani (marchesa Attavanti), Olga Vittoria Gentili (regina di Napoli), Adriano Rimoldi (Angelotti), Nicolas D. Perchicot (Sciarrone), Juan Calvo (Spoletta), Nicola Maldacea (pittore di Corte), Claudio Ermelli (Paisiello), Enzo Musumeci Greco (ufficiale della regina), Massimo Girotti (Massimo).
Nel 1939 Koch e Renoir iniziarono un adattamento di “Tosca”. L’idea di portare sullo schermo con produttori italiani, tra cui la “Scalera” e la “Era film” di Vittorio Mussolini, il dramma di Sardou per la prima volta con il sonoro – dopo il film muto diretto da Alfredo de Antoni, interpretato da Francesca Bertini nel 1918 – ebbe numerosi cambi di programma. Così Renoir spiegò i suoi intendimenti: “Nonostante i pregi dell’opera di Puccini e di Sardou, credo di aver trovato la possibilità di presentare questo soggetto da un punto di vista diverso: mi sono messo nei panni di un regista di opere poliziesche”. Le riprese iniziarono il 6 maggio 1940, ma, dopo quattro giorni, la dichiarazione di guerra italiana alla Francia costrinse Rénoir al rientro in patria. La lavorazione poté essere riavviata nel settembre 1940, quando arrivò a Roma la nuova interprete, l’attrice e cantante argentino-spagnola Imperio Argentina. Koch sostituì Rénoir nella regia e il nome del francese scomparve dai titoli iniziali e dall’elenco degli sceneggiatori. Gli esterni furono girati quasi tutti di notte, utilizzando ambienti romani resi suggestivi dalle luci cinematografiche. Koch attribuì alla città il ruolo di “prima attrice”. L’interpretazione di Imperio Argentina riscosse scarso apprezzamento. Molti consensi ebbe invece l’attore svizzero Michel Simon. Rossano Brazzi, selezionato personalmente da Rénoir, affrontò uno dei suoi primi ruoli da protagonista.
Il film, considerato dai critici “un’opera in prosa”, ebbe un’accoglienza positiva e un ottimo risultato commerciale (al secondo posto fra gli incassi del 1941, con 12 milioni di lire). “ ‘Tosca’ – scrisse “Cinema” – è uno sforzo produttivo imponente e riuscito. Il regista si dimostra un tecnico eccezionale ed un narratore sensibile”. Adolfo Franci riconobbe che “nonostante cambiamenti e sconvolgimenti il film è riuscito benissimo. Roma antica vi occupa una posizione centrale” . Per “Film” il maggior pregio di “Tosca” è Roma, “fotografata con intelligenza e senso artistico eccezionale”.
CAMILLO MASTROCINQUE (1901-1969)
Visse alcuni anni in Francia, dove lavorò come scenografo. Tornato in Italia, esordì dietro la macchina da presa nel 1937 con “Regina della Scala”. Diresse più di sessanta film, privilegiando il genere comico.
1936 – REGINA DELLA SCALA
Regia: Guido Salvini e Camillo Mastrocinque. Musiche aggiunte di Pietro Mascagni, cantate dal tenore Galliano Masini. Cast: Margherita Carosio Marta Bianchi), Nives Poli (Arianna, ballerina), Giuseppe Addobbati (Guido Vernieri), Mario Ferrari (Candido Ponti), Olivia Fried (Olivia Ferry), Osvaldo Valenti.
Storia d’amore fra un musicista e una cantante debuttante. Tra mille difficoltà, anche di carattere sentimentale, il compositore riesce a far rappresentare una sua opera alla Scala. Intorno alla vicenda si svolgono episodi rievocativi delle glorie del celebre teatro.
I critici lodarono la regia per la parte relativa alla Scala.
1940 – DON PASQUALE
Regia: Camillo Mastrocinque. Cast: Armando Falconi (don Pasquale), Laura Solari (Norina – Sofronia), Maurizio D’Ancora (Ernesto), Greta Gonda (Arianna), Franco Coop (dottor Malatesta).
Adattamento dell’omonima opera di Donizetti, che deride l’amore senile con un fondo di malinconia: “Ben è scemo di cervello / chi s’ammoglia in vecchia età / va a cercar col campanello / noie e doglie in quantità”. Fa parte della selezione italiana alla Mostra del Cinema di Venezia del 1940. Gli interpreti non cantano e la musica del compositore bergamasco è presente come colonna sonora, nell’adattamento di Alessandro Cicognini. Rispetto alla vicenda originale sono inseriti episodi aggiuntivi. Tra gli sceneggiatori, a fianco del regista e di Alessandro De Stefani, due futuri registi: Gianni Puccini e Giuseppe De Santis. Gli esterni sono realizzati a Roma, in piazza Navona, Campo de’ Fiori, Villa Sciarra e in alcune ville storiche nei dintorni della città.
Il film fu presentato in una sala vicino a piazza San Marco il 7 settembre 1940, prima di aver ottenuto il visto di censura. Circostanza, questa, che non pregiudicò l’apprezzamento della critica. Il futuro regista Michelangelo Antonioni scrisse: “Con pulita ed educata regia Mastrocinque sfrutta tutto il fascino del bisbetico personaggio e della musica donizettiana. La quale nondimeno entra nel lavoro come puro e semplice commento, avendo i riduttori evitato l’indegno compromesso (indegno per il cinema e per la musica) che sono i film cosiddetti musicali” (“Cinema”, prima serie, n. 102 del 25 settembre 1940). Ennio Flaiano giudicò il film “agile, scorrevole e melodioso. Mastrocinque sembra aver avuto dei momenti felici ed ha condotto avanti l’avventura con piglio originale e denso di avvenimenti” (“Cine illustrato”, n. 42 del 16 ottobre 1940). Qualche riserva fu espressa da Adolfo Franci: “In un film impostato su un personaggio comico di quella forza, l’invadenza di Falconi è tale e la sua figura prende così largo campo che lo spettatore finisce per seguire lui e lui soltanto” (“L’Illustrazione italiana”, n. 47, 24 novembre 1940).
“Don Pasquale” ebbe un buon successo anche all’estero e contribuì a far conoscere l’attrice Laura Solari.
1941 – RIDI PAGLIACCIO!
Regia: Camillo Mastrocinque. Soggetto e sceneggiatura: Giuseppe Zucca, Camillo Mastrocinque. Musiche: Alessandro Cicognini, Ruggero Leoncavallo (sono stati inseriti solo alcuni brani dell’opera “Pagliacci”). Cast: Fosco Giachetti (Pietro Rinaldi), Laura Solari (Anna Alessandri), Otello Toso (Giorgio Veri), Elli Parvo (amante di Giorgio), Giulio Donadio (commissario), Paolo Carlini.
La vicenda ha scarsi riferimenti con l’opera di Leoncavallo. Finita in prigione per difendere un collega, la protagonista, una volta uscita, scopre che il suo uomo si è fidanzato con un’altra donna. E’ salvata dal suicidio da un acrobata circense, di cui s’innamora.
Così si esprime la critica: “I motivi di facili sentimentalismi ci sono tutti. Mastrocinque ha diretto con impegno e ha saputo trarre fuori, da una materia difficile per intima debolezza, tutto quanto poteva dar risalto ed efficacia al racconto” (Giuseppe Isani in “Cinema”, 10 maggio 1941).
1942 – FEDORA
Regia: Camillo Mastrocinque. Sceneggiatura: Giorgio Pastina, Camillo Mastrocinque. Dal dramma di Victorien Sardou. Musica di Umberto Giordano (nei titoli di testa è chiamato Eccellenza). Cast: Luisa Ferida (Fedora), Amedeo Nazzari (Loris Ipanov/Ivan Petrovic), Osvaldo Valenti (principe Vladimiro Yaryskine), Rina Morelli (Olga Soukarev), Memo Benassi (principe Yaryskine padre), Sandro Ruffini (De Sirieux), Cesare Polacco.
Russia, 1870. Il principe Vladimiro è ucciso alla vigilia delle nozze con la principessa Fedora, che giuria di vendicare il promesso sposo. Seguendo le tracce del colpevole, arriva a Parigi, dove si innamora di un pittore, Loris, che è proprio l’assassino che cerca. Da lui Fedora apprende una terribile verità e muore fra le braccia del pittore.
“Bellissimo film di squisita fattura. Mastrocinque, che sembra si sia specializzato nella fedeltà e nella efficacia delle ricostruzioni ottocentesche, dà qui un’altra magnifica prova. Tutto è plausibile, evocativo, a Cinecittà non si pensa. E gli interpreti, muovendosi a loro agio, aggiungono verità alla vicenda” (Mino Doletti, “Film”, n. 47, 21 novembre 1942).
1946 – IL CAVALIERE DEL SOGNO (L’INFERNO DEGLI AMANTI)
Conosciuto anche con il titolo “L’elisir d’amore”.
Regia: Camillo Mastrocinque. Soggetto e sceneggiatura: Vittorio Nino Novarese, Camillo Mastrocinque. Fotografia: Arturo Gallea. Musiche di Alessandro Cicognini, adattate da opere di Donizetti. Orchestra dell’Opera di Roma, diretta da Vincenzo Bellezza. Soprano Angelica Tuccari. Cast: Amedeo Nazzari (Gaetano Donizetti), Mariella Lotti (Luisa di Cerchiara), Mario Ferrari (principe von Wallenburg), Dina Sassoli (Virginia Vasselli Donizetti), Giulio Tomasini (Antonio), Tito Schipa (Gilbert Duprez), Sergio Tofano (Zingarelli).
Il film narra l’amore fra Donizetti e la principessa Luisa di Cerchiara, conosciuta alla Corte di Napoli. Il sogno si realizza quando i due si incontrano in un albergo della Engandina. Poi si rivedono a Bergamo. Il musicista è vedovo, ma Luisa è sposata con un militare austriaco. Nella vicenda si inserisce un episodio patriottico.
“E’ uno dei film più decorosi prodotti in Italia negli ultimi tempi. A Mastrocinque si può fare l’appunto di una certa staticità nella tecnica. La parte musicale è stata assai curata e costituisce uno dei maggiori pregi della pellicola” (“Intermezzo”, n. 18, dicembre 1946).
1955 – FIGARO, BARBIERE DI SIVIGLIA
Regia: Camillo Mastrocinque. Musica diretta da Jacques Rach Milovic per la parte operistica e da Franco Ferrara per la parte sinfonica. Cantanti: Tito Gobbi, Giulietta Simionato, Giulio Neri, Nicola Monti, Vito De Taranto, Patricia Deren. Coreografie: Alba Arnova e Victor Ferrari. Cast: Armando Francioli (conte d’Almaviva), Irene Genna (Rosina), Tito Gobbi (Figaro), Cesco Baseggio (don Bartolo), Carlo Campanini (Mendez), Andrea Aureli (il sergente).
Trasposizione cinematografica del capolavoro di Rossini non ripreso in teatro, con attori doppiati da cantanti. “Il film è soggetto alle limitazioni proprie del genere. Anche l’interpretazione subisce naturalmente le limitazioni imposte dal canto. Le voci dei cantanti sono in genere buone.” (“Segnalazioni cinematografiche”, vol. 88, 1955).
RAFFAELLO MATARAZZO (1909-1966)
Nel 1933 firma il suo primo lungometraggio con “Treno popolare”, che presenta alcuni tratti innovativi rispetto allo stile cinematografico dell’epoca, descrivendo una società nella quale, a parere della critica, “acquistano rilievo i momenti di evasione e divertimento”. E’ anche l’esordio del musicista Nino Rota. Dopo l’insuccesso del film, i temi ispiratori di Matarazzo diventano i romanzi di appendice di Sue, Hugo e Carolina Invernizio. E’ stata evidenziata una relazione fra questo cinema e la diffusione dei fotoromanzi. Matarazzo era un uomo timido, riservato in modo quasi ossessivo, geloso dei suoi libri e della sua collezione di dischi jazz, molto superstizioso. La sua scomparsa passa quasi inosservata nel mondo dello spettacolo.
1953 – GIUSEPPE VERDI
Regia: Raffaello Matarazzo. Soggetto: Maleno Malenotti. Sceneggiatura: Leo Benvenuti, Liana Ferri, Mario Monicelli, Piero Pierotti, Giovanna Soria. Fotografia: Tino Santoni. Musiche: Giuseppe Verdi. Consulente musicale: Renzo Rossellini. Cast: Pierre Cressoy (Giuseppe Verdi), Anna Maria Ferrero (Margherita Barezzi), Gaby André (Giuseppina Strepponi), Camillo Pilotto (Antonio Barezzi), Emilio Cigoli (Gaetano Donizetti), Loris Gizzi (Gioachino Rossini), Mario Del Monaco (Francesco Tamagno), Tito Gobbi (Giorgio Ronconi), Aldo Bufi Landi (Alexandre Dumas figlio), Guido Celano (Victor Hugo), Irene Genna (Violetta).
Vicino a morire, il compositore ripensa agli anni lontani della giovinezza e le memorie della sua vita si riaccendono.
Il film ebbe molto successo. Risultò il terzo maggior incasso della stagione cinematografica 1953-54, preceduto solo da “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini e da “Il ritorno di don Camillo” di Julien Duvivier.
“La rievocazione biografica è molto dignitosa: misurata la recitazione del Cressoy nella parte di Verdi, ottima la parte musicale, ricca di interessanti brani operistici” (“Segnalazioni cinematografiche”, vol. 35, 1954).
AMLETO PALERMI (1889-1941)
Nel 1914 lavora al suo primo film, “L’orrendo blasone”. Diviene uno dei registi più richiesti fino al suo trasferimento in Germania, dopo la guerra. Ritorna a Roma nel 1929 e riprende a dirigere una grande quantità di film (circa trentacinque, fino allo scoppio del secondo conflitto).
1939 – CAVALLERIA RUSTICANA
Regia: Amleto Palermi. Soggetto: Giovanni Verga. Sceneggiatura: Pier Maria Rosso di San Secondo, Santi Savarino, Tomaso Smith, Amleto Palermi. Fotografia: Massimo Terzano. Musiche: Alessandro Cicognini (non figurano nei titoli). Cast: Isa Pola (Santuzza), Doris Duranti (Lola), Carlo Ninchi (Alfio), Leonardo Cortese (Turiddu), Bella Starace Sainati (mamma Nunzia), Luigi Almirante (zio Brasi).
Mascagni nega l’utilizzazione della sua partitura. Le musiche e le canzoni, curate da Alessandro Cicognini, sono tratte dal patrimonio folkloristico siciliano, liberamente arrangiate e commentano con efficacia la storia d’amore e di gelosia di Turiddu, Lola e Santuzza.
Nel novembre 1939 la rivista “Cinema”, a seguito di un referendum fra i lettori, giudica “Cavalleria rusticana” il film migliore dal 1939. “La prima lode – scrive Ugo Ojetti su “Film”, 4 novembre 1939 – va a chi ha preparato trama e spettacolo, così da far dimenticare che esiste una ‘Cavalleria’ di Mascagni. Rivivono, pittoreschi, i costumi popolari, le processioni, i pellegrinaggi, le carrettelle, le bardature, i gioielli, le musiche, i canti. Un film italiano come pochi”. Il critico A. Franci nota: “Nella prima parte del film si sente il calore delle stagioni, la pietra nuda delle rocce, l’arsura appena ventilata del paesaggio meridionale, cui contrasta il cartone e il legno della seconda parte, dove voci e passi risuonano sul palcoscenico, sotto la luce falsa dei riflettori” (“L’illustrazione italiana”, n. 48, 26 novembre 1939).
1941 – L’ELISIR D’AMORE
Regia: Amleto Palermi. Soggetto: Eugenio Bonelli, Eugène Scribe. Sceneggiatura: Amleto Palermi, Ivo Perilli, Giovanni Spellani. Montaggio: Ines Donarelli. Musiche: Gaetano Donizetti. Scenografia: Gastone Medin. Costumi: Carlo Sensani. Cast: Armando Falconi (Dulcamara), Margherita Carosio (Adina), Roberto Villa (Nemorino), Carlo Romano (Belcore), Giuseppe Rinaldi (Pippetto), Silvio Bagolini (soldato), Claudio Ermelli (locandiere), Carmen Navasquéz (locandiera), Luigi Almirante (notaio), Pina Renzi (Dolores), Jone Salinas (Giannetta), Livia Minelli (Rosanna).
Il film è stato realizzato a Cinecittà. L’azione si svolge venti anni dopo quella dell’omonima opera lirica. Dulcamara ripassa negli stessi luoghi in cui si svolsero i fatti del libretto. I personaggi sono invecchiati e hanno figli impegnati nelle stesse battaglie d’amore dei genitori. Sull’onda della musica donizettiana la vicenda si conclude lietamente.
“Uno spettacolo divertente, arguto, rumorosissimo. La fantasia non ha portato che lievissime variazioni al libretto, sempre scintillante” (Diego Calcagno, “Film”, 21 marzo 1942).
GUIDO SALVINI (1893-1965)
Nipote del grande attore Tommaso Salvini, è tra i fondatori del Teatro d’Arte di Roma, diretto da Luigi Pirandello (1924). Nel 1932 assume la direzione del Festival musicale di Venezia. E’ responsabile del settore prosa del primo Maggio Fiorentino. Nel 1935 è chiamato alla direzione del Festival di Salisburgo, dove allestisce un famoso “Falstaff”, diretto da Arturo Toscanini. Nel 1946 fonda la rivista “Teatro”.
1955 – ADRIANA LECOUVREUR
Regia: Guido Salvini. Soggetto: Ernest Legouvré, Eugène Scribe. Sceneggiatura: Giuseppe Di Martino, Guido Salvini. Fotografia: Leonida Barboni. Musiche: Renzo Rossellini. Cast: Valentina Cortese (Adriana Lecouvreur), Gabriele Ferzetti (Maurizio di Sassonia), Olga Villi (principessa di Bouillon), Annibale Ninchi (principe di Bouillon), Memo Benassi (Michonnet), Leonardo Cortese (conte di Chazeul), Valeria Valeri (la Duclos), Monica Vitti, Carlo Tamberlani.
Ispirato all’omonima opera lirica di Francesco Cilea. Adriana Lecouvreur, celebre attrice tragica, aggredita da alcuni malviventi è salvata dall’intervento di Maurizio di Sassonia. Tra i due nasce un appassionato amore, che suscita la gelosia della principessa di Bouillon. Costei escogita un piano infernale per uccidere Adriana, che spira fra le braccia di Maurizio.
Così la critica: “La nota vicenda è narrata in modo convenzionale e caotico, la regia risulta inefficace, la recitazione dilettantesca e poco convinta. Anche dal punto di vista tecnico la realizzazione è superficiale e poco curata” (“Segnalazioni cinematografiche”, vol. 38, 1955).
GIACINTO SOLITO (1904-1991)
Giornalista professionista, diviene redattore capo del periodico “Cinematografo”, diretto da Blasetti alla fine degli anni Venti. Il suo primo film è “Fascino”. Fino al 1970 alterna l’attività di regia, sceneggiatura e montaggio.
1939 – FASCINO
Regia: Giacinto Solito. Aiuto regista: Mario Monicelli. Soggetto: Henry Clark, Sebastiano A. Luciani. Sceneggiatura: Camillo Mariani Dell’Anguillara. Fotografia: Piero Pupilli. Montaggio: Giuseppe Fatigati. Musiche: Vincenzo Bellini, Franco Casavola, Fryderik Chopin, Giovanni Paisiello, Enzo Sciambra. Cast: Iva Pacetti (Ada, cantante), Silvana Jachino (Liliana), Cesare Bettarini (Paolo), Bella Starace Sainati (la zia), Guglielmo Sinaz (l’impresario).
Una celebre cantante lirica ha smesso da dieci anni di interpretare “Norma”, perché, nell’ultima recita del capolavoro belliniano, la sorella è stata travolta dalla folla atterrita per un incendio scoppiato sul palcoscenico. L’amore per un pianista le farà riacquistare la voce proprio durante l’esecuzione della stessa opera.
Alla critica il film appare “sciatto, con scene e costumi modesti”.
1953 – LA GIOCONDA
Regia: Giacinto Solito. Soggetto: Arpad De Riso, Vana Arnould, Giacinto Solito. Musiche: Amilcare Ponchielli, adattate da Tarcisio Fusco. I brani musicali sono eseguiti da Giuseppe Campora e dal baritono Antonio Manca Serra. Cast: Alba Arnova (Gioconda), Elena Kleus (Laura Adorno), Peter Trent (Alvise Badoero), Paolo Carlini (Enzo Grimaldo), Stanislao Cappello (il Doge), Vittorio Vaser (Barnaba), Gino Scotti (Jacopo), Vira Silenti (una donna), Pina Cei.
Tratto dall’opera omonima di Amilcare Ponchielli, su libretto di Arrigo Boito. E’ la storia della danzatrice Gioconda, che ospita a Venezia il principe di Santa Flora, sfuggito all’Inquisizione e s’innamora di lui. Quando scopre che ama un’altra, lo denuncia, ma poi lo libera e si sacrifica per lui.
Il film fu considerato “lavoro artisticamente e tecnicamente molto debole” (“Segnalazioni cinematografiche”, vol. 34, 1953).
GUSTAVO LOMBARDO, IL “TORINESE” DEL CINEMA NAPOLETANO
di Mario Galeotti
Napoli ha avuto un ruolo importantissimo nella nascita dell’industria cinematografica in Italia, basti ricordare alcune figure di napoletani nella fase pionieristica del cinema italiano: gli esercenti Mario Recanati e Menotti Cattaneo, l’impresa dei fratelli Troncone, la prima regista donna Elvira Coda Notari, per non parlare delle numerose riviste specializzate sorte tra il 1907 e il 1912. Napoli è stata anche la città che per prima ha dato maggiore impulso al commercio di film nei primi anni del Novecento, con meccanismi assai diversi da quelli che comunemente associamo all’odierna distribuzione. E proprio in questo settore, prima ancora di diventare un produttore di successo e il fondatore della gloriosa Titanus, si è distinto il napoletano Gustavo Lombardo: un pioniere che, come hanno messo in risalto Vittorio Paliotti e Enzo Grano in un emozionante libro sulla storia del cinema napoletano (Vittorio Paliotti – Enzo Grano, Napoli nel cinema. Pionieri e dive del muto tra fine ‘800 e primo ‘900, Marotta & Cafiero Editori, Napoli 2006, p. 141), per acume e intraprendenza ha saputo sottrarsi al triste destino di tante altre innovative figure di precorritori, caduti nell’oblio, ed è riuscito a restare saldamente in sella. Ugo Gregoretti lo ha definito “il torinese del cinema napoletano” (Stefano Masi – Mario Franco, Il mare, la luna, i coltelli, Per una storia del cinema muto napoletano, Tullio Pironti Editore, Napoli 1988, p. 15).
All’indomani delle prime proiezioni pubbliche a Roma, Milano, Napoli, Genova nel marzo del 1896, esistevano due figure di professionisti legati alla nuova forma di intrattenimento: quello che oggi chiameremmo produttore, cioè chi realizzava materialmente i film (all’epoca chiamato comunemente editore di films), e l’esercente, colui che organizzava le proiezioni in qualità di ambulante con spettacoli itineranti nelle fiere e all’interno dei programmi dei caffè concerto, oppure come titolare dei primi spazi permanenti che nelle principali città furono adibiti esclusivamente a sala cinematografica fin dal 1897 (a Napoli la prima sala fu la Sala Recanati, aperta da Mario Recanati in Galleria Umberto). Almeno nei primi dieci anni di vita del cinematografo in Italia, le due professioni potevano sovrapporsi. Esisteva, cioè, la figura ibrida del produttore – esercente, che realizzava in prima persona i film, stampava le copie e le proiettava al pubblico. Ma a mano a mano che le attività cinematografiche andavano sviluppandosi e rafforzandosi, fu inevitabile che si delineasse una divisione sempre più marcata tra i due settori. Se da una parte, con il progressivo aumento della domanda da parte del pubblico, divenne necessario organizzare attività produttive a carattere industriale, raggiungendo livelli qualitativi e quantitativi che una dimensione artigiana non rendeva possibile, dall’altra cresceva (già dal 1904, e soprattutto nel biennio 1907/1908) la rete di sale fisse, in risposta alle esigenze di una clientela sempre più vasta e diversificata. Produzione ed esercizio consolidavano i propri rispettivi ruoli e competenze. Come ha evidenziato bene Aldo Bernardini, cominciò a “distinguersi e a differenziarsi dalla categoria dei realizzatori quella degli esercenti, che acquistano dai primi i film da proiettare nei loro locali, per poi rivenderli ad altri colleghi, fino a totale consumazione della copia” (Aldo Bernardini, Cinema muto italiano. I. Ambiente, spettacoli e spettatori 1896 – 1904, Laterza, Roma-Bari 1980, p. 5).
La primissima forma di organizzazione commerciale e distribuzione, dunque, ebbe per protagonisti quegli esercenti che, dopo aver proiettato nelle proprie sale le copie dei film e dopo un intenso sfruttamento, le rivendevano di seconda mano ad altri colleghi, ambulanti oppure proprietari di sale più periferiche frequentate da un pubblico meno esigente. Quando quegli stessi esercenti/commercianti erano anche i realizzatori delle pellicole, si verificava addirittura una prima, rudimentale forma di integrazione dei tre settori: produzione – esercizio – distribuzione.
Con il progressivo intensificarsi dell’esercizio stabile, che come abbiamo già detto subì notevole impulso soprattutto dal 1907, con la sempre più marcata separazione tra realizzatori ed esercenti e l’aumento della domanda, divenne necessario creare una rete commerciale fatta di nuove figure professionali che, attraverso agenzie in tutto il territorio nazionale, svolgessero una capillare opera di intermediazione tra il produttore e il proprietario di sale, acquistando e vendendo film e apparecchi per il cinematografo. Nasceva quello che Aldo Bernardini ha definito “un settore cinematografico nuovo, sotto certi aspetti parassitario, che richiedeva un investimento iniziale minimo, che non presupponeva alcuna competenza specifica” (Aldo Bernardini, Cinema muto italiano. II. Industria e organizzazione dello spettacolo 1905 – 1909, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 141).
Dopo il 1907, in un momento di transizione tra la fase primordiale del cinema italiano e un maggiore assestamento della nuova industria, iniziava una graduale conquista del settore del commercio il napoletano Gustavo Lombardo, ottenendo “in proprio concessioni per la distribuzione a Napoli e nelle province meridionali da parte di numerose ditte italiane e francesi” (Aldo Bernardini, Cinema muto italiano. II. Industria e organizzazione dello spettacolo 1905 – 1909, cit., p. 170). Lombardo agì sia in qualità di rappresentante concessionario, curando in esclusiva gli interessi di determinate case di produzione, sia come noleggiatore autonomo, operando cioè secondo un sistema di libera vendita o di contratti stipulati di volta in volta.
Nato a Napoli nel 1885, di estrazione borghese, contro il parere della famiglia Gustavo Lombardo abbandonò presto gli studi in giurisprudenza per dedicarsi già dal 1904 all’attività cinematografica, commerciando in pellicole e apparecchi. Nel 1907 aprì un vero e proprio ufficio in Calata San Marco e cominciò a gestire la rappresentanza di case italiane ed estere: Gaumont, Eclair, Vitagraph, SAFFI-Comerio, Croce, Aquila, Itala, Pasquali, Latium. In quel periodo, a Napoli, operavano nel commercio di film e apparecchi anche altri personaggi, come Alberto Fracassini, i fratelli Troncone, Menotti Cattaneo. In generale, in Italia si creò subito molta concorrenza nel settore dell’intermediazione e ciò causava un abbassamento nei prezzi dei film. Nel dicembre del 1908 Lombardo fondò anche una delle prime riviste specializzate del settore, «Lux», mensile al quale pochi mesi dopo si aggiunse un supplemento settimanale. Nel 1909 aprì una succursale della propria attività a Roma e l’anno dopo acquistò una sala cinematografica. Ma proprio nel periodo in cui Lombardo andava imponendosi nel settore, il cinema conosceva la sua prima crisi, quella del biennio 1908/1909: una crisi che dipendeva da una più generale congiuntura economica sfavorevole profilatasi dal 1907 a livello internazionale (Sull’argomento si veda: Franco Bonelli, La crisi del 1907. Una tappa dello sviluppo industriale in Italia, Einaudi, Torino 1971), che riguardò tutti i settori industriali e anche l’ambiente dello spettacolo. La rivista «Lux» si rivelò un utile strumento, a disposizione di Lombardo, per promuovere il suo lavoro e per ospitare un costruttivo dibattito sulla crisi, sulle sue cause e sui possibili rimedi.
Riccardo Redi ha notato, però, come le descrizioni di questa crisi, non solo in «Lux» ma in tutte le pubblicazioni dell’epoca, appaiano confuse e contraddittorie, mancanti di cifre concrete, e forniscano dunque un quadro altamente ambiguo. In Italia sembra si sia trattato in principal modo di una crisi di sovrapproduzione, tipico delle industrie nuove (Riccardo Redi, Cinema muto italiano (1896 – 1930), Marsilio, Venezia 1999, p. 45), problema al quale paradossalmente si reagì aumentando ulteriormente gli investimenti e i rischi, senza una mentalità cautamente imprenditoriale. In risposta alla crisi del settore cinema si tenne a Parigi, dal 2 al 4 febbraio del 1909, il Congresso degli Editori di Films presieduto da George Méliès. Lombardo, che all’epoca non era ancora diventato produttore, non vi prese parte. Per l’Italia parteciparono, tra gli altri, Carlo Rossi per la Cines, Camillo Ottolenghi per l’Aquila, Luca Comerio e Riccardo Bollardi per la SAFFI-Comerio, Carlo Sciamengo per l’Itala, Arturo Ambrosio, Filoteo Alberini. Semplificando, possiamo dire che la convenzione votata durante i lavori del congresso favorì gli interessi della già forte casa francese Pathè a danno delle concorrenti europee, incentivò un rapporto più diretto tra produttori ed esercenti penalizzando la compagine degli intermediari, impose agli acquirenti di noleggiare anziché comprare (com’era consuetudine in quegli anni) la pellicola e di restituirla alla casa produttrice dopo quattro mesi di sfruttamento e non oltre in modo da non lasciare in circolazione copie troppo usurate. In merito a quest’ultimo punto, l’esercente, che rischiava di diventare la vittima di “contratti-capestro loro imposti dalle Case di produzione più forti” (Aldo Bernardini, Cinema muto italiano. II. Industria e organizzazione dello spettacolo 1905 – 1909, cit., p. 180), avrebbe dovuto pagare il film 1,25 lire al metro solo per il noleggio, per poi riconsegnarlo dopo il lasso di tempo stabilito, mentre con il sistema delle vendite pagava 1,50 lire al metro ma ne restava unico proprietario e a suo piacimento poteva poi rivenderlo ad altri a un prezzo più basso, ammortizzando ulteriormente l’iniziale investimento. L’effetto della convenzione fu in sostanza un generale boicottaggio del catalogo Pathè, non solo in Italia, almeno fino a quando la casa francese non avesse cambiato linea. Come ha evidenziato Aldo Bernardini, il mercato italiano continuò ad essere contraddistinto da una varietà di pratiche distributive e di ruoli, mancando un serio coordinamento tra produzione, commercio ed esercizio. La pratica del noleggio a scadenza cominciò lentamente a diffondersi anche in Italia ma per ancora lungo tempo, e contestualmente alle nuove pratiche di gestione imposte dal diffondersi del lungometraggio, si continuò comunque a preferire in generale il sistema delle compravendite, soprattutto tra gli esercenti più grossi che, essendo meglio organizzati e controllando più sale, avevano maggiori possibilità di ammortizzare il costo d’acquisto e smaltire le scorte di vecchie pellicole.
Il numero di febbraio del 1909 della rivista di Lombardo, dopo aver elencato tutti i punti della convenzione approvata dal Congresso, sentenziò senza mezzi termini:
“L’aumento di valore della pellicola, ottenuto non per l’aumento del prezzo di vendita, ma per la restituzione della pellicola dopo 4 mesi, non determinerà, no, il fallimento de’ locatori, o la rinunzia da parte di costoro al commercio di locazione, quindi l’assunzione diretta del fitto da parte degli editori, e conseguentemente, per l’accordo tra questi, la disciplina della produzione ed il miglioramento delle films. No; la restituzione della pellicola dopo 4 mesi non porterà a tutto ciò, perché il locatore non fallirà, né rinunzierà al suo commercio, ma aumenterà i prezzi di noleggio, invece. Di talchè la famosa Convenzione non soltanto non faciliterà la soluzione della crisi, ma la inasprirà caricando sulle spalle esauste del Proprietario di cinematografo un peso maggiore, che ne renderà più precaria e difficile la condizione” (Il Congresso Internazionale degli Editori di Films, in «Lux», mensile, a. II, n. 3, febbraio 1909).
Ma Congresso e polemiche a parte, Gustavo Lombardo era ben consapevole del fatto che, così com’erano strutturati, i settori dell’industria cinematografica italiana presentassero evidenti mancanze. In un articolo dal titolo La crisi cinematografica, poco dopo il congresso parigino, Lombardo aveva parlato di disordine e di “marmaglia senza coltura né senso morale” riferendosi al commercio di pellicole e all’industria del film in Italia, sottolineando l’urgenza di approdare a una seria regolamentazione: “industria e commercio di films debbono essere governati come qualunque altra industria e commercio e bisogna fondare, in mancanza, enti seri e commerciali che dirigano e sfruttino questa nuova fonte di esplicazione di attività commerciale”. Mancando una veste seria e commerciale, scriveva Lombardo, “l’anarchia resterà la sovrana dell’ambiente” (Gustavo Lombardo, La crisi cinematografica, in «Lux», mensile, a. II, n. 4, marzo 1909).
Accanto a innate capacità imprenditoriali, Lombardo non mancò di dare prova anche di intelligenza e sensibilità artistica, nella convinzione che il cinema fosse “una delle più nobili, più utili, più pratiche invenzioni del XX° secolo” (La crisi cinematografica, cit.) e, per usare un’espressione di Gian Piero Brunetta, “un grande mezzo di emancipazione sociale e culturale”. In un’industria cinematografica come quella italiana, la cui storia economica sembrerebbe priva di importanti figure di magnati paragonabili a quelle hollywoodiane, come i Mayer, i Goldwyn o i Warner, secondo Brunetta un’eccezione sarebbe stata proprio il napoletano Gustavo Lombardo: “per lucidità imprenditoriale, conoscenza di tutti i problemi del mercato, convinzioni ideologiche (da giovane aveva militato tra le file socialiste), Lombardo è una figura anomala in un panorama egemonizzato da nobili e notabili che non brillano certo per intelligenza industriale, né per progressismo ideologico” (Gian Piero Brunetta, Cent’anni di cinema italiano. 1. Dalle origini alla seconda guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 32). Una conferma, ad esempio, potrebbe essere data dal fatto che Lombardo dimostrò coraggio, o quantomeno curiosità intellettuale, distribuendo il film “Vita futurista” (Arnaldo Ginna, 1916) e due film di Anton Giulio Bragaglia che presentavano elementi innovativi della ricerca futurista, “Perfido incanto” e “Thaïs” (1917).
Sensibile all’arte, ma sempre dotato di pragmatismo, Lombardo aspirava ad una razionalizzazione del settore del commercio e a una rete di organizzazioni regionali sapientemente collegate tra loro e così, sul fugace esempio di tentativi simili compiuti in passato come quello della Film Italiana di Torino o la Rigotti & C. a Milano, il 3 dicembre del 1910 si costituiva a Napoli con capitale azionario di trecentomila lire la Società Italiana Gustavo Lombardo Anonima (SIGLA), con filiale anche a Roma, che nell’annuncio dei soci fondatori si proponeva di “accentrare a sé il noleggio di film di tutte le Case per l’Italia Meridionale e Centrale, ed evitare così che molti piccoli speculatori continuino, con mezzi non sempre corretti, ad avvilire e deprezzare la produzione cinematografica” (Aldo Bernardini, Cinema muto italiano. Le imprese di produzione. 1. Il Centro-Sud, Kaplan, Torino 2012, p.238.). Primo azionista e amministratore delegato era Lombardo, che portò nella neonata compagine tutte le attività e concessioni personali, ad esclusione dei crediti maturati fino a quel momento e dell’esclusiva (secondo quanto riportato da Bernardini) per il lancio in tutto il mondo di quello ch’è considerato il primo lungometraggio italiano: “L’Inferno” (Francesco Bertolini – Giuseppe De Liguori – Adolfo Padovan, 1911), prodotto dalla Milano Films – società sorta dalle ceneri della SAFFI–Comerio – per il quale Lombardo stava “sperimentando originali tecniche e pratiche promozionali che dovevano poi restare in uso fino ai nostri giorni”, con il sistema della cessione dei diritti per zone e per paesi (Aldo Bernardini, Cinema muto italiano. Le imprese di produzione. 1. Il Centro-Sud, cit., p.238.).
L’articolo 4 dello statuto indicava come ambito d’azione della società “qualsiasi ramo delle industrie cinematografiche nel senso più esteso della parola, sia sotto forma di esercizio diretto, sia sotto forma di rappresentanze e concessioni”. Si trattò di un serio tentativo di controllo del mercato, nell’intento di contrastare l’esagerata proliferazione di piccoli noleggiatori e rivenditori in concorrenza tra loro e di imporre un’uniformazione delle tariffe, evitando il disperdersi della distribuzione cinematografica in “mille piccoli rivoli” (Stefano Masi – Mario Franco, Il mare, la luna, i coltelli, cit., p. 45.). Sulle pagine di «Lux» la SIGLA venne descritta come un “organismo cinematografico saldissimo, capace d’imprimere al nostro commercio un movimento nuovo”, la sola ditta di noleggio “in grado di fornire i programmi più belli e vari” («Lux», settimanale, a. IV, n. 79, 8 gennaio 1911.).
Tra le case di produzione, estere e italiane, che diedero mandato di rappresentanza del proprio catalogo per il mercato del Centro-Sud (e in certi casi dell’intero territorio nazionale) alla SIGLA figuravano Eclair, Gaumont, Le Film d’Art-Monofilm, Vitagraph, Edison, Itala, Milano Films (questa, però, nell’agosto del 1911 ritirò la concessione e riprese la distribuzione diretta dei suoi film attraverso i propri uffici). Mancavano le due più importanti case italiane, la romana Cines e la torinese Ambrosio, che anche per il commercio continuavano ad affidarsi alla loro organizzazione interna. Anche se Lombardo veniva accusato di voler creare un impero personale e di favorire il crescente ingresso dei film stranieri nel mercato italiano, è chiaro che non si poteva parlare di monopolio e inoltre, aspetto non trascurabile, c’era la concorrenza delle altre ditte di distribuzione come la Velf, l’Ercole l’Eltore, Mario Recanati. Nonostante l’introduzione di innovative (per quel tempo) pratiche distributive di cessione dei diritti di sfruttamento su base territoriale locale sull’esempio americano dello State Rights, in uso oltreoceano in quegli anni nella fase che precedeva la nascita dello studio system (Lombardo divise il mercato in tante aree e cedette ad ogni subconcessionario l’esclusività della pellicola per quella zona, creando così una vasta rete di agenzie locali in modo da definire contrattualmente tempi e modi dello sfruttamento e limitare la confusione nelle vendite), il settore in Italia continuò comunque ad apparire multiforme, frammentato, “aperto alle più diverse soluzioni” (Aldo Bernardini, Cinema muto italiano. III. Arte, divismo e mercato 1910 – 1914, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 24.). Ma l’esperimento di Lombardo ebbe senz’altro il merito di prefigurare un modello di grande distribuzione che nel tempo era destinato ad affermarsi su larga scala.
Naufragato il modello SIGLA, dopo poco tempo Gustavo Lombardo si ritirò dalla società, previo accordo col consiglio d’amministrazione, per riacquistare autonomia operativa già nel 1912. L’innovativo lancio del film “L’Inferno” gli permise, nel 1914, di aggiudicarsi l’esclusiva per il lancio internazionale di “Cabiria” di Giovanni Pastrone, film-manifesto dell’età d’oro del cinema italiano, distribuito sempre con il sistema delle esclusive a zone. Nel frattempo allargò le sue attività all’esercizio fondando un’altra società anonima, la DIVA (Divertimenti Imprese Varie). Nel 1915 riorganizzò la sua ditta di noleggio e vendita con il nome un po’ troppo altisonante di Monopolio Grandi Films, conosciuto come Monopolio Lombardo, con filiali a Roma e Milano: una società di distribuzione non molto diversa da altre, ma che ambiva a collocarsi sempre una spanna sopra al “sottobosco di mestieranti” (Vittorio Martinelli, Due o tre cose che so di Gustavo, in: AA.VV., Modi di produzione del cinema italiano. La Titanus, Di Giacomo Editore, Roma 1986). L’anno dopo fece ufficiale ingresso nel settore della produzione, dapprima con il marchio Lombardo-Teatro Film, utilizzando i teatri di posa della Polifilms di Giuseppe Di Luggo al Vomero. Il primo film sembrerebbe essere stato “L’avvenire in agguato” un dramma scritto da Roberto Bracco, diretto da Giulio Antamoro, anche se già negli anni precedenti risultano film registrati a nome di Gustavo Lombardo, probabilmente non prodotti in prima persona ma acquistati all’estero (Aldo Bernardini, Cinema muto italiano. Le imprese di produzione. 1. Il Centro-Sud, cit., p. 241). Successivamente rilevò la società di Di Luggo prossima al fallimento e diede vita a Napoli, nel 1917, alla Lombardo Film, che ereditava gran parte del personale tecnico e artistico del predecessore tra cui l’attrice Leda Gys, che diventerà la moglie di Lombardo. Sopravvivendo con sufficiente vitalità al declino del cinema italiano e realizzando oltre cinquanta film nell’arco di circa un decennio, senza abbandonare il settore distributivo dove ormai era ben radicato, nel 1928 l’attività produttiva di Lombardo assunse il nome di Titanus, glorioso marchio poi ereditato dal figlio Goffredo dopo la morte del padre nel 1951 e tutt’ora esistente. La produzione fu trasferita definitivamente a Roma, perché come hanno scritto Vittorio Paliotti ed Enzo Grano, Gustavo Lombardo “capì perfino quale era il momento giusto per andare via da Napoli” (Vittorio Paliotti – Enzo Grano, Napoli nel cinema, cit., p. 148).
Nel 1919 Lombardo era stato uno dei produttori che si rifiutò di aderire all’UCI, Unione Cinematografica Italiana, esperimento monopolistico promosso da Giuseppe Barattolo e dal barone Alberto Fassini naufragato miseramente nel giro di pochi anni. Grazie al suo acume, Lombardo si era salvato così dal fallimento. Negli anni Venti, poi, Lombardo apparve decisamente in controtendenza con le linee produttive del periodo, nel senso che anziché adagiarsi (come facevano in molti) sui fasti ormai tramontati del film storico e del divismo, perseguiva una politica più accorta e commerciale, diversificando i generi e diminuendo sprechi e rischi. In merito alla produzione legata ai temi della napoletanità, non mancarono ovviamente storie ambientate nella realtà partenopea, ma Lombardo voleva sempre conferire ai propri film un carattere nazionale e internazionale, anche quelli più strettamente connessi con la vita e la storia di Napoli, allontanandosi il più possibile dal localismo e dalla crudezza di certi film (come quelli prodotti dalla Dora) che – con vicoli degradati, scugnizzi e guappi – impensierivano seriamente il fascismo.
Per avere un’idea dell’importanza del suo ruolo di produttore, di pari lungimiranza e ingegno imprenditoriale a quello di distributore, basterebbe riportare un passaggio di un articolo del 1928 pubblicato da «La Rivista Cinematografica», che esaltava le capacità di Gustavo Lombardo e individuava i presupposti per un suo valido contributo a far uscire la cinematografia italiana da una crisi stagnante:
“La Lombardo Film di Napoli sta compiendo per la rivalutazione del film italiano in Patria e all’estero, un’opera ignorata dai più, ma non per questo meno meritoria. Se tutti coloro che vanno blaterando di cinematografia e di rinascita facessero, ognuno nel proprio campo, qualcosa di simile, potremmo dare per certa, realmente la fine della crisi entro un tempo brevissimo” (Mascamorto, in «La Rivista Cinematografica», n. 5, 15 marzo 1928).
“MISSION TO MARS”
LA VITA SOGNATA NEL VUOTO
di Danilo Amione
Se per Eastwood la Luna chiude la grande speranza extraterrestre del genere umano assurgendo ad ultima frontiera conquistata (con la morte) da uno dei suoi “Space cowboys”, con De Palma Marte diventa metafora di un sogno da cui non ci si può svegliare perché è solo nel sogno-arte che l’uomo vive. Esploratore per immagini, De Palma trova nel suo primo incontro con la fantascienza le ragioni per spiazzare ancora una volta se stesso ed arrivare ai confini della rappresentazione possibile.
Liquidato senza alcuna emozione l’incipit (siamo nel 2020, come dire oggi, e partire per una missione su Marte, o recuperarne i protagonisti in difficoltà, si immaginava, venti anni fa, non potesse far notizia più di tanto, e magari ancora così non è…), il film prende quota solo dinanzi a ciò che è comunque imprevedibile. E allora diventa arte astratta da incanto con gli smarties che in assenza di gravità assumono la forma di un DNA premonitore, con il fondale nero su cui si sprofonda rarefacendosi prima di approdare alla meta e di andare oltre la parola Fine. Film alieno, dunque, anche alla fantascienza, “Mission to Mars” si pone come primo e ultimo confine fra il sorprendere e il raccontare la sorpresa, fra finzione artistica e verità filosofica. In mezzo, un film dilatato, ipnotico, kolossal nella struttura ma minimalista nei forti contenuti espressivi. Bianco, nero e rosso i colori predominanti, come dire che prima di raccontare l’ultimo passo dell’uomo sui viali della conoscenza, De Palma ci ricorda il bianco e nero del nostro esistere sullo schermo della finzione che tutto ci disvela. E’ il Mito del cinema che De Palma ha deciso di (ri)costruire a sua immagine. Il creatore di visioni mai certe (vedi il finale dello splendido precedente “Omicidio in diretta”) si muove sul piano di chi sa di poter affondare colpi di luce su una verità inconoscibile, velata, qual è l’Origine –Destino dei suoi simili. E quale migliore occasione che lanciarsi, cinepresa in mano, verso il solo buio che ci è consentito di vedere, dunque di immaginare e finalmente di conoscere: il vuoto dello spazio che ci circonda. L’occhio elettronico, cinematografico, vince così su tutto e tutti, persino sulla madre “tecnologia” (spaziale in questo caso) ridotta oramai soltanto a calcoli e coincidenze. Troppo poco per la mente umana, sempre troppo dilatata verso ogni dove. L’avventura, dunque, del recupero di un equipaggio rimasto coinvolto sul pianeta rosso in una tempesta biblica e premonitrice, diventa svelamento di un Moloch primordiale, totem orizzontale dal profilo femminile quasi ad indicare un passato fertile ma inavvicinabile.
Il nuovo presente extraterrestre si rivela, invece, luce bianca, accecante, che tutto avvolge fino a togliere il respiro in una sospensione temporale che riassume il significato stesso dell’essere uomini in uno spazio indefinibile, che non dà tregua. Se non quella decretata da un piccolo alieno che più che indicarci il futuro (l’ennesimo spiazzamento depalmiano) ci indirizza verso le nostre origini, in un racconto fatto solo per immagini, unico mezzo efficace di comunicazione in una dimensione in cui la parola è troppo debole e breve per aggiungere qualcosa di più alla nostra volontà di conoscenza. E’ in questa lunga sequenza di percezioni e sensazioni che de Palma libera e comunica una emotività che è sì prodigiosamente accostabile al Tarkovskij di “Solaris” e al Kubrick di “2001: Odissea nello spazio”, ma che ha il pregio ancora più raro di allontanarsene per affermarsi come verità propria. De Palma, infatti, non si muove più su un piano di narrazione-spiegazione di un inconoscibile da sondare, il suo inedito approccio è viceversa quello di raccontare solo l’emozione che il sogno dell’avventura, del tentativo, della ricerca continua può regalarci. E come nel magnifico “Contact” di Zemeckis, l’unica verità possibile è l’incontrarsi razionalmente con la fantascienza, coniugare tecnologia ormai scontata e arte mai disvelata per fare dell’uomo l’ultimo baluardo di se stesso.
L’immersione di un gruppetto di uomini negli spazi siderali, in balia di se stessi, è l’approdo ultimo a quella stanza della conoscenza sulla cui soglia giungevano gli esploratori post-atomici dello stupendo “Stalker” di Tarkovskij. E quando, sul finale, uno dei protagonisti decide di non rientrare sulla terra ma di lanciarsi nel vuoto dell’inconoscibile, a prendere il sopravvento è la metafora riassuntiva di un film il cui significato stesso scivola più sul piano della necessità che del piacere, pur essendo quest’ultimo il vero traino di un sogno vissuto ad occhi aperti verso l’Isola che c’è.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
UNA RILEVANTE PRESENZA FEDIC ALLA MOSTRA DI VENEZIA
di Paolo Micalizzi
Anche quest’anno la presenza Fedic è stata notevole, anche se penalizzata dalle restrizioni dovute al Coronavirus. Al Forum Fedic, per esempio, si è dovuta limitare la partecipazione a non più di 70 persone. E’ stato un Forum, quello svoltosi giovedì 10 settembre nello Spazio Incontri del Venice Production Bridge dell’Hotel Excelsior, che è stato dedicato, soprattutto, ai Festival ed agli Autori Fedic ed agli studenti operanti nell’ambito di Fedic Scuola e del Booktrailer Film Festival.
Un Forum che quest’anno è stato impreziosito dall’intervento del Direttore Artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera nel quale ha sottolineato il ruolo della Fedic nel promuovere la produzione di cortometraggi ritenendola una componente fondamentale dell’attività cinematografica che va sostenuta con costante impegno.
Dopo un’introduzione del sottoscritto, che dal 1995 cura quest’iniziativa alla Mostra del Cinema di Venezia, è intervenuto il Presidente Fedic Lorenzo Caravello che ha affermato che l’obiettivo della Federazione è stato quello di trasformare gli ostacoli in opportunità e continuare nonostante le innumerevoli criticità dovuta alla situazione Covid 19 a proseguire con orgoglio le proprie attività di divulgazione e promozione culturale, così come fa con il Forum. Che ha reso omaggio al centenario della nascita del Grande Maestro Federico Fellini con un Video, presentato da Lauro Crociani che lo ha realizzato insieme a Cristiana Vitalesta, relativo a “Federico Fellini alle terme di Chianciano e dintorni” attraverso le testimonianze di alcune persone, tra cui la giornalista Simonetta Guidotti, che lo hanno incontrato in quella vacanza termale che si concedeva da alcuni anni. Via quindi alle proiezioni di trailer relativi ad alcuni Festival e di alcuni Autori. I Festival presentati sono stati: “Corto Fiction”, “Fedic Scuola Film Festival”, “Coltivacortidiretti” e “Visioni Corte Film Festival”, e relativamente agli Autori di alcuni cortometraggi realizzati nel 2019/2020, “Ricordi”(Lettera d’amore) di Sonia e Giorgio Bertuccioli (Cinevideoclub Pesaro), “Una finestra non è abbastanza” di Margherita Caravello e Antonio Nobili(Cineclub Cineamatori delle Apuane), “Diagonia” di Chiara Rizzati e Claudio Venanzini (Fotocineclub Fano), “La breve stagione” di Agostino Vincenzi(Cinevideoclub Pesaro), “Writer” di Franca Elisabetta Iannucci(Cineclub Cagliari). Spazio, infine, alla proiezione di opere realizzate nell’ambito della Scuola, presentate rispettivamente da Laura Biggi (Responsabile Fedic Scuola) e da Ilaria Copeta del Booktrailer Film Festival di Brescia. Per Fedic Scuola, “Gino” di Carlo Menegatti (Cineclub Delta del Po) e “Beatrice” di Giorgio Emanuele Torresani (Cineclub Kinema Brescia) realizzato nell’ambito del Progetto SicComeDante, coordinato da Laura Forcella Iascone. E del Festival di Brescia “L’occhio del male” di Alessandro Gregori, “Il giardini delle farfalle” di Maria Tallarico, “L’invenzione di Morel” di Nicola Barsottelli, “Blackwood smart project” di Simone Franceschini. Molti gli studenti presenti, tutti entusiasti di questa esperienza alla Mostra di Venezia. E’ stato anche proiettato, scelto dalla Rete REFF, il cortometraggio “Indimenticabile” di Gianluca Santoni.
Altra iniziativa, è il Premio Fedic che viene organizzato dal 1993 e viene destinato “all’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore”: la scelta è riservata ad un film italiano. Con la Presidenza del sottoscritto la Giuria – composta anche da Ugo Baistrocchi, Alfredo Baldi, Carlotta Bruschi, Massimo Caminiti, Giuliano Gallini, Massimo Giraldi e Chiara Levorato – ha attribuito il Premio al film “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli (presentato in “Venezia77”) con la seguente motivazione: “Per la capacità di rendere lo spessore culturale di Eleanor Marx ma anche le sue contraddizioni come donna e di attualizzarne il discorso politico mettendo in primo piano il tema dell’ingiustizia sociale”. La Giuria ha anche assegnato una Menzione speciale Fedic al film “Assandira” di Salvatore Mereu (Venezia77) perché “rappresenta il conflitto generazionale e il contrasto tra tradizione e innovazione socioeconomica coinvolgendo gli spettatori nella interpretazione dei sentimenti dei personaggi e del loro rapporto con la madre terra”.
Anche quest’anno vi è stata una Giuria che ha attribuito una Menzione speciale Fedic per il miglior cortometraggio. La Giuria, presieduta da Alfredo Baldi e composta da Laura Forcella Iascone e Luciano Volpi, lo ha assegnato a “Finis Terrae” di Tommaso Frangini (presentato in Sic&Sic) perché è la “Storia di una solitudine che decide di scomparire silenziosamente per non dare più fastidio al prossimo” aggiungendo che vi è anche una ”Vigorosa messa in scena di un problema esistenziale reale e sentito da parte di un giovane regista che sa raccontare storie, emozionare e usare magistralmente la macchina da presa”.
17° SEDICICORTO FORLÌ – FORMULA IBRIDA VINCENTE
di Gianluca Castellini
La 17° edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, data la particolare situazione emergenziale del Paese che ha comportato forti restrizioni per far fronte al Covid-19, si è svolta in modalità ibrida, con una parte in presenza (dal 2 all’8 ottobre 2020, presso il cinema Sala San Luigi) e la selezione ufficiale di 5 sezioni presentate in streaming online, dal 2 all’11 ottobre, avvalendosi della prestigiosa partnership tecnica di Mymovies.it, che ha creato una piattaforma apposita per poter ospitare al meglio la programmazione del nostro Festival all’interno del proprio palinsesto.
Nel rispetto, comunque, di una propria tradizione festivaliera, il primo weekend (dal 2 al 4 ottobre) è stato quasi interamente dedicato agli autori della sezione regionale CortoInLoco, con il Festival che è stato in grado, nonostante la necessità di ricorrere ad una modalità webinar online, di ospitare oltre il 90% degli autori presenti in selezione, durante il Forum CortoInLoco sviluppato su 2 incontri.
Le proiezioni dei corti in concorso si sono tutte svolte presso la Sala Casanova, la sala virtuale creata su Mymovies.
Per quanto riguarda, invece, le attività svolte in presenza alla Sala San Luigi, dopo un toccante intervento canoro della soprano riminese Paola Tiraferri, che ha inaugurato il 17° Sedicicorto Forlì International Film Festival intonando l’Inno di Mameli, le proiezioni erano dedicate alla presentazione al pubblico fisico di una delle sezioni cui il Festival è da sempre maggiormente affezionato. Parliamo dei cortometraggi previsti per la sezione sperimentale Experia, cui, nella giornata di sabato 3 ottobre, è stato affiancato l’evento speciale Rosto. The Thetralogy, che ha portato in sala la proiezione della monumentale opera di uno dei più rinomati e prestigiosi animatori della scena sperimentale internazionale, prematuramente scomparso a marzo 2019. L’evento è stato reso possibile grazie alla sinergia e collaborazione con una delle principali case di distribuzione internazionale, Autour De Minuit, che ha scelto proprio Sedicicorto come festival in cui svolgere, per la seconda volta in Europa, la proiezione in omaggio dell’artista olandese, presentata in anteprima internazionale al Clermont-Ferrand International Short Film Festival a febbraio 2020.
Il primo weekend è stato anche il momento scelto dagli organizzatori per presentare, sia in presenza che sui propri canali social (divenuti mai come quest’anno terza sala eventi a tutti gli effetti, con una propria programmazione giornaliera), una nuova rubrica inaugurata nel corso di questo 17° Sedicicorto Forlì International Film Festival. Ci riferiamo al Cinebook, curato in collaborazione con Gabriella Maldini, che ha selezionato per il Festival 5 titoli, 5 successi editoriali in qualche modo connessi con il mondo del cinema. Sono stati, quindi, presentati, nell’arco di tutte le giornate del Festival:
Mio fratello rincorre i dinosauri, bestseller letterario di Giacomo Mazzariol che narra la storia di Jack, della sua famiglia e di un fratello molto speciale e che, nel 2019, ha visto la propria trasposizione cinematografica, per la regia di Stefano Cipani e fortemente sostenuta dalla Film Commission Emilia-Romagna. Il film è stato presentato in anteprima a settembre 2019 tra gli eventi speciali previsti nell’ambito delle Giornate degli Autori.
I baci mai dati, romanzo di Roberta Torre, dalla storia molto particolare, non solo da un punto di vista narrativo, ma anche editoriale, visto che nasce successivamente alla distribuzione in sala dell’omonimo film della nota regista come rescript delle vicende narrate proprio al cinema. La regista è stata anche protagonista di una masterclass, svolta sulla piattaforma zoom, proiettata in sala a Forlì e diffusa anche sui canali social del Festival, in cui la regista ha avuto modo di approfondire il suo legame con letteratura, cinema e teatro, aspetti imprescindibili nella sua variegata produzione artistica.
Il ladro di giorni, di Guido Lombardi, che è poi passato direttamente dietro la macchina da presa per regalare al suo romanzo un’attenta trasposizione cinematografica, che ha visto tra i protagonisti l’attore pugliese Riccardo Scamarcio.
A proposito di niente, sofferta autobiografia del regista statunitente Woody Allen. Un testo dalla complessa vicenda editoriale, con la casa editrice italiana La Nave di Teseo tra le prime ad averlo pubblicato, dopo una sorta di censura cui il testo era stato costretto in America e in molti altri paesi europei.
Alla video recensione di Gabriella Maldini (sempre presentata sia in presenza che sui social), è seguita una masterclass online, svolta con il supporto della piattaforma Zoom e trasmessa sui profili social del Festival, con Giancarlo Zappoli, direttore responsabile di Mymovies.it e profondo conoscitore della figura e della cinematografia di Allen.
L’ultimo giorno della mia vita, di Paolo Genovese, regista in prestito alla letteratura, ma che ha già in previsione una trasposizione cinematografica per questo suo avvincente romanzo.
Da domenica 4 ottobre si è dato inizio anche alla 3° edizione di IranFest, che oltre alla proiezione dei 16 cortometraggi in concorso per la sezione, ha avuto anche momenti di incontro con docenti specializzati (Claudio Zito, professore dell’Università di Bologna, che ha approfondito la figura e il cinema di un grande regista iraniano: Jafar Panahi) e artisti iraniani che hanno contribuito a offrire una visione più ampia della cultura del paese di riferimento e delle difficoltà riscontrate nel fare cinema in Iran (incontri resi possibili grazie alla neo collaborazione con il regista documentarista iraniano Komeil Soheili, che li ha moderati sotto forma di webinar, diffusi sul sito internet ufficiale del Festival). Tutte le proiezioni della selezione di questa edizione di IranFest si sono svolte, in presenza, presso la Sala San Luigi, per permettere al pubblico di non dover rinunciare ad un evento che sempre più attira la loro attenzione e il loro consenso.
PREMIATI DA SEDICICORTO

Quest’anno l’edizione è stata ulteriormente arricchita da un momento dedicato alla danza, che ha coinvolto la ballerina Mara Vetricini e dalla proiezione del video-viaggio in Iran di Mattia Fiorentini, alla presenza dell’autore in sala e in collaborazione con l’associazione forlivese INZIR.
Nel corso della sua diciassettesima edizione, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria e l’impossibilità di poter avere ospiti, sia nazionali che internazionali in presenza, Sedicicorto Forlì International Film Festival non ha voluto comunque rinunciare ad una delle sue peculiarità: quella di poter offrire al proprio pubblico una serie di incontri e masterclass con professionisti del settore e talent di rilievo. Lo aveva già fatto nel corso della sua anteprima settembrina, Tracce… di Sedicicorto, portando alcuni dei giurati del Festival (l’animatrice Monica Manganelli per la sezione Animalab; il critico cinematografico Boris Sollazzo per CortItalia), importanti giornalisti di settore (Carlo Griseri di Cinemaitaliano.info, uno dei più affezionati media partner nazionali del Festival), sostenitori istituzionali (Fabio Abagnato, in rappresentanza della Film Commission Emilia-Romagna) e partner tecnici (Gianluca Guzzo, fondatore e direttore editoriale di Mymovies.it, venuto personalmente a spiegare le modalità di fruizione online del festival).
Inoltre, oltre agli incontri comunque svolti in modalità webinar del Forum CortoInLoco e alle masterclass virtuali che hanno accompagnato le video-recensioni del Cinebook, sono state organizzate altre masterclass virtuali, raccolte attorno alla rubrica denominata Webintalk e presentate, alcune anche in proiezione in presenza e tutte diffuse sulla pagina Facebook del Festival nonché sul sito web ufficiale della manifestazione. Nello specifico, durante le 10 giornate del 17° Sedicicorto Forlì International Film Festival, si sono svolti:
Webintalk AnimaInOnda: curati con la collaborazione del festival siciliano Animaphix Animated International Film Festival e moderati dal suo co-direttore artistico Andrea Martignoni, si è trattato di 3 incontri con rinomati animatori internazionali, che hanno parlato non solo delle loro opera e produzione personale, ma fatto una approfondita discussione sul ruolo e lo stato dell’animazione nel panorama del cortometraggio internazionale. Protagonisti degli incontri sono stati: Denis Tupicoff, Claudius Gentinetta e Franck Dion.
Webintalk Festival: tra i più colpiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria all’interno del settore cultura, i festival cinematografici si sono dovuti reinventare e sono stati costretti a rimodulare sia le proprie modalità di svolgimento che le proprie programmazioni. Spesso questo ha comportato una minore attenzione, anche a livello istituzionale e di accesso ai finanziamenti, verso importantissime realtà della promozione cinematografica nel nostro Paese. Sedicicorto ha voluto dare loro voce, andando a coinvolgere tre realtà festivaliere nazionali tra quelle giudicate più dinamiche e interessanti. Nascono così i webinar, trasmessi sulla pagina Facebook del Festival nel corso delle dieci giornate dell’ultima edizione, con: Rosalba Colla, fondatrice e co-direttrice artistica di Animaphix Animated International Film Festival; Franco Calandrini, fondatore e direttore artistico di Ravenna Nightmare Film Festival; Matteo Pianezzi, distributore e produttore di cortometraggi nonché direttore artistico del Figari Film Festival e dell’Olbia Film Network.
Webintalk IranFest: grazie alla preziosa collaborazione (avviata proprio per la diciassettesima edizione e destinata a diventare strutturale nel corso della prossima) con il regista documentarista iraniano Komeil Soheili, Sedicicorto Forlì International Film Festival è riuscito a coinvolgere, in due incontri virtuali disponibili sia sul sito internet ufficiale di Sedicicorto che sul quello di IranFest (www.iranfest.it), alcuni eminenti registi, tra i più attivi nell’attuale panorama cinematografico iraniano. Con loro è stato possibile analizzare non solo le difficoltà prodotte dalla contingente emergenza sanitaria, ma anche, più in generale, come e quanto essa abbia influito su un sistema cinematografico già complesso come quello iraniano.
Per quanto concerne l’attenzione al tema delle pari opportunità, oltre a registrare una partecipazione di oltre il 40% di registe donna sul totale degli autori presenti (percentuale sempre più crescente nel corso delle ultime edizioni), il 17° Sedicicorto Forlì International Film Festival ha voluto porre ulteriormente l’accento sulla sua volontà di promuovere e sostenere la cinematografia al femminile, istituendo il Premio WomanInSet, che è stato conferito in 3 differenti modalità:
Premio WomaInSet Mymovies a Roberta Torre, conferito per l’abilità della regista di portare la valorizzazione della donna e del suo ruolo nel settore in tutte le sue manifestazioni artistiche, dal cinema al teatro, passando per la letteratua;
Premio WomaInSet IranFest a Roya Teymourian, attrice iraniana tra le più prolifiche sia nel panorama della serialità televisiva e in quello cinematografico. Una delle più grandi star dell’attuale cinema iraniano;
Premio WomanInSet CortoInLoco a Olga Torrico, produttrice e distributrice capace e determinata, che quest’anno si è lanciata in una nuova impresa cinematografica: quella della sua prima regia di un cortometraggio, Gas Station, tra i più apprezzati della sezione CortoInLoco2020.
Sedicicorto ha poi riservato anche uno spazio dedicato alla valorizzazione dell’opportunità di valorizzare le opere di celebri pittori e illustratori. Ha, quindi, voluto unire la passione per l’arte con quello che da sempre è il suo mondo, il cortometraggio, realizzando tre mostre virtuali, realizzate come se fossero la produzione di tre diversi cortometraggi. Sono state presentate, sia al pubblico in presenza che a quello dei social (nell’ambito di una apposita rubrica, che gli organizzatori hanno voluto chiamare Notte al museo, andando in onda alle 22) nonché sul sito internet ufficiale del Festival:
Ritorno a Rimini: una serie di opere della pittrice Miria Malandri realizzate per omaggiare il regista Federico Fellini nel centenario dalla sua nascita e animate dall’artista Imhoff; Dread fear: le struggenti opere della pittrice iraniana Nasrin Amiri, dedicate alla difficile condizione del popolo del suo paese, prendono vita grazie all’animazione realizzata dal giovane animatore romagnolo Giona Dapporto; Vincent: l’artista iraniano Alireza Karimi Moghadamm ripercorre la vita e le opere di Vincent Van Gogh, creando una poetica animazione i cui disegni traggono ispirazione proprio da alcuni tra i dipinti più celebri del pittore olandese.
Da diversi anni, l’Associazione Sedicicorto realizza corsi di alfabetizzazione cinematografica e laboratori sull’audiovisivo e l’animazione e proiezioni presso i principali Istituti Scolastici presenti sul territorio locale. Questo, nel corso degli anni di attività del Festival ha permesso di creare un collaudato rapporto sinergico con le scuole della città e un rapporto fiduciario sia con i docenti che con gli studenti coinvolti. La particolare situazione che si è verificata all’inizio dell’Anno Scolastico e la volontà di tutelare la sicurezza dei ragazzi e del corpo docenti ha portato Sedicicorto Forlì International Film Festival a rimodulare la propria offerta per la sezione competitiva NO+D2, da sempre studiata specificatamente proprio per il coinvolgimento delle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, a cui erano dedicate le proiezioni diurne presso l’Auditorium CariRomagna (quest’anno non reso disponibile per la manifestazione a causa della sua ancora non programmata riapertura per eventi pubblici). Gli organizzatori hanno stabilito che, se gli studenti non potevano recarsi alle proiezioni, allora avrebbero portato il 17° Sedicicorto Forlì International Film Festival dagli studenti. In accordo con gli autori, produttori e distributori delle 19 opere selezionate, sono state realizzate delle chiavette USB contenenti l’intera selezione ed affidate agli insegnanti per la programmazione di alcune proiezioni all’interno delle scuole.
Come da tradizione, nonostante la nuova modalità di fruizione scelta, i ragazzi sono stati invitati a inviare le loro recensioni, pubblicate giornalmente, dal 5 al 9 ottobre, sul sito di informazione locale Forlitoday. Sono giunte al Festival oltre 100 recensioni. Le migliori 3 sono state premiate con un premio, offerto dal Festival, di 100 € ciascuna.
Lo stesso è stato fatto per la sezione Bebisciort, che coinvolge un target di bambini che va dai 5 agli 11 anni ed è costituita da 20 cortometraggi di animazione. Le chiavette sono arrivate presso l’intero plesso della Scuola Primaria De Amicis (coinvolte tutte le 15 classi) e in alcune classi della Scuola Primaria Bersani. I bambini e i loro insegnanti hanno particolarmente gradito la selezione presentata, accolta con gioia tra le pochissime attività extra-curriculari che potranno essere svolte durante quest’anno.
PER STARE INSIEME IN TEMPO DI COVID
di Roberto Merlino
E’ successo un paio di mesi fa. Una nostra Socia era nello studio di un ottico quando sentì squillare il cellulare e, visto con la coda dell’occhio il motivo della chiamata, chiese al dottore di interrompere la visita, perché lei “aveva un’urgenza”.
Per capire di cosa si trattasse… dobbiamo fare un passo indietro, al marzo di quest’anno, in piena ondata Covid19.
In Corte Tripoli Cinematografica, Cineclub FEDIC di Pisa, eravamo (come tutti, del resto) con attività artistica paralizzata e senza possibilità di incontrarci.
Tra l’alternativa di mettersi in ginocchio di fronte al malefico virus e il tentativo di reagire, abbiamo scelto di… “rilanciare” (!) e ci siamo inventati un gioco da portare avanti quotidianamente con internet.
L’obiettivo era quello di creare una “opportunità di stare insieme”, che non fosse un semplice palliativo contro l’isolamento, ma potesse diventare una forma di scambio costruttivo e creativo.
Detto fatto! Dal 23 marzo abbiamo dato inizio ad un “gioco”, tuttora in pieno svolgimento, rivolto ai nostri “Soci”, ai “Simpatizzanti” e a tutti quelli che hanno voglia di “tenersi attivi in modo intelligente”.
E’ stato creato un Comitato Organizzatore che, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) prepara un quiz, lo filma e lo invia direttamente a un elenco di circa 400 contatti.
I quesiti sono di vario di tipo, spaziando dal cinema al teatro, dalla poesia all’arte culinaria, ecc. e vengono diffusi in prima mattinata. I partecipanti inviano le soluzioni per mail e, se hanno indovinato, acquistano un punteggio che varia a seconda della velocità di risposta. Ogni sera viene inviato un resoconto con “comunicazioni”, “classifica di giornata” e “classifica generale”.
Al sabato, poi, si realizza una sorta di “giornalino”, con materiale inviato dai partecipanti stessi: racconti brevi, poesie, fotografie, ecc. in cui si trovano anche “commenti” ai lavori altrui (con eventuali “risposte ai commenti”). Questo spazio del sabato, oltre a consentire la messa in mostra delle capacità artistiche dei partecipanti, offre la possibilità di comunicare e creare uno scambio di opinioni, che si sta rivelando oltremodo interessante.
La domenica, infine, è allestito il cosiddetto “spazio creativo”, in cui i partecipanti vengono cimentati nel realizzare piccole opere, su un argomento dato, sempre diverso. Gli elaborati, generalmente, sono di tipo letterario, fotografico o compositivo e vengono valutati da un’apposita Giuria.
Nel tempo i partecipanti sono aumentati e molti di loro aspettano con trepidazione (e quasi con ansia) il messaggio del mattino con il quiz da risolvere. Generalmente l’invio avviene attorno alle 9.00 (a volte un po’ prima, a volte un po’ dopo), ma sappiamo che alcuni sono all’erta (col cellulare a portata di mano) fin dalle 8,00!
Ed ecco spiegato, allora, quanto accennato all’inizio: può succedere che qualcuno riceva il quesito mattutino mentre è altrimenti impegnato e, con gran sorpresa dell’occasionale interlocutore, si metta a “spippolare” per inviare la soluzione, prima di rendersi nuovamente disponibile.
Ho citato il caso della “Socia dall’ottico”, ma ne conosco molti altri. E questo ci gratifica, perché è un segno della viva partecipazione e dell’entusiasmo che ci circonda.
Nel tempo il nostro gioco si è caratterizzato per variazioni e tentativi di miglioramento, arrivando a coinvolgere i partecipanti più creativi e disponibili, affinché fossero loro a suggerire nuovi quiz e differenti modalità di interazione.
Gli “appuntamenti”, iniziati il 23 marzo 2020, sono ormai giunti a quota 250 e si conta di andare avanti ancora per un bel po’! La possibilità di partecipare è aperta a tutti e in qualunque momento si può entrare in gioco, facendo richiesta al sottoscritto di essere inseriti nella mailing-list dei “Simpatizzanti-CTC”. Anche se c’è una classifica generale, quel che conta è… partecipare e divertirsi!
Come abbiamo più volte ribadito, quando torneremo alla “normalità”, organizzeremo una bella festa e saranno premiati tutti i partecipanti!
Nelle foto possiamo trovare una piccolissima parte del materiale pubblicato nello spazio del sabato:
SUCCESSO DEL 70.
ITALIA FILM FESTIVAL ORGANIZZATO DALLA FEDIC A MONTECATINI TERME
di Paolo Micalizzi
Dal 28 al 30 agosto la Fedic ha svolto a Montecatini Terme il 70. Italia Film Festival., ritornando a gestire direttamente , con il coinvolgimento di tutti i Cineclub associati che sono stati resi partecipi in ugual misura di un progetto comune aumentandone lo spirito di appartenenza e la condivisione di ruoli ed incarichi. Un Festival storico, quello della Fedic a Montecatini Terme, che risale al 1950 dopo che nel 1949 nella città termale toscana era stata costituita la Federazione Italiana dei Cineclub. Con 70. Italia Film Festival, la Fedic ha continuato a rafforzare il proficuo e storico gemellaggio con la città di Montecatini Terme, promuovendo ed organizzando quella che è la terza manifestazione cinematografica nazionale in termini di storicità e la prima come rappresentazione di cortometraggi, garantendo sul territorio importanti ricadute sia in termini economici che di prestigio.
Per farlo ha invitato nella Giuria Fedic Short importanti ospiti come l’attrice Milena Vukotic, alla quale ha anche attribuito l’Airone alla carriera, Il regista Luca Verdone (che l’ha presieduta) ed il critico, ex dirigente del CSC, Alfredo Baldi.
Una Giuria che ha valutato i 10 cortometraggi (durata non superiore ai 25 minuti), selezionati con il contributo di tutti i Cineclub Fedic, ed assegnato l’Airone al corto “Vomag” di Riccardo Salvetti che racconta la straordinaria storia, vera, di Hans Weidner che, deciso a tutto per di fuggire da Berlino Est, decise di sfondare il Muro di Berlino a bordo di un vecchio autobus scassato (marca Vomag) appositamente blindato per l’occasione. Lo ha premiato perché “si distingue per l’originalità del linguaggio che emerge coraggiosamente dalla felice sintesi tra l’elemento documentario e quello narrativo, che raggiungono risultati espressivi rilevanti e di notevole suspence, per raccontare una pagina di microstoria inserita nel grande quadro della storia del secondo dopoguerra”.
Nella motivazione la Giuria ha anche aggiunto:” E’ altresì incoraggiante per il lavoro svolto dal regista Salvetti notare come la propensione al linguaggio documentaristico che egli spesso adotta (come per “Poveglia”) sia una componente essenziale del suo stile”. E’ stata, inoltre, attribuita una Menzione Speciale al cortometraggio “Daniela” di Roberto Merlino ”per la descrizione appassionante e sincera di un caso clinico che ha come protagonista Daniela, una donna che, nel corso di vari anni, si è saputa liberare dalla condizione di infermità psichica cui sembrava condannata da un’ottusa pseudo-scienza medica, per arrivare a esprimere con gioia, libertà, profondità e originalità la propria personalità di pittrice”: una motivazione che indica anche il contenuto dell’opera. Le opere in concorso al Fedic Short erano 10 e sono state tutte recensite dai giornalisti Giuseppe Barbanti (“Nonsolocinema”) e Luca Griseri (Cinemaitaliano.info). Le proiezioni hanno avuto luogo nelle sale delle prestigiose Terme Tettuccio, sede di svolgimento di tutte le iniziative del Festival.
La Rete REFF nazionale ha premiato il corto “Indimenticabile” di Gianluca Santoni che ha per protagonista Luna, una ragazza disabile che sceglie di vivere la sua prima esperienza d’intimità amorosa pagando un escort. La scelta del REFF internazionale è, invece, caduta sul corto “White Mark” di Anton Mamkyn (Russia) su un minatore onesto che ammette di aver tradito la moglie, producendo così un’inclinazione in discesa della sua vita.
Per Fedic Scuola, le cui opere sono state visionate online e valutate da otto Cineclub FEDIC, ha vinto “Che ne sanno i 2000” del Cineclub Cineamatori delle Apuane, incentrato su un adolescente alle prese con una sorprendente scoperta: anche i nonni sono stati giovani alla loro età. Sul podio anche “Elisir (ajo)” (Cineamatori delle Apuane/Cagliari) e “Un mondo oltre la siepe” (Cineamatori delle Apuane).
Il Festival era ricco di altre iniziative, che hanno avuto un momento di spicco nell’Omaggio a Federico Fellini nel centenario della sua nascita che era collocato all’interno delle manifestazioni nazionali previste per l’iniziativa “Fellini 100”. Un’iniziativa espressa con un Video “Fellini, un affresco di vita di un grande regista” del filmmaker storico Fedic Giorgio Sabbatini e con la presentazione del libro della giornalista e scrittrice Marina Ceratto Boratto “La cartomante di Fellini. L’uomo, il genio, l’amico”: autori che hanno presentato personalmente le loro opere, intervistate da chi scrive.
Un Evento che è stato giudicato favorevolmente sia dall’Amministrazione comunale così come testimoniato dalle dichiarazioni del Sindaco Luca Baroncini e dall’Assessore alla Cultura Antonella Volpi, ma anche dai numerosi partecipanti al Festival le cui testimonianze si possono leggere nel numero 16 di Fedic Magazine.
FESTIVAL ED EVENTI
77. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
VENEZIA 77: LA MOSTRA DEL CORAGGIO
di Paolo Micalizzi
E’ stata la Mostra del Coraggio, quella del Cinema svoltasi Live al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Ed è stata giustamente premiata dalla presenza del pubblico e della critica che, pur nelle ristrettezze del Coronavirus, non hanno rinunciato a vedere film e cortometraggi, ma anche da presenze eccellenti del mondo del cinema. Una Mostra che ha avuto anche un ringraziamento ufficiale con il Premio MostraLido che è stato attribuito, nello Spazio dell’Ente dello Spettacolo all’Hotel Excelsior, al Presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, al Direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera e al Direttore Generale Andrea Del Mercato. Un Leone d’Oro, hanno aggiunto gli organizzatori, da condividere con tutto il team della Biennale: selezionatori, dipendenti e tutte le professionalità impegnate in questa grande sfida.
ll Premio è stato consegnato da Luca Pradel dell’Associazione Culturale MostraLido e da Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo con la seguente motivazione: “Nel 125 anniversario della sua Fondazione (1895 – 2020) la Biennale di Venezia ha saputo essere un esempio di cultura ed eccellenza capace di dimostrare al mondo il volto dell’ltalia migliore. Segno di un nuovo inizio, anche dopo 125 anni di storia”. ll “Leone d’oro” della Mostra è andato al film “Nomadland” diretto da Chloé Zhao ed interpretato da Frances McDormand.
Un’opera che costituisce un omaggio alla vita nomade, quella di alcune persone che hanno fatto da guida all’attrice Frances McDormand e alla regista (nata a Pechino ma ormai americana di adozione) nel loro viaggio in Camper attraverso i vasti paesaggi dell’Ovest americano. Portandoli alla scoperta di alcuni momenti di vita di questi nomadi moderni di indubbio fascino umano. Un verdetto, quello emesso dalla Giuria presieduta dall’attrice australiana Cate Blachett, non completamente condiviso. Le si rimprovera soprattutto di aver trascurato il cinema italiano. ln effetti potevano ambire a tale prestigioso premio anche tre film italiani che, seppur diversi, avevano un grande spessore autoriale. ll riferimento è a “Notturno” di Gianfranco Rosi, da noi preferito rispetto alle altre due concorrenti: “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante e “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli.
Il film di Rosi, girato nel corso di tre anni sui confini fra lraq, Kurdistan, Siria e Libano, racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze, sino all’apocalisse omicida dell’lSlS. Con gli occhi attenti su un’umanità che vive lungo il confine che separa la vita dall’inferno della guerra, mostrandoci scene strazianti che ti colpiscono al cuore. Tante emozioni anche nel film di Emma Dante, incentrato su cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento della periferia di Palermo, che ti coinvolge pienamente per l’amore che le lega e che tiene in vita la loro esistenza, anche dopo la morte. L’opera di Susanna Nicchiarelli è il ritratto di una donna, Eleanor Marx la figlia più piccola di Karl Marx, e ne sottolinea la sua partecipazione alle lotte operaie, il suo combattere per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Attualizzando temi del femminismo, non trascurando di raccontare anche la sua vita sentimentale finita tragicamente. Un bel ritratto di una donna colta, libera, appassionata. ll cinema italiano ha fatto comunque la sua gran bella figura nel Palmares con Pierfrancesco Favino che ha conquistato la Coppa Volpi come miglior attore per la sua interpretazione nel film “Padrenostro” di Claudio Noce. Riveste il ruolo di un vice questore che sfugge ad un attentato terroristico. Una storia che viene raccontata dal figlio di dieci anni che fa un’amicizia inquietante, la cui vera identità alla fine scopre una realtà che lega i figli ai padri. Per l’interpretazione femminile è stata attribuita invece a Vanessa Kirby per il film “Pierce of a woman” battendo se stessa avendo interpretato anche un altro film in Concorso, cioè “The world to come” dove riveste però un ruolo abbastanza scabroso in una love story tra due donne. Gran Premio della Giuria a “New Order” del regista messicano Michel Franco, ambientato in una rivolta popolare contro la polizia che dà il via ad un violento colpo di Stato. Una storia raccontata attraverso gli occhi di una giovane sposa durante una festa in una villa di Città del Messico.

ll Premio per la Miglior Regia è stato appannaggio del film “Wife of a Spy” di Kiyoshi Kurosawa che esplora lo sfaldarsi di una coppia nella notte prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale in cui pone l’accento su una moglie che mette in discussione l’amore verso il proprio marito ed il proprio paese.
L’Italia, come già detto, non è rimasta a bocca asciutta alla 77.ma Mostra di Venezia grazie a Pierfrancesco Favino che ha conquistato la Coppa Volpi per la sua interpretazione in “Padrenostro” di Claudio Noce in Concorso a “Venezia 77” e al Premio per la migliore sceneggiatura attribuito a Pietro Castellitto per il film da lui diretto “I predatori” che figurava nella Sezione “Orizzonti”. Un film sul pericolo che incombe in tutta l’Europa: il rigurgito del fascismo e dell’intolleranza. Che il giovane regista racconta attraverso le vicende di due famiglie che vivono nella giungla romana: una borghese e intellettuale, l’altra proletaria e fascista. Un incidente li farà collidere. E’ un racconto corale nell’ambiente odierno della destra romana.
Una Sezione, “Orizzonti”, in cui come miglior film è stato giudicato il film “The Wasteland”(Terra desolata) dell’iraniano Ahmad Bahrami, ambientato in un mattonificio di una località remota che produce mattoni in modo tradizionale ed in cui lavorano etnie diverse.
Un giorno il padrone chiede ad un quarantenne che funge da tramite con i lavoratori, che riveste nella fabbrica il ruolo di sorvegliante, di riunire gli operai davanti al suo ufficio perché vuole annunciare loro la chiusura della fabbrica. Lui, compreso quale potrebbe essere il suo futuro pensa di andare in un altro villaggio portando con sé la donna che ama. Per la Giuria, presieduta da Claire Denis, il miglior regista di “Orizzonti” è il filippino Lav Diaz per “ Genus Pan”, un film incentrato su tre minatori che decidono di tornare a casa dalle loro famiglie. Ma nel viaggio di ritorno attraverso la foresta esploderà una spirale di invidia, rabbia e violenza. Un altro film di Lav Diaz sulla natura animalesca dell’uomo, ed in generale sulla natura dell’intera società filippina dominata dalla corruzione.
Un premio speciale della giuria per “Listen” (Ascolta) della regista portoghese Ana Rocha de Sousa che si porta a casa anche il premio opera prima Luigi De Laurentiis – Leone del futuro: è incentrato su una coppia di migranti che vive, a fatica, con tre bambini in una zona periferica di Londra e conduce un’instancabile battaglia contro la legge per tenere insieme la propria famiglia.
Come sempre anche la SIC ha designato il suo vincitore. Che è stato “Hayalether” (Ghosts), opera prima della regista turca Azra Deniz Ekyav, un vivido ritratto delle tensioni che lacerano la società turca contemporanea.
Le “Giornate degli Autori” hanno premiato, grazie alla votazione del pubblico, “200 Meters” del palestinese Ameen Nayfeh: ha avuto il 68,9% di preferenze. Si tratta di un film sui ricordi dolorosi di un uomo che non ha mai potuto varcare quel muro che lo divideva, a soli venti minuti da casa sua, dai suoi parenti e dagli amici più cari. Sul podio (terzo posto con il 57,2%) il film italiano “Spaccapietre” (Una promessa) di Gianluca e Massimiliano De Serio. Un’opera sull’amore tra padre e figlio che non hanno più casa e sono costretti a rifugiarsi in una tendopoli.
Se alcuni film meritevoli non hanno avuto alcun riconoscimento, cosi non hanno fatto le varie Associazioni culturali che assegnano Premi Collaterali. Su “Notturno” di Gianfranco Rosi, per esempio, si è orientata l’attenzione dell”‘ArcaCinemaGiovani” che lo ha considerato Miglior film italiano, ma ha anche avuto una segnalazione di Cinema for Unicef al Premio Leoncino d’Oro di Agiscuola/Unicef ed un ex equo con “Non odiare” del Premio di critica sociale “Sorriso diverso Venezia 2020. “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli ha ottenuto il Premio Fedic, il Premio la Pellicola d’Oro assegnata alla sarta di scena Paola Seghetti ed il Premio Soundtrack Star per la colonna sonora relativamente alle musiche dei Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, mentre “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, altro film italiano sconfitto, è stato considerato miglior film dal Premio Francesco Pasinetti del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici ltaliani che ha anche premiato il cast come miglior interpretazione femminile: ha ricevuto anche il Premio Carlo Lizzani dell’Anac (Associazione Nazionale Autori Cinernatografici) e il Premio per il miglior direttore di Produzione attribuito a Cristian Peritore. Premiati anche altri film italiani: “Assandira” di Salvatore Mereu ha avuto una Menzione speciale Fedic, mentre altri hanno avuto riconoscimenti particolari: per “Non odiare” di Mauro Mancini, l’attore Alessandro Gassman è stato premiato per l’interpretazione maschile, per “Lacci” di Daniele Luchetti premiata, da RB Casting, Linda Caridi, Ma a ricevere Premi sono stati anche l’attrice esordiente Eleonora De Luca, interprete in due film :”Le sorelle Macaluso” e “Padrenostro”; e Giorgio Moroder per la carriera da parte di Soundtrack Stars che ha anche premiato il cantante Diodato con il premio speciale musica&cinema.
Riconoscimenti anche per il film “Padrenostro” (già gratificato con la Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino) di Claudio Noce che ha ottenuto il Premio di critica sociale “Sorriso diverso Venezia 2000” da Viaggio Turismo Enit) ed un riconoscimento al capo macchinista Raffaele Alletto da “La Pellicola d’Oro”. Per quanto riguarda l’ltalia, premi anche per il cortometraggio: “Finis Terrae” di Tommaso Frangini ha ottenuto una menzione speciale Fedic, “”Le mosche” di Edgardo Pistone, il Premio alla migliore regia e “Gas station” di Olga Torrico il premio al miglior contributo artistico: tutti e tre sono stati presentati nella Sic&Sic. Un film che avrebbe meritato di essere premiato dalla Giuria presieduta da Cate Blanchett è sicuramente l’interessante “Quo Vadis, Aida? Di Jasmila Zbanig che racconta la guerra in ex Jugoslavia con gli occhi di una donna, quelli di una traduttrice dell’ONU di base a Sebrenica nel 1995, in cerca di un rifugio per Ia sua famiglia e Ia sua gente mentre l’esercito serbo occupa la città. Ci hanno pensato l’Unimed (Unione delle Università del Mediterraneo] e il Brian. Un premio anche per “Places of a Woman” di Kornél Mondruczò su una donna che oltre al dolore per la perdita del bambino dovrà affrontare il confronto in un processo con la negligente ostetrica e gestire le difficili relazioni con il marito e la dispotica madre. ll Leone d’Oro “Nomadland” ha ricevuto anche il Premio Collaterale Fair Play al Cinema – Vivere da sportivi e una menzione speciale da parte della cattolica Signis.
Alla Mostra di Venezia di certo non c’è stata l’atmosfera festosa degli altri anni. Colpa, come è drammaticamente noto, del Coronavirus che ha frenato la partecipazione di colleghi, di pubblico e di tanti Divi. È stato un po’ triste non poter vedere a causa di alcune barriere il Red Carpet, ma soprattutto l’affollamento di tantissimi fan che sin dal mattino campeggiava nella zona in attesa delle Star, che, comunque, non sono mancate del tutto. Ma se i Divi non c’erano Live cosi come eravamo abituati, una Mostra ci ha riproposto quelli del passato e del presente. Mostra intitolata “Divine. Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018”. Curata dal Direttore Alberto Barbera con l’organizzazione della Biennale con il suo Archivio Storico, è stata allestita fino al 1° novembre, con ingresso gratuito, a Forte Marghera, ex polveriera austriaca. Erano esposte 92 fotografie di attrici divise cronologicamente in quattro periodi. Dal 1932 al 1952, dal 1953 al 1967, dal 1970 al 1991 e dal 1993 al 2018. Sono immagini di Dive indimenticabili come Ingrid Bergman, Anna Magnani, Greta Garbo, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, Michèle Morgan, Lauren Bacall, Bette Davis, Sophia Loren, Gina Lollobrigida.
Ma anche di “Divine” d’oggi, quelle che negli anni più recenti abbiamo visto alla Mostra di Venezia: Claudia Cardinale, Julie Christie, Meryl Streep, Isabelle Huppert, Michelle Pfeiffer, Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Monica Bellucci, Valeria Golino, Cate Blanchett. Un bel tuffo nella bellezza e nei miti del cinema.
Alla Mostra di Venezia era presente, anche se per poche ore, il regista Pupi Avati che ha ricevuto all’Ente dello Spettacolo il Premio Robert Bresson, alla presenza del Presidente della Biennale Roberto Cicutto e del Direttore della Mostra Alberto Barbera che, parlando di lui, ha affermato, tra l’altro, “I meriti di Pupi Avati sono tantissimi ed è inutile elencarli: partendo dalla provincia è riuscito a conquistarsi una posizione di prestigio nel cinema italiano, dando vita a una società di produzione con cui ha tutelato la sua creatività. Pupi è un grandissimo narratore di storie che rimarranno: gli spettatori di domani scopriranno qualcosa di questo Paese grazie ai suoi film». E Mons. Davide Milani, Presidente dell’Ente dello Spettacolo, nel consegnargli il prestigioso riconoscimento ha sottolineato «che si tratta di un premio per andare oltre ciò che ci imprigiona e a partire da ciò che ci imprigiona, per volare verso il senso nella forma di una scultura in argento che rappresenta una gabbia da cui si stagliano delle ali. Il suo significato è ben preciso: invita ad andare oltre ciò che ci affatica. Verso la grazia, che deriva dalla realtà che viviamo e non è un assoluto sciolto dalla contingenza». Intervistato dalla giornalista Tiziana Ferrario, Pupi Avati ha raccontato, da grande affabulatore, aneddoti e retroscena della sua carriera di regista. Partendo da quando era venditore di surgelati ed aveva sposato la più bella ragazza di Bologna a quando avendo visto “8 e 1/2” di Federico Fellini ù si convinse a prendere la strada del cinema. Aggiungendo che la sua è stata un’esistenza attraversata da incontri speciali, tra cui, Mario Monicelli, Pier Paolo Pasolini e Mariangela Melato che tanto insistette per entrare nel suo film e che lui cercava di respingere, ma che quando si mise a recitare, lo fece talmente commuovere al punto di non riuscire a dare lo stop. Quel film era “Thomas…e gli indemoniati”, girato nel 1969 a Ferrara, e che chi scrive l’ha invitato, sostenuto anche da altri estimatori, a riportare alla luce. Pupi Avati ha anche parlato del film che sta girando proprio a Ferrara, “Lei mi parla ancora”. Terminate le numerose interviste, ha ripreso la strada per ritornare sul set a continuare la lavorazione del film.
Alla Mostra sono stati presentati anche alcuni film importanti sul rapporto Cinema e Lavoro. A partire da un film che nella Sezione “Venezia 77″ ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria, presieduta dall’attrice Cate Blanchett.Ci riferiamo a “Dorogie Tovarischi! “(Cari Compagni) di Andrei Konchalovsky, regista che nei suoi film racconta ansie e contraddizioni della Russia contemporanea. Come fa anche con “Cari compagni” che è incentrato su una donna, membro del Partito comunista di Novocherkassk, i cui ideali cominciano a scricchiolare quando assiste a una sparatoria su degli operai di una fabbrica di locomotive che stavano protestando per l’aumento del prezzo di carne e burro e le sempre più dure condizioni lavorative imposte per aumentare la produzione, ordinata dal governo per reprimere lo sciopero. Molti i feriti e i dispersi, un vero massacro, e fra le persone di cui non si hanno notizie vi è anche la figlia. Che lei va a cercare tra i tumuli di cadaveri occultati in un campo sotto falso nome affinché non venissero mai ritrovati. Tra essi però non c’è la figlia di lei cercata in un’affannosa quanto rischiosa ricerca poiché la vediamo apparire all’improvviso in famiglia. Un evento che cambierà per sempre la visione del mondo da parte della donna. Non una fiction di pura invenzione, ma un’opera basata su un fatto realmente accaduto in quella cittadina russa il 2 giugno del 1952 e secretato fino agli anni Novanta.
Alla realtà è anche legato il film di Susanna Nlcchiarelli “Miss Marx”, cioè la figlia più piccola di Karl Marx I’autore di “ll Capitale”. Una persona, di cui la regista, evidenzia, oltre alle vicende personali, l’essere stata tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, l’aver partecipate alle lotte operaie, l’aver combattuto per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. “ll ritratto di una donna fortissima, dichiara la regista che si era rivelata nel 2009 proprio alla Mostra di Venezia con il film “Cosmonauta”, nella quale però la forza delle convinzioni poteva sbriciolarsi di fronte alla sfera emotiva”. Alla Mostra anche il ritratto di un’altra donna coraggiosa. Si tratta di un personaggio illustre della vita italiana che è stata Presidente della Camera per tre legislature tra il 1979 e il 1992. ln “Nilde lotti, il tempo delle donne” (presentato a “Le Giornate degli Autori”), il regista Peter Marcias ne evidenzia le faticose battaglie da lei intraprese che sono alle origini dei diritti delle donne: la interpreta Paola Cortellesi.
La trasformazione del mondo rurale in agriturismo nella corsa al business è al centro di “Assandira” di Salvatore Mereu, presentato “Fuori Concorso”. Un film che prende l’avvio da un incendio dove ci lascia la vita il figlio di Costantino (interpretato in maniera eccezionale dallo scrittore sardo Gavino Ledda) dal quale si si era fatto convincere, anche sotto la spinta ambiziosa della nuora tedesca, a trasformare Ia sua terra sarda, che prima era dedita al pascolo delle pecore, in agriturismo ad uso e consumo dei turisti nordeuropei. La storia dei Vigili del Fuoco è raccontata in “Fuoco Sacro” di Antonio Maria Castaldo.
Un docu-film (presentato, come Evento, “Fuori concorso”) che nasce dalla domanda: “che cosa spinge uomini e donne a rischiare la propria vita per salvare quella degli altri”? Alla quale si dà riposta attraverso la voce dei protagonisti che, in mezzo secolo di storia, hanno affrontato con abnegazione e competenza le più grandi calamità che l’Italia ha tragicamente vissuto sulla propria pelle. Con “Fuoco Sacro” ha dichiarato il regista “ho voluto onorare tutti quegli uomini e quelle donne che con amore e competenza hanno fatto diventare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Il racconto della vita di un uomo, Salvatore Ferragamo, che ha creato scarpe per i più grandi Divi di Hollywood è, invece, nel documentario di Luca Guadagnino “Salvatore – Shoemaker of Dreams” (Salvatore – Calzolaio dei sogni). Due ore di film per raccontare una vita nella quale si intrecciano la storia dell’emigrazione italiana e quella del sogno americano, partendo dai diari che Salvatore Ferragamo ha la sciato. “Un materiale ricchissimo, dichiara il regista, incredibile, denso di aneddoti, dettagli, un racconto di vita nella quale si intrecciano mille temi” che gli consente, come vede nel film, di attraversare anche la storia stessa di Hollywood, rendendo omaggio al cinema. La vicenda di un uomo che partito da un piccolo paese del Sud ltalia (Bonito, in lrpinia) raggiunge il successo ad Hollywood, superando anche la crisi del 1929 in America, e ritornando poi ad operare in ltalia a Firenze. Altro personaggio all’attenzione del cinema è “Greta” di Nathan Grossman incentrato sulla studentessa svedese di 15 anni Greta Thunberg che nell’agosto del 2018 inizia uno sciopero per il clima che nel giro di un mese si trasforma in un movimento globale. Il film vuol raccontare la storia del suo modo di pensare nel tentativo di rappresentare il mondo dal suo punto di vista. ll film è stato presentato “Fuori concorso”, mentre alle “Giornate degli Autori,’ si è visto “Spaccapietre – Una promessa” di Gianluca e Massimiliano De serio, un film sul bracciantato partendo dal ricordo degli autori della nonna paterna morta a soli 33 anni mentre lavorava come bracciante a giornata sotto un caporale, nella Puglia del 1958.
Ripetiamo, una Mostra del Coraggio (con la C maiuscola), perché, come ha dichiarato Alberto Barbera, nella Conferenza Stampa, hanno operato in una situazione nella quale le regole del gioco cambiavano in continuazione, costringendoli a grandi flessibilità e ad essere disponibili a continue operazioni di cambiamenti di rotta. Arrivando alla fine, e con anticipo, alla decisione di effettuarla nelle date indicate. Chapeau!
LA BIENNALE DI VENEZIA
77 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA
APPUNTI DI UN SOCIO FEDIC, GIORNO PER GIORNO
di Luciano Volpi
E’ difficile iniziare a parlare di una kermesse gioiosa per tutti i protagonisti. Il pubblico pagante, quello curioso, gli abitanti del Lido, con questo odio-amore nei confronti di questo mostro che tutti gli anni deturpa il loro confort. I partecipanti da tutto il mondo, con il business a fare da padrone assoluto, gli attori e gli artisti a sfoggiare il loro personaggio dopo mesi e renderli irriconoscibili agli occhi di chi dopo alcune ore li ha visti sul grande schermo.
Le case di produzione mondiali, hanno dovuto dare forfait, a causa del Covid.
Chi doveva decidere se intraprendere di nuovo dopo 75 anni di imperterrita continuità, ha tentennato come si suol dire e come poi spifferato alla fine, dai direttori sia della Biennale sia della Mostra, giorno per giorno hanno preso delle decisioni in base a come si evolveva la situazione. Nella riunione, dove ho presenziato, nella consegna dei premi e menzioni speciali della Fedic a cui appartengo, si è potuto appurare quanto sia stato difficile portare avanti tutta la macchina organizzativa.
Lo stesso dimezzamento dei posti, come anche una categoria come Sconfini e lo stesso VR da vedere online, hanno ridimensionato la Mostra del Cinema fino dalla sua creazione organizzativa.
Sicuramente la dea bendata ha favorito certe decisioni, un po’ di spregiudicatezza fino a pensare di iniziare e poi se le cose si mettevano male prima, durante e dopo, chiudere tutto e dire abbiamo scherzato oppure osato troppo.
Tutto questo non è successo e pure con qualche adattamento da parte di tutti, la Mostra del Cinema ha dato ottimi risultati sia in termini di pubblico pagante e di accreditati.
Per quanto mi riguarda come accreditato da ormai sei anni, alla titubanza nell’iscrivermi, con il dubbio poi eventualmente di perdere i soldi del pagamento anticipato in caso di rinuncia, alla fine la 77 Mostra è stata la più intensa e forse la migliore vista e vissuta.
Sarà una mia ottica particolare, ma anche sotto le restrizioni, ho dato e ricevuto il meglio. Prendiamo per esempio, l’accesso alla zona della Mostra con le nove postazioni, due in più, per il controllo e la misurazione della temperatura e la scorrevolezza delle stesse operazioni. L’obbligo della mascherina sempre, anche e soprattutto nelle sale durante tutta la proiezione, con il disturbo degli stuart sulla eventuale caduta dal naso della stessa e il repentino ripristino nella sua posizione corretta. Confesso il mio disappunto quando succedeva, ma per il bene di tutti, mi sono adeguato fino a non farci più caso perché ligio al dovere. Niente code per gli ingressi, se non quattro-cinque persone, dovuto al fatto che se ti dovevi presentare all’ingresso della sala, era necessario comunicare il numero del posto precedentemente prenotato. Questa prerogativa farà scuola per il futuro, ed è già stata appurata e conclamata da tutti, consumatori ed organizzatori. La piattaforma ha funzionato molto bene, con il dovuto approccio iniziale da digerire, ma dopo è stato un divertimento assoluto.
Queste le sole difficoltà iniziali, stemperate anche dal fatto che le sale di proiezione sono aumentate, le proiezioni rispetto agli anni scorsi sono state quadruplicate con il risultato che in sala, oltre al distanziamento sia laterale che davanti e dietro, anche quando era pieno sembravano e veramente lo erano mezze vuote ed i film sono stati goduti e capiti moto meglio.
Questa analisi, a dire il vero, sembra trascurare il perché di questo miglioramento e che il tutto è dovuto al Coronavirus, che ha inasprito le misure, ma che in qualche modo alla fine non ha fatto altro che migliorare certe necessità. Invece sotto il profilo economico e sociale, con perdite sia umane che sociali, la catastrofe è sotto gli occhi di tutti noi che ancora mentre scrivo è palpabile, ci stiamo adattando a questa nuova forma di esistenza.
Primo giorno, venendo ai film e documentari visti fino dall’inizio con il film di pre-apertura e Fuori Concorso di Andrea Segre ” Molecole “.
Anche senza volerlo, siccome è girato tutto a Venezia, è stato scelto appositamente per entrare in sintonia e parla della infanzia del regista, i racconti del padre veneziano sull’acqua alta, le maree e la vita dei veneziani veraci. Molto bello per immergersi nei vecchi racconti veritieri di questa gente.
Secondo giorno e primo per la Mostra del Cinema, Fuori Concorso di Daniele Luchetti ” Lacci ” film di apertura. Molto bello, italiano, bella storia con molti protagonisti bravi e che rivedrò sicuramente. Poi la giornata è passata con la vista di un film Fuori Concorso giapponese “Night in Paradise”, triller molto bello. Un film greco di apertura in Sezione Orizzonti ” Mila (Apples) “, complicato sulla perdita di memoria sempre più frequente in Grecia. Un bel film Indiano “Milestone” che ho avuto il piacere ed il desiderio di rivedere, tanto fatto bene in un ambiente di autotrasportatori, girato molto bene con una storia lenta ed inesorabilmente particolare di vita di quei luoghi così lontani da noi ma tanto attuali, come povertà ed umanità. Se uscisse in Italia lo consiglierei per una serata al cinema.
Poi per non farsi mancare niente, per la Settimana Internazionale della Critica, un corto del mio amico Adriano Valerio, partecipante al Festival Fedic di San Giovanni Valdarno con “Banat”, vincitore di premi, ho visto ” Les Aigle de Carthage “. Storia vera di una memorabile partita di calcio rivissuta dal popolo Tunisino contro l’odiato Marocco. Semplice e carino.
Una toccatina e fuga, cosa che succede quando inizi, sei già stanco, il film non ti dice nulla e ti alzi insoddisfatto ” The Book of Vision ” di Carlo H. Hintermann. Subito dopo il film tedesco ” Final Account ” con le interviste totali a novantenni tedeschi abitanti di cittadine dove erano i campi lager e la loro completa estraneità ed incredulità ai fatti accaduti. Inconcepibile verità negata ma testimonianza vera e crudele.
Terzo giorno, inizia con il primo corto della Sezione dove dall’anno scorso il mio amico Paolo Micalizzi, giornalista e vera anima della Fedic mi ha inserito, Settimana della Critica Sic@Sic e l’obbligo di vedere undici corti e dare dei voti di merito. ” Gas station ” di Olga Torrico mi è piaciuto nei suoi dieci minuti.
Poi primo film in Concorso77, “Amants” di Nicole Garcia, bellissimo film francese. Sicuramente esce in Italia e va visto e rivisto, anche se costruito ad arte.
Di corsa a vedere ” The Human Voice ” di Pedro Almodovar, trenta minuti di quella straordinaria attrice che verrà premiata con il Premio alla Carriera Tilda Swinton. Geniale, particolare, con un monologo sulla crisi di una donna che finge di lasciare il suo amore per non trovarsi in quella situazione.
Subito dopo, senza alzarsi dalla sedia, novità di quest’anno e direi buona, ripetuta per il pubblico nel pomeriggio, ” Quo Vadis, Aida? ” in Concorso77 il film bosniaco fatto molto bene sulla storia vera del massacro di Srebreniza, per me già vissuto e partecipato a San Giovanni Valdarno con due giorni di gemellaggio e lo svisceramento di questa tragedia umanitaria che ha causato ottomilacinquecento morti, tutti della cittadina bosniaca con donne e bambini musulmani, che per esigenze realizzative è solo in parte raccontata.
In Concorso77 ” The Disciple ” di Chaitanya Tamhane. Bel film Indiano, un po’ monotono con la musica monofonica carnatica (Rada), millenaria classica locale. Lascia una buona impressione di cinema oltre i nostri confini Europei ed ottiene il Premio come migliore Sceneggiatura. Poi altri due corti della mia sezione che non mi sono piaciuti.
Quarto giorno e subito di buon’ora un corto della mia sezione da vedere, “Le mosche” di Edgardo Pistone, quindici minuti su un gruppetto di adolescenti napoletani che non hanno “fermezza”. Poi di corsa a vedere un capolavoro del cinema inglese che spesso non si smentisce, ” The Duke ” di Robert Michell, storia vera, interpretata dalla splendida Helen Mirren e da Jim Broaddbent, vera star del film, purtroppo sembra che esca nel 2021, bisogna aspettare un po’. Poi subito dopo “Padrenostro ” di Claudio Noce, bellissimo film italiano, vero ed intenso, con il miglior attore a Venezia77, Pierfrancesco Favino. Complimenti a tutti ed al regista.
A seguire, quello che poi diventerà il mio miglior film ” Pieces of Woman ” di Kornél Mundruczò con l’eccezionale Shia LaBeouf e la poi premiata migliore attrice di Venezia77, Vanessa Kirby. Come uomo ho fatto il tifo anche io per i primi quindici minuti, ho soffiato e respirato con loro. Bello, originale ed il seguito del film ti commuove e lascia il dolce in bocca alla fine. Per finire l’altro mio carissimo amico di Festival Fedic, Abel Ferrara con il suo documentario Fuori Concorso “Sportin’ Life” ed il suo interprete Willem Dafoe.
Quinto giorno che inizia con un corto dell’italiano Xin Alessandro Zheng ” Le foglie che cadono “, quindici minuti di tranquillità. Senza alzarsi, ” Non odiare ” con Alessandro Gassman, della Settimana della Critica, di Mauro Mancini. Film molto sponsorizzato a Venezia, già ad oggi che scrivo nelle sale, da vedere, capire ed interrogarsi se ci capita cosa faremo e come lo faremo.
Poi in Venezia77 “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli. Da me molto atteso, visto il nome e la storia della figlia minore di Marx. Bellissimo, girato benissimo ed anche interpretato, meritevole di premi non assegnati, purtroppo deludente con la storia, ma la brava regista non ha colpa. In serata il documentario di dodici minuti Fuori Concorso ” Fiori, Fiori, Fiori ” di Luca Guadagnino sulla sua Sicilia dopo il look down. Subito dopo l’omaggio molto bello a Salvatore Ferragamo ” Salvatore – Shoemaker of Dreams ” bella la storia raccontata sempre da Luca Guadagnino. Chi si ferma è perduto ” Khorshid” (Sun Children) in Concorso77 film bello Iraniano di Majid Majidi. Essendo in Iran si accetta tutto, bel film, carino, girato molto bene con protagonisti bambini molto bravi, in un contesto veritiero sullo sfruttamento del lavoro minorile. Riceve il Premio “Marcello Mastroianni“.

Sesto giorno che inizia con il solito corto della mia sezione, “Accamòra “undici minuti calabresi di Emanuela Muzzupappa. Poi ” The World to Come ” di Mona Fastvold in Concorso77. A me è risultato un film sconvolgente, sia per il contesto femminilistico che per la trama e la conclusione. In sostanza lascia soddisfatti ed increduli, con la premiata Vanessa Kirby. Altro film in Concorso77 ” Never Gonna Snow Again ” di Malgorzata Szumowska e Michal Englert. Complimenti per la storia, elegante, simpatico e realista quanto basta, buona la doppia regia e le immagini. Un magico massaggiatore, entra nella vita di facoltosi abitanti nella periferia di una città ricca polacca, dove prospera tristezza e desiderio. Subito dopo immersione in Sardegna con il film di Salvatore Mereu ” Assandira ” Fuori Concorso. Bel film sulla storia vera dell’incendio che ha distrutto il bell’Agriturismo.
Settimo giorno con il corto che poi sarà premiato con la Menzione speciale Fedic, ” Finis Terrae ” di Tommaso Frangini cosi descritta: – Storia di una solitudine che decide di scomparire per non dare più fastidio al prossimo “.
Poi ” Cari Compagni ” in Concorso77 di Andrei Konchalovsky. Film russo di un fatto realmente accaduto nel 1962 e secretato fino agli anni 90. Durante una manifestazione operaia, con molti morti e feriti ed arresti. I responsabili non sono mai stati condannati, perché i principali sospettati negli alti vertici governativi erano già morti. Film semplicemente favoloso in bianco e nero e mi domando come sarebbe stato a colori. La coppia Andrei – Julia sua moglie ed interprete del film, ha centrato il bersaglio, ottenendo il Premio speciale della Giuria. Altro film in Concorso77 ” Laila in Haifa ” di Amos Gitai. L’Israeliano Amos non si smentisce con questo film colorato, elegante, attuale ed evoluto nel focalizzare il problema atavico fra arabi, palestinesi ed ebrei, con uomini e donne etero e gay, radicali e moderati, tutti racchiusi in un locale, dimostrando che si può essere diversi e che non si deve necessariamente uccidere o distruggere l’altro.
Ottavo giorno con il corto ” J’ador ” di Simone Bozzetti ed il tentativo incuriosito di assistere ad un film lungo della settimana della critica, andato a vuoto costringendomi ad alzarmi prima della fine. Gianfranco Rosi presenta ” Notturno ” documentario molto bello ammesso in Concorso77. Solo per il tempo trascorso a girovagare per immagini in Iraq, Kurdistan, Siria, e Libano, tre anni, nel tentativo di riprendere e filmare persone che in quei luoghi in perenne guerra, cercano e tentano di ricucire le loro esistenze. Un film della sezione Orizzonti, consigliatomi da mia moglie e che non mi ha lasciato completamente soddisfatto. Girato molto bene ed interpretato altrettanto, la storia è molto bella ed attuale con la famiglia ed i bambini tolti, quindi c’è tutto meno il più piccolo che viene definitivamente tolto e dato in adozione. Comunque ha preso due premi della sezione, Premio Leone del Futuro e Premio speciale della Giuria. Altro piccolo corto “Omelia contadina” di Alice Rohrwacher e JR. In nove minuti è raccontata la morte inflitta ai contadini di tutte le epoche, ma con ironia. In Concorso77 “Spy no Tsuma” (Moglie di una Spia) di Kiyoshi Kurosawa. Bellissimo film giapponese, misterioso ed affascinante nella trama, mostra il vero volto giapponese nelle immagini. Alla Mostra premiato con il Leone d’Argento, ed è tutto dire.
Nono giorno, in Concorso77 ” Le sorelle Macaluso ” di Emma Dante. Film italianissimo con dodici interpreti tutte femmine e bravissime. Diviso in tre capitoli corrispondenti ad una età precisa, infanzia, l’età adulta e la vecchiaia. Film sul tempo e l’amore fra sorelle, sulla memoria e sulle cose che durano. Sulle persone che restano anche dopo la morte e sulla vecchiaia come incredibile traguardo della vita. Emma Dante ha partorito un capolavoro. Poi altro Concorso77 “E domani un altro giorno” film tedesco di Julia von Heinz che prende un voto alto nella mia personale classifica perché la regista centra il problema sociale tra destra ed oppositori in Germania, mettendo a nudo anche la realtà europea. In serata Fuori Concorso ” Paolo Conte, Via con me ” di Giorgio Verdelli. Bel documentario sulla vita di questo straordinario cantautore-avvocato, di cui conosciamo moltissimo sulla prima professione, ammirandolo e cantando tutte le sue canzoni scritte ed anche interpretate da altri famosi cantanti. Bella serata con moltissima musica ma anche la filosofia di questo personaggio quasi unico.
Decimo giorno con l’ultimo corto della mia sezione e poi una chicca di Alessandro Rossellini, nipote un po’ scapestrato del famoso nonno regista Roberto. ” The Rossellinis “, oltre ad essere fatto bene, con coraggio nell’affrontare ed interrogare i parenti, cugini come Isabella, deux macchina di tutta la famiglia, mette in risalto le vite vissute dal famoso regista, con più famiglie figli e figliastri. Piacevolissimo e se capita di vederlo si rimane positivamente affascinati.
In Concorso77 “Nuevo Orden” di Michel Franco. Sconvolgente film, ennesimo film messicano che mette a nudo il modo sconnesso di vivere di questo popolo, bravissimo Michel Franco a dirigere questo film e quindi a meritarsi di prendere il Gran Premio della Giuria a Venezia77.
Questa decima giornata è intervallata dal 25° Forum FEDIC a cura di Paolo Micalizzi – Fedic Cinema, a cui prendo parte da tre anni. Si svolge nella prestigiosa cornice dell’Hotel Excelsior nello Spazio Incontri Venice Production Bridge con lo scopo di mettere in risalto opere di Autori Fedic ed il tema di quest’anno è “Il futuro del corto di autore”. Molto ben organizzato e ristretto in sole due ore, dato la location messa a disposizione, ma ricco di contenuti e di piccole discussioni ed esperienze, nonché di progetti, come quello ormai puntuale grazie alla FEDIC, che da anni propone Il cinema nella scuola con Laura Biggi (Responsabile Fedic Scuol) e Ilaria Copeta (Booktrailer Film Festival), dando vita alle proiezioni della Fedic Scuola. Si rimane meravigliati dalle tante idee che escono fuori sia dagli autori Fedic che dai ragazzi delle scuole presenti come quelli del Liceo di Brescia. Dopo, riunione per stabilire la menzione speciale come ho già accennato per i cortometraggi e pizza-riunione insieme all’altra Giuria, fine della serata con altro film in Concorso77 “In Between Dying” di Hilal Baydarov. Film di Azebairgian, Messico e Usa. Semplicemente la storia di una vita, racchiusa in 92 minuti. Hilal sarebbe da premiare per me, ma forse è troppo complicato parlare dell’amore basandosi sulla frase di Bresson ” sentire prima della comprensione “.
Undicesimo giorno In Concorso77 ” Nomadland” di Chloé Zhalo con Frances McDormand. Per me troppa aspettativa, il concetto del film è valido, un pò sopravvalutato ma va bene. Gli attori molto bravi anche quelli raccolti nella zona. Vince meritatamente il Leone D’Oro 2020.
Nella sezione Orizzonti ” I Predatori ” di Pietro Castellitto che si prende il premio come Migliore Sceneggiatura. Sconvolgente e particolare, ma alla fine mi è piaciuto e il regista si è distinto anche come attore. Ultimo film Fuori Concorso e film di chiusura della Mostra ” Lasciami andare ” di Stefano Mordini. Da vedere e rivedere per il contesto veneziano, gli attori, la storia commovente, anche se lascia degli interrogativi.
In conclusione, sono tanti i motivi che mi lasciano contento e felice. L’aver passato dieci giorni in serenità, parola grossa ma veritiera, superando i motivi che conosciamo con forza di volontà ma aiutato dalla meraviglia di Venezia, sempre bella ed affascinante, ora di più senza mega navi e meno gente per le calli. Anche il Lido è sembrato più bello, le spiagge ancora aperte con meno gente e rumorosità, più disponibilità nei nostri confronti, precedentemente motivo di disturbo con biciclette e quant’altro. La mia nuova sistemazione, frutto di sacrifici precedenti con adattamento sia per dormire in abitazioni con i proprietari, diventati però amici, sia per mangiare con orari e pasti saltati. Quest’anno, fortunatamente anche per le prenotazioni online, c’è stato più tempo a disposizione, la nuova abitazione più spaziosa e comoda, sempre vicino alla Mostra e la gentilezza della proprietaria che ha subito legato con mia moglie.
Cosa si vuole di più !!! dei bei film, delle belle storie originali e non, delle belle sceneggiature, la fotografia sempre ottima e quella che piace di più a me, che mi trasporta in luoghi meravigliosi, spazi aperti, chiusi come con Amos Gitai, attori e attrici protagonisti e non molto bravi, bambini sempre più bravi e sempre più protagonisti. I registi da me sentiti nominare, famosi, che quest’anno ho potuto anche se soltanto per un film, scoprirne il pensiero e quando questo viene dopo tanti film e storie prodotte, si pensa che siano frutto di novità non ancora sperimentate ed espresse.
Questo è stato da me capito e registrato, lasciandomi con la bocca dolce, anche se qualcosa non mi è piaciuta, ma fa parte del gioco e lo rende ancora più bello.
Credo di essermi arricchito cinematograficamente, ho carpito cose nuove, originali, della vita che cambia o che è sempre stata cosi ma non ci ho fatto caso. In tutto questo sicuramente c’è la mano di chi ha saputo scegliere i film tra quelli a disposizione o quelli che potevano essere disponibili, anche se poi saranno perfezionati nei futuri montaggi, Una cosa mi è molto chiara, durante questa Mostra, più temi si ripetevano, come un fil rouge, ho trovato una sequenza di motivazioni che scoperte in un film, avevano un proseguimento in un altro, sotto un’altra forma e sostanza, ma era come se qualcuno lo avesse già raccontato e sottolineato. Il tema dei rapporti tra persone dello stesso sesso femminile, l’amore, quello c’è sempre e la violenza di uno stesso stato come il Messico, lo sfruttamento minorile, la musica antica, per non parlare di cinema Iraniano, Pakistano con le storie di vita, Polacco in crescita, il cinema Giapponese sempre in ottima forma ed il cinema Francese (con un solo film però, ma bellissimo). È mancato il cinema Americano, se non con qualche co-produzione, ma forse è stato meglio per disintossicarsi da Hollywood.
Alla prossima, Venezia.
IL CINEMA, ANCHE QUELLO DEL PASSATO, VINCE IL CORONAVIRUS
di Vittorio Boarini
Il cinema al tempo del Covid 19 non solo sopravvive, ma continua ad avere cura della propria storia, dei capolavori del passato, ma anche di tutti i film che in qualche misura contribuiscono a definire la sua identità. Lo abbiamo constatato con gioia quando, a Bologna, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha anticipato la sua ormai consolidata sezione Venezia Classici che, per l’occasione, è stata ospitata dal Cinema Ritrovato. La Mostra veneziana, infatti, primo dei grandi Festival internazionali ad aprire le sale per la sua 77. edizione, mettendo in campo un formidabile apparato per garantire la sicurezza degli ospiti, ha stretto una felice collaborazione con Bologna per cui, una settimana prima dell’inaugurazione al Lido, i film restaurati selezionati da Venezia per la propria tradizionale rassegna, hanno iniziato ad essere programmati nel migliore contesto si potesse desiderare. Come è noto, il Cinema Ritrovato, giunto alla sua 34. edizione, è una manifestazione dedicata al ritrovamento, al recupero e al restauro dei film, con una sezione, Ritrovati e Restaurati, nata con il Festival, che quest’anno presentava ben 67 titoli. In questa circostanza i due film italiani di Venezia Classici, per fornire un solo esempio significativo, si trovavano in compagnia di due straordinari film di P.P. Pasolini (“Accattone” e “Comizi d’amore”) e de “I Cento Cavalieri” di Vittorio Cottafavi, un vero e proprio babà per i cinefili.
I film italiani di Venezia non sfiguravano affatto al loro confronto perché si trattava di “Cronaca di un amore”, primo lungometraggio di M. Antonioni edi “Sedotta e abbandonata”, secondo film della nota trilogia di Pietro Germi (gli altri erano “Divorzio all’italiana” e “Signore e signori”) che tanto scalpore sollevò fra il 1961 e il 1965.

Il film di Antonioni è del 1950, quando la grande stagione del neorealismo è praticamente conclusa, anche se Rossellini, padre nobile della tendenza, non vi ha ancora messo la pietra tombale con “Viaggio in Italia”, percorrendo la penisola all’inverso rispetto alle truppe alleate nel 1943-45 (“Paisà”). Ma non era concluso il dibattito su quella temperie culturale che, anzi, si trascinerà ancora a lungo in termini ideologici. Antonioni, che sostanzialmente non era mai stato neorealista nei suoi straordinari documentari, realizza un’opera nella quale non ricorre alcun elemento della tradizione neorealista, a cominciare dall’oggetto su cui cade la sua lente d’ingrandimento, non il popolo, ma la borghesia italiana ai suoi vari livelli, oggetto che continuerà poi a tenere inquadrato con la parentesi di “Il grido”, un capolavoro che ha per protagonista un operaio, il quale però risolverà la sua crisi esistenziale uccidendosi. Poi le innovazioni linguistiche, prima fra tutte l’uso, allora poco frequente, del piano sequenza, che diverrà un cavallo di battaglia del nostro regista, e l’attenzione all’oggettività dell’ambiente in cui si muovono i suoi personaggi, dei quali emergono, anche dal confronto con l’ambiente stesso, la personalità e i sentimenti più profondi. Abbiamo così, un’operazione critica che Antonioni stesso descrive esattamente, “Ho analizzato la condizione di aridità spirituale e anche un certo tipo di freddezza morale di alcune persone dell’alta borghesia milanese, proprio perché mi sembrava che in questa assenza di interessi al di fuori di loro, ….in questo vuoto interiore, ci fosse materia sufficientemente importante da prendere in esame (Il mio Antonioni, a cura di Carlo Di Carlo, Edizioni Cineteca di Bologna 2018). Il film costituisce una svolta nel cinema italiano superandone una sintassi consolidata e divenuta stereotipa, aprendo così, alla fine di una gloriosa stagione, nuovi orizzonti.
Il film è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna con la collaborazione di Surf Film, presso L’Immagine Ritrovata con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
In quanto a “Sedotta e abbandonata”, ”una farsa tragica con qualche vertigine grottesca, una tarantella macabra che accompagna con forzata allegria i funerali della ragione”, come scrisse icasticamente Enrico Giacovelli, non è solo, come troppo spesso si è detto, la feroce satira della società siciliana con la sua arcaica morale. Certo che il tema centrale attorno al quale si snoda l’opera, con un ritmo incalzante che rapisce lo spettatore, sono le nozze riparatrici imposte dal padre, un Saro Urzì premiato giustamente con un Nastro d’Argento e un riconoscimento a Cannes, a una figlia trasgressiva, una splendida Stefania Sandrelli, ma lo sguardo di Germi va ben oltre, fino a coinvolgere il conformismo sociale in quanto tale, in quanto strumento di ogni padre padrone. Lo conferma lo stesso regista: “Io trovo che il mio non è nemmeno un film molto siciliano, il film trae spunto dalla realtà siciliana, ci affonda dentro con tutte le radici, per mirare a un significato assolutamente simbolico che è proprio quello dell’alienazione, cioè è la rappresentazione di uomini alienati da un mito, che in questo caso è quello dell’onore, che in altri casi può essere quello della Patria, del Denaro, della Religione” (Pietro Germi. Ritratto di un regista all’antica, Autori Vari, Pratiche, 1989).
Rivedendo il film, nell’ottima copia curata dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con Cristaldfilm e con il sostegno del MiBACT, nel laboratorio L’Immagine Ritrovata, pensiamo che il regista abbia assolutamente ragione.
Anche il Giappone era presente con due film, uno dei quali, prodotto nel 1943, durante il dramma della II Guerra Mondiale, ha avuto una storia affascinante, documentata anche dal corto che lo accompagnava. Muhomatsu no issho, universalmente conosciuto come L’uomo del riksciò, di Hiroshi Inagaki, divenuto famoso nel mondo per il remake che dello stesso film fece nel 1958.
Infatti la censura giapponese, stranamente perché il protagonista, un conducente di riksciò, è una figura molto popolare che incarna le virtù morali attribuite ai nipponici, apportò molti tagli all’opera. Ancor più stranamente, altri tagli furono apportati dalle forze di occupazione americane dopo la fine del conflitto. Il regista, quindi, rifece il film quindici anni dopo a colori e in cinemascope, affidando la parte del protagonista a Toshiro Mifune e vincendo il Leone d’oro a Venezia. E’ questa la versione che vedemmo anche in Italia, dove ebbe notevole successo.
Il documentario che accompagna la copia restaurata, girato quest’anno da Ema Ryan Yamazaki, è una preziosa testimonianza delle vicissitudini attraversate da Masahiro Miyajima per effettuare questo difficile restauro, spostandosi da Tokyo a New York, da New York a Lisbona e riuscendo alla fine nell’intento che era divenuto uno degli scopi della sua vita.
Abbiamo così potuto constatare – io non avevo mai visto questa straordinaria pellicola – che avevano pienamente ragione gli storici e i critici del cinema nel sostenere che il capolavoro di Hiroshi Inagaki era il film del 1943 e non certamente il remake del 1958.
Per completezza di informazione, va aggiunto che, sempre tratto dal romanzo da cui era stato preso il soggetto dell’opera girata ne 1943, vi fu un terzo adattamento cinematografico, effettuato nel 1965, da Kengyi Misumi, che in Italia ebbe un discreto successo.
L’altro film, La vendetta è mia (Fukushù Suru Wa Ware Ni Ari, 1979) è dovuto a Shohei Imamura, uno dei protagonisti del Nuovo cinema giapponese agli inizi degli anni ‘60, esperienza che si può ancora intravvedere dietro allo sguardo freddo, entomologico con cui gira quest’opera sulla criminalità urbana impersonata, come forza naturale, da un protagonista che si pone al di là del bene e del male. Il soggetto è tratto da una storia vera, come il celebre Ecco l’impero dei sensi, del più rappresentativo regista del Nuovo cinema, Nagisa Oshima, e ciò non credo sia dovuto al caso. Infatti nel film che abbiamo visto, nell’ottimo restauro realizzato da Shochiku nel suo laboratorio, il finale è analogo a quello del capolavoro di Oshima a parti invertite. Il protagonista de La vendetta è mia, ladro, seduttore, imbroglione e assassino seriale, strangola la propria amante consenziente mentre fa l’amore con lei.

Durante sessantotto giorni questo nichilista totale ha commesso ogni genere di nefandezze assumendo le più svariate identità per coprire la sua assoluta mancanza di identità, se non quella radicalmente antisociale e distruttiva, di una distruttività fine a se stessa. Poi verrà catturato, ma la sua vicenda sembra paradossalmente far emergere un’amara realtà: il comportamento asociale del delinquente “naturale” coincide dialetticamente con la natura della società, della quale pareva costituire l’antitesi. Un contesto sociale, sembra concludere Imamura, sostanzialmente autodistruttivo.
La presenza più massiccia nella rassegna è stata quella degli Stati Uniti, presenti con quattro film, uno dei quali dovuto al mitico, anche per la sua instancabile attività per favorire il recupero dei film del passato, Martin Scorsese.
“Quei bravi ragazzi” (“Goodfellas” 1990) è un saggio antropologico esemplare sulla mafia gangsteristica italo-americana, sia per la rilevazione che pare fatta “sul campo” da uno scienziato, sia per la rappresentazione specificamente cinematografica, impeccabile in tutti i suoi aspetti a cominciare dalla colonna sonora accuratissima. “Gran montaggio della sonorità di un’epoca che non è quella ‘eroica’ e dunque finta e stereotipata del proibizionismo e del jazz ma è quella moderna dei dischi e della TV. Nonostante abbia “Nemico Pubblico” (film di Wellman del 1931, ndr ) sullo sfondo, “Quei bravi ragazzi” è storia di oggi, storia di piccoli gangster moderni senza alcun alone mitico”. Osserva puntualmente Alberto Farassino (Martin Scorsese, Dino Audino Editore, 1995), che cita anche, giustamente, come riferimento il capolavoro di Rossellini “La presa del potere da parte di Luigi XIV”. L’apparente ricerca sul campo è una efficacissima ricostruzione storica, palpitante di attualità, che ci consegna definitivamente un aspetto fondamentale della realtà americana.
Dobbiamo essere grati alla Warner Bros, che nel proprio laboratorio ha restaurato il film nel 2014.
Passiamo ad un altro prodotto della cinematografia americana, anche questo interpretato da un grande Al Pacino, che assume a oggetto della propria narrazione la faccia simmetricamente opposta alla mafia gangsteristica, la polizia della Grande Mela, denunciandone la devastante corruzione.
“Serpico”, diretto con grande rigore da un Sidney Lumet nella sua forma migliore, è tratto dalla biografia autorizzata di un agente del dipartimento di polizia newyorkese, Serpico appunto, un agente che ama conversare con i barboni e ascolta Bach, il quale ha una naturale e quasi nevrotica avversione per l’illegalità, in particolare se questa è radicata fra le forze dell’ordine.
La lotta di Serpico, che rischia la vita per tener fede ai suoi principi, diventa una felice innovazione nell’ambito del film poliziesco, coniugando il ritmo della narrazione con la durezza della denuncia di un altro aspetto realistico e inquietante della società americana, la collusione fra malavita organizzata e tutori dell’ordine.
Rivedendo quest’opera, nella bella versione che ci ha fornito il restauro effettuato pochi mesi fa dallo Studio Canal nel laboratorio L’Immagine Ritrovata, abbiamo avuto conferma, forse anche perché influenzati dalla luminosa proiezione su grande schermo nella Piazza Grande di Bologna, della sua attualità tematica e linguistica.
Sempre dagli Stati Uniti, grazie alla 20th Century-Fox che ha restaurato il film l’anno scorso, presso il laboratorio Fotokem, “Claudine”, ovvero come si vive da neri onesti e poveri nella New York degli anni’70, oggi probabilmente, nonostante la parentesi Obama, si vive ancora peggio.
Con un piacevole tono da commedia popolare con incursioni nel musical, John Berry, regista di successo, realizza un film di ottimo spessore culturale, probabilmente il suo migliore, oltre che il meno noto, grazie soprattutto all’interprete, una bella e felicissima Diahan Carroll, che aveva brillato in “Carmen Jones” e “Porgy and Bess” di O. Preminger. Il film fu prodotto come esordio della Third World Cinema, una casa sorta proprio per fornire opportunità alle minoranze americane. Ambientata ad Harlem, dove Claudine vive con i suoi sei figli avuti da tre uomini diversi, che l’hanno tutti lasciata, l’opera mostra efficacemente come sia difficile sopravvivere con i sussidi pubblici, sempre insufficienti, con il terrore di essere scoperta a fare lavoretti precari necessari a sbarcare il lunario. Proprio in una ditta dove presta clandestinamente i suoi servizi, Claudine, una forza della natura nonostante i problemi che anche i figli le procurano, conosce un simpatico corteggiatore, psicologicamente solido e deciso ad averla. La conseguenza dell’amore che nasce è che il mondo di Claudine migliora per la prospettiva di un lieto fine e peggiora per la drammaticità che la sua nuova condizione comporta. Prevarrà il lieto fine per la vicenda, ma anche per il film che guadagna in qualità da un finale non scontato, anzi, ottenuto per un complesso di circostanze che normalmente non si ripeteranno.
La protagonista ebbe una nomination all’Oscar come miglior attrice nel 1974 ed una nello stesso anno ai Golden Globes.
Infine, il più atteso da una certa tipologia di festivalieri, “Sono Innocente” (“You only lives once”,1937), il miglior film girato negli USA da Fritz Lang, che i più vecchi di noi avevano potuto vedere nella versione italiana con i dialoghi orribilmente manipolati. Il protagonista è Henry Fonda, al quale il Cinema Ritrovato ha giustamente dedicato una retrospettiva, in coppia con Sylvia Sidney, notevole attrice drammatica, e con l’accompagnamento di notevoli caratteristi.
Negli anni del New Deal era più facile trovare produttori come Walter Wanger, un uomo illuminato a cui Fonda deve la sua carriera, che lasciò piena autonomia artistica a Lang, fuggito dalla Germania nazista fin dal 1933 e approdato ad Hollywood nel 1935. Lang, autore di pietre miliari della storia del cinema come “Metropolis” (1926), è entrato pienamente nello spirito più avanzato dell’America roosweltiana e gira, con estremo senso critico verso una società puritana conformista e ipocrita, che non concede alcuna possibilità di riscatto a chi ha sbagliato sia pure una sola volta, questa tragedia di ordinaria cronaca per un contesto sociale chiuso nelle proprie certezze.
Un ladruncolo che ha scontato il suo debito con la giustizia e, assieme alla moglie, vuole rifarsi una vita, si scontra con la diffidenza feroce che lo circonda per il suo passato, la stessa infondata diffidenza che lo accusa di un delitto non commesso e lo fa condannare irrimediabilmente. Di qui il dramma: evaso dal carcere finirà braccato senza scampo come una bestia feroce.
Una vicenda esemplare, un film di alto livello, restaurato con grande sapienza questo stesso anno da Studio Canal, nel laboratorio Video Digital Multimedia.
Un capolavoro ci viene dall’Unione Sovietica, siamo nel 1977, il famoso “Partitura incompiuta per pianola meccanica” (tr. lett.), un film di Nikita Michalkovche molti dinoi videro in anteprima al Festival di Pesaro, la distribuzione italiana infatti lo portò nelle sale solo nel 1985.
Il film è tratto da una commedia di Anton Cechov non ancora ventenne, lasciata senza titolo e pubblicata postuma, il cui protagonista Platonov è rivisto da Michalkov come un intellettuale fallito che porta il lutto di se stesso, incapace di concludere drammaticamente la sua vita, finirà ridicolmente per fallire anche il suicido, gettandosi in pochi centimetri d’acqua. La nascente e già declinante borghesia russa di metà ottocento, radunata in una folta rappresentanza nella grande villa con parco della ricca vedova di un generale, è descritta in modo da ricordare al meglio il nostro Luchino Visconti. Pare che il punto di forza attorno a cui ruota la compagnia, apparentemente allegra e piena di vita, in realtà reclinata su se stessa e sul proprio incerto futuro, sia la generalessa, una figura solida perché erede del ceto militare zarista.
La nuova classe resta nei canoni fissati da Cechov, rivisitati da un sostanzialmente rispettoso Michalkov, ma con tocchi magistrali che vanno oltre il suo modello dichiarato. Se il regista aveva detto: ”mi sento molto vicino a Cechov perché non dà risposte alle domande che pone, il suo segno di interpunzione preferito non è il punto, né il punto interrogativo o esclamativo, ma i puntini di sospensione” (intervista a “Telérama”, 1979), il film ci suggerisce che la borghesia russa non riuscirà a consolidarsi come classe dirigente e sarà travolta assieme all’aristocrazia zarista non essendone divenuta mai il superamento.
Siamo stati anche lieti di constatare che la Mosfilm continua a migliorare la capacità di restaurare con somma cura le proprie produzioni.
Dalla Francia un film di culto, opera del prestigioso Jean- Pierre Melville, “Le Cercle rouge”, girato nel 1970 e venuto in Italia con il titolo “I senza nome”, ma tagliato dalla distribuzione di ben 20 minuti, riguardanti soprattutto l’ispettore Mattei, uno straordinario Bourville, già malato, che morirà appena finite le riprese. Dodicesima e penultima pellicola del regista si avvale di un notevolissimo cast, nel quale gareggiano in bravura Alain Delon, Gianmaria Volonté e Yves Montand, casualmente associatisi per rapinare notte tempo una lussuosissima gioielleria nel centro di Parigi.
Non è necessario dire come finirà l’impresa, ma bisogna citare Roberto Chiesi che nel catalogo scrive: “Le cercle rouge può sembrare realistico per la precisione dei dettagli e l’adesione alla continuità reale delle azioni, ma in effetti Melville dissemina e moltiplica una serie di sottili, deliberate e stranianti inverosimiglianze che conferiscono al film un’atmosfera quasi trasognata”. In altre parole, la cifra del film è un realismo così minuzioso che approda all’iperrealismo e sfuma in un surrealismo drammatico che dà risalto alla solitudine di tutti i protagonisti, una solitudine esistenziale che accompagna il loro destino fino alla inevitabile morte, rappresentata dal cerchio rosso del titolo.
Per la storia del cinema bisogna notare che l’uscita di quest’opera, accolta con entusiasmo da critica e pubblico, segnò la fine di una lunga e tormentata amicizia fra Melville e il maggior protagonista dell’avanguardia internazionale, Jean-Luc Godard, il quale pubblicò una feroce stroncatura de “Le Cercle rouge” firmandola conuno pseudonimo.
Il restauro, ineccepibile, è opera del CNC, il grande centro di conservazione e restauro al quale il governo francese non lesina risorse.
Quello che segue è stato per me una gradevolissima sorpresa, un film cubano che non avevo visto del grande Tomás Gutiérres Alea, del quale credo di conoscere tutto, restaurato proprio quest’anno dall’ ICAIC, l’istituto cubano per il cinema, e dall’Academy Film Archive in collaborazione con la Cinèmathéque Royale de Belgique. Il film, girato nel1976, è una caustica allegoria della religiosità professata dai colonizzatori nel XVIII secolo ed imposta come strumento del loro potere ai pre-colombiani e agli schiavi neri. La mano del regista, uno dei migliori cineasti formatisi a Cuba, dopo la Rivoluzione Castrista, appare subito evidente nell’ironica messa in scena di un soggetto tratto da un paragrafo di un ponderoso testo di storia economica dovuto a Manuel Moreno Fraginals (“El ingenio” 1964). In tale paragrafo si narra del Conte di Casa Bayona, che un Giovedì santo lavò i piedi a 12 suoi schiavi e li fece sedere alla sua tavola; ed ecco che vediamo una straordinaria, nel senso letterale del termine, “Ultima cena” con il Conte nella parte di Cristo e gli schiavi in quella degli apostoli, tutti perfettamente tenuti sul filo della blasfemia costituita in realtà dalla cultura ipocrita dei feroci colonialisti, messa in luce dalla forma di parabola che Alea ha impresso al racconto.
I colloqui fra il Conte e gli apostoli neri, quelli degli schiavi fra loro, le parole sprezzanti del nero che aveva poco prima ricevuto una severissima punizione per aver tentato la fuga, il suo atteggiamento irriducibilmente ribelle, costituiscono i prodromi di quanto succederà una volta che il Conte, di buon mattino, sarà partito dopo aver rapidamente superato i postumi delle abbondanti libagioni.
Il Conte aveva disposto che nel Venerdì santo gli schiavi non avrebbero lavorato, ma il sovraintendente, più realista del re, non rispetta quella disposizione e. quindi, ineluttabilmente, scoppia la rivolta che verrà repressa nel sangue. Solo il capo dei ribelli, lo schiavo che già aveva tentato la fuga ed era stato punito anche con il taglio di un orecchio, scamperà al massacro fuggendo nella foresta.
Alea, che aveva studiato cinema a Roma ed era uno dei fondatori dell’ICAIC, lascia aperta una speranza, la speranza, sia pur ancora vaga, del riscatto degli oppressi.
Sono stato felice di vedere confermata la mia stima per l’autore di “Memorie del sottosviluppo”, forse il suo film migliore, girato nel 1968, e dell’universalmente applaudito “Fragola e cioccolato”, Orso d’argento a Berlino nel 1994, con il quale Alea difende la libertà sessuale come simbolo di tutte le libertà.
A proposito di libertà, abbiamo visto un film, presentato in concorso a Venezia nel 1967 con il titolo “Fine stagione”, traduzione letterale di “Utòszezón”, dell’ungherese Zoltán Fábri, uno dei protagonisti del Nuovo cinema, la nuova ondata che, anche nei paesi “socialisti”, aveva rinnovato, come in tutto il mondo, la cinematografia rivisitandone il linguaggio e introducendo tematiche che, soprattutto nell’Europa dell’est, erano tabù.
I cineasti di questa tendenza, il cui ferro di lancia si rivelerà Miklós Jancsó, operavano appassionatamente non solo per migliorare la cinematografia del loro paese, ma, più in generale, per contribuire a sciogliere l’Ungheria dai robusti lacci dello stalinismo. Si trattava, quindi, di fare dei film che superassero il linguaggio conformisticamente codificato, rompessero la retorica ufficiale e introducessero, più o meno direttamente, un discorso politico allusivo ma comprensibile sul generale bisogno di libertà.
Sotto questo profilo Zoltan Fábri aveva già realizzato, nel 1965, “Venti ore”, un film politicamente molto coraggioso, e, con maggiore cautela, ma non con minor forza stilistica, tornò alla ribalta due anni dopo con “Fine stagione”, dove mescola felicemente la forma drammatica con quella disinvolta e paradossale della commedia, spesso spinta fino al grottesco, per approdare alla più disperata tragedia.
Nella provincia ungherese un gruppo di anziani giocano uno scherzo, che si rivelerà più che crudele, ad uno di loro facendogli credere che la polizia lo ha convocato per un colloquio. Nell’animo dello sciagurato il rimosso ritorna e si scatena l’inferno, costituito dal passato che, con i suoi segreti riguardanti anche la storia dell’Ungheria, a partire dalla sua adesione al nazismo, si protende come un’ombra cupa sul presente. Un avvertimento severo a quanti si adeguano opportunisticamente alle circostanze: la responsabilità storica, come quella personale, non si può cancellare, seppellendola nel profondo della propria memoria. Rivedendo il film, nel diligente restauro effettuato dal Majar Nemzeti Film Archivum, sembra anche opportuno citare il commento scritto da Federico Gironi, che assieme ad Alberto Barbera dirige la sezione, “Fábri mescola con grande libertà soluzioni moderniste, richiami felliniani, ammiccamenti al cinema di JacquesTati e al neorealismo italiano: il protagonista….è anche fisicamente un personaggio che pare declinare l’”Umberto D” di De Sica in chiave ungherese, afflitto non dal problema della povertà ma da un peso enorme sulla coscienza che ha rimosso per anni e con cui si trova improvvisamente a dover fare i conti”.
Siamo giunti alla fine della nostra rassegna, un lieto fine, non perché terminiamo con un film ottimista, ma per aver potuto vedere una pellicola del Mali, diretta dal valoroso Souleymane Cissé, che nel suo paese era stata sequestrata per tre anni, e l’autore, che l’ha girata nel 1975, arrestato. Finalmente disponiamo di una buona copia integrale grazie al restauro che lo stesso Cissé, con la Cinématèque Française e la Cinématèque Afrique, ha effettuato questo stesso anno nel laboratorio Hiventy. Speriamo vivamente che il film, come tutti i film della rassegna, abbia la stessa sorte di “The Elephant Man”, presentato al Cinema Ritrovato e ora già nelle sale distribuito dalla Cineteca di Bologna.
Sarebbe un’ottima cosa che il pubblico italiano potesse vedere il primo lungo metraggio dell’autore di “Finyé” e “Yeelen”, opere passate in molti prestigiosi festival internazionali, un film di indiscussa qualità, che non mostra certamente i suoi anni, esibita intrecciando una storia melodrammatica, una bella sordomuta sedotta e abbandonata incinta, con la realtà dello sviluppo anarchicamente impetuoso del Mali.
Certamente non piacque alla dittatura militare che allora era al potere, come d’altra parte lo è ancora, sia pure con caratteri meno violenti, la descrizione quasi documentaria di un’urbanizzazione incontrollata che amplia le differenze sociali fra una borghesia facoltosa, residente in lussuose ville, e la massa di giovani proletari dal futuro incerto che affollano le vie di Bamako, la capitale dello stato, vivacchiando nelle viuzze sterrate, residui del paese di un tempo. Ma probabilmente non fu gradita neppure la storia de “La ragazza”, traduzione letterale di “Den Muso”, appartenente a una famiglia mediamente agiata, che non solo è respinta dal suo violentatore, bensì anche dalla famiglia, che la ripudia per averla colpevolmente disonorata e vuole imporre ai parenti di negarle ogni aiuto.
La vicenda della sordomuta, simbolo della condizione femminile in una società patriarcale arcaica (ma lo è poi solo nel contesto arcaico?) rivela un inestricabile groviglio di motivi sociali e religiosi tesi a confermare lo stato di cose esistente impedendo, soprattutto ai più deboli, di intravvedere, come fa il regista con la sua singolare scrittura filmica, la possibilità di un mondo migliore.
PESARO 56
di Paolo Vecchi
La 56a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, spostata per forza maggiore a fine agosto rispetto alle tradizionali date di giugno, pur nelle limitazioni imposte dalla pandemìa, ha saputo offrire un programma di tutto rispetto, non indegno della sua cospicua tradizione. Nell’ambito del concorso, la giuria, composta da Renato Berta, Vinicio Marchioni e Virgilio Villoresi, ha attribuito il premio Lino Miccichè a “A metamorfose dos pàssaros”, opera prima della portoghese Catarina Vasconcelos. Una madre e una nonna ricordate da una pluralità di voci narranti fuori campo, con la memoria individuale che si lega allusivamente ma imprescindibilmente a quella del Portogallo di Salazar, la notizia della morte del quale è riportata nella copertina di un settimanale, mentre i francobolli di una collezione rinviano alla sua lunga avventura coloniale.

Una mdp fissa, sulla falsariga del maestro De Oliveira, inquadra persone e oggetti, animali e piante, paesaggi agresti e marini, fotografati in colori saturati dal tempo e della malinconia, messi quasi in parallelo con riproduzioni di opere di grandi artisti e commentati da musiche pianisti**che di Schubert e Liszt, oltre che dall’elettrizzante incipit della “Petite messe solennelle” di Rossini. Passato alla Berlinale e premiato a Vilnius, il film è un altro esempio di quel cinema di poesia prodotto sotto gli auspici della benemerita fondazione Gulbenkian, che fa orgogliosamente della staticità il suo carattere distintivo.
“A metamorfose dos pàssaros” si è aggiudicato anche il premio della giurìa degli studenti, che ha assegnato una menzione speciale a “Il n’y aura plus de nuit” della francese Eléonore Weber. La regista ha avuto accesso agli archivi militari dell’esercito americano e del suo Paese d’origine, montando immagini riprese dalle telecamere termiche poste sugli elmetti dei piloti e dei mitraglieri impegnati in azioni belliche in Afghanistan, Iraq e Siria. Anche qui una voce fuori campo le commenta, spesso facendo riferimento alle indicazioni di un fantomatico Pierre V., che in esse ha avuto parte attiva. In un alternarsi di bianco e nero e colore, ci viene offerta una serie di agghiaccianti esempi di morte in diretta e nella soggettiva di chi la causa. Quello che soprattutto colpisce è l’arbitrarietà più assoluta nelle scelte di chi mitraglia o bombarda, al quale più volte è capitato di irrigando i campi.
La consueta sezione “Cinema in piazza”, che ha riscosso un buon successo nonostante la cancellazione di molti posti dovuta al cosiddetto distanziamento sociale, data l’impossibilità a ricorrere al sistema di votazione cartaceo, ha assegnato il premio del pubblico in base agli applausi degli spettatori. Se l’è aggiudicato “Il caso Braibanti” di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese. Aldo Braibanti ha rappresentato una figura del tutto anomala nel panorama culturale italiano del secondo dopoguerra. Partigiano, poeta, filosofo e mirmicologo, fu al centro di un assurdo processo per plagio che oggi fa tornare alla mente quello che portò alla condanna di Oscar Wilde e che divise l’opinione pubblica, facendo emergere, nello schieramento contro, il peggio del becerume nazionale. Il film monta sapientemente materiali compositi, usando come filo conduttore lo spettacolo teatrale messo in scena dai due registi: video d’arte girati da Braibanti, film sperimentali di Alberto Grifi, testimonianze d’epoca (Pasolini, Pannella) e di oggi (Dacia Maraini, soprattutto il concittadino Piergiorgio Bellocchio), con le vicende, familiari oltreché processuali, ricostruite dal nipote Ferruccio. Suo grande merito da un lato è di riportare in luce la figura di un intellettuale di straordinario valore, dall’altro di svelare impietosamente come l’intolleranza possa condurre a simili aberrazioni, favorite d’altronde da una legislazione non del tutto liberatasi dell’eredità del fascismo.
Nella stessa sezione dedicata agli spettatori di Piazza del Popolo, di grandissimo interesse ci è sembrato “The Nose or Conspiracy of Maveriks” di Andrej Khrzhanovskij, che lo ha co-sceneggiato insieme a Yuri Arabov, abituale collaboratore di Sokurov. Diviso in tre parti, usa l’opera di Shostakovich, che per inciso ebbe la ventura di mettere in scena quando il compositore era ormai anziano, per farlo incontrare con Gogol e Ejzenstejn, Mejerchold e Bulgakov, cedendo progressivamente il campo a Stalin e alla sua corte di sguatteri, impegnati a difendere l’arte socialista da individualismo, formalismo e altri crimini (si legga in proposito “Il rumore del tempo” di Julian Barnes). Il divertimento della caricatura è solo la maschera del dramma, il finale allinea le foto segnaletiche degli intellettuali destinati ai gulag e alla morte ma anche i protocolli di purghe a più ampio raggio, finchè i milioni di ritratti formato tessera delle vittime vanno a formare una specie di universo stellato. Il regista mette il racconto in una cornice in cui i passeggeri di un jet assistono allo spettacolo nei visori di bordo, si citano frammenti del cinema sovietico classico, il lavoro degli animatori è mostrato nel suo farsi. Il modo in cui Khrzhanovskij organizza tutto questo materiale composito è la testimonianza del multiforme spessore di questo troppo poco conosciuto Grande Vecchio.
Tra le altre sezioni lo spazio tiranno ci costringe solo a segnalare “Corti in mostra – Animatori italiani oggi” ricco di film davvero sorprendenti, “diversissimi tra loro per linguaggio, stile e tecniche di realizzazione” ma che “sanno dare…un’idea del livello di vitalità, creatività, innovazione e ricerca che molti animatori da noi sono in grado di esprimere”, come scrive nel catalogo il curatore, Pierpaolo Loffreda.
Senza voler nulla togliere alla presenza di Oliver Stone, venuto a presentare il proprio libro autobiografico, e il ricordo di Corso Salani a due lustri dalla scomparsa con la proiezione del limpido, commovente “Gli occhi stanchi”, introdotto dalla sua co-sceneggiatice Monica Rametta, possiamo dire che Pesaro 2020 si è caratterizzato soprattutto per l’evento speciale dedicato ai novant’anni di Giuliano Montaldo. Pur vigendo le già citate restrizioni, per le quali la personale è diventata un omaggio di sei titoli, si è ugualmente trattato di un’occasione importante, che ha consentito di ripercorrere l’iter artistico di uno dei protagonisti della nostra cinematografia. Per l’occasione è uscito un corposo un volume edito da Marsilio, “Giuliano Montaldo: una storia italiana”, a cura di Pedro Armocida e Caterina Taricano, che contiene una lunga intervista al festeggiato, saggi di specialisti, testimonianze di compagni di viaggio e l’analisi dettagliata di tutti i film.
Regista, ma non solo. Montaldo nasce infatti come attore in “Achtung! Banditi!”, dopo un incontro quasi casuale con Carlo Lizzani, che lo avrebbe in seguito chiamato più volte in ruoli di carattere. In questa veste sarebbe poi comparso in pellicole di Emmer, Maselli, Petri e Moretti tra gli altri, “carriera” coronata tre anni fa dal David di Donatello per l’interpretazione dell’anziano compagno di viaggio del giovane Alessandro (Andrea Carpenzano) in “Tutto quello che vuoi”, nonostante Vera Pescarolo, sua moglie oltreché insostituibile collaboratrice di una vita, lo avesse sconsigliato caldamente all’autore, Francesco Bruni (“Lascialo perdere! E’ cane!”, pare gli abbia detto). Ma di lui vanno ricordate sia l’attività didattica al Centro Sperimentale, per la quale gli sono ancora grati i registi di un paio di generazioni, che quella politico-produttiva, come fondatore e presidente di Rai Cinema. Questo inesausto attivismo, sempre sorretto da irreprensibilità sul piano etico e disponibilità su quello umano, lo ha portato ad affrontare un kolossal televisivo come “Marco Polo” ma anche, sempre nello stesso ambito, a rischiare di confrontarsi con la sperimentazione di “Circuito chiuso”, da un racconto di Bradbury, nel cui fantasmatico rapporto schermo-spettatore qualcuno ha visto l’anticipazione della “Rosa purpurea del Cairo” di Woody Allen. E a cimentarsi più volte con la messa in scena operistica, lui che ha voluto spesso Ennio Morricone a scrivere le partiture per i suoi lavori.

Regista eclettico, la cui robusta professionalità ha saputo gestire con sicurezza prodotti di genere interpretati da attori di fama internazionale (Edward G. Robinson, Janet Leigh, John Cassavetes, Burt Lancaster, Philippe Noiret…), crediamo tuttavia che Montaldo verrà ricordato soprattutto come protagonista di un cinema nobilmente civile, rigoroso sul piano ideologico e stilistico quanto anti-intellettualisticamente rispettoso delle attese di un pubblico vasto. In questo ambito, “Gott mit uns”, “Sacco e Vanzetti”, “Giordano Bruno”, “L’Agnese va a morire” e “Gli occhiali d’oro”, pur nelle differenze di temi e toni, appaiono ancor oggi accomunati dalla necessità etica di raccontare momenti significativi della Storia, vista immancabilmente dalla parte degli sconfitti.
Tra i film proiettati a Pesaro vogliamo soffermarci su quello d’esordio, “Tiro al piccione”, uscito nel 1961. Tratto dal romanzo omonimo e parzialmente autobiografico di Giose Rimanelli, racconta l’agonia del regime fascista attraverso il punto di vista di Marco, un ventenne che aderisce alla Repubblica Sociale per una necessità di schierarsi sulla cui confusa determinazione giocano sia la tragedia in atto che le incertezze dell’età.
Questo capovolgimento di prospettiva, con la Resistenza vista dalla parte sbagliata, appare estremamente coraggioso, tantopiù perché Montaldo rifugge da ogni schematismo, pur non prestando il fianco ad ambiguità sul piano del giudizio storico. In questo senso risulta di grande interesse il modo tutt’altro che sbrigativo con il quale il regista caratterizza i repubblichini, soprattutto tre figure che assumono particolare importanza nella formazione del protagonista: il sergente Elia, con i suoi dubbi che lo porteranno alla diserzione e alla morte, il tenente Nardi, che si suicida una volta resosi conto della fine dei “valori” in cui aveva creduto, e il capitano Mattei , che invece butta la divisa e fugge in abiti borghesi, probabilmente in grado di riciclarsi nella nuova Italia democratica, così poco incline ad epurare gli ex fascisti.
In un periodo che, sotto l’egida di un centrosinistra in fieri, vede rinascere l’interesse del cinema per le tematiche resistenziali rimosse negli anni del centrismo, non stupisce che questa ottica abbia infastidito la critica di sinistra, almeno quella più rigidamente schierata. Tantopiù se si pensa che un’operazione analoga verrà effettuata in Francia ben tredici anni dopo con “Cognome e nome: Lacombe Lucien” di Malle, che pure avrebbe fatto storcere qualche naso, in patria e altrove. Rivisto oggi, una volta decantate certe contrapposizioni schematiche, “Tiro al piccione” sorprende per originalità del tema e robustezza dell’impianto narrativo, con la finzione che si alterna a frammenti di documentario sull’incalzare degli eventi. La copia è stata da poco restaurata, rendendo giustizia all’incisivo bianco e nero, in qualche modo d’epoca, di Carlo Di Palma.
IL GEORGIANO BEGINNING E’ STATO IL GRANDE TRIONFATORE DELLA 68° EDIZIONE DEL SAN SEBASTIAN FILM FESTIVAL
di Alessandra Pighi, Xoxan Villanueva
La giuria del San Sebastian Film Festival, presieduta dal regista palermitano, Luca Guadagnino, non ha avuto dubbi, il film georgiano Beginning è stato il grande trionfatore della 68esima edizione che si è tenuta nella città basca dal 18 al 26 settembre. Non solo ha vinto la Conchiglia d’oro per il miglior film, ma la regista, Dea Kulumbegashvili, ha anche vinto la Conchiglia d’argento come Miglior regista nel suo primo lungometraggio; la Conchiglia d’argento per la Migliore attrice per la sua protagonista, Ia Sukhitasvili, nonché il premio per la Migliore sceneggiatura, alla stessa Dea Kulumbegashvili ed a Rati Oneli.
Il film era già tra i favoriti per un premio all’inizio del Festival, in quanto era stato selezionato per partecipare al Festival di Cannes, cancellato a causa del Covid, e ottenuto il premio per la critica al Festival di Toronto. La pellicola che ha provocato una forte divisione di opinioni tra spettatori e specialisti, racconta le molestie subite da una testimone di Geova e dalla sua famiglia da parte di un gruppo estremista e della polizia della remota cittadina in cui vivono. Per alcuni critici, un film troppo sperimentale e monotono con inquadrature fisse troppo lunghe e noiose. Infatti, nel bel mezzo del film, alcuni spettatori hanno lasciato la stanza già mezza vuota a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Tuttavia, per altri, come la stessa giuria, il lungometraggio di Dea è originale, significativo, ambizioso, sconcertante e indispensabile. Una scoperta piacevole e inaspettata, in quanto rappresenta un nuovo modo di vedere e intendere un’arte che respira, si muove e si agita con proposte diverse. Una boccata d’aria fresca.
La Conchiglia d’argento per il Miglior attore è stato vinto collettivamente dai 4 attori Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang e Lars Ranthe, protagonisti di “Another Round”, il nuovo film del danese Thomas Vinterberg. Il film racconta la crisi esistenziale di quattro insegnanti di liceo che decidono di verificare se il consumo quotidiano di alcol sia benefico, con l’unico obiettivo di salvare le loro vite dalla miseria, dall’infelicità e dalla noia. Il Premio Speciale della Giuria è andato al caotico e brillante documentario “The Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan”, una produzione dell’attore americano Johnny Depp diretta dal documentarista e regista inglese Julien Temple. La pellicola è un ritratto emozionante e straordinario del talentuoso e irripetibile Shane MacGowan, leader apprezzato di “The Pogues”, la famosa band di musica folk irlandese dallo spirito punk. Il premio per la Migliore fotografia è andato a Yuta Tsukinaga per “Any Crybabies Around?”, del giapponese Takuma Sato. La pellicola racconta la svolta nella vita di un uomo che viene ripreso dalla televisione nudo e ubriaco a Capodanno. Ostracizzato per aver svergognato il popolo e la tradizione, fugge a Tokyo. Due anni dopo, torna per sistemare le cose con l’ex moglie e la figlia, ma si troverà in una situazione molto difficile e complicata.
Woody Allen immortala San Sebastiàn nel suo ultimo film
Il Festival in questa 68esima edizione ha beneficiato dell’inaspettata cancellazione, dovuta a Covid-19, del Festival di Cannes. Per questo e grazie all’amichevole collaborazione tra i due concorsi, San Sebastian ha inserito 16 titoli nelle diverse sezioni del suo programma (13 lungometraggi, di cui 7 nella Sezione Ufficiale, e altri 4 cortometraggi), proveniente dal Festival francese. Infatti, il suo direttore, Thierry Fremaux, ha partecipato al Gala di apertura per rendere omaggio al suo Festival e al resto degli eventi nel mondo che non si sono tenuti a causa del coronavirus.
Il Festival si è aperto con la prima mondiale di “Rifkin’s Festival”, il nuovo film di Woody Allen presentato fuori concorso. Una commedia romantica leggera e semplice, ambientata nell’ambito del Festival stesso. Una canzone d’amore di Allen che immortala San Sebastian, il suo fascino, la sua gente, la sua gastronomia, il mare, le spiagge. Il film è anche un omaggio alla Storia del cinema, in quanto ricrea alcune delle scene più importanti del cinema d’autore che hanno segnato il regista americano, come il cinema europeo di Fellini, Truffaut, Bergman. Vale la pena citare alcuni titoli della Sezione Ufficiale come “In The Dusk”, dramma dal background bellicoso del lituano Šarūnas Bartas, da cui ci si aspettava sicuramente qualcosa di più; “True Mothers”, una nuova esplorazione del microcosmo familiare della giapponese Naomi Kawase; “Summer of 85”, un racconto di amori adolescenziali firmato dal prestigioso regista parigino François Ozon; “Forgotten We’ll Be”, di Fernando Trueba tratto dall’omonimo libro di Héctor Abad Faciolince, che ha chiuso il Festival, fuori concorso. Il film, adattamento dell’omonimo romanzo di Héctor Abad Faciolince, racconta la storia di suo padre, medico e attivista per i diritti umani nella violenta Medellín degli anni ’70.
Da segnalare anche le varie serie televisive presentate nella Sezione Ufficiale, anche se fuori concorso. La serie spagnola “Riot Police”, di Rodrigo Sorogoyen. Una serie su un gruppo di poliziotti antisommossa che si recano negli inferni della corruzione spagnola. Oltre alla proiezione speciale di “Patria”, creata da HBO Europe dall’acclamato romanzo di Fernando
Aramburu, sulla violenza generata da ETA ed i suoi effetti nella società basca. Così come la serie “We Are Who We Are”, diretta da Luca Guadagnino per HBO-SKY. La serie esplora l’amicizia, il primo amore e l’identità di due adolescenti che vivono in una base militare statunitense in Italia. Una bella ode alla libertà e all’individualità delle persone, in particolare dei giovani. Infine, dobbiamo anche evidenziare il lungometraggio documentario dell’attore americano Matt Dillon, il suo secondo film come regista “The Great Fellove”. Un bellissimo documentario che trascende la storia umana del singolare e sconosciuto al grande pubblico, compositore e cantante cubano, Francisco Fellove.

Viggo Mortensen, Premio Donostia
Il momento clou del Festival è stato quando l’attore e regista Viggo Mortensen ha ricevuto il Premio Donostia in riconoscimento della sua carriera. Il premio è stata l’occasione per l’attore americano di presentare il suo primo film da regista, “Falling”. Pellicola interpretata dal veterano Lance Henriksen e dallo stesso Viggo Mortensen, che ha anche firmato la sceneggiatura. Interpretano un padre e un figlio i cui mondi diversi si scontrano a causa di una relazione contraddittoria tra padre e figlio. Un film intenso che approfondisce sensazioni dolorose, il peso dei ricordi e la complessità dei sentimenti familiari.
In sintesi, questa edizione è stata il trionfo di un impegno svolto con grande prudenza, pazienza e professionalità da parte dell’organizzazione diretta dal suo direttore, Josè Luis Rebordinos. La pandemia non ha impedito la presenza del pubblico e dei professionisti del mondo cinematografico. Nonostante le restrizioni e i controlli, la gente ha continuato a frequentare le sale cinematografiche e questo è ciò che è importante ed è ciò che conta. Nonostante le difficoltà, la vita va avanti e anche il cinema.
“LUNANA: UNO YAK IN CLASSE” VINCE LA 26a EDIZIONE DEL FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA
di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
Il lungometraggio “Lunana: uno yak in classe”, di Pawo Choyning Dirji, giovane regista del Bhutan ha vinto il premio Lessinia d’oro alla 26a edizione del Film Festival. La pellicola è la storia di Ugyen, un giovane insegnante mandato per punizione nella scuola più remota del mondo a 5.000 metri di altitudine sull’Himalaya, nel villaggio di Lunana con 56 abitanti e una dozzina di bambini. In sostituzione della giuria internazionale che non si è potuta convocare dovuto al Covid-19; il premio, per la prima volta, è stato concesso in votazione dal pubblico in sala e chi ha assistito in streaming alle proiezioni. Il film è stato riconosciuto anche con il premio Microcosmo del Carcere di Verona, che da 10 anni collabora con il Festival.

Il Festival della Lessinia non sè ha arreso al Covid-19, nonostante i mesi di confinamento, i ritardi organizzativi provocati ed il drastico taglio di risorse, ha presentato dal 21 al 30 agosto una 26a edizione ricchissima di autori, 63 film, 40 paesi partecipanti e 32 anteprime italiane. In concorso ci sono state 28 opere, tra le quali 10 lungometraggi e 18 cortometraggi.
“Asho”, cortometraggio dell’iraniano Jafar Najafi, ha conquistato il premio Lessinia d’argento. Asho è un giovanissimo pastore iraniano, che sogna un futuro da attore e dimostra di avere talento da vendere davanti alla macchina da presa. Il film è un ritratto di un Iran rurale, ancora legato alle tradizioni imposte dalla religione ma in cui il sogno di un nuovo stile di vita si va insinuando. Altro vincitore, il lungometraggio “Kanants Gyuche” dell’armena Tamara Stepanyan, premio del Curatoriun Cimbricum Veronense, alla memoria di Piero Piazzola e Mario Pigozzi, al Miglior film di un giovane regista. L’opera di Tamara parla di un paese di montagna abitato solo da donne, vecchi e bambini perché gli uomini lavorano tutti in Russia. Sulle donne pesano il lavoro e tutte le funzioni della famiglia.
Altro lungometraggio premiato è stato “L’Apprendistato”, del regista romano Davide Maldi. Ha ricevuto il premio della Cassa Rurale Vallagarina, assegnato alla migliore opera cinematografica sulle Montagne italiane. Luca ha 14 anni e le mani già segnate dalla vita di montagna. Sembra felice nel suo ambiente, fino a quando la famiglia non lo convince a iscriversi presso una scuola alberghiera. Quest’anno il Festival ha inaugurato una nuova sezione FFDLgreen, che ha ospitato 6 documentari sul rapporto tra uomo e pianeta con attenzione alle tematiche ambientali. Il vincitore è stato il film “Apolithomata” del regista freelance greco, Panos Avarnitakis. Interessante è stata la sezione FFDL+ (21 opere) dedicata ai bambini ed agli adolescenti. Il premio per miglior film è stato attribuito alla favola animata “La cerise sur le gateau”, diretto dal belga Frits Standaert.
Il Festival è l’unico concorso cinematografico internazionale esclusivamente dedicato a cortometraggi, documentari, lungometraggi e film di animazione sulla vita, la storia e le tradizioni in montagna. Nato nel 1995 come rassegna videografica dedicata alle montagne veronesi, il Festival ha gradualmente ampliato il suo interesse alle montagne di tutto il mondo. Dal 1997 il Festival è guidato dal direttore artistico Alessandro Anderloni. Dal 2007 la sede ufficiale è Bosco Chiesanuova (Verona), presso il Teatro Vittoria. La chiusura è stato un omaggio al maestro recentemente scomparso, Ennio Morricone che ha esaltato con la sua musica le montagne in molte pellicole, come nel capolavoro “Il grande silenzio” di Sergio Corbucci, che ha concluso il Festival.
OCCHIO CRITICO
CINEMA E STORIE VERE
di Marco Incerti Zambelli
È una storia reale, raccontata in un pregevole documentario televisivo di una decina di anni fa (“Roubaix, commissariat central, affaires courantes” di Mosco Levi Boucault), l’occasione per Arnaud Desplechin di confrontarsi con un diverso raccontare cinematografico rispetto alle opere precedenti. Come ha dichiarato lo stesso autore in occasione della presentazione di “Roubaix, una luce nell’ombra” a Cannes 2019: ‘Ho sempre rifiutato di raccontare nel mio cinema la realtà del mondo circostante. Quasi tutti i miei film sono stati romantici. E anche troppo. E quel troppo è ciò che desideravo veramente. Era dunque arrivato per me il momento di una svolta: volevo raccontare un film che da sotto tutti i punti di vista aderisse al reale’.
La Roubaix del titolo, città natale del regista, non è più lo sfondo immaginifico e fiabesco di “Racconto di Natale”, ambiguamente mitico come in “I miei giorni più belli”, rifugio misterioso ma sicuro de “I sogni di Ismael”, ma realisticamente, appunto, una città di confine tra Francia e Belgio che la deindustrializzazione ha impoverito e incattivito. Il commissario Daoud, di origine algerine, ma profondamente affezionato alla città nel quale ha sempre vissuto, si muove tra modeste luminarie in una vigilia di Natale nella quale, come comunica la centrale di polizia, ‘c’è la solita routine’: una macchina bruciata, una lite familiare, una sparizione, uno stupro, una casa incendiata. Magistralmente interpretato da Roschdy Zem, Daoud è un poliziotto carismatico, di grande umanità, apprezzato e stimato dalla sua squadra, che capisce empaticamente la città e i suoi abitanti e le cui vicende personali sono suggerite più che narrate: la solitudine dopo il rientro di tutta la famiglia in patria, la feroce ostilità del nipote in carcere, l’amore per i cavalli. Il giovane investigatore Luis (Antoine Reinartz), da poco arrivato al commissariato offre alla trama una sorta di narratore esterno, un alter ego coinvolto e volonteroso, che ha sublimato una incerta vocazione sacerdotale nell’impegno per la legge, le cui goffe intuizioni sottolineano la tranquilla sagacia del commissario. Se nella prima parte del film si intrecciano diversi ‘affaires courantes’, in seguito la vicenda si concentra sull’uccisione di una anziana signora in un degradato quartiere e riporta all’attenzione una coppia di giovani donne che già in precedenza si erano dimostrate sfuggenti e non collaborative. Interpretate con grande efficacia da Léa Seydoux e Sara Forestier, Claude e Marie, povere, emarginate, alcolizzate, legate da un rapporto d’amore diseguale, sono accompagnate da Daoud a riflettere su sé stesse, a ripetere l’insensato percorso che le ha portate al delitto, in un susseguirsi di interrogatori ad un tempo intenso e rarefatto che culmina in una raggelante ricostruzione del delitto.
Desplechin orchestra un equilibrato alternarsi di primi piani in campi e controcampi avvolgenti che evidenziano il rigore ma anche l’umanità, la compassione del commissario che non assolve ma capisce le sue imputate. Avendo come riferimento dichiarato il Dostoevskij di ‘Delitto e castigo’ e l’Hitchcock de ‘Il ladro’, l’autore mette in scena un polar anomalo, di emozionante intensità, impreziosito dalla fotografia della fida Irina Lubtchansky e dalle strepitose performances dei suoi attori.
Se “Roubaix, una luce nell’ombra” è un’opera sorprendente ed inaspettata, ispirata ad un periferico fatto di cronaca nera, “Il processo ai 7 di Chicago” di Aaron Sorkin, che mette in scena un momento storico degli Usa al termine degli anni ’60, mantiene tutte le promesse che il film faceva presagire, esempio perfetto di quel cinema liberal che ha segnato tanta produzione hollywoodiana. Il regista è al suo secondo film ma da trent’anni è drammaturgo e autore di prestigiose sceneggiature che hanno raccontato con efficacia il panorama della vita americana, spaziando dalla grande politica della serie “West wing” sulla casa Bianca alla visione dietro le quinte del funzionamento di un network televisivo in “The newsroom”, fino ad affrontare al cinema le figure di Jeff Bezos e Steve Jobs. Steven Spielberg, con cui aveva collaborato per “Schindler’s list”, gli commissiona già nel 2006 lo script per un’opera sul processo ai sette attivisti pacifisti accusati di aver fomentato i disordini che accompagnarono la Convention democratica del 1968. Fortemente voluta dalla neoeletta amministrazione Nixon, che cercò in tutti modi di pilotarne l’esito, la vicenda giudiziaria divenne un evento che coinvolse l’intera nazione, rivelandosi nella sentenza d’appello un boomerang per chi l’aveva promossa. La realizzazione del film subisce diversi rinvii ed è solo nel 2018, dopo l’elezione di Trump, che Spielberg ne affida a Sorkin, grazie al felice debutto con “Molly’s game”, la regia.
Memore del suo primo grande successo, la drammaturgia di “Codice d’onore”, il regista concentra il cuore del racconto negli scontri nell’aula di tribunale. Con la riconosciuta maestria, sorretto da un cast stellare, con in prima linea Eddie Redmayne (Tom Hayden), Sacha Baron Cohen (Abbie Hoffman) Jeremy Strong (Jerry Rubin) e Mark Rylance (l’avvocato difensore William Kunstler), Sorkin orchestra uno scoppiettante susseguirsi di dialoghi, non disdegna anche toni da commedia, disegnando le personalità dei protagonisti, i loro differenti obiettivi politici, il diverso approccio alla battaglia processuale. I rari ma intensi flashback a rammentare i fatti, alternano ricostruzioni ed immagini di repertorio e non possono non richiamare da un lato la preziosa testimonianza coeva di “America, America dove vai”, non felicissima intitolazione italiana del ben più incisivo e machluhaniano “Medium cool” di Haskell Wexler e dall’altro le innumerevoli manifestazioni che attraversano gli States negli ultimi mesi. “La sceneggiatura non è cambiata per rispecchiare i tempi, i tempi sono cambiati per rispecchiare la sceneggiatura” dichiara l’autore nelle note di produzione ed in effetti gli echi di quegli eventi di 50 anni fa risuonano in più momenti fortemente contemporanei: la figura del giudice Hoffman, superbamente impersonato da Frank Langella, sarebbe apparsa probabilmente fin troppo caricaturale in tempi non trumpiani, la fredda, ambiziosa determinazione del giovane procuratore Schultz (un ottimo John Carrol Lynch) nel perseguire gli ordini dell’establishment richiama la miope fedeltà alle imposizioni presidenziale di una consistente parte dell’attuale gabinetto governativo statunitense. È un triste segno dei tempi che un film come questo, potenzialmente in grado di interessare un vasto pubblico per il giusto equilibrio tra pop e impegno, abbia goduto di una limitata distribuzione per approdare ben presto ai domestici schermi di Netflix.
RISCOPERTE PREZIOSE
di Francesco Saverio Marzaduri
Cleo dalle 5 alle 7
Rivedersi una rarità cinematografica, una di quelle pellicole destinate ai circuiti meno popolari e vasti, quelli di nicchia da subito, che la condannano a sempre più rare programmazioni sino all’invisibilità di fatto – e chi l’ha vista beato lui, gli altri se l’immaginino – non è esperienza che non richieda atteggiamenti particolari. Nel caso in cui il (nuovo) spettatore ci si accostasse senza pensarci troppo su, potrebbe essere la pellicola stessa a risultargli strana; se lo spettatore in oggetto è dotato di sensibilità e partecipazione, sarà il film stesso a fornirgli di che riflettere. Sempre che sia onesta l’intenzione reciproca: dello spettatore e dell’autore. In questo caso, dell’autrice.
“Cleo dalle 5 alle 7”, di Agnès Varda, ragazzaccia dolce, irriverente e acutissima ancor quando a novant’anni ci ha lasciati, di riflessioni ne impone parecchie. E, prima di esse, suscita prese d’atto, come ogni buon documentario dovrebbe. E che si tratti di un documentario più ancora d’un film a soggetto (benché se non fosse anche questo, semplicemente, non sarebbe) si fa ben chiaro nel suo sviluppo: dagli eventi – che si susseguono con l’indicazione dell’orario in cui avvengono – quanto dalle tecniche di ripresa, dall’uso di un bianco e nero da reportage cinegiornalistico, dai primi piani come istanti isolati dal flusso della quotidianità.
Non si tratta però solo di un documentario “su una figura di donna e su una città”, come pare che il film venga prevalentemente catalogato, né che il suo valore consista nel solo essere indicativo di un’epoca storica (i primissimi Sessanta) in un luogo preciso (Parigi), in un Paese e in una società che si dibattono tra dubbi e cambiamenti di non poco conto. Lo sguardo di Agnès Varda non è quello che Richard Lester poserà sulla “Swinging London” e sui Beatles quattro anni dopo, non mitizza figure già mitiche suggerendo un adorante “milieu” giovanile pago di ciò. Cléo è giovane e graziosa, ha inciso qualche quarantacinque giri di discreto successo e chi la riconosce non manca di chiederle una foto con autografo; il mondo, però, non sembra ruotare attorno alla sua figura, e tra le cinque e le sette avrà modo di accorgersene. Perché il mondo sono gli avventori del “café” che non solo non la riconoscono ma si sentono disturbati dal juke-box in cui ha gettonato un suo disco; i fidanzati al tavolino accanto, che stanno per lasciarsi perché lui pretende di dormire con lei e lei non ne accetta l’“aut aut”; la tassista che la porta in giro, una donna non classicamente bella, forse, ma sicura e consapevole di sé, tanto da apparire interessantissima; l’amica modella all’atelier, che fa scivolare la propria nudità nell’abitino ed esce con Cléo neppure la guardano, senza preoccuparsi della biancheria…
Nel mondo, quello di Cléo, ci sono la segretaria-factotum, un po’ balia e un po’ dama di compagnia; c’è il signore elegante e distinto, di eccellente posizione, che la copre di regali, sicuramente ne accontenta i capricci, probabilmente ne finanzia lo stile di vita, e magari l’accompagna laddove sia utile mettersi in mostra; c’è il proiezionista che le offre la visione di una comica attraverso il pertugio della sala di proiezione. E c’è un soldato il cui permesso sta per scadere, destinato all’Algeria e alla “sale guerre”.
Sono forse, in questa varia umanità, proprio le figure maschili a indicare un altro possibile percorso di lettura: il film è, sì, la registrazione di una presa di coscienza, suggerita da un timore che prima genera ansia e poi si fa angoscia (l’attesa del risultato di un’analisi medica con la paura di essere condannata). È, sì, il passaggio di una linea d’ombra, quella che separa Cléo dalla consapevolezza di essere oggetto di consumo (la sua voce nei dischi e per radio, la sua foto sulle foderine dei dischi e sulle cartoline autografate), dall’aderire agli schemi bamboleggianti che lo prevedono (i tantissimi cappellini provati dalla modista prima di scegliere quello che già aveva deciso di prendere; il “monsieur” ricevuto in veste da camera ornata con piume di struzzo nella regale alcova su cui lui pure si accomoda come su un sofà) a una consapevolezza che da un certo punto in poi si fa largo e si impone. Abbandonati negligé e parrucca, Cléo s’infilerà un tubino nero e s’immergerà tra la gente, lasciando i musicisti e arrangiatori con cui provava non potendo più reggere la distanza tra il suo stato d’animo e il loro; lasciando andare per abitudine ma senza vero rimpianto il suo distinto amico, avaro di visite e di tempo da dedicarle, ma voglioso di baci. E imbattendosi poi in un giovane, solo come lei, in un parco. Trovandosi a parlare con lui come con nessun’altra persona nell’ora precedente. Un giovane che conosce la propria destinazione e la data di partenza, ma nulla sa di eventuali ritorni, e che pure trova più bello il vero nome di lei rispetto a quello d’arte che si è data, che gliene spiega l’etimologia svelando un animo poetico e sereno.
Cosicché, quando lui si offrirà di accompagnarla all’ospedale, dal medico che le ha dato appuntamento per il risultato delle analisi, tutto si condurrà in un’atmosfera non più d’attesa, ma di inconsapevole vuoto mentale, come di tranquilla normalità. Il medico – maschio, va detto – neppure l’attenderà in ambulatorio, ed è solo perché lei lo vede passare con l’auto che ha occasione di parlargli. Lui la rassicura senza rassicurarla, dice e non dice, sprizza l’ottimismo di chi dopotutto sa che in ballo c’è una vita altrui e non la propria. Col fare di chi sa autorevole il suo ruolo e si aspetta deferenza, specie da chi giudica probabilmente una giovane viziata. Per poi allontanarsi con l’auto e lasciare in un mesto e densissimo “zoom” indietro, sempre più distanti da lui, la ragazza e il giovane.
Non si sa – e perché si dovrebbe, poi? – quali saranno gli sviluppi. Ma lo spettatore, una cosa, può presumerla. Cléo non sarà più, probabilmente, la stessa di qualche ora prima. Quando ancora non aveva parlato con la tassista che non teme di fare un lavoro usualmente maschile, che non teme le prepotenze e le furbastrerie dei maschi e all’occorrenza sa come agire e farsi rispettare. Quando ancora non aveva parlato con l’amica modella, che vive in assoluta armonia con il corpo e la femminilità che le appartengono, e posare nuda negli atelier non le crea problema (“Non mi imbarazzano quelli a cui mi mostro, non vedono il mio corpo, lo guardano e lo riguardano cercando una loro idea”). Quando ancora non aveva ascoltato il giovane parlarle non di quanto lo attendesse, ma di quanta purezza e bellezza possano esistere anche solo in un bel nome che evoca i fiori, o nello stare nudi, potendo, o in quel primo giorno d’estate.
Il percorso di Cléo è la fotografia di un cambiamento già in atto, sui ruoli e sui costumi, sul residuale ma ancor dominante sciovinismo e sulle crepe già visibili nella sua struttura, sulla società in trasformazione di cui già si possono calcolare gli orientamenti. Tanto squisitamente al femminile da evocarne i modelli più alti, persino le ineffabilità più inattese. All’inizio della sua importante giornata, e del romanzo a lei intitolato, la signora Dalloway stabiliva che i fiori per decorare la tavola li avrebbe scelti e comprati lei, come Cléo il cappellino dalla modista; per poi, dopo una giornata di commissioni, di visite, di incontri – una giornata su cui incombe l’inspiegabile senso di un’attesa, il presagio di un cambiamento imminente, forse letale, certamente totale – risolversi nell’incontro con un soldato, prossimo a svoltare la propria vita. E a cambiare inconsapevolmente la sua. Che la Varda abbia trovato in Virginia Woolf un’ardente sorella, e un sentire comune, può sorprendere solo chi abbia del femminismo e del femminile la più aliena delle idee. E la contiguità con un capolavoro narrativo può esistere solo con un altro capolavoro: anche se narrato per immagini.
Oscar insanguinato
“Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba?”
PIERO CIAMPI, Adius
Quando il raccapriccio concilia con la commedia: se ci s’abbandona per qualche oretta al “black” humour più perfido, condito d’un “nonsense” neppure troppo velato, si intuisce perché il “teatro di sangue” – come declama il titolo originale – di “Oscar insanguinato” non denunci tuttora la minima scalfittura rispetto al pravo smalto con cui si presentò. Sulla falsariga del bel dittico dedicato al dottor Phibes, in cui consumava una vendetta seriale ai danni degli assassini della moglie prima di tentarne la resurrezione, un Vincent Price già anziano ma non meno luciferino scruta i più reconditi anfratti della psiche e, grazie al consueto “charme” d’incontrastato mattatore, cattura il pubblico per un’ora e quaranta di proiezione. Entro una confezione “all british” irta di comprimari e maestranze indiscutibilmente annessi al comparto filmografico inglese, sotto la direzione del pur non eccelso Douglas Hickox, seguiamo la ballata macabra d’un consumato guitto da palco, Edward Lionheart, deciso a sfogare la propria rabbia omicida sulla critica “upper class” rea di non avergli conferito una prestigiosa onorificenza, a suo dire meritevole, preferendogli un interprete più fresco e forse meno talentuoso. Complice l’apporto della figlia Edwina (la Diana Rigg, recentemente scomparsa, della serie tv “Agente speciale”), la faida è introdotta da un incipit in cui l’uomo, abbigliato da “bobby”, lascia che una combriccola di avvinazzati “clochard” in un magazzino abbandonato pugnali la prima vittima con bottiglie di vetro infrante, per concludersi nel rogo d’un teatro con la morte del Nostro; per il quale l’ultimo bersaglio, scampato per un soffio a un accecamento, serba giusto un riconoscimento sulla sua abilità nell’uscir di scena. Siamo ben lontani dalla sete di giustizia della “Sposa in nero” Julie Kohler, indotta solo dalla volontà di eliminare gli assassini del marito, rivendicandone l’uccisione e impedendo che alcuna accusa ricada su altri. Quanto sia probabile che Tarantino si sia rammentato di tale schema per “Kill Bill” – schema peraltro classico – non è dato sapere, ma “Oscar insanguinato” ne è ulteriore ipertesto: si può scommettere che lo abbia visto e gli sia piaciuto assai, conoscendolo per opere e dichiarazioni; che se ne sia appuntato la componente grandguignolesca e ferocemente ilare, nel roboante crocevia di morti ideate (e inscenate) per contrappasso, tutte ispirate alle tragedie shakespeariane. Non sempre il colpaccio va a segno e, per quanto necessario, talvolta la resa scenica tralascia gli eccessi: si prenda la ritorsione sulla falsariga di “Otello”, in cui, convinto di un inesistente tradimento coniugale, è il predestinato a far fuori la moglie subendo una condanna all’ergastolo, o il duello coi fioretti – nient’altro che una pausa tonale – in cui Lionheart affronta il pezzo grosso della critica ferendolo senza volerlo uccidere – e lo stesso promettente epilogo si risolve in una blanda maniera catastrofica. Ma il restante florilegio, nonostante un’ironica cornice “art déco” sacrificata da un’impostazione televisiva, è uno spasso d’assortita e perversa fantasia, in cui non si risparmia nemmeno la critica femminile in stile Hedda Hopper, letteralmente arrostita dalla propria vanità (il salone dal parrucchiere trasformato in una sedia elettrica). C’è perfino la stoccata al consumismo più avido, di cui fa le spese un goloso recensore cui Edward, a sua insaputa, cucina un “pastiche” coi suoi adorati barboncini costringendolo a ingurgitarlo sino a soffocarlo. Aveva ragione Tullio Kezich scrivendo che con Price siamo davvero all’università dell’orrore. Accentuato da un’iperbolica “mise-en-scène” e da una recitazione volutamente sopra le righe, “Oscar insanguinato” è una deliziosa favola moralista d’incandescente forza tragica: mentre da un lato ci si spaventa per le (lucide) follie nefande d’un protagonista ogni volta reso irriconoscibile da vistosi camuffamenti, dall’altro, un osservatore ineluttabilmente invischiato nella morsa non può non provar compassione, o persino tifare, per quella patetica figura, così intrigante perché, mentre se ne deplorano le azioni, in larga misura s’interpreta quale diabolico mantra dei nostri stati d’animo. Complice un colpo al cerchio dei sedicenti acculturati e l’altro alla botte delle loro pance vuote, gli uni e le altre atrocemente puniti con espedienti “gore” debitori della lezione cormaniana (che persino preludono alla buffoneria nichilista dei Monty Python), meritoriamente soddisfatta è la derisione di un’“élite” egocentrica e fredda, evanescente e mediocre: nulla più d’una raggiera di arroganti arricchiti, autoreferenziali e sostanzialmente vuoti, edificata su giudizi falsamente consenzienti e soggettive preferenze, di cui fa le spese la versatilità, se non la passione, di qualsiasi artista. “Milieu” incapace di cambiare opinione anche a prezzo di esistenze segnate dall’umiliazione, che una morte inscenata riesuma in un’estrema occasione di riscatto (non a caso, il solo pubblico condiscendente di cui dispone è una combriccola di barboni). Poco interessa che il ribrezzo, un po’ come nel terzo segmento di “Trilogia del terrore”, sia più sensoriale che visivo: lo spettatore cinefilo ben conosce tale casta, detestata per la supponenza e il dotto quanto esibito nozionismo vanamente sfoggiato, ma pur chi nulla sa di tutto questo è messo nella condizione di esecrare lo stralcio di mondo che gli viene presentato – e viziosamente descritto – godendo, beffardo, a ogni efferato delitto. Se ne delinea il ritratto d’un instancabile mediocre, a modo suo un eroe, tanto convinto del proprio talento da non poter accettare il superamento dei tempi, per il quale la concezione di “gloria” è solo contemplata. Anche più che in “Birdman”, che pur realizzato una quarantina d’anni dopo ruoterà su un tema affine, l’inappagata brama di meriti tesi a compensare la bravura tocca, qui, vertici di cattiveria tanto paradossali da suscitare empatia, e – facendo i conti con la propria metà oscura – evocare una mentale resa di conti con gli antagonisti di ciascuna sfera quotidiana. E chi scrive, dovendo contentarsi della semplice fantasia, non nasconde d’aver immaginato il medesimo schema per parecchi scribi del settore, divertendosi a fantasticarne giocosamente e gioiosamente analoghi scenografici trapassi. Ma si sa, l’ironia in punta di fioretto è privilegio di pochi, e solo a pochi consentito: l’immortale Bardo, tirato in causa, lo sapeva bene: “Il piacere e la vendetta sono più sordi del serpente alla voce di una decisione equa”. “Sic docet”!
“VOLEVO NASCONDERMI” DI GIORGIO DIRITTI
di Tullio Masoni
Antonio (Toni) Ligabue (già Laccabue), ossia il Mistero. Un artista senza veri maestri – lo fu, solo parzialmente, Marino Mazzacurati – e prodigio della inconsapevolezza. Col tempo, e l’evoluzione della critica, gli schemi categoriali: primitivismo, naiveté, sono saltati; come il paragone, certo giustificato per vari aspetti, con Van Gogh. Il Mistero (non per caso adopero la maiuscola) ha prevalso e prevale, perché Ligabue spunta da una opacità, o da una notte, in cui ogni rapporto di storia estetica, memoria, o superficiale esperienza, sembra vano. Ligabue un folle? Probabilmente. Un isolato speciale, cioè un diverso di zingaresca attitudine, di inaspettata malizia, talvolta, ma sempre incompatibile per una micro-società che poi, grazie all’opera sua e di pochi altri vissuti nello stesso ambiente, si è rivelata grande? Sì. Ligabue asociale e tuttavia ospite, oltre che dei manicomi e delle case di carità, di amici e protettori… «è più mago che pittore – disse Anatole Jakovsky – più pazzo che ingenuo, più veggente che osservatore: resterà uno dei grandi enigmi dei nostri tempi.» e Mazzacurati, dal canto proprio: «Possiamo interpretare, contestare, esaltare, magari perfino sottovalutare l’opera di Ligabue: resta qualcosa di più complesso che ci sfugge. C’è quella magia che alcuni riescono talvolta a captare nel cosmo e a trasmettere agli altri, e che va al di là dello spazio e del tempo.» Una sorta di ascesi, dunque, rivelata dalla pittura quale sintesi poetica senza un prima e un dopo, cioè involontaria sacralità materiale e “animalesca”: … bramava dipingere alto / – scrive Cesare Zavattini in un famoso poemetto – era il solo italiano da murales. / Disse davanti alla cappella Sistina / ma non è pittore chi non mette in un quadro le bestie…
Qualcuno ha rilevato come nella sua totale incultura abbiano finito per manifestarsi simultaneamente tre scuole otto-novecentesche: il simbolismo l’espressionismo, e il surrealismo, e come l’ossessiva frequenza dell’autoritratto esprimesse nel “bruto” un sorprendente desiderio di affermazione; «…è il colore – scrive Giuliano Serafini in un saggio prezioso – a sostenere il ruolo maestro nell’opera e a funzionare da momento liberatorio sia in accezione emotiva, che in quella strettamente tecnica, prevalendo sulle incertezze e le goffaggini della mano (…) Quello che più conta – aggiunge – è che l’“espressionismo” di Ligabue non deve essere interpretato alla luce della consuetudine esegetica che mette in relazione vita e arte (…) un espressionismo che affonda piuttosto in una forma di autoesaltazione: è una fuoriuscita dell’”io” che trabocca nel narcisismo più estremo fino a produrre, al di là della metafora e dell’allegoria, un’immagine di sé lirica e insieme fantastica».
Con “Volevo nascondermi” Giorgio Diritti si colloca fra gli autori – registi, teatranti, musicisti – che al pittore di Gualtieri si sono dedicati; vale ricordare per il cinema e la Tv, fra diversi altri di cui ho insufficiente memoria, Raffaele Andreassi (“Lo specchio, la tigre e la pianura” – 1960, “Antonio Ligabue pittore” – 1965, “I lupi dentro” – 2000) Salvatore Nocita (“Ligabue” – 1977, “Antonio Ligabue fiction e realtà” – 2009) Pierpaolo Ruggerini (“Il paese del sole a picco” – 1960), Ezio Aldoni (“Antonio Ligabue, l’Uomo” – 2015).
Nella prima parte, credo la più personale e innovativa, il regista guarda al personaggio secondo una sensibilità che già qualificava alcuni dei suoi lavori più originali e riusciti; penso a “Con i miei occhi” (2002), a “Il vento fa il suo giro” (2005), a “Piazzati” (2008).
Il Ligabue che ci mostra, infatti, è un uomo di confine. Un essere diviso per lingua, povertà (anzi miseria), aspetto e costume quotidiano, al punto di rientrare nella tipologia più estrema dell’emigrante: «La storia delle due famiglie, i Laccabue e i Göbel – scrive ancora Giuliano Serafini – è stata in sostanza una storia di emigrazione, di senza terra, di chi ha subito dure condizioni di precarietà e aleatorietà sociale. Lo stesso Antonio visse i suoi giorni in uno stato di apolidismo mentale, senza riuscire mai a integrarsi né nel paese d’origine, la Svizzera, né in quell’Italia padana compresa fra Mantova, Reggio Emilia e Parma, che è il centro della sua vita errabonda». Un essere affine all’animale – incarnato da un Elio Germano che sembra esaltarsi con personaggi assai diversi fra loro ma accomunati dall’alterità, si pensi al Leopardi di Martone – che emette versi più che parole, o meglio una specie di idioma selvaticamente formato da accenti tedeschi, italiani e dialettali; che si aggira per scatti, fughe o sortite in luoghi di ombre, desolati, resi sinistri da inquadrature tagliate con linee “irregolari” e sghembe. Un essere che lascia l’osservatore incerto fra partecipazione patetica e ripulsa, fra desiderio di soccorso e panico per una possibile, improvvisa espressione di ferocia.
La seconda parte del film schiarisce e prende un colore più diurno; forse un poco prolissa – ma non dimentico di essere uno spettatore-covid, cioè segnato dalla lunga astinenza e dal disagio della protezione in sala – e più rigidamente scandita. L’impressione è insomma di un passaggio dalla ricerca (e scoperta) a una pur pregevole aneddotica. O, detto in altro modo, da un coinvolgimento che per via di reciprocità sfiora la provocazione, al giustapporsi di squarci “biografici” pur se evocati e reinventati con libera scelta.
DUE NON FICTION
“Paolo Conte – Via con me” di Giorgio Verdelli
“Genesis 2.0” di Christian Frei e Maxim Arbugaev
di Paolo Vecchi
Una Topolino, in un bianco e nero d’epoca che si trasforma ben presto in un fiammante amaranto, si aggira per gli ordinatissimi vigneti dell’astigiano prima di entrare nelle strade e nelle piazze della città fermandosi davanti allo studio legale Conte. L’Avvocato, per antonomasia dopo la scomparsa del suo omonimo torinese, parla di sé con precisione, disincanto e una neppure tanto sottesa malinconia: parla di canzoni ma anche di enigmistica e di grafica, discipline che conosce piuttosto bene e continua a praticare assieme alla musica e alla poesia ad essa strumentale, nonostante abbia girato proprio quest’anno la boa degli ottanta, puntando forse a continuare per un altro decennio, come il collega Charles Aznavour. Il suo raccontarsi è ovviamente scandito dalle registrazioni di cinquant’anni di attività concertistica, in teatri mitici come l’Olympia di Parigi o in luoghi simbolo come l’Arena di Verona. Poiché agli inizi era solito affidare ad altri le sue canzoni, biancoeneri reperti d’epoca ci fanno vedere e ascoltare Adriano Celentano (“Azzurro” e, insieme a Claudia Mori, “Chi non lavora non fa l’amore”), Enzo Jannacci (“Messico e nuvole”), Bruno Lauzi (“Genova per noi”, “Onda su onda”) e Caterina Caselli (“Insieme a te non ci sto più”). Volendo essere pignoli, manca “Una giornata al mare”, resa indimenticabile, anche, dalla voce nasale di Maurizio Vandelli dell’”Equipe 84”.
Ci sono poi quanti si sono assunti la responsabilità delle cosiddette cover, da Francesco De Gregori (con Lucio Dalla) a Peppe Servillo degli “Avion Travel” a Cristiano Godano dei “Marlene Kuntz”. C’è Jane Birkin, l’unica ad aver registrato un duetto insieme a Conte, dopo quelli col marito Serge Gainsbourg e, al cinema, con Dirk Bogarde nel tenerissimo “Daddy Nostalgie” di Bertrand Tavernier. Un caso particolare è poi quello di Roberto Benigni, che a Conte aveva commissionato la colonna sonora del suo film d’esordio come regista, “Tu mi turbi”, in cui esegue con sorprendente disinvoltura e impeccabile intonazione il brano del titolo, “Via con me”, e che interviene più volte con la sua travolgente verve a spiegare cosa rappresenti per lui il cantautore di Asti. Tenute insieme dalla voce narrante di Luca Zingaretti, che appare talvolta anche di persona, assistiamo a una nutrita serie di testimonianze (Bollani, Arbore, Paolo Jannacci…) alcune delle quali non vanno al di là dell’apprezzamento occasionale e comunque potevano essere asciugate per risultare in tono con l’essenzialità del personaggio. Divertenti oltrechè significative quelle di due registi, Patrice Leconte e Pupi Avati. Il primo sottolinea l’internazionalità di Paolo Conte, che paragona a Marcello Mastroianni. Il secondo, il cui atteggiamento simpatetico è sostenuto dalla comune matrice jazzistica, non riesce tuttavia a nascondere l’invidia nei suoi confronti perchè è bello e piace alle donne, lui che era arrivato a odiare Dalla quando aveva capito di non poterlo neppure avvicinare come solista di clarinetto. Giorgio Verdelli, già autore di due ritratti cinematografici di Pino Daniele e Mia Martini, alle prese con un mostro sacro dimostra di saper essere comunque all’altezza nel mettersi al servizio della sua imponente personalità.
Altra musica, sempre di notevole qualità anche se in assenza di un personaggio forte, in “Genesis 2.0” dello svizzero Christian Frei, segnalatosi in passato per “War Photographer”, sul grande James Natchwey, e dell’ex giocatore di hockey su ghiaccio russo covertitosi alla non-fiction e alla direzione della fotografia Maxim Arbugaev. Nelle due facce di questo interessante documentario si alternano infatti gli score del veterano Eduard Artemev, collaboratore storico di Andrej Tarkovskij e dei fratelli Andrej e Nikita Mikhalkov – Konchalovskij, e il più giovane, minimalista Max Richter, che si è fatto le ossa con Steve Reich e Philip Glass, ha attraversato tanto cinema, da Scorsese a Malick a Villeneuve e ha pubblicato per la Deutsche Grammophon una curiosa versione delle “Quattro Stagioni” di Vivaldi. Due facce, dicevamo, perchè la parte del film ambientata nelle isole della Nuova Siberia narra la ricerca di zanne di mammut da vendere ai mercanti cinesi, di pari passo con quella, con finalità scientifiche, dei loro corpi il più possibile integri. Ad essa si alternano immagini rubate all’iGEM di Boston e alla Harvard Medical School, dove gli studi sulla clonazione puntano a ridare vita ad animali estinti, oltrechè alla coreana Sooam Biotech, dove il disinvolto e chiacchierato Woo Suk-huang per una cifra non proprio modica è in grado di ricreare copia conforme del vostro cane da compagnia passato a miglior vita.
Piu che in questo pullulare di ipotesi scientifiche al limite della stregoneria, con una presa di distanza sulla loro ambiguità che solo a tratti rievoca le analoghe, beffarde operazioni herzoghiane, ci sembra che il fascino del film risieda soprattutto nella funebre bellezza del paesaggio artico e nell’alone leggendario che lo circonda.
QUALITÀ IN SERIE
LA BANDA
IL PROGETTO
di Luca Serasini e Nico Malvaldi
La Serie è prodotta dall’associazione culturale Cantiere Nuovo con la collaborazione di Corte Tripoli Cinematografica
IL PROGETTO

PREMESSA
Nel 2018 l’associazione culturale Cantiere Nuovo con Nico Malvaldi (fotografo che vive a New York), Luca Serasini (artista, socio di CTC ed ex membro del direttivo), Francesco Bottai (cantautore) ed Enrico Caroti Ghelli (sceneggiatore, ex presidente CTC) hanno avuto l’idea di realizzare una serie web che narra le vicende di un gruppo di marinesi ‘doc’ che, in reazione ai soprusi subiti per colpa di un sistema per loro ingiusto, formano La Banda.
Nello stesso anno sono stati fatti “i provini del Cantiere” dove si presentarono circa 60 persone di tutte le età. Subito dopo è nata la sceneggiatura vera e propria che è stata girata nella primavera-estate del 2019. A cavallo del 2020, fino a tarda primavera, sono stati realizzati il montaggio e la colonna sonora. Infine, alla presenza di circa 500 persone, la serie web è stata proiettata in prima visione il 24 agosto 2020 e poi resa disponibile su youtube.
A Natale 2020 uscirà il DVD con gli episodi, la versione film, tanti materiali inediti e il making of. Le parole che seguono sono il risultato di alcuni incontri (tra autori, collaboratori e alcuni protagonisti della serie) sul senso di questo lavoro, per certi versi “immane”, se si considera che è stato realizzato con una piccola comunità, qual è Marina di Pisa.
PERCHÈ MARINA?
ENRICO CAROTI GHELLI: Sono sempre stato attirato dalle dinamiche di comunità. Il luogo dove le persone abitano segna il carattere dei suoi abitanti, creando un canale di comunicazione, una trama comune. Abbiamo indagato questo rapporto, lasciandoci guidare dalla certezza che solo andando in profondità nel particolare si riesce a parlare dell’universale.
LUCA SERASINI: Gli abitanti di Marina di Pisa dicono di sé stessi di essere “marinesi”, omettendo il “di Pisa”, solo perché superfluo… L’essere singolari, unici, ne evidenzia il carattere. Amano la loro terra di quell’amore cieco che non vuole vederne i difetti, difendendola a spada tratta da ogni offesa “straniera.” Il carattere dei Marinesi è tale, perché sono imbevuti fin dalla nascita da salmastro, libeccio, sole, sabbia, pesca, belle ragazze, bei ragazzi, pineta, funghi… Le Ville Liberty anni ‘20 si mescolano a condomini anni ‘80 con i muri rovinati. E c’è il porto, molto bello, che cozza col resto. Questo, per me, è Marina: una piccola Cuba.
L’operazione, che abbiamo portato avanti dal 2018 al 2020, si può definire come un vero “progetto di coinvolgimento, inclusione e conoscenza intergenerazionale di un piccolo paese”. Quello che una volta accadeva nei circoli, in cui più generazioni si ritrovavano insieme a giocare a carte e a vedere le partite.
I NON-ATTORI
LUCA: L’idea di fondo di usare persone “normali” mi è venuta al cinema, durante la visione del primo film di Ligabue (Radiofreccia), in cui avevo visto in scena alcuni personaggi di paese. Era il 1998 e non avevo mai preso in mano una telecamera. Solo dal 2007, dopo il mio ingresso in Corte Tripoli Cinematografica, con l’attrezzatura e l’esperienza di tanti soci, ho iniziato a realizzare video, soprattutto lavori di videoarte e videoinstallazioni.

NICO MALVALDI: Penso che la decisione dei “non-attori” abbia funzionato perché essenzialmente abbiamo fatto un casting al contrario: invece di trovare gli attori per la nostra storia, abbiamo scritto la storia considerando i personaggi che avevamo a disposizione.
ENRICO: La scelta dei non attori è stata inevitabile. Quel livello di incertezza e approssimazione è per noi l’espressione intima di un lavoro che si pone a metà tra un film e un documentario.
SCENEGGIATURA E RIPRESE, IL METODO
LUCA: Il metodo di lavoro doveva tener conto che ci stavamo approcciando ad un mediometraggio, con una sessantina di persone ed ambientazioni molto diversificate. Altro aspetto importante era che quasi tutte le persone coinvolte durante la settimana lavoravano e molti avevano famiglia (qualcun con dei problemi). Dovevamo, quindi, trovare un sistema di lavorazione che cercasse di scongiurare (il più possibile) ogni defezione. Si è poi deciso, su suggerimento di Enrico, di seguire cronologicamente l’ordine delle scene, anche perché gli interpreti, col passare del tempo, cambiavano esteticamente (abbronzatura della pelle, taglio dei capelli, ecc.). Oltre a queste problematiche, poi, c’erano di mezzo il lavoro (mi occupo di infografica e multimedia per l’istituto di fisiologia clinica del CNR) e la famiglia: abbiamo diluito le riprese in 6 mesi.
ENRICO: Il lavoro di Luca è stato immane. Tutte le scelte artistiche, quando poi si calano nella realtà, si complicano in modo esponenziale. Il fatto di non avere attori professionisti lo ha costretto a inseguire continuamente. In tutta sincerità mi sarei aspettato una riduzione drastica in corso d’opera del numero di riprese e tagli notevoli alla sceneggiatura. Invece è accaduto il contrario, non solo Luca è riuscito a portare in fondo il piano prefissato, ma nel cammino si sono aggiunti spunti e idee. Io avrei optato più per lasciar parlare gli attori su un semplice canovaccio ma gli altri, soprattutto Francesco, si sono impegnati nello scrivere e forse il conforto di avere delle “battute” ha dato sicurezza agli attori. È stato molto bello condividere la fase di scrittura.
NICO: il montaggio è stato tanto divertente quanto impegnativo. Una prima volta che ha sicuramente lasciato il segno. A mano a mano che il lavoro si sviluppava, era sempre più’ chiara l’importanza del ritmo, per far sì che le battute esprimessero la storia e creassero l’atmosfera voluta, conservando la schiettezza dei personaggi.
ANDREA MALVALDI: La mia collaborazione a questo progetto è iniziata per puro caso. Mio cugino, Nico Malvaldi, appena rientrato dall’America, mi ha parlato del progetto che intendeva realizzare. Sapendo della mia grande passione per il cinema e la fotografia, coltivata e alimentata negli ultimi due anni di studi universitari, mi ha proposto di partecipare al progetto come operatore.
Ho accettato immediatamente, nonostante l’ansia e la paura di sbagliare: la voglia di imparare ha subito preso il sopravvento. I primi giorni arrivavo sempre in anticipo, col terrore di non riuscire a preparare la camera in tempo per le riprese. Ma, appena arrivavano gli attori e il resto della troupe, la paura lasciava il posto a un clima di convivialità fatto di risate e lunghe chiacchierate. In fin dei conti eravamo tutti (o quasi) alle prime armi e penso che questo sia uno dei punti di forza dell’intero progetto. L’inesperienza degli attori, tra battute dimenticate e improvvisazioni, ci ha regalato un’infinità di materiale, creando un “repertorio di cultura marinese contemporanea”.
La scelta di registrare gli attori anche durante le prove si è rivelata fondamentale: il loro genuino modo di esprimersi e scherzare, spesso, forniva battute più autentiche di quelle previste dal copione, spingendoci, durante il montaggio finale, ad utilizzare scene inizialmente escluse.

LE MUSICHE, L’ATMOSFERA
FRANCESCO BOTTAI: Ho scritto la musica per questa serie con amore ed ho agito per sottrazione, conferendo vuoto e pulizia ad una musica che descrivesse in modo onirico questo microcosmo che si affaccia sul mare. La ricerca è stata soprattutto timbrica, in modo da legare le facce, gli ambienti e la storia, in un’unica pasta sonora riconoscibile. Seguendo la sceneggiatura ho capito che la musica doveva rappresentare un ambiente su cui poggiare la storia. Tante le ispirazioni naturalmente: Tom Waits, Nino Rota, Carlo Rustichelli, solo per citarne alcuni. Il tutto filtrato dalla mia sensibilità e dallo sguardo di chi vive una Marina ferma nel tempo.
OLTRE MARINA
Il progetto de “La banda” è creato in una dimensione locale, ma presenta anche elementi che escono dal paese in termini culturali e sociali.
NICO: “A Marina di Pisa non ci sono solo gelati e tramonti” dice Claudia, una non-attrice della serie. Per chi li sa cogliere, infatti, ci sono parecchi dettagli che esulano dal contesto locale: si parla di ingiustizie create dalla disparità delle classi sociali, della “uguaglianza di genere”, della teoria macroeconomica MMT, della “tolleranza che fa diventare amico lo straniero”.
ENRICO: Oggi è difficile trovare dei temi comuni sui quali impegnarsi dal vivo, in battaglie che non siano fatte solo a colpi di like. Abbiamo descritto una comunità come la vorremmo perché, con il potere del cinema e dell’immedesimazione, possa poi diventare reale. Un gruppo di amici che si unisce e combatte per un’idea. Non importa se in modo sgangherato, con mezzi risibili, con risultati opposti. Il vero valore sta nel cammino fatto insieme. Abbiamo descritto l’umanità che vorremmo, fatta di vicinanza e dialogo.
LE TESTIMONIANZE
CLAUDIA GUAZZINI (la poliziotta): Marina di Pisa, non è semplicemente Pisa col mare. Marina ha una propria identitá, modi di dire, abitudini, modi di godersi il mare, modi di farsi conoscere, mai banali. Uno di questi per esempio, è stata la serie web ideata da Luca e Nico e tutta l’Associazione culturale Cantiere Nuovo. Questo progetto ha riunito grandi e piccini, facendo conoscere tra loro i marinesi di “inizio marina” con quelli di “fondo”, mischiando in un cocktail “esplosivo” le più disparate personalitá. Ha creato coesione, integrazione e ha sviluppato doti innate da grandi attori dentro ognuno di noi. Credo che la parte piú emozionante sia stata la sera della proiezione integrale, quando finalmente è stata svelata l’intera trama della serie anche agli attori.
Vedere le scene montate, provare quel piacevole imbarazzo di vedersi in uno schermo, vivere completamente immersi in 50 minuti di grasse risate, è stato il finale piú bello di tutta la serie. Ringrazio il Cantiere Nuovo per essere riusciti a dedicarsi con cosí tanta passione e dedizione a “La Banda”, nonostante i tanti impegni quotidiani, e per averci fatto sentire tutti un po’ Vip.
ROBERTO ASCIONE (il basista): È stato bello partecipare, esserci, vederci e rivederci sullo schermo, sentire di appartenere ad una comunità e poter contare su di lei. Abbiamo la fama di essere salmastrati, ruvidi e rugginosi ma, quando vogliamo, sappiamo essere uniti. Questo mi ha emozionato. Grazie al Cantiere Nuovo e a tutti i marinesi.
FABIO DE RANIERI (gendarmerie): Esperienza bellissima anche per me che, pur non essendo un nativo, amo Marina come mia vera casa. In questo luogo, decadente ma fascinoso come nessun altro, trascorro da sempre la mia estate e qui ho scolpito i ricordi più belli della mia vita. Marina ti strizza l’anima.
MICHELE BERTONI (non riesce mai a giocare a biliardo): Partecipare e rivedersi ne “La Banda” è stata una vera emozione. Un’esperienza bellissima! A prodotto finito già le prime note dell’intro musicale mi hanno riportato subito ai temi musicali degli spaghetti western, evidentemente molto cari a Francesco (Bottai), inseriti qua in un contesto completamente diverso. Al posto del villaggio fantasma di Tombstone una apocalittica Piazza Viviani, rallegrata solo da un luna-park semideserto, dove a completare il quadro mancava soltanto qualche rotolacampo che scivolava sul lungomare sospinto dal vento di libeccio. La bellezza di Marina di Pisa e dei suoi mille contrasti, strade larghe e case minime, sassini e Sunset, panfili e patini, amata alla follia da chi ci è nato o cresciuto, come tutti i protagonisti della serie compreso me, ma snobbata dal resto del mondo, solo perché il resto del mondo non ha né tempo né voglia di capire com’è veramente questa acciuga vestita da orata. “La Banda” per me si inserisce bene in questa altalena emozionale, perché è una via di mezzo fra poliziottesco-noir e commedia all’italiana, dove i cattivi (i francesi) sembrano stupidi come l’Ispettore Closeau e i cosiddetti buoni sono più cattivi dei veri cattivi e soprattutto più vendicativi di Rocco Musco di “Milano Calibro 9”. Ma qua l’ironia prende il posto dello splatter, si grida vendetta recitando Rimbaud e se ci sono delle esplosioni (e ce ne sono) il più delle volte sono solo i raudi sparati dal Niccolai. Il mio contributo nell’economia della serie è stato minimo, un cameo quasi casuale di cui ringrazio molto Luca (Serasini).

MAURIZIO BIGONGIALI (il barista zoppo): Non ho esitato neppure un istante a partecipare ai provini per “La Banda”. Ho subito intravisto la possibilità’ di mettermi alla prova in un’avventura per me nuova e ganza. Ho cercato di mettere molto impegno nell’interpretare il personaggio del barista, anche se non avevo molte battute, cercando di caratterizzarlo, quando possibile, secondo una chiave di lettura tutta mia. Per me è stato anche un atto d’amore nei confronti del paese più bello del mondo!
FRANCA MASI (la riccona): Che dire? Che mi avete preso quasi con l’inganno, perché non era previsto che io facessi la parte della donna anziana snob e aristocratica. Beh, devo dire però che mi è piaciuta e per questo motivo vi ringrazio!
ANDREA BORELLI (Il Pirata): Esperienza bellissima con amici di vecchia data… Sane risate e ilarità allo stato puro nel nostro paese d’origine… Nella vita bisogna sorridere e se lo si fa con persone care… tutto prende quota! “La banda” è stato il sole di agosto, caldo e confortevole.
I RISULTATI
ENRICO: Alla fine speriamo di aver regalato al paese dove viviamo una fotografia del momento. Un ‘come eravamo’ da poter rivedere con nostalgia tra qualche anno. Di momenti come questi sentiamo forte la necessità. Oggi i paesi si svuotano, le periferie sono dormitori e le classi sociali non esistono più, perse in un individualismo esasperato. Il nostro auspicio è aver creato un luogo dell’anima dove ricchi e poveri, giovani e vecchi si possano specchiare insieme.
NICO: Condivido l’analisi di Enrico e, anzi, vorrei andare oltre: secondo me il regalo è stato fatto, non c’è’ “da sperare”. Penso di poterlo affermare senza peccare di presunzione e dando i giusti meriti all’associazione del Cantiere Nuovo. Il regalo al paese l’abbiamo fatto tutti insieme. Il paese intero se l’è regalato. Anche chi è venuto a vedere la prima ha contribuito a definire l’ampiezza che il progetto ha raggiunto. Dimostrazione del fatto che una reazione viene ed esiste, solo quando c’è la debita provocazione.
QUALCHE APPROFONDIMENTO
Perché il tema delle “ghiaie” è importante a Marina di Pisa
NICO: Il discorso delle “ghiaie” è di natura locale e storica, un problema vecchio come il paese stesso, dovuto al fenomeno dell’erosione costiera. In duecento anni siamo passati da bellissime dune di sabbia agli scogli e dagli scogli alle ghiaie.
C’è chi è critico, per svariati motivi, e chi, invece, accetta con fatalismo la situazione. Ne “La Banda”, per rispetto ad entrambe le campane, sono riportate le opinioni discordanti, in un montaggio alternato volutamente buffo, anche se l’argomento è della massima serietà.
L’esistenza del porto è legata alla storia del paese, alla trasformazione del luogo e all’istintiva avversione al cambiamento.
NICO: Il porto è stato discusso, aspettato e “temuto” per generazioni. Ognuno vorrebbe che fosse in un modo diverso. Per alcuni l’apparenza pecca un po’ di presunzione e quindi viene associato più alla “superba” Versilia che alla “schietta” decadenza marinese. Per chi vive a Marina, il forte legame al territorio e alla sua storia spesso si trasforma in avversione al cambiamento. Anche in questo caso, probabilmente, la verità sta in mezzo…
La locandina ha il suo perché
NICO: Il personaggio ritratto nella locandina è Emiliano, il bombarolo della banda. La somiglianza con la maschera di Anonymous e chiara e voluta. Il riferimento è quello della ribellione al sistema.
La grafica cerca di ricordare lo stile in cui Sheppards Fairy, artista “di strada” contemporaneo, ritrae i suoi eroi: grafica presa dalla propaganda imperialista di un po’ tutte le fazioni politiche, ma utilizzata a supporto dell’esatto opposto: contro il “sistema” oppressore.
DATI TECNICI
Titolo: “La Banda”
Stagione 1 – Episodi: 7
Durata totale: 60 minuti circa
Anno: 2020
Produzione: associazione culturale Cantiere Nuovo
In collaborazione con Corte Tripoli Cinematografica
Regia: Luca Serasini
Montaggio: Nico Malvaldi
Musica: Francesco Bottai
Soggetto e sceneggiatura: Enrico Caroti Ghelli, Francesco Bottai, Nico Malvaldi e Luca Serasini
Riprese: Andrea Malvaldi, Luca Serasini, Nico Malvaldi
Fonia: Massimo Giannoni, Maurizio Bigongiali
Fotografo di scena: Marco Vaselli
Effetti speciali: Nico Malvaldi, Lorenzo Russo
Riprese Drone: Marco Paterni
Playlist youtube:
https://bit.ly/35HzX8T

Le foto della Serie Web sono di Marco Vaselli.
L’ANALISI CRITICA
di Marcello Cella
“La Banda”: ovvero come resistere alla globalizzazione divertendosi
Ci sono molti modi per raccontare le diseguaglianze di questo nostro mondo devastato sul piano umano e ambientale dalle pandemie e dalla dittatura economica neoliberista e la resistenza delle popolazioni locali ad un modo di concepire il mondo e le relazioni fra gli esseri viventi che non prevede eccezioni e non accetta diversità di vedute e di stili di vita. Il modo scelto dagli autori di questa web serie in sette puntate, girate lo scorso anno, è senz’altro originale e in qualche modo anche preveggente.
La storia è quella di una piccola comunità locale, quella di Marina di Pisa, litorale pisano con vista su Livorno, con le sue tradizioni, il suo modo di vivere, le sue abitudini, le sue idiosincrasie, le sue piccole manie, il suo quotidiano fatto di una frequentazione costante nel tempo di persone e luoghi che possono apparire obsoleti ad uno sguardo esterno, ma che invece costituiscono l’identità più profonda di una comunità, che improvvisamente si trova a dover subire le conseguenze materiali e immateriali di decisioni economiche assunte in luoghi lontanissimi da Marina e da persone sconosciute che minacciano di cambiare per sempre il paesaggio umano di quel luogo. Il porto di Marina, infatti, è stato acquistato da una società francese che pretende di imporre le sue logiche imprenditoriali e culturali, una sorta di “francesizzazione” di Marina che, a suo modo di vedere, dovrebbe trasformarsi nell’ennesimo resort per ricchi vacanzieri globalizzati con mega yacht al seguito. La perdita del posto di lavoro di uno dei protagonisti che rifiuta di piegarsi alla volontà dei nuovi arroganti padroni di “francesizzare” il menu del ristorante dove lavora funziona da detonatore per un microcosmo che non accetta di uniformarsi alle nuove regole e di scomparire in silenzio. E qui entra in campo “la banda”, ossia un gruppo di amici che si frequenta da sempre nei soliti bar e circoli di Marina e che decide di vendicare il torto subito dall’amico e di combattere a proprio modo questa ennesima prepotenza del potere finanziario globale e dei suoi feroci manutengoli globalizzati e locali, cioè costruendo una bomba artigianale che dovrebbe far saltare in aria lo yacht di colui che dirige a livello locale questa azienda. Ma “la banda” è solo un gruppo sgarrupato di vecchi amici non particolarmente acculturati (anche se il Bottai, quello licenziato dai francesi, a causa del trauma subito comincia ad esprimersi in linguaggio poetico), che si esprimono in vernacolo pisano, appassionati di calcio, donne e biliardo, non un gruppo politicizzato o di professionisti del terrorismo armato. La loro è una resistenza “di pancia” e le conseguenze del loro gesto saranno tragicomiche, con un finale (che non riveliamo) che lascia aperte molte porte narrative, molte riflessioni e molte interpretazioni.
Raccontata così, questa esilarante web serie costruita con 64 “non-attori”, in una sorta di work in progress narrativo sapientemente condotto dalla scrittura fine dei due autori in collaborazione con la penna di Enrico Caroti Ghelli e di Francesco Bottai, e che alterna momenti travolgenti di commedia all’italiana con sequenze di stampo più neorealistico e inserti grotteschi dalle risonanze ora oscure ora malinconiche (come la figura della “Maga” o il misterioso ciclista che pedala all’indietro per le strade di Marina e che attraversa l’intera narrazione senza mai rivelare la propria identità, ma a cui gli spettatori potranno dare le più diverse interpretazioni) potrebbe essere percepita come un serioso pamphlet contro la globalizzazione.
In realtà “La Banda” non è nulla di tutto questo e probabilmente il valore più “politico” di questa web serie sta più nel modo in cui è stata costruita che nella sua più o meno dichiarata posizione pro local e antiglobal. Infatti la serie in questione non è ascrivibile, dal punto di vista autoriale ai soli registi, montatori e sceneggiatori, ma appare come il prodotto artistico di una intera comunità che gli “autori” nominali (peraltro tutti nativi di Marina o di Pisa) hanno sapientemente coinvolto e lasciato esprimere fino quasi a scomparire. “La Banda” appare infatti come un’opera collettiva, dove un’intera comunità afferma con forza il valore non negoziabile e non monetizzabile della propria identità esistenziale e culturale pena la propria eutanasia. Ma, d’altro canto, non si tratta nemmeno di un’affermazione di localismo esasperato e chiuso, di “sovranismo culturale” e i riferimenti al mondo esterno e le riflessioni sui problemi della contemporaneità sono numerosi, come nella bella sequenza in cui i bambini, dopo una partita di calcio di strada senza distinzione di genere, si trovano a ragionare sull’immigrazione (la bambina che, parlando con un’amichetta, afferma convinta che “viaggiare insegna la tolleranza e, se tutti viaggiassimo, anche solo per un giorno, comprenderemmo meglio quella condizione”) o sull’economia (“il deficit del governo è l’attivo dell’economia”, afferma serioso un altro bambino al suo compagno di giochi, citando la Modern Monetary Theory – MMT, trattata da Stephanie Bell Kelton nel suo libro “The Deficit Myth” e sostenuta da molti esponenti politici americani di spicco come Bernie Sanders).
“La Banda” è quindi una web serie in cui alto e basso, comico e tragico si mescolano in modo intelligente in una storia densa di molte suggestioni sanguigne, ma anche grottesche e perfino malinconiche in alcuni momenti, rafforzate dal colorito vernacolo pisano di questa gente di mare, ma anche dalle musiche di Francesco Bottai (componente di un altro riuscito prodotto musicale “glocal”, il duo pisano de “I Gatti Mèzzi”), che rimandano alle pagine più belle di artisti come Tom Waits, Marc Ribot e Paolo Conte. Un modo leggero, ma mai banale di parlare delle paure, dei conflitti e delle incertezze del nostro tempo senza mai perdere il gusto del sorriso e magari anche del ponce fatto alla maniera dei vecchi abitanti di Marina di Pisa.
LA BANDA
Regia: Luca Serasini
Montaggio: Nico Malvaldi
Musica: Francesco Bottai
Soggetto e sceneggiatura: Enrico Caroti Ghelli, Francesco Bottai,
Nico Malvaldi e Luca Serasini
Riprese: Andrea Malvaldi, Luca Serasini, Nico Malvaldi
Fonia: Massimo Giannoni, Maurizio Bigongiali
Fotografo di scena: Marco Vaselli
Effetti speciali: Nico Malvaldi, Lorenzo Russo
Riprese Drone: Marco Paterni
Attori in ordine alfabetico:
Sandro Andreoni, Alice Andreoni, Carlo Alberto Arzelà, Roberto Ascione, Francesca Bacchiet, Susanna Baldacci, Michele Bertoni, Alessandro Bertozzi, Maurizio Bigongiali, Andrea Bottai, Gioele Bottai, Francesco Bottai, Andrea Borelli, Maria Brogna, Rachele Camporese, Andrea Capasso, Manola Carli, Pierangelo Cartone, Giada Catastini, Uliano Catastini, Alessandra Ceccherini, Maria Daniela Corso, Iolanda Fabris, Rossella Ferrari, Aldo Franco, Iara Gelsi, Felipe Gelsi, Emanuele Gelsi, Stefano Gelsi, Fabio Gelsi, Roberto Gemignani, Mariagrazia Di Giannatale, Edoardo Giari, Daniela Ghinassi, Claudia Guazzini, Luca GuelY, Sergio GuelY, Michele Hage, Roberta Leone, Stefano Liberati, Nico Malvaldi, Michela Manzi, Franca Masi, Walid Mokni, Carlo Musto, Andrea Nardi, Sabrina Natali, Maurizio Nerini, Emiliano Niccolai, Mara Novelli Ceccherini, Roberta Nuti, Gianfranco Perondi, Felice Pantone, Andrea Pieralli, Andrea Possenti, Vladut Prelucan, Fabio De Ranieri, Simona Rindi, Massimiliano Schiavelli (Ufo), Niccolò Schimizzi, Luca Serasini, Eleonora Simi, Silvia Talamucci, Elvira Todaro.
Produzione: Associazione Culturale “Cantiere Nuovo”, Corte Tripoli Cinematografica, Cineclub FEDIC di Pisa
Web:
La Banda:
Associazione Cantiere Nuovo
http://www.cantierenuovo.org/?fbclid=IwAR2FAG4j_ami-HAHI1XJ2hY3lhKJWXyuOtv7D2MHSVW_-VMeLjMn7OE24wM
https://www.facebook.com/cantiere.nuovo.9/about/?ref=page_internal
Corte Tripoli Cinematografica
http://www.cortetripoli.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=128
PANORAMA LIBRI
a cura di Paolo Micalizzi
FELLINI 23 ½. TUTTI I FILM
di Aldo Tassone
Edizioni Cineteca di Bologna 2020
Pagg. 871, Euro 29
Uno studio sistematico e approfondito sull’intera filmografia di Federico Fellini da parte di uno studioso come Aldo Tassone che anche in altre occasioni ha affrontato con grande serietà di storico del cinema altri Autori: vedi i suoi libri su Michelangelo Antonioni, Francois Truffaut, Akira Kurosawa, per esempio.
Un volume che raccoglie oltre quattro decenni di studi di ricerche, di incontri d’amicizia con il maestro e i suoi collaboratori. A partire dalla sua tesi di laurea sul regista riminese che gli valse, dopo averlo conosciuto tramite Ennio Flaiano, di essere ammesso da Fellini come ospite fisso sul Set, a partire dal “Satyricon” del 1969. Un libro, scritto su invito di Tullio Kezich al quale aveva proposto di farlo come complementare al suo volume edito nel 1987 da Camunia, che consente al lettore di immergersi nell’universo felliniano, film per film con ricche Schede che oltre al racconto del film da parte di Aldo Tassone comprendono le motivazioni che hanno indotto il regista a realizzarlo, l’accoglienza della critica italiana, francese e statunitense. Ma anche un’ampia Nota biografica completata dalla Filmografia che riguarda Soggetti, Sceneggiature e interpretazioni (in tutto, oltre 40) e le Regie.
Contiene anche un’intervista inedita di Dario Zanelli, anch’esso giornalista ammesso sui Set di Fellini, che l’aveva scritta negli anni Settanta per “Il Resto del Carlino”, e mai pubblicata, incentrata soprattutto su alcune considerazioni del regista sulla Mostra di Venezia. Ma anche il Capitolo “Fellini e gli altri” con testimonianze, raccolte nel tempo dall’autore del libro, di registi come Robert Altman, Theo Angelopoulos, Michelangelo Antonioni, Luisi Buñuel, Elia Kazan ed altri: in tutto una ventina.
Un’opera monumentale, dalla quale non si può prescindere nello studio di questo Grande Maestro del cinema mondiale.
Il volume è corredato da 40 fotografie significative dei Set e della vita di Federico Fellini.
IL VERO FELLINI. UNA VITA PER IL CINEMA
di Virgilio Fantuzzi
Ancora Editrice – La Civiltà Cattolica, 2020
Pagg. 182, Euro 20
Nell’arco di vent’anni padre Virgilio Fantuzzi ha pubblicato alcuni Saggi su Federico Fellini, soprattutto sulla Riviste dei Gesuiti “La civiltà cattolica” della cui redazione ha fatto parte dal 1973 fino alla morte avvenuta a Roma nel 2019. Frutto della visione e analisi dei film ma anche di diversi incontri con il regista sui Set dei suoi film per arrivare a raccontarci “L’ultimo film “ del regista riminese ripercorrendone la vita sin dal momento in cui fu colpito a Rimini dall’ictus mentre si trovava, nel pomeriggio del 3 agosto 1993, in una stanza del Grand Hotel , per arrivare al suo funerale nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli, dove il cardinale Silvestrini nell’omelia ricorda le parole “Nulla si sa; tutto si immagina” pronunciate da un personaggio del film “La voce della luna”. Un libro diviso in 9 capitoli che, oltre a quello citato, comprende “Viaggio alla ricerca di se stesso”, le “cinque notti sul set del Casanova” con la “Controlettura” di quel film, “E la nave va”, “Ginger e Fred”, “Intervista”, “Sul set de “La voce della luna” e “Fellini a Villa Malta”, cioè un incontro di padre Virgilio Fantuzzi nella sede della Rivista ”La Civiltà Cattolica” dove , nel flusso dei ricordi, il regista ha parlato dei suoi inizi al “Marc’Aurelio”, di Roberto Rossellini e la sua collaborazione al film “Roma città aperta” e “Paisà”, della conoscenza di Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Jean Renoir, Pier Paolo Pasolini e di altre situazioni che arricchiscono la conoscenza del cinema da parte del lettore del libro. Che affronta film e vita di Federico Fellini, in un viaggio avvincente alla scoperta della sua poetica e della sua personalità, dal punto di vista di un cattolico molto attento al cinema.
LE MUSE AL CINEMA
di Gian Piero Brunetta
Algra Editore, 2020
Euro 19, pagg 318
Un altro libro dell’emerito storico del cinema Gian Piero Brunetta in cui “Mito, scienza, memoria, presenze e metamorfosi del pensiero classico e delle sue forme nell’iconosfera mediatica novecentesca, influenza delle muse sul cinema” sono, come avverte lo stesso autore nell’introduzione, “i motivi guida, i fili soggiacenti che uniscono i saggi di questo volume scritti dalla fine degli anni Sessanta ad oggi”. In ciò spinto dai suoi interessi per i rapporti cinema e letteratura che più volte avrebbe voluto affrontare analizzando la “confluenza, traduzione, ricambio e metamorfizzazione della letteratura del mondo classico sullo schermo”. Analizzare in che modo autori come Omero, Lucrezio, Virgilio, Seneca ed altri del mondo greco e latino siano rivissuti sullo schermo nelle forme più diverse. Nascono da questi intenti una serie di Saggi in cui analizza anche” Il western, la forma più popolare dell’epica contemporanea”, “Il cinema e le arti dal futurismo al neorealismo”, “Ritmi spaziali sul cinema tra avanguardia e entertainment”, “Pasolini: periodicità del mito e evoluzione della forma” e “Itinerario di Pasolini verso il mito di Edipo”. Vi figura anche un saggio inedito su “I robot nel cinema”.
Scritti molto approfonditi di uno storico che s’immerge (e ci immerge) nelle tematiche che affronta da studioso che attinge anche all’esistente confrontandosi criticamente.
Sul suo valore, ed il suo livello, di studioso ne è testimone la qualificata (anche se descritta in sintesi) biografia, che si può leggere in quarta di copertina, che gli è valsa nel 2017 il Premio Feltrinelli per la Storia del cinema dall’Accademia dei Lincei.
IL MIO CINEMA
di Claudio G. Fava
Edizioni Falsopiano, 2019
Euro 20, pagg. 319
E’ il primo del volume di recensioni di Claudio G. Fava che per più di vent’anni è stato critico cinematografico del quotidiano “Corriere mercantile” di Genova. Sono recensioni che vanno da Robert Aldrich (di cui recensisce “Che fine ha fatto Baby Jane”, “Quella sporca dozzina” e “Un gioco estremamente pericoloso”) a Stanley Kubrick analizzato nei suoi “Lolita” e “Arancia meccanica”. Passando per Autori italiani come Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci, Vittorio De Sica, Federico Fellini, Marco Ferreri ed altri e registi internazionali come, tanto per citarne alcuni, Woody Allen, Robert Altman, Ingmar Bergman, Robert Bresson, Luis Buñuel, John Cassavetes, Charlie Chaplin, Jean- Luc Godard, Alfred Hitchcock fino ad arrivare, in questo volume, a Stanley Kubrick. Interessante leggere anche i “dizionarietti” dedicati a registi come Vittorio de Sica ed Alfred Hitchcock.
Un libro che rende merito ad un critico (che mi onoro di aver conosciuto vivendo momenti cinematografici importanti in molti Festival avendo così modo di apprezzarne l’arguta sensibilità di valutazione) le cui recensioni i genovesi attendevano quotidianamente di leggere sul “Corriere mercantile” e coloro che non abitavano in Liguria su “La Rivista del Cinematografo”, soprattutto, ma anche su “Vita e pensiero” ed altri periodici di area cristiana. Il percorso critico di Claudio G. Fava viene tracciato da Nuccio Lodato che ne ricorda la sua attività sui giornali, al CUC ed alla Rai e ne confronta la sua linea critica con quella di altri illustri colleghi.
Un critico, Claudio G. Fava, che così viene “fotografato” dal collega Natalino Bruzzone de “Il Secolo XIX”, come ricorda Nuccio Lodato, il giorno successivo alla sua morte: “Ha vissuto di film e di libri, di passione per tutto quanto fa cultura, anche la più eccentrica, di devozione per la parola nel racconto e nella scrittura, di abnegazione d’altri tempi per il lavoro alla Rai, di sincera bontà d’animo, di squisita gentilezza per il prossimo e di amore per la compagna di sempre”.
LUIGI ZAMPA
a cura di Orio Caldiron e Paolo Speranza
Edizioni CinemaSud
Euro 12.00, pagg.183
Un numero dei Quaderni di CinemaSud dedicato al regista Luigi Zampa. Un volume su Zampa, questo a cura di Caldiron e Speranza, che si articola in 12 Interventi critici che ne percorrono la sua filmografia. Interventi di studiosi come Giovanni Memola, Vito Attolini, Anton Giulio Mancino, Marcello Marmo, Raffaele De Berti, Ennio Bispuri, Mario Gerosa, Luca Pallanch, Franco Grattarola e Domenico Monetti.
Continuando con un’intervista a Paolo Bianchini che fra il 1953 e il 1966 ha lavorato dapprima come assistente e poi come aiuto regista in quattordici film di Zampa, prima di passare lui stesso alla regia nel 1997, dopo aver realizzato circa duemila spot pubblicitari, con “La grande quercia”. Un’intervista che ripercorre, con le tante vicissitudini vissute, il lavoro sui set del regista romano arrivando a quando egli non riuscì più ad avere una regia e si mise a scrivere: “Il primo giro di manovella” è uno di questi. Viene anche pubblicata l’ultima intervista di Luigi Zampa, dove il regista ricorda il suo rapporto con Alessandro Blasetti al CSC, l’atmosfera del Meridione nei suoi film, della sua preferenza per gli ambienti veri “perché significa anche trovare la vita. Andare a visitare i posti dove girare significa anche trovare idee”. Ma parla anche del rapporto con gli attori e del suo disinteresse di andare a Hollywood, e anche del suo rapporto con la censura con cui ha dovuto fare i conti tagliando certe battute o immagini per assecondare il produttore. Concludendo con la sua attenzione a umiliati e offesi, “persone, come sottolinea la domanda, semplici che lottano contro i furbi” che lui considerava “la gente più vera, più sana. La gente che si alza la mattina e va a lavorare è l’umanità più ricca che ci sia”. Nel libro, oltre a filmografia e bibliografia ed immagini di alcuni suoi film (locandine e copertine di riviste), la pubblicazione del progetto “Notizie sensazionali, liberamente ispirato alla vita di Matilde Serao e Edoardo Scarfoglio “non andato in porto perché la censura crea l’autocensura”, riferendosi ai produttori. Ed altri interessanti documenti per meglio conoscere un regista che è stato un buon osservatore della società italiana denunciandone anche vizi e malcostume.
PENSARE MONDI TRA REALTA’ E IMMAGINAZIONE, VIAGGI LETTERARI IN ITALIA E NELLE CULTURE DEL MEDITERRANEO
di Rita Castaldi
a cura di Maurizio Villani
Diogene Multimedia – Bologna
Pagg. 298, Euro 26
Un volume in nove capitoli in cui è pubblicata anche una testimonianza dello scrittore Antonio Debenedetti conosciuto da Rita Castaldi in occasione di due “incontri letterari” da lei organizzati, insieme ad Antonietta Molinari, al Liceo Classico “Ariosto” di Ferrara, dove insegnava. Una testimonianza in cui lo scrittore – giornalista ricorda, Rita Castaldi analizzare in modo compenetrato il rapporto indissolubile tra Bassani e la sua città, Ferrara. E come in lei convivevano la passione per l’insegnamento e l’amore per la letteratura, che viveva ed amava perché per Rita la letteratura era vita e questo faceva di lei un’insegnante esemplare. Un volume, curato dal marito Maurizio Villani in ricordo della moglie scomparsa, che raccoglie la maggior parte degli scritti pubblicati nel corso degli anni che vanno dal 2010 al 2015, e contiene studi di storia e letteratura ma anche di cinema, alcuni dei quali sono stati ospitati su questa Rivista della quale è stata apprezzata collaboratrice. Quello relativo al cinema è l’ultimo capitolo (il nono). Rita Castaldi vi pubblica alcuni Saggi relativi a “Letteratura e Cinema”: Giorgio Bassani, Mario Soldati, ma anche Carlo Emilio Gadda che già nel 1926 aveva iniziato a collaborare con la Rivista “Solaria” e che dal cinema vide la trasposizione del suo romanzo “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana con “Un maledetto imbroglio” (1959) di Pietro Germi. Rita Castaldi non poteva poi non essere interessata alla trasposizione cinematografica di “Il giovane favoloso” riferito a Giacomo Leopardi. Ma anche ad un Autore illustre come l’Ariosto che a lei sovviene dalla visione del film “Cabret” di Martin Scorsese. Ed, infine, il suo interesse verso Alberto Moravia che tratta in una conversazione, proprio con Antonio Debenedetti, e verso lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia, inducendo così il lettore ad una rilettura degli Autori da lei rivisitati con senso d’amore e di analisi critica.
CREDITS
Carte di Cinema 23
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 23 della rivista online: Danilo Amione, Roberto Baldassarre, Vittorio Boarini, Gianluca Castellini, Marcello Cella, Marino Demata, Mario Galeotti, Mario Giunco, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Roberto Merlino, Paolo Micalizzi, Alessandra Pighi, Giorgio Sabbatini, Luca Serasini e Nico Malvaldi, Paolo Vecchi, Xoxan Villanueva, Luciano Volpi, Marco Incerti Zambelli.