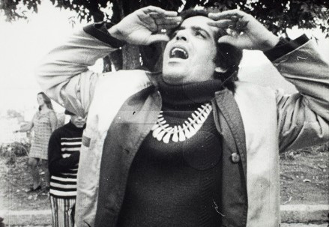Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 3.1 LIGHT OF DORIS DAYdi Francesco Saverio Marzaduri
- 3.2 “VERTIGO” E LE EBREZZE CINEFILE A SEGUIRE di Roberto Baldassarre
- 3.3 “MRS DOUBTFIRE”, IL FILM DI CHRIS COLUMBUS, DIVENTA UN MUSICAL DI BROADWAY di Roberto Lasagna
- 3.4 UN CINEMA PROFETICO NEL TEMPO DELLA PANDEMIA di Maurizio Villani
- 3.5 MARIO MEROLA E LA CINE-SCENEGGIATA di Mario Galeotti
- 4 MAKE UP
- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 6 FESTIVAL ED EVENTI
- 6.1 IL TFF CONTINUA AD ESSERE UN VALIDO PUNTO DI RIFERIMENTO CINEFILOdi Paolo Micalizzi
- 6.2 CORTINAMETRAGGIO, PRIMO FESTIVAL ONLINE IN TEMPO DI CORONAVIRUSdi Paolo Micalizzi
- 6.3 RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2019di Maria Pia Cinelli
- 6.4 APPUNTI DI UN CINEFILO FEDICLA FESTA DEL CINEMA A ROMA….È PROPRIO UNA FESTAdi Luciano Volpi
- 6.5 FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO DI VERONAdi Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
- 7 OCCHIO CRITICO
- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 9 PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
- 10 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
IL NUOVO CINEMA BRASILIANO di Vittorio BoariniI
Il Cinema novo spinge il Brasile nella prima linea della neoavanguardia cinematografica mondiale, accanto all’Underground americano e a Godard.
RICHARD JEWELL, (ANTI)EROE DEI NOSTRI TEMPI di Francesco Saverio Marzaduri
Nell’ultima dolente ballata di un eroe (non) per caso, Clint Eastwood moltiplica i suoi schermi per rappresentare un’epoca in cui lo “storytelling” conta più della verità.
SAGGI
LIGHT OF DORIS DAY di Francesco Saverio Marzaduri
Una breve disamina filmografica della compianta Doris Day: simbolo rassicurante dell’“American Way of Life”, innocua e consolante fidanzatina d’America a basso tasso di sensualità, protagonista d’una lunga serie di amabili commedie e utilizzata anche nel genere thrilling.
“VERTIGO” E LE EBREZZE CINEFILE A SEGUIRE di Roberto Baldassarre
“Vertigo”, pellicola quasi snobbata alla sua uscita, con il passare delle decadi ha acquisito prestigio nella storia del cinema. In questa immaginifica vertigine cinematografica creata da Alfred Hitchcock, molti autori a seguire vi ci si sono immersi per creare le proprie ossessioni non solo cinefile.
MRS DOUBTFIRE, IL FILM DI CHRIS COLUMBUS, DIVENTA UN MUSICAL DI BROADWAY di Roberto Lasagna
Torna a teatro la storia di Daniel Hillard, la cui trasformazione in Tata tuttofare è un monito di incoraggiamento ai figli di genitori divorziati, che possono trovarvi un senso ad alcune delle loro domande: quelle che solitamente si rivolgono coloro che sono vissuti in famiglie allargate e in nuovi matrimoni.
UN CINEMA PROFETICO NEL TEMPO DELLA PANDEMIA di Maurizio Villani
Una riflessione tra cinema e filosofia nell’età della pandemia attraverso l’interpretazione del film “Melancholia” di Lars von Trier. Sono messi a tema il valore dell’arte, poetica e cinematografica, la sua capacità di indagare il senso che possono avere le esperienze drammatiche della sofferenza e della morte e la riscoperta dei principi etici della responsabilità e dello “stare insieme”.
MARIO MEROLA E LA CINE-SCENEGGIATA di Mario Galeotti
Scomparso nel novembre del 2006 all’età di settantadue anni, Merola è stato uno dei maggiori interpreti della canzone napoletana, attore di film in una breve ma intensissima stagione cinematografica concentrata tra il 1978 e il 1984, e soprattutto conclamato re della sceneggiata, un genere teatrale popolare che appartiene alla storia di Napoli e che Merola contribuì a riportare in auge a partire dalla metà degli anni Sessanta.
Nella sua filmografia, accanto a storie di guappi romantici e lotte di camorra, troviamo anche vere e proprie cine-sceneggiate, ovvero le trasposizioni per il grande schermo di alcuni dei cavalli di battaglia che Merola aveva replicato lungamente a teatro.
MAKE UP
CRAXI E CRAXI – Breve nota sul trucco di Pierfrancesco Favino in “Hammamet” di Tullio Masoni
La maschera di Andrea Leanza: Favino identico a Craxi, Craxi identico a Favino.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
DOPO LA SCOMPARSA, RICORDI E TESTIMONIANZE SU MASSIMO MAISETTI di Paolo Micalizzi
FEDIC SCUOLA FILM FESTIVAL A CARRARA di Laura Biggi
Cerimonia di premiazione con i titoli dei film vincitori e le relative motivazioni.
UN NUOVO NOTIZIARIO FEDIC: FEDIC MAGAZINE di Giuseppe Mallozzi
Caratteristiche di un Nuovo Notiziario volto a informare sulla vitalità della Fedic.
FESTIVAL ED EVENTI
IL TFF CONTINUA AD ESSERE UN VALIDO PUNTO DI RIFERIMENTO CINEFILO
di Paolo Micalizzi
I film vincitori della 37^ edizione del Torino Film Festival, l’Omaggio a Mario Soldati e l’ampia Retrospettiva dedicata all’Horror con la presenza di Barbara Steele.
CORTINAMETRAGGIO, PRIMO FESTIVAL ONLINE IN TEMPO DI CORONAVIRUS di Paolo Micalizzi
Un Festival che, per primo, non si è arreso alla pandemia, inaugurando, ed indicando, lo svolgimento Online. I Premi.
RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2019 di Maria Pia Cinelli
“River to River”, il festival che ogni anno porta i colori e i suoni dell’India dalle rive del Gange a quelle dell’Arno, è tornato con un’edizione in buona parte dedicata al mondo femminile.
APPUNTI DI UN CINEFILO. LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA di Luciano Volpi
Considerazioni sulla quattordicesima edizione dell’importante manifestazione di Roma.
FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO DI VERONA di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
Resoconto sulla 39^ edizione con l’elenco dei vincitori e notizie sulle Opere premiate.
OCCHIO CRITICO
STORIE VERE di Marco Incerti Zambelli
Due registi di grande spessore come Terrence Malick e Todd Haynes si ritrovano a confrontarsi con la messa in scena di due storie vere e, pur con approcci e risultati diversi, confermano la straordinaria vitalità del loro talento.
AFFARI DI FAMIGLIA: “STORIA DI UN MATRIMONIO” E “PARASITE” di Francesco Saverio Marzaduri
Giunto alla dodicesima fatica, il cronista di fallimenti Noah Baumbach dirige un racconto incisivo ed empatico, tra verità e finzioni, sulla fine e la possibile rinascita d’un rapporto coniugale.
Conquistando Cannes per la prima volta, il sudcoreano Bong Joon-ho confeziona invece un apologo sull’indigenza e le efferatezze che questa spinge a compiere, ma pure una radiografia di matrice hegeliana sul conflitto di classe; la condizione economico-familiare di quattro poveracci funge da spunto per la nitida lastra d’un Paese desideroso di progredire, fermo in verità all’obsoleto paradigma secondo cui l’“upper class” esiste, e prospera, sulla pellaccia (e l’odore) dei meno abbienti.
“POWIDOKI / IL RITRATTO NEGATO” DI ANDRZEJ WAJDA di Tullio Masoni
Ultimo film di un maestro del cinema che, sul comune sfondo storico polacco, si confronta col celebre pittore di avanguardia Strzeminski e coi caratteri stilistici fondativi della propria opera.
BONG JOON-HO A REBOURS: “MEMORIE DI UN ASSASSINO”.di Paolo Vecchi
Tra il 1986 e il 1991, nella provincia di Gyunggi, non lontano da Seoul, dieci giovani donne furono violentate e uccise. “Memorie di un assassino” racconta le indagini condotte da un poliziotto del luogo assistito da un
collega venuto dalla capitale. Lo squallore in cui si muovono i personaggi rimanda a un avvertibile sottotesto di continui riferimenti alla situazione politica della Corea del 1983, schiacciata sotto una ferrea dittatura.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
NON SOGNARE: FALLO! STORIE DI PUNK ROCK ITALIANO. QUATTRO DOCUMENTARI (E UN LIBRO) di Marcelo Cella
Alcuni documentari più o meno recenti e un libro di Marco Philopat “Lumi di punk” fanno luce su uno dei fenomeni controculturali più controversi e dimenticati degli ultimi decenni: il punk rock italiano.
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
Segnalazione-recensione di Libri di Marco Giusti, Paolo Protti, Lino Capolicchio, Roberto Pugliese, Paola Dei.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
IL NUOVO CINEMA BRASILIANO
di Vittorio Boarini
1. La nascita e l’affermarsi del Cinema novo
Negli anni sessanta, ma spesso il fenomeno si manifesta già nel decennio precedente, si assiste a un generale, cioè diffuso in tutto il mondo, rinnovamento del cinema, cioè al tentativo di superare o, addirittura, di destrutturare radicalmente il linguaggio cinematografico consolidatosi fino a quel momento.
Nell’Europa, occidentale e orientale, così come nelle Americhe, nasce la neoavanguardia, ovviamente con modalità differenti e con denominazioni significativamente specifiche; per l’URSS, ad esempio, si userà il termine dissenso, ma normalmente le tendenze innovative andranno sotto la categoria di Nuovo Cinema, (Nouvelle Vague, Novi vilna, New American Cinema e, per quanto riguarda il Brasile, Cinema novo).

Si parlerà anche, a questo proposito, di rivisitazione delle avanguardie storiche, terminologia corretta, a mio avviso, anche se le avanguardie storiche sono un fenomeno del tutto europeo, ma, oltre a notare la loro massiccia emigrazione negli Stati Uniti, esse hanno avuto per varie vie un impatto significativo con un’ampia parte della cultura mondiale. Sottolineato che il rinnovamento artistico-letterario degli anni cinquanta e sessanta, nell’ambito del quale si sviluppa il Nuovo Cinema, pur marcando rispetto alle avanguardie storiche alcune profonde differenze, ha in comune con esse, al di là della negazione del passato e della critica alla mercificazione, il fatto di investire in un’ottica transartistica, non solo il cinema, ma tutti gli aspetti separati disciplinarmente della cultura: arti figurative, musica, teatro, e perfino la scienza. A proposito del cinema, vorrei insistere, tornando su quanto ho già cercato di mettere in evidenza, prendendo spunto dalla retrospettiva Orizzonti 1960-1978, proposta dalla 68° Mostra di Venezia, sul fatto, da molti negato, che anche in Italia si è manifestato, sia pure più timidamente che altrove, un Nuovo cinema di qualche rilievo (si veda I fuochi e la cenere: la neoavangurdia cinematografica italiana, in “Cinecritica” n.64, ottobre-dicembre 2011).
Tutto ciò per chiarire che le specificità del Cinema novo sono definibili solo a partire dalla sua appartenenza a un contesto internazionale di critica radicale allo stato di cose esistente; alla cultura tradizionale, ma anche agli assetti politici e sociali consolidati, nonché agli equilibri mondiali ancora incardinati negli accordi di Yalta del 1945.
Siamo all’inizio del decennio che si concluderà con la rivolta giovanile del sessantotto, con epicentro in Francia, un paese appena uscito dalla tragedia colonialista della guerra algerina; che vedrà la terribile guerra del Vietnam, contro la quale i giovani americani anticiperanno il sessantotto a Berckeley, mentre si afferma in tutto il paese la cultura beat.
Il binomio avanguardia – rivoluzione mantiene tutto il suo fascino e l’idea di poter sovvertire l’ordine sociale riprende vigore e assume forme inedite. L’ideologia terzomondista guadagna consensi anche in Europa, nel senso del focolaio guerrigliero, teorizzato da Che Guevara, o, come chiarirà la rivoluzione culturale cinese, in quello delle campagne che accerchiano le città (Lin Piao).
In questo quadro assumono particolare significato le affermazioni di Glauber Rocha, il più rappresentativo esponente, assieme a Ruy Guerra, del Cinema novo, rilasciate assieme a Carlos Diegues, un altro regista autorevole teorico del movimento, che suonano: “la macchina da presa si apre sulla fame, sul sottosviluppo e sulla rivoluzione”. Questa dichiarazione è sicuramente coerente con le tradizioni culturali del popolo brasiliano, con i suoi riti arcaici, con la sua religiosità pagana e mistica, con la sua storia di colonizzazione, ma riguarda molti altri paesi, forse tutti, dell’America latina e non solo, basti pensare ai paesi ex coloniali africani e asiatici. Inoltre , trova eco anche nella vecchia Europa, dove si diffonde la convinzione che il nuovo in senso rivoluzionario può venire solo dal terzo mondo, al quale, come sostengono gli intellettuali più avvertiti, l’occidente è legato in quanto responsabile del suo sottosviluppo e dell’ancora imperante neo colonialismo.

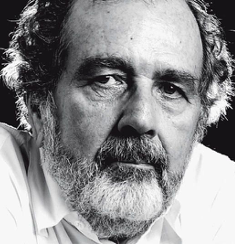
A questo proposito credo opportuno citare André Gunder Frank e la sua teoria del sottosviluppo prodotto dallo sviluppo e funzionale a questo. I paesi colonialisti, oltre a depredare le colonie delle loro materie prime, ne distruggono l’assetto economico – sociale senza sostituirlo con null’altro che una rigida dipendenza dalla matrigna patria, rendendo così strutturale e irreversibile un rapporto inversamente proporzionale fra evoluzione del colonizzatore e depressione del colonizzato (si veda Capitalismo e Sottosviluppi in America Latina, Einaudi, 1969). Anche Franz Fanon e il suo I dannati della terra (un vero e proprio manifesto per la lotta al colonialismo, pubblicato per la prima volta nel 1961 da Maspero con una introduzione di J.P.Sartre) debbono essere ricordati perché hanno profondamente influenzato la cultura degli anni in cui le nuove avanguardie prendono slancio e vigore, ricordati in particolare, com’è ovvio, per le tendenze avanguardistiche dei paesi terzi. Ma veniamo finalmente al Cinema novo prendendo spunto, perché si tratta di un buon osservatorio, proprio dall’Italia, dove, all’inizio degli anni sessanta, nonostante si fosse tenuta a Santa Margherita Ligure una grande rassegna di cinema latino-americano, promossa da padre Arpa, un gesuita indistruttibile, allora direttore del Columbianum di Genova, e realizzata da Gianni Amico, un regista che ancora compiangiamo, si conosceva generalmente del cinema brasiliano soltanto “O Cangaçeiro”, di Lima Barreto, presentato nel 1953 alla Berlinale e al Festival di Cannes, dove aveva vinto un premio per il miglior film d’avventura e avuto una citazione speciale per la colonna sonora. Alcuni, i più informati, conoscevano anche “O pagador de promessas”, di Anselmo Duarte, vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 1962, ma meno fortunato al botteghino del precedente. Ho voluto citare queste due opere anche perché alcuni critici li considerano degli antecedenti del Cinema novo, ma i registi di questa tendenza, Rocha in particolare, li relegano nella cinematografia alla quale è necessario dare un taglio netto. In questa negazione del passato c’è qualche analogia con la Nouvelle vague e il suo rifiuto del “cinéma de papa”; non solo, ma come la Nouvelle Vague salva solo due registi di tutto il cinema francese (Renoir e Bresson), il Nuovo cinema brasiliano salva anch’esso due registi e precisamente Humberto Mauro e Nelson Pereira Dos Santos. Quest’ultimo in realtà è da molti considerato il padre del Cinema novo, avendo realizzato già nel 1955 “Rio, 40 graus” (t.l. “Rio, 40 gradi”), un riferimento assai importante in cui è riconoscibile l’influenza del neorealismo, ma a me sembra più corretto, soprattutto per il suo “Vidas Secas” , girato nel Sertao nel 1963, inserirlo nella compagine del Nuovo cinema, dalla quale si allontanerà dopo il colpo di stato militare del 1964, quando fu costretto dalla dittatura a ripararsi dietro un linguaggio metaforico.
In quanto a Mauro, del quale la Mostra veneziana del 2018 ci ha mostrato, nel bel documentario del nipote, André di Mauro, un interessantissimo profilo della sua vita e della sua opera (“Humberto Mauro”, distribuzione internazionale Lença filmes), è da valutarsi come il grande pioniere del cinema latino americano in generale, anche se Rocha lo ritiene “il fondatore dello stile cinematografico brasiliano e il grande precursore del Cinema nuovo”.
Ma torniamo all’Italia e precisamente all’anno 1962; mentre a Santa Margherita Ligure la Fondazione Columbianum, sempre Angelo Arpa e Gianni Amico, realizza un’ampia rassegna del cinema argentino, la Mostra internazionale del cinema libero presenta a Porretta in concorso il primo lungometraggio di Rocha, “Barravento”, finito appena di montare, grazie anche alla collaborazione, casuale e generosa, di Pereira Dos Santos, dopo una vicenda produttiva molto tormentata iniziata nel 1961.
Capimmo subito che si trattava di un film eccezionale, parlo per me e per alcuni amici presenti alla proiezione, ma, fuorviati dalle analogie, indubbiamente presenti, con La terra trema di Visconti, anche qui infatti si tratta del dramma che si svolge in un villaggio di poveri pescatori alle prese con una natura ostile (“Barravento” significa tempesta senza scampo) e, soprattutto, con lo sfruttamento inumano, protetto dalle autorità, dei mercanti di pesce, sopravvalutammo l’influenza del neorealismo e ci sfuggì la profonda novità stilistica e tematica che sarà poi la cifra del Cinema novo. Il film usa, infatti, un linguaggio assolutamente innovativo e funzionale a una vicenda che svela la realtà di una condizione disumana, la quale non ha possibilità di riscatto se non con la violenza rivoluzionaria. Estremamente significativo il personaggio di Firmin, tornato fra i pescatori di Bahia dopo una lunga assenza, che incita i pescatori stessi alla ribellione senza quartiere e senza esclusione di colpi, come lui stesso, una sorta di equivalente di quello che sarà il Cangaçeiro del Sertao, fà, arrivando fino a tagliare le reti ai pescatori per bruciare alle loro spalle ogni altra possibilità se non la lotta. Ma i pescatori come, e lo vedremo, gli abitanti del nordeste sono schiavi anche di credenze arcaiche e di superstizioni paralizzanti. Il seguito è al successivo film di Rocha, ma, prima di esaminarlo dobbiamo svolgere un’altra considerazione sulla seconda mostra di Porretta, che era biennale. Assieme al film di Rocha erano in concorso, fra gli altri, quelli di P.Truffaut, “Jules et Jim” (1961); di J. Mekas, “I fucili degli alberi2 (“The Guns of theTrees”, 1961), che vinse il primo premio; di L. Anderson, “March to Aldermaston” (1958). Una buona rappresentanza della neoavanguardia europea e statunitense, nella quale era stata giustamente inserita la prima opera di quello che sarà il Cinema novo, una tendenza che non solo sta alla pari delle europee Nouvelle Vague e Free Cinema, ma gareggia per radicalità innovativa e forza critica con l’underground americano. Questo avevamo potuto intuirlo assistendo alla grande rassegna del cinema brasiliano che, spostatisi a Sestri Levante, i nostri amici e referenti culturali del Columbianum ci avevano offerto, intuizione definitivamente confermata con la successiva manifestazione, a Genova nel 1965, dedicata proprio al Nuovo cinema brasiliano. Intanto però, anche noi, legati al festival di Porretta, avevamo colto il senso profondo della eccezionale novità venuta dal Brasile quando, nel 1964, la Mostra del cinema libero presentò in concorso, oltre al capolavoro di Rocha Il “Dio nero e il diavolo biondo” (“Deus e o diablo na terra do sol”, 1964); “Ganga Zumba”, di Carlos Diegues, dello stesso anno, e “Vidas Secas” , di Nelson Pereira Dos Santos (1963).
Tre opere imprescindibili del Cinema novo, che finalmente si mostrava per quello che era, la sezione brasiliana dell’internazionale avanguardistica, giudizio confermato anche dal confronto con il Free Cinema (in concorso, come gli altri che seguono, c’era anche “Gioventù amore e rabbia”, di Tony Richardson); con la Novi vilna cecoslovacca (“Qualcosa d’altro”, traduzione letterale di “Nĕcĕm Jiném”, 1963, di Vera Chytilova); con il nuovo cinema ungherese, rappresentato da “Sciogliere e legare” (t.l. di “Oldás és Kötes”, 1962), di M. Jancsó, il più autorevole rappresentante di questa tendenza; e con la prima retrospettiva italiana, se ricordo bene, della Nouvelle Vague. Infatti Porretta, nata nel 1960 come anti-Venezia, si era ormai caratterizzata quale festival, unico in Italia, d’avanguardia, sul modello di quello di Knokke le Zoute, voluto e realizzato dal direttore della Cineteca reale belga. Non casualmente, sempre in quell’anno, venne presentata dalla Mostra un’assai rappresentativa, e per molti inaspettata, rassegna del cinema underground americano (di cui alcuni film erano stati presentati al Festival dei due mondi senza tuttavia avere goduto di molta attenzione da parte dei critici cinematografici).
A proposito del, ricordo che i due teorici del Cinema novo, citati più sopra, chiariscono meglio la loro posizione affermando che “Si tratta, se si vuole, di una posizione neo-romantica, ma anche molto didattica. Quel che sottolinea bene Guevara è che la guerriglia non è un’avventura romantica, ma un’epopea didattica… è un marxismo spogliato di tutto lo spirito Vaticano del cremlino.” È’ anche su queste premesse infatti che Rocha, al quinto incontro di Genova dedicato al cinema latino-americano, nel 1965, allargato al terzo mondo, formulerà Una estetica della fame (in Lino Micciché, Glauber Rocha: scritti sul cinema, La Biennale di Venezia, 1986 ed anche, sotto il titolo L’estetica della violenza, in “Cinema sessanta”, n.51, 1965). Queste enunciazioni si colgono nel “Dio nero e diavolo biondo” in una ispirazione che concilia lo straniamento critico di Brecht con la crudeltà di Artaud dando vita a una narrazione, ambientata nel Sertao, ritmata su una ballata popolare cantata da un aedo cieco, che si accorda perfettamente non con il neorealismo, ma con il realismo ideologico di S.M. Ėjzenštejn (la fuga del vaccaro Manuel con la moglie nel Sertao) e con il naturalismo mistico e delirante delle folle miserabili che seguono il profeta nero, il Beato Sebastiano. Ecco, allora, l’incontro di Manuel con il Dio nero, al quale, alla fine di un lungo travaglio, finirà per non credere più orientandosi verso una soluzione anarchica proposta dal Cangaçeiro Corisco, il Diavolo biondo, figura emblematica di ultimo dei ribelli fuori legge. Ma anche questa soluzione non è praticabile per l’arrivo di “Antonio das mortes“, cacciatore di Cangaçeiros e di Beatos per conto dei proprietari terrieri e della chiesa, che uccide, alla fine di una sequenza drammaticamente shakespeariana, Corisco.
L’ambigua figura di Antonio si chiarirà in un successivo film, che in Italia verrà col titolo ““Antonio das mortes“ (“O dragão da maldade contra o santo guerreiro”, 1969), dove Antonio rivolgerà le sue infallibili pistole contro i padroni suoi mandanti. Intanto, alla conclusione della ballata con questi versi: “Un mondo mal diviso/ non può dare niente di buono,/ poiché la terra è dell’uomo,/non di Dio, non del demonio,” Antonio das mortes dice al cantastorie, quasi a premessa del film futuro, che la rivoluzione certamente avverrà e non sarà opera né del Dio nero né del diavolo biondo, da lui uccisi. Scrive Pietro Bonfiglioli, in un piccolo mirabile saggio sul film, scritto nel 1969, “ Questo convulso impasto di gonfiezza barocca e folklorica, di imprecisione barbarica e di lucide sintesi improvvise, questo gusto greve delle sovrapposizioni simboliche e metaforiche, questa commistione dirompente di materiali culturali eterogenei si distende con pacatezza rapsodica nella storia del Vaccaro Manuel” (P. Bonfiglioli, Scritti per l’arte e per il cinema, a cura di Vittorio Boarini, Edizioni Cineteca di Bologna, 2016).
Manuel, infatti, come abbiamo visto, ha rifiutato la soluzione individuale che lo aveva spinto a uccidere il suo padrone e fuggire nel deserto; ha rifiutato, dopo molti tormenti, la soluzione mistica dei Beatos e, infine, rifiuta anche la soluzione anarchico-nichilista dei Cangaçeiros, per correre verso il mare, simbolo di potenza e di libertà.
Sono passati cinquantasei anni e il film resta un’opera eccezionale per l’immutata forza incongrua e caotica, che rompe con tutti gli schemi linguistici del cinema che lo precede. Il miglior commento critico su quest’opera, come afferma Bonfiglioli, è dato dalle parole dello stesso Rocha: “Tecnicamente imperfetto, drammaticamente dissonante, poeticamente ribelle, sociologicamente impreciso… aggressivo e insicuro politicamente, come le stesse avanguardie politiche del Brasile, violento e triste, anzi più triste che violento come il nostro carnevale”.
2. Il Cinema novo diviene patrimonio dell’umanità
Anche gli altri due film brasiliani presentati assieme all’opera maestra di Rocha, che vinse quell’anno il premio per il miglior film, sono di notevole importanza per la comprensione del Cinema novo. Ovviamente “Vidas Secas” (“Vite aride”), per girare il quale Pereira Dos Santos aveva scoperto per primo la drammatica poesia del Sertao, l’invivibile deserto del nordeste, dove, ha scritto un intellettuale brasiliano, noto anche in Italia, lo stesso Dio, se vi andasse, dovrebbe essere armato (Joäo Guimaraes Rosa).
Il regista, un comunista militante, aveva già dato, come abbiamo detto, buona prova con “Rio 40 graus”, interpretando originalmente il neorealismo e dando un’inedita immagine di Rio de Janeiro, della quale mostrava anche una favela. Abbastanza per attirarsi contro gli strali del la censura e subire il sequestro del film. Con “Vidas Secas” il potente realismo di Pereira Dos Santos si arricchisce di aspetti originali, la famiglia contadina, nella terra assetata del nordeste, diviene l’emblema della fame e della miseria imposta dal sopruso naturalmente praticato sui deboli in quell’inferno. Inizia il superamento, che Rocha porterà fino in fondo, del grande modello rosselliniano del realismo documentario. “Ganga Zumba”, offre un importante elemento che caratterizza l’humus culturale da cui nasce il Cinema novo, il problema degli africani, ex schiavi e della loro lotta per la libertà. Carlos Diegues ricostruisce la storia del mitico Ganga Zumba, figlio della regina del Congo, violentata dai portoghesi e portata schiava in Brasile, attorno al 1670. Fuggito, diverrà il capo della comunità di schiavi liberatisi stanziata a Quilombo das Palmares, una sorta di reame nero in grado di far fronte agli attacchi dei colonialisti portoghesi.
Ancora una volta si dimostra, con la forza delle immagini, che solo la lotta senza quartiere può portare la libertà. Nello stesso anno che Porretta premiava come miglior film “Deus e o Diablo na terra do Sol” , il Festival di Berlino assegnava l’Orso d’argento (Gran premio della critica) a “Os fuzis”, un altro straordinario “classico” del Cinema novo, diretto da Ruy Guerra, un portoghese nato in Mozambico,che aveva studiato cinema all’IDHEC di Parigi e, successivamente, si era trasferito in Brasile, dove aveva girato il suo primo lungometraggio nel 1962, “Os cafajestes”, titolo che viene normalmente tradotto “I vitelloni”(!). Anche questa opera è ambientata nel Sertao, nella zona della siccità (l’altra parte del nordeste è ugualmente depressa a causa della monocultura dello zucchero imposta dal colonialismo), abitata prevalentemente dai Cablocos, di sangue misto indio e portoghese (anche sul problema del meticciato il Cinema novo punterà l’obiettivo), tormentati dalla fame e vittime, come abbiamo visto nel Dio nero, di credenze messianiche vagamente cristiane ispirate a un misticismo di tipo medievale.
Guerra non ci mostra i Cangaçeiros, ma i fucili di un distaccamento militare chiamato dal sindaco di Milagres, il piccolo centro in cui si svolgono i fatti, per difendere il suo spaccio dalle possibili incursioni delle vittime della periodica siccità (anche questa dovuta al sistema coloniale di gestire l’ambiente). Ma gli affamati non pensano alla rivolta. Con gli animi imprigionati nella gabbia messianica di credenze irrazionali chiedono aiuto a una natura feticisticamente personificata danzando e cantando il Bumba meu boi, un tradizionale rito propiziatorio. Narrata con felice combinazione di un realismo scabro, che fa parlare il paesaggio, e il turgore neobarocco delle tante catene che tengono sottomessi i derelitti, la vicenda cresce invitando lo spettatore, come ha scritto Renzo Renzi in una bella presentazione del film, nel 1969,” a un responsabile guarda e capisci, per un dramma in cui la condizione delle cose è già psicologia, idea e sentimento”.
Alla fine, per la coraggiosa ribellione di un camionista di passaggio, sconvolto dalla morte per fame di un bambino, i fucili faranno una strage. Solo allora il popolo uscirà dal torpore mistico e il Bumba meu boi diventerà un inno di rivolta accompagnando una “Jacquerie contadina” culminata in un banchetto rituale con il quale finalmente gli oppressi si sfamano. Auspicio, anticipazione, speranza di una prossima rivoluzione? Su questo interrogativo si chiude il capolavoro di Guerra che, con Il “Dio nero e il diavolo biondo” porta il Cinema novo al suo apice e fa di questa tendenza un patrimonio dell’umanità.
Ma la neoavanguardia brasiliana, nonostante il regime militare con i suoi interventi censori, ha ancora molto da esprimere, basti pensare a La sfida (t.l. di O desafio, 1965), di Paulo César Saraceni, un regista già noto in Europa per la sua attività documentaristica (il documentario del Cinema novo meriterebbe un suo capitolo), dedicato ai problemi di un intellettuale di sinistra. Un film, osteggiato dal regime, che divise critica e pubblico, ma favorevolmente recensito da Rocha.
Oppure “A grande citade” girato nel 1966 da Carlos Diegues, autore che già abbiamo citato, o, ancora, “A fàlecida” (t.l. La defunta, 1965), di Leo Hirszman, che due anni dopo girerà un’altra pellicola importante, “A garota de Ipamena” (t.l. “La ragazza de Ipamena”, titolo di un notissimo brano di Bossa Nova). Ambedue i film analizzano la classe media brasiliana, un mondo chiuso dal quale, come da un incubo, è problematico uscire. Infine, allo stesso Rocha che ci stupirà con “Terra em Transe”, realizzato nel 1967, vincitore di due premi a Cannes e uno a Locarno.
Abbandonati i Beatos e i Cangaçeiros del Sertao, troviamo al centro dell’opera un intellettuale, Paulo Martins, giornalista e poeta, tormentato dal dubbio su quale atteggiamento assumere di fronte alla crisi del proprio paese, un immaginario stato di Eldorado, nel quale si intuisce facilmente il Brasile del golpe militare. Il cambio di registro nel contenuto non significa abbandono del linguaggio avanguardistico che fino ad allora ha caratterizzato Rocha, anzi qui assistiamo a un montaggio delle sequenze, girate prevalentemente con la camera a mano, particolarmente ardito e stupefacente, con originali soluzioni che spesso turbano lo spettatore per la loro capacità di comunicare, pur essendo fortemente enigmatiche, o, forse, proprio per questo, il tumultuoso, assurdo contesto sociale di Eldorado. Anche la colonna sonora, bellissima, contribuisce a rendere la caoticità del moderno, la città che ha inglobato il sottosviluppo e ne è diventata una sorta di superfetazione, mescolando canti neri, ai quali si ricollega la trance in cui è caduto il mondo, con Verdi, del quale risuona l’ouverture dell’Otello, e con sambe brasiliane. Il protagonista che non trova soluzione al problema di conciliare poesia e azione politica (Martins dirà a un certo punto: “poesia e politica sono troppo per un uomo solo”), per un atto avventato sarà colpito dal fuoco dei militari ed entrerà in un delirio preagonico, nel quale rivivrà metaforicamente la storia del Brasile prima del colpo di stato militare e potrà constatare l’impotenza degli intellettuali di fronte alla forza sopraffattrice dei potenti. La città è mortifera come il Sertao, dove gli intellettuali sono dei Beatos senza seguito popolare e dei Cangaçeiros senza la forza, ovviamente, di opporre resistenza ai bravi dei signori, adesso organizzati nell’esercito. Giustamente il film è stato considerato da gran parte della critica come il più politico di Rocha e, nello stesso tempo, il più poetico e personale. Inoltre, questa opera segna un momento di riflessione per il regista che più ampiamente esprime lo spirito del Cinema novo, una fase importante per un ritorno al Sertao con maggior consapevolezza del problema fondamentale per il Brasile e tutto il terzo mondo: trasformare le varie forme alienate di rivolta popolare in rivoluzione. Ma prima di affrontare “O Dragão da Maldade contra o santo guerreiro”, dobbiamo dar conto di un film sperimentale, “Câncer”, iniziato da Rocha nel 1968 in 16 mm e montato nel 1969 a Cuba, dove il regista si era rifugiato per sottrarsi al regime dei militari divenuto intollerabile. In seguito, nel 1972, fu fatta dell’opera una versione italiana, curata da Rocha stesso, per i programmi sperimentali della RAI, che aveva comprato il film, il quale fu trasmesso varie volte dal benemerito Fuori orario.
“Câncer” è un film a costo zero, girato in presa diretta, tecnica inedita nel cinema brasiliano, praticamente saltando il montaggio vero e proprio perché girato in tanti piani sequenza di una decina di minuti l’uno, la durata di un rullo di pellicola in una cinepresa Eclaire, che teoricamente potrebbero alla fine semplicemente essere uniti l’un l’altro. Ricordiamo che questo procedimento, oltre ad essere tipico di Straub, con il quale Rocha era in rapporto, è la grande trovata di Warhol, che in questo modo gira moltissimi film tornando ai Lumière. Ma non basta Warhol, uno dei più significativi autori underground newyorkesi, anche J.L Godard, sicuramente il più radicale regista dell’avanguardia europea, è chiamato in causa perché al suo cinema estremo si ispira Rocha in questo film, che la critica ha definito il suo più all’avanguardia e che Rocha stesso chiamerà “il primo e unico film underground 68, made by Glauber Rocha”. Infatti “Câncer”, ambientato nell’inferno urbano, agita i temi tipici del moderno; il sesso, la droga, la violenza insita nelle città, il femminismo, la diversità (i protagonisti sono due emarginati, un bianco e un nero in lotta fra loro), ma con un linguaggio che mette in questione se stesso e, quindi, il cinema, la cui “macchina”(camera, operatori, microfoni) entra in campo, mentre parte dell’azione si svolge fuori campo, fino a trovare il suo limite contro lo schermo non potendo oltrepassarlo per l’impossibilità di superare il linguaggio destrutturato. Qui si innesta la polemica di Rocha con i registi del Cinema Marginal, che egli chiama spregiativamente udigrudi (pronuncia brasiliana di underground), una tendenza che meriterebbe un capitolo a sé, ma della quale qui diremo soltanto che è la prosecuzione, ad avanguardia in via di esaurimento, del Cinema novo in forma totalmente sotterranea, fino alla più esibita e patologica pornografia, analogamente al Cinema della trasgressione, la continuazione dell’underground negli USA in modalità perversamente sconce. Aggiungo, infine, che all’origine del Cinema marginal vi è anche l’inasprirsi della censura con la svolta del regime, nel 1968, che adotta forme cruente di repressione sociale e politica, per cui il cinema diventa sotterraneo e Rogeiro Sganzerla, che proprio nel ‘68 aveva girato “O bandito da luz vermelha”, un’opera marginal duramente criticata da Rocha, diviene l’esponente più rappresentativo di questa tendenza. Intanto Rocha era arrivato a Cuba portando con sé, oltre al girato di Câncer, la copia di “Antonio das mortes“ appena terminato.
Quello stesso anno, il 1969, il film vince ben quattro premi a Cannes e diventa un successo mondiale. La critica e il pubblico accolgono con molto favore questo ritorno di Rocha ai Cangaçeiros e ai Beatos del Sertao, cioè ai temi del sottosviluppo contadino che avevano caratterizzato il primo Cinema novo, anche se molti non colgono il salto qualitativo che quest’opera fa compiere al nuovo cinema anche rispetto al Dio nero e “Os fuzis”. Non voglio dire che “Antonio das mortes“ sia come livello cinematografico superiore alle due opere citate, questo è un quesito che attende ancora una definizione storica, ma sottolineo che con quest’ultima prova Rocha ritorna sì alle origini, però arricchendone la tematica, per dirla con Hegel, di tutte le sue determinazioni.
Affiora, infatti, che il neocolonialismo, responsabile del sottosviluppo e della fame che affligge il popolo, è in realtà un’articolazione dell’imperialismo, fase suprema, per civettare con Lenin, del capitalismo. Ma andiamo con ordine. Nei villaggi del Sertao il popolo continua a praticare i propri ancestrali riti magici, mentre un maestro cerca di educare i bambini in modo laico e progressista. Un coronel, che mantiene i villaggi succubi per il terrore, ha al suo servizio il delegato di polizia, il quale è l’amante della moglie del coronel stesso. Il delegato incarica ““Antonio das mortes“ di uccidere un ultim”O Cangaçeiro” protetto dai Beatos, incarico che Antonio porta a termine, con alterne vicende, affiggendo poi il cadavere del Cangaçeiro ad un albero del Sertao, come un Cristo crocifisso, non tanto per volere del mandante, quanto per essere l’incarnazione di una alienante promessa di liberazione. Finalmente Antonio si scatena, come un San Giorgio contro il drago malvagio, e coadiuvato dal maestro, che ha preso le armi del Cangaçeiro, stermina i sicari uccidendo lo stesso coronel. Il popolo tutto, compreso il parroco, finalmente consapevole che solo lottando si può vincere la fame e le sopraffazioni, si avvia verso il Sertao. Verso la guerriglia? Questo Rocha non lo dice, ma ci mostra “Antonio das mortes“ che, dopo aver dissolto i miti del misticismo fideistico e della rivolta brigantesca, abbandona il Sertao per avviarsi lungo una grande strada asfaltata percorsa dall’autobotte della Shell, simboli della modernità imperialistica.
Con queste immagini suggestive e dense di significato si conclude il film, che costituisce anche il canto del cigno del Cinema novo, giunto al termine della sua luminosa parabola, così come la neoavanguardia in tutto il mondo, assorbita dalla rivolta giovanile del sessantotto, nella cui lotta antistituzionale sono confluiti il nichilismo e la polemicità radicale anche delle nuove e più originali tendenze cinematografiche.
Inizia la restaurazione dei valori, quindi anche dell’arte, analogamente a quanto era avvenuto con le avanguardie storiche, e abbiamo una riedizione della tradizione del nuovo, per cui i linguaggi della neoavanguardia, anche quelli sottoposti a radicale destrutturazione, divengono nuovi linguaggi artistici compatibili nel lungo periodo, la restaurazione post sessantotto è tuttora in corso, con la cultura dominante.
Questo, lo abbiamo detto, vale anche per il cinema e, nel nostro caso, possiamo verificarlo prendendo ad esempio Guerra e Rocha, i ferri di lancia del Cinema novo. Essi, infatti, continueranno, come molti loro compagni d’avventura, a fare film, ma per quanto interessanti e qualitativamente alti, confermeranno l’affievolirsi del loro slancio eversivo iniziale e segneranno l’atrofizzarsi anche di questa tendenza.
È comunque doveroso segnalare che Guerra, nel 1978, dopo aver realizzato “Sweet Hunters” (t.l. “Teneri cacciatori”) e “Os deus e os mortos” (t.l. “Gli dei e i morti”), nei quali il suo stile originale resta sullo sfondo, tornerà a Milagres per girare “A queda” (t.l. “La caduta”), un seguito di “Os fuzis”, con i personaggi del 1964 ritrovati. L’opera è una denuncia spietata della condizione in cui vivono le città brasiliane in quel periodo, un documento straordinario dello sfruttamento disumano a cui sono sottoposte le popolazioni urbane, ma stilisticamente non va oltre il nobile film di denuncia ottimamente realizzato. In quanto a Rocha, nel suo esilio fra Cuba, Spagna, Africa e Italia, gira Il leone a sette teste, versione italiana del geniale intrico linguistico “Der Leone Habe Sept Cabeças” (1970), e, nello stesso anno, “Cabezas Cortadas” (t.l. “Teste tagliate”), nei quali mantiene uno stile avanguardistico, ma molto di maniera, criptico e difficilmente decifrabile univocamente. Dopo alcune sperimentazioni, fra le quali una girata in Italia in 16mm. con Carmelo Bene (“Claro”, 1975), torna in Brasile, dove realizza, fra l’altro, il suo ultimo film, “A Idade da terra” (t.l. “L’età della terra”, 1979).
Io vidi l’opera a Venezia, dove fu presentato in concorso nel 1980, ma, dopo aver letto l’interessante articolo di Giovanni Ottone, Il testamento di Glauber Rocha, nell’ultimo numero di questa rivista, dovrei rivederlo, cosa che non mi è possibile fare se non dopo che avrò spedito questo articolo. Azzardo però un giudizio, che è anche la conclusione della mia argomentazione complessiva. Ammettendo che la tesi di Ottone, ragionata con sapienza e finezza, sia giusta, verrebbe a cadere il giudizio che formulai dopo la visione veneziana del film, ma ritengo resterebbe la netta divaricazione fra quest’opera e l’innovativa vitalità del Cinema novo. Anche se “Il testamento di Glauber Rocha” non fosse, come a me parve, il risultato dell’incertezza in cui il regista si dibatteva per l’estenuarsi delle avanguardie con la conseguente emarginazione degli spezzoni più irriducibili di esse, resterebbe pur sempre un’opera della restaurazione, vale a dire formalizzata con uno stile non più critico del cinema e, insieme, della comunicazione sociale in quanto comunicazione reificata di una società alienata, ma omogeneo, anche se stridente, alla koiné linguistica del dopo avanguardia. La cinepresa si apre ancora sulla fame e il sottosviluppo, ma non più sulla rivoluzione.
RICHARD JEWELL, (ANTI)EROE DEI NOSTRI TEMPI
di Francesco Saverio Marzaduri
“Il potere della burocrazia continua a crescere mentre il pianeta si restringe e i problemi della società diventano più complessi. Ho paura che l’indipendenza individuale stia diventando un sogno obsoleto.”
CLINT EASTWOOD
Consapevole dei pochi calendari ancora a disposizione, il novantenne Clint Eastwood innesta, nei suoi ultimi lavori da regista, un “quid” che sfugge ai più, ma a ben guardare lucidamente inerente col proprio percorso esistenziale, in cui una sospirata saggezza concilia con un cerchio della vita prossimo all’epilogo – e pazienza se negli States, e non molto più diversamente da noi, l’esito al botteghino è inferiore alle aspettative. Come ne “Il corriere – The Mule”, uscito subito prima, anche in questo trentanovesimo lungometraggio, “Richard Jewell”, si coglie una sensazione di graduale “risveglio” che collima con una progressiva e faticosa maturità, conseguita non senza incagli. Spunto che, immediato, rinvia alla filmografia New Hollywood, dalla quale lo stesso cineasta di San Francisco in certo qual modo discende; eppure, se gli archetipi all’origine sono – e rimangono – quelli del cinema classico americano, basta leggere tra le righe della sceneggiatura (ad esempio quando Billy Ray riadatta un articolo di Marie Brenner) per scorgervi un’educazione sentimentale che, da improvvisata, si delinea strada facendo. Perché anche un’ignominiosa pagina di diffamazione cronachistica torna succulenta occasione per una potenziale ricostituzione familiare, dove un demiurgico angelo attempato appare non (sol)tanto quale ancora di salvezza quanto idealista personificazione di cui l’America, specie quella trumpiana, si fa portavoce. A parole.
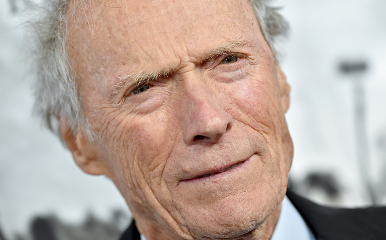
Sicché la ballata-“pamphlet” suona tragicomico sberleffo all’odierno andazzo demagogico, tutto chiacchiere e distintivo, che, esaltando un sistema garantista pronto a pavoneggiarsi dietro occasionali eroi, etichetta come individuo sospetto chi non sia degno d’indossare (secondo un ben definito punto di vista) l’uniforme di tutore della legge. Peggio ancora se l’eroe, trasformato in terrorista, è un “freak”: ovvero, riutilizzando il famigerato pregiudizio, un perdente. Non a caso l’effigie di Trump fa capolino dall’identico schermo tv origine del misfatto, antiteticamente speculare a quella del vero Jewell intervistato dopo aver impedito l’attentato. L’indice di Eastwood, dunque, è puntato contro l’inattendibilità dei media, palmare metafora “bigger than life” del giustizialismo e delle proprie trame oscure. Nient’altro. Lasciamo perdere le ambigue spigolosità, ricercate o meno a bella posta, che la confezione potrebbe manifestare al solito, a rischio di essere interpretata quale ennesimo insidioso manifesto ideologico – come peraltro suggerirebbe lo schizzo della “working girl” su cui si concentrano tutti i difetti (sessisti), e di fatto dipinta come la solita cronista d’assalto, priva di etica e scrupoli. Non mancano, beninteso, passaggi magistrali, incluse le scene che preludono al ritrovamento della bomba, in un dosaggio semplicemente ineccepibile di ritmo, dilatazione dei tempi, inquadrature, montaggio, commento sonoro. In un apologo incentrato su un caso d’ingiustizia mediatica, l’autore – non nuovo all’impiego di figure reali che intercedono sugli interpreti conferendo un autentico parallelo “vérité”-leggenda – mira a far chiarezza nel disegno d’una creatura solitaria, dai contorni simil-hitchcockiani e, benché non del tutto innocente, in grado di sbugiardare il Paese in cui fieramente afferma di credere, senza lasciarsi abbindolare da colpe che la stessa nazione è incapace di confessare, e i cui valori non sono ormai che paraventi.
La citata ricerca d’una salvifica paternità fa il paio con uno sdoppiamento di caratteri: l’antesignano dell’antieroe nichilista, incarnazione del prototipo eastwoodiano, offre due pesi e due misure. Da un lato, l’icona del giustiziere armato si risolve in uno scalognato clone, animato da pari volontà di sicurezza e scambiato per invasato guerrafondaio quando l’FBI, dopo perquisizione, trova un fornito arsenale nella sua stanza; dall’altro un legale finto-cinico, all’inizio elegante avvocato d’un grosso studio e poi sciatto difensore scartoffiaio, ricalcato su personaggi che solo una ventina d’anni prima – da Red Garnett a Frankie Dunn, passando per Luther Whitney e Steve Everett – Clint medesimo avrebbe incarnato, coi guizzi e paradigmi a lui congeniali. Padre e figlio putativi s’incontrano nell’incipit, quando Richard è fattorino addetto all’ufficio in cui Watson Bryant lavora: il primo sorprende il secondo con una brillante deduzione (il cestino in cui dice di scrutare gli permette d’intuire che Watson è ghiotto di barrette Snickers, e il giovane gliene procura una generosa scorta nel cassetto), affibbiandogli l’ironico appellativo di “Radar” come l’occhialuto caporale di “M.A.S.H.”. Ma pure un analogo disordine tipologico sembrerebbe appaiarli: Dick è obeso, trasandato, incurante della linea e completamente privo di quell’aspetto che il tradizionale paladino della legge dovrebbe detenere, così pure il suo “alter ego” è un patrocinante quasi svogliato, dall’aria sciatta, la cui apparente disillusione per l’attività (e in generale un po’ tutto il sistema) è bilanciato da tagliente ironia e combattiva tenacia. “Siamo la coppia più comica del mondo”, chioserebbe Nick Pulovski, laddove Eastwood, intenzionato a salvaguardare alcuni aspetti privati delle vite dei personaggi dallo sguardo del pubblico, sosterrebbe che “è molto più interessante per gli spettatori scriverli e disegnarli insieme a te”. Se il piccolo schermo disponesse di quel briciolo di discrezione che serbano gli asciutti narratori del cinema, senza sfoggio di inutili orpelli, l’ambiziosa Kathy Scruggs non ricorrerebbe agli usuali, arcinoti stratagemmi da arrivista e non trasformerebbe una vaga soffiata dei federali in uno scoop sensazionalistico, credendo di sbattere legittimamente il mostro in prima pagina. Basterebbero i primi minuti di film, lungi dal prender posizione e basandosi sulla mera descrizione, a suggerire come il trionfo d’una sofferta verità sia possibile grazie a un disordinato alveo, specchio d’una condizione prevaricatrice quanto alienante.

Di un ordine costituito fallace (e malevolo), incapace di stanare i colpevoli, che per sedare il “climax” di collettiva paranoia fa di manovrabili pedine i capri espiatori, il cineasta aveva parlato una dozzina d’anni fa in “Changeling”, ma anche “J. Edgar” è lì a ribadirlo: “il potere può trasformare una persona in un mostro”, sono le parole con cui Watson – eroe in celluloide nell’aiutare Richard, a sua volta eroe mediale per un’esigua manciata di minuti – congeda l’amico prima di assumerne le difese, riverbero del monito campeggiante sul poster del suo ufficio (“Si ha paura del governo più di quanto se ne abbia del terrorismo”). E più in là, la segretaria russa e futura moglie di Watson ribatte con un aforisma che non dissocia granché ambedue i sistemi, ponendoli anzi su univoco asse (“In Russia when the government says someone’s guilty, it’s how you know he’s innocent. Is it different here?”). Sicché un videogame di genere bellico può apparire nulla più d’un innocente gioco atto a incrementare un’amicizia, non fosse che le immagini seguenti mostrano il protagonista nell’atto di esercitarsi a un poligono di tiro e poco dopo, in un campus universitario, ammonire un gruppo di giovanotti ubriachi sulle norme di sicurezza, tenendo testa a chi lo sfotte. Richard, meschino, non sa che il troppo zelo, cioè l’eccessiva fede nell’autorità, è una contraddizione in termini che non ammanta di alloro, ma è osservata con sospetto; né si rende conto che l’erudita preparazione su strategie terroristiche e tattiche di attacco non ne fanno un esperto, ma un facile bersaglio. La qual cosa torna utile all’FBI, che anche a causa d’una fedina penale non troppo limpida (non paga le tasse da un paio d’anni, e per di più ha subito un arresto per essersi spacciato da poliziotto), e di ripetute lamentele sul lavoro procurate da abuso d’autorità a fin di bene, fa leva sulla sua dabbenaggine: dapprima lo convince a rilasciare una confessione filmata, spacciata per una registrazione a scopi documentaristici, e poi una serie di prove telefoniche nel tentativo di ottenere la minacciosa voce dell’attentatore.

Ma, si diceva, la manipolazione non ha a che fare con l’autenticità, e lo stesso giovanotto che allo stadio scambia uno zaino di bibite per uno dal contenuto sospetto, dietro l’apparente scorza candida, non è così babbeo da firmare “davvero” un documento ufficiale. Lampi di acume si fan luce anche in sprovvedute tipologie, benché lo sguardo dell’autore, senza eludere il fattore umano, non desideri prendere totalmente le difese d’un essere patetico. Che invero, a propria volta, persiste nel difendere chi lo riverisce e contemporaneamente lo umilia, lo adula mirando a incastrarlo, lo incalza per il bene del Paese solo per gettarlo in pasto agli sciacalli del Potere. Come se non bastasse, tenta di convincere un amico di Jewell a dare una falsa testimonianza facendosi passare per il suo complice gay, senza porsi molti scrupoli nel requisire oggetti personali suoi e di mamma Bobi, la sola insieme a Watson a credere nell’innocenza e nelle qualità del figlio. Anche se questi ha il torto di andare a caccia di cervi, di conservare una spoletta Mk2 a mo’ di fermacarte o la scheggia d’una panchina del parco, luogo dell’esplosione, quale souvenir: elementi che non depongono a favore d’una coscienza cristallina, all’occorrenza non priva di atteggiamenti sensibili (elargisce acqua a donne incinte e anziani o bibite ai “colleghi” poliziotti, e ancora strilla di non guardare programmi tv che destino sospetti, prima di consolare la madre in lacrime un istante dopo), il cui fanatismo ha minor peso d’un sistema contraddittorio e mendace. Ne scaturisce un quadro dolente giocato sulla sottrazione, dove l’assunto viaggia al livello d’intensità dell’inchiesta, e nel triste annuncio ai microfoni di Bobi al presidente Clinton, nel toccante tentativo di riabilitare il nome brutalmente calpestato del figlio, trova un sobrio risultato che equipara i personaggi principali all’identico livello degli antagonisti. Il governo federale incastra Dick, ma non è meno vittima del pervasivo e cinico circo mediatico che fa strame di entrambi, e nell’epilogo – chissà – forse ci metterà una pezza.

Chiudendo il cerchio, dunque, “Richard Jewell” è anche la parabola di un’ideale relazione paterno-filiale (come quella, per esempio, tra Frankie e Maggie o, più indietro, fra Thunderbolt e Lightfoot in “Una calibro 20 per lo specialista” di Cimino). Perché il protagonista riesce a mostrarsi finalmente uomo, nonostante gli incorreggibili limiti, solo grazie all’incontro con Bryant che, a suon di ironiche critiche, battute e stoccate (“Hai il centone che mi devi?”, domanda memore d’una precedente promessa), gli spalanca gli occhi, lo “ridesta” a costo di ferirlo. L’impossibile (la ribellione di Jewell, sin lì repressa e compresa dalla remissione), dopo un “tête-à-tête” con Watson, si concretizza davanti alla commissione federale in cui un laconico Richard si prende la rivincita verso gli scettici aguzzini. L’incubo che attanaglia il giovane, eco del delirio di Sully, si conclude. E anche se non riesce a diventare un eroe, la divisa da piedipiatti di cui sospirato si riappropria (il sogno era lavorare nelle forze armate), è la lauta ricompensa, ma non il totale risarcimento, d’uno sfortunato servizio. A Bryant, inoltre, il compito di rivelare al “figlioccio” il colpevole dell’attentato, tal Eric Rudolph, nell’ultima scena quando paternamente lo saluta alla centrale, rimirandolo estasiato. E a mamma Bobi non resta che sopperire alla mancanza del suo bambino, stroncato da un infarto a soli quarantaquattro anni, facendo da babysitter ai pargoli di Watson. Dove il fatuo idealismo a stelle e strisce sostiene di potere senza riuscire, sta all’individuo solitario adempiere al recupero di perduti valori, e non è detto che non vi riesca. Al di là di qualsivoglia operazione mitopoietica, amicizia e amore faranno il resto. Contro un procedimento contorto che fagocita e spazza (per la cronaca, oltre a Dick, anche Kathy è mancata a quarantadue anni per un’overdose di antidolorifici).

SAGGI
LIGHT OF DORIS DAY
di Francesco Saverio Marzaduri
Per curiosa casualità, solo pochi giorni prima della scomparsa di Doris Day, chi scrive è incappato nella messa in onda d’un documentario di una rubrica, “Vite da star”, fatta di approfondimenti sulle leggende hollywoodiane, incentrato nello specifico sulla “fidanzata d’America”. Nessuno dice che sia stata una grande attrice, e forse, pur disponendo d’un bel timbro vocale e venduto milioni di dischi, neppure una cantante eccelsa. Eppure il sorriso raggiante, il biondo carré, il carattere ora spigliato e vivace, ora intraprendente ed esuberante, erano tratti bastevoli a radiografare un’America e un’epoca che avrebbero avuto tutto il tempo di intorbidire, in seguito, quell’innocenza all’acqua di rose. A ribadire l’effimera longevità di tale candido ottimismo, senza bisogno di addentrarsi nella sfera personale della diva o sul divario di quest’ultima col mutamento del “milieu” di Hollywood e del suo pubblico, è una filmografia perlopiù costituita da commedie e musical, generi nei quali l’attrice-cantante nativa di Cincinnati e d’origine mitteleuropea mostrava con maggior disinvoltura le proprie qualità. Non sorprende che la sua figura pulita fosse apprezzata da firme quali Michael Curtiz, Stanley Donen, Gene Kelly, così come breve è stato il salto verso il “mélo”, grazie al quale Doris avrebbe sfiorato, pur senza vincerla, la statuetta con “Amami o lasciami”, storia di una danzatrice che raggiunge il successo come cantante, grazie all’intervento di un gangster con cui ha un tormentato rapporto. Pellicola che peraltro permise alla Day di tornare a recitare col vecchio ammiratore James Cagney, già suo partner in “The West Point Story”. E anche se non vi è cinefilo che sullo schermo non ne associ il talento d’attrice a Hitchcock e a “L’uomo che sapeva troppo” – e ovviamente al brano incluso in colonna “Whatever will be (que sera sera)”, destinato a diventare un classico – ineluttabile quanto ingiusto è ripensare a tutti quei ruoli, quei segmenti e quei titoli che ne rendono inconfondibile la bionda icona. Ecco dunque sfilare una Calamity Jane ben lontana dal ruspante prototipo mascolino, ma schiettamente verace, in “Non sparare, baciami!”. O la ragazzina di “Tè per due” che, nel riadattamento di “No, No, Nanette”, riesce a strappare al ricco zio l’ingente somma per finanziare uno spettacolo di rivista di cui essere protagonista. E ancora, in “10 in amore”, la docente di giornalismo che dà una lezione d’umiltà (complici i buoni sentimenti) al cinico giornalista Clark Gable; la segretaria zitella de “Il visone sulla pelle” che accetta di trascorrere una vacanza alle Bermuda col ricco playboy Cary Grant; la madre pre-femminista di “Non mangiate le margherite” alle prese con una famiglia scatenata e il marito David Niven sul punto di tradirla; o l’arredatrice de “Il letto racconta…” che, grazie a un duplex galeotto, s’incontra-scontra con un compositore (il Rock Hudson con cui Doris avrebbe recitato in altri due film, stringendo una salda amicizia) in fotogrammi che li raffigurano insieme anche se in stanze diverse, “frame” citato e parodiato in tante commedie successive. Escludendo la verve brillante dell’attrice, che spesso le consentì di lavorare con gli stessi partner, si direbbe che molti dei suddetti prodotti, nella discontinuità o meno della loro sostanza alla prova del tempo, si ricordino più per i loro titoli, in certi casi divenuti modi di dire, che per la loro intrinseca qualità. Nondimeno, “Quel certo non so che” o “Non mandarmi fiori!”, merito anche dell’apporto di geniali sceneggiatori (Carl Reiner o Julius J. Epstein) e della regia di Norman Jewison, mantengono tuttora una spanna in più fungendo da archetipo per quella “sophisticated comedy” che futuri commedianti in ascesa avrebbero ereditato. Quanto a dire che l’impronta lasciata dalla star, destinata a trasformare la propria ormai stereotipata effigie in qualcosa d’insolito e maturo per tempi prossimi al cambiamento (si pensi a “La mia spia di mezzanotte”), non è degna dell’oblio a cui gli stessi Stati Uniti che l’avevano eletta a simulacro l’avrebbero poi relegata, convincendola a optare per il sin lì parodiato “format” televisivo (il fortunato show che recava il suo nome). Si diceva, però, che se nessuno dei ruoli menzionati fosse tuttora degno di segnalazione, anche a causa del tasso eccessivo di saccarosio, pensa quello di Jo McKenna, la madre di famiglia suo malgrado vittima d’un intrigo spionistico insieme al marito, a rammentarne le inattese doti drammatiche e, con l’immortale urlo che sventa un attentato alla Royal Albert Hall, rubare la scena a James Stewart consegnandola alla memoria, ancor prima del motivo intonato di lì a poco e successivamente riproposto altrove. Un successo che col simil-hitchcockiano “Merletto di mezzanotte”, pur notevole, non riesce a convincere pubblico e critica in egual modo. Ma tanto basterebbe, assieme al fatto di aver sopperito alla Marilyn da poco scomparsa in “Fammi posto tesoro”, a dir d’un personaggio e una carriera destinati sullo schermo a un tenero (e sbiadito) ricordo, nonostante l’alterno esito. “Que sera sera”, appunto.
“VERTIGO” E LE EBREZZE CINEFILE A SEGUIRE
di Roberto Baldassarre
Nel 2015 Kent Jones realizzò “Hitchcock/Truffaut”, un documentario basato sul libro intervista Le cinéma selon Alfred Hitchcock, edito in Italia come Il cinema secondo Hitchcock. Partendo da quel fondamentale testo cinefilo, il regista Jones, oltre a mettere in immagini la conviviale e feconda conversazione tra i due registi, voleva trasmettere a una nuova generazione di spettatori l’importanza di Sir Hitchcock nella storia del cinema. Il documentario, che si apre con dei titoli di testa che citano lo stile di Saul Bass, è assemblato con le foto di quel mitico incontro, da molte sequenze tratte dalle più significative pellicole di Hitchcock (oltre da un paio provenienti dai film di Truffaut) e, a volte, il commento over è quello originale derivante dalla conversazione tra i due. Oltre a questo materiale di repertorio, ci sono anche gli interventi di alcuni registi contemporanei ammiratori del regista inglese, che esternano la loro passione soffermandosi su una determinata sequenza o una particolare tecnica di ripresa che li ha influenzati. Il documentario, a differenza del libro, non ripercorre completamente, cioè pellicola per pellicola, l’opera di Hitchcock, ma tra le molte opere che ha diretto il maestro inglese si sofferma particolarmente su due sue pellicole: “Vertigo” (“La donna che visse due volte”, 1958) e “Psyco” (1960). Ambedue, oltre ad essere opere fondamentali nella filmografia di Hitchcock, sono dei veri cult che hanno suggestionato i registi intervistati.
“La donna che visse due volte”, come declama il titolo affibbiatogli dalla distribuzione italiana, effettivamente ebbe una doppia vita. Pellicola quasi snobbata da pubblico e critica alla sua uscita, e su cui Hitchcock aveva delle riserve (riteneva che ci fosse un grosso buco nella storia), solamente con il passare del tempo – e di visioni “clandestine” – che quest’opera ha gradualmente acquisito lo status di capolavoro. In pratica “Vertigo” ha quasi avuto lo stesso iter (ri)valutativo di “Peeping Tom” (“L’occhio che uccide”, 1960) di Michael Powell che, stroncato all’inizio, lentamente ha avuto la sua rivalutazione critica. “Vertigo”, che aveva estasiato sin dall’inizio solamente i cinephiles francesi, nel 1989 è stato inserito nel patrimonio della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti; nel 1998 l’AFI (American Film Institute) lo incluse nei migliori cento film statunitensi (posizione sessantunesima, per poi passare, dieci anni dopo, al nono posto) e, infine, in un sondaggio effettuato dal BFI (British Film Institute) attraverso la rivista Sight and Sound nell’agosto 2012 è stata posizionata al primo posto come più importante opera della storia del cinema.
Tra gli intervistati di “Hitchcock/Truffaut” c’è Paul Schrader, che rievoca come scoprì – e amò – “Vertigo” in una visione “furtiva” degli anni Settanta dietro consiglio di Martin Scorsese. È proprio Schrader che, assieme a Brian De Palma, realizza uno dei migliori omaggi a “Vertigo”, scrivendo la sceneggiatura di Obsession (Obsession – Complesso di colpa, 1976). La pellicola di De Palma prende spunto dall’idea di base di “La donna che visse due volte” per raccontare la tragica storia d’amore – e inganno – del protagonista Michael Courtland (Cliff Robertson), che rivede in un’altra donna l’immagine della sua ex-moglie morta tragicamente. A differenza della pellicola di Hitchcock, in “Obsession” l’inganno architettato da Robert Lasalle (John Lightow) contro Courtland è più arcigno, e nella storia confluiscono le “ossessioni” di Schrader (il senso di colpa e il peccato) e le “ossessioni” di De Palma (l’erotismo e i sofisticati movimenti di macchina). “Complesso di colpa”, tacciato alla sua uscita di semplice scopiazzatura di “Vertigo”, si avvicina comunque all’originale per la composizione della colonna sonora da parte di Bernard Herrmann, che nello stesso anno compose anche la Soundtrack di “Taxi Driver”, che fu la sua ultima composizione. Ambedue le OST furono nominate agli Oscar, ma nessuna delle due si aggiudicò la statuetta. Brian De Palma, che doveva anche lui apparire nel documentario di Kent Jones ma causa altri impegni (la realizzazione del documentario “De Palma”), è con “Body Double” (“Omicidio a luci rosse”, 1984) che riesce a realizzare un omaggio a “Vertigo” – e a tutto il cinema di Hitchcock – più stratificato. In quest’opera De Palma unisce l’idea di base de “La donna che visse due volte” e l’idea di “Rear Window” (“La finestra sul cortile”, 1954), aggiungendovi il suo gusto per il cinema spazzatura e l’erotismo voyeuristico; senza dimenticare la perizia tecnica. “Omicidio a luci rosse” mette in mostra, a più livelli, l’inganno. Illude lo spettatore all’inizio (la finta pellicola horror, il finto fondale); inganna il protagonista Jake Scully (Craig Wesson) (il finto amico che gli presta casa, la danza erotica che vede è attuata da un’altra donna); e infine spiega il trucco presente all’inizio di “Dressed To Kill” (“Vestito per uccidere”, 1980), cioè come venne realizzato il nudo di Angie Dickinson. Oltre a questo, De Palma recupera l’idea della fobia che affliggeva Scottie (James Stewart) e la tramuta in claustrofobia.
Di tutt’altro tipo è l’omaggio che ne fa Mel Brooks in “High Anxiety” (“Alta Tensione”, 1977). La pellicola è un atto di ossequio declinato in forma parodica, cogliendo le scene più famose del cinema di Alfred Hitchcock. Giustamente anche “Vertigo” viene citato, attraverso le vertigini di cui soffre il protagonista Richard H. Thorndyke (Mel Brooks), che nel momento della sua fobia viene ripreso mentre cade nello spirare della vertigine (proprio come accadeva a John “Scottie” Fergusson). Inoltre Brooks parodia anche la scena del campanile, contaminandola, in modo demenziale, con “The Wizzard of OZ” (“Il Mago di Oz”, 1939) di Victor Fleming. Sempre restando all’omaggio ironico, è molto interessante il videoclip Last Cup of Sorrow (canzone dei Faith no More contenuta in Album of the Year del 1997). Diretto dal pluripremiato Stephen Kahn, che successivamente ha diretto l’action Torque (Torque – Circuiti di fuoco, 2004), il videoclip è un veloce “remake” sintetizzato in quattro minuti de “La donna che visse due volte”, a cui viene aggiunto un pizzico di humour: l’amica innamorata di Scottie, “Midge” (Barbara Bel Geddes), che cercava di aiutarlo a superare il trauma, nel video è sostituita da un amico dandy. Altro interessante atto d’amore, e “remake” compresso, è quello sperimentato dal trio Evan Johnson, Galen Johnson e Guy Maddin con “The Green Fog” (2017). Questo salace esperimento non è un semplice omaggio, ma è un “rifacimento” totale di “Vertigo” assemblando scene prese da differenti pellicole e serial che hanno come sfondo la città di San Francisco. Gli autori hanno montato oltre cento clip differenti e hanno condensato il plot di 129 minuti della pellicola di Hitchcock in soli 63 minuti. Tra le scene utilizzate appare anche un frammento di “Vertigo”, cioè una mano che si arrampica su una scala.
Altri atti d’amore appassionanti riguardo “Vertigo”, si possono riscontrare anche solo a livello di accenno, ossia citazioni in cui può apparire una scena trasmessa in TV oppure l’apparizione di un manifesto. Nel primo caso, una scena della pellicola di Hitchcock appare in “12 Monkeys” (L’esercito delle dodici scimmie, 1996) di Terry Gillian, poco prima della fine. Nel secondo caso, un manifesto di “Vertigo” fa una fugace apparizione sul lato di un autobus in “Manhattan Murder Mystery” (“Misterioso omicidio a Manhattan”, 1993) di Woody Allen.
In ambito italiano, “La donna che visse due volte” e il suo plot hanno avuto la sua importanza. “Una sull’altra” (1969) di Lucio Fulci è un calco dell’idea alla base della pellicola, a cui vengono aggiunte atmosfere erotiche e una maggiore tensione da thriller vero e proprio. Quest’operazione, che ha molti fans, viene comunque considerata una semplice scopiazzatura dell’originale. Anche a livello di veloce e amorevole rimando, in “La leggenda di Al, John e Jack” (2002) di Aldo, Giovanni e Giacomo, un frammento di “Vertigo” appare nella sequenza iniziale al cinema, dove viene appunto proiettato il film di Sir Hitchcock. Restando in ambito italiano, va anche messo in rilievo come la pellicola di Hitchcock sia vissuta due volte. Nel primo caso a livello di doppiaggio, perché il primo fu del 1958, con le voci di Gualtiero De Angelis (Scottie) e Rosetta Calavetta (Madeleine/Judy), mentre il secondo è dei primi anni Ottanta, quando la Universal decise di rieditare il film. Per questo ridoppiaggio furono scelti Giorgio Piazza (Scottie) e Vittoria Febbi (Madeleine/Judy). L’altro aspetto curioso è la riproposizione in televisione, nel 1997, della pellicola restaurata dopo ben 12 anni di assenza dai palinsesti.
Oltre a questa tipologia di citazione, cioè omaggiare (o copiare) il plot o una determinata scena, “Vertigo” è stata una di quelle opere in cui una particolare tecnica cinematografica è stata recuperata da altri registi. Alfred Hitchcock, oltre a maestro della suspense e briccone nel divertirsi a fare dei camei nei suoi film, era noto per la sua ricerca, per ogni nuova pellicola, di una particolare tecnica registica che fosse capace di stupire. In “La donna che visse due volte” la tecnica innovativa e sorprendente fu la ripresa che ricreava il senso di vertigine del protagonista Scottie. Tale senso di “capogiro” fu creato azionando lo zoom in avanti mentre la macchina da presa carrellava all’indietro. Questo funzionale artifizio è stato utilizzato da molti registi, come ad esempio: Martin Scorsese in “Raging Bull” (“Toro scatenato”, 1980) e in “Goodfellas” (“Quei bravi ragazzi”, 1990); Brian De Palma in” Body Double”; Steven Spielberg in 2Jaws2 (“Lo squalo”, 1975); Sam Mendes in “Road to Perdition” (“Era mio padre”, 2002); Tobe Hooper in “Poltergeist” (“Poltergeist-Demoniache presenze”, 1982)
“MRS DOUBTFIRE”, IL FILM DI CHRIS COLUMBUS,
DIVENTA UN MUSICAL DI BROADWAY
di Roberto Lasagna
Tra gli spettacoli annunciati alla riapertura di Broadway, affiora anche Mrs. Doubtfire, non per un remake cinematografico o televisivo, e tantomeno per il sequel di cui si parlava da anni prima della scomparsa di Robin Williams, ma di un musical con libretto di Karey Kirkpatrick e John O’Farrell e musiche e testi di Wayne Kirkpatrick e Karey Kirkpatrick. Daniel Hillard, il doppiatore divorziato e disoccupato del film diretto da Chris Columbus nel 1993, avrà il volto di Rob McClure e la scommessa è ambiziosa. Come noto, “Mrs Doubtfire” coglieva i temi del trasformismo e della doppia identità, in un racconto letteralmente sostenuto dalla performance di Williams, esaltato con il cambiamento della voce, della postura e la completa trasformazione fisica aiutata da un make-up laborioso che avrebbe aggiudicato al film un premio Oscar per il miglior trucco. A Teatro, la sfida è anche tenere i tempi rapidi richiesti alla trasformazione di Hillard nella governante tutto fare, motivo di comicità per una neo-Mary Poppins adatta al palcoscenico, tour-de-force garantito dalla squadra che accompagnerà l’interprete protagonista, per il quale, a differenza di quanto vediamo nel film, avverrà tutto in tempo reale. Quando Williams riceve la visita dell’assistente sociale, si precipita nell’altra stanza e si traveste in tutta fretta da tata, la soluzione è resa possibile dal fatto che ci si trova in un film, ma a teatro? La posta in gioco è alta, e Mrs Doubtfire musical si annuncia come una scommessa che il regista Jerry Zack accoglie da veterano dei Tony Award.
Nel film diretto da Chris Columbus, in cui già si intravvedevano le potenzialità di spettacolo musicale, il doppiatore Daniel Hillard, messo alle strette da un divorzio che rischia di limitargli fortemente la frequentazione dei tre amati figli, si traveste da attrezzata governante e trova così il modo per trascorrere il tempo con loro; in tal modo innesca più di un corto-circuito, portando in scena come la pari dignità dei coniugi sia rilanciata dalla pretesa che un uomo possa diventare “mammo per sempre” e in ciò sferrando anche un colpo alle tirate femministe e alla freddezza della burocrazia, atta a scompaginare equilibri e a porre talvolta vincoli d’insensatezza.
Il confronto in parallelo tra genitori e figli attraversa il film, le cui vicende sono condizionate dalla separazione dei genitori, mentre il racconto apre lo scenario alla rappresentazione civile del divorzio. Lisa Jakub, che interpreta la figlia maggiore di Robin Williams e Sally Field, ricorda l’esperienza affiatata sul set che per lei fu anche causa della sospensione dal liceo, viste le numerose assenze a scuola per completare le riprese (Williams avrebbe scritto anche un’accalorata lettera al preside per sostenerne il rientro, da perfetto genitore vicario) e porta la sua voce di adolescente in un ricordo molto intenso: “Molte persone sono venute da me e mi parlavano di quanto il film fosse stato importante per loro durante il divorzio dei loro genitori. L’idea che la tua vita non sia quella che speravi ma che comunque non significa che sia brutta o sbagliata. Che tutto passerà, che starai bene. È un messaggio potente”).
C’è davvero molto di personale in questo film, dove Williams, coadiuvato dall’amico regista Chris Columbus, è un bravo doppiatore ma dal temperamento irrefrenabile e la sua indisciplina lo porta al licenziamento spingendo la moglie alla decisione di lasciarlo e di tenerlo lontano dalla custodia dei tre figli, perché lo ritiene poco presente e inaffidabile. Il disagio per la lontananza lo induce a inventarsi il secondo personaggio del film, Mrs Doubtfire, tata e baby sitter dalla lunga esperienza, frutto di un’invenzione formidabile che finisce per riequilibrare l’assetto di famiglia e compensare i vuoti nella vita della ex-coppia: Miranda si sente meglio quando in casa c’è Mrs Doubtfire, Daniel riesce finalmente a vivere a tempo pieno in compagnia dei figli e ad essere persino pagato per il suo lavoro.
Williams infonde nel film il suo camaleontismo, la cui eco è appena anticipata nelle sale dal precedente successo del film d’animazione “Aladdin” (1992) della Disney, in cui l’attore, che sarebbe finito ai ferri corti con la casa di produzione per sfruttamento indebito del suo nome, prestava la voce alle metamorfosi del Genio della lampada.
In “Mrs Doubtfire” Robin Williams confermava la sua vocazione di Peter Pan nella capacità di trasformarsi in eterno ragazzo e cogliere le sfumature emotive dei figli. Mrs Doubtfire è allora un personaggio di passaggio, mediazione tra il passato e il futuro, suscettibile di destare subito empatia grazie al suo modo di fare travolgente che prevede anche siparietti rock nei quali Williams si scatena lasciando danzare l’ingombrante signora al suono della chitarra elettrica (che poi è la scopa come si addice ad una moderna Mary Poppins). Lo spettacolo di Broadway attingerà a piene mani dai momenti musicali previsti, coinvolgendo un cast che prevede anche Jenn Gambatese (Miranda Hillard), Peter Bartlett (Mr. Jolly), Charity Angél Dawson (Wanda Sellner), Mark Evans (Stuart Dunmire), J. Harrison Ghee (Andre Mayem), Analise Scarpaci (Lydia Hillard), Jake Ryan Flynn (Christopher Hillard), Avery Sell (Natalie Hillard) e Brad Oscar (Frank Hillard).
Annunciato dapprima allo Stephen Sondheim Theatre il 5 aprile, per i noti motivi di pandemia da Coronavirus, lo spettacolo è in attesa di nuove date, ma ci si aspetta una prova emozionante. Il film, d’altro canto, si ricorda per il trasformismo divertente, che rispecchiava i limiti della realtà più vera quando nel finale Daniel capisce la necessità di dover cambiare, per cercare un dialogo con la ex-moglie e poter intravvedere un’altra parte in definitiva anche più gratificante, quella del padre maturo e costante che non ha più bisogno di una maschera per assicurarsi un posto nella vita dei figli. Ma prima di arrivare al suo traguardo, il film divertiva grazie alla scelta di Daniel di vestire i panni di un’altra persona, e le maggiori trovate comiche avvenivano al cospetto della gelosia dell’uomo per l’aitante contendente dell’ex-moglie Miranda, il facoltoso Stuart Dunmeyer (Pierce Brosnan), occasione per innescare situazioni davvero irresistibili.
Non c’è volgarità in questa commedia che affronta il tema dell’amore per i figli in una prospettiva al maschile, dove Williams, nel lungometraggio del 1993, è particolarmente a suo agio nel ritratto di generosa simpatia a fianco della brava e irrisolta ex-moglie interpretata da Sally Field. Il ritratto en travesti di Williams offre una versione spassosa del suo lato clownesco ed è il motore comico di una commedia agrodolce, in cui molti temi sociali sono sullo sfondo, a cominciare dalla ricerca di un lavoro incline alle proprie aspirazioni, dove il protagonista, un bravissimo doppiatore di cartoon, nell’America della disoccupazione e con tre figli a carico, si permette di licenziarsi perché non vuole che i film insegnino ai bambini a fumare e cambia deliberatamente i testi già scritti da altri; quindi, a partire dal momento in cui il tribunale lo vorrà lontano dai suoi figli, egli attingerà dalla sua fantasia pedagogica per inventare la governante ideale.
Una visione utopica riequilibrante in stile neo-hollywoodiano, che Broadway rilegge come un omaggio sentito a Robin Williams a sei anni dalla scomparsa, rivisitazione di quella cronica sindrome di Peter Pan che Miranda non accettava più in Daniel, di cui però sarebbe restata traccia nel futuro per entrambi i genitori, quando Daniel verrà assunto in televisione per interpretare in una sit-com la governante del titolo, e Miranda aprirà gli occhi sull’autenticità del sentimento di Daniel, necessario come il suo per i suoi figli. La donna dovrà allora riconoscere che persino un travestimento, con tutta l’energia necessaria, può essere un utile stratagemma per affrontare il cambiamento.
C’è da augurarsi che il musical renda giustizia a un film che per primo si pose il problema del ruolo di un padre divorziato al cospetto con figli desiderati e bisognosi del proprio genitore, grande successo di Robin Williams la cui celebre performance negli anni sarà facilmente affiancata a quella, altrettanto memorabile, sostenuta da Dustin Hoffman per Tootsie (1982) di Sidney Pollack.
Il trasformismo del personaggio di “Mrs Doubtfire” non si rifà unicamente al dinamico protagonista di “Tootsie”, con cui il confronto è inevitabile e che, figlio di una sceneggiatura diversa, riporta precise differenze nelle motivazioni e negli atteggiamenti (tra i due attori, è Williams che cerca in modi esuberanti l’empatia), ma si collega inevitabilmente anche al modello Jerry Lewis, attore e cineasta che ha moltiplicato le possibilità del cinema comico dalla fine degli anni Quaranta rinnovando la lotta dell’individuo infantile in conflitto con la società. Come Lewis, Williams sgomita per l’integrazione e il successo riportando nel suo cinema la contrapposizione tra uomo e donna (declinata in Lewis nella rielaborazione della screwball comedy e in Williams nella comicità sfrontata della sua generazione) per derivarne situazioni in cui il rapporto con l’altro sesso è espressione di disagio e motivo di rivolta, sintomi del bisogno di emancipazione da ingranaggi arrugginiti e dai rapporti personali sessisti. Williams, la cui comicità prende avvio dai trascinanti stand up, come in Lewis de-costruisce i dispositivi del potere abitando dall’interno macchine cinematografiche che contribuisce a smontare. Così in Toys, l’ibridazione scomposta dei generi porta il mondo del travestimento nella dimensione dell’elettronica, in un universo di merci che sono consegnate irreversibilmente a quello spettrale delle immagini. È il destino, fatto di garbo e insieme di impudenza, di un commediante che non troppo diversamente da Lewis perde spesso i connotati della disciplina, per scivolare con il corpo e il linguaggio dentro un’epoca in cui i dispositivi di potere si nascondono in pose inavvertite. Ma Williams non sarà mai regista di se stesso come Jerry Lewis, e il confronto con la disciplina avverrà sempre con il sostegno di altri cineasti. A proposito di “Mrs Doubtfire”, Robin Williams, a dirla tutta, somiglia a un possibile Danny Kaye memore di Jerry Lewis, tanto è disarmante il ritratto dello straordinario doppiatore di cartoon Daniel Hiillard, licenziato e con tre figli, sempre pronto ad emozionarsi e a far sorridere. Sono trascorsi quattordici anni da “Kramer contro Kramer” (1979), quando Mery Streep e Dustin Hoffman si affrontavano duramente per la custodia del figlio.
Questa volta, con “Mrs Doubtfire”, le cose cambiano: Williams, che eredita il dinamismo di Hoffman e fa suo il detonante anarchismo di Lewis, plasma l’istrionico tour-de-force sfoderando un taglio rivoluzionario che non prevede riconciliazione alcuna tra i genitori. Nel dolce risvolto della commedia di famiglia questa volta mamma e papà non tornano insieme nemmeno nel finale, e dietro la facciata di film da gustare comodamente sul divano di casa, in realtà il lavoro diretto da Chris Columbus e fortemente voluto da Robin Williams assistito da vicino dalla seconda moglie Marsha, è un film esplicitamente indirizzato ai figli di genitori divorziati, che possono trovarvi un senso ad alcune delle loro domande: quelle che solitamente si rivolgono coloro che sono vissuti in famiglie allargate e in nuovi matrimoni.
UN CINEMA PROFETICO NEL TEMPO DELLA PANDEMIA
di Maurizio Villani
Lo spunto per scrivere questo articolo mi è stato offerto dalla lettura di un editoriale scritto da Annalisa Caputo pubblicato ai primi di aprile del 2020 sulla rivista Logoi. Logoi è una rivista di filosofia, Annalisa Caputo è docente di filosofia teoretica all’Università degli Studi di Bari, il tema dell’articolo è filosofico, come lo è il titolo «Un segno intelleggibile, / che può dar senso al tutto». Franare e rilucere del linguaggio sulla responsabilità ai tempi del Corona virus.
Non è questa la sede per entrare nel merito dello scritto in questione e delle tematiche di etica pubblica e privata che affronta in questo tempo calamitoso che «sta cambiando, radicalmente, il nostro modo di concepire la vita e la morte, la malattia e la salute, i diritti individuali e i doveri collettivi (o i doveri individuali e i diritti collettivi?), e quindi sta cambiando anche il modo con cui fino all’altro ieri abbiamo vissuto e pensato la responsabilità».
C’è, però, una parte dello scritto che è meritevole di essere commentata in una rivista di cinema. La Caputo, infatti, stabilisce una sorta di tempistica tra la filosofia e le arti nella comprensione degli avvenimenti contemporanei. «Oggi più che mai – leggiamo nell’editoriale – sentiamo quanto è vero quello che ci dicevano – in maniera opposta e perciò paradossalmente convergente – Hegel e Nietzsche: che la filosofia è “in ritardo” rispetto al proprio tempo, e alla vita. Nottola del crepuscolo. Inattualità anti-eroica e quasi mai realmente profetica».
Al contrario, questa sorta di “capacità profetica” negata alla filosofia, competerebbe alle arti in generale, e al cinema in particolare, dotati della facoltà di anticipare nel loro immaginario ciò che il destino ci riserva nel tempo futuro.
L’esempio specifico che la Caputo ci propone è un rimando a certe corrispondenza tra poesia e cinema: il testo poetico, L’incontro, è di incerta attribuzione: forse è un componimento postumo di Montale, più probabilmente non appartiene all’opera del poeta; il film è “Melancholia” di Lars von Trier.
Leggiamo L’incontro (da Diario postumo. 66 poesie e altre, dello (pseudo) Montale. Milano, Mondadori, 1996).
Esitammo un istante
e dopo poco riconoscemmo
di avere la stessa malattia.
Non vi è definizione per questa
mirabile tortura,
c’è chi la chiama spleen e chi malinconia.
Ma se accettiamo il gioco ai margini
troviamo un segno intelleggibile
che può dar senso al tutto.
A commento di questa poesia scrive Annalisa Caputo: «Ci interessano l’immagine iniziale: di un incontro che esita, nel riconoscimento di una comune malattia; e l’immagine finale: di un gioco/lavoro da fare sui margini, alla ricerca di un segno, di un senso. E ci interessa la connessione centrale: tra malattia, malinconia e poesia.
Ci piace collegare tutto questo al finale del film di Lars von Trier, “Melancholia”. Non solo in maniera apotropaica (per rimuovere il senso di angoscia che crea la visione dell’apocalisse). Ma anche perché ci uniamo a quanti hanno tentato una lettura simbolica della conclusione di questo testo cinematografico. Cosa, d’altra parte, autorizzata dalla costruzione metaforica dell’intero film».
Anche noi ci avventuriamo nella “foresta di simboli” di “Melancholia” e proviamo, dopo aver riassunto la trama del film, a farne una lettura non estetica o storico-critica, ma ermeneutica che punti alla interpretazione dei significati trasmessi dalle immagini.
“Melancholia” è un film, del 2011, diretto da Lars von Trier con Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte Rampling, Alexander Skarsgård, Stellan Skarsgård, Udo Kier, John Hurt, Brady Corbet. L’opera è stata scritta dal regista in un periodo di depressione e in essa si riflette chiaramente questo stato d’animo patologico dell’autore, ma trascende il caso particolare per esprimere valori simbolici generali che attengono al sentimento tragico della vita di fronte alla minaccia dell’apocalisse imminente dovuta alla collisione della Terra con il pianeta Melancholia.
Il film si apre con il preludio al Tristano e Isotta di Richard Wagner, prologo ad una dinamica narrativa in cui il sogno di un amore idealizzato e trasfigurato può realizzarsi, autenticamente, solo nella morte.
Il racconto poi si sviluppa in due parti.
Nella prima parte la protagonista della storia, Justine, è una ragazza apparentemente allegra e felice per il matrimonio appena celebrato, che arriva con il marito alla festa delle nozze organizzata dal cognato e dalla sorella Claire, la quale cerca di “tenere sotto controllo” ogni situazione. Nel corso della festa Justine cade in uno stato d’angoscia che la porta ad assumere comportamenti sconcertanti, dissacranti e anticonvenzionali (si apparta da sola in camera, respinge gli approcci del marito per poi avere un rapporto sessuale con un collega di lavoro, si licenzia dalla propria occupazione). La festa si conclude con l’abbandono del neomarito e con la fuga di Justine in cerca di conforto a casa della sorella.
La seconda parte del film è ambientata nella villa in cui vivono Claire, suo marito John e il figlio Leo, e di cui Justine è ospite. Incombe, sempre più minaccioso, il rischio della collisione della Terra con Melancholia, annunciata da eventi anomali. Lo stato di angoscia di fronte alla morte ormai inevitabile porta John a suicidarsi e getta Claire in uno stato di panico in cui solo la compagnia della sorella può esserle di sollievo. La richiesta insistente di Claire è quella dello “stare insieme”: “voglio che stiamo tutti insieme, magari sulla terrazza. Voglio farlo nel modo migliore. Un bicchiere di vino, insieme”. Ma la risposta di Justine è sprezzante “un po’ di musica? …Candele? … Cantiamo? … Con il vino?… Una bella stronzata”. Tutt’altro atteggiamento ha Justine nei confronti del piccolo Leo, piangente e sempre più impaurito. La zia accarezza e rincuora il nipote e ha con lui uno scambio di battute che segna una svolta nella struttura narrativa del film. “Ho paura che il pianeta ci colpirà sicuramente”. “Non aver paura”. “Papà diceva che non ci sarebbe nessun posto dove nascondersi” – replica il bambino. E Justine: “se ti ha detto questo è solo perché ha dimenticato un posto: io sono sicura che ha dimenticato la grotta magica”. Leo: “È una cosa che tutte le persone possono costruire?”. Justine replica che lei sa farlo. E si prepara, con l’aiuto del bambino, a costruire di questo luogo protettivo, che solo pochi sanno fare.
Il finale del film mette in scena Justine e Leo che costruiscono una “grotta magica” che dovrebbe salvarli dall’imminente collisione.
Le psicologie dei personaggi delle due sorelle sono tra loro conflittuali: Claire sembra essere la personalità più razionale, dotata di un forte carattere e di capacità organizzative con cui tiene tutto sotto controllo, ma di fronte all’incombere di un evento incontrollabile che non dipende da lei ogni sua sicurezza crolla e si scopre fragile e indifesa; al contrario, Justine ha una personalità fuori dagli schemi, angosciata da un male di vivere che sembra portarla verso il naufragio, ma che le permette di reagire positivamente davanti alla catastrofe.
Nel titolo di questo articolo abbiamo usato la categoria del “cinema profetico” per designare l’approccio critico al film, secondo un duplice significato contenuto nel concetto di profezia: predizione di eventi futuri e rivelazione di cose ignote che la mente umana non riesce a comprendere. Non c’è nessun rimando alla dimensione sacrale, che pure il termine possiede, relativa all’interpretazione di oracoli divini o all’annunciazione di messaggi ultraterreni. C’è invece il coinvolgimento di istanze esistenziali e morali che mettono in gioco, in un orizzonte tutto “terreno”, il sistema valoriale dei protagonisti.
Avviamoci a fare un primo esercizio interpretativo utilizzando la coppia di concetti natura/uomo. “Melancholia” mette a tema il fatto che in questo rapporto si può celare una verità sconvolgente: la scoperta che la natura nella sua potenza devastante può rivoltarsi contro l’uomo e perseguirne la distruzione.
Il tema ha una lunga e memorabile storia nella tradizione poetica. Eccone due esempi.
Oltre duemila anni fa Lucrezio, nella sua visione “scientifico-atomistica” della creazione del mondo e prima della descrizione di come l’uomo possa domare con immensa fatica la natura, si pone tre domande, che ci possiamo benissimo porre anche noi oggi nell’attuale tragedia pandemica (De rerum natura, libro V, vv.218-221):
Perché la natura in terra ed in mare tiene in vita ed accresce la terribile razza delle belve selvagge, nemica degli uomini?
Perché le stagioni nel loro ciclo annuale provocano le malattie?
Perché dilaga fra noi la morte prima del tempo?”
Due millenni dopo, non ignaro delle domande lucreziane, Giacomo Leopardi, nel Dialogo della natura e di un Islandese, esplicita il passaggio alla concezione del pessimismo cosmico in cui la natura si fa matrigna, e immagina l’incontro dell’Islandese, simbolo dell’umanità, con una figura di donna con il volto “tra il bello e il terribile”, personificazione della natura. A lei espone le sue lamentazioni per una condizione di vita gravata da asprezze climatiche, disastri naturali, malattie, epidemie, vecchiaia e tanti altri mali. La Natura così risponde: «Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro che alla felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.»
A proposito di questo tema della tensione dialettica tra natura e umanità, messo in scena da “Melancholia”, ha osservato Giancarlo Zappoli (www.mymovies.it): «Una Natura che in Von Trier è sempre “avanti” rispetto all’essere umano sia che avverta i segni di una catastrofe sia che ne anticipi la dissoluzione . Una ambiguità inquietante per lo spettatore, che si trova davanti all’interrogativo non risolto se la catastrofe sia, o non sia, un esito dovuto di un destino in cui il mondo meritava di dissolversi.
Come leggere il finale del film? L’esplosione della Terra è la definitiva vittoria della morte sulla vita? Oppure possiamo trovare un altro senso, meno nichilistico? Ancora Zappoli scrive: «Sulla complessità di un mondo che vorrebbe poter amare non riuscendoci, il regista danese fa intervenire il suo amore per l’Arte che si è data il compito di “leggere” per noi la realtà nel profondo». L’arte come via di salvezza. L’immaginazione più forte della realtà. La “grotta magica” immaginaria come luogo dell’anima che finisce per identificarsi con l’arte, con il cinema. Tornano in mente i versi delle “pseudo-Montale” citati all’inizio: Quel «gioco ai margini» della poesia che – una volta accettato il limite – diventa «segno intelleggibile / che può dare senso al tutto». La forma simbolica dell’arte – del cinema nella fattispecie – «è ludus precario, straniato e straniante. Che “può” dare senso. Ma anche non darlo. E dipende da me. Da te. Da ciascuno. A suo modo» (Caputo).
Ritornando al film, l’avvicinarsi della catastrofe, del male, disvela l’essere autentico dei protagonisti, con le loro angosce e le loro fragilità, ma anche con le loro capacità e le loro risorse.
Il confronto tra John e Justine è rivelatore di due opposti atteggiamenti morali, quello della resa e quello della resistenza.
John per fuggire dalla catastrofe sceglie di suicidarsi con il mix letale di farmaci: è un arrendersi davanti all’impotenza e alla disperazione.
Justine non si arrende, costruisce la “grotta magica” e lì crea le condizioni per ripristinare una convivenza umana degna di essere vissuta, dando una testimonianza di un’etica della responsabilità tradotta in atto. «Resiste perché ha già decostruito le illusioni ed elaborato il lutto della nostra finitezza. Il limite, l’incomprensione, il dolore, la malattia, la mortalità non sono “altro”, ma siamo noi. Se le persone intorno a lei guardano verso il cielo, terrorizzati da quello che potrà accadere, Justine, invece, non certo serena, ma consapevole, continua a “vivere” la terra» (Caputo).
Nella “grotta magica”, troviamo le due sorelle – Justine e Claire – e il figlio di Claire, Leo. La grotta è un rifugio immaginario che non può offrire alcuna protezione, una parvenza di capanna, fatta di fragili rami intrecciati, come intrecciate sono le mani dei tre protagonisti, impauriti ma ancora capaci di avvertire un sentimento di solidarietà e di amore.
Non necessariamente possiamo far consistere il messaggio profetico di “Melancholia” nella conclusione apocalittica della distruzione della Terra. L’ignorare come e quando finirà il mondo non ci esime dal pensare che nel momento drammatico della catastrofe, di ogni catastrofe, se ci saranno uomini e donne, bambini e adulti, che si stringeranno le mani e che si guarderanno negli occhi, anche senza dirsi una parola, allora la malattia della solitudine sarà sanata.
La lettura ermeneutica che suggerivo all’inizio dell’articolo ci spinge a cercare il senso profondo del film, che va oltre i fatti rappresentati, e che ci può far ritrovare, nel tempo della pandemia, un universo simbolico al centro del quale si trova il valore dello “stare insieme”.
MARIO MEROLA E LA CINE-SCENEGGIATA
di Mario Galeotti
“Non è più tra noi il sole di Napoli”, “Mario Merola, sei stato cento chili d’uomo e una tonnellata di voce”, “Napoli saluta Merola”, “Mario sei stato e resterai per sempre il re di Napoli, non ti dimenticheremo mai”… sono alcune delle frasi con le quali una folla commossa, radunata davanti alla Basilica di Santa Maria del Carmine, salutava Mario Merola nel giorno dei suoi funerali, il 14 novembre del 2006. Scomparso all’età di settantadue anni, Merola è stato uno dei maggiori interpreti della canzone napoletana, attore di film in una breve ma intensissima stagione cinematografica concentrata tra il 1978 e il 1984, e soprattutto conclamato re della sceneggiata, un genere teatrale popolare che appartiene alla storia di Napoli, snobbato dalla critica ma molto apprezzato dal pubblico, che Merola contribuì a riportare in auge a partire dalla metà degli anni Sessanta.

La sceneggiata: una forma di teatro intesa come “summa e sintesi di autentici squarci di vita genuina, vissuta e sofferta da un popolo candido e stoico che in questa rappresentazione scenica si riconosce, si identifica, e, pertanto, l’accoglie quasi con venerazione” (A. Sessa – A. Sebastiani, Sua Maestà Mario Merola leggenda della sceneggiata napoletana, International Artist Editore, Milano 1980, p. 38), quella che Franco Franchi ha definito “sintesi di una Napoli riflessa nel suo specchio forse più inclemente ma, certo, il più fedele”. Prendendo spunto da un brano musicale, in genere proposto dal protagonista sul finire della rappresentazione, la sceneggiata napoletana si basava su uno schema fisso, ripetitivo, un intreccio la cui linearità era protesa a rappresentare l’eterna lotta tra Bene e Male, a esaltare la bontà dell’eroe e condannare la malvagità del fetente: rispettivamente isso e ‘o malamente, ai quali si aggiungevano i personaggi femminili di essa (solitamente la moglie del protagonista buono, ma anche la sorella come nel caso della sceneggiata ‘A sciurara) e Chella sant’e mammà (l’anziana madre, la solenne istituzione che incarna la sacralità della famiglia e che, con incrollabile fede, si rivolge alla Madonna nella speranza di raddrizzare ogni stortura).
L’allora presidente della Regione Campania Antonio Bassolino, commentando la scomparsa del grande artista napoletano, disse ai giornalisti che “riconoscere la forza di Merola e della sceneggiata non vuol dire condividerne contenuti e messaggi, spesso negativi e reazionari, ma saper sentire che quel conflitto strutturale tra codice morale e sentimento individuale su cui si fonda il testo della sceneggiata è intimamente nostro, meridionale, popolare”. Altre personalità di spicco sfilarono davanti ai microfoni dei cronisti parlando di un “cantore della Napoli verace” (Clemente Mastella), “un ambasciatore positivo della migliore tradizione popolare napoletana” (Nicola Oddati, all’epoca assessore alla cultura), un “prepotente buono” come lo ha definito Rosa Russo Iervolino che aggiunse: “dobbiamo recuperare la guapparia nella misura in cui è orgoglio” (G. D’Avanzo, Se Merola diventa un eroe, in «La Repubblica», 15 novembre 2006). Guapperia, non tanto nella sua accezione storiografica di uomini che, come ha scritto Vittorio Paliotti, erano “veri e propri camorristi autonomi” (V. Paliotti, Storia della camorra dal Cinquecento ai nostri giorni, Newton & Compton Editori, Roma 2002, p. 169). Guapperia nel senso più romantico, quello espresso da molti personaggi di Merola, prepotenti buoni per l’appunto, dove un senso dell’onore, di giustizia e dei valori della famiglia adombrava l’aspetto criminoso, tollerato solo perché funzionale alla sopravvivenza di un popolo che storicamente ha sempre dovuto arrangiarsi. È per questo che, finita la recita e tornato alla realtà, il Mario Merola uomo continuava a ergersi a paladino dei poveri e a giustificare taluni comportamenti delinquenziali, ad esempio reclamando ad alta voce la sopravvivenza del contrabbando di sigarette, che offriva modesta sopravvivenza a tante persone che altrimenti, abbandonate a loro stesse, non avrebbero avuto altro mezzo di sostentamento. Ma mai oltrepassare una certa soglia e mai, nella maniera più assoluta, giustificare gli eccessi di una criminalità moderna senza scrupoli, efferata, che dagli anni Settanta andava perdendo ogni residuo di romanticismo.
Al cinema Mario Merola ha riproposto molte volte il personaggio del guappo buono, un eroe antieroe, singolare figura di camorrista dal cuore d’oro che ha connotato con successo quel filone partenopeo del genere poliziottesco ch’è stato definito per l’appunto “cinema guappo”. Ricordiamo alcuni titoli: “L’ultimo guappo” (1978), “Napoli… serenata calibro” 9 (1978), “Il mammasantissima” (1979), “I contrabbandieri di Santa Lucia” (1979), tutti concepiti dalla mente creativa di Ciro Ippolito e diretti da Alfonso Brescia.
Il poliziesco italiano degli anni Settanta, che gli osservatori del costume definirono in tono polemico e dispregiativo “poliziottesco”, è un genere sorto sui resti del declinante spaghetti western, di cui ha mantenuto in parte schemi e linguaggio trasferendoli nel clima teso degli anni di piombo ma che ha poi assunto una fisionomia più specifica, riproponendo le atmosfere mortifere di un momento storico carico di violenza e tensione, dominato dalla paura del terrorismo e della criminalità e da occulte trame del mondo della politica. A dispetto delle pessime critiche, che all’epoca lo tacciarono di qualunquismo destrorso, il poliziottesco rappresenta un utile specchio sociale di quegli anni, capace di coglierne la quotidianità, le ansie, le contraddizioni. Con un incasso di un miliardo e settecento milioni di lire, “La polizia ringrazia” di Stefano Vanzina è generalmente riconosciuto come il film che nel 1972 inaugurò il filone. Dietro la macchina da presa, da quel momento, si alternarono Enzo Girolami Castellari, Stelvio Massi, Marino Girolami, Fernando Di Leo, Mario Caiano. Ma accanto a pellicole qualitativamente ineccepibili, le richieste di un mercato in evidente ascesa portarono anche al proliferare di titoli a basso costo, a volte raffazzonati e di pessima fattura, realizzati da società di produzione che duravano solo il tempo di un unico film. In certi casi poteva trattarsi di prodotti concepiti essenzialmente per un mercato regionale, che puntavano già nel titolo sul richiamo esercitato dalla città in cui si svolgeva l’intreccio: Roma, Milano, Genova, Napoli.
Il campione d’incassi del sottogenere partenopeo che, come abbiamo detto, era noto come cinema guappo è stato senz’altro Mario Merola. Concepiti principalmente per i circuiti del meridione e realizzati con budget molto contenuti, i suoi film hanno registrato incassi da record e sono riusciti a superare i confini regionali del Sud d’Italia. Dopo tutto, era stato proprio Merola a portare la sceneggiata in trasferta e a decretarne il successo anche fuori da Napoli, nei principali teatri del Nord e all’estero. Anche nel “film guappo”, del resto, si innestavano schemi tipici della sceneggiata. Va detto inoltre che nella filmografia di Mario Merola, accanto a storie di guappi romantici e lotte di camorra, troviamo anche vere e proprie cine-sceneggiate, ovvero le trasposizioni per il grande schermo di alcuni dei cavalli di battaglia che Merola aveva replicato lungamente a teatro e che vedevano protagonisti onesti lavoratori dalla morale integerrima: l’infaticabile contadino di “Zappatore”, che dopo una vita di sacrifici corre a New York per redimere il figlio ingrato, o il magliaro di “Lacrime napulitane”, che vittima di un inganno ripudia la moglie per un tradimento che in realtà non c’è mai stato e decide di emigrare negli Stati Uniti.
Interpretazioni memorabili, che fecero dire a Carmelo Bene che Merola era “il più grande attore contemporaneo” perché riusciva a commuoverlo: “e se mi commuovo io significa che tu sei veramente il più grande”, gli disse di persona. Recensendo il film “Zappatore”, il critico Giovanni Buttafava aveva scritto: “Merola che arriva a far la paternale al figlio avvocato ingrato e perduto dietro le gonnelle piangendo, disperato e rabbioso, col suo formidabile faccione, e cesella antiche parole stereotipate di dolore con un’incredibile penetrazione, mentre il figlio bello e dannato si getta ai suoi piedi e tutto intorno si ferma nella melodia immortale è un pezzo che ha pochi uguali nel cinema musicale italiano” (M. Giusti, Dizionario dei film italiani stracult, Frassinelli, Milano 2004, p. 945).
Uno dei film più belli di Mario Merola è la trasposizione cinematografica di una sceneggiata tratta dalla canzone del 1930 ‘E figlie (di Libero Bovio e Ferdinando Albano). Diretto da Alfonso Brescia, soggetto e sceneggiatura di Gino Capone, “I figli… so’ pezzi ‘e core” (1981) ci offre un ritratto intenso e commovente della Napoli tristemente buona: non quella della camorra e della violenza, ma la Napoli pura del popolo, del vicolo, la Napoli degli stenti, dei mestieri di strada più strani, dell’arte furba dell’arrangiarsi, ma anche della solidarietà tra inguaiati, di quei diavoli che “sono buoni e leggeri come angeli” (A. Ghirelli, Una certa idea di Napoli, Mondadori, Milano 2010, p. 11), la Napoli della gente che parla animatamente, che discute, che litiga, ma che finiti gli schiamazzi si prodiga con tutte le forze per aiutare l’altro, la Napoli delle lacrime facili, dei buoni sentimenti… il cuore pulsante della Napoli autentica abitata da quel “popolo vero, folto, oscuro” di cui aveva parlato Matilde Serao quasi un secolo prima (M. Serao, Il ventre di Napoli, Avagliano Editore, Roma 2009, p. 177).
L’angusto cortile su cui si affacciano vecchi palazzi di quel ventre di Napoli ancora intatto, e dove non manca l’edicola votiva dedicata al santo protettore, racchiude una piccola e variopinta umanità – a tratti divertente, a tratti malinconica – che fa da corollario indispensabile ai protagonisti della storia: il femminiello (Ernst Thole, attore di origini olandesi morto nel 1988 a soli trentacinque anni), aspirante mago e sensitivo dalla dubbia mascolinità, che rientra a casa all’alba e di giorno si riposa; l’onnipresente portinaia, donna Assunta (Anna Walter), e sua figlia Maria Stella (Michela Miti); Vincenzo Cacace (Carlo Giuffré), un trafficone playboy inseguito dagli ufficiali giudiziari; Maria (Gloriana), la sua compagna; Nicola (Gianni Ciardo), il giovane e timido professore spiantato, che non ha mai i soldi per pagare l’affitto, innamorato follemente di Maria Stella; donna Concetta (Rosalia Maggio), sufficientemente benestante, attempata e sola, con la fissa della cartomanzia. Si affacciano tutti sullo stesso cortile e, tra un battibecco e l’altro, condividono gioie e dolori, miserie e allegrie, segreti, bugie, magagne di tutti i giorni, notizie belle e altre brutte. È l’esempio di quella “promiscuità mediterranea”, tipica anche di altre città, di cui ha parlato Marcello Ravveduto: condizione che ha dato vita per secoli ad una “cultura di vicinato tra nobili e plebe, tra borghesi e proletari: risiedono entrambi nel centro storico della città condividendo i ristretti ed angusti spazi urbani, i comportamenti abituali, il dialetto come lingua, i rituali religiosi e le superstizioni. Si stringono legami di solidarietà che traggono linfa dal vissuto quotidiano e dalle condizioni di precarietà degli abitanti del centro storico. Anche grazie alla conformazione fisica dei luoghi si riescono a tutelare le attività illegali da possibili denunce esterne” (M. Ravveduto, Napoli… Serenata calibro 9. Storia e immagini della camorra tra cinema, sceneggiata e neomelodici, Liguori Editore, Napoli 2007, p. 17).
Nel variegato microcosmo napoletano che popola il film “I figli… so’ pezzi ‘e core” c’è anche Tommaso Maffettone, che ha il volto bonario di Mario Merola. Tommaso sbarca il lunario come cantastorie di strada, con una pianola a manovella montata su carrettino: uno degli antichi mestieri di strada sorti e proliferati su quell’innata predisposizione napoletana a sceneggiare che non si trova solo nel teatro, ma anche nella vita quotidiana. Ad aiutarlo c’è la moglie Matilde (Anna Maria Ackermann). Il loro lavoro è quello di portare musica e allegria in mezzo ai vicoli. Quando arrivano con il loro carretto, la gente si raduna attorno, le persiane si spalancano e chi apprezza lancia una moneta.
Il più grande desiderio di Tommaso e Matilde è quello di completare la famiglia con un figlio, ma non riescono ad averne e neanche ad adottarne uno. Un giorno, mentre sono per la strada ad allietare con la musica i passanti, la donna ha un malore. Consultato il medico, si scopre con stupore che finalmente Matilde è rimasta incinta. Tutti accolgono la notizia con grande gioia. I vicini di casa le si stringono attorno, con un istinto solidale tutto partenopeo che aveva fatto dire alla Serao, parlando proprio delle donne in gravidanza: “appena una donna incinta si ferma in una via, tutti quelli che mangiano o che vendono qualche cosa da mangiare, senza che ella mostri nessun desiderio, gliene fanno parte, la obbligano a prenderlo, non vogliono avere lo scrupolo” (M. Serao, Il ventre di Napoli, cit., p. 96).
Arriva il tanto atteso momento del parto. Quando sua moglie ha le doglie, Tommaso è fuori casa. La raggiunge in ospedale. Trascorse tre ore, non si hanno ancora notizie e l’uomo comincia seriamente a preoccuparsi. Poi viene a sapere che ci sono state complicazioni, che ha perso il bimbo e che non sarà mai più nelle condizioni di avere figli perché i medici sono stati costretti ad asportarle tutto. Matilde, invece, è convinta di aver dato alla luce un bel maschietto. Tommaso non ha il coraggio di dirle la verità, almeno per il momento.
La soluzione sembra arrivare quando l’ostetrica (Clara Colosimo, attrice di teatro e brava caratterista in molti film tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta) propone a Tommaso Maffettone di prendersi un neonato la cui mamma è morta durante il parto e del cui padre non si conosce l’identità. Per rassicurarlo sull’eventualità di future rivendicazioni, la levatrice racconta che il padre e tutti gli altri parenti sono deceduti nell’ultimo terremoto, anche se non è vero. Discutono della delicata questione seduti su una panca della cappella dell’ospedale. La donna, tutt’altro che disinteressata, mette in chiaro che ci vogliono soldi per poter portare a compimento senza problemi questo illecito: occorre pagare il silenzio e la connivenza di tante persone. Lui, lo sappiamo, non ha denaro, campa alla giornata. E così, Tommaso decide di accettare la proposta di un antiquario, che giorni addietro gli aveva offerto due milioni per il suo bel carretto musicale ereditato dal nonno. Formalizzato l’accordo, il nascituro viene consegnato alla coppia, Matilde non sospetta nulla e la presenza del bel bimbo fa sorgere istinti materni anche nelle altre donne del caseggiato, soprattutto in Maria, che senza alcuna speranza vorrebbe un bambino da Cacace.
Sprovvisto di pianola, Tommaso inizia a lavorare alla giornata come scaricatore di porto. Ma è dura, non sempre c’è lavoro. Il tempo passa, Feliciello (questo il nome dato al bambino) compie due anni. La coppia è felice, l’arrivo di un figlio ha portato una gioia immensa, ma Tommaso e Matilde si barcamenano tra stenti e sacrifici. Una sera, per lasciare la cena al marito, la donna dice di aver già mangiato, ma in realtà è a digiuno e quando la brava donna Concetta – sempre secondo quella legge napoletana di carità e amore per il vicino – suona alla porta per offrire alla famiglia Maffettone un bel piatto di polpette avanzate, Matilde comincia a divorarle con voracità.
La malasorte si accanisce sulla povera coppia. Mentre Tommaso è al porto, Matilde ha un mancamento e viene ricoverata d’urgenza. Sul letto d’ospedale, sentendo che ormai la fine è vicina, la donna raccomanda al marito di prendersi cura di Feliciello e confessa che, per istinto, sapeva che non si trattava veramente del loro figlio ma lo ha sempre amato come se fosse stato sangue del suo sangue.
Matilde è morta, ma la vita continua. Il bambino è cresciuto e ha quasi dieci anni (il piccolo attore che lo interpreta è Michele Esposito), va a scuola, vive col padre e la sera si esibisce insieme a lui nei ristoranti: Tommaso canta e suona la chitarra, Feliciello lo accompagna con la fisarmonica. Una delle canzoni che sentiamo nel film è Io, na chitarra e ‘a luna (di E. A. Mario).
Il padre biologico di Feliciello, il facoltoso Lorenzo Berisi (Ivan Rassimov), tornato a Napoli dopo molti anni di lontananza vuole trovare suo figlio. Dopo essere riuscito a risalire all’ostetrica dell’ospedale, le offre una lauta ricompensa per riavere il bambino nonostante non se ne sia mai preoccupato. Quando la levatrice, sempre attratta dai soldi, si reca a casa di Tommaso per confessargli la verità, e cioè che il padre naturale non era morto e che ora reclama il proprio figlio, lui non vuole sentire discussioni e caccia via la donna in malo modo chiamandola “stronza”. Ma l’increscioso episodio lo ha sconvolto e Tommaso viene assalito da una febbre alta. Quella sera Feliciello è costretto ad andare a suonare nelle trattorie da solo e chiede a donna Concetta di badare a suo padre, il suo vero padre, quello che lo ha cresciuto con tanto amore e sacrificio e al quale è tanto affezionato. L’altro padre, quello che non se n’è mai preso cura, sta cenando proprio nel ristorante dove il piccolo Feliciello intrattiene i clienti con la malinconica Chiove (di Nardella – Bovio). Lo avvicina, gli parla, capisce che il figlio è proprio lui.
Arriva il giorno della Prima Comunione, che come in altri film di Merola non è solo un sacramento della religione cattolica, ma è anche un momento di unione, che rinsalda ulteriormente i rapporti famigliari. Ed è il giorno nel quale indossare il vestito che Feliciello aveva visto nella vetrina del negozio e che, nonostante costasse la cifra esosa di cinquantasettemila lire, Tommaso non ha esitato a comprargli impegnandosi l’anello. Ora, in un giorno che dovrebbe essere di festa, al mattino sotto casa arriva Berisi accompagnato dagli avvocati e dal giudice per rivendicare la paternità del bambino e portarlo via per sempre. Tutto il vicinato scende in cortile e si stringe attorno a Tommaso Maffettone che, costernato e smarrito, canta ‘E figlie, il grido di dolore di un uomo che ha tutte le ragioni per ritenersi l’unico vero padre di Feliciello, ma che è anche consapevole di non potersi opporre a quanto stabilito dalla legge. Gli amici si commuovono, piangono, e sulla bella e straziante canzone finisce il film.
Nel quartiere dove il 6 aprile del 1934 era nato Mario Merola, Sant’Anna alle Paludi sezione Mercato, gli è stata dedicata una targa commemorativa con bassorilievo, realizzata da Domenico Sepe, su cui è incisa la scritta “A Mario Merola ambasciatore della canzone napoletana nel mondo”, accompagnata da un messaggio di commiato: “v’aggio voluto bene… penzateme”… vi ho voluto bene… pensatemi!

Ma nel caso di un personaggio carismatico come Merola, uno degli ultimi veri baluardi dell’orgoglio napoletano, vengono alla mente anche le parole che Francesco II di Borbone, l’ultimo re delle Due Sicilie, aveva rivolto al suo popolo durante l’assedio di Gaeta, alla fine del 1860, poco tempo prima di arrendersi ai piemontesi: “Io sono napoletano, nato tra voi, non ho respirato altra aria, non ho veduto altri paesi, non conosco altro che il suolo natio. Tutte le mie affezioni sono dentro il Regno: i vostri costumi sono i miei costumi, la vostra lingua la mia lingua, le vostre ambizioni mie ambizioni”.
MAKE UP
CRAXI E CRAXI
Breve nota sul trucco di Pierfrancesco Favino in “Hammamet”
di Tullio Masoni
“Hammamet” ha avuto successo per la rievocazione della vicenda umana e politica che ha segnato la fine della Prima Repubblica o per la “popolarità” che, nel bene e nel male, il personaggio Craxi ha fissato in un tempo lungo? Per la vicinanza con la cronaca nazionale, che aveva già favorito “Il Traditore” di Bellocchio, o per la scommessa di Amelio: dal pubblico al privato, dal protagonismo in patria al ritiro tunisino? A questi e altri motivi, che possono avere influito va aggiunto, credo, il trucco fisiognomico cui Favino si è sottoposto per entrare nel ruolo. Cinque ore al giorno per “indossare” una maschera prodigiosa, essere un Craxi finto perfettamente uguale al Craxi vero, con ciò regalando ai giornali, alla TV, dunque al pubblico, un clamoroso gioco di raffronto.

Il trucco, come è noto, si deve ad Andrea Leanza e ai suoi collaboratori. Leanza ha studiato per oltre un anno il volto di Craxi e, all’appuntamento col set, è arrivato dopo una infinità di prove. Inutile dilungarsi sull’esito: già appassionato di dinosauri, ma da qualche tempo del ritratto, il truccatore – l’artigiano/artista – ha fatto un lavoro magnifico.
Ciò premesso, una domanda assai impegnativa rimane: dove è finito Pierfrancesco Favino? Interrogato da più parti in proposito l’attore ha paragonato la sparizione della propria faccia dietro quella di Craxi a quella degli attori nel teatro greco che, appunto, recitavano con la maschera, cioè adottando dall’inizio il carattere fisso del personaggio.
Favino ha parlato, quindi, di un impegno superiore al consueto per la concentrazione e lo sforzo di mutuare finzione da realtà e viceversa. Una spiegazione suggestiva, ma non sufficiente a cancellare una sorta di disagio. L’attore protagonista di “Hammamet” può apparire infatti come dimezzato, cioè professionalmente abile nel riprodurre la gestualità di Craxi – uno scrupoloso studio dei reperti visivi – ma, per così dire, decapitato. Il teatro della Grecia antica? No, Dopo quasi due secoli di verosimiglianza il richiamo non è pertinente. L’exploit del trucco fisiognomico che si confonde coi valori recitativi sembra perciò affermare la maschera quale risorsa espressiva nuova e unica, ormai indispensabile per il biopic, ma non solo.
Fino a oggi le somiglianze erano cercate attraverso interventi parziali che consentivano di riconoscere la mimica facciale dell’attore e, al tempo stesso, alludevano alla memoria del personaggio; d’ora in poi la somiglianza potrebbe essere affidata esclusivamente all’opera di specialisti (creatori) sempre più bravi ma fatalmente “separati”: non più, per loro, il creare figure fantastiche di genere, ma un trionfo della somiglianza dal vero, cioè un pesante e pignolo “naturalismo” che limita l’attore fino a identificarlo con la maschera.
A chi è convinto che tutto questo faccia parte della storia spettacolare del cinema, e alle sue provvidenziali impurità, vorrei portare il solo esempio del Roberto Hedrlitzka in “Buongiorno notte”. Quell’attore/personaggio penalizza la figura di Aldo Moro, o invece la prova tiene assieme il valore della memoria con quello dell’interprete e della sua specifica ricerca? A una simile domanda, il Favino di “Hammamet” e altri che verranno, non potrebbero dare risposta.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
DOPO LA SCOMPARSA, RICORDI E TESTIMONIANZE SU MASSIMO MAISETTI
di Paolo Micalizzi

Il 31 gennaio del 2020 è scomparso Massimo Maisetti, uomo dalla grande passione per il cinema, figura importante della FEDIC di cui è stato anche Presidente dal 1993 al 2012. Era conosciuto anche al di fuori di questa Federazione per la sua attività di critico(era socio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) ed è stato presente per molti anni alla Mostra di Venezia ,soprattutto al Forum Fedic, da me curato, incentrato su argomenti volti al Futuro del Cortometraggio, un settore per il quale Massimo Maisetti si è prodigato tanto partecipando anche , come chi scrive, alle battaglie delle Associazioni come la FICE per un maggiore riconoscimento legislativo. All’Associazionismo Massimo Maisetti credeva fortemente ed io che da anni rappresentavo la FEDIC nel novero delle 9 Associazioni di Cultura Cinematografica riconosciute dal MIBACT, ho avuto da lui un sostegno convinto e deciso nelle iniziative che venivano intraprese a livello culturale, l’AICA per esempio, ed in quelle per una maggiore operatività delle stesse a livello nazionale.
A Massimo Maisetti ho dedicato un Dossier in suo ricordo con la collaborazione di Maria Teresa Caburosso, che è stato pubblicato sul numero del 9 febbraio 2020 di Fedic Magazine, il nuovo Notiziario della FEDIC.
Nell’introdurre il Dossier ho sottolineato come Massimo sia stato un Presidente FEDIC, pieno di energie e di interessi che appena incominciava una cosa stava già pensando a come iniziarne un’altra. Ed era anche un uomo di grande capacità oratoria desideroso con molto entusiasmo di trasmettere nei giovani l’amore per il cinema e per la cultura. Massimo, prima di incontrarlo personalmente, l’ho conosciuto attraverso i suoi saggi, molto approfonditi, come quelli su il colore nel cinema, Ingmar Bergman, il cinema d’animazione italiano, quello delle Repubbliche Sovietiche, del cinema d’animazione cecoslovacco, ungherese, bulgaro, svizzero. Un settore, quello del cinema d’animazione, che portava avanti, con entusiasmo, attraverso l’ISCA (Istituto per lo Studio del Cinema di Animazione). Attività che nel 20° anniversario della Fondazione di questo Istituto gli valse da parte del Comune di Milano, l’Ambrogino d’Oro, riconoscimento di cui andava molto fiero, come ricorda anche il figlio Marco. Il suo rapporto con la FEDIC inizia nel 1975. Da qui un lungo percorso che lo vide diventare Presidente FEDIC dal 1993 al 2012. Ed è con questo suo ruolo che io, che nella FEDIC operavo già dal 1960 prima come socio del Cineclub Ferrara e poi come critico cinematografico ed operatore culturale, inizio con lui un’intensa attività che mi vede al suo fianco nella Direzione Artistica del Festival di Montecatini e nelle iniziative che dal 1993 porto avanti alla Mostra di Venezia: Premio e Forum FEDIC, di cui lui era un convinto sostenitore. Importanti sono i suoi scritti elaborati per tante iniziative FEDIC e, mi auguro, di poterne offrire prima possibile un’Antologia da pubblicare su Carte di Cinema. Ma importante è stata anche la Rassegna Cinema e Psicoanalisi, portata avanti a Milano. Nel Dossier, toccante è il ricordo della moglie Franca che lo ringrazia “per tutti gli anni vissuti insieme, per quanto hai fatto per rendere la mia vita la più ricca possibile di emozioni, di esperienze piene di sempre nuovo sapere”. Ma anche quello del figlio Marco che sottolinea quei giusti comportamenti di Massimo Maisetti che più volte abbiamo visto. Marco ricorda anche un altro comportamento conosciuto da chi lo ha visto operare in tanti anni di FEDIC, “quando era in buona salute e parlava alle platee con l’entusiasmo di chi amava ciò che faceva, seguendo le sue passioni”. Poi il ricordo di Maria Teresa Caburosso , con la quale Massimo “aveva condiviso molti interessi: dal Festival di Dervio, al Valdarno Cinema, a FilmVideo di Montecatini, alla gestione della FEDIC”. “La mia libreria, continua Maria Teresa, è piena di tutto il materiale prodotto insieme” e ricorda quanto gli è stata d’aiuto quando ha scritto i libri di testo per la materia che insegnava: mi ha sempre incoraggiata e ha sempre dimostrato di credere nelle mie capacità, più di quanto non ci credessi io”.

Il Dossier contiene Testimonianze di amici FEDIC con i quali Massimo aveva rapporti di collaborazione e di stima. Ma anche dei Presidenti dell’Associazionismo con i quali condivideva le battaglie per un giusto riconoscimento di un maggior ruolo nell’ambito del Cinema italiano. Tra le testimonianze pervenute anche quella del regista Bruno Bozzetto per il quale Massimo ha organizzato più volte delle iniziative che riguardavano il suo cinema d’animazione. Un genere di cinema che Massimo valorizzava con la creazione, insieme ad alcuni studiosi ed illustri Autori come Bruno Bozzetto, Lele Luzzati, Osvaldo Cavandoli e Nedo Zanotti, dell’ISCA. M anche con rassegne, e relative pubblicazioni, dedicate al cinema d’animazione delle Repubbliche Sovietiche che ha presentato in Russia a Mosca e Pietroburgo, e nelle Repubbliche, tra cui Kiev e Tbilisi, dove ha stabilito rapporti d’amicizia con i migliori autori del cinema d’animazione. Esperienze trasferite in Italia, favorendo così la conoscenza di quelle cinematografie.
Un Dossier che ho elaborato con affettuosa amicizia e come giusto riconoscimento ad un uomo di cultura con il quale ho condiviso numerosi momenti importanti della vita culturale della FEDIC.
ADDIO MASSIMO!


FEDIC SCUOLA FILM FESTIVAL A CARRARA
di Laura Biggi
Presso il Cinema Garibaldi di Carrara, unica sala cinematografica della città apuana, il 15 novembre scorso si è tenuta la giornata conclusiva del Fedic Scuola Film Festival. (XVI ed)
L’edificio imponente, costruito in epoca fascista, presenta l’esterno interamente rivestito in marmo bianco di Carrara, aspetto certamente originale e suggestivo e ben diverso da quello di una moderna multisala.
La capienza, di oltre 450 posti tra platea e galleria, è stata appena sufficiente a contenere il numeroso pubblico, prevalentemente scolastico, pervenuto da ogni parte d’Italia.

I cortometraggi finalisti e premiati sono stati visionati e selezionati da una giuria tecnica presieduta dal regista Luigi Parisi e composta da Nino Celeste, direttore della fotografia e Ludovico Orlandi giovane esperto di cinema. Inoltre è stata attivata una giuria popolare formata da diverse classi di scuola secondaria della provincia di Massa Carrara che ha assegnato un premio.
Come docente ed autore di cortometraggi posso ritenermi più che soddisfatta sia del livello tecnico espressivo delle opere pervenute, sia dello svolgimento della stessa manifestazione che si è rivelata dinamica e partecipata. Frequentando Festival, ormai da molti anni, mi è capitato di far notare a qualche organizzatore l’assenza di una specifica sezione dedicata alla cinematografia scolastica. Mi è stato risposto, in più occasioni, che non volevano rischiare di abbassare il livello qualitativo della selezione filmica in concorso. Affermazione che, personalmente, non riesco a condividere. Onestamente il rischio può essere reale se non si attua una selezione seria e con determinati parametri. Negli ultimi anni, ed in particolare in questa edizione del Festival, ho notato una grande evoluzione tecnica, probabilmente dovuta anche al fatto che alcuni istituti scolastici abbiano avuto accesso a finanziamenti piuttosto cospicui tramite bandi nazionali o europei e si siano quindi affidati ad esperti del settore, che affiancando i docenti, hanno realizzato film apprezzabili.
Oltre l’aspetto prettamente tecnico vengono valutati anche il tema trattato e la capacità comunicativa dell’opera.

Il pubblico in sala ha apprezzato molto il film “Lost in prato” dell’istituto GramscI- Keyns Prato insegnante Cocchi al quale è stato assegnato il Premio Giuria Scolastica consegnato da Pio Bruno Presidente del Cineclub Fedic Cagliari.
Di seguito i premi assegnati con le relative motivazioni.
Premio Impegno Sociale
“Rifugio” Scuola Media Balletti di Quattro Castella (RE) insegnante Settembrino
Per l’idea intelligente dell’argomento trattato e per l’eccellente riuscita corale degli studenti che hanno dimostrato un’alchimia di recitazione sempre attenta e mai banale.
La scuola “Balletti” da anni promuove un corso extracurricolare di cinema e produce cortometraggi.
Molto applaudito il film “1440” realizzato dal giovanissimo autore Fausto Alongi di 15 anni che lo ha scritto, diretto ed interpretato con risorse proprie e la collaborazione di due coetanei, uno dei quali ha creato la colonna sonora.
Premio Primo Ciak Il Cinema che cresce a Fausto Alongi per il film “1440” Liceo Scientifico Palmi (RC)
Per il soggetto originale e per aver realizzato senza mezzi prosumer, un’opera non professionalmente impeccabile ma valida sul piano dell’impegno e del coraggio dimostrato.
Molto suggestivo il film realizzato da una scuola primaria ligure e che tratta il tema della disabilità. La scolaresca e l’insegnante purtroppo non hanno potuto essere presenti per ritirare il premio.
Premio Inclusione Sociale
“Perfection” I.C Taggia, Imperia
Basato su uno stile semplice ma diretto, attraverso un linguaggio preciso, si evidenzia un messaggio profondo sulla “diversità” che cattura e scalda il cuore.
Premio Fiction Tema Libero
“Lib(e)ri” Scuola Superiore Scarpa Mattei di Verona insegnante Dalla Valle
La narrazione dell’opera scorre senza troppe distrazioni verso un finale fiabesco e sognante. Ottima la scenografia e lo studio di alcune sequenze statiche e dinamiche esercitate dalla macchina da presa.
Premio Miglior Corto
“Cristallo” Liceo Classico Minghetti Bologna insegnante Iacondini
Consegna il premio il regista Luigi Parisi Presidente di giuria
Si nota uno spiccato senso fotografico e registico professionale, con inquadrature studiate e movimenti di macchina eseguiti secondo una grammatica esemplare del linguaggio cinematografico. Ottima anche la recitazione e la direzione degli attori.
Nel primo pomeriggio si è tenuto un focus sul cinema di animazione a cura di Nedo Zanotti, storico autore Fedic che ha realizzato anche la grafica per la locandina dell’evento “Il cinema che cresce”. Nedo ha presentato alcuni suoi corti che sebbene datati risultano ancora attuali.
A seguire si è tenuta la proiezione del pluripremiato film “Rwanda” alla presenza del direttore della fotografia Riccardo Salvetti che ha dialogato con il pubblico.


UN NUOVO NOTIZIARIO FEDIC:
FEDIC MAGAZINE
di Giuseppe Mallozzi
Da 71 anni la Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub, una delle nove associazioni di cultura cinematografica riconosciute dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali, oltre a fare promozione porta avanti la produzione di opere cinematografiche (dai 50 ai 100 all’anno), per la maggior parte cortometraggi.
Le opere dei soci, oltre a partecipare a festival nazionali e internazionali, rappresentano l’Italia al Festival Mondiale “Unica”, riportando lusinghieri consensi e moltissimi riconoscimenti. Le opere, inoltre, entrano a far parte della Cineteca Nazionale Fedic, fornita di migliaia di titoli, dagli anni ’50 ad oggi, sia in pellicola (che sono in fase di digitalizzazione, dando priorità agli autori italiani) che in digitale, disponibili non solo per i soci, ma per chiunque ne faccia richiesta (studiosi, appassionati, operatori culturali). Nel 2017 la sua gestione è stata affidata all’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea – Centro Sperimentale di Cinematografia. La Fedic cerca di valorizzare i film dei propri Soci, sia favorendo la realizzazione di compilation (da presentare nei Cineclub e anche all’esterno), sia creando situazioni ad hoc.
Inoltre, attraverso i suoi Cineclub sparsi in tutta Italia, organizza convegni, seminari, concorsi, rassegne, festival nazionali e internazionali; coordina, anche tramite le Consulte Regionali, il lavoro delle Associazioni federate; valorizza la cultura dell’immagine nelle scuole, con un volontariato.
Proprio per far conoscere a un pubblico più ampio tutte queste importanti attività, lo scorso anno, nel cruciale anniversario del 70esimo compleanno, è nato l’organo di informazione “Fedic Magazine”, un quindicinale pubblicato direttamente sul web nel quale vengono veicolate le notizie provenienti dai Cineclub oltre che informazione più in generale riguardante il cinema italiano e internazionale.
Direttore del nuovo organo di stampa è il giornalista, critico e storico del cinema Paolo Micalizzi, mentre la redazione è affidata al giornalista Giuseppe Mallozzi, presidente del Cineclub “Il Sogno di Ulisse” di Minturno (LT).

“Stiamo portando avanti un discorso di evoluzione della nostra Federazione – spiega il presidente Fedic Lorenzo Caravello – attualizzandola ai tempi che corrono. Era pertanto necessario pensare a un nuovo modo di informare e comunicare utilizzando gli strumenti tecnologici a nostra disposizione. Un passaggio obbligato era chiaramente quello di utilizzare il web. Per questo, seppur a malincuore, lo scorso anno il consiglio direttivo ha votato per una evoluzione del nostro organo di informazione, il “nuovo Fedic Notizie”, gestito sapientemente da Giorgio Sabbatini negli anni passati. Si tratta di un vero e proprio aggiornamento, creando una versione online, più performante e utilizzabile con i cellulari. Siamo al lavoro per la costituzione di una redazione con collaboratori fissi, ai quali si affiancheranno le varie comunicazioni provenienti dai cineclub”.
“Ci auguriamo – prosegue Caravello – che diventi un veicolo per attirare nuovi associati, che potranno leggere tutte le nostre iniziative. Grazie alla disponibilità di tutti i Cineclub che inviano le proprie notizie su eventi e ogni attività svolta, il sito è aggiornato quotidianamente e viene inviata una newsletter quindicinale con gli ultimi articoli pubblicati”.
Tra gli articoli già pubblicati figurano lo speciale dedicato a Massimo Maisetti, già presidente Fedic, attivissimo sulla promozione cinematografica. Scrive Paolo Micalizzi nel suo ricordo all’interno dello speciale: “La Presidenza della Fedic gli viene attribuita nel 1993. Ed è in questo ruolo che io inizio con lui una intensa collaborazione che mi vede al suo fianco (insieme a Claudio Bertieri, a Floriana Maudente e a Ernesto G. Laura) anche nella Direzione Artistica del Festival di Montecatini e che lo vedo sostenermi nella Direzione Artistica di Valdarno Cinema Fedic. In quegli anni ho il suo sostegno anche in due iniziative, da me curate, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: dal 1993 il Premio Fedic e dal 1995 il Forum Fedic. Un’attività quest’ultima volta a ‘Il futuro del cortometraggio d’autore’ con l’approfondimento, anno per anno, di tematiche utili alla sua conoscenza ed alla divulgazione, affrontando anche il problema del finanziamento ai cortometraggi, della loro distribuzione e della loro circuitazione”.
Ma non mancano articoli dedicati ai soci più longevi, come Nino Giansiracusa che lo scorso 10 marzo ha compiuto la veneranda età di 100 anni. Per il suo impegno come filmmaker e come presidente del Cineclub Milano la Fedic gli ha donato una statuetta dorata del tutto simile all’Oscar americano al compimento dei suoi 90 anni. A 10 anni di distanza è stato festeggiato con una Targa al merito.
Oppure altri scritti riguardanti la presenza di artisti importanti al Valdarno Cinema Fedic come Michelangelo Antonioni che 25 anni fa – dopo aver ricevuto l’Oscar alla Carriera – è stato premiato con il Premio Marzocco. Un altro bel ricordo è quello dedicato all’attrice fiorentina Ilaria Occhini, scomparsa lo scorso anno, che ha ricevuto il “Marzocco d’Oro” nel 2009 al Valdarno Cinema Fedic in occasione della presentazione del film di Federico Bondi “Mar Nero” di cui è protagonista. Oppure quello dedicato al grandissimo attore Rutger Hauer, il replicante Roy di “Blade Runner”, anch’egli scomparso l’anno scorso, che ha ricevuto a “FilmVideo 2004” l’Airone d’Oro. Alla 55^ Mostra Internazionale del Cortometraggio di Montecatini Terme l’attore olandese ha presentato il suo corto “The room” da lui diretto nel 2001, e fu proiettato il making “Prosit Ermanno” (30’) di “La leggenda del santo bevitore” di Ermanno Olmi, tratto dal romanzo di Joseph Roth, in cui riveste il ruolo di un alcolizzato ex minatore che vive come un barbone a Parigi. In quell’occasione, Rutger Hauer ha tenuto un workshop con filmmaker partecipanti al festival portandoli alla realizzazione di un cortometraggio.
Insomma, il Fedic Magazine informa sulla vitalità di una Federazione, la Fedic, che oggi si affaccia al mondo, così frenetico e tecnologico, ma senza dimenticare il suo glorioso passato.
FESTIVAL ED EVENTI

IL TFF CONTINUA AD ESSERE UN VALIDO PUNTO DI RIFERIMENTO CINEFILO
di Paolo Micalizzi
È un film islandese il vincitore della 37^ edizione del TFF – Torino Film Festival. Si tratta di “Hvìtur, Hvìtur Dagur/A white, white day” che prende l’avvio da una macchina che precipita da una scogliera con a bordo la moglie di un poliziotto. Il quale, mentre prosegue nelle sue investigazioni per capire l’accaduto, continua ossessivamente a ristrutturare la casa di famiglia. Un film, soprattutto, sulla vite esistenziale di un uomo e le sue ossessioni, pur non trascurando il lato patologico del dolore. Ha ricevuto un premio di 18.000 euro.
.

Riferendoci soltanto ai premi principali, da segnalare il Premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo(7.000 euro) al film tunisino “La Réve de Noura” della regista Hinde Boujemaa, che racconta di una donna costretta dalla legge tunisina a vivere con il marito, uscito dal carcere, dal quale vorrebbe divorziare. Un film in cui è tracciato un forte ritratto di una donna che lotta per la propria emancipazione in una società profondamente repressiva: ha ricevuto anche il Premio FIPRESCI della Stampa cinematografica internazionale. Premio per la migliore sceneggiatura al film “Wet season” di Anthony Chen’s incentrato sull’amicizia tra una giovane cinese che insegna in un liceo di Singapore ed uno studente, l’unico interessato alla sua materia. Un film ambientato nella stagione dei monsoni in cui i due protagonisti sono osservati con pudore nelle loro emozioni e nello sforzo di liberarsi dalla solitudine. Premio del pubblico al film “Ms. white light” dello statunitense Paul Shoulberg. Protagonista una giovane donna che ha il dono particolare di saper entrare in empatia con le persone che muoiono. Un dono che è diventato un mestiere gestito con il padre, ma quando è messo in discussione da una nuova cliente le cose sono destinate a cambiare. L’Italia entra nel Palmarès con l’attribuzione come migliori attori a Giuseppe Battiston e Stefano Fresi nel film “Il grande passo” di Antonio Padovan. Il film è incentrato sulla storia di due fratelli che non si erano mai incontrati, a causa delle vicende familiari. Uno, Mario (Stefano Fresi) vive a Roma e l’altro, Dario (Giuseppe Battiston) nella nebbia del Polesine. Uno ha un negozio, l’altro, che nel suo paese è considerato “il matto”. vuole andare sulla luna. Un giorno Mario riceve dal Veneto la telefonata di un avvocato che lo avverte che Dario è accusato di incendio doloso al campo del vicino e rischia il carcere o il manicomio, a meno che qualche parente non si occupi di lui. Mario lo raggiunge ed i due fratelli, con il passare dei giorni, impareranno a comprendersi. Una bella storia, con toni di favola.
Nella sezione “Internazionale. Doc” il premio (6.000 euro) per il miglior film è stato attribuito a “143 Rue du desert” di Hassen Ferhani, dove prendono vita storie e racconti che nascono nelle conversazioni che avvengono nel punto di ristoro, gestito da una donna, tra camionisti, viaggiatori e vagabondi che attraversano il Sahara. La sezione “Italiana.Doc” vede vincitore (6.000 euro) “Fuori tutto” di Gianluca Matarrese che racconta una storia personale che riguarda la sua famiglia che ogni mattina si sveglia nella propria casa di Torino senza sapere cosa inventarsi per pagare i debiti della Cooperativa di calzature che avevano fondato nei primi anni. Non è solo un racconto, quello del regista, ma anche una sua riflessione sulla situazione che si è determinata. Premio miglior cortometraggio (2.000 euro) a “Spera Teresa” di Damiano Giacomelli, storia di una cantante disabile, determinata a diventare qualcuno nel mondo della musica tradizionale, malgrado le varie difficoltà che dovrà affrontare.
Ma il TFF era arricchito di tante proposte di grande interesse cinefilo. Ha reso omaggio al regista Mario Soldati con “Viaggio nella valle del Po (Alla ricerca dei cibi genuini)” trasmesso dalla televisione in 13 puntate di 30 minuti ciascuno dal 3 dicembre 1957 al 4 marzo 1958. Il TFF lo ha riproposto nella sezione Festa mobile nell’iniziativa “Soldati’s day”. La quinta puntata del programma è interamente dedicata alla scoperta del Po, cantato, immaginato, raccontato, raffigurato, dipinto, scolpito. Rappresentando l’immagine di un Mississipi italiano e di una pianura come il west americano, scenari fantastici di un proliferare di arti: cinema, pittura, fotografia, architettura, musica. Proiettato anche il film “La provinciale” (1953) che descrive un soffocante ambiente di provincia e le ipocrisie nascoste sotto una facciata di perbenismo attraverso la storia di Gemma (una convincente Gina Lollobrigida in una delle sue interpretazioni migliori), figlia di un affittacamere, che non potendo sposare l’uomo che ama, suo fratellastro segreto, va a nozze con una persona che non ama e si lascia invischiare nelle manovre di una losca contessa che si installa in casa sua.
È il film più interessante di Mario Soldati e costituisce un ottimo esempio di post-neorealismo borghese. È tratto da un racconto di Alberto Moravia, ed alla letteratura s’ispira anche “Malombra” (1942) tratto dal romanzo di Antonio Fogazzaro. Protagonista è Marina di Malombra, segregata in una villa sul lago di Como che impazzisce e crede che in lei si sia incarnata una zia defunta. Per vendicare l’antenata uccide lo zio, poi uno scrittore che credeva di amare ed infine si toglierà la vita allo stesso modo della parente. Una storia drammatica inquietante, ora surreale, ora crepuscolare, dall’atmosfera suggestiva. Un capolavoro del “cinema calligrafico” che precedette il neorealismo. Un movimento al quale appartiene l’altro film presentato al 37° Torino Film Festival, “Fuga in Francia” (1948) in cui un gerarca fascista, condannato a morte, cerca di passare clandestinamente il confine alpino.” Uno dei capolavori, secondo Paolo Mereghetti, che gridano vendetta al cielo per la dimenticanza a cui è stato costretto”. Un giusto risarcimento critico a Mario Soldati.
Un grande interesse ha registrato poi la sezione “Si può fare”, un’ampia Retrospettiva dedicata all’Horror classico. Testimone di quel periodo l’attrice Barbara Steele, “Regina del terrore”, protagonista di una affollata Conferenza Stampa e di un incontro per presentare il film “L’orribile segreto del Dr. Hichcock” (1962) di Riccardo Freda, dove lei è la giovane sposa di un vedovo necrofilo. Ma al TFF è stato possibile vederla anche in altri due cult movie come “La maschera del demonio” (1960) di Mario Bava dove appare nelle vesti di una strega giustiziata che si risveglia dal sonno mortale e compie una serie di orrendi delitti e “Il pozzo e il pendolo“ (1961) di Roger Corman dove è il fantasma di una moglie sepolta viva che va e viene dalla tomba. Ma in questa sezione, altri classici : da “Il gabinetto del dottor Caligari” (1920) di Robert Wiene a “Nosferatu- Il vampiro”(1922) di F.W.Murnau, da “Il fantasma dell’opera”, quello del 1925 con Lon Chaney, di Rupert Julian a “La mummia” (1932) di Karl Freund con l’indimenticabile Boris Karloff, ma anche i film di Tod Browing(“Freaks”, 1932 e “La bambola del diavolo”,1936), quelli di Jacques Tourneur( “Il bacio della pantera”,1942 e “Ho camminato con uno zombi”, 1943) oltre ad alcuni film su Frankenstein ed altri mostri come quello della laguna nera di Jack Arnold o il Dracula di Terence Fisher.
Non mancano, giustamente, il film di Roman Polanski “Rosemary’s Baby” (1968) e “Toby Dammit”, episodio di Federico Fellini per “Tre passi nel delirio” (1968) che comprende anche due episodi dovuti a Luis Malle e Roger Vadim: un piccolo capolavoro, quello di Fellini, interpretato da Terence Stamp.
Ma in Rassegna vi erano altre opere significative di questo genere cinematografico: in totale era composta da 36 film.
Come sempre, il TFF ha continuato ad essere un valido punto di riferimento cinefilo, molto seguito.

CORTINAMETRAGGIO, PRIMO FESTIVAL ONLINE IN TEMPO DI CORONAVIRUS
di Paolo Micalizzi
Il Coronavirus ha fermato alcuni Festival del cinema importanti, in primis quello di Cannes, ma non ha fermato Cortinametraggio perché la vulcanica e combattiva Maddalena Mayneri, Presidente di questo Festival di cui è stata l’ideatrice quindici edizioni fa, non si è per niente arresa di fronte all’imperversare della tragedia che ha colpito l’Italia, e non solo. Il “suo” Festival l’ha fatto online, ed è stato il primo in Italia, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura, per contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive. Ed è stato un gran successo.

Le cinque serate, presentate da Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli, hanno avuto una media di 50.000 visualizzazioni giornaliere sul sito del Festival, con una finestra dedicata, e in contemporanea, su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono arrivate non solo dall’Italia ma anche dal resto del mondo, spaziando tra l’Europa e l’America. Per il Premio miglior Corto assoluto-Aermec, la Giuria (Cinzia Th Torrini, Caterina Shulha, Francesco Foti, Nicola Giuliano, Salvatore Allocca) ha scelto “Anne” di Stefano Malchiodi e Domenico Croce, ispirato alla vera storia di James Leininger, un bambino americano che, fin dalla tenera età, mostrava di avere ricordi di una vita passata. E molti di questi ricordi, incredibilmente, sembravano combaciare con le vicende di un personaggio realmente esistito, il pilota di aviazione James Huston II, morto durante la battaglia di Iwo Jima nel 1945.
Un Cortometraggio premiato “per essere riuscito, attraverso un uso originale del linguaggio filmico, mescolando materiali d’archivio con scene ricostruite e fotogrammi dipinti a proporre un emozionante racconto spazio temporale”. “Anne” ha anche vinto il Premio Anec-Fice che darà al corto la distribuzione in 450 sale cinematografiche d’essai. Ed ha anche vinto il Premio Rai Cinema Channel RaiPlay al “corto” più Web. La giuria ha anche attribuito alcune Menzioni speciali. A “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere l’educazione sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazie di un racconto privo di moralismi o paternalismi e che sembra invece provenire dall’interno del mondo che rappresenta”; a “Il nostro tempo” di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”. Ma anche a “Il primo Giorno di Matilde” di Rosario Capozzolo con la motivazione “Un corto che ha raccontato in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De Filippis”. Una menzione speciale anche per “Pizzaboy” di Gianluca Zonta perché “il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo”. Una quinta Menzione speciale è andata a “Osuba” di Federico Marsicano “per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e nero della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che la soluzione la si può trovare andando a ritroso e bloccando per tempo gli aggressori”.
Premio del Pubblico-Lotus Production, ex aequo, a “La Regina si addormenta dove vuole” di Lorenzo Tiberia, “Punto di rottura” di Janet De Nardis e “A cup of Coffee with Marilyn” di Alessandra Gonnella che ricostruisce l’episodio della giovane Oriana Fallaci che nel 1956 venne mandata in America per un’inchiesta su Hollywood: voleva intervistare Marilyn Monroe ma non ci riuscì; ma è stata quell’inchiesta a farla diventare la più grande giornalista italiana conosciuta nel mondo. Il Premio Viva Production come Miglior attrice l’ha conquistato Margherita Rebeggiani per il corto “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt “per la grazia, dolcezza , timidezza e innocenza trasmesse con una naturalezza che lascia presagire una prossima e fulminante carriera”: lo stesso tipo di Premio assegnato invece al miglior attore è stato appannaggio di Giga Imedadze per il corto “Pizza Boy” di Gianluca Zonta “ per aver interpretato al meglio un ruolo non privo di insidie e pericoli”: è Saba, un ragazzo di origine georgiana, che lavora a Bologna come porta pizza e che avendo ricevuto, durante il turno serale , la notizia che sta per nascere suo figlio, costretto a finire le consegne attraverserà la città nella speranza di arrivare in tempo all’ospedale. Anche questo è un ex aequo con Teodosio Barresi di ”Stardust” di Antonio Andrisano “per la creazione di un carattere che fa breccia nel cuore subito”, quello di Teodosio dalla genuina onestà. Premio per la migliore Fotografia a Benjamin Manenti per “L’alleato” di Elio Di Pace, per la migliore Colonna sonora a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto ”A Cup of Coffee with Marilyn” e quello per i migliori Dialoghi-Cinemaitaliano.info a Paola Minaccioni per il corto” “Offro io” che vince anche il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award. Premiato anche come miglior corto in Sala, in partnership con Vision Distribution, “L’amica del cuore” di Sara Donatella Cardillo.
Cortinametraggio è un Festival che dà spazio anche Ai Videoclip Musicali. Miglior Videoclip Mainstream è stato giudicato “E’ sempre bello” di Coez per la regia degli Younuts (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), mentre una Menzione speciale è andata a “Settembre” di Gazzella diretto da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri. Premio Miglior Videoclip Underground- I Santi di Diso è andato a “Immensità” di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino ed una Menzione speciale della Giuria a “Sad Vicious” di Theo diretto da Tommy Antonini.
La Direzione di Cortinametraggio ha poi dato alcuni Premi speciali. Il Premio Bagus va a “Osuba” di Federico Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’ ma per una consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per migliorare il proprio presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la violenza non ha colori, ‘Osuba’ ferma lo spettatore in un finale che è solo l’inizio di un grande e necessario cambiamento”.
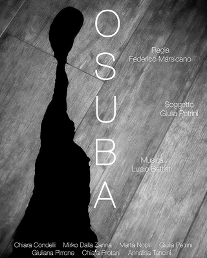
Attribuito anche il Premio Camilleri, nato quest’anno per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista. È dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Cortinametraggio l’ha attribuito a Ester Pantano, interprete e co-protagonista della serie tv Imma Tataranni. Altri ancora i Premi attribuiti
Cortinametraggio, un Festival, giunto alla XV edizione, che continua a registrare grande interesse nel Panorama del Cinema Italiano.
RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2019
di Maria Pia Cinelli
Stando al film di apertura del 19° River to River Florence Indian Film Festival il cielo è rosa. Così lo dipinge un bambino in “The sky is pink” della regista di origini bengalesi Shonali Bose che ha dato il via alla kermesse. Narrato dalla protagonista post mortem e ispirato a una storia vera, il melodramma segue per due decenni le vicissitudini dei Chaudhary, famiglia medio-borghese di Delhi con due figli, il maschio in buona salute e la minore affetta da una rara malattia genetica che la toglierà ai suoi cari a soli 19 anni [1]. L’attenzione della Bose – che ha ella stessa perso un figlio adolescente – è rivolta alle ripercussioni che una situazione critica ha sul rapporto di coppia e sulle dinamiche familiari e alla ricerca di una normalità quando il futuro non è dato, facendo particolarmente leva sulla figura materna, ruolo rivestito dalla star Priyanka Chopra Jonas, qui anche produttrice.

Rosa è altresì il colore che ha caratterizzato il concorso dell’abituale appuntamento con il cinema e la cultura indiani svoltosi dal 5 al 10 dicembre 2019 nel capoluogo toscano, sia per l’incidenza muliebre quanto a regia e scrittura, sia per i temi spesso legati all’universo femminile ma – similmente al film citato – non sempre si è associato a circostanze lievi e spensierate, virando più verso il rosso dal quale nasce, simbolo sì di passione e forza vitale ma anche di violenza.
Di violenza, reale e simbolica, legata a costumi atavici parla “The last color”, opera prima di Vikas Khanna – chef stellato celebre nel mondo dello show cooking – tratta dal suo romanzo omonimo. Ambientata intorno al 1989 a Varanasi (o Benares, la città sacra dell’induismo) la pellicola mette a fuoco due realtà ahimè ancora presenti: gli orfani abbandonati a se stessi e le vedove private dei loro diritti e costrette in una sorta di ricoveri, i cosiddetti ashram [2]. Povertà, solitudine, emarginazione sono comuni a Chhoty, bimba di strada che si guadagna la vita vendendo fiori o esibendosi come funambola, in cerca di denaro per pagarsi una scuola, e Noor, vedova internata perennemente vestita di bianco secondo la tradizione, due reiette che da un incontro casuale sviluppano un rapporto affettivo di sostegno reciproco. Centrale nel film – a suo tempo in gara per la nomination agli Oscar 2020 – è l’Holi festival, la festa indù dei colori che celebra l’inizio della primavera, all’epoca dei fatti ancora preclusa alle vedove. Nel finale, con un salto temporale al 2013 dopo che tale divieto è stato rimosso dalla Corte Suprema [3], quando finalmente anche i sari bianchi scendono in strada trasformandosi in tavolozze da pittore fra lanci di polveri colorate e petali di fiore, si ha un notevole impatto visivo, in un film peraltro molto attento all’immagine, sebbene il suo punto di forza restino le interpreti, una sorprendente Aqsa Siddiqui per la piccola – in una performance che ricorda un po’ la Lila bambina della serie tv “L’amica geniale” – e per Noor l’attrice di lungo corso Neena Gupta.

Un altro brillante esordio è costituito da “Hellaro (The Outburst)”, prodotto dall’industria filmica del Gujarat[4] e scritto e diretto da Abhishek Shah, al battesimo dietro la macchina da presa dopo quasi un ventennio di esperienze teatrali, radiofoniche e di direttore di casting per il cinema. Anche in questo caso il regista sceglie l’impegno sociale e si concentra sulla condizione femminile narrando la presa di coscienza contro il patriarcato e la superstizione da parte di un gruppo di donne in un villaggio del Kutch afflitto dalla siccità ormai assuefatte alle restrizioni, che risultano invece ardue da assimilare per la giovane Manjhri, appena giunta dalla città in seguito al matrimonio. Relegate in casa e dedite unicamente alla cura del focolare – persino la garba [5], danza propiziatrice della pioggia in favore della dea Amba, è una prerogativa maschile, mentre per loro vale il digiuno – vivono un momento di libertà e socializzazione solo nelle due ore mattutine in cui si recano tutte insieme a raccogliere l’acqua. L’inizio della trasgressione arriva grazie all’incontro con un musicista forestiero che salvano dall’arsura e alla spinta di Manjhri a mettersi a ballare al suono del suo dhol[6]; la danza diventa un’abitudine quotidiana e la liberazione del corpo nei movimenti tersicorei apre il cammino verso una nuova consapevolezza. Se la vicenda sembra appartenere a un passato remoto, l’annuncio via radio dello stato di emergenza [7] la colloca invece nel 1975, ma situazioni simili non sono rare neppure oggi in molte parti del mondo. Laureatosi vincitore del “River to River” 2019 “Hellaro (The Outburst)” eragià stato insignito nell’agosto precedente del prestigioso Indian National Film Award [8] come miglior lungometraggio in assoluto, riconoscimento che la cinematografia gujarati si è aggiudicata per la prima volta nella sua storia.
Anche la vivace commedia “Badhaai Ho (Congratulations!)” può vantare un Indian National Film Award in quanto trionfatrice nella categoria riservata all’intrattenimento popolare. L’opera seconda del regista Amit Sharma prende a pretesto la gravidanza di una donna di mezza età con figli adulti e adolescenti per ironizzare sull’atteggiamento dell’indiano medio nei confronti dell’eros. Le esilaranti situazioni d’imbarazzo che si creano a livello sociale e familiare – in particolare la fatica del primogenito ad accettare dei genitori ancora amanti – rivelano che nella patria del Kama Sutra il sesso è perlopiù associato alla fase riproduttiva e giudicato sconveniente per i capelli brizzolati, specie quando l’attivismo erotico viene palesato da una pancia in crescita. Nei panni della gestante tardiva ritroviamo Neena Gupta, volto noto del grande e piccolo schermo, che molti ricorderanno come la nipote Abha nel “Gandhi” di Attenborough.
Il divo per eccellenza e leggenda vivente Amitabh Bachchan compare invece nel thriller giudiziario “Badla (Revenge)”, rifacimento del successo spagnolo del 2016 “Contratiempo” di Oriol Paulo, di cui anche il nostro Stefano Mordini ha realizzato un remake nel 2018, “Il testimone invisibile”. Analogamente al film italiano il regista Sujoy Ghosh ha rispettato fedelmente la struttura dell’originale limitandosi a a inserire qualche rimando alla cultura indiana e a declinare i ruoli principali all’inverso, vale a dire al maschile per l’avvocato (Bachan) e al femminile per la presunta omicida, impersonata da Taapsee Pannu.
Nientemeno che un intero cast stellare, perfettamente amalgamato, è quello che sostiene “Basu Paribaar (The Bose family)” del veterano Suman Ghosh, dramma di natura teatrale ispirato al racconto joyciano “I morti”, che riflette sulle problematiche della famiglia odierna viste attraverso il vissuto dei singoli componenti, riunitisi per le nozze d’oro dei Basu. Un film di stampo classico che ben rappresenta la cinematografia bengalese e include la presenza di due sue pietre miliari: Aparna Sen, che unisce alla recitazione una prolifica carriera registica, e l’attore feticcio di Satyajit Ray, il Soumitra Chatterjee protagonista della Trilogia di Apu nonché indimenticabile Amal di “Charulata”.

Al contrario l’ucraina Dar Gai (Daria Gaikalova) – convertitasi alla settima arte dopo il trasferimento in India ma con una lunga gavetta di palcoscenico in patria – per il suo secondo lungometraggio “Namdev Bhau: in Search of Silence” ha scelto un uomo comune per dar vita a un personaggio del quale condivide nome e professione. Con una recitazione pressoché muta e alquanto espressiva, il non-attore restituisce con immediatezza il ritratto dell’autista sessantacinquenne esasperato dai rumori di Mumbai, dal chiacchiericcio casalingo e dalle continue telefonate del datore di lavoro, che un bel giorno smette di parlare e parte per la Silent Valley sull’Himalaya, dove il suono si avvicina agli zero decibel, incontrando però lungo il cammino un ragazzino petulante deciso a percorrere insieme buona parte del viaggio. Piccolo film indipendente, girato con una troupe ridotta e impreziosito dalle musiche del nostro Andrea Guerra, si sofferma sulla necessità di quietare la nostra mente e offre un particolare sguardo esterno sulle contraddizioni locali.
Troviamo di nuovo una donna al timone di “My Home India” eletto miglior documentario di questa edizione, in cui Anjali Bhushan porta alla luce la figura di Kira Banasinska, moglie del primo console generale a Bombay del governo polacco in esilio, e del suo impegno umanitario. Venuta a conoscenza nel 1942 della presenza in Iran di molti suoi connazionali fuoriusciti dai campi di lavoro siberiani dopo l’invasione tedesca della Russia, come operatrice della Croce Rossa Kira mise in piedi un’organizzazione per inviare aiuti ai profughi indigenti e trasferirne parte in India. Fu così che a Valivade nel distretto di Kolhoupur, stato del Maharashtra, sorse la cosiddetta Little Poland, un centro di accoglienza con case, scuole, negozi, giardini e una chiesa, che permise ad oltre 5.000 rifugiati una vita dignitosa fino alla loro partenza nel 1948. Per difficoltà a reperire i fondi la Bhushan – attiva in vari settori dell’audiovisivo – ha impiegato diversi anni per portare a termine il suo mediometraggio, che alternando raro materiale d’archivio e testimonianze dei superstiti ricorda un esempio di solidarietà da tener presente in tempi di aridità assistenziale.

Rispetto ai film di finzione la presenza femminile alla regia è stata più incisiva nei documentari in concorso, che ha ospitato anche “Kandurwan (Backing History)” di Mehvish Rather dedicato ai fornai del Kashmir che producono il pane secondo un’antica ricetta, “Indian Space Dreams” di Sue Subdury sull’industria aerospaziale di Mumbai e l’esordio di Saadgi Gupta “Not for Display” che analizza il rapporto delle donne indiane con la biancheria intima.

Per quanto riguarda i cortometraggi, accanto al vincitore “Seher” del regista Sachin Aggarwal – dove un guasto al motore genera un’inaspettata confidenza fra il conducente di un taxi e la sua passeggera – sono proprio le filmmaker a svettare per messa in scena e scrittura: Meera Krishnamurthy con l’animazione“A flowering tree” basata su una leggenda popolare, Myriam Raja che vanta una nomination ai Bafta britannici 2020 per “Azaar”, racconto di formazione della preadolescente del titolo in un piccolo villaggio isolato e senza uomini a causa della guerra, diretto con un grande senso dell’immagine, infine Shazia Iqbal autrice di “Bebaak (Dying wind in her Hair)”. Nel suo corto la Iqbal descrive il conflitto fra tradizione e modernità dal punto di vista individuo versus autorità ispirandosi alla storia vera di una studentessa bisognosa, ritenuta non osservante dei principi islamici dall’ente religioso che può concederle una borsa di studio ed è pertanto invitata a mettere il velo e imparare a mente i versetti del Corano in vista di un nuovo colloquio. Non sarà facile scegliere se restare fedele alle proprie idee o cedere al compromesso per costruirsi un futuro, ma saprà prendere la decisione migliore poiché – come la madre del film di apertura rassicura il figlio ammonito a scuola per aver tinto il cielo di rosa – il cielo può essere di qualsiasi colore. Sta a noi trovare la giusta sfumatura.
NOTE
1. Aisha Chaudhary era una scrittrice (My Little Epiphanies – 2015) e oratrice motivazionale di Delhi, molto nota in patria. Affetta da SCID (immunodeficienza combinata grave) ereditata dai genitori, entrambi portatori sani che avevano già perso un’altra figlia neonata per la stessa ragione. È scomparsa nel 2015 in seguito a una fibrosi polmonare.
2. Si stima che il numero di donne deprivate dei loro beni e esiliate dalle proprie famiglie dopo la morte del marito si aggiri sui 40 milioni. Il fenomeno e più diffuso nell’India settentrionale, maggiormente nella città di Vrindavan nello stato dell’Uttar Pradesh, lo stesso di Varanasi.
3. Con una sentenza del 2012 la Corte Suprema indiana, in un’ottica di lotta alle disuguaglianze, oltre alla rimozione del divieto citato ha esortato il governo a prendersi cura in modo appropriato delle vedove hindu nelle case di accoglienza, ma il processo è molto lento.
4. Noto anche come Gollywood o Dhollywood il Gujarati Cinema, nello stato del Gujarat, è una delle più importanti industrie regionali, fondata dall’inizio del novecento e con al suo attivo oltre un migliaio di film.
5. Garba (dal sanscrito Garbha che significa grembo) è una danza tradizionale del Gujarat, di solito ballata in cerchio al centro del quale viene posta una lampada.
6. Strumento a percussione originario dell’India settentrionale.
7. Per far fronte alle insorte spinte secessioniste con relativi scioperi e proteste nel 1975 la Gandhi indisse lo stato di emergenza nazionale, unitamente alla promulgazione di leggi speciali che tra l’altro annullarono la sua recente condanna per brogli elettorali.
8. Fra i premi cinematografici indiani di maggior importanza, se non il principale, i Film Awards – istituiti nel 1954 – sono paragonabili agli Academy Awards statunitensi.
APPUNTI DI UN CINEFILO FEDIC
LA FESTA DEL CINEMA A ROMA….
È PROPRIO UNA FESTA
di Luciano Volpi
“Alcune cose sono come domande. Passa un minuto, o anni, e la vita risponde”
ALESSANDRO BARICCO

La quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si è svolta dal 17 al 27 ottobre 2019 all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale, è stata un ulteriore successo sia di pubblico pagante, di accreditati e di visitatori. La struttura firmata da Renzo Piano, fulcro della manifestazione, ha ospitato proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Festa si sono trasformati in uno dei più grandi Red Carpet al mondo.
Ho potuto rilevare con mio interesse che le Sezioni da vedere erano tante e lo Staff organizzativo composto da persone valide del cinema.

Quello che più colpisce di questa manifestazione è la sua evoluzione nel corso di cinque anni. Nessuno scimmiottamento con Cannes e Venezia, eventi culturali con personaggi sempre di rilievo che lasciano spazio alle novità.
Gli Incontri Ravvicinati con vari personaggi sono stati il motore di tutta la Festa, per la gioia di tutto il pubblico, fatto di moltissimi giovani studenti del settore Cinema ma anche di appassionati paganti ed accreditati oltre ai giornalisti. Ospiti della festa: Bill Murray, Viola Davis, Ethan Coen, Edward Norton, Ron Howard, Bret Easton Ellis, John Travolta (nella foto sotto).

Tutti gli anni novità, quest’anno due: Duel e Fedeltà/Tradimenti.
Non conosco i dati ufficiali ma sembra che abbiano incontrato molta curiosità di argomenti trattati in Duel, come riavvicinamento a vecchi film, il cinema in generale ed i suoi protagonisti. Per ora una bella nicchia all’interno della manifestazione.
Per Fedeltà/Tradimenti, la partecipazione di autori e personalità del mondo della cultura e del cinema per commentare la trasposizione cinematografica di celebri opere letterarie divenute film, ha dato quel tocco di qualità alla manifestazione stessa.
Le retrospettive, Omaggi e Restauri ed I Film della nostra vita, hanno visto protagonisti in ordine Max Ophuls e Kore-Eda Hirokazu alla Casa del Cinema a Villa Borghese quindi in piena città ed a ingresso libero anche se con poche centinaia di posti ed al Maxxi con altrettanto successo anche perché vicino alla Festa con pubblico però pagante.
I Film della nostra vita. Come ogni anno, il Direttore Artistico, i membri del Comitato di Selezione ed il responsabile delle stesse, hanno condiviso con il pubblico, ad ingresso gratuito, una breve rassegna di film che hanno segnato la loro passione per il cinema; dopo il western, il musical, il noir, è stata la volta della comedy screwbal, la commedia sofisticata statunitense degli anni Trenta e Quaranta. Grande successo degli appassionati presso la Casa del Cinema.
Omaggi e Restauri. Quest’anno è stato reso omaggio al grande costumista Piero Tosi, recentemente scomparso, con le proiezioni di tre film di cui ha curato i costumi: “Ludwig” e “Gruppo di famiglia in un interno” di Luchino Visconti e “Metello” di Mauro Bolognini.
All’interno dei locali della Festa, RomaLazio Film Commission, si è svolta la XII Edizione di Cinecampus Lezioni di Cinema moderati da Steve Della Casa e la IV Edizione di
Cinecampus atelier Professioni Cinematografiche moderata da Mario Tani.
Grande successo di pubblico, che per la maggior parte erano visitatori della Festa, grazie ad una bella location molto visibile e di passaggio strategico: massiccia partecipazione di artisti, attori e attrici sia di teatro che di cinema, oltre a scrittori registi, politici impegnati nei Ministeri, Presidenti di Associazioni di Cinema e personaggi della Televisione. Rileggendo il programma sulla bellissima brochure, è veramente una iniziativa premiante in tutti i sensi. Non solo di facile accesso e condivisione ma per la vasta area di discussioni e temi che abbraccia è da seguire e cercare di non perdere nemmeno un incontro, data l’alta qualità tematica proposta. Per chi scrive come me ed ha partecipato alla Festa con la visione di quasi cinquanta film in maggioranza Selezione Ufficiale e Tutti ne Parlano, con qualche altro passaggio fra Incontri Ravvicinati, Conferenze Stampa e Riflessi, tale meritevole proposta è stata solo sfiorata, ma conoscendo Steve Della casa non ho potuto fare altro che congratularmi per la ennesima dimostrazione di come sia possibile parlare e far conoscere il mondo cinematografico e chi lo circonda.
Alcuni temi e partecipanti: Masterclass di Gabriella Pession; Gree Movie Award sulla figura di Antonio Cederna; Artmedia Cinema e Scuola: immagini personaggi storie percorsi di cinema per studenti; presentazione libro Buio in sala; Masterclass di Amos Gitai; Anteprima nazionale cortometraggio Eclissi; presentazione Cinemadamare iniziativa a sostegno dei giovani filmaker italiani; La Pellicola D’Oro – Mestieri e Artigiani del Cinema Italiano ha presentato “ La produzione e le aziende cinematografiche “; Premio Nazionale Elio Petri.

Tra le opere che ho visto, mi piace segnalare in modo particolare.
“Motherless Brooklyn”, film di apertura di e con Edward Norton. Se non è Oscar ci va vicino.
“Pavarotti” (foto sotto), un bel documentario di Ron Howard sul celebre tenore.

“Downton Abbey”di Michael Engler bel film da vedere sotto tutti i sensi cinematografici, film che consigliamo di non perdere assolutamente da andare a vedere al cinema, soprattutto se si è stati dei fan della serie tv.
Tra i film che consiglio di vedere se saranno programmati in Italia, “The Farewell”, film cino-americano con solo attori cinesi; “1982”, storia veritiera fra Libano ed Israele: coinvolge ed appassiona; il film macedone “Willow”. Purtroppo non capiterà di vedere il film inglese “Military Wives”. Meritevole da vedere è il film italiano “Il ladro di giorni”, Guido Lombardi, a cui va il mio plauso.
“The Irishman”, in particolare, merita un commento: un mega cast stellare (De Niro, Al Pacino, Joe Pesci) e la regia di quel mostro sacro di Martin Scorsese. Spettacolosa storia vera descritta nei minimi particolari (tre ore che passano velocissime), c’è tutto quello che ci deve essere in un film. Netflix non ha badato a spese perché c’è il ritorno sicuro e qui ci sono sicuramente più Oscar.

Visti anche: “Deux”, film francese di Filippo Meneghetti, da vedere e rivedere più volte; “Trois jours et une vie” di Nicolas Boukhrief. È un film francese/belga tra i migliori della Festa.
“In the Footsteps of Bruce Chatwin”, nella mia speciale classifica il migliore visto. Werner Herzog non poteva fare meglio nel raccontare lo scrittore e viaggiatore suo amico e la loro ultima storia commovente di viaggi e fotografie sulle tribù del Sahara. Ispirato alla vita nomade, storie perdute, tradizioni aborigene, dinosauri, viandanti e sognatori che ci trasportano alla primordialità.
Dalla Patagonia al Galles fino all’Australia in omaggio ad uno dei più grandi scrittori del 900.

“Judy” , film inglese di Rupert Goold sulla vita di Judy Garland con un magnifica Renée Zellweger da Oscar.


“Waves”, film Statunitense di Trey Edward Shults. Bellissimo film che, a detta di Antonio Monda, può vincere qualche Oscar.
“Were’s My Roy Cohn?”, film sulla vita di questo personaggio demagogo ed insulso che ha imperversato nellla politica americana. Triller/Documentario che ti lascia attonito ed incredulo che possano esistere tali figure, anche se attuale.
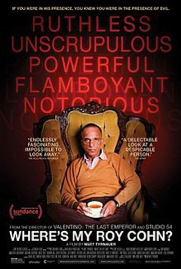
Matt Tyrnauer ha diretto “Where’s my Roy Cohn?”, documentario su uno degli uomini americani più controversi della storia. La pellicola, nella selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2019, ripercorre la vita di Roy Cohn, avvocato spietato e senza scrupoli, nonché importante mediatore politico. Consulente capo del senatore McCarthy e avvocato personale di Trump tra il 1973 e il 1985, Cohn fu radiato dall’ordine nel 1986 per condotta non etica e morì poco dopo per AIDS.
Il documentario pone, con il suo titolo, un interrogativo, al quale risponderà con la ricostruzione dei fatti: Cohn è ancora oggi presente tra gli oscuri fili che collegano la politica americana. Una politica reazionaria e violenta che ha plasmato l’attuale situazione statunitense, portando Trump al potere. Roy Cohn ha impersonato le arti oscure della politica americana del ventesimo secolo, lavorando al fianco di pericolosi demagoghi, quali il senatore Joseph McCarthy. Congegnato come un thriller, il documentario svela e ricostruisce le origini dell’ascesa di una destra reazionaria e violenta, rivelando come un manipolatore, scaltro e profondamente instabile abbia contribuito a plasmare l’attuale situazione degli Stati Uniti, scommettendo sul futuro di Donald J. Trump.
“438 Days” bel film svedese sulla storia di due giornalisti catturati fra Somalia ed Etiopia nel 2011. Il calvario degli interminabili giorni, che il titolo riporta in evidenza, viene riassunto nei fatti salienti che hanno portato alla cattura dei due reporter svedesi Martin Schibbye e Johan Persson, e nell’odissea processual-giudiziaria che coinvolse i due accusati e l’ambasciata del paese scandinavo, protesa a far liberare dalla carcerazione in Etiopia i due giornalisti. Giunti clandestinamente nel paese africano con l’intento di documentare le verità che si celavano dietro una industria petrolifera locale in stretti rapporti di business con la Svezia, i due rimangono vittime di una imboscata che li vede cedere all’esercito, e poi arrestare con false accuse di terrorismo e trasporto di sostanze illecite.
“Le meilleur reste à venir” altro film francese che ha sbancato quest’anno a Roma. Il duo A .de La Patellière e M. Delaporte ha fatto un capolavoro. Fabrice Luchini e Patrick Bruel hanno preso dieci minuti di applausi alla serata di presentazione con il cast in sala.


“Run with the Hunted”, ennesimo bel film statunitense.
“Your Honor”, un complicato film estone-russo.
“Western Stars” di Thom Zimny e Bruce Springsteen film-documentario di moda girato molto bene. La sensazione è di essere seduto al concerto per pochi intimi in una cascina riammodernata in Arizona, intervallata dal commento di Bruce con filmati bellissimi dei luoghi che raccontano la sua vita. Dice Bruce: «Questo album è un ritorno alle mie registrazioni da solista, con canzoni ispirate ai personaggi e con travolgenti, cinematografici arrangiamenti orchestrali. È un gioiello di disco». Un film, un documentario, un concerto, una riflessione personale sulla vita, l’età, l’amore diviso in 13 canzoni.

“Fete de Famille”, altro bel film francese con una splendida Catherine Deneuve, che è da vedere sempre.
“On Air”, documentario Belga su una storia vera della Radio Publique Africana, il suo direttore e la lotta per la libertà del Burundi.
“Santa Subito” di Alessandro Piva. Documentario su Santa Scorese che ha vinto la 14esima Edizione Premio del pubblico BNL.
“Tornare” di Cristina Comencini, bel film italiano girato molto bene con i bravissimi Giovanna Mezzogiorno e Vincenzo Amato.
Dice Cristina Comencini: “Tornare” è un ‘thriller dell’anima’, ed è utile sapere che ciò che è raccontato è una sorta di percorso psicanalitico della protagonista all’interno della propria memoria, perché consente di accettare, da spettatore, parecchie svolte che in un thriller convenzionale apparirebbero prevedibili, se non insensate.

Tutti ne parlano
“La Belle Epoque”, terzo e bellissimo film francese da non perdere assolutamente. Cast meraviglioso con Daniel Auteuil e Fanny Ardant. Il fumettista Victor si trova nel bel mezzo di una crisi lavorativa e personale, sentendo di detestare un presente in cui non riesce a riconoscersi e in cui non fa altro che litigare con sua moglie, Marianne. Grazie all’incontro con l’imprenditore Antoine, tuttavia, a Victor viene offerto un rimedio adatto alla sua nostalgia: tramite una ricostruzione storica così accurata da sembrare vera, potrà rivivere artificialmente la propria belle époque personale, ovvero il 16 maggio del 1974, il giorno in cui incontrò Marianne per la prima volta.
Tra gli Eventi speciali, segnalo: il documentario “Nick Drake-Songs in a Conversation”. Un viaggio interiore e artistico intrapreso da Angelini e d’Erasmo tra canzoni, emozioni e suggestioni, un racconto corale e coinvolgente impreziosito dalle interpretazioni di Andrea Appino, Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, Piers Faccini e Adele Nigro che hanno in comune con il duo il loro amore per Nick Drake, arricchito dallo straordinario incontro in studio di registrazione con John Wood, il sound engineer che ha registrato tutti e tre gli album di Drake.
Il documentario “Negramaro-L’anima vista da qui” di Gianluca Grandinetti. A ridosso del ventennale della loro formazione, la band dei Negramaro svela per la prima volta il lato nascosto del “rock”, fatto di semplicità, amicizia, amore e famiglia. Un connubio di diverse emozioni per raccontare gli ultimi tre anni di vita del gruppo: dalla genesi dell’album Amore che torni all’adrenalina del tour vissuto attraverso momenti di backstage, alla gioia per la nascita di nuove vite e fino al momento delicato vissuto dal chitarrista Emanuele Spedicato.
“Very Ralph”: documentario di Susan Lacy sullo stilista Ralph Lauren molto bello. Ralph Lauren sbarca sul piccolo schermo con un documentario interamente dedicato alla sua vita e ai momenti salienti della sua carriera lavorativa. Il progetto si chiama Very Ralph, è diretto e prodotto da Susan Lacy, specializzata in documentari e vincitrice di Emmy Awards. Un film dedicato ad uno dei più potenti uomini della fashion industry.

70 film in cartellone per 258 proiezioni complessive e 25 paesi rappresentati. Questi numeri sono la base di partenza da cui Antonio Monda, il direttore artistico della manifestazione, è partito per diffondere in conferenza stampa i dati consuntivi della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Ancora una volta, per il quinto anno consecutivo, in forte crescita. I biglietti venduti hanno registrato un incremento del 10%, gli incassi della biglietteria del 18%, gli accrediti sono aumentati del 13%. Consequenzialmente, la copertura dei media ha registrato altrettanti valori positivi, capitalizzati dal +86% ottenuto dal sito ufficiale.
Ciò, per sottolineare che non siamo in un festival, bensì in una vera e propria festa che, per undici giorni, ha guardato al prossimo futuro (negli anni scorsi sono stati pescati alcuni Oscar a venire), ma anche al passato.
FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO DI VERONA
di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
La 39a edizione del Festival di Cinema Africano celebrato a Verona dal 8 al 17 novembre dello scorso anno, è stata una nuova occasione per gettare uno sguardo sul continente, nelle sue diverse e multiple realtà nazionali, culturali, religiose, sociali, e raccontare come la società cambia e si evolve. La città scaligera è stata, la prima italiana a organizzare nel 1981, una rassegna di cinema africano, adottando dal 2007 il formato concorso.
In questa edizione si sono presentati film provenienti da 15 paesi africani, con 138 proiezioni di cui 71 destinate alla cittadinanza e 67 allo “spazio scuola”. Circa 18.000 gli spettatori in città e in provincia di cui più di 8.300 studenti e circa 900 docenti.
La giuria internazionale, formata dalla giornalista Miela Fagiolo, la studiosa di cinema Amina Lamghari e il compositore belga Christian Leroy, ha scelto i migliori film tra i 20 in concorso, 10 tra i lungometraggi di “PanoramAfrica” e i 10 tra cortometraggi di AfricaShort.

Il Premio PanoramAfrica lo ha vinto il lungometraggio di Burkina Faso, “Le vie de Château” di Modi Barry e Cédric Ido, ambientato nel vivace quartiere africano di Château d’Eau a Parigi. Per la giuria il film è “un affresco sociologico di una società multietnica nel cuore di Parigi, in un quartiere in cui la convivenza ha stabilito legami positivi tra culture diverse”.
Una menzione speciale è stata assegnata al film egiziano, “Yomeddine” di Abu Bakr Shawky, che parla di un lebbroso guarito, le cui cicatrici l’hanno costretto a vivere lontano dal mondo. Dopo la morte della moglie decide di lasciare la comunità isolata dove viveva ed insieme a un piccolo orfano che ha preso con sé, intraprende un viaggio verso la città natale alla ricerca di un posto cui appartenere.
Anche la giuria della sezione parallela “spazio scuole” ha scelto “Yomeddine” come miglior film. Altro premio attribuito in questa sezione, il premio “New Generation”, è andato al film keniano “Supa Modo” del regista, Likarion Wainaina. Jo, una simpatica ragazzina di 9 anni, malata terminale, viene portata a trascorre l’ultimo periodo della sua vita nel villaggio dov’è nata con l’unico conforto di sognare di essere una eroina, dotata di super poteri.
Il premio del pubblico per i lungometraggi è stato attribuito al film tunisino “Fatwa”, di Mahmoud Ben Mahmoud. Una pellicola che affronta una problematica di drammatica attualità come l’integralismo islamico. Un tunisino che vive in Francia torna al suo paese per seppellire suo figlio morto in un incidente stradale. Arrivato scopre che il figlio militava in un gruppo islamista radicale e decide scoprire i motivi della sua radicalizzazione ed identificare quelli che lo indottrinarono.
Altro lungometraggio premiato, nella sezione Cinema al di là del muro attribuito dalla giuria dei detenuti della Casa Circondariale di Montorio di Verona è andato al film “Hakkunde”, del cineasta nigeriano autodidatta, Asurf Oluseyi. Il film, attraverso l’intrigante storia di un giovane laureato che lotta contro tutto e tutti, ritratta la società nigeriana contemporanea, con i suoi chiaroscuri.
Per quanto riguarda i cortometraggi, la giuria internazionale ha consegnato il Premio AfricaShort al film, “Brotherhood” della regista di origini tunisine, Meryam Joobeur. La pellicola parla di un pastore che vive con la moglie e due figli in un villaggio rurale della Tunisia. Quando il figlio maggiore militante dell’Isis, torna a casa con una misteriosa moglie, il padre ne rimane scosso.
La menzione speciale è stata assegnata al film “Le pastèques du cheikh” della regista tunisina, Kaouther Ben Hania. È la storia di un imam devoto e rispettato che acconsente di pregare sul cadavere di una donna sconosciuta, ma il suo atto di pietà diventerà il pretesto per la sua espulsione, provocata dal suo machiavellico giovane assistente. Il film si distingue per la sua denuncia dell’uso strumentale della fede religiosa.

Premio del pubblico per i cortometraggi è andato a “Tangente”, di Rida Belghiat e Julie Jouve. Una giovane madre partecipa a una maratona estrema. Per tre giorni e notti, corre motivata a superare i propri limiti e sfidare i demoni del passato. Film anche riconosciuto dalla la giuria di studenti dell’Università di Verona, che lo ha premiato perché “sviluppa il tema universale della dignità della donna e della persona in situazioni di vulnerabilità, quali la violenza e il carcere”. La stessa giuria di studenti ha attribuito una menzione speciale al corto egiziano di Tamer Ashry, “Eyebrows”. È la storia di Aisha, che pubblica in un gruppo Facebook di ragazze che indossano il burqa, una domanda provocatoria che fa riflettere sul mondo femminile nella cultura islamica.
Una volta finita la mostra cinematografica, il festival ha lanciato l’ultima sezione in concorso, denominata Viaggiatori&Migranti, 5 serate sotto le stelle con la cinematografia dedicata ai temi delle migrazioni, che si terrà a Verona dal 13 al 19 luglio di queste anno 2020. Dieci film in concorso con premio al miglior film decretato da una giuria di esperti.
Noi ci auguriamo che il festival continui a crescere e prosegua a fornire dibattiti nella società del veronese in particolare, per fare riflettere sull’Africa, sulle sue specifiche contraddizioni e i propri disagi che indubbiamente ci riguardano ed influenzano anche noi. Soprattutto la nostra visione e esperienza di un continente così vicino geograficamente però molto distante e sconosciuto allo stesso tempo.
OCCHIO CRITICO
STORIE VERE
di Marco Incerti Zambelli
“Recentemente ho lavorato senza una sceneggiatura, ma ultimamente me ne sono pentito, l’ultimo film che abbiamo girato e che ora stiamo montando è basato su una sceneggiatura costruita con molta accuratezza” ha dichiarato Terrence Malick durante la lavorazione di “Una vita nascosta”. Questo affidarsi alla solida struttura narrativa di una vicenda vera non impedisce all’Autore di dispiegare tutte le scelte stilistiche che hanno caratterizzato da sempre il suo lavoro, del tutto funzionali in questa occasione alla sua poetica, lontane dagli eccessi delle ultime opere: la mistica immersione nella natura, l’accurato uso dei suoni e delle musiche, l’utilizzo della voce fuori campo, la certosina costruzione del montaggio, la superba resa luministica delle inquadrature e la mirabile eleganza dei movimenti di macchina, anche qui dove alla fotografia Jorg Widmer sostituisce il fido Emanuel Lubezki di cui è stato a lungo operatore.
La lunga narrazione di quasi tre ore trae giovamento dalla volontà di raccontare il dipanarsi di una storia ed anche dalla distanza temporale delle vicende, che si svolgono all’epoca della seconda guerra mondiale, che già Malick aveva affrontato, in tutt’altri luoghi, in uno dei suoi capolavori, “La sottile linea rossa”.
Franz Jägerstätter, interpretato con efficacia da August Diehl, è un contadino austriaco la cui vita è contrassegnata dall’idilliaco seppur gravoso e povero lavoro nei campi e dal tenero rapporto con la moglie e le tre piccole figlie. Quando la Storia irrompe nella atemporale quotidianità del piccolo e tranquillo paesino delle Alpi Austriache, le forti convinzioni morali lo indurranno ad un rigoroso rifiuto dell’accettazione della formula di adesione all’ideologia ed alle scelte Hitleriane, fino al sacrifico supremo della vita.
Malick sceglie un’esposizione del racconto per contrapposizione, sia nelle scelte linguistico/cinematografiche che narrative. Il film inizia alternando immagini di repertorio tratte da “Il trionfo delle volontà” di Leni Riefenstahl, apogeo della propaganda nazista che documenta il raduno di Norimberga, in B/N e in rigoroso formato 4/3, alle ariose, riprese in panoramica dei campi, delle montagne, dei caldi interni dove vive e lavora Franz con la sua famiglia. Nell’edizione originale si alterna l’utilizzo dell’inglese, a caratterizzare l’uso del linguaggio comune, quella sorta di dialetto che è l’austriaco, al tedesco che è la parlata degli invasori, del potere. Esemplare è la sequenza del processo, nella quale Bruno Ganz nella parte del giudice, qui alla sua ultima, perfetta, apparizione sullo schermo, si esprime in tedesco nel ruolo ufficiale per passare al più colloquiale inglese nel dialogo privato con Franz, tentando inutilmente di convincerlo ad abbandonare le sue ferree decisioni. Nella seconda parte del film il contrasto tra le claustrofobiche ambientazioni delle prigioni in cui è rinchiuso il protagonista, vittima di gratuite angherie e la serena luminosità delle ambientazioni montane sottolinea la dolorosa separazione dei coniugi, attenuata dallo scambio di commoventi lettere che la voce off declama. La originaria armonia che caratterizzava il rapporto tra la famiglia e gli altri abitanti del paesello, tra gentilezze e lavori comuni evolve in distacco, frattura, conflitto.
Malick tratteggia un martire più che un eroe, del quale non indaga le motivazioni profonde di una coerenza che è figlia della libertà più che della ribellione, che alla ennesima offerta di un burocrate nazista che basterebbe una sua firma su un documento per essere liberato obietta: ‘ma io sono già libero’ perché ‘non posso fare ciò che credo sbagliato’.
La intensa fede cristiana dalla quale scaturisce la sofferta ma cristallina scelta di Franz pare evocare una certezza metafisica, eppure la sua decisione è segnata da una assoluta umanità, da una dignità universale e la citazione di George Eliott alla fine del film, dalla quale è tratto il titolo, ne chiosa mirabilmente il senso.
Mark Ruffolo, attore dal talento multiforme, capace di convincere come Hulk nella serie Avengers, di dare corpo al giornalista investigativo di “Il caso Spotlight”, di interpretare il dissestato produttore discografico in “Tutto può cambiare”, il medico infetto di “Cecità”, il gaudente padre biologico ne “I ragazzi stanno bene”, è da sempre un ambientalista convinto. In questa veste propone a Todd Haynes di portare sullo schermo la storia vera di Robert Bilot, un avvocato che inizia una carriera come difensore di potenti industrie ma che si impegnerà anima e corpo per vent’anni nell’attacco al colosso chimico Dupont, battaglia tutt’ora in corso, a partire dalla denuncia di un contadino che gli fa scoprire lo smaltimento illegale di sostanze tossiche della multinazionale, causa di morti e devastanti mutazioni ecologiche. Ruffolo dà fondo a tutta la sua abilità attoriale, si immedesima nei panni del un poco goffo legale, ne evidenzia i tic, la smorfia nel labbro, il tremore delle mani, la postura da uomo qualunque, evidenziandone così la caparbia, ostinata dirittura morale. Lo affianca Anna Hathaway, nel ruolo della moglie, che riesce a smorzare, ma non del tutto, l’affascinante bellezza.
Può apparire sorprendente l’adesione di Haynes ad una siffatta vicenda: le opere precedenti, ricche di felici intuizioni stilistiche, di innovative modalità narrative, hanno affrontato tematiche queer, riletto nel profondo dell’America della depressione, messo in scena il Glam Rock degli anni settanta, attraversato con geniali e visionari racconti poetici la poliedrica personalità del mito Bob Dylan, fino alla fiabesca (e sottovalutata) magia di storie parallele nel tempo. Qui, in “Cattive acque”, si mette a disposizione di una narrazione classica, mette la sordina alle invenzioni sperimentali e così fa emergere la solida maestria del suo fare cinema, sorretto anche dal fido sodale Edward Lachman alla fotografia, capace, al solito, di dare corpo anche cromaticamente alla vicenda, con i caldi toni degli interni che fanno ancor più risaltare le pallide, cineree, tetre visioni degli esterni in West Virginia, una degli stati più poveri degli USA.
Viene immediato il rimando all’Eastwood di Richard Jewell, di Scully, ma più in generale a quel solido filone del cinema americano di impegno civile, di denuncia, di battaglia indomita del singolo che non arretra di fronte ai poteri forti e che testardamente confida nella forza della verità.
E se sono le note della celebre “Country road” di John Denver che accompagnano la scelta dell’impegno di Eliot, è la splendida versione di Johnny Cash di “I won’t back down” di Tom Petty a suggellarne la battaglia: ‘Ehi, manterrò la mia posizione e non mi tirerò indietro, so cos’è giusto, ho solo una vita’
AFFARI DI FAMIGLIA: “STORIA DI UN MATRIMONIO” e “PARASITE”
di Francesco Saverio Marzaduri
“STORIA DI UN MATRIMONIO”
“Forse sono stupito dal modo in cui sei sempre con me
Forse temo il modo in cui ti lascio
Forse sono stupito dal modo in cui mi aiuti a cantare la canzone
Mi correggi quando sbaglio
Forse sono sorpreso per il modo in cui ho bisogno di te…”
PAUL McCARTNEY, Maybe I’m Amazed
Esiste nella filmografia del newyorchese Noah Baumbach, che a distanza di quasi cinque lustri conta una bella dozzina di titoli, un sottotesto da non interpretare come il fulcro nodale d’una visione registica; eppure, dettato da circostanze in linea con la frenesia della metropoli, questo sottotesto emerge inatteso a mo’ di chiave, qualificandosi come altra faccia dell’assetto narrativo. Così, in “Mistress America”, una scrittrice in erba si serve di materiale umano per essere accolta da un club universitario per aspiranti narratori: niente di meglio che lo stile di vita glamour, scanzonato e irriverente, della sorellastra Brooke e i segreti progetti di costei, per concretizzare l’ambizioso capriccio. La stessa Brooke inscena una pantomima, con tanto di palchetto e pubblico plaudente, per ottenere un prestito dall’ex partner. Lo si era già visto in un titolo precedente di Baumbach, “Giovani si diventa”, dove il documentarista Josh, in attesa dell’occasione che potrebbe rilanciarlo, vede sottrarsi l’ambizione da un giovane ammiratore forse più talentuoso (ma all’uopo anche scorretto). Nessuno, sembra dire l’autore, è realmente sincero con sé stesso, temendo che la riposta sensibilità sia a uso e consumo d’una società che persevera nella propria cinica sopravvivenza; sicché la frase fatta “vai a far del bene alla gente” non è da leggersi quale edificante e obsoleto apologo morale, semmai come una strategia difensiva per non incappare nella coazione a ripetere. Nulla di strano che in “Storia di un matrimonio”, il cui titolo vagamente bergmaniano suggerirebbe da subito la crepa d’un “ménage”, l’incipit, complice un efficace montaggio alternato, ci mostri le parti in causa nel tentativo di discorrere i reciproci pregi senza risentimenti. Né suona insolito che il teatro “off Broadway” rechi la componente diegetica più basilare nella “mise–en–scène” caratteriale dei coniugi Adam Driver (feticcio di Baumbach: proprio il Jamie che defraudava Ben Stiller in “Giovani si diventa”) e Scarlett Johansson, rispettivamente regista e primattrice, alle prese con un divorzio sempre più dolente, che la divisione tra la Grande Mela e Los Angeles ostenta in modo anche più marcato. Come sempre in Baumbach – non nuovo allo spunto, ripensando a “Il calamaro e la balena” – è difficile provare qualcosa di attiguo alla simpatia verso i personaggi, negli egoismi e nelle contraddizioni, e il fatto che una separazione funga da epicentro azzera qualsiasi presupposto di parzialità, nonostante una delle parti, perlomeno all’inizio, non voglia saperne. Se l’ago della bilancia è il figlioletto conteso, la vera discrepanza si cela nel fragile “milieu” d’una sicurezza solo apparente, che risalta via via più labile quando Nicole, confidandosi con l’avvocato femminista Nora (Laura Dern), rivela la meschinità d’un coniuge forse fedifrago. Da par suo, la sfera legale non è che una sciarada spettacolarizzata che non nasconde l’aggressività, nel caso di Nora rivendicando orgoglio femminile, quando non carrierismo rampante (la controparte incarnata da Ray Liotta). E non molto può la figura dell’anziano consulente (Alan Alda), divorziato a propria volta, per venire a un umano compromesso. La teatralità si fa, in sintesi, tenore di vita dove chiunque è chiamato a recitare un ruolo (la goffa Cassie che, incerta su come dare la notizia della citazione di divorzio a Charlie, fa le prove in una tra le molte parentesi tragicomiche del film, prima che Nicole le rammenti che non è una performance). Così pure la parzialità, come ostenta la suocera Julie Hagerty, a favore dell’uno e non dell’altra implica avversità, se non un camuffamento d’odio maggiormente grottesco rispetto alle maschere che i protagonisti – lei da David Bowie, lui da Uomo Invisibile – indossano durante un funesto Halloween. Tale ostilità si mostra nella propria palpabile e deformante sincerità, nel bel mezzo d’un appartamento spoglio, luogo d’un “tête-à-tête” che, anziché far chiarezza, fa crollare farse e feticci, mostrando da parte dell’uomo una sofferenza sin troppo implosa che denuda la vulnerabilità dell’ex moglie. La sobrietà della situazione frantuma l’artificio, con tutti i bizzarri esiti del Caso (l’episodio dell’inviata del tribunale chiamata a valutare le capacità di Charlie nell’occuparsi del figlio, al termine del quale un banale incidente domestico per poco non dissangua l’uomo), prima di tornare a una serenità non più solo di facciata. “Storia di un matrimonio” è l’apologo d’un contrasto tra sentimenti (magari non d’amore, senza dubbio d’affetto), mai spenti e tuttavia impossibilitati a un’unione concreta, che nella dualità reale-finzione non sarebbe dispiaciuto a quel Seymour Chatman che teorizzò l’importanza – anzi, la necessità – della parte recitata nella vita. “Being Alive”, non a caso, è il successo di Broadway che un Charlie sconfitto (quanto più maturo e consapevole) intona malinconico al microfono in un sottofinale che, insieme alla citata scena del “vis-à-vis”, Driver gioca di risalto emotivo, rivelando un’inusuale bravura che ruba la scena all’impeccabile Johansson. Non si dimentichi che in tema di messinscene, in “BlacKkKlansman” dell’anno prima, l’ebreo Driver “interpretava” il collega detective nero per infiltrarsi nella congrega del Klan ed incastrarne gli adepti. Rileggendo l’Avery Corman di “Kramer contro Kramer”, ancora prima di pensare al suo celebre adattamento, fa specie che il “mondo di emotività compressa e ridotta a pura apparenza” di Baumbach, per citare Leonardo Gandini, si riscontri pressoché invariato tra le pagine di quel libro: ineludibile esito d’un processo, psicologico e sentimentale, dove il pubblico apparire fa da contraltare alla sfera più intima e privata. Oltre al nome di Benton, nell’ampio tracciato cinematografico degli sfaceli coniugali, inevitabili tornano alla mente Cassavetes, Mazursky, Nichols, Allen medesimo (come la presenza di Alda e Wallace Shawn confermerebbe), e per tal motivo, se si esclude l’ineccepibile confezione, “Storia di un matrimonio” è la riproposta in epoca postmoderna d’una produzione già sorpassata, il cui nostalgico registro fa i conti col percorso di crescita autoriale. Lo insegnava Bogdanovich, principale modello ispiratore di Baumbach: i classici del passato sono insostituibili e non si può far altro che rifarli. E nonostante le musiche di Randy Newman, è un peccato non trovare in colonna “Maybe I’m Amazed” di McCartney, altrettanto azzeccata per lo spunto trattato e impiegata nell’ingannevole “preview”.

“PARASITE”
“Io che conosco tanta gente, son venuto su dal niente,
C’ho una bella posizione, non è giusto che la perda,
Mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me,
Mi son fatto tutto da me…
Mi son fatto tutto di merda!”
GIORGIO GABER, L’odore

Nella recente crociata contro “cinecomics” e prodotti Netflix – che vedono eponime firme del grande schermo schierarsi contro i primi, optando per i secondi pur di continuare l’attività – lo spettatore più attento avrebbe di che riflettere. Certo, non mancano le eccezioni se è vero che nel catalogo della citata Netflix un po’ di sole (d’autore) nell’acqua gelida della mediocrità permette di riscoprire antichi sapori in apparenza smarriti; così, mentre Amazon si decide a far uscire l’ultima fatica di Woody Allen nel mare magno delle polemiche, il crepuscolo d’una malavita in fase cimiteriale (“The Irishman” di Scorsese) o la dolente lastra d’un “ménage” in crisi tra verità e finzioni (“Storia di un matrimonio” di Baumbach) farebbero ben sperare che tali esiti non s’arenino alle società di distribuzione via Internet e consentano al cinema, sempre più sfera dall’incerto avvenire, di perseverare nella propria (seppur limitata) forma d’espressione sull’odierno presente. Ancora una volta, una possibile ancora di salvezza giunge dalla produzione asiatica, cui bastano pochi indizi e molta inventiva registica per confezionare un prodotto che comunichi col pubblico, e col quale quest’ultimo si riverberi tra divertimento e amarezza. Vedere per credere “Parasite”, ottavo lavoro di Bong Joon-ho, col quale per la prima volta la Sud-Corea conquista Cannes, incassando più di cento milioni di dollari nel mondo: la finestra d’uno scantinato, un sottoscala, una connessione Wi-Fi abusiva, una blatta a gironzolare su un tavolo, già da soli dicono della condizione economico-familiare di quattro poveracci ma pure del “climax” d’un Paese desideroso di progredire, fermo in verità all’obsoleto paradigma secondo cui l’“upper class” esiste, e prospera, sulla pellaccia (e sull’odore) degli indigenti. Complice la soffiata d’un amico, studente in una facoltosa università, il Caso vuole che il giovane rampollo della famiglia protagonista, costretta a campare grazie al sussidio di disoccupazione, trovi lavoro come insegnante privato della figlia d’una coppia d’arricchiti; la scaltrezza del ragazzo e della sorella, esperti d’informatica quanto occorre per ottenere una laurea contraffatta, fa sì che l’uno introduca l’altra nel nucleo in qualità di tutrice di sostegno per il figlio più piccolo. Quel che scaturisce è un machiavellico carosello, dettato dall’avidità prima che dalla disperazione, che induce la nuova arrivata a far licenziare lo “chauffeur” per consentire al padre di occuparne il posto, e quest’ultimo, a mo’ di effetto-domino, a far assumere la moglie come colf, una volta messa in disgrazia la vera domestica grazie a un’allergia da pesche indotta dai diabolici ragazzi. I presupposti per traslare un canovaccio neorealista in movimentata farsa al cianuro figurano tutti, e nel cinico progetto, studiato per consentire a quella ciurma di poveri cristi una grama fetta di benessere, a tratti pare d’assistere a un lavoro francese “à la” Veber o di tornare ai fasti della commedia italiana. Quando poi i padroni di casa decidono di trascorrere il weekend fuori città, lasciando custodi della villa i Nostri, un imprevisto rimette le carte in tavola: i meschini scoprono di non esser gli unici ad abitarla, né soprattutto i soli desiderosi d’un agiato tetto sulle spalle. Se chi scrive non va oltre per non sciupare la sorpresa, occorre segnalare come il nerissimo humour impiegato nella prima metà sfumi in un’atmosfera hitchcockiana sempre più allucinata, dove la tensione incalza quanto la girandola di colpi di scena, sino a sgombrare il campo da ogni equivoco. Sicché “Parasite” non è solo un apologo sull’indigenza e sulle efferatezze che questa spinge a compiere, ma pure una radiografia di matrice hegeliana sul conflitto di classe, tant’è che le venature thrilling di cui è imbastita la messinscena, sfocianti in un misterioso sotterraneo-bunker, fanno persino ripensare a un capolavoro sull’identico tema, “Il servo” di Losey. Tuttavia Bong Joon-ho non inverte i ceti sociali, ostentandoli per come sono dietro i paraventi: se il “gap” fra entrambi risiede nella piccola salita che conduce il basso rango verso lo chalet, rimarcando l’incolmabile distanza, il giocoso interesse del piccolo Da-song per gli indiani d’America non si può non leggere quale segnale d’uno storico esproprio macchiato d’intolleranza; lo stesso bimbo, a un certo punto, funge da ago della bilancia individuando negli intrusi l’identico odore, e al momento opportuno è l’unico a rimanere fuori dalla villa quando padroni e servi, questi ultimi nascosti, sono riuniti nello stesso raggio. A dispetto dell’americano “Storia di un matrimonio”, qui la farsa non serve per camuffare sentimenti genuini, né cessa di serbare amarezza dietro la risata (si pensi allo scetticismo di Da-hye verso il fratellino, considerato un genio dai genitori): emblematico è il segmento che raduna gli intrusi Kim intenti ad ingozzarsi di alcol e schifezze nel lussuoso salotto – quasi un Cenacolo di grossolana fattura – finché un risentito Ki-taek non reagisce alle battute della moglie che lo paragona allo scarafaggio dell’incipit; e come un insetto l’uomo deve strisciare via per non esser scoperto dai Park mentre fanno sesso (e per eccitarsi accennano alle mutandine lasciate dalla figlia di Ki-taek nella loro auto) e, all’occorrenza, rifugiandosi nel sotterraneo per sfuggire alla polizia quando una festa di compleanno culmina in tragedia. La finzione svela una verità atta a presentare i ricchi come creature anche più mostruose e ignoranti di chi, patetico ma non innocente, s’accapiglia per un’infima fetta di opulenza: l’orrore è nel “surplus” di benessere dietro la superficiale scorza, profittatore di un’eterna guerra tra poveri, questi ultimi indiretto capitale umano di reali parassiti che solo a parole dicono di ammirare chi viaggia in metropolitana e non ambisce a oltrepassare alcuna soglia sociale. Strumenti all’apparenza fortunosi, dallo “smartphone” a Google, si rivelano malefici; nella propria scarna icona, una medaglia si riduce a vanificato spiraglio di gloria, una pietra ornamentale a corpo contundente da scagliare sulla testa di qualcuno, o a plausibile auspicio di speranza. Lo scantinato è inequivocabile allegoria dell’unica posizione sociale che i meno abbienti possono permettersi: gli effetti d’una copiosa alluvione riconducono a una realtà sovrastante che assembla in un “unicum” i rifugiati, azzerando la discrepanza sul gradino successivo della scala, un tombino o un water, portando i protagonisti a un “milieu” da cui non poter fuggire (e poco prima l’acqua gli serve per cacciare un “clochard” che orina vicino alla loro misera abitazione). Un’inattesa resa dei conti ha luogo durante una festicciola, pensata per superare il trauma di Da-song nell’aver visto un intruso aggirarsi tra le mura domestiche: il quale non solo si ripresenta ma innesca in Ki-taek quel piano di cui, secondo la sua constatazione, non si dovrebbe mai disporre per non conoscere la delusione. Anche se un soprassalto d’orgoglio implica che per la “cosa giusta” tre persone perdano la vita, la finestra che introduce e sigla “Parasite” concede uno spiraglio possibilista, mentre la neve cade nel solo istante poetico del film. La maledetta magione, un giorno o l’altro, potrà essere luogo d’una conseguita felicità familiare: ma forse è solo un sogno d’incerta realizzazione, pronosticato da una missiva che il figlio computa al padre in alfabeto Morse, ripristinando un umano legame (guarda caso, gli unici Kim a tornare alla vita di sempre sono madre e figlio, principio e fine dell’utopica “escalation”). Sino ad allora, mostrano le immagini conclusive, lo chalet è ereditato da un nuovo nucleo di ricchi emigrati, con un intruso nel bunker, destinato a portare avanti un’eredità dai sinistri contorni. Come una nuova storia infinita. Altro che aggiornamento dei tempi, altro che progresso: globalizzazione e capitalismo continuano a condurre il gioco. Il crimine – glaciale – è sempre dietro l’angolo.
“POWIDOKI / IL RITRATTO NEGATO” DI ANDRZEJ WAJDA
di Tullio Masoni
Giunto agli ultimi istanti della sua vita il maestro polacco vagheggiava, ironicamente, un paradiso che somigliasse al Parco Planty di Cracovia in una giornata di sole. Aveva appena licenziato “Pwidokli / Il ritratto negato”, un film che, a mio avviso, si può definire, nell’ultima fase di lavoro, come un’impennata.

E’ opinione diffusa, infatti, che dall’Uomo di marmo in qua l’opera di Wajda abbia perso molto della sua problematica energia : «…peccato che l’ultimo Wajda – ha scritto Goffredo Fofi – nello sforzo di restare centrale anche nella nuova situazione politica, abbia dato film “internazionali” e bolsi come il “Danton” (1982, da Przybyszewska) o “Eine libe in Deutschland” (“Un amore in Germania”, 1983) e abbia davvero annaspato in patria, senza più vera originalità e autonomia di creatore» (Come in uno specchio. I grandi registi della storia del cinema, Donzelli 1995). Un giudizio che tutto sommato condivido (salvo che per “Danton”; non conosco “Katyń”, né “Walesa”), se penso al venir meno della tensione eclettica che aveva portato il cinema dell’autore polacco – per contrasto polemico, azzardo di stile, o pura inquietudine – all’eccellenza.
“L’uomo di marmo” metteva in rapporto materiali visivi diversi, unificandoli in una critica dell’ideologia che includeva i dettami del “realismo socialista”. Dialettica e provocatoria denuncia (l’eroe del lavoro Birkut muore “anonimamente” negli scontri di Danzica, e di lì a poco il sistema polacco scoppierà), esprimevano però la tormentata memoria di un’antica passione socialista. Il Wajda di “Powidoki” (il regista è stato a sua volta pittore) non vagheggia davvero il paradiso in terra promesso dal comunismo – specie se di importazione staliniana – e tuttavia, rimarcando l’intima e tenace coerenza di Strzeminski (che non aveva mai rinnegato l’esperienza russa di A.R – Arte Rivoluzionaria) allude alla vicenda di un artista – sé medesimo – che ha tentato di resistere nel sistema totalitario, si è talvolta compromesso ma, negli esiti migliori, ha saputo interpretare i segni di una storia non solo nazionale.
Forse è troppo scontato definire il suo ultimo film come un testamento, ma è pur vero che il pittore Wladyslaw Strzeminski, il protagonista, comincia a morire in una sorta di recupero del famoso barocco” wajdiano: quell’inquadratura mossa, esasperata, col vecchio invalido che si aggrappa ai manichini, o li vuole distruggere mutilandoli; una inquadratura che poi quasi si vuota per un movimento di camera orizzontale (come il corpo caduto) includendo, oltre la vetrina, il palazzo di fronte. Un recupero stilistico, quindi artisticamente autobiografico, che al paradiso in terra vagheggiato dal maestro però non fa pensare. “Powidoki” infatti si chiuderà con la visita della figlia al povero letto d’ospedale del padre: un grigio interno, nel quale spiccano il rosso del cappotto della ragazza e il bianco livido delle lenzuola.

E un po’ barocco, cioè nel segno di una fase d’opera gloriosa, era stato anche l’inizio, col maestro – privo di un braccio e una gamba persi durante la prima guerra mondiale, ma in circostanze “misteriose” – che per raggiungere tre allievi ai piedi della collina si lascia rotolare giocosamente per la scoscesa del prato. La sua è anche una sottile, drammatica provocazione, pur se altri allievi che stavano con lui in alto si divertono a imitarlo.
Poi la “lezione”: «…L’immagine deve essere soprattutto quel che si assorbe quando noi guardiamo un oggetto …immagini residue…i colori dentro l’occhio che guarda un oggetto…perché noi vediamo solo quello di cui siamo consapevoli…».
Dalla voce del maestro all’ascolto degli allievi la camera compie un movimento regolare, “esaustivo”, appena sublimato dal rapimento di una ragazza e dalle note scarne di un violino.
Quale affinità, dunque, fra il pittore Strzeminnski e il cineasta Waida?
***
1948. Nel suo studio Strzeminski si prepara a dipingere. La tela è disposta verso le due finestre. Da fuori arriva la voce di un altoparlante, un discorso di propaganda al quale l’artista non bada. All’improvviso, dopo che il pennello ha mischiato colori e sta per posarsi sulla tela vergine, la superficie si fa rossa, e tutta la stanza è invasa da un rosso totale, uniforme. Il pittore è sorpreso, noi siamo sorpresi, perché quella luce rossa, quella monocromia, sembra per un attimo una misteriosa suggestione astratta. Un attimo soltanto; il rosso è imposto da un grande drappo calato sulle finestre, e in quel drappo è stampata la faccia di Stalin. La propaganda sonora, adesso è anche figurata, imprescindibile, e la momentanea astrazione rivela un inganno, cioè i precetti del “realismo socialista”: via le ricerche dell’avanguardia rivoluzionaria e, nel colore cui l’avanguardia stessa aveva guardato come a un ideale, ecco l’obbligo di tornare all’accademia, alle regole di rappresentazione, al racconto che “educhi” e inciti le masse, al culto dei santi ideologici cui vanno affidati la speranza di vittoria, l’amor di patria, la minaccia di castigo e la protezione.
Fra il barocco dell’incipit e quello del pre-finale, Wajda racconta la sventura di Strzeminski usando piani medi d’interno ed esterni cupi – dove la realtà poliziesca e burocratica trova le sue ottuse incarnazioni – forse con qualche eccesso verbale. E piani medi alternati dalla frequenza di primi piani del protagonista, un Boguslaw Linda sempre magnifico.
L’affinità fra Strzeminski e Wajda può dunque essere riconosciuta, per concludere, in un agire dell’ideologia ancora pulita lungo il percorso artistico di entrambi. Più coerente e tragica la vicenda di Strzeminski, più “compromessa” e oscillante quella di Wajda il quale, affidandosi dagli anni ‘80 a Solidarnosh – e recuperando in effigie l’osservanza liturgica cattolica: L’uomo di ferro – aveva tentato di affrontare a cuore aperto le contraddizioni inevitabili di ogni trapasso storico. Nei paesi ex satelliti dell’Urss è poi andata come è andata ma, nel periodo in cui Wajda è stato coinvolto, la scommessa antistalinista era d’obbligo per chi volesse un futuro liberato dal totalitarismo. Lo schiacciamento sui modelli occidentali, poi il nazionalismo e il populismo erano forse prevedibili, ma non ancora scontati.
BONG JOON-HO A REBOURS: “MEMORIE DI UN ASSASSINO”.
di Paolo Vecchi
Gli Oscar a “Parasite”, più che la Palma d’Oro di Cannes, hanno convinto un distributore italiano a far uscire da noi “Memorie di un assassino”. Iniziativa benemerita, se non fosse stata uccisa sul nascere dalla chiusura delle sale per pandemia. Scriviamo queste note con la speranza che il film possa essere quanto prima recuperato, anche perché vorrebbe dire che l’emergenza è finita.

Per il soggetto, Bong Joon-ho, anche cosceneggiatore, si è ispirato a un fatto di cronaca. Tra il 1986 e il 1991, nella provincia di Gyunggi, non lontano da Seoul, dieci giovani donne furono violentate e uccise. Tutti i crimini vennero commessi in un giorno di pioggia, le vittime vestivano un indumento di colore rosso, una radio trasmetteva la stessa canzone. “Memorie di un assassino” racconta le indagini condotte da un poliziotto locale, Park Doo-man, assistito da Seo Tae-yoon, un collega venuto dalla capitale. Con metodi piuttosto sbrigativi, essi ottengono dapprima la confessione di una sorta di scemo del villaggio dal viso sfigurato che era solito pedinare una delle ragazze, poi di un poveraccio che si eccita sessualmente immedesimandosi nelle gesta del maniaco. L’incriminazione di entrambi non regge però alla prova dei fatti. Quando pensano di avere scoperto finalmente l’assassino in un giovane dalle movenze androgine e dallo sguardo glaciale, vengono smentiti dall’esito del DNA. Vent’anni dopo, Park Doo-man, che ha cambiato mestiere, torna sul luogo del delitto…
“Memorie di un assassino” è l’opera seconda del regista coreano dopo “Barking Dogs Never Bites” (“I cani che abbaiano non mordono mai”, 2000), della quale ha dichiarato di non essere contento ma che a questo punto saremmo curiosi di recuperare, magari in dvd. Conferma infatti se ce ne fosse bisogno la statura dell’autore dell’ammirevole noir “Madre”, illuminato da una splendida figura femminile, oltre a una versatilità che lo ha visto passare dallo horror-ecologico “The Host” al distopico “Snowpiercer” alla favola multinazionale “Okja”.
Il film si apre e chiude con due sequenze in esterni luminosi, di campi di grano inquadrati da sguardi infantili. Ma quelle immagini nette, quei colori dorati incorniciano una vicenda a tinte cupe, magmatica di fango, pioggia e vento, casupole miserabili, uffici di polizia, prigioni e obitori accomunati dalla sporcizia e dallo squallore. Le vite allo sbando che li popolano sono non solo quelle dei criminali o presunti tali, ma anche di tutori dell’ordine la cui scarsa professionalità cerca quasi sempre la scorciatoia di una violenza che il regista esorcizza con il controcanto del ridicolo. L’ambiguità del suo sguardo è dichiarata quasi programmaticamente quando il commissario capo chiede al collega venuto da Seoul, che per inciso poco prima è stato scambiato per il violentatore da una ragazza che aveva fermato per chiederle informazioni stradali, di indovinare, tra due uomini che siedono di fronte a lui, quale sia lo stupratore e quale il fratello della vittima, tanto simili essi sono nell’aspetto. “I miei personaggi principali sono dei poliziotti violenti, non degli intellettuali: fanno il loro lavoro un po’ a casaccio, ma era un’epoca che gli assomigliava” ha dichiarato il regista. “Era interessante il fatto che, anche se quei personaggi sono idioti e violenti, si può simpatizzare con loro perché ci ricordano il nostro passato che era idiota e laido: è così che l’abbiamo vissuto noi stessi, che l’abbiamo sofferto allora”.
La vicenda criminale e il suo contesto non funzionano tuttavia solo sul piano metaforico, ma esibiscono un sottotesto di continui riferimenti alla situazione politica della Corea del 1983, schiacciata sotto una ferrea dittatura. Lo si avverte, ad esempio, quando la radio chiama alla mobilitazione per un possibile attacco da parte del Nord, ossessione che attraversa tanto cinema prodotto anche oggi a Seoul, ammorbandone in avvertibile filigrana le atmosfere. Oppure quando i poliziotti, avendo la certezza che lo stupratore sia sulle tracce di un’ennesima vittima, chiedono rinforzi per pattugliare le strade del piccolo centro, vedendoseli rifiutare perché sono impegnati a reprimere una manifestazione di piazza. Già sapientemente padrone dei propri mezzi espressivi, Bong Joon-ho gioca da par suo su questa doppia alternanza realistico/grottesco e vicenda criminale/situazione nazionale, concedendoci il beneficio di un intensissimo finale aperto, anche perché all’epoca in cui fu realizzato il film non si conosceva ancora l’identità dell’assassino, che confessò i dieci omicidi dopo essere stato condannato per quello della cognata. Impeccabile come sempre la direzione di attori, tra i quali spicca Song Kang-ho, futuro capofamiglia “proletario” di “Parasite” nonché fedele compagno di viaggio del regista.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
NON SOGNARE: FALLO!
STORIE DI PUNK ROCK ITALIANO. QUATTRO DOCUMENTARI (E UN LIBRO)
di Marcelo Cella
A Federica, lunare, enigmatica e perduta punk veneta
“Non sognare, fallo”. Questa scritta campeggiava su alcuni muri della mia città fra gli anni ’70 e gli anni ’80. E forse qualcuna ancora resiste su qualche muro sbrecciato delle sue periferie. Si trattava di uno slogan fatto proprio dalla più famosa punk band della zona, i Fall Out e che esprime bene la filosofia di vita di quell’universo magmatico che è stato il punk italiano. Mi è tornata in mente visionando compulsivamente, in questi giorni di forzata staticità, alcuni documentari sul punk rock italiano, uno dei fenomeni controculturali più mistificati e dimenticati fra tutte le sottoculture giovanili che si sono succedute negli ultimi decenni nel nostro paese. Eppure, al di là degli elementi di autobiografismo, di scarso interesse in questa sede, in quei confusi e violenti semi di rivolta erano contenute alcune riflessioni sulle dinamiche che muovono la nostra società e sulle sue distorsioni socio-culturali che in qualche modo hanno resistito al tempo e tornano periodicamente in scena come un fiume carsico che ribolle sotto la superficie apparentemente pacificata dei nostri stili di vita occidentali. È opportuno però porsi qualche domanda.

Quando nasce il punk italiano e perché? Si può dire che esso si manifesti chiaramente come tale nella seconda metà degli anni ’70 quasi in contemporanea con l’esplosione eclatante del fenomeno nel Regno Unito e in altri paesi europei. Sulle motivazioni invece il discorso si fa più complicato. Molti lo etichettano come un fenomeno imitativo rispetto al fenomeno cultural-musicale britannico che subito esplose con band diventate poi famosissime come Sex Pistols, Clash, Stranglers, Damned, Siouxsie and the Banshees, e decine di altre. Questa componente non può essere negata anche perché da sempre il pop-rock anglosassone ha goduto di una distribuzione e di una copertura mediatica capillare che ne hanno favorito la visibilità. Ma per quanto riguarda l’Italia il fenomeno si è subito caratterizzato per alcuni elementi che lo hanno differenziato dalla matrice britannica. Intanto la società italiana dei tardi anni ’70 era caratterizzata da una politicizzazione di massa e da una violenza politica sconosciuta in quel momento in Gran Bretagna.
Il punk italiano infatti nasce come rifiuto di una politicizzazione fortissima che sul finire di quel decennio aveva assunto il colore livido del terrorismo e delle trame oscure degli apparati dello Stato contro la vita democratica. Ma anche di una ottusa e impersonale visione della vita e del mondo, filtrata attraverso gli occhiali miopi di ideologie consolidate, ma già scricchiolanti sotto i colpi dei mutamenti irreversibili in atto nel mondo della produzione e del consumo di massa. Inoltre in quegli anni erano ancora presenti, nei suoi aspetti più opprimenti, i pesanti condizionamenti etici di una società ancora fortemente pervasa dalla morale cattolica. Quindi il punk italiano si caratterizza subito per un elemento che segna una netta rottura con questo stato di cose, e cioè l’ironia.
Questo aspetto emerge chiaramente nel documentario “Il punk italiano. Le radici 1977-1982” di Angelo Rastelli (https://www.youtube.com/watch?v=h2cxE-mZ4-c) del 2005, che non a caso inizia con le immagini di repertorio dell’eterno Giulio Andreotti che entra al senato, ma anche con quelle di scontri di alcuni manifestanti contro la polizia e di allarmati titoli di giornale in montaggio alternato con quelle di giovani punk, accompagnate dalla canzone “Mamma, dammi la benza” dei Gaznevada, uno dei primi irriverenti gruppi punk italiani dell’epoca. Del resto, come afferma Freak Antoni, leader di un altro gruppo punk icona dell’epoca, gli Skiantos, “furono individuati due bersagli, due protagonisti del periodo che erano da una parte il carabiniere e dall’altra parte l’autonomo. In qualche modo una presa in giro a 360°: la presa in giro dello stereotipo del carabiniere, ma con altrettanta convinzione e determinazione la presa in giro dello stereotipo del settantasettino, movimentista, autonomista e barricadero. La demenza è una piccola invenzione degli Skiantos, insieme al rock demenziale che è una forma particolare di punk rock”. Ironia, sarcasmo corrosivo, sberleffo situazionista (impagabile la scena in cui gli Skiantos durante un concerto smettono di suonare e, con degli scolapasta in testa, cominciano a cucinare una enorme pentola di spaghetti chiedendo al pubblico come li preferiscono) sono quindi gli aspetti più evidenti di questa prima fase del punk rock italiano, confermato anche dalle altre numerose interviste con giornalisti come Michel Pergolani, Red Ronnie, Claudio Sorge, e con alcuni dei protagonisti musicali più o meno noti di quel momento come Enrico Ruggeri (Decibel), Ivan Cattaneo, Gianni Muciaccia (Kaos Rock), Tony Face (Not Moving), Steno (Nabat), Sandro Raffini (Gaznevada), Helena Velena (Raf Punk), ecc. Anche se non vanno dimenticati altri aspetti importanti del fenomeno punk di quegli anni come la centralità di una città come Bologna, che, per le sue specifiche caratteristiche (una “metropoli provinciale”, la definisce in ossimoro sempre Freak Antoni) di città universitaria cosmopolita e aperta alle correnti politiche e culturali più avanzate (il movimento del ’77 in fondo nasce e muore lì), senza perdere nello stesso tempo le proprie radici rurali nella sterminata pianura padana, assume subito un ruolo carismatico e catalizzatore. Come anche non va dimenticata la capacità di autorganizzazione sul piano produttivo (il “do it yourself”, uno degli slogan più diffusi all’epoca) che porta alla nascita di numerose case discografiche (la Italian Records di Oderso Rubini su tutte) che sostengono queste prime esperienze musicali. Per non parlare del rivendicato dilettantismo in fatto di formazione musicale, con molti giovani punk che prendevano in mano uno strumento musicale per la prima volta in vita loro poco prima di esibirsi su un palco, contro i noiosi leziosismi sonori e le vuote narrazioni fantastiche dei testi di molti gruppi progressive che andavano per la maggiore in quegli anni e si astraevano da una realtà sociale e culturale che premeva per esprimersi in modo più diretto. Insomma c’era una scena che voleva prendere la parola e fare un bagno di realtà e il punk era una buona arma a disposizione.
Questa prima fase ironica e spregiudicata, come fanno capire anche alcune delle interviste sul finale del documentario, si conclude però quando la violenza politica comincia a conquistare il centro del palcoscenico, insieme ad altri fenomeni tragici come la diffusione di massa delle droghe pesanti, in particolare dell’eroina, che tagliano le gambe al movimento punk e lo costringono ad esprimersi sotto altre forme e in altri luoghi più chiusi come i centri sociali che si moltiplicano durante tutti gli anni ’80 e anche oltre un po’ in tutta Italia.
Due documentari, in particolare, raccontano bene questi mutamenti del fenomeno punk italiano: “Italian Punk Hardcore 1980-1989” di Angelo Bitonto, Giorgio S. Senesi, Roberto Sivilia (https://www.youtube.com/watch?v=g2idFNnFhjM&t=10s) del 2015 e “Punx. Creatività e rabbia” di Ermanno Guarnieri (https://www.youtube.com/watch?v=_dthTdF5hcg), realizzato originariamente nel 1984, ma remixato e restaurato nel 2005.
“Italian Punk Hardcore 1980-1989” racconta questa evoluzione della scena punk italiana, in modo quasi didascalico con la sua divisione in nove capitoli (Le origini, Le città e i centri nevralgici, Le band, L’autoproduzione e le etichette indipendenti, Le fanzine e il passaparola antagonista, Il rapporto antagonista tra punk e stampa, I concerti, Le droghe, L’apice e il declino), la sua parabola dalla nascita e dal sogno di autodeterminare la propria vita e di poter esprimere la propria individualità fuori da qualsiasi condizionamento sociale fino al suo declino (“punk is dead”). “Nessuno ha il diritto di decidere la nostra vita”, si legge su uno striscione alle spalle di un gruppo punk che si sta esibendo davanti al suo pubblico in uno dei tanti filmati amatoriali dell’epoca di cui è costellato il documentario, ma il concetto è ulteriormente chiarito dalle varie interviste che si succedono, in particolare in quella di Helena Velena dei bolognesi Raf Punk (“la storia è nostra, la musica è nostra”), in cui la consapevolezza della propria diversità e della sua intrinseca politicità è espressa molto chiaramente. “Il punk è energia, il punk è sicuramente una rabbia a tutto tondo, ma è sicuramente una rabbia a tutto tondo contro il sistema, contro una società autoritaria, repressiva, contro una società che sostanzialmente consegna i propri membri ad una quotidianità fatta di malessere diffuso”, racconta invece con grande lucidità un certo Enrico (cognome non specificato) degli Infezione di Modena. Il documentario ha anche il merito di mettere in luce altri aspetti della scena punk italiana. Per esempio, riguardo ai suoi centri di espressione e divulgazione del fenomeno (capitolo 2 Le città e i centri nevralgici), segnala un’importante novità rispetto alla fase precedente. Se nella prima parte della sua storia Bologna era il centro riconosciuto del movimento punk italiano, nel suo sviluppo anni ’80 si nota un progressivo decentramento del fenomeno. Quindi non più solo Bologna, ma anche altre città emergono come centri di diffusione di questo humus culturale, anche se Milano, soprattutto con i suoi affollati centri sociali come il Leoncavallo, il Virus, ecc. e la sua politicità intrinseca emerge progressivamente come città leader. Le interviste a molti dei protagonisti dell’epoca lo rilevano chiaramente.

Il punk si diffonde come un virus nella sterminata provincia italiana e contamina per la prima volta molte altre città, grandi e medio-piccole, Torino, Alessandria, Ferrara, Modena, Pisa, Napoli, Trieste, Bari, Grosseto, Verona, Macerata, Firenze, Piacenza, Udine, Roma, Palermo, Lucca, La Spezia, ecc. con una miriade di band dai nomi duri e fantasiosi (Raf Punk, I Refusi It, Nabat, Cheetah Chrome Motherfuckers, Crash Box, Chain Reaction, Rappresaglia, Negazione, Indigesti, Kandeggina Gang, Fall Out, ecc.), anche totalmente femminili, che cominciano a realizzare ed a sviluppare criteri e metodi di distribuzione dei propri prodotti culturali mai utilizzati prima di allora.
Nascono centri sociali un po’ in tutta Italia (famosi il Mongolfiera di Modena, il Victor Charlie di Pisa, lo Zeta X di Napoli) e un po’ ovunque (perfino le sale parrocchiali non vengono risparmiate) che diventano vettori di una creatività di massa, non solo musicale (in quel periodo si sviluppano moltissimi progetti che riguardano altri ambiti culturali come fumetti, video, teatro, cinema, editoria, ecc.), che si avvale di metodi produttivi e nuovi canali distributivi. Un ruolo decisivo lo assumono le fanzine, cioè le piccole riviste autoprodotte e autodistribuite da parte di chi le realizzava avvalendosi di tecniche basic come la fotocopiatrice, le forbici o addirittura la fattura a mano e il più diffuso dei canali di diffusione dell’epoca, l’ufficio postale, quando non addirittura, la distribuzione diretta da parte di eroici “postini” punk che partivano dalla propria città in automobile o in treno e portavano queste piccole pubblicazioni, ricche di informazioni e articoli riguardanti concerti e band della scena punk, ma anche tematiche nuove come il femminismo, la vivisezione, il vegetarianismo, l’antimilitarismo, ai concerti, nei centri sociali, nei negozi di dischi “amici”, o direttamente nelle case dei simpatizzanti, con cui magari avvenivano scambi di materiale simile da riportare poi nel proprio ambiente di provenienza. Insomma, una sorta di “rete comunicativa” che anticipava concettualmente l’idea di rete affermatasi con internet e i social network. Una comunità di persone che si disgrega alla fine degli anni ’80 sotto i colpi della repressione poliziesca, con lo sgombero dei luoghi in cui questa scena culturale si esprimeva, ma anche a causa di limiti intrinseci alla visione del mondo e della vita dei punk.
Molto significativo in questo senso è il documentario “Punx. Creatività e rabbia” di Ermanno Guarnieri, incentrato sul punk milanese degli anni ’80 e soprattutto sul locale simbolo dell’epoca, il Virus, ma estremamente utile per capire pregi e difetti del movimento punk italiano nel suo insieme, soprattutto se si tiene conto dello sfondo socio-economico sul quale emerge e si sviluppa il punk non solo come musica, ma anche come cultura antagonista.
Il documentario di Guarnieri assume un’importanza storica più forte di altri perché realizzato nel 1984 (era allegato ad un libro di Stampa Alternativa sul punk italiano) e restaurato nel 2001. Una fotografia in presa diretta del punk italiano, emblematica fin dalle immagini di apertura, con giovani punk che si aggirano in un capannone industriale abbandonato, che poi diventerà il locale simbolo dell’epoca, il Virus di Milano, come a segnare anche a livello simbolico l’effettivo trapasso in corso in quegli anni dalla fabbrica alla società postindustriale, con i luoghi della produzione manifatturiera sostituiti da centri autonomi di produzione culturale: colonna sonora la musica punk, i conduttori di Radio Popolare, una delle prime radio libere italiane, attiva fin dagli anni ’70, e i giovani che intervengono durante i suoi programmi. Ma al di là dell’aspetto musicale che per larghi tratti del documentario appare marginale rispetto all’esprimersi di una realtà culturale a tutto tondo ed al significato politico fortissimo che essa assume subito, “Punx. Creatività e rabbia” racconta in modo molto efficace l’energia, la voglia di esprimersi incontenibile a tutti i livelli, il dinamismo esistenziale e culturale di una comunità di giovani decisi a ripensare, a rifiutare ed a cambiare i paradigmi etici e sociali, i ruoli di genere, le gerarchie professionali, l’edonismo anestetizzante sparso a piene mani dal potere politico ed economico, dominanti nell’Italia dell’immobilismo democristiano, dello yuppismo craxiano e delle emergenti televisioni di Berlusconi. Uno spazio importante lo assume, rispetto ad altri filmati di argomento analogo, la componente femminile del movimento, con alcune delle analisi più lucide e lungimiranti sui possibili sviluppi e sugli oggettivi limiti del punk e di analoghi movimenti antagonisti contemporanei e successivi. “La donna va un po’ dietro al punk maschio, un po’ macho, cattivo. Le donne punk vengono viste come fighe anche dai punk stessi”, afferma una di loro durante una bellissima discussione a più voci. E poi, più avanti, aggiunge: “Posso fare i più bei discorsi del mondo, però guardo anche la realtà. Anche noi punk siamo contro tante cose, vorremmo fare tanto, e poi…poi non facciamo niente. Per cui non puoi non sentire questa impotenza. C’è il nostro discorso, però c’è il discorso più completo di tutto il resto, di tutti, non solo di noi punk. Che cosa stiamo facendo? (…) Che cosa si riuscirà a fare? La repressione è troppo grande. Per cui mi chiedo: dopo verranno altre cose, o potrà anche non venire niente. È questa l’impotenza che sento. Dico no a tutte le ideologie, ma in fondo spero che non ci sia sempre la merda che c’è adesso. Siamo tutti bravi a parlare. Poi alla fine riusciamo a fare ben poco”.

Il no del rifiuto, ma anche la difficoltà a costruire quel mondo nuovo che anche il punk, sulla scia dei movimenti giovanili di protesta che hanno attraversato il tardo Novecento, sogna, appare quindi il punto debole di tutto il movimento. Raccontato anche da due momenti che il documentario sottolinea, come la protesta situazionista dei giovani punk che, durante un convegno di sociologi che presentano un lavoro di ricerca sul punk milanese, si tolgono le camicie e si tagliano il petto con le lamette, e lo sgombero del Virus, con il malinconico corteo giovanile che attraversa le vie della città urlando slogan minacciosi sotto le finestre di una Milano sostanzialmente indifferente.
Negli anni ’90 il punk non muore, ma si trasforma in un’interessante corrente musicale, che arriva anche ad un certo successo commerciale (basta pensare al successo di punk band d’oltreoceano come Green Day, Offspring, Bad Religion o a quello nostrano, relativo, di band come i CCCP, poi CSI, o come i Punkreas, Persiana Jones, Derozer, Shandon, ecc.), evoluzione che è al centro del racconto di un altro documentario del 2019, “La scena. Il punk italiano degli anni ’90” (https://www.youtube.com/watch?v=FgPtsEnf4cE) dei fratelli Marx (Silvia, Diego e Beppe Marchesi). Il punk sopravvive anche negli anni ’90 continuando a frequentare molti degli stessi luoghi che lo avevano visto protagonista negli anni ’80, come i centri sociali, ma, al di là dell’aspetto musicale, sembra aver perso la sua carica eversiva, la sua caratteristica di espressione controculturale per adagiarsi all’interno del contenitore più rassicurante, più catalogabile e quindi più appetibile commercialmente che potremmo definire come “ribellione adolescenziale”.

Lo confermano anche molti dei protagonisti nelle numerose interviste del documentario quando, affermano si di voler azzerare quella distanza fra musicisti e spettatori che è sempre stato uno degli obiettivi intrinseci del punk, ma all’interno di una scena sempre meno politicizzata. “Basta politica! Birre, ragazze, vita!”, dichiara convintamente uno degli intervistati. L’analisi più interessante di tutto il fenomeno è quella espressa da Marco Philopat, scrittore e agitatore culturale milanese, attivo fin dai primi anni ’80, quando afferma: “Lo scrittore americano David Forster Wallace ha fatto un quadro degli anni ’90 come se fosse un grande party nella società. Soprattutto per i giovani dai 16 ai 24 anni che avevano attraversato quel periodo lì sembrava una grande festa. Tutto andava bene. Anche i centri sociali stessi erano pieni di gente, con il fenomeno delle posse che vendevano un sacco di dischi, come i 99 Posse. Quindi c’era questo big party come lo chiamava Forster Wallace. Poi di colpo ci si è resi conto che la festa era finita”. Sta iniziando un’altra storia, quella del movimento no global. “Questo abbaglio che ha colpito il movimento no global e con loro la scena degli anni ’90 si è infranto con il G8 di Genova e il crollo delle Torri Gemelle. La crisi che è venuta dopo coinvolge la scena punk degli anni ’90, ma anche i centri sociali stessi che per tutti gli anni 2000, fino al 2009, vivono dell’eredità della grande esplosione degli anni ’90 e delle tematiche che erano state elaborate dopo il Virus negli anni ’80. Vivono di rendita”. Altri affermano invece che comunque nel fare una fanzine o un gruppo punk continua a sopravvivere un elemento politico. “L’attitudine punk”, continua Philopat, “è molto vicina al pensiero anarchico, al pensiero libertario del non volere un padrone ma anche nel non essere capace di esercitare il potere, nel non essere capace né di comandare, né di essere comandato, credo che sia ancora il denominatore comune dei punk degli anni ’80, degli anni ’90 e di quelli di adesso, perché esiste anche adesso una scena underground. In questa dicotomia esistenziale, il punk è un po’ difficile da omologare o da sfruttare. (…) C’è un autore americano che proviene dall’esperienza controculturale degli anni ’60 che si chiama Hunter Thompson che dice che se un popolo ogni 25 anni non fa una rivoluzione genera mostri omologati e conformisti. (…) Ci sono ancora oggi dei punk ventenni che rappresentano una scena molto simile a quella degli anni ’80 come numero e come radicalità. (…) Chi è stato punk non può far altro che portare dei piccoli mattoni, e io in particolare porto libri, per la costruzione di una rivoluzione futura”.
Concetti che Philopat esprime anche in un bel libro a più voci da lui curato, e disponibile in rete in libera lettura, che si intitola “Lumi di Punk. La scena italiana raccontata dai protagonisti” (http://www.drexkode.net/PageContents/Saggi/Lumi%20di%20punk.pdf), che racconta in modo chiaro e partecipato la parabola di tutto il movimento punk italiano, dai suoi esordi negli anni ’70 agli anni 2000. Insomma “punk is dead”, il punk è morto, ma finché ci sarà qualcuno che avrà voglia di rivendicare ciò che si è, di esprimere liberamente il proprio immaginario, la propria idea estetica fuori dal coro, il punk resterà un punto di riferimento, anche se magari non si chiamerà più così.
Giovanissime antenne sono forse già attive in appartate cantine per elaborare suoni e concetti estranei alla vita adulta e ai suoi ammuffiti paradigmi, per tentare di cambiare questo mondo. In fondo tutta la scena rap e hip hop deviante molto amata dagli adolescenti di oggi con i loro suoni duri, i testi incendiari, la filosofia di vita ‘contro’, la ribellione che cova sotto la cenere, l’autoproduzione rivendicata e realizzata, lo dimostra. Non è ancora una certezza, ma una luce di speranza in tempi bui come quelli che viviamo
PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi
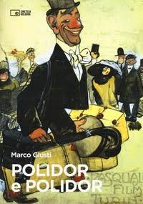
POLIDOR POLIDOR
di Marco Giusti
Edizioni Cineteca di Blologna, 2019
Euro 20, pagg. 292
Il nome di Polidor riporta subito alla mente il film di “La dolce vita” (1960) e “Le notti di Cabiria” (1957). Nel primo lo vediamo nel ruolo di un fraticello questuante che ricorda alla povera Giilietta Masina l’importanza di vivere nella Grazia di Dio dopo aver vissuto una drammatica avventura che la stava portando alla morte, mentre nel secondo è l’uomo con i palloncini che si esibisce in un night club destando la meraviglio dei presenti dediti alla “dolce vita”.
Ma Polidor disegna una figura caratteristica anche in “Un ettaro di cielo” (1958) di Aglauco Casadio ambientato nel Delta del Po.
Polidor è il nome che Ferdinand Guillaume scelse per le sue comiche. È stato uno dei più celebri comici del cinema muto, ancora prima di Charlie Chaplin e di Buster Keaton. Si esibiva come clown musicale, ginnasta e salvatore nel circo dei genitori cavallerizzi, originari della Francia ma naturalizzati italiani. Notato dai dirigenti della Cines di Roma fu ingaggiato per una lunga serie di comiche espresse con il nome di Tontolini. Nel 1911 divenne Polidor e fu interprete di brevi comiche che andranno avanti fino alla prima guerra mondiale. È stato il primo Pinocchio cinematografico: lo interpreto, infatti, nel 1911 nel film diretto da Giulio Antamoro, in cui dà al famoso burattino, creato da Collodi, cadenze meccaniche. Negli anni Venti, coinvolto nella generale crisi di quegli anni abbandona il cinema per la rivista ed interpreta alcuni film fino, appunto, alla riscoperta di Fellini. Lo si vedrà dopo in qualche altro film, tra cui “Accattone” (1961) di Pasolini, nell’episodio felliniano di ”Boccaccio ‘70” ed in quello di “Toby Dammit. Poi senza lavoro viene sostenuto dall’assistenza pubblica e sarà ricoverato anche al Policlinico di Roma. Morirà novantenne a Viareggio. Una figura che Marco Giusti ci ricorda, ripercorrendone la vita anche con documenti inediti, attraverso una serie di succosi capitoli.

UN ORIZZONTE CHIAMATO CINEMA
Di Paolo Protti
Editoriale Sometti, 2018
Euro 18, pagg. 165
Un libro che racconta la storia di una famiglia di esercenti operante soprattutto a Mantova, la Famiglia Protti. A raccontarla è Paolo Protti che ne ripercorre la storia fin dal 1904 quando nacque nella bassa e nebbiosa provincia mantovana grazie alla pima impresa cinematografica di Gino e Ottorino. Un’avventura che da Mantova avrebbe presto allargato i suoi confini. Una storia raccontata attraverso ricordi ed aneddoti che, come giustamente afferma l’editore, ci restituiscono un tempo passato e accompagnano i cambiamenti di una società e dei suoi costumi. Una storia di grandi imprenditori, la cui attività non si è fermata nemmeno di fronte alle guerre, alle crisi dei cinema di provincia e della politica. Chi la racconta, cioè Paolo Protti, ha iniziato a collaborare con il padre Alberto sin dal 1969 arrivando a trasformare l’”Ariston” di Mantova, in una multisala di città, mantenendo anche la caratteristica di teatro, che da anni è la Sede degli Incontri di Mantova della FICE. Ha anche ricoperto incarichi di Presidenza nazionale all’Anec ed all’Agis. Il racconto si avvale anche della collaborazione di altri appartenenti alla Famiglia Protti: Daniele, Mario, Vania, Roberto ed Erik, esercente in Emilia Romagna che gestisce a Ferrara il Cinepark “Apollo”. Ne scaturisce un racconto appassionato di chi ama il Cinema.

D’AMORE NON SI MUORE
di Lino Capolicchio
Rubettino Editore-CSC Roma, 2019
Euro 18., pagg.252
Lino Capolicchio in questo libro ripercorre la sua carriera mettendosi “a nudo”, come riferito in una nota editoriale, non davanti alla macchina da presa o sul palcoscenico ma sulla pagina scritta per raccontarsi e raccontare gli anni incredibili che ha vissuto, costellati da incontri straordinari: da Sergio Tofano a Giorgio Strehler, da Anna Magnani a Vittorio De Sica e a Pier Paolo Pasolini, da Federico Fellini ai Beatles ed a Carmelo Bene ed a Fabrizio De André. Al cinema vi è arrivato per caso. Doveva fare il perito chimico in qualche Azienda, ma la passione per la recitazione l’ha portato sulla strada, piena di successi, dell’attore. Trasferitosi a Roma, inizia a frequentare l’Accademia d’Arte Drammatica d Silvio D’Amico e debutta in teatro nel 1965, ad appena 22 anni, con il grande Giorgio Strehler. Per essere diretto poi nell’arco della sua carriera da altri registi, tra cui Roberto Faenza, Dino Risi, Giuseppe Patroni Griffi, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis, Elio Petri, Luca Ronconi, Renato Castellani, Francesco Maselli, Mauro Bolognini, Pupi Avati, Carlo Lizzani, i fratelli Taviani, Pasquale Squitieri: il meglio del cinema italiano. Di tutte queste esperienze Lino Capolicchio parla, tra l’altro, in questo suo libro di memorie, cosi come di tanti altri straordinari incontri, come quello con i Beatles. Ma riferisce anche dei suoi tanti amori, senza morirne, come afferma anche nel titolo di questo suo libro. Un libro gustoso da leggere che è anche uno strumento per conoscere la storia del nostro cinema, non da un punto di vista critico ma aneddotico. Che è quella meno conosciuta, ma altrettanto interessante.

VITA AGRA DI UN RIBELLE PERMANENTE. IL CINEMA DI GIUSEPPE FERRARA
di Roberto Pugliese
Edizioni Falsopiano, 2019
Euro 19, pagg. 161
Un libro incentrato sui film a soggetto di Giuseppe Ferrara, regista molto attivo anche nel documentario con un centinaio di opere. Un cinema, quello di Beppe Ferrara, come amichevolmente ed anche chi scrive, lo chiamava nella lunga frequentazione ed amicizia, in cui subito fece irruzione il suo impegno civile e politico. Dopo aver partecipato con un episodio a “I misteri di Roma”, un documentario, ideato e coordinato da Cesare Zavattini, su alcuni aspetti della Capitale in un giorno qualsiasi, Giuseppe Ferrara esordisce nel lungometraggio nel 1970 con” Il sasso in bocca”, un film sulla mafia del dopoguerra e le sue connivenze politiche per continuare poi con “Faccia di spia” (1975) apologo fantapolitico sulle imprese della CIA attraverso una carrellata sui più importanti e tragici avvenimenti politici internazionali, ma anche italiani (i casi Feltrinelli e Valpreda, in primis) dal 1955 al 1975. È poi autore di “Panagulis vive” (1982) sulle vicende politiche e umane del poeta greco, compresa la sua relazione con Oriana Fallaci e la sua lotta politica in Italia, il rientro in patria e la sua morte sospetta in un incidente automobilistico. Ma anche “Cento giorni a Palermo” dove ricostruisce i cento giorni di Prefetto nel capoluogo siciliano del Generale Dalla Chiesa, sottolineando come esso fu lasciato da solo dal governo fino all’agguato in cui lui e la moglie vengono trucidati: un inquietante spaccato di una società, non solo siciliana, inquinata dalle connivenze con la mafia.
Affronta poi altri personaggi italiani con “Il caso Moro” (1986), dove con rigore formale e senza compiacimento ne ricostruisce con lucidità e fermezza un robusto film-cronaca del rapimento e assassinio dello statista italiano. Ma anche ”I banchieri di Dio” (2002) dove ricostruisce in maniera graffiante la vicenda del Presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi, trovato morto nel 1982 impiccato in un traliccio sotto un ponte di Londra.
Ma anche con “Guido che sfidò le Brigate Rosse” (2007) sull’operaio dell’Italsider che denunciò la presenza delle Brigate Rosse nella fabbrica per coinvolgere la classe operaia nell’abbattimento delle Multinazionali: sarà ucciso dai brigatisti.
Affronta ancora un film politico sull’Italia, “Segreto di Stato” (1994) incentrato sulla collusione tra mafia, terrorismo, politica e servizi segreti. Altro film d’impegno sociale- politico di Beppe Ferrara è “Narcos” (1992) incentrato sui narcotrafficanti del cartello di Medellìn.
Tutti questi film– ma Roberto Pugliese si sofferma anche sull’inedito, per questioni produttive, “Roma nuda” realizzato nel 2010 in quattro puntate da 90’ sulla criminalità romana dal 1968 al 1972 prima dell’avvento della Banda della Magliana — vengono rivisitati dall’autore di questo volume nell’ottica del regista che è spronato dall’urgenza e dalla passione etica, prima ancora che politica, prendendo posizione nel fare le cose e i film giusti. Moltiplicando il potenziale della realtà tramite una sua ricostruzione drammaturgica, il più fedelmente possibile ma anche con la massima libertà consentita dalle regole della rappresentazione. Un libro assolutamente stimolante per meglio capire la cifra autoriale di Giuseppe Ferrara.
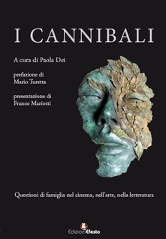
I CANNIBALI
A cura di Paola Dei
Edizioni Efesto, 2019
Euro 12.50, pagg. 167
È il tredicesimo volume dedicato alla cinematografia internazionale dal Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie espressive. Si propone di esplorare, come recita il sottotitolo, questioni di famiglia nel cinema, nell’arte, nella letteratura partendo dai nuovi scenari, nel mondo occidentale, derivati dalle evidenti metamorfosi della società che considerano la famiglia non più solo “naturale”, composta dal nucleo essenziale genitori-figli, ma delle molteplici configurazioni (famiglie con un solo genitore, famiglie di fatto, famiglie con genitori dello stesso sesso). Cambiamenti che continuano a suscitare interrogativi, dando vita ad ampi dibattiti che anche il cinema, inevitabilmente, racconta. E che questo volume affronta attraverso vari contributi in cui vengono esaminati alcuni film, tra cui, “Il Conte Ugolino” di Riccardo Freda, “Via col vento” di Victor Fleming. “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola, “Quarto potere” di Orson Welles, “Vogliamo vivere” di Ernst Lubitsch, “Il bacio della pantera” di Jacques Tourneur, “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica, “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi, “Giulietta degli Spiriti” di Federico Fellini. Ma anche film più recenti come “La favorita”, “Perfetti sconosciuti”, ”Il traditore”.
Contributi dovuti a tanti studiosi che da anni collaborano con l’attivissima Paola Dei.
CREDITS
Carte di Cinema 21
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 21 della rivista online: Roberto Baldassarre, Laura Biggi, Vittorio Boarini, Marcello Cella, Maria Pia Cinelli, Mario Galeotti, Roberto Lasagna, Giuseppe Mallozzi, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Alessandra Pighi, Paolo Vecchi, Maurizio Villani, Xoxan Villanueva, Luciano Volpi, Marco Incerti Zambelli,