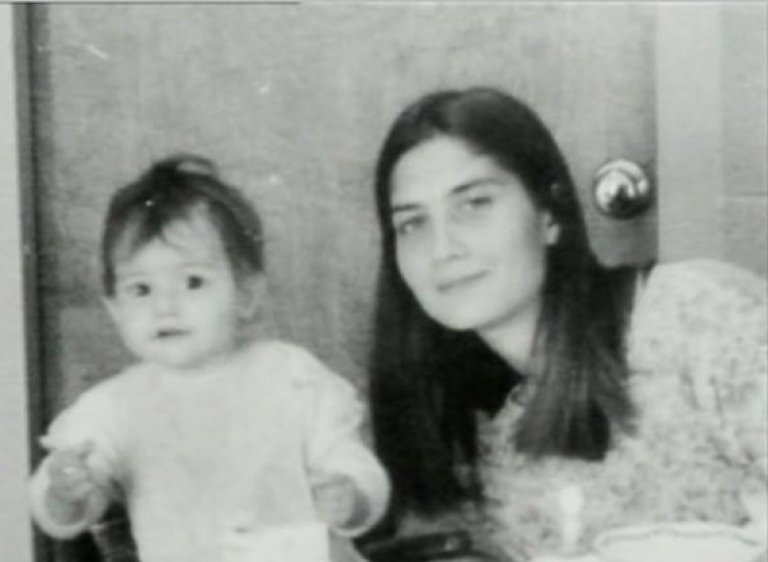Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 5.1 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
- 5.1.1 LA MOSTRA DI VENEZIA DIVENTA SEMPRE PIU’ UN PUNTO DI RIFERIMENTO MONDIALEdi Paolo Micalizzi
- 5.1.2 “EXTASE” APRE LA SEZIONE VENEZIA CLASSICIdi Vittorio Boarini
- 5.1.3 76 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICAAPPUNTI DI UN CINEFILO FEDICdi Luciano Volpi
- 5.1.4 VENEZIA 76: INTERVISTA ALLA REGISTA NUNZIA DE STEFANO di Laura Biggi
- 5.2 67 EDIZIONE DEL SAN SEBASTIÀN INTERNACIONAL FILM FESTIVALdi Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
- 5.3 CORTO FICTION, FESTIVAL ALL’INSEGNA DEL BELLO, GIUSTO ED UTILE DEL CORTOMETRAGGIOdi Paolo Micalizzi
- 5.4 NOMI ILLUSTRI E GIOVANI CRITICI AL FESTIVAL ADELIO FERRERO – CINEMA E CRITICAdi Bianca Ferrigni
- 5.1 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
- 6 OCCHIO CRITICO
- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 8 QUALITA’ IN SERIE
- 9 PANORAMA LIBRI
- 10 CREDITS
ABSTRACT
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
L’EVENTO MUSICALE E LA SUA RESTITUZIONE: DAL “ROCKUMENTARY” ALLE DIRETTE PLANETARIE di Francesco Saverio Marzaduri
Un’analisi del genere “Rockumentary”, inteso come evento musicale fortemente attivo dalla fine degli anni Sessanta lungo un intenso decennio, sino a un progressivo declino dovuto all’avvento del medium televisivo e al costante miglioramento delle proprie tecnologie.
“AIDADE DA TERRA”: IL TESTAMENTO DI GLAUBER ROCHA di Giovanni Ottone
Una critica di “Aidade da terra” e un’analisi del documentario “Anabazys”, straordinaria indagine sulla realizzazione del capolavoro di Glauber Rocha.
SAGGI
ROBIN WILLIAMS. IL RISVEGLIO DELLA LEGGEREZZA di Roberto Lasagna
Robin Williams e la commedia d’autore, tra candore e irrefrenabile ebbrezza, in uno dei periodi felici della produzione dell’attore scomparso cinque anni fa.
BREVE ABC BELLOCCHIANO: AUTOBIOGRAFIA-BOBBIO-(FARE)CINEMA di Roberto Baldassarre
Un veloce breviario su tre fondamentali aspetti del cinema di Marco Bellocchio, che alimentano le sue opere e hanno uno stretto legame fra di loro,
IN VIDEO VERITAS? di Roberto Baldassarre
L’utilizzo delle differenti tipologie di filmini privati nel mondo odierno, e in particolar modo l’uso che ne ha fatto il cinema, innestando la verità nella finzione.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
LE PROFESSIONI DEI SOCI FEDIC di Roberto Merlino
Un’analisi sulle professioni dei soci FEDIC attraverso la lettura delle risposte dei presidenti della Federazione ai questionari inviati da Roberto Merlino per condurre l’indagine che gli era stata richiesta.
STAGE NAZIONALE FEDIC. CALCI (PI) DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2019: “SCRIVIAMO UN FILM” di Enzo Bruno
Un resoconto dello Stage nazionale FEDIC concentrato nel 2019 su lo scrivere una sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio in una atmosfera gioiosa.
FESTIVAL ED EVENTI
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
LA MOSTRA DI VENEZIA DIVENTA SEMPRE PIÙ UN PUNTO DI RIFERIMENTO MONDIALE di Paolo Micalizzi
Un festival dai risultati positivi, molto condivisi, con ampio spazio ai premi collaterali ed iniziative culturali di grande interesse.
“EXTASE” APRE LA SEZIONE VENEZIA CLASSICI di Vittorio Boarini
Film di gran livello in “Venezia Classici”, da anni sezione imperdibile della Mostra.
APPUNTI DI UN CINEFILO FEDIC di Luciano Volpi
Appunti-memoria di un socio FEDIC sugli eventi della Mostra che l’hanno particolarmente interessato.
INTERVISTA ALLA REGISTA NUNZIA DE STEFANO di Laura Biggi
Al termine della cerimonia dei Premi collaterali, intervista della Responsabile di Fedic Scuola alla regista a cui è stata attribuita la Menzione speciale Fedic.
PRIMA EDIZIONE DEL SAN SEBASTIÀN INTERNACIONAL FILM FESTIVAL di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva
I premiati dello storico Festival spagnolo.
CORTO FICTION, FESTIVAL ALL’INSEGNA DEL BELLO, GIUSTO ED UTILE DEL CORTOMETRAGGIO di Paolo Micalizzi
Un festival del cortometraggio che tiene soprattutto presenti valori importanti come la Fratellanza tra i popoli e la Libertà, senza rinunciare ad un sano Divertimento.
NOMI ILLUSTRI E GIOVANI CRITICI AL FESTIVAL ADELIO FERRERO – CINEMA E CRITICA di Bianca Ferrigni
Resoconto dell’ultima edizione del Festival alessandrino dedicato a Cinema e Critica.
OCCHIO CRITICO
LUCI DALL’ORIENTE di Marco Incerti Zambelli
Parasite e Burning, due film di grandi registi dalla Corea del Sud, mettono in scena, con stili diversi ma uguale forza, le contraddizioni della società contemporanea, illuminati dalla strepitosa fotografia di Hong Kyung-pyo
PALCO E CONTRO-PALCO: “STANLIO & OLLIO” E “ROCHETMAN” di Francesco Saverio Marzaduri
Due “Biopic” celebrativi, uno dedicato al duo comico più famoso del cinema e l’altro alla rockstar Elton John, che dà l’addio alle scene dopo oltre cinquant’anni di carriera.
“IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ” DI MARIO MARTONE di Tullio Masoni
Da un dramma di Eduardo De Filippo del 1960 Martone traduce un film ambientato nella Napoli di oggi. Il Rione Sanità, adesso come allora, è percorso da violenza per bande in un quadro di povertà, degrado sociale e soprusi. Interpretato dagli attori del collettivo Nest di S.Giovanni a Teduccio, che opera in periferia allo scopo di togliere i ragazzi dalla strada.
FAMIGLIE: “LE VERITÀ” DI HIROKAZU KORE-EDA; “VICINANZA” DI KANTEMIR BALAGOV di Paolo Vecchi
Una madre diva, una figlia sceneggiatrice, una nipote già in grado di osservare e giudicare i loro screzi, più un paio di mariti, un amante, un maggiordomo tuttofare, una tartaruga in giardino e un cane da portare a spasso. E il mondo del cinema, con i suoi retroscena di invidie e rancori, piccinerie e ambizioni. Regia elegante, soggetto un po’scontato.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
“COWSPIRACY: THE SUSTAINABILITY SECRET” IL CIBO CHE UCCIDE di Marcello Cella
Il consumo di cibo, gli allevamenti intensivi e il loro impatto sul cambiamento climatico in questo documentario americano del 2014 di Kip Andersen e Keegan Kuhn.
QUALITA’ IN SERIE
CHERNOBYL di Giancarlo Zappoli
“Chernobyl” una mini serie che si colloca nei vertici dei prodotti televisivi di qualità e che ci ricorda quanto accadde nel 1986 proponendo un mix di generi finalizzato a una ricostruzione di quegli eventi da una molteplicità di livelli di narrazione.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
L’EVENTO MUSICALE E LA SUA RESTITUZIONE:
DAL “ROCKUMENTARY” ALLE DIRETTE PLANETARIE
di Francesco Saverio Marzaduri

La diffusione di radio e cinematografo, la prima in termini di accessibilità domestica e il secondo di nuovo luogo sociale, permisero di concepire e poi attuare la trasmissione sinestetica di un evento; il concetto di trasmissione mutò paradigma, complice anche il miglioramento dei sistemi di registrazione e riproduzione fonica e, da ultimo, il cinema sonoro. Sino ad allora la comunicazione era rimasta sostanzialmente un problema di trasmissione – orale o scritta, in chiaro o in codice – d’un testo di natura verbale, così come “mediata” l’informazione relativa a un avvenimento.
Supportata da fattori visivi e sonori, accentuata dalle scoperte che condussero alla fonoregistrazione (si pensi alle prime trasmissioni radiofoniche integrali di concerti sinfonici e opere liriche), tale mediazione si sforzò di offrire un’oggettiva “ri-presentazione” dell’evento; restava tuttavia una mediazione, incapace di superare l’impossibilità sinestetica, sia pure spostandosi a un maggior livello di analisi e ad uno più profondo di riflessione in seguito all’avvento del cinema sonoro. In seguito, la diffusione dei media elettronici modificò irreversibile il quadro delle possibilità, rimettendo in discussione i capisaldi da cui prescindeva qualsiasi forma di mediazione: “azione” (l’evento nella propria irripetibilità), “spazio” (il luogo o l’area deputati all’evento), “tempo” (la durata dell’evento presentato, il dilatarsi o comprimersi dell’arco temporale idoneo alla fruizione), cui a loro volta seguivano concezioni di rilevanza non meno fondamentale: “trasmissione” (l’evento nel suo compiersi a scopo divulgativo), “fruizione” (la ricezione dell’evento presso il pubblico), “partecipazione” (l’interazione del pubblico).
In conseguenza della rottura concettuale imposta dal “medium” televisivo e dalla sua espansione, anziché documentato in relativa integrità ed oggettività attraverso ricostruzioni destinate a fruizioni successive, qualunque evento era percepito nell’insieme di attimi che determinavano l’effettivo svolgersi, nel medesimo istante in cui aveva luogo. Anche il concetto di “luogo” subì un’irreversibile crisi di senso e, in identico modo, vennero a cadere le distanze e le barriere percettive necessarie a una certa mediazione sull’evento ai fini d’una sua ri-presentazione. Le possibilità e specificità del nuovo mezzo rendevano concettualmente possibile l’organizzazione dell’evento allo scopo d’una sua documentazione e trasmissione, mettendo in crisi parecchi modelli: di relazione, di comportamento sociale e – sul versante comunicativo – di quello legato alla documentazione sinestetica d’un qualsiasi evento (come dimostra l’immediata diffusione del digitale terrestre).
Tanto il cinema imponeva modalità di fruizione destinate a uno spazio “altro” rispetto a quello domestico, legate a specifiche deroghe di comportamento, quanto la televisione consentiva una fruizione esattamente antitetica: agendo nell’usualità, s’è posta a propria volta quale produttore di quotidianità, laddove il cinedocumentario – in quanto “cinema” – agiva sull’immaginario conferendo agli eventi, anche reali, un’aura mitica indipendentemente dai criteri estetici della loro ri-presentazione. Anziché luogo di percezione diretta, la sala cinematografica era pur sempre luogo di “compresenza”, di condivisa e rituale fruizione dell’evento; il pubblico del cinematografo, anche quello dei cinedocumentari, era un “pubblico”, mentre quello televisivo un’“utenza”.
Analizzare il “rockumentary” come fenomeno, prima che come genere – considerando in particolare le pellicole prodotte dalla fine degli anni Sessanta alla metà dei Settanta – significa perciò, fatalmente, esaminarne l’omogeneità alla luce di questa crisi di modello (organizzativo, produttivo, operativo, fruitivo), ché l’inevitabile dialettica scaturita da tale crisi ha lasciato segni evidenti. Se dalla fine degli anni Settanta in avanti tale dialettica si sarebbe progressivamente alterata, lo sbilanciamento a favore del nuovo “medium” accentuato e la crisi di modello accelerata, il “medium” televisivo – grazie al costante miglioramento delle proprie tecnologie – è stato prima in grado di avvicinare, poi di eguagliare ed infine superare le possibilità operative del “medium” concorrente (complici le continue, mirabolanti scoperte e applicazioni elettroniche, nonché il virtualmente infinito novero di possibilità).
Quanto al cinema documentario, a mutare è stato il panorama produttivo e distributivo. Prassi ed estetiche mutarono a loro volta. Aumentarono sia la propensione ai consumi che la loro offerta, e la stessa fruizione di avvenimento si fece consumo sino a cortocircuitare, dopo quello di “luogo”, anche il concetto di “evento”. Molti furono i concerti organizzati in funzione della registrazione cinematografica, come in seguito lo furono in funzione della loro programmazione televisiva, alla presenza d’un pubblico non sempre consapevole dell’operazione in atto o addirittura escluso dall’immanenza filmica (ossia non più visibile all’interno del film). Per giungere, da un certo punto in poi, a un normativo recupero testuale della “fiction”, a informare di sé le immagini destinate al completamento sinestetico della musica, secondo logiche in seguito fatte proprie dall’estetica pantografata del videoclip.
Di lì in poi il “rockumentary” come genere cinematografico – la produzione di film destinati alle sale che documentavano e ri-presentavano festival, tournée, concerti rock – s’avviò a una progressiva estinzione. Nel decennio successivo agli anni Settanta la produzione di cinedocumentari rock si è diradata fino ad esaurirsi, sostituita da operazioni affini pensate e prodotte in funzione del piccolo schermo. Il “rockumentary” cessò di essere genere cinematografico per farsi direttamente e completamente genere televisivo. Finendo, nell’onnipresenza e onniscienza virtuali imposte dai nuovi e dominanti media elettronici, col perdere agli occhi del sistema (produttivo, economico e di controllo culturale) ogni ragione di esistere, non essendo più funzionale alla gestione (produttiva, economica e di controllo culturale) del fenomeno rock, destinato ad assumere connotazioni sempre più di consumo.
Durante gli anni Ottanta si sono prodotti parecchi cinedocumentari sul rock, ma il numero di tali produzioni prese tuttavia a diminuire in fretta, progressivamente, in proporzione alla crescita delle possibilità televisive e al pieno controllo del nuovo media sulle conseguenti possibilità estetiche e mediatiche. Basterebbe citare lo spettacolo “Live Aid”, organizzato in beneficenza dal musicista Bob Geldof nel 1985, per mostrare le conseguite possibilità della televisione sul piano mediatico, all’epoca agli inizi e già oggetto di mutamenti, via via destinati a subire perfezionamenti tecnologici non ancora concepibili: tanti mini-concerti in contemporanea tra Londra e Philadelphia, con possibilità d’inserire trasmissioni di altri concerti e collegamenti in diretta con altre località, per un totale incalcolabile di venti ore di trasmissione. Qualcosa che solo l’ipotetica versione integrale dell’intero materiale girato durante certi festival avrebbe potuto eguagliare – ma non superare, per le difficoltà di fruizione cinematografica d’un simile ipotetico prodotto.
Se si considerano le prime trasmissioni “ante litteram” in mondovisione e il pubblico “potenziale” da esse ricoperto, e le si paragona in termini di durata, quantità di materiale musicale documentato per immagini e audience “effettiva” col programma dell’85, si può avere un’idea della rivoluzione mediatico-musicale nel frattempo avvenuta. Rivoluzione che, a propria volta, non s’è arrestata: tesa a celebrarne la ricorrenza ventennale nel 2005, la riedizione dell’avvenimento – ribattezzato “Live 8”, giacché tenutosi in undici paesi appartenenti al G8 di quell’anno – ne fornisce la riprova. Se “Live Aid” non ha rappresentato che lo stadio iniziale del fenomeno, numerosi grandi eventi relativi alla musica rock sarebbero risultati, di lì in avanti, pertinenza esclusiva del “medium” televisivo.

La diffusione delle emittenti televisive, di cui l’americana MTV fu senz’altro quella di maggiore audience, dalla fine degli anni Settanta ha consentito la messa in onda di programmi dedicati al rock, la più parte costituita da videoclip, versione televisiva riveduta dei vecchi “promo” cinematografici. Cortometraggi spesso appositamente girati, in larga parte ottenuti enucleando materiali da film più lunghi tramite operazioni di ritaglio ed editi nelle sale di specifici circuiti, allo scopo di promuovere un gruppo o un artista, o la sua ultima produzione, talora proiettati a complemento di altri film quali riempitivi del programma e altre volte, dopo esser stati cuciti insieme più o meno all’ingrosso, proiettati come spettacoli cinematografici a sé stanti. A una dimensione “corta” del brano musicale, privilegiata dai nuovi orientamenti musicali, è seguito un genere “rockumentary” dedicato alle nuove tendenze, ma perlopiù costituito da successioni di brani uno dietro l’altro, misura e formato del rock show televisivo o cinematografico del periodo immediatamente antecedente.
Questa tendenza fu incoraggiata e fatta propria dalla musica commerciale per intuibili motivi, legati alla maggior facilità di memorizzazione del pubblico di brani più corti rispetto ad altri più lunghi e complessi, alla conseguente maggior possibilità divulgativa dei prodotti musicali, a una loro più agile possibilità di produzione, confezione, smercio. E ad essa s’adeguò con estrema facilità il mezzo televisivo, per il quale una simile restituzione visiva del rock non era mai stato un problema e che ora, grazie al progresso dell’elettronica e delle sue applicazioni, era in grado di effettuare con risultati migliori: sempre più, attraverso specifici programmi e specifiche emittenti, la televisione si diede a diffondere musica rock confezionata per immagini in base a tale formato; col tempo, sempre più s’impose l’abitudine di promuovere dischi visualizzandone i brani di punta in “shorts” destinati alla fruizione televisiva.
Alla fine del “rockumentary”, soppiantato dalla trasmissione in diretta e dall’abolizione di un luogo di condivisione fruitiva, corrispose l’egemonia del videoclip rispetto ad ogni altra forma di visualizzazione musicale relativa al rock. In pratica, risultò dapprima uno straordinario veicolo promozionale, successivamente la “conditio sine qua non” per giungere al più vasto successo; in quest’ottica, considerate le reciproche possibilità di penetrazione e diffusione, non v’è dubbio che il clip garantisse in termini di ritorno commerciale, cioè di promozione sul mercato, risultati infinitamente migliori rispetto al “rockumentary”.
Una volta che l’industria culturale comprese l’importanza dei nuovi media e intuì le possibilità consentite dall’elettronica, una volta concentrati investimenti e ricerche nel settore da parte delle “majors” discografiche e cinematografiche, una volta operatasi la connessione tra queste e le emittenti televisive più diffuse e potenti tramite opportune “joint ventures” e altre forme di scambio, l’industria culturale raggiunse il controllo definitivo dello specifico mercato, controllandone gli accessi. Ma a dispetto di quanto esibivano i “rockumentaries”, il clip documentava poco o nulla, al più mostrando visualizzazioni musicali precedute e seguite da altre di analoga lunghezza e disparato riferimento; e a parte ciò, vi fu sempre meno spazio per il rock alternativo in un sistema divulgativo d’immagini dominato dalla televisione e da un’elettronica i cui prodigi erano riservato dominio del grande capitale produttivo: sempre meno in quanto le produzioni a basso costo nel settore non potevano competere a livello di esiti con quelle più ricche. Quand’anche avessero potuto, l’accesso alla grande distribuzione televisiva era controllato da alleanze economiche interne all’industria culturale, che promuoveva solo quel che appariva funzionale, su cui investiva e da cui era lecito attendersi un congruo ritorno finanziario; quand’anche fossero riusciti ad accedere alla diffusione, si sarebbero infilati in un rosario di prodotti affini, in programmi di ore in mezzo a sterminati altri, dove la possibilità di essere notati dipendeva dal numero di messe in onda – i cosiddetti “passaggi”, naturalmente a pagamento – e dalla collocazione in programmi di videoclip di richiamo.
Non mancarono strutture indipendenti e reti televisive più autonome, che permisero diffusioni di prodotti meno commerciali, e tuttavia – in un panorama che ha visto prevalere il modello di rete commerciale su altri modelli di rete – simili strutture dovettero accettare compromessi o votarsi alla marginalità. Si creò per gli artisti rock una distinzione di mercato, in cui la parola “off” manteneva intatto il proprio storico significato di autonomia produttiva e libertà creativa, peraltro accentuando il senso di esclusione dai grandi circuiti e dai grandi incassi. Era sempre possibile superare la demarcazione per quanti avevano talento e qualità, a patto di collaborare col sistema produttivo, accettare la logica di mercato nella sua interezza e rinunciare a consistenti porzioni della propria autonomia. Il paradosso originale del rock – quello di essere musica antitetica al sistema, avente però bisogno di esso per esser prodotto e divulgato – rimase più insoluto che mai. Il che non impedì – come sempre, d’altronde – l’esistenza di artisti e produzioni alternative, l’insorgere di nuove tendenze e nuove forme espressive.
Il declino del “rockumentary” e il dominio del clipmusicale hanno sanzionato l’abbandono del lungometraggio a favore d’una dimensione breve, ma anche l’abbandono d’ogni pretesa di documentazione dal vero e il trionfo della “fiction”. Dalla fine degli anni Settanta in poi, l’opzione dominante diventò quella di costruire per immagini attorno al brano musicale delle vere e proprie storie, o comunque di visualizzarlo indipendentemente dall’esecuzione, talvolta pure indipendentemente dai contenuti testuali (in termini, cioè, di pura fantasia compositiva).
Dal canto loro, le trasmissioni dedicate ai grandi rock-eventi non avevano più alcuna necessità di offrirne costruite ri-presentazioni, optando per documentazioni più o meno integrali in diretta: in una logica di consumo, l’“hic et nunc” mediatico e le sue implicazioni toglievano interesse alle possibili sintesi a posteriori d’un evento spettacolare. E gli eventi di questo tipo, nel mare magno delle sollecitazioni visive e del proliferare dei palinsesti, in mezzo a centinaia d’altri che ogni giorno ormai si offrivano all’utenza direttamente a domicilio ventiquattr’ore su ventiquattro, in mezzo a ogni altro genere di evento di cui i media elettronici permettevano l’immediata conoscenza, persero l’aura mitica che li permeava, dopo aver perso parecchio del loro significato in termini di cultura antagonista, d’identità giovanile alternativa, di contestazione, di autonomia. In un’era telematica dove ogni evento è ridotto a informazione tra milioni di altre, era la definizione stessa di “evento” a doversi ricapitolare, e in ogni caso, nei vecchi termini di senso, a non riguardare più alcun programma di consumo e intrattenimento.
Tutto ciò ha implicato una trasmutazione del pubblico, in termini fruitivi e di rappresentazione. Destinato alle sale, il “rockumentary” mostrava il pubblico dell’evento a un pubblico che tale avvenimento riviveva, in sedicesimo, con le medesime caratteristiche rituali, ripresentandone riduzioni a sineddoche o visualizzazioni estese, secondo tipologie, intenzioni semantiche, scelte estetiche; a volte lo riduceva ad apparizioni marginali, altre volte concentrava su di esso maggiori attenzioni; in ogni caso, la sua presenza costituiva un simulacro interno al testo filmico, teso a incrementare la possibilità di aggancio virtuale del pubblico cinematografico all’evento stesso. Una volta ridotto l’evento da cinematografico a televisivo, venuto meno il luogo di condivisione della sua ri-presentazione, il pubblico finì per risultare inutile nelle sue ri-presentazioni. Le trasmissioni televisive dei grandi eventi rock, da “Live Aid” in poi, non mancarono mai di mostrare il pubblico sempre e soltanto nella propria globalità, nel suo insieme di mani e teste, braccia e corpi all’occorrenza ondeggianti collettivamente al ritmo di un brano, o altrettanto collettivamente impegnato a cantare in coro assieme alle star sul palco, a far scattare accendini per produrre scenografici mari di fiammelle, ad applaudire e vociare. Non si ricordano però trasmissioni di questo tipo in cui il pubblico venga esaminato, intervistato, al limite inquadrato a campioni singolari, in cui l’obiettivo cerchi di penetrare la massa indistinta a cercarne singoli comportamenti o singole fisionomie. La rockstar è sempre l’unica figura a spiccare; il pubblico è solo ciò che ne giustifica l’apparizione in un luogo e un tempo preciso, apparizione destinata non tanto ad esso quanto a telematiche epifanie avulse dal concetto di spazio e tempo.
Sembrerebbe giustificata l’opinione di alcuni, secondo la quale il rock e l’elettronica hanno di fatto stabilito una tacita alleanza, atta all’edificazione di un supermondo digitale, replica esatta dei sogni, delle fantasie e degli incubi d’ogni fruitore, milioni se non miliardi di fan nel mondo; un’alleanza il cui fine ultimo è dato dall’interconnessione, quasi la creazione d’un mega-ipertesto. I divi del rock risultano sempre più apostoli di un messaggio ideologico, vere e proprie icone che i videoclip rendono simili a eroi del fumetto e dei “cartoons”, simulacri di un passaggio (quello all’elettronica multimediale di consumo) destinato a cambiare non tanto la percezione del rock, ma la percezione della realtà “in toto”. Il principio della frammentazione (fruitiva, compositiva ed esecutiva; sensoriale, percettiva e sinestetica; musicale, cinematografica e pubblicitaria), man mano si è replicato su scala virtualmente infinita, al punto da omogeneizzare eventi e spazi pubblicitari, filmati a contenuto sociale e apparizioni divistiche, appelli umanitari ed altro ancora, in un’interconnessione che tutto uniforma e appiattisce.
Altresì, la novità ha coinciso con la diffusione dell’evento. Se all’inizio, sovente, le località in cui avevano luogo i concerti erano collegate come le emittenti radiofoniche che li trasmettevano, oggi l’evento è mandato in onda, in diretta, sui siti web ad esso dedicati, consentendo virtualmente a milioni di persone di essere spettatori, certo, ma pure d’interagire, scambiarsi opinioni sul concerto, discutere di musica e dei temi intorno al quale è costruito l’evento (musicale nello specifico, ma non solo). In sostanza, oltre che vedere un concerto, è possibile inviare messaggi agli artisti, inoltrare domande, seguire le conferenze stampa, leggere i documenti prodotti dalle organizzazioni impegnate nelle svariate cause che l’evento promuove. Qualcosa ancora una volta d’inedito, che pone sempre più nuove riflessioni circa le possibilità del futuro.
Se la novità s’è allargata a sviluppi e progressi d’impensabile realizzazione nel trentennio scorso – culminata con la diffusione di programmi e “file” informatici appositamente dedicati alla musica, che hanno reso possibile la duplicazione a distanza di brani o video musicali mediante la connessione – oggi Internet è il privilegiato canale di fruizione degli spettacoli rock. C’è da scommettere che, a breve, si possa assistere a vere e proprie Woodstock telematiche: il che imporrà ulteriori slittamenti e aggiustamenti di senso relativi alle concezioni di “luogo”, “evento”, “fruizione”, “trasmissione”, “partecipazione”. Quale potrà essere il ruolo del cinema in tutto questo, quali nuove forme di sinergia si svilupperanno con esso, lo stabilirà il Tempo.
In chiusura, chi scrive desidera dedicare queste righe al regista Donn Alan Pennebaker, eponima firma del genere “rockumentary”, scomparso la scorsa estate.


“A IDADE DA TERRA”:
IL TESTAMENTO DI GLAUBER ROCHA
di Giovanni Ottone
“A Idade da Terra”, il film testamento del maestro del cinema brasiliano Glauber Rocha (1939 – 1981), presentato in concorso alla 37. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia del 1980, fu considerato da molti critici, dopo quella prima proiezione, un’opera confusa ed irrisolta. Venne invece giudicato una lezione di cinema moderno e fu fermamente difeso da personalità quali Michelangelo Antonioni, Fernando Birri e Renzo Rossellini. Il film venne escluso dai premi e Glauber inscenò una clamorosa contestazione contro la direzione del Festival e la Giuria, denunciandone la possibile collusione con il sistema di potere di Hollywood e la preferenza per un cinema accademico e “pre-psicanalitico”. Il film costituisce un tentativo coraggioso ed eccessivo di sintesi vigorosamente e costantemente metaforica, essendo lontano dalla tentazione naturalista ed estraneo a qualsiasi visione illuminista. Contemporaneamente è un’immersione nella frammentazione e nella molteplicità della vita e dell’esperienza sociale brasiliana. Si può ipotizzare che Glauber abbia cercato il dialogo con maestri quali Eisenstein, Welles, Visconti, Buñuel e Godard. Nella sua ansia protesa ad una rappresentazione drammatica ed “epico – didattica”, sviluppa un’operazione esplosiva di de-costruzione della realtà e della drammaturgia classica, mescolando generi diversi: il documentario, la rappresentazione allegorica, lo sperimentalismo ed il manierismo che rammentano il melting pot dell’Udigrudi (deformazione ironico – nazionalistica dell’underground americano), ecc. Combina spazi fisici e scenari diversi: Brasília, l’interior del Brasile, Rio de Janeiro e Salvador de Bahia.
Pur essendo un film non narrativo e visionario, si può sinteticamente enunciarne il percorso attraverso le definizioni stesse che ne diede Rocha: “Nel film vi sono 4 diversi Cristo che poi sono i 4 Evangelisti, trasfigurati nei 4 Cavalieri dell’Apocalisse. Il Cristo Militare, capo e redentore dell’impero portoghese (Tarcísio Meira); il Cristo Nero, profeta politico ed intellettuale rivoluzionario (Antônio Pitanga);il Cristo Terrorista, il cangaceiro schizofrenico (Geraldo Del Rey); il Cristo Pescatore, simile al Cristo classico, che parteggia per il popolo lavoratore (Jece Valadão)……”; “Vi è una lunga marcia di personaggi in lotta contro Brams (Maurício do Valle che rappresenta il potere in tutte le sue forme metafisiche, metaforiche e anche realistiche. Egli è Cesare e anche Dio e il Diavolo”……; “La resurrezione di Cristo nel Terzo Mondo provoca un rovesciamento totale: la crocifissione di Cesare-Brams da parte di Cristo Terrorista suo figlio”. Esistono anche alcuni personaggi femminili principali: la Regina delle Amazzoni che poi diventa la Maddalena convertita, agitatrice politica, militante di strada e profeta e quindi il Cristo femminile (Norma Bengell); la Regina del Carnevale e Regina del Terzo Mondo, ispirata a Cleopatra (Ana Maria Magalhães); la Musa Bionda, moglie di Brams (Danusa Leão). Nel film la morte si sostanzia in Brams, figura di conquistatore capitalista, mescolanza di Cesare e Faust, che afferma il suo potere in un Paese periferico, di fronte ad un’élite locale debole e divisa la quale evoca vanamente un presunto passato glorioso…..”.
“A Idade da Terra” presenta varie parabole, con digressioni e ripetizioni, ma la metafora più potente è l’immagine biblica di un popolo, schiavizzato dallo sfruttamento imperiale, che edifica grandi tumuli. È un riferimento all’architettura monumentale di Brasília e rappresenta la sfiducia dell’autore rispetto allo spazio urbano. In contrapposizione Glauber inneggia all’energia popolare della nazione periferica. Seppure in forma frammentaria, squilibrata e contraddittoria, in una visione messianica della storia, ripone la speranza in un messaggio evangelico di rigenerazione della umanità, in un momento di crisi dell’Impero, e quindi di liberazione dell’oppresso attraverso la riappropriazione di un simbolismo sacro, altro rispetto a quello della gerarchia religiosa dominante. Quindi la vita trova il suo riferimento nella mitologia popolare, nella festa di strada, surreale e visivamente esuberante, nel carnevale, nella processione e nell’energia del rito che riunisce il popolo e si contrappone al progresso borghese. È una visione totalizzante, politicamente ambigua e precaria ed ingenuamente arcaizzante e nazionalista. Glauber, ansioso di marcare il suo ritorno in Brasile, dopo il complicato esilio, esprime l’esigenza di rappresentare il Paese come formazione sociale dotata di energia nelle manifestazioni di massa ludiche e religiose, ma soffocata da una classe dirigente anemica e dalla dominazione imperialista esterna. È una ricapitolizzazione storica che procede attraverso un’accumulazione di elementi e cerca di evidenziare, in forma delirante e provocatoria, una speranza, ma non delinea una nitida visione del presente.
“A Idade da Terra” è assolutamente straordinario a livello stilistico e tecnico. Glauber sviluppa creativamente una varietà incredibile di movimenti della cinepresa, in particolare i piani sequenza. Inoltre sperimenta un montaggio antinaturalistico che definisce “montaggio nucleare”, caratterizzato dal rifiuto di simmetrie e concatenazioni. Non si preoccupa della comunicazione classica, dell’esposizione tradizionale e di un linguaggio coerente delle immagini. È interessato al ritmo, al colore, ai gesti e ai suoni. Un altro elemento peculiare è la drammatizzazione sonora. Nel film vi è un totale sovvertimento dei concetti e degli standard tecnici riguardanti il suono. Glauber impone di includere suoni tecnicamente inferiori o intenzionalmente distorti, considerandoli poetici. Vi è un contrasto violento tra segmenti in cui prevale il silenzio ed altri saturi di suoni. Quindi si nota la predilezione per la rottura musicale esplicita ed il rifiuto della cosiddetta “musica di fondo”. Per concludere si può affermare che “A Idade da Terra” è un’esperienza visiva e sonora dove l’occhio dello spettatore, scorrendo sulle scene e sulle azioni che avvengono in successione simultanea, ne riordina la sequenza.
“Anabazys”(2007), di Joel Pizzini e Paloma Rocha, presentato alla 64. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia del 2007, è un documentario molto interessante e suggestivo. Non è un resoconto storico né un tributo, ma piuttosto un’indagine emozionante sulle motivazioni estetiche e politiche di Glauber nella fase febbrile di realizzazione di “A Idade da Terra”. Ricostruisce, con un percorso originale e creativo, la genesi, le fasi di rodaggio sul set, il montaggio, l’esibizione e la risonanza del film, esplorando anche i preconcetti che lo esclusero dal circuito cinematografico. Anabasis, parola che in greco classico significa marcia verso l’interno di un Paese, allude al titolo dato dallo stesso Glauber ad una delle prime versioni della sua sceneggiatura originale del film. Non è un tradizionale making of dell’opera di Rocha e non ha una struttura lineare. È composto da 11 nuclei autonomi che riguardano le posizioni politiche del regista sul regime militare nella fase di abertura e il processo esecutivo del film, vale a dire la concezione, l’interpretazione, i costumi, il “montaggio nucleare”, la colonna sonora (eseguita dal vivo durante lo stesso rodaggio) e la polemica provocata dal film alla Mostra Biennale di Venezia del 1980. Le denominazioni delle suddette sezioni del film sono le seguenti: anabasi; alba; la nascita della terra; metodo; personaggi; allegoria; luci del Terzo Mondo; suoni della Terra; trabicolado psicodélico; estetica del sogno; il Leone di Venezia. Nel documentario vengono mostrate scene di “A Idade da Terra”, ma anche scene inedite tratte dalle 60 ore di materiale rinvenuto, non utilizzato nel montaggio finale del film.
Il filo conduttore è quindi la narrazione in prima persona di Glauber, le sue molte “voci” e l’espressività delirante che scandiva la sua regia. Rocha entra nel suo film, attraverso dialoghi inediti con gli attori e i tecnici ed esprime anche pensieri e riflessioni visionari, estetici e politici, sulla storia e sul cinema del suo Paese. Pizzini e Paloma Rocha si sono avvalsi di testimonianze ed interviste di attori come Tarcísio Meira e di tecnici come il montatore Ricardo Miranda e i tecnici del suono Roberto Leite eOnélio Motta che hanno lavorato in “A Idade da Terra”, ma anche di amici e collaboratori di Glauber, come Gustavo Dahl, João Ubaldo Ribeiro e Odete Larae degli eminenti critici cinematografici brasiliani Ismail Xavier e Ivana Bentes. “Anabazys”è quindi un film che si colloca sotto un altro film, che ne ricrea la memoria della produzione, proponendosi di ampliare la percezione di quel “cinema spaziale” proposto da Glauber, che diventa attore della sua storia, all’apice del processo di rottura e rivoluzione del linguaggio cinematografico.
SAGGI
ROBIN WILLIAMS. IL RISVEGLIO DELLA LEGGEREZZA
di Roberto Lasagna

“In realtà era uno psicopatico totale, probabilmente un serial killer. Ma era il personaggio più dolce, simpatico e chiacchierone che avessi mai incontrato. Mi fece ridere sino alle lacrime”. A parlare così di Robin Williams è il regista Terry Gilliam, che si appresta a girare La leggenda del re pescatore (The Fisher King, 1991), un film in cui ritrova l’interprete di Mork e Mindy il quale, a detta di Gilliam, aveva già “salvato” il regista regalando dialoghi improvvisati e una generosa interpretazione per Le avventure del barone di Munchausen (The Adventures of Baron Munchausen, 1988). Per il nuovo incontro con l’attore diventato nel frattempo una star del cinema grazie a Good Morning, Vietnam (id. 1987) e L’attimo fuggente (Dead Poets Society, 1989), Gilliam sceglie un script di Richard La Gravenese che porta il fantasy medievale arturiano nella realtà americana dei primi anni Novanta, dimensione urbana segnata da egoismo ed accentuata emarginazione sociale. Il film, che diverrà tra le consacrazioni dell’estro creativo Williams, è il bizzarro contenitore della singolare natura del periodo. Commedia su due amici improbabili e, al contempo, elaborazione del lutto dagli echi tragici, La leggenda del re pescatore ha il dono della leggerezza irresistibile, nella descrizione del rapporto compensatorio e reciprocamente terapeutico tra due individui che si nutrono della loro relazione e cercano un senso al loro cammino. Jack Lucas, con il volto e la parlata sicura di Jeff Bridges, è il deejay compatto che si trova da un giorno all’altro per strada, cacciato dalla radio per aver incoraggiato uno dei suoi spettatori a sparare sulla folla; Parry, vagabondo di strada convinto di essere incaricato a trovare il Santo Graal, è un delirante ometto perseguitato da un sinistro cavaliere di fuoco, in realtà un insegnante di storia divenuto “Parry” dopo che sua moglie è stata uccisa nella sparatoria provocata dallo stesso Lucas. Secondo lo sceneggiatore, il film doveva aiutare ad illustrare l’egoismo rampante nell’era di Reagan, ma l’ispirazione arrivò anche da un libro dell’analista junghiano Robert A. Johnson intitolato “Cosa vuol dire essere uomini”, dove l’autore affronta la mente maschile attraverso figure mitologiche come il Re pescatore, personaggio mortalmente ferito che non può morire, che guarisce soltanto quando un pazzo innocente si presenta alla sua corte e pone una certa domanda. Quel pazzo innocente è il professor Henry Sagan, che presta a Robin Williams il pretesto per dare volto a un giullare disposto a mettere in luce la parte innocente e più fragile di noi, con la fiducia che ci proietta in avanti, verso il futuro dell’immaginazione, contro una visione paralizzante del sapere, quella rappresentata nel film dal personaggio di Bridges, che nega la necessità di una redenzione, trovandola poi però nella solidarietà verso Parry che gli consentirà di esplorare una parte preziosa di sé. Ed è per Williams, che ha appena lasciato il ruolo di mentore uscendo di scena ne L’attimo fuggente, una sfida come attore e uomo di spettacolo: affrontare la parte dell’individuo che si maschera e con le menzogne si fa scudo nei confronti di verità sgradevoli. Dopo l’indiavolato commentatore Cronauer che galvanizzava il risveglio delle truppe in Good Morning, Vietnam, l’inarrestata processione di personaggi improvvisati trova una condensazione spazio-temporale nel personaggio di Parry, come lanciato sopra il filo sottile della rimozione: uno psicolabile che ha dimenticato fatalmente l’origine del suo trauma.

Parry, come Williams, sembra recitare barcamenandosi, senza guardare la parte negativa dell’esistenza. Eppure Parry permette a Williams, con l’intuizione immaginifica di Gilliam, di liberare l’istrionismo dell’attore mostrando la complessità del suo personaggio, tanto che il regista avrebbe ricordato: “Toccava qualcosa dentro di lui. Era un comico, e tutti i comici vogliono essere Amleto, si sa. Vuoi dimostrare che non sei solo un pagliaccio, che dentro quel pagliaccio c’è una profondità, un’oscurità. E soffri. E penso che tutti i comici finiscano sempre per scrivere la loro autobiografia, nel tentativo di dimostrare quanto hanno dovuto soffrire nella vita”. Gilliam coglie benissimo Williams, a tal punto che le sue affermazioni non verranno smentite dai successivi lavori dell’attore, il quale sarà un redento uomo d’affari e smemorato Peter Pan in Hook (id., 1991) di Steven Spielberg, nonché un padre divorziato con un bisogno smisurato dei suoi figli in Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (Mrs. Doubtfire, 1993) di Chris Columbus. Sul set de La leggenda del Re Pescatore, Williams dà prova al fascinoso Jeff Bridges di non essere soltanto un impenitente battitore libero della parola, ma un interprete capace di delicatezza e sensibilità. La sintonia sul set si esprime nel film con il progressivo e rapsodico trasalimento del mondo emotivo dell’uno nella vita dell’altro personaggio. Uno svelamento dietro le maschere inavvertite come tali dai protagonisti, le cui vite si mescolano in un disegno mirabolante della solidarietà. Se c’è una commedia d’autore nella Hollywood dei primi anni Novanta, questa è propriamente La leggenda del re pescatore che mescola e confonde, assieme alle vite dei protagonisti, i canoni della commedia statunitense con le ruspanti esigenze delle corde stilistiche più personali di Terry Gilliam. Il talento visionario e l’energia narrativa dell’autore trovano il cuore di senso nell’appoggio che i due personaggi si scambiano. Tutta l’epica di un mondo medievale ritrovato nelle polveri dei contesti metropolitani si aggroviglia attorno alla vicenda del DJ che cambia lavoro e vita dopo essersi sentito responsabile di un delitto a causa della sua abituale arroganza, trovando una svolta nella figura del barbone che lo salva assieme ai suoi colleghi dopo che una sera viene aggredito da due ragazzi pronti ad ucciderlo. L’amicizia che nasce tra Lucas e Parry significa anche redenzione e riparazione, desideri che il DJ pentito e divenuto gestore di un negozio di videocassette avverte nei confronti di chi lo ha aiutato con un un gesto di lealtà lontano dalle sue abitudini. Il narcisista e il barbone pieno di tenerezza proiettano lo spettacolo in una fiaba scritta con meticolosa bravura, dove si fondono con armonia incubi, sogni, nel segno di un realismo drammatico che Gilliam altrove non padroneggia sempre con esiti altrettanto felici. Il posto del sentimento si esprime anche con il corteggiamento, stralunato ed irresistibile, che Parry rivolge alla stralunata Lydia (Amanda Plummer), alter-ego femminile della sua sbadataggine surreale. Williams, fluviale mattatore, qui pone il suo lavoro al servizio del comprimario Bridges che bilancia, recitando con tono di complicità, il graduale interessamento del cinico nei confronti del barbone delirante ma umanamente disarmante.
La solidarietà sociale così evadente nello spirito del film si esprime nella loro amicizia, in cui Williams, allucinato e messianico condottiero metropolitano, convince a un certo punto il suo scettico amico a condividere la sua fede folle, a dar spazio all’immaginazione; che in lui è scoperta dell’amicizia, della reciprocità, ma anche il riconoscimento di una necessaria liberazione la cui lezione di vita passa attraverso il progressivo mettersi a nudo. Il copione richiedeva che, allo Sheep Meadow di Central Park, Parry e Lucas si spogliassero, senza veli per affrontare insieme l’incoraggiamento ad essere liberi, come succede anche nella sequenza conclusiva del film. Una gioiosa innocenza che è quando Parry induce in Lucas, il quale ha sicuramente bisogno di ritrovare se stesso così come Parry ha bisogno di un amico che lo accompagni durante la sua scorribanda elettrizzata sul terreno dell’utopia. Tra chi vive il torpore e chi necessita di essere ridestato sui terreni dei significati condivisi, inevitabilmente Robin Williams è in questo periodo della sua vicenda artistica e professionale l’attore cinematografico che meglio incarna una raffigurazione del cuore pulsante dell’umanità, come avrebbe sottolineato sul “Chicago Trubune” Dave Kehr all’uscita del successivo film interpretato Williams, quel Risvegli (Awakenings, 1990) “il cui fascino poggia sulla sua capacità di proiettare sensibilità e compassione fino al punto in cui queste qualità sfociano nella demagogia”. Film che invece, per Robert Ebert il quale aveva accolto molto duramente L’attimo fuggente, è addirittura: “una delle migliori interpretazioni di Robin Willams, pura e incontaminata, senza le spumeggianti distrazioni che aggiunge a volte, senza gli sketch non richiesti”. Morale: Willams non avrebbe vinto alcun oscar né per La leggenda del re pescatore né per Risvegli, come saggiamente avrebbe presagito Gilliam: “Era così fiero della sua interpretazione in Risvegli. Ma gli dissi: ‘Rob, non vincerai mai. Ti mancano tutti i tic e le smorfie di De Niro. Quelli che vincono sono quelli con più tic”.
Nell’adattare per lo schermo il saggio del 1973 del neurologo Oliver Sacks, il regista Penny Marshall si affida alla sceneggiatura di Steven Zaillian e dà corpo, con Risvegli, a un film zuccheroso, condito degli stereotipi del cinema ospedaliero in salsa hollywoodyana, in cui il virtuosismo manifesto di Robert De Niro deve colpire a tutti i costi ed è nettamente sbilanciato rispetto alla misura di Williams che invece regala qualche nota di controllata umanità ad un contesto sensazionalistico. Williams, cui è affidato il ruolo del medico ispirato al vero lavoro di Oliver Sacks al Beth Abraham Hospital del Bronx, deve aver avuto buon prova di sé nell’affrontare un ruolo drammatico, proprio quando nessuno lo considerava un attore di tale capacità e poteva facilmente temere il confronto con Robert De Niro.
A Williams andò dunque il personaggio del medico che curò i pazienti sopravvissuti a un’epidemia di encefalite letargica, una malattia che li riduceva a uno stato catatonico, pur lasciandoli anche coscienti. Attraverso la somministrazione del farmaco L-Dopa, solitamente usato per il Parkinson, Sacks ottenne di rianimarli, di portarli letteralmente in vita, seppure soltanto per una stagione. I personaggi che si risvegliano alle pratiche quotidiane, che mangiano, camminano, sorridono e parlano dopo anni o mesi di catatonia, sembrano rievocare l’importanza del “cogli l’attimo” evocato dal professor Keating e Williams, che aveva paura che De Niro potesse metterlo in ombra, in realtà aveva scelto di prendere parte ad un film vicino alla sua sensibilità, non lo intimoriva il ruolo al confine tra ironia e serietà, secondo una modulazione che sarebbe stata oltremodo più accentutata, sul versante clownesco, soprattutto in Patch Adams (id.) del 1998. Laddove il risveglio è un’esortazione urlata alle truppe di Good Morning, Vietnam, oppure l’evocazione del professor Keating de L’attimo fuggente – film che racconta anche la storia di un giovane che vorrebbe fare l’attore, incapace di ribellarsi, ovverosia di ridestarsi, al cospetto di un padre severo che pretenderebbe che il figlio si dedicasse a una carriera più stabile – e ancora, dove il risveglio è quello reciproco dei due interpreti speculari de La leggenda del re pescatore in cerca di un senso nel loro smarrimento, i “risvegli” di Penny Marshall sono l’occasione per un confronto di attori che per Williams rappresenta però soprattutto l’opportunità per lavorare a fianco con lo stesso Sacks, operatore del settore medico intelligentissimo, compassionevole e gentile, uomo libero laureato in medicina a Oxford, appassionato di motociclette, sollevatore di pesi e autostoppista, vero ribelle che permise all’attore di studiare le riprese private realizzate in prima persona mentre curava i pazienti encefalitici fuoriusciti dallo stato catatonico anche solo per pochi istanti. Fuori dal significato metaforico del “carpe diem”, per Williams si trattò dell’occasione per dare una misura nuova al suo lavoro, per riflettere sulla millimetrica densità interpretativa della componente attoriale, per divagare su quella “magia” della vita che si esprime al mondo anche attraverso la fisiognomica del volto. “Sembrava di guardare qualcosa che a prima vista è morto, ma attraverso cui traspare ancora la mente e lo spirito umano”. Sacks si rivolgeva ai malati cui era stata somministrata L-Dopa, diceva loro “guarda” e loro di colpo, per un attimo, ritornavano. Questa fiducia nella terapia è in realtà fiducia nella presenza delle persone, che puntualmente poi si immobilizzavano di nuovo, ma potevano ridestarsi. Una fiducia nel risveglio, nella possibilità di ridestarsi. Ed è con questa fiducia che Williams, tra le star più affermate dei primi anni Novanta, inanella film senza sosta, alternando successi a flop che passano quasi inavvertiti, secondo una traiettoria che sarebbe troppo facile vedere calcolata nel minimo dettaglio. Senza l’incessante rincorsa dei “risvegli”, in film più o meno centrali, non avremmo avuto gli alti vertiginosi della sua carriera. Senza alcuni film minori e apparenti “passi falsi”, avremmo avuto di sicuro meno sperimentazioni rischiose e meno riuscite.
Un passo falso non è di certo Hook, film dagli esiti sotto tono ma rivalutato con il tempo dai suoi più scrupolosi esegeti, in cui Williams collabora in uno dei momenti più tesi e autobiografici del cinema spielberghiano. Mentre l’atmosfera dei romanzi di James Matthew Barrie è al centro del racconto, il cineasta immagina un sequel delle avventure di Peter Pan coadiuvato delle idee di Nick Castle e James V. Hart, ma soprattutto sceglie come protagonista del suo Peter Pan per il grande schermo da settanta milioni di dollari proprio Robin Williams, attore che per il cineasta raffigura al meglio lo spirito di Peter così come Richard Dreyfuss è dichiaratamente il suo alter-ego riconosciuto.
Per Steven Spielberg si tratta del primo film in cui si trova coinvolto in un progetto che non parte in prima istanza da lui; nondimeno, Hook è il veicolo per proporre una precisa volontà autoriale, in cui la cavalcata tra il sogno e il reale produce un’opera fantasy rivolta ad un pubblico adolescente sebbene si parli agli adulti, a cui si intende ricordare che l’esistenza è un’avventura straordinaria. E l’adulto Robin Williams è il tramite per modulare il racconto spielbeghiano rivolto al dialogo tra padre e figlio, con tutte le paure che derivano dalla disgregazione della famiglia e dal fatto stesso di crescere. Con il cuore rivolto a Frank Capra (l’immaginazione di una realtà altra) e a Fellini (il passato dai contorni mitici), Spielberg con Hook crea un contesto appesantito dalla concezione spettacolare ancora pachidermica, che salvaguardia solo a tratti un cuore vibrante, un segreto di leggerezza racchiuso nel pensiero felice che permette di vincere la paura di volare. Paura ed equilibrio sono al centro del lavoro del cineasta, che in Williams individua l’uomo impietosamente soggiogato dal ticchettio del tempo. Questi è Peter Banning, avvocato in carriera che trascura moglie e figli per il lavoro; egli accusa il figlioletto di non crescere ma è lui in realtà ad essere cresciuto troppo in fretta, a tal punto di aver dimenticato di essere il vero Peter Pan. Durante un viaggio a Londra (sul volo che epifanicamente si annuncia della “pan am”) i suoi figli vengono rapiti da Capitan Uncino (Dustin Hoffman) mentre la nonna Wendy (Maggie Smith) gli rivelerà il segreto importante della sua vita: lui è Peter Pan ma con il tempo ha dimenticato di esserlo, dedicandosi a un’esistenza priva di immaginazione. Grazie a Trilli (Julia Roberts), Peter verrà trasportato verso l’Isola che non c’è dove potrà salvare i suoi figli. L’immaginazione al potere è qualcosa che per Peter Banning suona strano, eppure dovrà ricredersi. Le aspettative dei figli e le effettive risposte dei genitori creano un contrasto che sbilancia le esistenze generando scompenso, nella disarmonia che si palesa tra il principio del piacere e il principio di realtà. Alla dittatura del tempo è ben allineato Capitano Uncino, cui Dustin Hoffman restituisce una caratterizzazione del cattivo di sontuosa prestanza: tanto Uncino è pensante e lucidamente consapevole del suo ruolo cinico, tanto Peter Bannie è svagato e privo di reale dimensione tragica. Quest’ultimo, nella personificazione di Robin Williams, è davvero una figura di leggerezza che vive di proiezioni altrui: l’amore di Trilli, che strappa un bacio dichiarando il suo sentimento impossibile, quello eterno di Angela Moira Darling, quello dei “bimbi perduti” che ripongono in lui la promessa di una figura paterna che Uncino, luciferinamente e in modo surrogato, finisce per incarnare per i veri figli di Peter, quando questi dedica loro le irresistibili lezioni su come i genitori odino i propri figli. La musica di John Williams – l’altro Williams di Hook – accompagna con note wagneriane l’ascensione di Peter verso la consapevolezza di potere volare nell’isola che non c’è. Un’universo parallelo, dalle scenografie sontuose e dalle atmosfere retrò, dove un certo idealismo pedagonico trova nei volteggi di Robin Williams – che per la parte perde anche nove chili – il terreno immaginario propizio, in ultima analisi, per un racconto sul tema dell’abbandono, da se stessi e a se stessi, nell’orbita di una lezione disneyana modulata sui temi della disgregazione della famiglia; aggiornamenti che appartengono tanto a Spielberg quando al Robin Williams di Mrs Doubtfire e di altri film che faranno seguito.


BREVE ABC BELLOCCHIANO:
AUTOBIOGRAFIA-BOBBIO-(FARE)CINEMA
di Roberto Baldassarre
Marco Bellocchio, nato a Bobbio il 9 novembre 1939, esordì nel 1965 con l’arrabbiato lungometraggio“I pugni in tasca”, massima espressione di una fugace nouvelle vague italiana. Marchiato da questo furente esordio come un arrabbiato, a cui seguirono per almeno un decennio altre feroci pellicole contro le istituzioni, il suo tono con il passare degli anni si è lentamente addolcito, benché la stoccata verso la società permanga tagliente. Come lui stesso ha confermato, questo percorso di cambiamento è stato anche per merito delle analisi collettive di Massimo Fagioli, con cui ha collaborato in modo stretto in tre pellicole (“Diavolo in corpo”, “La condanna” e “Il sogno della farfalla”). Le sue pellicole, sin dall’esordio, raccontano la realtà italiana con piglio grottesco, come già confermano i cognomi di molti personaggi, che sono allegorie del loro comportamento. Nella sua corposa carriera è possibile mettere in rilievo un breve ABC, composto da tre argomentazioni che alimentano il suo cinema: Autobiografia – Bobbio – (Fare) Cinema. Tre elementi che nelle ultime due decadi si sono amalgamate con frequenza.
AUTOBIOGRAFIA
Un elemento fondamentale dell’opera di Marco Bellocchio è lo spunto autobiografico. Spesse volte viene trasfigurato, ad esempio utilizzando un alter ego o delle metafore, e altre volte si manifesta esplicitamente, per esempio quando si mette in scena lui stesso. Già ambientare una storia a Bobbio comporta inevitabilmente un avvicinamento tra la finzione cinematografica e la vita vissuta. “I pugni in tasca” (1965), suo fulminante esordio nel lungometraggio, era ambientato nel borgo natale e, in particolare, nella casa di famiglia.
Tale particolare scelta, che fu dettata per semplici motivi di budget, era una trasfigurazione della sua rabbia contro l’istituzione familiare. Benché il nucleo è una famiglia benestante piacentina, l’arrabbiato pugno è contro l’istituzione in generale (che successivamente si perpetuerà con altre istituzioni classiche: scuola, corpo militare e chiesa). La vera realtà e il vero astio autobiografico appaiono nel film nelle uscite di Ale (Lou Castel) e di sua sorella Giulia (Paolo Pitagora) nel borgo natio. Il mirino registico è lo stesso occhio di Bellocchio, quindi senza ricostruzioni, che inquadra Bobbio come un paese agricolo, gretto e asfissiante. Questa rabbia autobiografica sarà messa in scena anche in “Nel nome del padre” (1972), e il pensiero di Bellocchio si scinderà in due personaggi: nel nevrotico e succube studente Franco (Aldo Sassi) e nel sicuro e pragmatico Angelo Transeunti (Yves Beneyton), che sfida schernendola l’istituzione scolastica. La funzione di un alter ego, però, sarà più forte e meno sfumata in tre opere successive, che a loro modo mostrano a tappe lo stato psichico di Bellocchio: “Il gabbiano” (1977), “Gli occhi, la bocca” (1982) e L’ora di religione (2001). Ne “Il gabbiano”, trasposizione televisiva dell’omonima pièce di Anton Checov, il personaggio del giovane drammaturgo Konstantin (Remo Girone) rappresenta la sua insoddisfazione di autore, frustrato da una madre “diva” e con l’opinione di aver realizzato solo opere mediocri. In “Gli occhi, la bocca” l’elemento autobiografico è alla base della storia, cioè il suicidio del fratello gemello, e Giovanni Pallidissimi (Lou Castel) è l’alter ego cinematografico di Bellocchio, che non a caso ha scelto il protagonista de “I pugni in tasca”. Infine, in “L’ora di religione” Ernesto Picciafuoco (Sergio Castellitto) è una variante, non tanto camuffata, del regista stesso. Con quest’opera Bellocchio affrontava l’uscita dal nucleo familiare (e il giudizio sulla figura materna) con un piglio rilassato, senza matricidio o profondi rancori. La corrispondenza tra Bellocchio e l’illustratore Picciafuoco è anche data dai quadri e dai disegni che appaiono nel film, che sono stati realizzati dello stesso regista.
Di altro tenore sono le opere in cui Bellocchio mette in scena se stesso. Se in “Matti da slegare” (1975) e “La macchina cinema” (1978) è semplicemente Marco Bellocchio regista dentro l’inquadratura, in “Vacanze in Val Trebbia” (1980) è se stesso, ma allo stesso tempo “recita” Bellocchio. Questo documentario, girato a Bobbio e dintorni, è stato realizzato come un filmino familiare, in cui l’autore (che aveva cominciato l’analisi collettiva) accompagnato dalla moglie Gisella e il figlio Pier Giorgio, riflette sulle sue radici natie, ed è pensieroso se reciderle definitivamente per affrontare una nuova vita personale e cinematografica (“Gli occhi, la bocca”, benché è una autobiografia trasfigurata, non venne girata a Bobbio).
Gli aspetti autobiografici, però, possono anche restare in bilico, cioè veri ma esposti in modo cinematografico. In “Sorelle Mai” (2010), prolungamento del precedente mediometraggio “Sorelle”, Bellocchio mette in scena la storia delle sue due sorelle e vi affianca una storia di finzione con attori cinematografici, e come ponte tra i due mondi (reale e fittizio) c’è il personaggio di Elena (Elena Bellocchio). Tra l’altro, in “Sorelle Mai” c’è un perfetto connubio artistico tra Autobiografia – Bobbio – (Fare) Cinema, perché oltre a trattare un argomento autobiografico e con alcuni attori del nucleo famigliare, la pellicola è stata girata a Bobbio e realizzata attraverso Fare Cinema (oltre a contenere alcune sequenze de “I pugni in tasca”). “Sangue del mio sangue”, pellicola di “genere”, nel suo tessuto cinematografico di finzione contiene anch’esso qualche elemento autobiografico. Le due vicende, distanti di secoli, sono ambientate a Bobbio; la storia del suicidio del fratello gemello di Federico Mai è una trasfigurazione del suicidio del gemello di Bellocchio (già affrontato in “Gli occhi, la bocca”, ma secondo lo stesso regista non fu soddisfatto di quel risultato); Pier Giorgio ed Elena, fratelli nella realtà, interpretano i due fratelli nella Bobbio odierna.
Rimanendo nell’ambito autobiografico, una menzione a parte riguarda l’utilizzo dei membri della propria famiglia. Se ne “I pugni in tasca”la famiglia aveva collaborato dall’esterno, finanziando la pellicola, nelle successive opere il regista piacentino coinvolge i propri parenti anche come attori. Innanzi tutto Bellocchio si è fatto affiancare dalle compagne, che vanno anche a segnare dei cambi stilistici/emotivi nella carriera del regista: l’impegnata Elda Tattoli (“I pugni in tasca”, “La Cina è vicina” e l’episodio “Discutiamo, discutiamo”); la tradizionale Gisella Burinato (“Nel nome del padre”, “Il gabbiano”, “Vacanze in Val Trebbia”, “Salto nel vuoto”); la montatrice Francesca Calvelli, con cui collabora e vive sin da “Il sogno della farfalla”. Ci sono poi le sue sorelle (Elena Bellocchio, Maria Luisa Bellocchio e Letizia Bellocchio) che compaiono in “Sorelle mai” e in alcuni cortometraggi di Fare Cinema, e i suoi due figli, Pier Giorgio ed Elena. Se Pier Giorgio nelle pellicole del padre ha interpretato ruoli totalmente di finzione, escludendo “Vacanze in Val Trebbia”, “Sorelle mai” e qualche cortometraggio, Elena ha praticamente interpretato sempre se stessa. Esordì nel cinema paterno con il cortometraggio di Fare Cinema a lei dedicato, “Elena” (1997). Successivamente interpretò ruoli adatti alla sua età (bambina senza nome in “L’ora di religione” e in “Buongiorno, notte”), e fu nuovamente se stessa nelle successive opere paterne: “Sorelle”, “Sorelle Mai”, “Sangue del mio sangue” e nel corto “Per una rosa”.
BOBBIO
Bobbio è il nucleo d’origine, dove tutto ebbe inizio. È un piccolo comune situato nella provincia di Piacenza, nell’entroterra italico. Luogo al principio odiato e alla fine accettato dopo un lungo percorso di analisi. Bobbio è divenuta nota cinematograficamente, attraverso differenti tappe psicoanalitiche distanti di anni, proprio attraverso le pellicole del regista piacentino. Gretto sfondo ne “I pugni in tasca”, veloce sfondo in “Nel nome del padre”, luogo tanto magico quanto frustrante in “Vacanze in Val Trebbia” (1980), e infine luogo di riappacificazione come mostrano i cortometraggi realizzati nell’ambito del laboratorio Fare Cinema. In questo caso, però, Bobbio non viene scelta per particolari meraviglie paesaggistiche, ma semplicemente perché è una pratica location low cost, proprio come accadde per il suo esordio registico. Per il momento le ultime immagini di Bobbio, escludendo i saggi finali realizzati durante Fare Cinema, sono quelle contenute in “Sangue del mio sangue”.
Bobbio, in quest’ultima opera, diviene sineddoche dell’Italia, con un passato politicamente violento e tragico, e un presente ormai lieve e farsesco.
(FARE) CINEMA
Fare Cinema è un laboratorio che fu ideato e creato da Bellocchio nel 1995, nel proprio borgo natale di Bobbio. Il regista piacentino lo ha creato per dar modo ai giovani, che vogliono fare regia cinematografica o recitazione, di avere un vero contatto con la creazione e la modellazione di una pellicola. Un’esperienza non dissimile da quella ideata qualche anno prima da Ermanno Olmi con Ipotesi cinema (1982). Per come è organizzato il laboratorio, non è errato pensare a un’analisi collettiva traslata in workshop cinematografico. Da questa “bottega” ogni anno viene forgiato un saggio finale, sotto forma di cortometraggio, realizzato da Bellocchio, che dovendo fare leva su un budget pari a zero, utilizza come sfondo Bobbio e come attori alcuni membri della sua famiglia (in particolare Pier Giorgio ed Elena). Attraverso Fare Cinema, e la realizzazione in video delle opere ideate, Bellocchio è come se tornasse un regista alle prime armi, dovendo realizzare il cortometraggio con poco, oppure avere massima libertà di espressione come con “Vacanze in Val Trebbia”. Questi piccoli “esperimenti”, però, hanno anche dato degli spunti a Bellocchio per le sue opere di grande formato. “Sorelle” è un assemble di vari pezzi realizzati a distanza di anni: 1999, 2004 e 2005. Nel 2010 questo montaggio si è completato con altri tre parti e ha formato “Sorelle Mai”, che fu presentato al Festival di Locarno nel 2010. La scena finale di “Sangue del mio sangue”, in cui Suor Benedetta che era stata murata viva viene liberata, e invece di essere invecchiata come gli altri personaggi è di una bellezza sfolgorante che uccide il Cardinale Mai, era un’immagine venutasi a creare proprio in uno dei workshop.
IN VIDEO VERITAS?
di Roberto Baldassarre
Nel 1995 Roger Odin pubblicò il libro “Le film de famille – Usage privé, usage public”, saggio in cui rifletteva specificamente sui filmini realizzati in famiglia, e di come la loro fruizione con il tempo fosse mutata. Da notare che quando Odin pubblicò il libro, la tecnologia video era certamente migliorata (costi molto meno eccessivi, e la possibilità di visionare il girato rapidamente), ma internet era ancora un medium a disposizione di pochissimi.
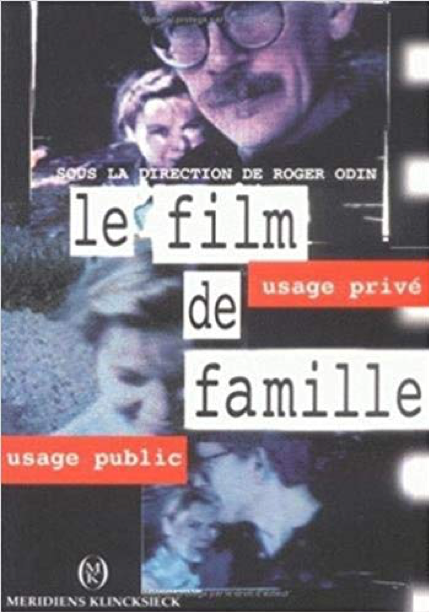
Con il nuovo millennio le due tecnologie (il video e il web) hanno avuto un percorso evolutivo abbastanza simile, e ciò ha permesso che il passaggio da visione privata (rivivere il momento da soli o al massimo con la propria famiglia o i propri amici) a visione “pubblica” (la condivisione di quel momento con persone sconosciute) sia ormai divenuta risibile.
I filmini familiari si realizzano primariamente per questioni affettive: immortalare momenti felici e poterli rivedere infinite volte anche in futuro, da soli o con un ristretto gruppo di conoscenti. Inoltre, almeno fino a tre decadi fa, la realizzazione di un filmino significava anche marcare un acquisito status symbol, perché la famiglia possedeva una cinepresa o una videocamera, un bene certamente non comune. Basandosi sul primo punto, per testare l’emotività che può suscitare un vecchio filmato, è utile recuperare il videoclip degli Squeeze “Last Time Forever”, realizzato nel 1985. Nel video, oltre alla band inglese che esegue il pezzo (in playback), vediamo un anziano che sta guardando in solitaria un vecchio filmato nella quale c’è una giovane ragazza sorridente sulla spiaggia. Si può facilmente dedurre che sia una sua giovane fiamma, e così comprendere anche la rabbia dell’anziano nel (ri)vedere un passato – felice – che non tornerà più. La giovinezza è rimasta intatta solamente in quel filmato, “un’ultima volta per sempre”.
Il secondo punto è ormai svanito, essendo la tecnologia a portata di tutti, ma la grande importanza in passato di questo bene tecnologico è attestato dai filmini privati che sono innestati nelle pellicole cinematografiche, che non a caso è sempre e solo materiale proveniente da famiglie facoltose (artisti o ricchi d’origine).
Dal lontano testo di Odin si può anche constatare che in questo ultimo lustro è sorto un nuovo tipo di filmino privato, cioè il video-selfie. L’utente riprende se stesso, principalmente in primo piano, mentre fa cose comuni o con altre persone. Questa specie di “One Man Show”, mentre tiene in mano lo smartphone (ormai divenuto una videocamera 2.0) parla direttamente all’obiettivo, che è come uno specchio in cui si riflette, e snocciola opinioni da condividere agli spettatori/seguaci. Questa nuova tipologia di video non è assolutamente realizzata per se stessi (se non per saziare la propria vanità in stile Regina Grimilde di “Biancaneve e i sette nani”), ma è creata solamente per raccogliere consensi pubblici sui social. Benché rappresenti un momento comune, tale video amatoriale non è esente da aggiustamenti (ripetizione dell’azione se è risultata goffa o se c’è stato un impappinamento nel pronunciare un discorso, oppure aggiustamenti con filtri fotografici per risultare più affascinanti). Un esempio lampante sono i video-selfies dei politici, che comunicano al popolo attraverso un breve video. Tattica comunicativa – purtroppo – funzionale che fa sembrare l’uomo di potere vicino alla gente, come un uomo comune che parla faccia a faccia con un linguaggio giovane.
Ritornando al filmino privato classico, bisogna fare delle distinzioni, e anche in questo caso si ritorna al saggio di Roger Odin. La prima diversificazione da eseguire è tra filmini privati ed ego produzioni. Ambedue sono filmini casalinghi, cioè realizzati in ambito domestico con i propri congiunti o con amici, quello che cambia è l’approccio alla realizzazione.

Il filmino familiare classico è quello sciatto, con molte immagini sfocate o sghembe e un montaggio fatto solo accendendo o spegnendo la videocamera. Non vi sono scene create ad hoc, quello che si vede è quanto accadeva in quel momento. Le ego produzioni, invece, sono realizzate con più cura. Il video-maker, benché dilettante, prepara la scena (detta ordini alla famiglia su quali azioni deve eseguire) e sceglie il taglio d’inquadratura più adeguato. Successivamente il video-maker monta il video, aggiungendoci della musica oppure un commento orale. Roger Odin definiva queste realizzazioni una negazione rispetto al filmino di famiglia classico, ed elencò in tre punti in cosa consisteva questa differenza:
- Colui che fa del cinema privato vuol fare del cinema;
- Colui che fa del cinema privato si considera a tutti gli effetti come autore che si vuole esprimere;
- Colui che fa del cinema privato fa un film con il quale entra in comunicazione con i suoi spettatori;
Una riflessione cinematografica su questo status egocentrico fu realizzato da Krzysztof Kieślowski con “Amator” (“Il cineamatore”, 1979), pellicola nella quale mostrava un operaio che una volta comprata una macchina da presa Quasar 2 (status symbol nella Polonia comunista), per dilettarsi a riprendere alcuni piccoli avvenimenti celebrativi, si appassionava talmente tanto al mezzo, per cercare di riprendere la realtà con stile, che si alienava dalla vita reale e stava perdendo tutto della sua vita privata.
Per quanto riguarda i filmini privati classici, invece, bisogna fare delle distinzioni, per mettere in evidenza delle particolari varietà che si possono riscontrare in tale ambito. Si potrebbero elencare in tre punti:
- Filmino familiare;
- Filmino amatoriale di una “papera”;
- Filmino porno;
Come scritto poc’anzi, i filmini familiari sono solo rozze riprese, senza un vero montaggio, fatte da parenti o amici che riprendono quegli avvenimenti legati a circostanze festose (nascite, battesimi, comunioni, matrimoni, anniversari ecc.). Usualmente gli spettatori che assistevano a questi video erano sempre un gruppo ristretto di parenti o amici (a volte invitati con l’inganno a una cena). Solo in questi ultimi anni la gente mette il video, tranciato in spezzoni brevi e con una cernita delle scene migliori, anche on-line, per condividere il momento e/o creare invidia se l’avvenimento era stato lussuoso.
Il filmino contenente una “papera”, cioè una gaffe, è un video realizzato casualmente, in cui l’amatore ha ripreso, per esempio, la caduta ridicola di una persona. In una pellicola normale, o anche in una ego-produzione, sarebbe considerato un blooper, una scena da eliminare e quindi da ripetere, ma attraverso trasmissioni televisive come l’italiana “Paperissima”, questi tipi di filmati sono diventati un “genere” di successo. Sono dei brevissimi filmati della durata di una gag e hanno uno stile arrabattato, proprio perché la ripresa è avvenuta casualmente. Questi video sono divenuti virali (a distanza di anni “Paperissima” ripropone ancora video di oltre vent’anni fa), e l’importanza di questi filmati casarecci risiede nel fatto che il realizzatore brama nell’inviare queste goffe scene solo per ottenere i famosi 15 minuti di gloria (benché la gloria andrebbe cronometrata in secondi) fregandosene del ridicolo.
Infine ci sono i filmini porno amatoriali. Quasi sempre è una videocamera fissa puntata verso l’alcova, ma ultimamente si stanno affermando video realizzati con la videocamera a mano. Tali filmini vengono realizzati per puro piacere feticistico e/o voyeuristico dalla coppia (che non sempre sono marito-moglie o fidanzato-fidanzata). A volte vengono messi direttamente on-line dalla stessa coppia, perché hanno delle pulsioni esibizioniste, ma altre volte finiscono in rete, e vengono visti e apprezzati da tutti, perché sono stati rubati da qualche hacker. Questi sono i veri video “familiari”, che divengono virali, perché un utente/spettatore ha il desiderio di vedere l’intimità di due persone, soprattutto se sono famosi. Ad esempio qualche tempo fa il video hard di Belen, realizzato a uso e consumo della coppia, fu trafugato e messo on-line e visto da milioni di persone, non solo da parte di erotomani ma anche da semplici utenti curiosi di vedere la nota soubrette nella vita intima.
Quel che è certo è che tutte e tre le tipologie vorrebbero riprendere la vita familiare e/o di coppia in modo onesto, senza nessun filtro. Escludendo il video con le “papere” (benché anche in questo caso si potrebbe speculare se sono effettivamente vere), purtroppo anche questo proposito non si realizza completamente, perché quando il soggetto sa di essere ripreso, le sue reazioni non saranno mai spontanee al 100%, ma saranno tutto sommato controllate per timidezza oppure alterate per manie di esibizionismo.
Rapportando questo tipo di “genere”, cioè il filmino familiare, con il cinematografo, si possono riscontrare differenti pellicole che lo hanno utilizzato. Il privato rinvenuto – a distanza di anni – viene reso pubblico, e con dei piccoli aggiustamenti trasformato in una narrazione classica. L’utilizzo è avvenuto con diverse graduazioni di utilizzo del materiale. Quando si impiega questo materiale privato si potrebbe parlare di “biopic di montaggio”, perché si ricostruisce il profilo di una persona (o di una famiglia) attraverso i filmati privati originali.
Il mostrare un momento familiare privato a un pubblico di sconosciuti, però, non è propriamente una prassi di questi ultimi decenni. Tra i dieci filmati che i fratelli Lumiere proiettarono il 28 dicembre del 1895, c’erano anche due filmini familiari. I dieci rulli mostrati erano esperimenti atti a mostrare alla gente il movimento fotografico, riprendendo luoghi, fatti e gesti di vita quotidiana. “La pêche aux poissons rouges”e “Le repas de bébé” (“La colazione del bambino”) sono a tutti gli effetti preistorici filmini familiari, che mostravano due momenti divertenti nella vita della famiglia Lumiere, con protagonista una neonata (Andrée, figlia di August e Marguerite).
Un caso “estremo” di “biopic di montaggio” fu “Un’ora sola ti vorrei” (2002) di Alina Marazzi, costruito completamente con i filmini girati dalla famiglia e commentati dalla lettura, da parte della regista, dei diari della madre. Quest’opera era da un lato un modo, per la figlia, di recuperare il volto, le parole e i gesti della madre Luisa, perduta e non completamente conosciuta; e dall’altro un modo di condividere con altri la figura di Luisa Hoepli attraverso il suo privato, e mostrare che non fu solamente una giovane donna che si suicidò.
Opera similare, presentata al Festival di Venezia del 2004, nella sezione “Nuovi territori”, fu il catalano “Un instant en la vida aliena”(2003) realizzato da José Luis López-Linares e Javier Rioyo. Anch’esso si può benissimo considerare come un “biopic di montaggio”, benché all’inizio ci sia l’intervento di López-Linare, che come un professore spiega quello che si vedrà. La pellicola è una condensazione del vasto materiale (circa 900 bobine) realizzato da Madronita Andreu (1895-1982), figlia del ricco industriale farmaceutico Dottor Andreu. La grossa mole filmica, girata tra gli anni ’20 e la seconda metà degli anni ’70, immortalava la vita, i costumi e i viaggi per il mondo della facoltosa famiglia. I due autori hanno montato il materiale per mostrare, attraverso gli occhi di Madronita, la vita della sua agiata famiglia, e anche per descrivere, con questo “found footage” una Spagna ormai scomparsa.
A lato di queste due opere si può affiancare il cortometraggio “A song of Air” (1987) di Merilee Bennett, che in un certo qual modo è in bilico tra ego-produzione e “biopic di montaggio”. Il materiale di partenza è una precisa scrematura di tutti i filmini che il padre della Bennett aveva girato con la famiglia. La particolarità è che il genitore aveva il vezzo autoriale, e amava costruire le scene tagliando in un certo modo l’inquadratura e indicando ai congiunti cosa dovevano fare davanti l’obiettivo. La Bennett monta il materiale scelto apponendo freeze-frame, graffi, commenti ecc.. Il suo lavoro è come se fosse una ribellione nei confronti dell’egoismo paterno, che costrinse, anche con fragorose sgridate, lei e gli altri a recitare, e a non essere semplicemente stessi.
In altre opere, invece, il materiale privato svelato a un vasto pubblico non familiare, può essere di dosaggio minimo o irrisorio. Tali filmati sono quasi sempre innestati con scene di pura finzione o interviste ad altre persone. Attraverso queste differenti percentuali, che non occupano tutta la pellicola, si potrebbe parlare di “biopic cine-memorialistico”.
Ad esempio il documentario “Jag ä Ingrid” (“Io sono Ingrid”, 2015) di Stig Björkman, è un “biopic cine-memorialistico”, composto visualmente al 60% dai filmini che la Bergman aveva girato personalmente, al 25% da materiale d’archivio (backstages o cinegiornali) e al 15% dalle interviste ai suoi figli. “Io sono Ingrid”, come già faceva “Un’ora sola ti vorrei”, come commento alle immagini fa ampio uso della lettura dei diari o delle lettere della Bergman, letti da sua figlia Isabella Rossellini. Questo documentario, ricco di materiale raro, sceglie di descrivere la carriera – e la vita – dell’attrice svedese attraverso l’intimo (come se fosse un backstage), mostrando soprattutto la sua vita familiare, e facendocela (ri)vedere come una donna normale, in particolar modo la sua stagione italiana.
Altro “biopic cine-morialistico” interessante è “Stanley Kubrick: A life in Pictures” (2001) di Jan Harlan, realizzato dopo la morte del noto autore cinematografico. Il cognato ha inserito nel tessuto della pellicola, che ripercorre in modo cronologico la vita del regista, qualche filmino familiare privato. I brevi filmini amatoriali, realizzati dallo stesso Stanley Kubrick, maniaco della sua privacy, mostrandoli pubblicamente divennero come un fatto epocale, perché veniva resa pubblica la sua super segreta vita privata. Fino a quel momento le uniche immagini private di Kubrick erano quelle apparse nel backstage di “Shining”, girato da sua figlia Vivian alla fine degli anni Settanta.
A lato di queste realizzazioni, c’è un altro particolarissimo filmino di famiglia, anzi “filmino delle vacanze”, cioè “Vacanze in Val Trebbia”, realizzato da Marco Bellocchio nel 1980. Il regista piacentino era andato con sua moglie Gisella e il figlio Pier Giorgio in vacanza a Bobbio, e si portò dietro anche una cinepresa 16 mm per filmare quella permanenza nel luogo natio. Da un lato Bellocchio filma quello che accade, in presa diretta, ma dall’altro costruisce le scene, soprattutto quelle oniriche. Vacanze in Val Trebbia, quindi va considerato come una “ego-produzione”.
Altra espressione di ego-produzione privata trasposta in seguito – casualmente – al cinema, è quella presente nella raccolta “Chaplin Unknown” (“Chaplin sconosciuto”, 1982) di Kevin Brownlow e David Gill. Tale antologia mostrava materiale raro girato da Charlie Chaplin, sia come regista professionista e sia come padre di famiglia con il vezzo del filmino amatoriale. Tra la mole di materiale montato, è interessante quello contenuto nella terza sezione intitolata “Hidden Treasures” (Tesori nascosti), che contiene alcuni filmini familiari girati da Chaplin nella sua villa in Svizzera. Charlie Chaplin, benché lontano dall’industria cinematografica, continuava a girare soprattutto dei filmini in famiglia per successive allegre visioni con la sua famiglia. Non dei semplici filmati, ma creando delle scenette in cui lui era il giullare protagonista, ancora in forma per piccole gag comiche. E restando nel passato, un filmino privato reso pubblico fu quello in cui si vedevano Stan Laurel & Oliver Hardy sorridenti e giocosi, ma ormai vecchi. Questo brevissimo filmato, realizzato nel 1956, era stato girato per sigillare un momento felice: l’incontro tra i due dopo che Stan aveva avuto un attacco di cuore. Il filmino purtroppo trasuda tristezza, perché si vede Hardy terribilmente dimagrito, e da lì a qualche mese sarebbe morto. Un filmino privato che ha segnato l’ultima apparizione pubblica del duo comico.
Restando sui filmini familiari, di vacanza o amatoriali innestati nel tessuto di una pellicola di fiction, sono interessanti i finti Home Movies spacciati per veri. Per esempio in “Dillinger è morto” (1969) di Marco Ferreri, il protagonista Glauco (Michel Piccoli), a un certo punto della sua noia, si proietta alcuni filmini girati durante una vacanza in Spagna. In realtà quel materiale è parte del documentario “Corrida!” (1966) girato dallo stesso Ferreri.
Altro esempio potrebbe essere quello dei titoli di testa di “Mean Streets” (1973) di Martin Scorsese, in cui un proiettore mostra dei filmini della vita familiare dei protagonisti, ma girati dallo stesso regista. Oppure, restando a Scorsese, i filmini girati ad Hoc in “Racing Bull” (“Toro scatenato”, 1980), in cui vediamo Jack e il fratello insieme alle consorti. Ulteriore esempio di filmino (finto) dentro una pellicola di fiction si trova anche in “Philadelphia” (1993) di Jonathan Demme. Dopo la morte del protagonista Andrew (Tom Hanks), la sua famiglia rivede una videocassetta in cui rivediamo la vita di Andrew.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
LE PROFESSIONI DEI SOCI FEDIC
di Roberto Merlino
Tutto è cominciato da una richiesta dell’amico Paolo Micalizzi: “Perché non fai un articolo sulle professioni dei Soci FEDIC?”
Mi è sembrata subito un’idea interessante e ho accettato.
Per poter affrontare l’argomento, inutile dirlo, occorreva procurarsi una serie di dati.
Istintivamente ero (e sono) abbastanza scettico sulla possibilità di realizzare un censimento “scientificamente” valido, cioè fondato su una quantità di dati pressoché vicina al 100%: conosco bene la pigrizia della gente (e in particolare dei nostri Soci) nel rendersi disponibile a interagire e collaborare.
Comunque, mi sono buttato nell’impresa, cercando di fare del mio meglio.
Per prima cosa ho ritenuto importante contattare i Presidenti dei vari Cineclub, affinché diffondessero tra i loro Soci la richiesta di sapere quale professione facessero.
A questo proposito ho preparato una scheda, di facile compilazione, in cui venivano richieste 4 cose: 1) nome, 2) cognome, 3) Cineclub di appartenenza, 4) posizione lavorativa.
Sul punto “4” le opzioni erano: “pensionato”, “studente”, “disoccupato”, “occupato” (in quest’ultimo caso andava specificata la professione).
Chi voleva, inoltre, poteva lasciare un numero di cellulare per una eventuale piccola intervista telefonica.
L’intera operazione comportava un impegno inferiore ai 5 minuti (dalla lettura della mia mail alla compilazione della scheda e re-invio).
La spedizione ai Presidenti è stata effettuata dall’amico Enzo Bruno, Segretario FEDIC.
Ho lasciato quasi un mese di tempo per poter rispondere e, alla fine, mi sono ritrovato con i dati di 232 Soci FEDIC.
51 sono i Soci che mi hanno risposto direttamente;
50 forniti dal Presidente del Cineclub FEDIC di Cagliari, Pio Bruno; 45 da Lorenzo Caravello, per i Cineamatori delle Apuane di Carrara; 40 dalla Segreteria di Corte Tripoli Cinematografica;
29 dal Presidente del Sedicicorto di Forlì, Gianluca Castellini;
17 dalla Segreteria del Fotovideo Genova.
Parallelamente ho richiesto alla Presidenza e alla Segreteria FEDIC l’elenco dei Cineclub regolarmente iscritti nel 2019, con relativo numero di Soci. Questo perché i dati che raccoglievo non hanno un valore “assoluto”, ma “relativo” al numero dei Cineclub e dei Soci esistenti.
Purtroppo questo tipo di informazione ha richiesto molto più tempo del previsto, anche a causa del cambio di consegne determinatosi con l’entrata in funzione di un nuovo Consiglio FEDIC.
Alla fine, comunque, ho potuto trarre una serie di conclusioni che mi sembrano interessanti.
Collaborazione dei Presidenti di Cineclub
La collaborazione dei Presidenti di Cineclub è stata piuttosto “variegata”: alcuni hanno provveduto in prima persona a fornire notizie sulle professioni dei loro Soci (Cagliari, Carrara, Forlì, Genova, Pisa); altri non hanno neppure avvisato i Soci e loro stessi non hanno compilato la scheda.
Qualità delle risposte
In buona sostanza sono arrivate risposte corrette e precise. Va comunque sottilineato che, nonostante la stringatezza e banalità delle domande, c’è stata una piccola percentuale di schede con omissione del “lavoro svolto” (ma è proprio su quello che verte l’indagine!) o del “Cineclub d’appartenza” (costringendomi a “recuperarlo” nell’elenco fornitomi dalla Segreteria FEDIC).
Per quel che riguarda la “disponibilità” ad una eventuale piccola intervista telefonica, solo una cinquantina hanno fornito il loro numero di cellulare (poco più del 20%).

Partecipazione dei Cineclub
Su 40 Cineclub FEDIC, iscritti nel 2019, solo 14 hanno inviato le loro risposte (35%):
Fotovideo Genova 17 risposte su 17 Soci (100,00%)
Cineamatori delle Apuane 45 risposte su 45 Soci (100,00%)
Sedicicorto Forlì 29 risposte su 29 Soci (100,00%)
Cineclub Cagliari 50 risposte su 55 Soci (90,90%)
Cineclub Alassio 4 risposte su 5 Soci (80,00%)
Corte Tripoli Cinematografica Pisa 65 risposte su 87 Soci (74,71%)
Circolo Savonese Cineamatori 6 risposte su 16 Soci (37,5%)
Cineclub Piemonte 8 risposte su 30 Soci (26,66%)
Cineclub Piacenza 2 risposte su 10 Soci (20,00%)
Video Club Pesaro 2 risposte su 15 Soci (13,33%)
Cineclub Ferrara 1 risposta su 15 Soci (6,66%)
Cineclub Fano 1 risposta su 15 Soci (6,66%)
Cineclub Peyote 1 risposta su 16 Soci (6,25%)
Cineclub Merano 1 risposta su 23 Soci (4,34%)
Partecipazione dei Consiglieri FEDIC
Il Consiglio FEDIC è formato da 10 persone. All’inchiesta 8 hanno risposto (80%), 2 no.
Professioni svolte (le principali)
56 pensionati
41 insegnanti
31 attività artistica
22 impiegati
13 salute (medici, veterinari, psicologi, farmacisti)
12 studenti
9 imprenditori
4 finanzieri/militari

Commento finale
Le mie considerazioni finali, del tutto personali e contestabili, sono basate sui dati numerici (sopra ampiamente riportati) e sulla mia conoscenza del mondo FEDIC, in cui sono stato Consigliere per quasi vent’anni e Presidente per 3 anni.
1) Molti Presidenti di Cineclub non svolgono in modo corretto e
completo il loro compito: uno dei primi e imprescindibili
impegni da rispettare sarebbe quello di informare i propri
Soci, affinché possano partecipare alle iniziative della
Federazione (e non solo).
Questa inchiesta ha confermato che molti Soci non sono a
conoscenza di cosa faccia la FEDIC e quali opportunità possa
offrire, visto che su 682 Soci FEDIC 2019 sono arrivate solo
232 risposte (34%).
2) Per quel che riguarda il “nocciolo” dell’inchiesta svolta (“quali
sono le professioni dei Soci FEDIC”), salta agli occhi il fatto
che i “pensionati”, con il 24%, siano i più rappresentati.
Questo dato non mi sembra confortante, perché documenta
il fatto che la FEDIC ha un’età media dei suoi affiliati
decisamente avanzata. Il dato è confermato dal fatto che la
percentuale di “studenti” (5,17%) è decisamente bassa.
3) Piuttosto “confortante”, invece, mi è sembrato il fatto che 31
persone (13,36%) svolgano una professione artistica (attori,
autori, cantanti lirici, direttori artistici, direttori della
fotografia, fotografi, graphic designer, musicisti, operatori
culturali, registi, segretarie di edizione, tecnici video,
videomaker).
4) Altro dato “positivo” è quello riguardante la disoccupazione:
solo 4 Soci (1,72%) ne sono afflitti.
5) Un dato “curioso” che mi ha particolarmente colpito
è che su 232 Soci FEDIC solo 1 (uno!) faccia l’operaio.
Questo dato mi ha fatto molto riflettere: “Perché abbiamo 41
insegnanti, 22 impiegati, 13 operatori sanitari, 9 imprenditori
e… un solo operaio?”
Non sono riuscito a darmi una risposta concreta.
Suggerimenti
Mi permetto di concludere il mio lavoro (più lungo e faticoso del previsto, seppur stimolante) con qualche modesta indicazione, nella speranza che possa essere utile alla Federazione e ai suoi Soci.
1) Potrebbe essere utile rifare (come tanti anni fa) un fine
settimana dedicato alla “Scuola dei Presidenti”, per istruirli su
quali siano i loro compiti culturali, amministrativi ed etici.
2) Favorire l’ingresso in FEDIC di giovani e giovanissimi.
E’ vero che esistono agevolazioni economiche per la loro iscrizione;
come è vero che esistono lo splendido Campus FEDIC (per i
giovanissimi) e lo Stage Nazionale FEDIC (che, pure, coinvolge
una discreta percentuale di giovani). Ma ritengo che occorra
fare di più.
3) Favorire, stimolare e incentivare l’interazione tra Cineclub:
finché ognuno starà chiuso nel suo guscio, sarà difficile far
capire che siamo sulla stessa barca ed è importante che tutti
collaborino -nel loro stesso interesse!- alla crescita della
Federazione di cui fanno parte.
4) Favorire il decentramento delle iniziative, portandole nelle scuole,
nelle parrocchie e, perché no?, nelle fabbriche! Con la speranza di
ritrovarci al prossimo censimento (magari tra 10 anni) con tanti
giovani e tanti operai nei nostri Cineclub!

STAGE NAZIONALE FEDIC. CALCI (PI) DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2019.
“SCRIVIAMO UN FILM”
di Enzo Bruno
Calci, 12 settembre 2019.
Rieccoci qui. Per me il terzo anno consecutivo presso lo Stage Nazionale Fedic.
Se il primo anno è stato quello delle sorprese ed il secondo quello delle conferme, di sicuro questo è l’anno della familiarità.
Non me ne voglia la Signora Caterina, proprietaria dell’agriturismo “I Felloni” che ci ospita, ma ormai sembra che questa cascina in qualche modo mi appartenga. Ritrovare la stessa camera, rigorosamente la numero 2, la cucina, il salottino, il giardino, tutto rimasto come l’anno precedente mi ricorda quando, ragazzino, andavo d’estate in vacanza da mia nonna e, nella mia cameretta, ritrovavo ancora i giocattoli così come li avevo lasciati l’anno prima.
Che dire poi dei compagni di corso? Con quelli degli anni precedenti si è ormai creata, più che amicizia, una vera e bella complicità che ha subito coinvolto i nuovi arrivati.
Ma torniamo allo stage. Quest’anno, a differenza dei precedenti, è stato monotematico, tutto concentrato sullo scrivere una sceneggiatura da trasformare in cortometraggio durante il prossimo stage del 2020, con la guida, consulenza e professionalità del regista Alessandro Grande.

Ogni anno Roberto Merlino, insostituibile organizzatore degli stage, è riuscito a coinvolgere personalità eccellenti che si sono prestate a fare da docente nei settori più diversi, nell’ambito della realizzazione di un film.
Quest’anno Roberto si è ulteriormente superato, perché Alessandro Grande non è solo un bravo regista, sceneggiatore, autore di programmi televisivi in RAI, MEDIASET e SKY.
Alessandro ha vinto con il suo cortometraggio “In My Prison” molti riconoscimenti, tra cui il Premio Amnesty International ed il Premio del Pubblico al Festival Internazionale di Tokio. Con il corto “Margerita”, interpretato dall’attore Moni Ovadia, ha vinto 81 premi nel mondo ed è entrato nella cinquina finale dei Nastri d’Argento. <<Vabbè>> qualcuno dirà: <<Tutto qui?>>.
No, perché con il corto “Bismillah” ha vinto il David di Donatello nel 2018 e ha rappresentato l’Italia nella corsa al Premio Oscar 2019. Può bastare?
Lo stage in realtà è iniziato durante l’inverno, perché Roberto ed Alessandro ci hanno dato i compiti a casa: scrivere brevi racconti, possibilmente ambientati nell’agriturismo che ci ospita ogni anno, giusto per tenerci allenati fino all’inizio dello stage vero e proprio.
Direi che questo riscaldamento ha dato i suoi frutti, perché siamo arrivati carichi come molle…
Fin dal primo giorno è stata un’esplosione di idee, punti di vista, creazione di racconti che bene si sono abbinati all’ambientazione nella cascina.
In realtà, forse per le caratteristiche del posto, abbiamo immaginato soprattutto racconti ambientati durante la seconda guerra mondiale.
Non è stato facile per Alessandro riuscire a sintetizzare in un’unica sceneggiatura tutte le idee che gli abbiamo quasi tirato addosso perché in certi momenti, causa la nostra indisciplina, parlavamo tutti sopra a tutti contemporaneamente, come in una assemblea di condominio.
Questo dovrebbe aggiungere Alessandro al suo curriculum: avere trasformato una violenta assemblea condominiale in una sceneggiatura degna del suo nome. Alla fine ci siamo riusciti e se sapremo trasformare in immagini la storia che abbiamo scritto, il prossimo anno potremmo realizzare qualcosa di veramente bello.
Chiaramente non c’è stato tempo solo per lo stage. Come ogni anno abbiamo avuto la possibilità di visionare e commentare cortometraggi realizzati dai soci Fedic presenti, abbiamo partecipato alla votazione del Premio del Pubblico nel concorso fotografico “Acqua” ed abbiamo assistito ad una interessante serata in cui l’ospite d’onore, la Signora Enrica Ricci, professionista in comunicazione e marketing, ci ha illustrato tecniche e curiosità alla base della realizzazione degli spot pubblicitari, vera forma di arte visiva contemporanea.


Infine la visita alla Certosa di Calci. Semplicemente stupenda.
Fin qui la parte più “istituzionale” dello stage. Quello che in realtà è più difficile descrivere è l’atmosfera che si respira in quei giorni, il back stage, fatto di barzellette dopo cena, rigorosamente zozze, bevute clandestine di grappa all’una di notte, caccia al geco da parte dei più temerari e lunghe partite a scopone trasformate in duelli all’ultimo sangue.


A proposito di scopone, fonti rimaste assolutamente anonime, riferiscono che quest’anno la coppia dei genovesi Claudio Serra e Luca Noli, abbia inferto numerose sconfitte alle coppie pisane composte da Roberto Merlino e…. vari.
Purtroppo di questi “vari” non si hanno più notizie da giorni. Spariti nel nulla.
Ma questa è un’altra sceneggiatura…

N.B. Tutte le foto di quest’articolo sono di Giacomo Bernardi (videoClub Brescello))
FESTIVAL ED EVENTI
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
LA MOSTRA DI VENEZIA DIVENTA SEMPRE PIU’ UN PUNTO DI RIFERIMENTO MONDIALE
di Paolo Micalizzi
Ha vinto il “Leone d’Oro” il blockbuster “Joker” di Todd Philips, ma ha vinto anche lo straordinario protagonista del film Joaquin Phoenix: significativa, in questo senso, la sua presenza sul palco alla cerimonia di premiazione poiché, in fondo, poteva meritare la Coppa Volpi per il migliore attore ma non era possibile dato il regolamento della Mostra che non consente di attribuire 2 premi allo stesso film. In un certo senso ciò non dispiace perché avrebbe significato l’esclusione dal premio di Luca Marinelli che l’ha conquistata per la sua eccezionale ed intensa interpretazione nel film “Martin Eden” di Pietro Marcello. “Jocker” deve, infatti, il suo successo soprattutto a Joaquin Phoenick che si è calato perfettamente nel personaggio del cattivo nella lunga serie di Batman, della quale il film di Todd Philips ne racconta la genesi.
Luca Marinelli, dal canto suo, è straordinario nel ruolo del marinaio del romanzo di Jack London che cerca di riscattarsi socialmente con la cultura diventando uno scrittore che cerca la verità, ma dovrà combattere fortemente. Il premio lo ha dedicato a tutte le persone che sono in mare a salvare i tantissimi naufraghi che fuggono. Ed ai migranti ha dedicato la sua Coppa Volpi come miglior attrice per il film “Gloria mundi” di Robert Guédiguian, suo marito, Ariane Ascaride dichiarando “Questo premio è per tutti quelli che dormono per l’eternità nel fondo del Mediterraneo”, aggiungendo che i suoi nonni emigrarono dall’Italia in nave. Tutti soddisfatti per il Gran Premio della Giuria “Leone d’Argento” al film “J’accuse” di Roman Polanski sul caso Dreyfuss, l’ufficiale francese condannato, ingiustamente, all’ergastolo per spionaggio. Un riconoscimento che poteva essere inficiato dalle polemiche suscitate in seguito alle dichiarazioni della Presidente della Giuria, Lucrecia Martin, che era contraria all’ammissione in concorso di un regista condannato per violenza sessuale ad una minorenne. Invece il riconoscimento c’è stato perché, come ha dichiarato il giurato italiano Paolo Virzì “ nella discussione su Polanski si è parlato solo del film”.
“Leone d’Argento”, sul quale non tutti i critici sono d’accordo, al film “About Endlessnes” di Roy Andersson, il regista svedese del “Leone d’Oro” di cinque anni fa per “Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza”, che racconta ,in modo ironico e malinconico, la bellezza della vita attraverso alcuni personaggi. L’Italia, oltre al premio a “Martin Eden” grazie a Luca Marinelli, ne ha avuto un altro attribuito al film di Franco Maresco “La mafia non è più quella di una volta” che racconta, attraverso le fotografie di Letizia Battaglia e le testimonianze dell’organizzatore di feste Ciccio Mira, il fenomeno in Sicilia della mafia.
Importanti, oltre a quelli legati al “Leone d’Oro”, anche altri Premi attribuiti alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019. Che è bene segnalare come memoria storica e come indicazione di futuri talenti. Il “Premio Orizzonti” è stato attribuito al film “Atlantis” del regista ucraino Valentyn Vasyanovych che racconta gli effetti della guerra tra Ucraina e Russa nei suoi aspetti economici ed ecologici attraverso la storia di un ex soldato, affetto da disturbo da stress post – traumatico che, in un futuro prossimo, ritorna nella propria terra devastata dalla guerra e si unisce ai volontari che si stanno occupando di recuperare i corpi dei soldati morti.
Nella stessa sezione i premi principali sono stati cosi attribuiti: miglior regia al film “Blanco en Blanco” del cileno Theo Court ambientato nella Terra del Fuoco, dove un fotografo si reca per realizzare un servizio sul matrimonio di un potente proprietario terriero e sarà costretto a diventare complice della realizzazione di una nuova società che sorge dal genocidio del popolo Selknam; premio speciale al film “Verdict” del filippino Raymund Ribay Gutierrez su una storia di violenza a causa di un marito ubriaco: Quando fa del male alla bambina, la moglie decide di denunciarlo accorgendosi però della lentezza della giustizia che fa sì che esse siano sempre più in pericolo. Per l’opera prima, “Leone del futuro” premio a “You will die at 20” del sudanese Amjad Abu Alala. Un ‘opera presentata nelle “Giornate degli Autori” che denuncia la superstizione come una condanna.
La Giuria della SIC (Settimana Internazionale della Critica) ha decretato vincitore del Gran Premio “All This Victor” di Ahmad Ghossein incentrato sulle vicende di un figlio che durante la guerra del Libano va alla ricerca del padre che rifiuta di lasciare il suo villaggio nel sud del Paese. Per la Giuria, un’opera in cui il regista “ha saputo raccontare un tema non certo nuovo, la follia della guerra, con una forza espressiva e una tensione inedite e coinvolgenti”. Il film ha ottenuto anche il Premio del Pubblico. A scegliere il Premio delle “Giornate degli Autori” è stato il pubblico. Ne è risultato vincitore “ un Divan a Tunisi” della regista franco tunisina Manele Labidi che racconta in forma di commedia, attraverso l’espediente narrativo della psicoanalisi, la follia e la vitalità della classe media tunisina, profondamente lacerata tra modernità e tradizione.
I premi collaterali assegnati da organizzazioni sociali e cinematografiche hanno poi messo in rilievo anche altre opere non prese in considerazione nei Palmares ufficiali.
Premi che hanno dato riconoscimenti ad alcune opere che meritano l’attenzione dei cinefili ed appassionati di cinema.
Opere emerse, soprattutto, su indicazione delle altre realtà associative: critici, associazioni culturali, cineclub e cinecircoli di cultura cinematografica.
Per l’Italia, merito al film “Martin Eden” di Pietro Marcello, probabilmente escluso dal Palmares ufficiale per l’attribuzione al suo interprete, Luca Marinelli, della Coppa Volpi per il miglior attore, al film di Mario Martone “Il Sindaco del Rione Sanità” ma anche ai tre suoi interpreti Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo e Valeria Golino.
Premio anche per “Citizen Rosi” di Didi Gnocchi e Carolina Rosi, ma anche, per l’escluso dai Premi “Ema”(Venezia 76) film di Pablo Larrain sul tema dell’adozione, oppure per opere interessanti come “Corpus Christi” (Giornate degli autori) del polacco Jan Komasa su un ventenne cui viene impedito , essendo un detenuto e quindi con la fedina penale sporca, di farsi prete fino a quando non può farlo una volta uscito dal centro di detenzione. Sempre nelle”Giornate degli Autori” era presente “Llorona” di Jayro Bustamante ambientato durante la guerra civile guatemalese, mentre nella SIC figuravano “All This Victor” di Ahmad Ghossein ambientato nel Libano del luglio 2006 con la guerra che infuriava tra Hezbollah e Israele e “Scales” di Shahad Ameen su una brutale usanza in un povero villaggio di pescatori dell’Arabia Saudita, governato da un’oscura tradizione per la quale ogni famiglia deve sacrificare la propria figlia femmina alle creature del mare. Nei cortometraggi premi per “Veronica non sa fumare” di Chiara Marotta , per “Il nostro tempo” di Veronica Spedicati e per “Los ocèanos son le verdaderos continents” di Tommaso Santambrogio. Tutte Opere che ritengo utile segnalare affinché , se proiettate in Sala o nei Cinema d’Essai, cinefili ed appassionati di cinema siano stimolati ad andare a vederle.
Il Premio Fedic, quest’anno, è stato attribuito ad autori emergenti. Quello per “l’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore” è stato attribuito dalla Giuria, presieduta da Ferruccio Gard, al film “Sole” di Carlo Sironi( Venezia Orizzonti), la Menzione speciale Fedic è andata invece a “Nevia” di Nunzia De Stefano, presentato anch’esso in “Venezia Orizzonti”.
Due opere che affrontano temi sociali. Emergente è anche l’autrice del miglior cortometraggio, attribuito dall’apposita Giuria presieduta da Alfredo Baldi, Beatrice Balducci che ha realizzato “Supereroi senza superpoteri”(Venezia Orizzonti- Concorso Corti): commosso omaggio ad una madre. Tutti i registi erano presenti alla cerimonia svoltasi, come avviene da alcuni anni, allo Spazio dell’Ente dello Spettacolo, situato all’Hotel Excelsior. Insieme a Beatrice Baldacci era presente la giovane attrice Virginia Apicella.
La Fedic era presente anche quest’anno con il Forum (24°) che si è svolto giovedì 5 settembre allo Spazio Venice Production Bridge presso l’Hotel Excelsior. Un Forum che voleva sottolineare, attraverso l’intervento del Direttore dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea il rapporto che esso ha con la Cineteca Fedic, ivi depositata. Essendo il Direttore Bartolomeo Corsini dovuto ritornare nella Sede del Piemonte del Centro Sperimentale di Cinematografia, l’ha sostituito Domenico Monetti che opera al CSC di Roma e che ha illustrato ai presenti come si sta procedendo alla digitalizzazione della produzione Fedic in loro possesso. Ad esempio della qualità della digitalizzazione che si sta effettuando è stato proiettato uno dei Classici della Fedic, e cioè “Scano Boa” di Renato Dall’Ara. Molti i classici di autori Fedic presenti nella Cineteca della nostra Federazione, in fase di digitalizzazione, opera molto complessa a causa delle condizioni in cui esse, tecnicamente, si trovavano. E molte anche le opere di altri autori che avevano presentato le loro opere, ma non solo, ai Festival “Valdarno Cinema” e “FilmVideo”. La digitalizzazione sta privilegiando gli autori italiani e già sono pronte alcune compilation, con la supervisione di Giorgio Sabbatini, che possono già essere utilizzate dai Cineclub Fedic ed essere fruite anche da altre Associazioni e organizzazioni cinematografiche. E’ seguita la proiezione, alla presenza del regista, del corto “Il mondiale in piazza” indicato dalla Rete REFF, coordinata da Gianluca Castellini, come miglior cortometraggio 2018 .
Nel prendere la parola, il regista, dopo alcune sue considerazioni sul corto realizzato, ha ringraziato la Fedic per la prestigiosa opportunità che gli è stata offerta. Alla proiezione del cortometraggio era presente anche il giornalista Ferruccio Gard, uno dei mitici 7 di “Novantesimo minuto” che si è complimentato con il regista ed ha ricordato anche la sua esperienza di calciatore della Nazionale di calcio Giornalisti: l’organizzazione, per sua iniziativa, di una partita nella Piazza San Marco di Venezia.
Il Forum Fedic di quest’anno si era proposto di evidenziare nuovi autori Fedic. Per dare loro spazio, invece di proiettare, dati i tempi a disposizione, due- tre opere complete, si è preferito proiettare alcuni trailer (non superiori ai 3 minuti ciascuno) di opere realizzate dal 2018, o in fase di realizzazione, di alcuni soci Fedic: quelli pervenuti all’organizzazione dopo invito a tutti i Presidenti Fedic con apposita mail inviata dalla Segreteria Fedic. Si è potuto così dare visibilità a nuovi autori come Vincenzo Cirillo e Rocco Oliveri, autori di “Il balcone dei gerani” su sceneggiatura di Enzo Bruno e Claudio Serra(Cineclub Filmvideo Genova) dal romanzo di Elio Esposito che ha illustrato il film al Forum; Antonella Santarelli “//Smartphone”(Cineclub Corte Tripoli Cinematografica-Pisa); Giorgio Bertuccioli,“Non tutte le ciambelle riescono col buco”(Cineclub Pesaro) ; Franco Bigini,”Morte – Dison”(Cineclub Phoenix Cinematografica – Massa Carrara), Francesco Presta e Ferdinando Romito, “9O secondi all’inferno”(Cinecircolo Maurizio Grande – Diamante-CS); Gabriele Gasparotti, “La nascita di Zelda”( Gruppo Cineamatori delle Apuane). I cortometraggi sono stati presentati oltre che da Elio Esposito , da Antonella Santarelli, Giorgio Bertuccioli, Franco Bigini, Gabriele Gaparotti. Ma anche da Laura Biggi che ha presentato “Oltre il tempo” realizzato dalla collaborazione tra il Cineclub Fedic Sentieriblei e Gruppo Cineamatori delle Apuane.
Spazio poi agli “Autori del futuro”, cosi come possono essere definiti gli studenti che hanno realizzato dei cortometraggi nell’ambito dell’attività di Fedic Scuola e del Booktrailer Film festival di Bresca. Sono stati introdotti da Laura Biggi e da Ilaria Copeta, secondo il programma del Forum Fedic che è stato reso noto anche a tutti i Presidenti dei Cineclub Fedic prima del suo svolgimento, e che potrà quindi essere riletto. Simpatica, a questo proposito, la presenza di alcuni studenti : del Liceo Leonardo da Vinci di Brescia, Elena Coccoli, Gaia Di Donna, Barbara Salvalai, Valeria Ronchi, Francesca e Elisabetta Frassine; del Liceo Umberto Boccioni di Milano, Laura Cataran, Francesca Coari, Matilde Tiraboschi.
Tutte iniziative che possono essere svolte grazie alla lungimiranza del Presidente della Biennale Paolo Baratta e del Direttore della Mostra Alberto Barbera, che ne avallano e incoraggiano la realizzazione.

Partecipare alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è sempre un’esperienza che ti arricchisce culturalmente. Non solo perché vedi tanti film, molti dei quali se li perdi alla Mostra poi non hai la possibilità, a causa della mancata distribuzione in Italia, di poterli conoscere, ma anche per la conoscenza di problematiche relative al cinema attraverso i vari eventi culturali, convegni, eccetera che si svolgono nell’ambito della Kermesse veneziana. L’Hotel Excelsior è, soprattutto il punto di riferimento di questi Incontri grazie agli spazi occupati dall’Italia Pavilion, dall’Ente dello Spettacolo e dalla Regione Veneto, ma anche dal Venice Production Bridge situato al terzo piano. E’ avvenuto cosi, tanto per citarne alcuni ai quali abbiamo partecipato, che allo Spazio “Italia Pavilion” si poteva assistere alle conferenze stampa di alcuni Premi e di alcune Film Commission, tra cui quella molta attiva della Sardegna, il lancio del Protocollo Comitato Fellini, la presentazione delle riviste “Bianco e Nero” ed “8 ½”, ma anche del mio libro “Giorgio Ferroni: dai documentari e film di genere ai Western spaghetti”, alla presenza del pronipote del regista, con i prestigiosi critici Franco Mariotti, Valerio Caprara e Steve Della Casa, alla consegna del Premio Zavattini che l’anno scorso era stato vinto dal documentario “Supereroi senza superpoteri” di Beatrice Baldacci, a cui la Fedic ha attribuito nel 2019 la Menzione speciale, quella dei premi Imaie, Lizzani e della Sic.
A quello dell’Ente dello Spettacolo, era di scena la trasmissione serale di “Hollywood party” , ma anche la presentazione del libro di Thierry Frémaux “Cannes Confidential”, quella del Rapporto Cinema 2019, il ricordo di Ugo Gregoretti con un’iniziativa CInit, la presentazione degli Incontri di Mantova sul Cinema d’essai, il dibattito sulle politiche di promozione delle attività cinematografiche nei piccoli centri e nelle grandi città, il “Videocatechismo della Chiesa cattolica”, ma soprattutto la cerimonia del Premio Robert Bresson che quest’anno ha consentito un interessante incontro con la regista argentina Lucrecia Martel, presidente di “Venezia 76”.

Interessante poi l’” About Women” che ha affrontato problematiche relative alle leggi per le donne ed al mondo del lavoro. Oltre alla visione di alcuni cortometraggi. E’ all’Ente dello Spettacolo poi che nella giornata conclusiva della Mostra ha avuto luogo la consegna dei Premi Collaterali tra cui quello della Fedic. Per quel che mi riguarda, all’EdS sono intervenuto per parlare di Victor e Carlo Rambaldi ai quali il Premio Adelio Ferrero di Alessandria dedicava un omaggio.
Tanti poi gli Incontri allo Spazio della Regione Veneto in cui sono state presentate alcune iniziative della Polesine Film Commission, il 10° Premio “Mattador” relativo alla sceneggiatura in cui è intervenuto anche il regista, socio Fedic, Stefano Bessoni, il libro “Montanelli e il cinema” ed il ricordo di Luciano Salce per iniziativa del Cinit, alcuni Festival tra cui “Cortinametraggio 2020”, e l’Incontro “Euroimages” sulle prospettive per il futuro del cinema europeo. A conclusione, è stato presentato il libro “I cannibali. Questioni di famiglia nel cinema, nell’arte, nella letteratura”, a cura di Paola Dei dove sono intervenuto quale autore di un saggio incluso nel volume.
Incontri anche alla Villa degli Autori, sede delle “Giornate degli Autori”, con la presentazione di tanti documentari che hanno consentito di poter aver un panorama più ampio della produzione del settore: tra essi, uno che riguarda il pittore Emilio Vedova. Poi gli Incontri della Rivista Ciak, ed anche la presentazione, con la partecipazione dei familiari del regista, del mio libro “Massimo Sani. La Storia in televisione” con gli interventi del Presidente Anac Francesco Ranieri Martinotti, del Direttore delle “Giornate” Giorgio Gosetti e del giornalista Rai Fabrizio Berruti. Di particolare interesse poi le Masterclassi dei registi Marco Bellocchio e Margarethe von Trotta. In uno degli Incontri di Ciak è stato lanciato un appello ad una campagna di sensibilizzazione da parte di tutte le forze che compongono la filiera del cinema perché quest’ultimo diventi materia di insegnamento scolastico. A lanciarlo sono stati l’Amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, l’Amministratore delegato di Medusa Film Giampaolo Letta e l’AD di Vision Distribution Nicola Maccanico. L’appello ha trovato, oltre ai presenti, il favore di Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato giornalisti cinematografici e della Fondazione Cinema per Roma invitando a costituire una “cabina di regia” per sensibilizzare la politica.
Dal canto suo il Venice Production Bridge, di cui è direttore Pascal Driot, oltre che essere punto di riferimento per l’attività di networking tra i partecipanti dell’Industry Gold Club e gestire la Digital Video Library, è un luogo di interessanti incontri : in particolare, l’ANICA ha svolto un suo Focus con il Giappone, il Parlamento Europeo ha presentato i film in concorso per il Premio Lux, l’Associazione Amici di Giana ha svolto la cerimonia di premiazione del cinema migrante in Italia, in collaborazione con la Corte costituzionale ha avuto luogo la proiezione del film di Fabio Cavalli “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”, il Premio Kinéo ha presentato il progetto di salvaguardia del mare “Ocean for all” realizzato dall’UNESCO e la Fedic ha continuato a svolgere il suo annuale Forum.
“Fuori concorso” era collocato il film di chiusura della Mostra “The Burnt Orange Heresy” di Giuseppe Capotondi, un thriller con Mick Jagger che ha “infiammato” il Red Carpet. E proprio la passarella in cui ogni sera hanno sfilato le Star della Mostra ha offerto, più degli altri anni, uno spettacolo di grande entusiasmo e da fenomeno sociologico: affollato di persone, giovani ma anche di mezz’età, sin dal mattino( qualche cronista ha scritto che lo era già dalle quattro) con ombrelli per ripararsi dal sole ed altro come se fossero accampati, cosi come mi è capitato tante volte di constatare mentre verso le 8 mi recavo alla Darsena o in Sala Grande per vedere il film del giorno. Segno di una kermesse festivaliera che di anno in anno diventa più frequentata: 200mila persone secondo il Presidente Paolo Baratta, un record. Appuntamento al prossimo 2 settembre.

“EXTASE” APRE LA SEZIONE VENEZIA CLASSICI
di Vittorio Boarini
La ormai definitivamente istituzionalizzata Venezia Classici, sezione imperdibile della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, si è presentata nella 76. edizione della Mostra stessa come un evento straordinario, a cominciare dalla sua pre-inaugurazione con il tanto celebre quanto poco visto, almeno nella sua versione integrale, “Estasi” (“Extase”, 1933) di Gustav Machatý. Dopo questa straordinaria partenza, che per consuetudine avviene la sera prima dell’inaugurazione ufficiale del festival, il livello della rassegna si è mantenuto altissimo, con la riproposta del primo lungometraggio di Bernardo Bertolucci, “La commare secca”, e de “La strategia del ragno”, che, a pochi anni dal primo, rivela un regista già straordinariamente maturo. Sempre nell’ambito della cinematografia italiana e a proposito di opere prime, abbiamo avuto il piacere di rivedere “Lo sceicco bianco” (1952), film che segue “Luci del varietà”, unica opera girata fino allora dal maestro di Rimini assieme ad Alberto Lattuada. Anche Giuliano Montaldo era giustamente presente, anche simpaticamente di persona, per presentare il suo indimenticabile “Tiro al piccione”, un’operaprima che dovrebbe essere proiettata in tutte le scuole. Infine, per quanto riguarda l’Italia, un film, che speriamo riceva dalla proiezione veneziana la possibilità di essere visto da un ampio pubblico, prodotto dalla sede per il Friuli e la Venezia Giulia della televisione nel 1981 e rivelatosi alla rivisitazione una pellicola di autentica qualità: parlo di Maria Zef, dovuto a Vittorio Cottafavi. Va aggiunto che altre opere italiane erano presenti nella interessantissima sezione dei documentari sul cinema, i suoi protagonisti e i suoi generi, sulla quale torneremo.
È bene notare subito che, oltre alle cinematografie più frequentate, erano presenti un notevole film neozelandese, “Mauri”, girato nel 1988 da Merata Mita, in parte parlato in farsi, e due cortometraggi iraniani, “Khaneh siah ast” di Forough Farrokhzad, e “Tappe-haye Marlik”, di Ebrahim Golestan, che aveva vinto un premio a Venezia nel 1964. I corti, restaurati dalla Cineteca di Bologna, saranno distribuiti in Italia e all’estero dalla Cineteca stessa, per cui fortunatamente avranno un pubblico.
Proprio leggendo la Nota di restauro relativa a “Mauri” ho realizzato che questa edizione di Venezia Classici aveva in programma molti film, partendo da quello cecoslovacco d’apertura, che presentavano notevoli difficoltà di restauro, cosa che mi è stata confermata rileggendo le schede contenute nel catalogo. Questo fatto potrebbe avere un significato, al quale sarebbe bene pensare. Intanto torniamo alle cinematografie nazionali presenti nella rassegna, cominciando da quella degli Stati Uniti, che aveva ben quattro film in programma. Veramente interessante rivedere “New York, New York”, dell’ormai mitico, per le tante attività che svolge validamente nell’ambito cinematografico, Martin Scorsese. Il film, del 1977, è stato ristampato dalla United Artists in 35 mm. nella versione voluta dal regista di 163 minuti, ed è una rivisitazione accurata dei grandi musicals hollywoodiani degli anni ‘40 e ‘50 visti anche con gli occhi moderni, parole di Scorsese, di John Cassavetes. Infatti, la minuziosa e perfetta ricostruzione di uno spettacolo tipico della Hollywood del dopoguerra, spettacolo che pretende identificarsi con la vita e sostituirla con un feulleton orchestrato fra canti e balli, crea anche, grazie alla felice mano di Scorsese, uno spazio critico fra il “pezzo di vita americano” (il film inizia nel 1945, con la resa del Giappone, e il suo tempo diegetico è di otto anni), e il pubblico, spazio critico che non evita ai nostalgici di spargere qualche lacrima presi dalla colonna sonora e dalle performances di Liza Minelli e Robert De Niro.
Pienamente condivisibile l’inclusione nella rassegna del terzo lungometraggio di Dennis Hopper, celeberrimo autore di “Easy Rider” (1969) e fra i precursori della nuova Hollywood, il meno noto “Out of the blue”, realizzato nel 1980. L’opera aggiunge un altro spaccato dell’America profonda, quella che rivela la povertà disperata dell’emarginazione sociale, il lato oscuro di una società che ha fatto dell’opulenza il proprio marchio di fabbrica. La storia, interpretata dallo stesso regista, narra di una giovane ragazza, innamorata di Elvis Presley, che fugge da una non-famiglia disastrata per andare incontro a una tragedia. Nonostante alcuni eccessi descrittivi, il film raggiunge risultati notevoli e conferma l’occhio ustorio di Hopper nella critica dell’esistente. La pellicola, restaurata dalla Discovery Production, è una coproduzione con il Canada, che è presente con una sola opera, ma di ottimo spessore storico-critico, l’inquietante “Crash”, girato nel 1996 da David Cronenberg, Leone d’oro alla carriera 2018.
Abbiamo rivisto con grande piacere, anche grazie all’ottimo restauro in 4k, effettuato in Germania presso LSP Medien, laboratorio ad alta tecnologia, questo straordinario saggio in forma di film. Nell’età della tecnica, per dirla con Heidegger, non è possibile non misurarsi con le tecnologie che ci sovrastano. Anche l’erotismo, uno degli elementi più caratteristici, profondi ed intimi del genere umano, si esprime in inedite e perverse pulsioni intrecciando la tecnica automobilistica, la velocità, il pericolo di morte e l’enigma del destino. “Crash è una storia d’amore futuristica ambientata nel presente” dice il regista stesso, il quale aggiunge: “gli incidenti automobilistici sono una metafora dello scontro fra la tecnologia del presente e la psiche umana.” Gli scontri d’auto, girati magistralmente, infatti, costituiscono l’occasione di nuovi impulsi erotici, veicoli di una futuribile sessualità, nella quale i rottami meccanici e le lesioni corporee si fondano nell’esaltazione dell’unità inscindibile di Eros e Thanatos.
Torniamo ora agli Usa, anche se “Il grande gaucho”, titolo italiano di “Way of a gaucho” (1952), è girato dal francese Jacques Tourner, stabilitosi a Hollywood in giovane età e divenuto uno degli autori che ha contribuito alla fortuna dei film di genere americani.
Di lui tutti ricordano il primo lungometraggio, “Cat people”, in Italia “Il bacio della pantera”, un horror del 1942 di grande successo e più volte imitato; ma non solo, anche nel genere western si affermò ripetutamente, specie con “Wichita” del 1955. Ho richiamato il genere western perché ad esso è ispirato Il grande gaucho, ambientato nella pampa argentina, spazio libero analogo al west statunitense, sostituendo i cow boys con i gauchos. Il protagonista dell’avventurosa storia è, infatti, un gaucho legato alle tradizioni e desideroso di assoluta libertà, che entra in conflitto con le nuove regole imposte dal “progresso” anche alla non più sterminata prateria dell’Argentina.
Il film, ottimo esempio del genere, con tanto di gratificante lieto fine, è in realtà centrato sulla contraddizione fra il passato cavalleresco, regolato dalla legge dell’onore e dai noblesse obliges, e il presente fondato sulle leggi del mercato del quale la costruzione della ferrovia, contro cui si battono i gauchos ribelli, è il simbolo. Il restauro è stato felicemente effettuato sotto la supervisione della Twentieth Century Fox e dalla Film Foundation di Scorsese.
Per completezza, concludiamo la rassegna dei film americani restaurati con Radiazioni BX: distruzione uomo, titolo con cui apparve sugli schermi italiani “The Incredible Shrinking Man” (1957), di Jack Arnold. Un apparentemente genere fantascientifico, in realtà un’ecologica rappresentazione dell’angoscia di vivere negli anni cinquanta, gli anni dominati dalla paranoia della guerra fredda.
Il protagonista, Grant Williams, colpito da misteriose radiazioni, comincia a rimpicciolire inesorabilmente, nonostante le attente cure alle quali si sottopone. Ovviamente la sua vita e quella della bella moglie viene stravolta, soprattutto quando le dimensioni del protagonista giungono al punto da renderlo una preda per il gatto o, addirittura, per un grosso ragno.
Fortunatamente il regista è riuscito ad evitare il lieto fine che la produzione voleva imporre, sbagliando anche a giudicare le reazioni del pubblico che furono molto favorevoli, e ha potuto rappresentare a meraviglia una metamorfosi complessa del personaggio senza ricorrere ai tradizionali effetti speciali. Il film ha avuto, molti anni dopo, un remake al femminile, che non è mai arrivato nel nostro paese.
Passiamo alla gradita sorpresa di trovare in programma un Buñuel messicano di estremo interesse, quel “Ensayo de un crimen”, del 1955, che in Italia girò col titolo “Estasi di un delitto”. L’opera aveva anche un titolo internazionale, “La vida criminal de Archibaldo de la Cruz”, cioè del protagonista del film, infatti, l’opera era stata pensata dal grande regista, messicano d’elezione, come una commedia, un divertissement sulla ossessione di uccidere una donna, senza peraltro riuscirci mai, che affligge Arcibaldo a causa di un trauma infantile. In realtà è più vicino al vero George Sadoul, che definisce il film un “capolavoro dell’humor nero e del surrealismo”, col quale si mette in scena un’allegoria dei risvolti criminali generati dall’impotenza sessuale. È vero però che l’opera ha un lieto fine, ma assai buñueliano, cioè ironico e poco credibile. Il complesso restauro è stato effettuato egregiamente dalla Cineteca Nazionale messicana, che ne possedeva un negativo ininfiammabile.
In tema dei grandi registi, siamo stati felici di ammirare per la terza volta (la prima era stata a Bologna nel 1981 alla personale del regista organizzata dalla Cineteca) il capolavoro di Manoel de’ Oliveira “Francisca” (1981), ottimamente restaurato dalla Cineteca portoghese. Il film è tratto dal romanzo Funny Owen, della grande scrittrice Augustina Bessa Luis, ispirato a una storia vera, accaduta nel XIX secolo, nella quale era coinvolto il letterato Camilo Castelo Branco, autore di “Amor de perdiçao”, al quale de’ Oliveira si era ispirato, nel 1978, per il film omonimo. Con questa opera il regista completa quella che lui stesso ha definito “la tetralogia dell’amore frustrato” e, nello stesso tempo, il perfezionamento di una ricerca formale che non concede nulla al caso: ogni inquadratura è rigorosamente costruita, tutti i movimenti di macchina studiati con cura, la fotografia di una qualità impeccabile.
Il palese contrasto tra una storia dominata dalla passione amorosa e lo stile gelidamente distaccato con cui è raccontata, il ritmo lento, addirittura ieratico, il predominio teatrale della parola sull’azione, la recitazione degli attori rivolta alla macchina da presa, cioè direttamente allo spettatore, rivela la ritualità perversa di una borghesia morbosamente decadente. In 167 minuti de’ Oliveira narra con totale distacco critico la passione di Francisca, Teresa Menezes, rapita dal suo innamorato, Diego Doria, che, sospettando della sua purezza, la sposa ugualmente in ossequio alle convenzioni sociali, ma non consuma il matrimonio e il suo comportamento verso la moglie la spinge a lasciarsi morire di tisi. Il marito ordina la sua autopsia e, scoperto che essa era vergine, si suicida. Nulla di più atroce può essere raccontato con tanto sublime distacco.
Anche di altri autorevoli registi sono stati inclusi nella rassegna dai sapienti curatori, lo stesso direttore della Mostra, Alberto Barbera, e il suo validissimo collaboratore Stefano Francia di Celle, film di grande interesse. “Il passaggio del Reno” (“Le passage du Rihin”, 1960), di Andrè Cayatte, è senz’altro uno di questi.
Presentato a Venezia nel 1960, “rubò”, secondo molti critici, il Leone d’oro a Visconti, che era presente con “Rocco e i suoi fratelli”, e scatenò aspre polemiche sul piano internazionale. La vicenda dei due francesi prigionieri dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale, può prestare il fianco all’accusa di qualunquismo, che da più parti fu scagliata contro il film, ma, rivedendolo ora, non credo che sia giusto liquidarlo in questa maniera. Cayatte ci aveva sempre mostrato anticonformisticamente le gravi contraddizioni della società moderna nel suo normale andamento quotidiano, molti dei film, infatti, erano ispirati alla cronaca. Uno dei bersagli preferiti del regista era la giustizia borghese con i suoi burocratici tribunali e, a questo proposito, aveva dedicato un film alla pena di morte, “Giustizia è fatta” (trad. letterale), divenuto giustamente famoso, che aveva vinto il Leone d’oro nel 1950.
Pur avendo già trattato il problema della riconciliazione franco-tedesca, “Il passaggio del Reno” è per Cayatte un tema inedito, basato su una curiosa simmetria: uno dei prigionieri, un intellettuale, riesce a fuggire e nel dopoguerra deve dividersi dalla moglie accusata di collaborazionismo; l’altro, un pasticcere interpretato da Aznavour, si adatta alla detenzione, anzi si innamora di una ragazza tedesca e, tornato a casa alla fine del conflitto, ripasserà il Reno per andarla a cercare.
Pur appesantito da un certo didascalismo, la sua rilettura mi ha convinto che sarebbe opportuno riprendere in considerazione l’opera di questo regista oggi quasi dimenticato.
Nessun dubbio invece, sul valore storico-critico di “Nella corrente” (“Sodrásban”,1964), primo lungometraggio di István Gaál appartenente alla generazione che diede vita al Nuovo cinema ungherese, tendenza dove primeggio Miklós Jancsó.
Il film fu presentato al festival di Pesaro, grazie alla segnalazione di Pasolini, e rese noto il giovane autore in Italia, dove per altro aveva studiato, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, e dove riceverà in seguito il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al merito della Repubblica. Anche sul piano internazionale il film ebbe successo, soprattutto per le sue innovazioni linguistiche estremamente discordanti con il contesto culturale di un paese socialista fino ad allora fra i più ossequienti all’ideologia sovietica.
Alcuni giovani studenti in vacanza che, bagnandosi nel fiume, non si accorgono della scomparsa di uno di loro, annegatosi, forse per un malore, affrontano sgomenti la tragedia, alla quale non sono preparati. Gli angosciosi interrogativi che si pongono e il senso di colpa che li tormenta pongono fine alla loro spensierata adolescenza ponendoli, con repentina durezza, di fronte alla realtà della vita.
Un altro regista che ha lasciato un segno nel cinema degli anni ‘60 e ’70 è il siberiano Vasilij Shukshin, del quale abbiamo potuto rivedere “Viburno rosso”, (“Kalina Krasnaja”, 1974), girato poco prima di morire a 45 anni.
Scrittore, sceneggiatore, attore e regista, eccellendo in tutti questi ruoli, Shukshin in questo film sembra essere riuscito, ancora meglio che nelle tre opere realizzate negli anni sessanta e tanto elogiate, giustamente, da Giovanni Buttafava, a far filtrare nelle maglie burocratiche della cinematografia sovietica un’opera personale, dove, oltre a curarne la regia e la sceneggiatura, interpreta anche il protagonista.
Egor, un contadino traviato da falsi amici, sconta in carcere una condanna per furto, ma appena liberato torna al suo villaggio d’origine, anche per incontrare la donna che gli ha alleviato la reclusione con le sue lettere, per dimenticare il passato e iniziare una nuova vita. Questo nobile progetto si infrange contro il passato che ritorna. Il vero tema del racconto è il conflitto fra città e campagna, meglio, fra il progresso industriale e la vita serena e solida della civiltà agricola o, meglio ancora, fra il moderno disgregatore e l’arcaico in cui l’uomo era radicato. È il regista stesso a dichiarare la sua preoccupazione per la sicura scomparsa della campagna ad opera della tecnica, preoccupazione giustificata dall’ignorare totalmente quale sarà il nostro destino nel moderno tecnologico. Stando al racconto, parrebbe che il nostro futuro sia una società industrializzata, parcellizzata e criminogena. Che abbia ragione Shukshin?
Ultimo, ma non meno importante, è la straordinaria satira nera di “La morte di un burocrate” (trad. letterale), girata nel 1966 da Tomàs Gutièrrez Alea, il più prestigioso dei registi cubani, diplomato al Centro Sperimentalo e di Cinematografia di Roma.
Il regista del capolavoro “Memorie del sotto sviluppo” (1968), non dava molta importanza a questo suo film, il primo lavoro cubano presentato in Venezia Classici, ma credo sbagliasse, rivisto oggi rivela uno sguardo critico che va ben oltre la burocrazia, magistralmente messa alla berlina.
La vicenda di un lavoratore modello, sepolto con in mano la sua tessera sindacale, che si rivelerà indispensabile perché la vedova possa ottenere la pensione, non è soltanto narrata con tono morbido e calibrato supportato da pertinenti citazioni del cinema comico muto e da una sottile vena surreale che solo la perfetta comprensione del maestro Luis Buñuel può consentire, ma allude chiaramente alla società contemporanea nella sua sostanza surreal-dadaista. D’altra parte, la burocrazia è la struttura portante, il telaio del mondo moderno, mondo al quale appartiene la Cuba rivoluzionaria, per cui come può non essere assurda una società imperniata su un impianto amministrativo delirante?
Giunti alla fine dell’excursusdella rassegna, dobbiamo tornare su alcuni aspetti che l’hanno caratterizzata.
In primo luogo la sensazionale proiezione di Estasi, il film che aveva dato scandalo quando fu presentato, nel 1934, alla seconda edizione della Biennale Cinema, dove aveva vinto per la migliore regia la Coppa Città di Venezia. Dal momento che l’opera ha vinto il Leone d’oro per il miglior restauro, effettuato dal Narodny Film Archiv nel laboratorio di Bologna, premio assegnato da ventidue studenti di discipline cinematografiche coordinati dalla regista Costanza Quatriglio, è bene ricordare che si è trattato di una impresa molto complessa perché nessun elemento della copia presentata nel trentaquattro è stato conservato e si è dovuti ricorrere a versioni in altre lingue, nonché a reperti cecoslovacchi tratti da successive distribuzioni del film. Inoltre, il marito della protagonista aveva comprato e distrutto tutte le copie che era riuscito a trovare. Il tentativo di ricostruire in digitale 4K una versione del film il più possibile simile all’originale in lingua ceca, ha avuto un esito strepitoso, cosicché si è potuto ammirare quest’ opera non solo per le scene di nudo integrale della giovanissima Hedy Kiesler, divenuta Hedy Lamarr dopo il suo trasferimento a Hollywood, e l’amplesso di lei con il giovane amante, ma soprattutto per le qualità strettamente cinematografiche.
L’opera, infatti, si presenta in un fantastico bianco e nero, dovuto al grande direttore della fotografia Jan Stallich; si svolge con un perfetto ritmo da film muto, con tutta l’espressività che ciò comporta, contrappuntato da una straordinaria colonna sonora, composta dall’italiano trapiantato in Germania Giuseppe Becce, poi famoso nel mondo; con un dialogo ridotto al minimo, che conferisce ulteriore efficacia al lirismo sensuale dell’opera; una struttura narrativa costruita su, per dirla con Mario Gromo allora inviato a Venezia, “simboli chiari ed evidenti, allusioni velate, stanchezze e languori, ritegni e abbandoni, delineati in tocchi rapidi e precisi, efficacissimi”.
Si deve aggiungere un finale “lieto”, nonostante i due amanti si lascino a causa del suicidio del marito di lei, anziano, noioso e impotente: lei si consolerà con la creatura frutto del suo amore, lui troverà conforto nel lavoro. È interessante notare che questa ultima annotazione ci viene raccontata in una sequenza da realismo socialista, quando ancora si sentiva in esso l’eco dei grandi registi sovietici.
Dobbiamo tornare anche sulle opere italiane presenti nella rassegna, a cominciare dallo “Sceicco bianco”, film che anticipa un tema sul quale Fellini tornerà felicemente in seguito e che allora la cultura italiana non frequentava. Infatti, nel 1952 a Venezia la critica, con alcune lodevoli eccezioni, fra le quali quelle di Tullio Kezich e Renzo Renzi, accolse il film molto freddamente. In realtà l’opera è una inedita e tagliente critica dell’industria culturale rappresentata allora nel nostro paese, dove ancora non era arrivata la televisione, anche dalla diffusione di massa dei cineromanzi.
Lo sceicco bianco, un eccellente Alberto Sordi, è appunto l’eroe di una diffusa storia fotografica, del quale è perdutamente innamorata una sposina in viaggio di nozze a Roma (Brunella Bovo), tanto da rischiare la rottura del proprio matrimonio, non ancora consumato, per raggiungere il suo divo sul set. Alcuni recensori, più attenti ma non abbastanza, hanno parlato di una critica alla piccola borghesia provinciale; in realtà Fellini mette alla frusta il conformismo familista e bigotto del ceto medio, ma lo pone in contrapposizione con la manipolazione spietata che, su questo stesso ceto, esercita la cultura di massa, mostrando criticamente la perfetta equivalenza dei due termini.
Ancora un’opera prima che, non solo non fu compresa alla sua uscita, ma fu violentemente criticata per ragioni del tutto ideologiche, staliniste, dice Giuliano Montaldo, un regista colto e intelligente, al quale il cinema italiano deve molto. Il film, che si avvale di un cast di tutto rispetto, narra la vicenda di un giovane (Jacque Charrier) che, dopo l’8 settembre 1943, aderisce alla Repubblica di Salò, e si troverà solo e disperato al momento della resa dei conti. Montaldo, in questo emblematico “Tiro al piccione” (i legionari di Salò avevano sul berretto un’aquila), tocca un problema estremamente significativo della nostra storia, la drammatica scelta che si impose ai giovani con l’uscita dell’Italia dalla guerra e l’invasione tedesca: aderire alla repubblica nazi-fascista o raggiungere sui monti le prime formazioni partigiane. La storia del ragazzo che fa la scelta sbagliata, a scrivere la quale collaborò un comandante partigiano piemontese, è straordinariamente attuale e ancora oggi, dovrebbe far riflettere.
Di nuovo un’opera prima, “La commare secca” (1962), di Bernardo Bertolucci, che abbiamo visto con il piacere intenso con cui si rivisita l’infanzia di un grande.
Il giovanissimo Bertolucci, reduce dal set di “Accattone”, dove era stato aiuto di Pasolini, gira quest’opera, che prende spunto dall’ultimo capitolo di Ragazzi di vita, con la collaborazione alla sceneggiatura di Pasolini stesso, e riesce a non essere pasoliniano, mostrando già, pur fra le incertezze tipiche di un’opera prima, di possedere uno stile proprio, i cui contorni, con il senno di poi, ci sono parsi chiari.
Ci è poi sembrata un’ottima scelta quella di affiancare all’opera prima “La strategia del ragno”, girato nel 1970, quando Bertolucci si era già cimentato, con “Prima della rivoluzione” (1964), in un’impresa di grande impegno sperimentale, uscendone con onore.
La tela del ragno, metafora del labirinto costituito dalla vicenda, viene resa visivamente, grazie anche alla magia di Storaro, come una delicata tavolozza, nella quale predomina il blu, la luce che assume la pianura padana nel trascolorare del giorno nella sera. La storia è una felice contaminazione fra l’insondabile J.L. Borges, dal cui racconto Tema del traditore e dell’eroe (in Finzioni) è liberamente tratta, e la terragna edonistica cultura contadina del culatello e del lambrusco. Athos Magnani (un magnifico Giulio Brogi nella duplice interpretazione del figlio e del padre), torna al paese natale dove la memoria del padre è venerata, com’ è giusto per un eroe ucciso dai fascisti. Scoprirà che la verità è ben altra attraverso un percorso intricato dove si intrecciano la memoria individuale e quella collettiva, l’implacabilità della storia e la crudeltà dell’introspezione psicanalitica, gli elementi autobiografici e le pulsioni di una intera comunità. L’ambiguità della vita rimanda all’ambiguità della Storia, questa la fondamentale chiave di lettura dell’opera, che realizza un perfetto equilibrio fra una realtà impressionista e una oniricità surrealista sullo sfondo del cielo notturno di Magritte.
Infine, ma non ultimo per rilevanza storico-critica, “Maria Zef”, un film di Vittorio Cottafavi, che tutti conoscono per le opere storico-mitologiche della giovinezza e per “I cento cavalieri”, finalmente apprezzato dalla critica italiana, ma che dovrebbe essere sottoposto ad una attenta rilettura, comprendendo anche i filmati interessantissimi per la televisione.
La storia di Mariute e della sorella Rosute, ospiti-schiave dello zio Barbe, dopo la morte della madre, in una povera casa isolata, è quella rimossa degli umiliati e offesi, ma anche quella universale degli esclusi dalla società; una delle tante tipologie dei Dannati della terra, colta con dolorosa concretezza sulle montagne del Friuli. Grazie alle teche Rai per questo regalo.
Anche quest’anno, purtroppo, non mi è stato possibile seguire tutta la interessantissima selezione dei documentari che accompagnava i classici restaurati. Oltre a ”Fellini fine mai”, che, come tutti sanno non potevo non vedere, ho presenziato alla proiezione di pochissimi altri.
La scoperta del maestro riminese che non può avere mai fine è, inoltre, firmata da Eugenio Capuccio, uno studioso di Fellini che stimo e conosco personalmente, e alla sua realizzazione ha partecipato il carissimo amico Mario Sesti, un cineasta di spessore come dimostra, ancora una volta, il suo lungometraggio Mondo sexy, presentato alle Giornate degli autori. Sono, pertanto, ancora più dispiaciuto di non poter elogiare questa opera molto impegnativa se non per i materiali inediti che presenta e per i quali consiglio di vederla assolutamente.
A proposito di Fellini, si deve esprimere gratitudine a Nathalie Giacobino, che ha curato “Fellini in Frames” con le “Pillole” del benemerito Istituto Luce in collaborazione con le altrettanto benemerite Teche Rai. I due istituti hanno così anticipato le celebrazioni, che si stanno preparando in tutto il mondo, per i cento anni dalla nascita del maestro (20 gennaio 1920). In diciotto pillole, (spezzoni di un minuto, un minuto e mezzo l’uno) vediamo un panorama, che copre esattamente trenta anni (1953-1983), costituito da vivaci flash in cui Fellini appare sul set, a Venezia, a Cannes, alle anteprime, a Cinecittà, la sua vera casa. Imperdibile.
Ancora un amico, Steve della Casa, che si è cimentato con la consueta perizia a narrare il cinema horror italiano degli anni sessanta, cioè un genere popolare di grande successo che, facendo di necessità virtù, ha rovesciato la povertà dei bilanci in inventiva e creatività, conseguendo ottimi risultati. Teniamo a mente “Boia, maschere e segreti” da vedere alla prima occasione.
Dulcis in fundo, “Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera” (trad. letterale), dovuto all’omonimo figlio del grande regista russo che, come il padre, si considera anche italiano. Il lungometraggio, che speriamo possa presto uscire nelle sale, racconta la vita e l’opera del maestro sulla base delle parole registrate, documenti anche rarissimi, dello stesso Tarkovskij, contrappuntate dai versi del grande poeta Arsenij, padre del cineasta. Tre generazioni insieme per illustrare con lucidità e passione, la complessa e originalissima poetica che informa le opere, rivisitate per folgoranti frammenti, di uno dei grandi autori del cinema mondiale.
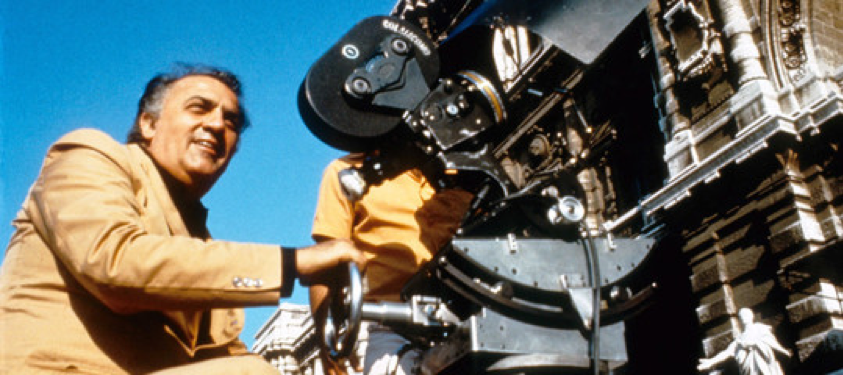
76 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA
APPUNTI DI UN CINEFILO FEDIC
di Luciano Volpi
Un’occasione per fissare nella propria mente, in modo particolare e sintetico, le sensazioni che ho provato.
“ ……come in un rapporto di amore, le parole sono irrilevanti “, ha detto
Paolo Sorrentino di Luca Bigazzi premiato con il Campari Passion per la
sua lunga carriera di direttore della fotografia, così chi ama il cinema e la Mostra del Cinema di Venezia potrebbe non trovare le parole e gli aggettivi giusti per osannarla.

Quello che risalta della kermesse appena finita, rispetto alle precedenti quattro edizioni è la qualità espressa dai film, per tutte le competizioni.
Venezia 76 ha prodotto film in linea con le ultime due edizioni, sotto il profilo della suddivisione di temi sia per l’attualità, per la storia, per il futuro e per la fantasia.
Fuori concorso come sempre un successo, non potendo ammettere
più di venti film a disputarsi il Leone D’Oro, questa sezione ospita veri e propri capolavori meritevoli e degni di visione in ogni parte del globo terrestre.
Orizzonti a vedere le file in attesa di questa sezione, in aumento costante negli anni, non possiamo che affermare l’ottimo successo tra gli appassionati.
Settimana della critica da sempre considerata e stimata, ha
avuto un altissimo gradimento sia negli Short che nei Lungometraggi tanto da essere una piccola Mostra dentro quella più blasonata delle Biennale.
Giornate degli autori per chi non la frequenta e respira quell’aria mista fra cultura, poesia e letteratura, non può avere un’idea di come si possano spalancare delle finestre sulla storia contemporanea e non, immergendosi in contesti ricchi di aperture mentali.
Fermandoci per un attimo a pensare, tralasciando il glamour che genera e circonda con il suo fascino la zona del Lido dove si svolge tutto questo, la sensazione di appagamento è palpabile.
Una cosa va detta, a Venezia non vince il film proposto, ma vince il regista con la sua opera ultima e del momento, anche se per produrre e finire le riprese e relativo montaggio, non sempre definitivo, impiegano mesi.
Questo succede in quasi ogni opera, che sia un corto od un lungo e che l’autore o gli autori delle riprese siano famosi od emergenti.
Quindi le Giurie, specialmente quelle più importanti e note ai media, hanno un arduo compito e devono divincolarsi fra le proprie convinzioni ed ideali di cinema, con le pressioni esterne non sempre identificabili e quantificabili.
La conclusione è che il dovere morale dovrebbe essere la scelta che deve essere fatta, fra l’idea e la linea, che il regista vuole dare alla sceneggiatura passata precedentemente al vaglio di chissà quale interpretazione.
Tra i film in Concorso di VENEZIA 76 molti meritevoli di essere
approfonditi e considerati nei temi ed anche per il contesto ambientale dove la storia si genera, che cito di seguito.
“La Veritè” di Kore-eda Hirokazu. Il centro del discorso è che in ogni storia di vita esistono verità, mezze verità e bugie dette in modo serio e quindi spacciate per vere. Modi di dire la verità scherzando e fingendo. Esiste anche il silenzio su certe verità in ogni famiglia, in amicizie e conoscenze. Comunque un bel film che racchiude tutte queste cose, ti coinvolge ed alla fine rimane la consapevolezza che tutto è verità e non verità. “The Perfect Candidate” di Haifaa Al Mansour. Il classico film che ti lascia trasportare in un paese dell’Arabia saudita, mettendo in evidenza il modo di vivere lavorativo alle prese con la politica locale e le differenze ancora chiare fra uomini e donne. Non credo lo vedremo nelle sale italiane. “Endlessnes” di Roy Anderson. Premiato l’ultimo film di questo ottimo regista, che affascina con l’ennesimo riferimento cinematografico e riflessivo sulla vita umana. Spezzoni filmati ironici in tutta la sua bellezza e crudeltà, splendore e banalità. Comunque un film complicato da digerire ed analizzare in maniera profonda. “Marriage story” di Noah Baumbach. Non fosse anche per le magnifiche interpretazioni di Adam Driver e Scarlett Johansson, questo film spero venga presto in programmazione in Italia. Bellissima trama capitata al regista nella sua vita privata e che abbraccia molte coppie sposate. Come essere a teatro con splendidi monologhi e duetti dei protagonisti. In questo film ci sono forse degli Oscar. “Ad astra” di James Gray. La storia del figlio che parte per ritrovare il padre scomparso, sarebbe fin troppo semplice, se non fosse che lo deve cercare “nel sistema solare“. Fantascienza sì, ma il film si svolge con imbarchi da attualità di tutti i giorni, e con lo spettacolo di quello che si vede dai finestrini molto ma molto diverso, essendo proiettati nel nostro Universo e nella velocità del tempo. “Ema” di Pablo Larrain. Devo ammettere che durante il film il primo pensiero è stato “questo regista è pazzo“!!!! Alla fine ero sconvolto dal susseguirsi di situazioni, e c è voluta la notte a portare il solito consiglio, per digerirlo, oltre un’altra visione. Il commento del regista ha veramente tolto tutti i dubbi sulla qualità della pellicola. La musica ed il ballo, a dire il vero erano subito risaltati sormontando il problema vero della storia. Siamo in Cile e le adozioni di minori non sono come in Europa, ma che esistano cosi differenze con affidi a genitori adottivi con problematiche molto superiori al normale non lo avremmo mai immaginato e pensato. Non so se lo vedremo dalle nostre parti. “Martin Eden” di Pietro Marcello. Appena tornato a casa, me lo sono trovato già in Multisala e siccome per impegni di Giuria SIC&SIC non avevo completato la visione, me lo sono rivisto. Luca Marinelli che è il protagonista è stato premiato come miglior attore con la Coppa Volpi, e questo la dice lunga.
“La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco. Diciamo subito che è un documentario-reportage tra i palermitani su cosa pensano di Falcone e Borsellino. Inspiegabilmente è emerso che di loro non gli frega assolutamente niente e che non riescono nemmeno a dire letteralmente “abbasso la mafia“. Potrebbe essere tutto qui, se non girato con personaggi locali che fanno veramente risaltare tale situazione. “Joker” di Todd Phillips. Leone d’Oro è tutto dire. Magistrale storia inventata più volte, ma questa ha davvero la drammaticità umana che la rende vera. “J’accuse” di Roman Polanski. Bellissimo film di una storia vera tratta da un romanzo.
“Il sindaco del rione sanità” di Mario Martone. Valido regista teatrale, cinematografico e sceneggiatore, che porta sugli schermi una bella commedia di Edoardo De Filippo.
SIC @ SIC
ShortItalianCinema@SettimanaInternazionaledellaCritica
Giunta alla quarta edizione, all’interno della 76 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, SIC @ SIC ha proposto una selezione competitiva di sette cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio, due eventi speciali fuori concorso presentati in prima mondiale ed inseriti e programmati nell’ambito della 34. Settimana Internazionale della Critica. Scelti da una speciale commissione di selezione il programma nasce dalla sinergia fra il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) e Istituto Luce-Cinecittà, ed è una delle iniziative per il supporto allo sviluppo del nuovo cinema italiano e per la promozione dei giovani autori. La FEDIC ha creato, nell’ambito del Premio FEDIC, una giuria di cui ho fatto parte relativamente ai cortometraggi.

E’ stata una nuova e bella esperienza prima di tutto per il confronto con altri giurati professionali, poi per lo scambio di opinioni sulle opere proposte e fedeli al principio che la critica cinematografica, è quel genere letterario che si propone di raccontare, analizzare, spiegare e giudicare un’opera cinematografica. Genericamente divisa in due correnti: la critica giornalistica, ossia la recensione, e la critica teorica, ossia lo studio del cinema. Io in questo momento faccio, credo di fare parte della prima.
24 Forum FEDIC su “Il futuro del corto di autore“
Autori FEDIC di ieri e di oggi
(a cura di Paolo Micalizzi – Fedic Cinema)
Seconda mia partecipazione al Forum Fedic nel 70° anno di attività di promozione di cultura cinematografica, proseguendo nell’opera di guardare al futuro e aprendosi ai necessari cambiamenti della nostra società. Questa attività procede con masterclass, proiezioni ed incontri con autori emergenti e con l’innovazione riguardante l’evoluzione dell’aspetto comunicativo interno ed esterno alla Federazione stessa. Queste innovazioni, fra le altre cose, incentivano la partecipazione attiva di tutti i cineclub, aumentando lo spirito di appartenenza, inoltre un impegno costante e continuo per le attività di formazione rivolte a soggetti di ogni età.

Sono state mostrate delle proiezioni di un Classico Fedic, di un Autore scelto dalla Rete REFF, e Trailer di alcuni cortometraggi di autori Fedic realizzati nel 2018/2019. Prova ne è anche la modalità esperienziale per ragazzi ed adulti, che possono conoscere e sperimentare tecniche espressive diverse, sempre più complesse ed evolute anche nella tecnica. Infatti la Fedic, con “Il cinema nella scuola “curato da Laura Biggi (Responsabile Fedic Scuola), e Ilaria Copeta (Booktrailer Film Festival), che hanno illustrato il progressivo aumento di questa iniziativa, ha ottenuto un successo incredibile nelle scuole. La preparazione, i contenuti e la tecnica dimostrata dai vincitori del Premio BFF con le proiezioni delle loro opere, ha meravigliato e stravolto i presenti con le loro capacità. 1° classificato: “Corpo” – Liceo Scientifico Leonardo di Brescia 2° classificato: “Esercizi di stile” -Liceo Scientifico Leonardo di Brescia 3° classificato: “Milk and honey” – Liceo Artistico Umberto Boccioni di Milano Complimenti agli autori, ai collaboratori ed ai produttori per aver proposto temi nuovi e tecniche all’avanguardia, nel segno di questa splendida iniziativa.
GIORNATE DEGLI AUTORI
16a edizione
Si sono svolte, sempre nel contesto della Mostra, nello scenario della Villa degli Autori sul Lungomare Marconi, a duecento metri dal famoso red carpet, era capitanata dal presidente Andrea Purgatori, che per l’occasione ha adoperato il motto “coraggio, curiosità e uno sguardo originale “. Da sedici anni le Giornate degli Autori sono una realtà che difende e promuove, il coraggio del cinema indipendente italiano e internazionale. Sostenute da Anac e 100 autori, nella piena libertà di scelta, le opere che sperimentano nuovi linguaggi anche nel documentario e nei film di animazione.

Il successo, è ripagato dall’impegno che le associazioni degli autori italiani mettono per la selezione e dai dibattiti che si susseguono sui diritti degli spettatori, sulla tutela del diritto d’autore e lo stato della produzione e sul confronto costante con le altre cinematografie. Il delegato generale Giorgio Gosetti, splendido conduttore di presentazioni per ogni opera od incontro, sia nelle sale della Mostra al Lido, nel Sestriere di San Marco, a Mestre e a Villa degli Autori, si è adoperato in maniera brillante per la riuscita di tutta la manifestazione. Atmosfera particolare, brillante negli incontri come quelli con alcuni membri del Parlamento Europeo, con Guido Crepax, Elio Germano, Marco Bellocchio (Premio Siae 2019) e, in particolare, il documentario su Emilio Vedova (pittore veneziano) scomparso di recente, narrato da Toni Servillo. Presentazioni di libri, come quello di Paolo Micalizzi dedicato a Massimo Sani. La Storia in Televisione. Tutto questo a significare l’impegno e la dedizione degli organizzatori per la riuscita di questo movimento di autori ed artisti, volto a far conoscere i loro modi di pensare e divulgare il cinema e l’arte.
VENEZIA 76: INTERVISTA ALLA REGISTA NUNZIA DE STEFANO
di Laura Biggi
Hotel Excelsior Lido di Venezia 7 settembre 2019. Nella sala dell’Ente dello Spettacolo si è appena conclusa la cerimonia di consegna dei premi collaterali.
Fedic ha assegnato la menzione speciale al film Nevia con la seguente motivazione “Da una storia autobiografica di povertà e disagio sociale, un film al femminile che affronta con sensibilità e in modo coinvolgente e avvincente, attraverso le vicissitudini di una 17enne alla ricerca di una propria identità, i temi della ricerca di un lavoro, dell’amore e del desiderio di libertà, lontano da imposizioni e condizionamenti “.

La giovane regista Nunzia De Stefano e la giovanissima protagonista Virginia Apicella hanno una luce particolare nello sguardo, guardandole non posso fare a meno di apprezzare e condividere la loro emozione per questo successo. Sono due donne “normali”, soddisfatte del riconoscimento ottenuto, ma molto lontane da ogni atteggiamento di superbia e di divismo. Mi avvicino per complimentarmi con loro, “Nevia” è uno dei pochi film che sono riuscita a vedere nel mio breve soggiorno a Venezia e che ho sinceramente apprezzato. Incuriosita pongo loro alcune domande, alle quali rispondono volentieri e con naturalezza. Da questo dialogo – intervista ho cercato di estrapolare i passaggi che mi sono sembrati più significativi e che riporto di seguito.
Chiedo a Virginia, giovane interprete di parlarmi di questa sua avventura cinematografica.
“E’ stata un’esperienza bellissima, ho scoperto di avere capacità che non sapevo di avere – indica la regista dicendo- grazie a lei che mi ha lasciato libera di esprimermi, di essere me stessa. Sul set ho quasi dimenticato la presenza della ‘macchina’”.
Chiedo alla regista di illustrare le varie fasi di questo progetto cinematografico “al femminile”.
“Innanzitutto per me è una grande soddisfazione essere qui, ricevere questo riconoscimento Fedic. Non è stato facile affrontare un tema che in parte mi riguardava, ho cercato comunque di allontanarmi dalla mia storia, di affrontare temi importanti ed universali come la posizione delle donne, nel film ce ne sono molte, ognuna diversa dall’altra, non vengono mai giudicate e questo è significativo. Mi hai chiesto come ho trovato la protagonista… la scelta è stata piuttosto ‘partorita’, la gestazione è terminata dopo mesi di casting; i selezionatori sono arrivati in un teatro dove c’erano ragazze che provavano acrobazie di tipo circense, lei faceva l’elastico, mi hanno mandato delle fotografie in diretta ed io ho detto ‘me la devi subito fermare’. Virginia ha fatto una breve intervista, poi ci siamo incontrate e lì è nata la scintilla, proprio feeling immediato”.

Si guardano con atteggiamento tenero e complice, sembrano essere legate da un vincolo parentale o da un’amicizia di lunga data. Appaiono decise ad alimentare e mantenere viva quella fiamma che insieme hanno acceso con grande passione ed intensità.
Nunzia De Stefano, collabora da anni con Matteo Garrone ed è al suo primo lungometraggio da regista. Virginia Apicella ha esordito da protagonista con un’interpretazione molto naturale e realistica. Credo che nel prossimo futuro queste due artiste saranno in grado di dare vita a nuove storie ed immagini suggestive di cinema neorealista.
67 EDIZIONE DEL SAN SEBASTIÀN INTERNACIONAL FILM FESTIVAL
di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

Dal 20 al 28 settembre si è svolta a San Sebastiàn, Paesi Baschi (Spagna), la 67 Edizione del Festival del Cinema. Un’edizione “discreta”, dove si son viste proiezioni interessanti, dove però è mancato il “grande” film. Ci si aspettava il titolo vincente, visto che la selezione ufficiale mancava di registi di richiamo internazionale, il che significa scommettere su opere prime o film che non si sa la rilevanza che potranno avere. In ogni caso non si può negare che il Festival abbia avuto la sua personalità ben definita dove il cinema è stato il vero protagonista, siano piaciuti o meno i titoli proposti.
Il cinema brasiliano è stato il grande vincitore di quest’edizione: “Pacified” ha vinto tre dei premi più ambiti del concorso. La giuria, presieduta dal cineasta Neil Jordan, ha consegnato la Conchiglia d’oro come Miglior film; la Conchiglia d’argento come Miglior attore, Bukassa Kabengele; ed il premio alla Miglior fotografia a Laura Merians. Si tratta del secondo lungometraggio diretto dall’americano Paxton Winters e nasce da una collaborazione con la comunità della favelas di Morro dos Prazeres. Ambientato durante i Giochi Olimpici del 2016 celebrati a Rio di Janeiro, quando la polizia cerca “pacificare” le favelas per dare al mondo un’immagine di normalità ed ordine, il film narra della relazione tra un’introversa tredicenne figlia di un boss narcotrafficante appena uscito di prigione e che rifiuta di essere di nuovo il capo del territorio.

L’altro film vincente, con due riconoscimenti ufficiali è stato “The Endless Trench” diretto da tre registi, Josè Maria Goenaga, Aitor Arregi e Jon Garano, fatto insolito nel mondo del cinema, che ha vinto i premi per la Miglior regia e sceneggiatura. Il lungometraggio, un’allegoria della paura e dell’istinto di sopravvivenza, narra la storia di un militante della sinistra che si nasconde, con l’aiuto della moglie, per 33 anni nella propria casa per paura della repressione franchista dopo lo scoppio della Guerra Civile spagnola. L’amnistia del 1969 da parte del governo, ha portato alla luce l’esistenza dei cosiddetti “topi”, persone che vivevano nascoste da anni, dalle quali il film ha tratto ispirazione.
Il premio speciale della giuria è andato al film francese “Proxima”, diretto da Alice Winocour, con Matt Dillon ed Eva Green, e descrive i dubbi, le incertezze e le crisi di una madre di una bambina di sette anni, dalla quale deve separarsi per prendere parte ad un’importante missione spaziale. Un film apprezzato da pubblico e stampa è stato “A Thief’s Daughter”, alla cui protagonista, Greta Fernàndez, è stata consegnata la Conchiglia d’argento come Miglior attrice. Narra le difficoltà di una giovane madre single alle prese con un padre assente, che deve guadagnarsi da vivere con lavori precari.
Il premio è andato ex aequo all’attrice tedesca Nina Hoss, per il suo schizofrenico ruolo nel film “The Audition”, secondo di Ina Weisse, che racconta la storia di un’insegnante di violino ossessionata da un suo alunno, al punto di trascurare famiglia ed amante.
Altri film valgono la pena di essere menzionati, nonostante non si siano aggiudicati premi. “Blackbird”, del sudafricano Roger Michell e interpretato da Susan Sarandon e Kate Winslet, che affronta il problema dell’eutanasia e delle conseguenti implicazioni familiari; “Roks”, dell’inglese Sarah Gavron, narra la storia di un’adolescente con grandi sogni che svaniscono quando la madre abbandona lei ed il fratellino. Il conosciuto attore portoghese, Gonçalo Waddington ha debuttato come regista con “Patrick”, la storia di un bambino di 8 anni rapito in Portogallo da una pederasta e che 12 anni dopo affronta il ritorno alla sua famiglia, cercando l’identità. Uno dei più attuali cineasti cinesi, Sonthar Gyal, ha presentato “Lhamo and Skalbe”, dove si racconta l’amore impossibile tra due giovani di una remota regione tibetana, uno scontro tra tradizione e desiderio di riscatto e libertà. La canadese Louise Archambault ha presentato “And the Birds Rained Down”, la sorprendente storia di tre anziani che hanno scelto di ritirarsi dal mondo e vivere nei boschi del Canada. Alejandro Amenàbar con “While at War”, rievoca gli ultimi giorni dello scrittore e filosofo spagnolo Miguel de Unamuno e della sua posizione ambigua di fronte al colpo di stato che ha dato inizio alla Guerra Civile Spagnola: per averlo sostenuto e per averlo condannato neppure quattro mesi dopo.
I protagonisti più speciali di questa edizione sono stati senza dubbio i tre vincitori del premio Donostia. L’attrice spagnola Penèlope Cruz, doppiamente protagonista: oltre a ricevere il riconoscimento per la sua carriera cinematografica è stata l’immagine del poster ufficiale dell’evento. Il regista francese di origine greca, Costa-Gavras per il suo impegno nel cinema sociale e politico.

Infine, una leggenda del cinema, Donald Sutherland, per cinquanta anni di eccellenza interpretativa.

CORTO FICTION, FESTIVAL ALL’INSEGNA DEL BELLO,
GIUSTO ED UTILE DEL CORTOMETRAGGIO
di Paolo Micalizzi
Frequentandolo sempre di più ci si affeziona maggiormente a questo “piccolo” Festival di Chianciano Terme ed ai suoi organizzatori principali Lauro Crociani e Cristiana Vitalesta che con il loro staff lo portano avanti con passione e capacità. Il tutto nell’accogliente cornice delle Terme dove Federico Fellini ha ambientato alcune scene del capolavoro “8 ½” e che oggi è ricordato con una Sala dedicata al Maestro riminese, diventato Maestro del Cinema in tutto il mondo. Ed è proprio nella Sala Fellini che è avvenuta anche la premiazione della 19^ edizione alla quale hanno partecipato 12 cortometraggi “più belli dell’anno” scelti tenendo presenti valori importanti come la Fratellanza tra i popoli, Libertà per gli individui, Ironia sulla società dei consumi, Idee di Pace e di Anima, e sano Divertimento , come recitano i principi che stanno alla base del Festival ed all’insegna de “Il Bello, il Giusto e l’Utile del Cortometraggio”. Si è aggiudicato il Premio come miglior cortometraggio “In zona Cesarini” di Simona Cocozza che non potendo intervenire alla premiazione ha delegato l’attore Domenico Aria, peraltro, premiato con una Menzione Speciale quale miglior interprete. Si tratta di una commedia assai brillante e spiritosa sul tema del coming out che nel corto emerge durante un pranzo della domenica preparato dalla mamma con tanto amore alla presenza di un ospite inaspettato.
Per il Tema spirituale, premiato “Testimoni silenziosi” di Irene Magnani e per la Miglior Comedy “Muse” di Stefano Scaramuzzino dove affronta il tema dell’ipocrisia.
Targa La memoria a “Mercurio” di Michele Bernardi con protagonista un giovane che fugge da un campo d concentramento, lasciando il buio ed avviandosi verso la luce della libertà. Per il tema libero premiato “Il mondiale in piazza”, opera che è un inno alla fratellanza. Protagonista, nel sud Italia, un gruppo di ragazzi che non potendo tifare per l’Italia perché non si era qualificata ai mondiali di calcio, organizza un mondiale in piazza( siamo a Bitonto) fra l’Italia e le altre nazionali composte di immigrati. Ed è per il calcio, e l’amicizia, una grande festa. “Elvis” di Andrea Della Monica ha ricevuto il Premio Cavallo Alato. Elvis è uno di noi che lascia per un improbabile successo la sicurezza familiare : In fondo potrà sempre “sognare quotidianamente un Cavallo alato sopra un carro trascinato dai cavalli del maestrale in volo”. Protagonista Elvis, un ragazzo che di giorno fa l’impiegato in un deposito e di notte imita il mito Elvis Presley trovandosi di fronte ad una difficile scelta quando gli viene proposto un tour in Cina. Premio Fellini a “ Armandino e le colline” dove si assiste ad un racconto breve divertente che ricorda il Ciccio Ingrassia di “Amarcord”, il matto in cima ad una pianta cosi come Armandino corre dietro le tette di una bella donna. Premio della critica ad ”Aida” di Mattia Temponi “ che sa esaltare l’importanza nell’essere umano dell’istruzione e della Cultura, una forza illuminata e vincente verso l’ottusa ignoranza che tende a imprigionare le persone e l’intera società”. Un riconoscimento anche a ”Nomofobia” di Ado Hasanovic dove si assiste ad un piano-sequenza tra due donne che porta in evidenza un problema che spesso nelle famiglie purtroppo non si vuole vedere ed affrontare: gli è stato attribuito il Premio Sociale.

A “Macerie” di Franco Ligalupi è stato giudicato miglior film Fedic, un autore alla perenne ricerca della verità. Miglior soggetto, “The bag” di Giacomo Buongarzoni , cortometraggio che affronta il tema della paura, graffiando e riuscendo a farci ridere sopra gli spettatori. Hanno presentato con garbo e impeccabilità Emanuela Cioli e Fabio Pirastu. Durante il Festival, il” Salotto Fedic “ ha offerto l’occasione di incontrarsi e confrontarsi sul tema dell’audiovisivo. Appuntamento al 2020 , anno del centenario della nascita di Federico Fellini. E Lauro ha in testa grandi idee.
NOMI ILLUSTRI E GIOVANI CRITICI AL FESTIVAL ADELIO FERRERO –
CINEMA E CRITICA
di Bianca Ferrigni
Shell Shapiro e Giuliana De Sio sono stati i protagonisti della serata finale del Festival Adelio Ferrero – Cinema e Critica, svoltosi ad Alessandria dal 10 al 13 ottobre: una delle edizioni più belle e apprezzate del Festival, quest’anno sotto la direzione artistica di Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli. Una nuova location (Il teatro alessandrino di via Verdi), una serata d’avvio dedicata all’avventurosa storia del cinema italiano (con Adalberto Maria Merli e Mirella D’Angelo, nei locali dell’Associazione Cultura e Sviluppo), la presenza di nomi illustri della critica come Marco Giusti e Oreste De Fornari, il regista Maurizio Ponzi e il David di Donatello Davide Favargiotti, omaggi a Massimo Troisi (con Anna Pavignano) e a Carlo Rambaldi (con i ricordi del critico Paolo Micalizzi, la proiezione del corto “Trespass” e di “L’occhio, la mano, il viaggio”, entrambi di Victor Rambaldi) e una lezione sulla musica nel cinema thriller del compositore Marco Werba.

Tra aneddoti e riflessioni, i molti ospiti hanno permesso quest’anno al pubblico di riscoprire momenti importanti della storia dello spettacolo degli ultimi decenni, con un occhio alla storia della critica (la presentazione del libro “Il mio cinema” che raccoglie gli scritti di Claudio G. Fava, in uscita per l’editore Falsopiano), e l’intenzione di difendere l’attualità del pensiero critico rivolto al cinema e ai media, ribadita dai direttori per i quali: “bisogna tenere viva l’abitudine di valutare, giudicare, analizzare il testo cinematografico, uscendo dalla superficialità e sopratutto dalla tendenza di parlare del cinema parlando di altre cose”.

Viva il futuro e la critica, allora, e soprattutto i giovani critici, premiati quest’anno per la loro partecipazione alle tre sezioni del Premio Ferrero. Le premiazioni hanno permesso di verificare come il “Ferrero” stia acquisendo una dimensione che travalica i confini nazionali. La sezione dedicata ai video saggi ha visto, infatti, la partecipazione di candidati di molti paesi europei e non solo. I vincitori sono stati un francese e un americano. Il primo classificato è stato Laînè Chloè Galibert di Parigi con Watching the pain of others. Il secondo premio è stato assegnato allo statunitense Philip Brubaker dagli Stati Uniti con Stranger/Things. Nella sezione “recensioni”, prima classificata Desirée Massaroni di Roma con Santiago, Italia di Nanni Moretti, secondo Leonardo Strano di Vimercate con High life. Segnalazione di qualità per Martina Puliatti di Lamezia Terme, Annagiulia Zoccarato di Borgone di Susa ed Elvira Del Guercio di Bologna. Per la sezione “saggi”, il primo premio è stato assegnato a Ilaria Puliti di Ascoli Piceno per il suo lavoro intitolato Spazi rivendicati. L’adolescenza femminile nel cinema di Alice Rohrwacher. Secondo premio a Matteo Macaluso di Castelnuovo Magra per Immagini di un mestiere. Rappresentazioni della critica nel cinema italiano. Segnalazione di qualità per Cristina Sivieri di Cremona e Federico Ercoli di Agnadello. Della giuria del Premio per gli elaborati cartacei hanno fatto parte nell’edizione 2019: Danilo Arona, Mathias Balbi, Davide D’Alto, Steve Della Casa, Bruno Fornara, Mario Gerosa, Roberto Lasagna, Luca Malavasi, Anton Giulio Mancino, Roy Menarini, Emiliano Morreale, Adriano Piccardi, Giulio Sangiorgio, Saverio Zumbo. Della giuria del Premio per i video saggi, hanno fatto parte: Marco Bertozzi, Luca Bigazzi, Marcello Walter Bruno, Cécile Chièze, Oreste De Fornari, Elfriede Gaeng, Paolo Lipari, Mirko Locatelli, Umberto Mosca, Giovanni Robbiano, Antonella Sica, Antonio Somaini, Giuditta Tarantelli. La sezione video-saggi è stata curata da Saverio Zumbo.
OCCHIO CRITICO
LUCI DALL’ORIENTE
di Marco Incerti Zambelli
La strepitosa fotografia di Hong Kyung-pyo illumina due tra i più belli ed importanti film che segnano la stagione cinematografica, “Parasite” di Bong Joon-ho e “Burning” di Lee Chan- Dong, ambedue sud coreani, a rimarcare la prodigiosa vitalità della produzione di quel paese, che vanta autori quali Kim Ki-duc e Park Chan-woog.
Hong, sulla scorta di grandi maestri a partire da Vittorio Storaro, ha infranto le regole delle strutture produttive del cinema coreano, che, come quelle americane, prevedono una rigida separazione di ruoli tra il datore di luci e il responsabile delle inquadrature, rivendicando il ruolo di coautore dell’opera, grazie anche alla ribadita volontà di coinvolgimento con il regista già in preproduzione. L’abilità nelle stesure cromatiche che diventano essenziali elementi del racconto e l’agilità nel dipingere movimenti di macchina in vere e proprie emozionanti coreografie che avvolgono e accompagnano lo spettatore, ne fanno uno dei sommi cinematographer del panorama contemporaneo.
Non è solo la resa luministica ad accomunare le due opere, ma il (ri)emergere di tematiche che il cinema occidentale pare spesso avere dimenticato: le profonde differenze tra ricchi e poveri e la lotta di classe, la latente ma potenzialmente esplosiva carica che sottendono.
In “Parasite” Bong ritorna, dopo le felici incursioni nella fantascienza di “Snowpiercer” e “The Host” e la meno riuscita nell’immaginifico di “Okja”, alla contemporaneità che già aveva attraversato in “Mother”.
La sua abilità nel padroneggiare diversi stilemi narrativi ci consegna un’opera di difficile definizione, costringendo i recensori on line ad accumunare commedia, dramma, thriller, grottesco. Dopo un prologo nel quale, con affettuosa ma feroce ironia, viene presentata la poverissima famiglia Kim, che vive in un seminterrato dibattendosi nella ricerca di sopravvivenza confezionando contenitori in cartone per le pizze a domicilio, inseguendo affannosamente un segnale WiFi non protetto, provando e riprovando ad accedere al college, la prima parte del film racconta con toni da commedia del progressivo installarsi dei familiari nell’entourage della ricca famiglia Park. Il figlio Ki-woo viene fortunosamente assunto come insegnante di inglese per la giovane Park e abilmente riesce a piazzare la talentuosa sorella Ki-jing cone tutrice artistica del piccolo irrequieto Park. Con spregiudicato cinismo vengono proditoriamente fatti licenziare autista e domestica sostituiti da padre e madre Kim. E tutto pare procedere serenamente: i quattro assolvono con diligenza ai loro compiti, usciti finalmente dalle ristrettezze, con soddisfazione dei padroni. Ma una notte nella quale i Kim si godono il lusso della villa approfittando della momentanea assenza dei Park una ‘simbolica’ tempesta scatena la realtà: quel temporale che non è che un noioso contrattempo per i ricchi è causa della rovina nella casa dei poveri, che si trovano anche a lottare ferocemente con chi è vive ancora più basso (non solo metaforicamente) di loro. E sarà la scoperta che l’odore, l’afrore irrimediabile che contraddistingue la miseria della famiglia e che suscita il fastidio dei ricchi ad essere elemento scatenante della tragica presa di coscienza di padre Kim, della sua lucida ribellione. Il finale, pur tra lutti e disgrazie, ambiguamente disegna la volontà indomita di Ki-woo di continuare a sognare il riscatto, una forse impossibile uscita dalla povertà e dalla miseria.
In “Parasite” Bong esalta al massimo il riconosciuto magico virtuosismo, dispiega ai massimi livelli la capacità di impreviste svolte narrative e la commistione dei generi, a confezionare un’opera che, nel mettere in scena le storie intrecciate delle singole famiglie e le loro relazioni, affronta con lucida concretezza la cruda realtà delle di una società ipercapitalista, fortemente competitiva, nella quale le differenze sociali sono strutturali, ineliminabili, che costringono i paria, i “parassiti” a dimenticare ogni solidarietà di classe, a combattere tra di loro sugli avanzi dei ricchi e potenti.
La maestria della fotografia di Hong Kung-Pio illumina anche “Burning”, ultima realizzazione di Lee Chan-dong, poliedrico autore sud coreano (anche musicista, drammaturgo, romanziere, produttore e pure Ministro della Cultura del suo paese) che torna sul grande schermo ad otto anni dal successo di “Poetry” e a quasi venti da “Oasis”.
Tratto con una certa libertà da un corto racconto di Murakami ed esplicitamente ispirato ad un breve romanzo di Faulkner dallo stesse titolo, “Burning” lascia allo spettatore, se lo vuole, sciogliere le tante sospensioni, le tante irrisolte ambiguità messe in scena, perché, lo spiega la luminosa Hae-mi con la pantomima dell’arancia da sbucciare: ”In realtà non devi immaginare che l’arancia sia qui, ma dimenticare che l’arancia non sia qui”. Con toni lievi, spesso lirici, il film racconta di Jong-su, giovane aspirante scrittore di origine contadina che si barcamena con lavoretti, quando incontra Hae-mi, leggiadra bellezza ed antica compagna di scuola della quale ben poco ricorda e, inevitabilmente, se ne innamora.
Ben presto però lei parte per un iniziatico viaggio in Africa, affidandogli la cura del suo gatto, compito assolto con cura coscienziosa, anche se l’animale non si fa mai trovare. Al ritorno Hae-mi è con Ben, affascinate, gentile e ricco coetaneo. Si instaura uno confuso triangolo, i rapporti tra loro rimangono sfuggenti, la vicenda si dipana tra ristoranti lussuosi, vecchie case contadine al confine con l’incombente Corea del Nord, sparizioni misteriose e confessioni di inquietanti passatempi. Se Lee pare non rivelare nulla, (l’esistenza del gatto, la realtà del salvataggio del piccolo Jong-se della ragazza dal pozzo, la verità degli incendi dei granai di Ben, dov’è finita Hae-mi, le ragioni profonde della tragedia finale) tuttavia disegna un vivido quadro di una società dalle profonde disuguaglianze, delle difficoltà di trovare un ruolo soprattutto per le giovani generazioni, per le quali, come dichiara in un’intervista l’Autore, ‘il mondo sta diventando un gigantesco, puzzle’, e la coscienza della sua irresolvibilità è tutta nello struggente pianto di Hae-mi che conclude la sua magica, sognante danza al tramonto, quando l’inarrivabile suono della tromba di Miles Davis sfuma.
PALCO E CONTRO-PALCO
STANLIO & OLLIO
di Francesco Saverio Marzaduri
Durante la trasmissione “Laurel & Hardy – Due teste senza cervello”, che la RAI dedicò alla celebre coppia nell’autunno 1985, Alberto Sordi – com’è noto, la più celebre “voce” di Ollio – testimoniò che il declino dei due comici cominciò a ridosso dei primi anni Cinquanta, prima di raggiungere il punto più basso col loro ultimo, infelice lungometraggio, “Atollo K”, girato tra Francia e Italia. All’insuccesso del film – raccontava Albertone – seguì un tour internazionale, durante il quale il duo si esibiva nei propri sketch più noti: eppure il gusto dell’Assurdo, un tempo magica scintilla, andava affievolendosi fino a ridursi a umilianti spettacolini da rivista, unico “modus operandi” per le star di sbarcare il lunario spinte dall’indigenza. Nel “biopic” che Jon S. Baird dedica alla coppia, tutto questo si ritrova, e fedelmente, optando il regista per l’ultima parte della carriera a mo’ di cornice, opposta a un prologo in cui i Nostri, in una fase del successo già in bilico, discutono animatamente (con Laurel che minaccia la rescissione contrattuale col simpatizzante fascista Hal Roach, e Hardy che vanamente cerca di dissuaderlo), mentre s’avviano sul set de “I fanciulli del West” per la scena del balletto all’ingresso d’un saloon. La riuscita di “Stanlio & Ollio” – inutile negarlo – scaturisce da un senso di verosimiglianza attenta a fotografare l’istantanea di un’epoca in cui i tempi d’oro di “quello” humour cedono il passo a nuove leve, nuovi talenti, nuovi fan. A conciliare con segmenti in cui il duo si esibisce in teatrini che si svuotano sempre più desolatamente, costretto ad alloggi mortificanti e non proprio all’altezza della loro fama, sono i nuovi astri d’un “vaudeville” in crescita, di cui Norman Wisdom è principale stella, o del cinema comico di Gianni e Pinotto (troneggiante su un manifesto che lo sconsolato Stan rimira), che sembra averli spazzati via. Tale senso di smarrimento imminente acquista maggior palpabilità nella scena in cui, essendo Ollie costretto a letto dopo un attacco cardiaco, il partner è indeciso se rimpiazzarlo o meno – e con chi, poi. Segue la lunga parentesi dell’ipotetica lavorazione d’una parodia di Robin Hood, che i due immaginano girata come un’operetta in stile “Fra Diavolo” e che la carenza di fondi (e lo scarso interesse del produttore Harold J. Miffin) rende impossibile. E si assiste, nel corso d’un ricevimento, a frizioni e malumori tra caratteri complementari e diversi, con Stan accusato di essere un vuoto egoista senza gag né macchina da scrivere, e “Babe” tacciato di pigrizia e scarso talento come interprete “serio” (e in effetti, se si esclude la partecipazione al fallimentare “Zenobia” dove Hardy “tradì” Laurel con Harry Langdon, la sola pellicola in cui recitò da coprotagonista fu “Dopo Waterloo”, al fianco di John Wayne). Ma pur nei contrasti, proprio la complementarietà fa sì che l’un l’altro si rivelino un’inconfessata verità, obbligando uno dei due, tra il clamore d’un pubblico che li applaude come un tempo, a una scelta rischiosamente consapevole. Benché talora si ceda il passo a inevitabili romanticherie, l’agiografica verosimiglianza è rispettata con scrupolo e dovizia: se ci si appassiona agli ultimi bagliori d’un (ilare) crepuscolo, è solo perché l’amore di tutti per quei clown irresistibili non s’è mai spento, e la loro storia è cosa nota. Né mancano i dettagli dei trascorsi d’alcolista di Stan o della mania per le scommesse di Ollie (presente, come pochi sanno, anche ne “La gioia della vita” di Frank Capra in cui Hardy concedeva un auto-ironico “cameo”). Complice l’apporto dello sceneggiatore Jeff Pope, Baird non dimentica d’includere il collaudato artificio realtà-finzione, che nell’episodio della lite disorienta gli invitati incapaci di stabilire se assistano o meno a uno sketch. Nonostante l’effettiva riuscita, dovuta “in primis” all’alchimia mimetica degli interpreti Steve Coogan e John C. Reilly (col secondo, ingrassato per l’occasione, a uscirne trionfante), ci si chiede cosa sarebbe stata l’operazione se avesse disposto del tocco filmologico d’uno Scorsese o di un Bogdanovich, che col recente documentario “The Great Buster: A Celebration”, dedicato a un altro pilastro della comicità, acclude un tassello al campionario della celluloide comica che fu. Qui, tornando la mente anche a quella commedia di Broadway ch’era “I ragazzi irresistibili”, appunto imperniata su due ex stelle del varietà e sulle loro incomprensioni, si (sor)ride e ci si commuove nel rimpianto d’uno humour prossimo al congedo, che – come specifica una dicitura conclusiva – non ha impedito al vecchio Laurel di continuare a scrivere, anche dopo la morte del partner e dopo il ritiro dalle scene. Come non ha impedito alla sua opera di essere riscoperta da futuri maestri della comicità, da Jacques Tati a Jerry Lewis, nonché allo scrittore Osvaldo Soriano di dedicare alla coppia (e un po’ a tutta la Hollywood dell’epoca) “Triste, solitario y final”. E, sullo scorrere degli “ending credits”, altrettanto inevitabile è veder riapparire le due stelle – quelle vere – che danzano nella scena de “I fanciulli del West”. Così ridevano. E così ridevamo anche noi, nati molto dopo, come i bambini di novant’anni fa.

Rocketman
“E quando piove la pioggia cade
Lavando la città di allevatori
E lei è lontana da qualche parte
Nel suo piumino
E sogna ruscelli cristallini
Giorni andati quando ci sporgevamo
Ridendo a crepapelle pronti a farci scoppiare a vicenda…”
ELTON JOHN – BERNIE TAUPIN
Classe 1947, Sir Reginald K. Dwight (in arte Elton Hercules John) ha da poco annunciato l’addio alle scene. E in contemporanea con il suo ultimo tour, dall’esplicativo titolo “Farewell Yellow Brick Road”, lo fa producendo un “biopic” promozionale sulla sua carriera, presentato fuori concorso all’ultima Croisette e accolto da enormi ovazioni. Si dubita tuttavia che “Rocketman”, insieme ad analoghe operazioni (ne risulta in preparazione un altro su Boy George) studiate per bissare il clamoroso consenso di “Bohemian Rhapsody”, possa ripeterne il miracolo: e questo, beninteso, non per fattori estetici. Nell’agiografia dedicata a Freddie Mercury si voleva restituire l’effigie d’un artista tormentato dalle proprie radici, per un bel pezzo rinnegate, e dalla graduale non meno inquieta consapevolezza della propria omosessualità: perfetti ingredienti per trasformare l’esistenza della star in “feuilleton” romanzato, maledettismi compresi, col rischio di trascurare il rapporto tra divo e palco, elemento dapprima accennato e solo nell’epilogo generosamente restituito. Proprio l’inglese Dexter Fletcher, chiamato a sopperire Bryan Singer nella direzione di “Bohemian”, nel mettere in scena il percorso umano di Elton John sceglie di giocare la carta più confacente a tale operazione: un musical semi-onirico, in cui ventidue brani tra i più noti della sua vasta produzione, all’occorrenza reinterpretati dal cast, fanno da commento a un tripudio di coreografie, luci, costumi, lustrini, “décor” all’insegna del kitsch. L’esito può dirsi felicemente compiuto, benché i luoghi canonici sugli artisti musicali e le loro debolezze siano un calcolato azzardo. Sin dall’incipit il regista non smentisce la regola, introducendo l’Elton dei primi anni Novanta, sulle melodiche note per archi di “Goodbye Yellow Brick Road”, abbigliato come un diavolo pennuto e sgargiante e gli immancabili appariscenti occhialoni, che pare aggirarsi dietro le quinte d’un palco raggiungendo invece una seduta di disintossicazione per alcolisti. Va da sé che mentre il protagonista s’accinge ad affrontare i demoni del passato, e ripercorrere le orme che l’hanno trascinato agli eccessi, dall’alcol alla droga (“Sono un sessuomane e un bulimico”), la narrazione opta inesorabile per il flashback tornando alla Londra degli anni Cinquanta. Qui, all’interno d’un “ménage” familiare operaio, anaffettivo e litigioso, il piccolo Reginald scopre per caso la naturale vocazione per il piano (con la frivola madre che acconsente alle lezioni di musica per levarselo di torno), sognando di dirigere l’orchestra che esegue il brano indicato dal titolo. Sfuggendo a un “climax” domestico incapace di comprenderlo e amarlo (il padre è un austero pilota della RAF, fanatico del jazz quanto privo di slanci amorevoli), il ragazzino stupisce l’insegnante eseguendo Mozart senza spartito grazie a un orecchio musicale straordinario, e spinto dall’unica persona convinta delle sue capacità, ovvero la nonna, vince giovanissimo una borsa di studio alla Royal Academy. Ed eccolo, nell’epoca dell’amato rock’n’roll (è la mamma a donargli un vinile di Elvis), esibirsi come pianista provetto in un locale con tanto di acconciatura “rockabilly”, e poi – in uno dei molteplici salti temporali di cui “Rocketman” è costellato – accendere il pubblico con “Saturday Night’s Alright For Fighting” e con esso danzare per le strade. La cornice, in sostanza, è quella d’un rutilante psicodramma in cui ciascun brano contemplato, talora dimentico dell’uscita cronologica, assurge a tassello per definire un disegno filologico, fedele e appassionato della rockstar. Anche se molto è omesso della sua carriera (e infatti l’iniziale versione del film è più lunga), l’agiografia non trascura gli inizi di Elton annoverando le prime esibizioni coi Bluesology, ex Corvettes, che accompagnano cantanti soul e rhythm & blues – durante le quali la futura star conosce i primi turbamenti sessuali – all’incontro con Elton Dean, sassofonista da cui prende il nome d’arte, e col manager Ray Williams, al quale si presenta col cognome John rimirando un’immagine dei Beatles. Segue la conoscenza con lo scettico discografico Dick James (cui Reginald accenna “Daniel”, “I Guess That’s Why They Call It The Blues” e “Sad Songs”), che lo ritiene deprimente, e, complice un’inserzione della Liberty Records, col compositore Bernie Taupin che con lui stringe un lungo sodalizio. Scacciati dall’amichetta di Elton, dopo che i due riparano dalla madre di questi, si assiste alla nascita di “Your Song” che Taupin ascolta, rapito dal sentimento intimo e personale dell’amico nell’intonarla; e c’è il momento in cui, durante una festa hippy, il Nostro canta malinconico “Tiny Dancer”, prima di compiere il grande balzo a Los Angeles e, davanti a mostri sacri della musica, infiammare la platea con “Crocodile Rock” raggiungendo la prima posizione in classifica. Quando poi il divo, ormai affermato, conosce l’avido manager John Reid e se ne innamora (con “Take Me To The Pilot” a commentarne il carnale “tête-à-tête”), l’edulcorato carosello segue una progressione attenta a sottolineare la superficie dell’artista, tra shopping compulsivi e progressive paranoie, dove la “terra dell’abbondanza” culmina in una depressione innescata dall’insicurezza. Ne esce il ritratto, tra l’eccessivo e il patetico, d’una psiche capricciosa in perenne fuga da un ego irrisolto e in lotta con un Edipo frustrato, dove le puntuali, sgargianti mascherate – marchio di fabbrica negli show – mal celano una solitudine interiore non superata. Prova ne sia l’incontro da adulto con l’arcigno genitore, che Elton rimira in lacrime trasmettere ai fratellastri l’amore mai avuto, mentre al primogenito chiede di autografare l’album d’esordio, “Empty Sky”, come Arthur anziché “papà”. O le incomprensioni con la madre – che da par suo rinfaccia al figlio i sacrifici fatti per consentirgli la musica – alla quale dichiara la propria omosessualità per telefono, restando di stucco nell’apprendere che già lo sa (“Nessuno ti amerà mai come si deve”). Così di fronte a un’altra vicenda su un gay egocentrico e irrequieto, che non poco ha in comune col Mercury di “Bohemian” – anche se più attiguo al modello di Liberace – non stupisce che il registro più imitato sia quello di Ken Russell, e non solo per il “tourbillon” con cui Elton, tra luci esagerate a smodata velocità e celeri cambi di travestimento, si esibisce nella “Pinball Wizard” immortalata da “Tommy”: si pensi al fallito matrimonio con la musicista tedesca Renate Blauel, nell’infelice tentativo di darsi un’apparenza “normale” che, nella reciproca incapacità d’instaurare un dialogo, riporta al Čajkovskij de “L’altra faccia dell’amore”. Ma è la scena del tentativo di suicidio, in preda a un delirio da psicofarmaci, a restituire la fragilità di un essere umano su una tangibile vetta (la stessa che lo porta a immaginare di levitare a mezz’aria) speculare ad un morale baratro: strillando “Rocket Man”, il fosforescente “uomo razzo” incrocia il proprio ossessivo spettro (il Reginald fanciullo) sul fondo della piscina, prima di rappacificarcisi nel prefinale risolvendo i dilemmi interiori con gli altri fantasmi, ostentati come felliniani simulacri, e dopo che un attacco di cuore segue al temporaneo divorzio artistico da Taupin. E se ogni musical ha il suo irrinunciabile lieto fine, il clip di “I’m Still Standing” (“Sto ancora in piedi”), rigirato ex novo, è l’idonea chiosa d’un eccentrico per induzione e per scelta, che – come specifica una didascalia finale – ha finalmente trovato chi lo ama “come si deve”, e con oltre 400 milioni di dischi venduti non teme più il disequilibrio. Quanto della varietà di accenti, sfumature e sottrazioni si debba all’immedesimazione del gallese Taron Egerton, nel non facile compito di restituire la carica contagiosa dell’artista, non s’arresta ai confronti tra le “performance” offerte e gli scatti fotografici, a mo’ di riferimento, sui titoli di coda: basta il tentativo di seguire, se non ricalcare, l’originale timbro vocale nelle numerose “cover”, e persino il duetto nella “I’m Gonna” scritta appositamente per il film, perché spettatore e fan escano soddisfatti. O perché la vita (non) sia tutto.

“IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ” DI MARIO MARTONE
di Tullio Masoni
Da un dramma dell’Eduardo maturo Martone e la co-sceneggiatrice Ippolita Di Majo traslano dal classico e, secondo la filosofia e la poetica che nel regista ha messo radici ormai solide, lo rivestono coi panni del presente.
Chi è questo Sindaco, cioè Antonio Barracano? Un malavitoso, un camorrista, o l’erede di una storia di ribellione – quando il dramma di Eduardo fu rappresentato si fece addirittura il nome di Masaniello – nella quale l’autorità illegale ed equivoca assume un ruolo di supplenza? «…La rivolta e la ribellione di Eduardo – scrive Andrea Bisicchia – non alludono affatto alla camorra e alla mafia, nascono dalla disperazione del tragico quotidiano, dal contatto diretto con gli egoismi degli sfruttatori o degli stessi amministratori della legge.» (1)
In ogni caso mi sembra che l’epilogo tragico fosse un modo per Eduardo, oggi per Martone, di tenere aperta un’ambiguità che proietta la riflessione di napoletani su Napoli ben oltre la cronaca vissuta da entrambi: «Non poteva continuare eternamente – dice nel testo originale Don Antonio, che sta morendo per la coltellata ricevuta da Arturo Santaniello – La ignoranza è assai. E’ un mare di gente che ha bisogno di essere istradata, protetta; un uomo solo come fa? (…) Non dico che quello che ho fatto io in trentacinque anni è stato inutile, anzi è servito a restringere una catena alla quale si potevano attaccare tante altre maglie…speriamo che col tempo non vi sarà più bisogno di un Antonio Barracano.» (2)
L’ambiguità comporta ovviamente rischi. Già nel testo drammatico originale – che suscitò animate polemiche – il boss appariva come un uomo ben sotto la linea della legalità; nella versione proposta dal film, per i caratteri più diversi che cercherò di ricordare, l’ambiente è quello malavitoso di oggi e il ruolo di Antonio è come recuperato dalla “tradizione d’onore”.
Sorge dunque il dubbio: proponeva Eduardo (come adesso Martone) l’idea di una camorra, più in generale un malaffare, pur sempre agganciati a un arcaico, ancorché ingannevole senso comune, che stabiliva per la camorra stessa una certa funzione di rimedio sociale?

La risposta credo vada cercata proprio nell’assunzione di rischio: da un lato, come scrive Bisicchia, la disperazione quotidiana era e resta dominante, dall’altra il conforto tradizionale, ancorché vicino o attaccato all’osso, può trattenere un’impura vacazione di pietà. Rischio assunto, quindi, e rischio proposto come circostanza per riflettere sulla complessità che accompagna, comunque, ogni situazione di degrado. Altri se lo sono assunto, in altri tempi e luoghi della nostra storia cinematografica; basti ricordare il Rosi di “Salvatore Giuliano” e “Le mani sulla città”.
L’Antonio Barracano di Eduardo è un uomo vecchio, quello di Martone è invece giovane, quasi coetaneo dei ragazzi inebetiti dalla pratica violenta, come loro abbigliato ed eccessivo nel modo di comportarsi. Questa specie di monocromia mortuaria, del nero, suggerisce una fatica di orientamento nell’oggi, cioè l’appiattirsi fatale della figure nella degenerazione. Il quartiere – il Rione Sanità – torna nel montaggio visto da finestre, magari di notte mentre piove, ad attestare una misera continuità: il quartiere vissuto e reinventato da Eduardo, il quartiere nella Napoli di oggi.
Quanto alla lingua, occorre rilevare che mentre Eduardo usa un italiano coi tempi dello scambio dialettale, cioè specificamente cadenzati, e richiami al dialetto propriamente, con funzione di raccordo o coloritura, Ippolita Di Majo e Martone usano solo il dialetto stretto, plebeo, antico e attuale. Lo stesso che si sente anche al nord, dopo che l’integrazione nei luoghi di arrivo ha subito forti condizionamenti e creato una sorta di “regressione” disperatamente indentitaria: non più due lingue, come è stato per un certo periodo: una chiusa e una d’accento e aperta, ma una sola da parlare fra simili nell’ “enclave” e, sovente, nel ghetto.

Per questo prezioso lavoro gli autori hanno cercato e trovato gli interpreti giusti (e bravissimi), cioè il Collettivo del Nest di S.Giovanni a Teduccio, un gruppo che ha fondato un suo teatro, e agisce sul territorio con lo scopo di togliere i ragazzi dalla strada.
Rimane ora una breve riflessione sullo stile.
Nel primo quarto d’ora – almeno a me questo è accaduto – si può assistere vagamente perplessi alla “teatralità” di una messa in scena che sconta i tempi delle battute e rispetta, della “teatralità”, tipiche pause, gesti, entrate e uscite.
Poi ci si accorge che Martone, probabilmente, ha operato una scommessa; che, come aveva già fatto nella sua feconda e intralinguistica esperienza, ha cercato fra teatro e cinema una sintesi particolare. Il testo di Eduardo, il teatro, viene quindi assorbito dal cinema: primi piani, inquadrature, stacchi di montaggio, ma il teatro, al tempo stesso, torna secondo i propri peculiari ritmi, con la scansione delle battute e la distribuzione drammaturgica di ruoli e caratteri.
Vale aggiungere, infine, che col “Sindaco” Martone ha affrontato per la prima volta Eduardo, e in continuità, per così dire, sta preparando un nuovo film dedicato alla figura di Scarpetta, padre naturale e artistico dello stesso Eduardo, Peppino e Titina De Filippo.
Note
1 – Invito alla lettura di Eduardo, Milano, Mursia, 1982
2 – Eduardo De Filippo – Il Sindaco del Rione Sanità, Milano, Fabbri (Il grande teatro di Eduardo De Filippo), 2002. Già Einaudi, 1961 e 1971.
FAMIGLIE: “LE VERITÀ” DI HIROKAZU KORE-EDA;
“VICINANZA” DI KANTEMIR BALAGOV.
di Paolo Vecchi
Per avere un’idea di quale sia la costante maggiore del cinema di Hirokazu Kore-eda è sufficiente scorrere i titoli conosciuti anche da noi, da “Father and Son” alla Palma d’Oro di Cannes “Un affare di famiglia”, passando per “Little Sister” e “Ritratto di famiglia con tempesta”. Lo sguardo limpido e distante ma tutto sommato benevolo se non proprio complice con cui ripropone ad ogni capitolo l’intrusione in quello che in fondo rimane il cardine dell’edificio sociale fa del regista giapponese – si parva licet – una sorta di Ozu dei nostri tempi. Conseguentemente, si potrebbe essere portati, come per il Maestro, a scambiare la coerenza per ripetitività. Anche per lui, dunque, vale quella che non è solo una battuta: lo spettatore che entrasse in una sequenza di un suo film passando poi ad un’altra faticherebbe a raccapezzarsi su dove si trova.
“Le verità” ripercorre in parte le stesse strade, mettendo in scena madre, figlia e nipote, più un paio di mariti, l’amante di turno, una sorta di maggiordomo- factotum, una tartaruga gigante in giardino e un cane da portare a spasso, con il milieu altoborghese che rende più crudeli le crudeltà e meno sfumate le sfumature. La prima differenza rispetto al passato è che si tratta di una coproduzione con la Francia, che si è girato a Parigi, in francese e, a parte lo scialbo Ethan Hawke, con attori francesi, anzi con due dive del calibro di Catherine Deneuve e Juliette Binoche.
La seconda è che una interpreta un’attrice famosa, l’altra una sceneggiatrice di secondo piano andata in America per sfuggire all’influenza deleteria della madre. Dunque siamo nel mondo del cinema, che vediamo nel suo farsi, in quanto tecnicamente set, e in molti se non tutti i suoi retroscena di invidie, rancori, piccinerie e ambizioni. Kore-eda, anche sceneggiatore, si confronta pericolosamente con un filone ormai secolare (una delle sezioni delle ultime Giornate del Cinema Muto di Pordenone era dedicata ai film sul cinema, con pellicole che partivano dal 1920), senza preoccuparsi di aggiungere nulla di nuovo al già detto, dunque con un risultato che l’abituale eleganza della regia e il prestigio delle due primedonne riescono solo in parte a salvare.
Se Kore-eda ha cinquantasette anni e una carriera ormai cospicua alle spalle, Kantemir Balagov ne aveva ventisei ed era fresco degli insegnamenti di Aleksandr Sokurov quando ha girato la sua opera prima, “Vicinanza”. Anche qui la vicenda è incentrata su un nucleo familiare, con le sue dinamiche peculiari: una madre dominante, un padre comprensivo, David, il figlio obbediente, Ilana, la figlia “maschiaccio” e ribelle. Ma si tratta di ebrei, nel contesto certo non facile di una repubblica caucasica della fine del secolo scorso, dunque di fresca indipendenza dall’ex-URSS, in cui devono convivere con russi, kabardi e balkari, gli ultimi due di religione mussulmana. Il dramma esplode con il rapimento di David e della sua futura moglie, ellitticamente mostrato solo nelle sue conseguenze. Per trovare il denaro del riscatto il padre è costretto a vendere la casa e l’officina in cui lavora anche la figlia. Ma la somma non è sufficiente, così Ilana viene promessa a un giovane ebreo benestante. Per evitare un matrimonio non voluto, la ragazza si fa deflorare dal fidanzato kabardo e, in una sequenza durissima, esibisce le mutande insanguinate davanti al promesso sposo e ai genitori di entrambi, riuniti a tavola per siglare il contratto nuziale.
In un film claustrofobico e notturno, in cui la mdp sta costantemente attaccata ai volti, ai corpi e agli ambienti domestici, concedendosi soltanto un paio di aperture su un tramonto fiammeggiante e, nel finale, su una suggestiva cascata, emerge tuttavia un retroterra di contrasti etnico-religiosi e di violenze inaudite, come lo sgozzamento dei russi da parte dei ceceni che gli amici kabardi di Ilana si godono nello sgrammaticato livore di una videocassetta, bevendo e sghignazzando, mentre qualcuno di loro arriva a dire che gli ebrei sono buoni solo per fare sapone. In attesa della conferma di “Dylda”, opera seconda di Balagov anch’essa presentata a Cannes e della quale si dice un gran bene, salutiamo con soddisfazione la nascita di un autore di sorprendente maturità, al quale la lezione di Sokurov non ha certo impedito di prendere la strada di un cinema del tutto personale.
Concludendo, ci sembra non si possa non segnalare la stupefacente interpretazione di Daria Jovner nel ruolo di Ilana, in un insieme di attori, peraltro, di ammirevole credibilità.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
“COWSPIRACY: THE SUSTAINABILITY SECRET”
IL CIBO CHE UCCIDE
di Marcello Cella
Nell’anno di Greta Thunberg, di “Antropocene” e del prepotente ritorno alla ribalta delle tematiche ambientaliste derivato dal forte impatto mediatico della giovane attivista svedese è interessante recuperare questo documentario americano del 2014, realizzato grazie ad una sorta di crowfounding e al sostegno del popolare attore Leonardo Di Caprio, da due giovani registi, Kip Andersen e Keegan Kuhn. “Cowspiracy” infatti si focalizza su un aspetto della nostra vita sociale, individuale e collettiva, che spesso viene lasciato nell’oscurità perché va a toccare uno degli aspetti più intimi della nostra esistenza, una sorta di tabù al pari del sesso e della morte, cioè il cibo e l’uso che ne facciamo. Qualcuno potrebbe obbiettare che di cibo, nel senso di gastronomia, cucina, chef star, ricette e affini sono pieni i nostri organi di informazione, dalla televisione che ha creato delle vere e proprie icone mediatiche sintetizzate nella figura dello chef (“capo, colui che comanda” in francese) ai quotidiani e ad una infinità di riviste dedicate all’argomento. Ma è sull’impatto sociale e ambientale di un atto così privato e individuale come il mangiare, e il mangiare carne in particolare, che si occupa “Cowspiracy”.

Lo stile narrativo è mutuato dai docufilm di Michael Moore, ma con meno ironia e maggiore vocazione divulgativa; vale a dire che il canovaccio è dato dal giornalista-autore (in questo caso uno dei due registi, Kip Andersen) che svolge la sua inchiesta sotto gli occhi dello spettatore e agisce da collante che unisce i vari episodi su cui è strutturato il film.
Kip è un ambientalista convinto e ha costruito tutto il suo stile di vita su valori etici improntati al più classico ecologismo (raccolta differenziata, risparmio energetico in casa e al lavoro, uso della bicicletta per spostarsi), convinto che questo possa essere utile all’ambiente e alla società in cui vive. Ma un giorno leggendo su internet alcuni articoli e rapporti di organizzazioni come la FAO, la Banca Mondiale, l’ONU, ecc. scopre dati e cifre che lo lasciano allibito e mettono in crisi tutte le sue convinzioni. Scopre, per esempio, che gli allevamenti intensivi di animali sono responsabili al 91% della distruzione della foresta amazzonica, al 51% dell’emissione di gas serra, che gli allevamenti animali per il consumo umano utilizzano 1/3 di tutta l’acqua potabile del pianeta, occupano il 45% della superficie terrestre, e sono responsabili dell’estinzione di molte specie animali, della distruzione di habitat, ecosistemi e sistemi sociali. Alla luce di questi elementi lo stile di vita ambientalista orgogliosamente esposto inizialmente da Kip appare, anche a lui stesso, molto inadeguato. Per questo Kip decide di saperne di più e di realizzare questo documentario dal sapore vagamente country nelle atmosfere da film on the road, dovute anche alla colonna sonora da ballata rurale nelle parti di viaggio che si alternano alle interviste e ai grafici animati rigorosamente scientifici e ben documentati. Ma il contenuto di “Cowspiracy” non fa sconti a nessuno, neppure alle organizzazioni ambientaliste che in gran parte, interrogate sul tema, appaiono stranamente reticenti e poco documentate, ripetendo quasi sempre le classiche nozioni ambientaliste sulle ragioni del cambiamento climatico che ormai conosciamo tutti a memoria (energia di origine fossile, trasporti inquinanti, città affollate, ecc.). Solo alcuni studiosi coraggiosi (e qui Andersen ricorda incidentalmente come mettersi contro gli allevamenti intensivi e l’industria alimentare in Brasile è costato la vita a 1100 attivisti negli ultimi anni) e fuori dal coro accettano di rispondere alle domande dell’autore e ciò che ne viene fuori è un quadro allarmante per la vita della Terra e dei suoi abitanti, cioè di tutti noi umani, in qualche modo preveggente se pensiamo che il documentario è stato realizzato 5 anni fa. Intanto l’incremento vertiginoso della popolazione umana sulla Terra che nel giro di un solo secolo è passata da un miliardo e mezzo a 7 miliardi e continua a crescere (le proiezioni future parlano di 9 miliardi nei prossimi decenni). Ma è l’impatto devastante su ambiente, cambiamenti climatici, ecosistemi e sistemi sociali degli allevamenti intensivi per soddisfare il crescente consumo umano di carne e di prodotti derivati ad apparire talmente abnorme da apparire incredibile (ed il film è stato accusato di essere esagerato nei dati per quanto sia assolutamente rigoroso nel citare fonti scientifiche certificate e al di sopra di ogni sospetto). Sono 70 miliardi gli animali allevati dall’uomo, ma mentre gli uomini quotidianamente bevono 19,7 miliardi di litri d’acqua e mangiano 9,5 milioni di tonnellate di cibo, gli 1,5 miliardi di bovini degli allevamenti bevono 170 miliardi di litri d’acqua al giorno e mangiano 62 milioni di tonnellate di cibo. Senza contare che a livello globale produciamo cibo sufficiente per sfamare tra i 13 e i 15 miliardi di persone, ma attualmente sulla Terra ce ne sono solo 7, fra cui, per di più, un miliardo soffre la fame. Ma, sempre a livello globale, il 50% dei cereali e dei legumi prodotti servono per nutrire gli animali degli allevamenti, mentre l’82% dei bambini che muoiono di fame nel mondo abitano nei paesi dove la maggior parte dell’agricoltura è di fatto una monocultura utile a sfamare la piccola parte ricca del pianeta che abita soprattutto negli USA e in Europa.
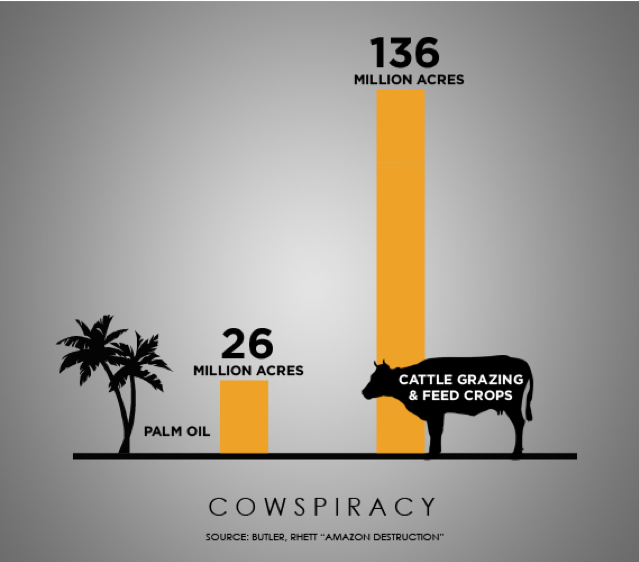
Non dobbiamo però pensare a “Cowspiracy” come ad un documentario a senso unico e assolutista nelle sue tesi di fondo, perché i due registi si sforzano di portare alla luce anche tesi contrarie a quelle qui riportate, ma spesso sono proprio gli operatori del settore a sottolineare come questo modello di sviluppo, di consumo di cibo (e di energia, e di suolo, e di risorse) da cui loro stessi traggono vantaggio, fra non molto non sarà più sostenibile. Sono illuminanti a questo proposito le conversazioni che Kip ha prima con un allevatore che afferma, imbarazzato ma convinto: “Una mucca consuma dai 63 ai 68 Kg di mangime al giorno e beve tra i 110 e i 150 litri d’acqua. Non c’è abbastanza spazio sulla terra per sostenere questa produzione. Non c’è abbastanza terra”, e poi con un consigliere d’amministrazione di una grossa azienda di latticini che ammette senza remore che “a livello mondiale la produzione lattiera non è sostenibile”.
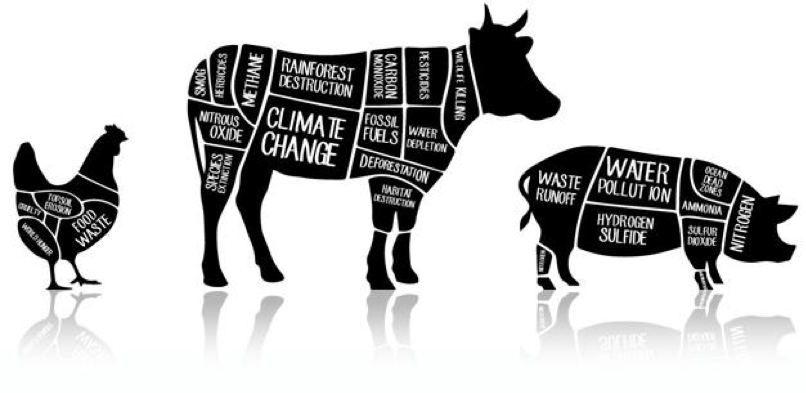
Che fare dunque per evitare di collassare noi stessi e il pianeta in cui viviamo? La risposta che i due registi danno implicitamente ed esplicitamente è quella di uno stile di vita e di consumo di cibo che eviti il più possibile il consumo di carne e dei suoi derivati, cioè la dieta vegana, o, almeno, il più possibile vegetariano (”io non voglio mangiare gli altri, ma mangiare per gli altri”, afferma dopo aver assistito suo malgrado alla brutale uccisione di due anatre da parte di un allevatore). Per corroborare le loro tesi, Kip visita una comunità vegana di Detroit, la Earthworks Urban Farm, i cui componenti dimostrano con i fatti come si possa produrre cibo sano, nutriente e piacevole al gusto utilizzando spazi infinitamente più piccoli e meno impattanti sull’ambiente quanto a consumo energetico per produrlo e socialmente più equilibrati, grazie anche ad una vita comunitaria che privilegia le relazioni sociali al posto dell’arricchimento individuale e della solitudine metropolitana.
Ma mentre, nella mente dello spettatore più avvezzo alle ideologie del ‘900 fa capolino la barba beffarda di Karl Marx e la sua tesi sul capitalismo e i suoi epigoni umani che si autodistruggeranno segando il ramo dell’albero su cui siedono, sullo schermo risuonano le parole di alcuni degli interlocutori più interessanti del narratore-viaggiatore Kip Andersen che si alternano a suggestivi paesaggi bucolici attraversati dai raggi di un sole lisergico.
“Fai quello che puoi fare nel miglior modo possibile ogni giorno della tua vita e quando morirai sarai la persona più felice che sia morta”.
“L’altruismo è un bel modo di essere. Ha tutti i vantaggi per te così come per il pianeta e per le altre persone. E’ un bel modo di vivere”.
“Vivere in maniera ecologica ci fa stare meglio. Si tratta di trasformare radicalmente il modo di mangiare della nostra società, perché è una necessità”.
“Si può cambiare il mondo. Voi dovete cambiare il mondo”.
Una fragile ragazzina svedese con le trecce, lo sguardo profondo e le parole di fuoco contro l’inerzia colpevole e interessata dei potenti della terra sembra idealmente dare corpo e senso alla citazione di Martin Luther King che i due registi mettono come incipit di “Cowspiracy”: “Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici”.
“Cowspiracy: The Sustainability Secret”
Durata: 90 min.
Regia: Kip Andersen, Keegan Kuhn
Formato: Video HD
Produzione: AUM Films, First Spark Media
Web: www.cowspiracy.com
Contatti media Italia:
Serena Capretti | Essere Animali: serena.c@essereanimali.org +39 342 0509174
QUALITA’ IN SERIE
CHERNOBYL
di Giancarlo Zappoli

Regia: Johan Renck
Soggetto e Sceneggiatura: Craig Mazin
Interpreti: Jared Harris (Valerij Alekseevič Legasov), Stellan Skarsgård (Boris Shcherbina), Emily Watson (Ulana Khomyuk), Paul Ritter (Anatoly Dyatlov), Jessie Buckley (Lyudmilla Ignatenko), Adam Nagaitis (Vasily Ignatenko), David Dencik (Michail Gorbaciov)
Produzione: Sister Pictures, The Might Mint
Distribuzione in Italia: Sky Atlantic dal 10/6/2019 all’8/7/2019 (ora on demand)
Origine: Stati Uniti/Gran Bretagna 2019
Durata: 6 puntate da 60’
SINOSSI

Nel secondo anniversario del disastro di Chernobyl Valery Legasov, che è stato il capo della commissione che ha investigato, registra dei nastri accusando l’ingegnere Anatoly Dyatlov e altri per quanto accaduto prima di nascondere i nastri ed impiccarsi. Due anni prima a Pipryat la moglie del vigile del fuoco Vasily Ignatenko, Lyudmilla, dalla finestra di casa vede esplodere il Reattore 4 della Centrale Atomica di Chenobyl. Nella sala di controllo Dyatlov nega l’evidenza dell’esplosione del nocciolo del reattore, chiama i pompieri e e gli operai per spegnere l’incendio ed ordina ai suoi sottoposti di abbassare le barre di controllo per raffreddare il nocciolo e poi abbandona la postazione. In questo modo gli operai e i vigili del fuoco, Vasily compreso, vengono esposti all’ARS (Acute Radiation Syndrome). Il direttore dell’impianto Bryukhanov, l’ingegnere capo Fomin e Dyatlov decidono che un’esplosione di idrogeno sia stata la causa della perdita dell’acqua contaminata del bacino e il Comitato Esecutivo di Pripyat decide di sottostimare l’incidente e di non procedere all’evacuazione dei civili. L’ingegnere che stava seguendo l’operazione dice di vedere della grafite sul tetto dello stabilimento ma gli altri lo mettono a tacere salvo poi obbligarlo ad un’ispezione personale del tetto in cui riceve una dose letale di radiazioni. Legasov, informato dell’incidente ora fuori controllo, prende in mano la situazione.

Sette ore dopo l’esplosione Ulana Khomyuk, , una scienziata dell’Istituto per l’energia nucleare dell’Accademia delle Scienze della Bielorussia, avverte un aumento non ordinario nei livelli di radioattività a Minsk. Si rivolge all’autorità locale del Partito che non le presta la benché minima attenzione. Decide allora di recarsi a Chernobyl. A Mosca Legasov espone ai membri del Consiglio e al Segretario del Partito Michail Gorbaciov le sue preoccupazioni che stimano il danno come di gran lunga superiore a quanto riportato. Viene inviato a Chernobyl accompagnato da uno scettico Boris Shcherbina, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Capo dell’Ufficio per il combustibile e l’energia. Nel frattempo nel superaffollato ospedale di Pripyat Lyudmilla, che sta cercando il marito, scopre che lui e tutti quelli colpiti da ARS sono stati trasferiti a Mosca. Giunti sul posto in elicottero Legasov e Shcherbina vedono i detriti di grafite e le prove che il nocciolo radioattivo è ormai esposto. Il vice primo ministro si trova davanti Bryukhganov e Fomin che accusano Legasov di mistificare la situazione ma il generale Pikalov, dotato di un misuratore di radioattività li smentisce. Legasov dà ordine di spegnere l’incendio con sabbia e boro come fase iniziale indispensabile anche se rischiosa. Finalmente Pripyat viene evacuata. Khomyuk al suo arrivo avverte però che Legasov non ha tenuto conto che nel sotterraneo c’erano due cisterne d’acqua piene e che se la lava radioattiva creata da sabbia e boro verrà in contatto con quell’acqua ci sarà una catastrofica esplosione. Una missione che potrebbe avere esiti letali per drenare l’acqua viene autorizzata ed attuata grazie a tre operai volontari: Baranov, Bezpalov e Ananenko.

Il drenaggio viene realizzato con successo ma è iniziata la contaminazione delle acque sotterranee. Legasov e Shcherbina riferiscono a Gorbaciov la necessità di un cambio di temperatura nei sotterranei per il quale vengono reclutati da Tula molti minatori che debbono operare in condizioni decisamente avverse. Shchebrina avverte Legasov che stanno entrambi operando sotto la sorveglianza del KGB. Legasov chiede a Khomyuk di andare all’ospedale di Mosca per effettuare un’indagine tra i testimoni dell’accaduto. Dyatlov non collabora ma Toptunov e Akimov, che stanno per morire, concordano sul fatto che il reattore è esploso dopo che Akimov aveva schiacciato il pulsante per arrestarlo. Intanto Lyudmilla ha raggiunto l’ospedale e strappato il permesso di incontrare il marito tacendo di essere incinta e contravvenendo alle istruzioni ricevute di non toccare il consorte. Khormyuk decide di riferire tutto quanto ha scoperto ma viene arrestata da agenti del KGB. Legasov riesce però a farla rilasciare. Mentre Shcherbina e Legasov fanno rapporto al governo e chiedono l’intervento di un alto numero di personale Lyudmilla partecipo alle esequie di Vasily.

Gli abitanti vengono evacuati dall’area e hanno inizio le operazioni di decontaminazione. La recluta Pavel viene inserito in un gruppo di reduci dall’Afghanistan incaricati di sopprimere tutti gli animali presenti nella zona perché potenzialmente contaminati. Il generale Tarakanov, incaricato delle operazioni di messa in sicurezza dell’impianto, chiede e ottiene un robot fabbricato in Germania ovest per operare sulla luna e tenta di utilizzarlo per rimuovere i pericolosissimi detriti dal tetto dell’edificio principale. L’impresa fallisce e diventa necessario impiegare 3.828 uomini da far intervenire per la ripulitura sul tetto per 90 secondi ciascuno. Khomyuk intanto a Mosca indaga negli archivi di Stato e incontra nuovamente Dyatlov che è sicuro che ai governanti non interessi la verità. In un luogo aperto, per evitare l’ascolto da parte del KGB, Legasov e Shcherbina la informano che dovranno testimoniare al processo contro Dyatklov, Bryukhanov e Fomin. Inoltre Legasov dovrà recarsi a Vienna alla IAEA (International Atomic Energy Agency) per riferire al mondo quanto accaduto. Khomyuk rivela loro l’esistenza di un incidente analogo accaduto, senza le stesse conseguenze, nell’impianto nucleare di Leningrado nel 1975 che il KGB aveva fatto in modo di tenere occulto. Dice loro anche che Lyudmilla ha dato alla luce una bambina morta per le radiazioni assorbite e invita Legasov a dire la verità all’AIEA. Shcherbina però lo dissuade facendogli presenti le conseguenze che ciò comporterebbe in patria.

In seguito alla relazione presentata da Legasov all’IAEA in cui ha taciuto dell’incidente del 1975, i tre imputati vengono processati a Chernobyl. Shcherbina è il primo a testimoniare sull’attività dell’impianto nucleare. Khomyuk e Legasov fanno riferimento a quanto accadde prima dell’esplosione, la prima sul piano delle testimonianze ottenute, il secondo sul versante scientifico. Era in corso un test di tenuta dlel’impianto che era stato ritardato di dieci ore e che, proprio per questo ritardo Dyatlov voleva portare a termine con impazienza. Nel momento in cui l’inevitabile stallo dell’impianto, provocato dall’accelerazione dei lavori, si era verificato Akimov aveva premuto il pulsante di arresto ma questo aveva innalzato di dieci volte la potenza del reattore. Legasov a questo punto rivela quanto appreso da Khomyuk e taciuto all’AIEA. Viene immediatamente preso in consegna dagli agenti del KGB e gli viene comunicato che la sua testimonianza verrà cancellata e che in futuro gli sarà proibito di parlare di quanto accaduto nell’impianto nucleare di Chernobyl, decadrà dal suo ruolo e non avrà più un lavoro. Attorno alla sua persona verrà creato il deserto. Alla fine della serie vengono mostrati i veri volti dei protagonisti e raccontato quello che accadde loro.

____________________________________________________________
Partiamo dai dati di gradimento della serie. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto il 96% di approvazioni sulla base di 76 recensioni. Su Metacritic un punteggio di 83 su 100 sulla base di 28 critiche e su IMDB più di 350.000 visitatori gli hanno assegnato un punteggio di 9,5 su 10 decretandolo come il 4° miglior prodotto televisivo,
Perché iniziare con questi dati? Perché i detrattori ‘a prescindere’ (come avrebbe detto Totò) delle serie televisive non possono neppure concepire che esista una produzione seriale di qualità che vada oltre i temi più popolari per affrontare questioni importanti con un livello elevato sia di scrittura che di realizzazione e impegno produttivo. È quanto accaduto in questo caso anche se già il trovare finanziamenti per un argomento come questo non deve essere stato facile. Ne è nata una miniserie che contamina i generi con ottimi risultati che rivelano l’attenzione e l’impegno profusi in tutte le fasi di realizzazione.
Intendiamoci: all’uscita della serie chi partecipò alle operazioni ha trovato degli elementi non corrispondenti al vero non tenendo conto che anche nelle biografie cinematografiche più accurate non si è mai totalmente verosimili e ciò accade neanche nei documentari. Il cinema (questa serie è cinema di fatto) ha le sue leggi che vanno rispettate. Resta però che, al di là del rilievo del “The Moscow Times” che trova troppo “moderne” le finestre degli edifici sovietici o del generale Tarakanov che afferma che gli animali non furono soppressi nell’area urbana e che i minatori non gli si presentarono nudi per il calore eccessivo riscontrato negli scavi la sostanza e la cronologia degli eventi sono state rispettate.
Alla base della sceneggiatura c’è stata una ricerca della verità nel suo complesso guidata anche da una domanda che può apparire banale ma non lo è. Mazin si è accorto che conosceva il disastro accaduto a Chernobyl ma “non sapevo il perché e ho pensato che ciò costituiva un inspiegabile vuoto della mia conoscenza. Così ho iniziato a leggere libri e documenti in materia e ciò che ho scoperto è stato che, mentre la storia dell’esplosione è interessante e si poteva anche conoscere il come e il perché, quello che più mi colpiva erano le vicende incredibili degli esseri umani. Quelli che l’avevano vissuta e che avevano sofferto e si erano sacrificati per salvare le persone che amavano, per salvare i compatrioti e l’intero continente e avevano continuato a farlo contro le avversità che diventavano sempre più forti.. La lezione di Chernobyl non è che l’attuale potere nucleare è pericoloso. La lezione è che la menzogna, l’arroganza e la soppressione di ogni voce contraria sono pericolose.”
I dati sulle conseguenze di quell’esplosione sono controversi anche a causa del muro innalzato all’epoca in materia dalle autorità sovietiche. Si veda una loro sintesi in https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_%C4%8Cernobyl%27
Ciò che però più ci interessa in questa sede è l’intreccio dei generi cinematografici. Come si può desumere dalla sinossi e da quanto sopra il tema della denuncia sociale è dominante. Torna alla mente un classico del genere (“Sindrome cinese” di James Bridges) con però l’aggiunta del grigiore della nomenklatura sovietica che viene sottolineato anche sul piano della fotografia. Le riunioni in cui, alla presenza di Gorbaciov, si cerca di affrontare il caso senza che però all’estero se ne venga a conoscenza sono emblematiche così come lo è l’ampio spazio dedicato al processo nell’ultimo episodio. Ma ciò che più colpisce in materia è come la negazione dell’evidenza fosse diventato un modus vivendi che toccava tutti i livelli dell’amministrazione.
Alla dettagliata sequenza degli avvenimenti (pur con le varianti già accennate) si sovrappone poi la spy story. Legasov e Shcherbina si accorgono di essere seguiti da agenti del KGB, temono di esser spiati e ricevono un primo avvertimento con il fermo della scienziata Ulana Khomyuk. La sentenza che su Legasov viene pronunciata in privato dal responsabile dei Servizi nel finale del film dopo la sua deposizione al processo, è di fatto una condanna alla morte civile a cui nella realtà è seguito il suicidio che fa da prologo all’intera serie.
Non può mancare la love story tra il vigile del fuoco Vasily e la moglie Ludmylla a fare da sotto testo non solo per la presunzione di accontentare il cosiddetto pubblico femminile ma soprattutto per raccontare una delle tante storie di gente comune coinvolta nella tragedia. Gente comune che si moltiplica tutte le volte che le sequenze si impegnano (con un importante dispiegamento di mezzi produttivi) esseri umani nelle pericolosissime operazioni di scongiuramento di un pericolo dalle dimensioni inimmaginabili o nella decontaminazione. Spesso queste scene aggettano sul versante del filone catastrofico che qui purtroppo non ha nulla della fiction ma mette in evidenza la tragicità dell’impegno di persone per le quali la morte imminente sembrava certa a causa delle funzioni che si facevano loro svolgere. A tratti si avverte come una sensazione di sci-fiction che viene subito rintuzzata dalla memoria degli accadimenti reali. I titoli di coda ci ricordano che ci è stata proposta, con le modalità della fiction, una vicenda di cui ci vengono mostrati protagonisti e dati. Su Sky on demand è anche disponibile, a integrazione, un interessante documentario dal titolo “The Real Chernobyl”.
PANORAMA LIBRI
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

RIFLESSI DI STELLE
di Diletta Pavesi
Mimesis/Unifestum 2018
Pagg. 318. Euro 26
Questo volume della giovane Diletta Pavesi, che svolge attività di docenza per la cattedra di Storia del cinema presso l’Università di Ferrara vuole presentare, come dice il sottotitolo, immagini divistiche nel cinema autoriflessivo Hollywoodiano. Cioè uno studio sul cinema americano che quando sceglie di riflettere su se stesso vede emergere la figura della diva come soggetto privilegiato. L’autrice, analizzando alcuni dei film più significativi di ambientazione hollywoodiana si sofferma, principalmente, sul groviglio di aspirazioni femminili, timori culturali e tensioni sessuali espresse nella figura della diva. Un’analisi, quella di Diletta Pavesi, che prende l’avvio dagli anni Venti per arrivare ai capolavori del dopoguerra, senza trascurare il melò degli anni Trenta. Viene così analizzato il periodo in cui la star è una ingenua pioniera (vedi “Maschere di celluloide” di King Vidor dove attori come Charlie Chaplin e John Gilbert ed attrici come Marion Davies interpretano se stessi con lo sguardo affettuoso ed ironico del regista: “una commedia pimpante e graffiante sul mondo di Hollywood. Una chicca”, secondo “Il Morandini”). Ma anche il decennio del melò con film come “E’ nata una stella” (1937) di William A. Wellman dove nelle vicende dei protagonisti Janet Gaynor e Frederic March il regista delinea ascesa e caduta nella “fabbrica dei sogni” hollywoodiana. Ma anche in tanti altri film che Diletta Pavesi prende in esame si rileva una presa di coscienza del lato oscuro del sogno divistico. Per i capolavori del dopoguerra, sono presi soprattutto in considerazione “Viale del tramonto” (1950) e “La contessa scalza” (1954) dove, sottolinea l’attenta autrice, “le protagoniste sono ormai deliranti astri in declino o sex symbol condannate a una carriera fortunata ma alla sconfitta nell’ambito privato”. Nel film di Billy Wilder, la vecchia gloria del cinema muto Norma Desmond (una straordinaria Gloria Swanson) sogna un clamoroso ritorno ma le vicende della sua vita vissute nel ricordo del mito la portano ad impazzire. Nel film di Joseph L. Mankiewicz sfila un’affascinante galleria di personaggi dell’International set, tra cui una bellissima Ava Gardner che riveste il ruolo di una ballerina spagnola che raggiunto il successo come attrice cinematografica sarà nella vita protagonista di una tragica vicenda. L’autrice poi dà particolare attenzione alla diva che ”si pone come presenza eversiva, decisa a non lasciarsi stritolare dagli alienanti meccanismi della tecnologia sonora”. Ed analizza, in tal senso, film come “Cantando sotto la pioggia” di Stanley Donen e Gene Kelly e “Lo strano mondo di Daisy Clover” (1965) di Robert Mulligan. Ma tanti altri sono i film che lo sguardo di studiosa di Diletta Pavesi esamina in questo libro che costituisce, relativamente al tema trattato, un importante punto di riferimento.

A FIL DI SPADA
di Steve Della Casa
Edizioni Fondazione Ente dello Spettacolo, 2017
Pagg. 140. Euro 26
Pirati e spadaccini nel cinema italiano in questo libro che Steve Della Casa, con la partecipazione di Nico Parente, dedica alla memoria di Umberto Lenzi che considera maestro, prima che di cinema, di vita. Si tratta di un ampio dizionario del cinema italiano di cappa e spada che ripercorre il genere, rispettando l’ordine alfabetico, dagli anni Trenta fino all’inizio dei Settanta. Inizia con “A fil di soada” (1952) di Carlo Ludovico Bragaglia si conclude con “Zorro marchese di Navarra” di Jean Monty realizzato nel 1969 prima che scompaia dal sistema produttivo. Un vasto fenomeno (circa 240 film) che è iniziato, come scrivono i due curatori del volume, come risposta autarchica ai grandi film di cappa e spada prodotti negli anni Trenta a Hollywood per poi diventare, nel secondo Dopoguerra, uno dei generi più esportati all’estero. Un cinema di cappa e spada, informano i due curatori, che raggiungono il loro massimo sviluppo produttivo nel periodo in cui il cinema italiano raggiunge l’apice della sua capacità produttiva. Spazio anche ai Profili di attori e registi, ma anche agli stuntmen “eroi oscuri spesso determinanti per il successo dei film”. Ma anche ad un Maestro d’arme come Enzo Musumeci Greco “che ha inventato un modo di fare cinema”. Schede-saggio per un’analisi dell’ampia filmografia che mettono a fuoco vicende produttive, personaggi, modalità narrative e di messa in scena coniugando così la storia economico-produttiva del cinema italiano con quella dell’immaginario popolare. Per lo studioso, una messe di informazioni ricchissima, basate anche su fonti orali, che consentono di conoscere “storie” non ufficiali del cinema italiano che approfondiscono la Storia “ufficiale” della nostra cinematografia.
Utile per una storia tutta da scrivere che negli anni si è resa necessaria grazie anche a contributi come queste di Steve Della Casa e Nico Parente. Il libro annovera anche una Postfazione di Antonio Tentori su “Emilio Salgari il principe dei pirati”.

CHARLIE CHAPLIN A KEAN LOACH
di Roberto Lasagna
Mimesis/Cinema, 2019
Pagg. 116. Euro 10
Da Charlie Chaplin a Kean Loach, un lungo percorso del cinema del lavoro che Roberto Lasagna analizza attraverso la psicologia, materia in cui è laureato ed attraverso la quale ha già analizzato anche il cinema di quel grande genio che è stato Stanley Kubrik. L’intento dell’autore, come scrive nell’introduzione, è di affrontare l’indagine di questioni collettive che si pongono in relazione con quello di individui alla ricerca di un’appartenenza in un gruppo, un ente, un’azienda, un’istituzione, che non voglia snaturarli ma che permette a ciascuno di sentirsi individuo coinvolto e compreso. Aggiungendo poi che l’etica della psicologia delle organizzazioni a cui l’autore vuole dedicarsi pone al centro l’individuo.
Un’analisi, quella di Roberto Lasagna che va alla ricerca dell’organizzazione del lavoro nel cinema. Un lungo percorso che tocca opere importanti, alcune mitiche, sul mondo del lavoro: “Tempi moderni”(1936) di Charlie Chaplin ( chi non ricorda la famosa scena di Charlot alle prese con la catena di montaggio), “La classe operaia va in Paradiso” (1971) di Elio Petri fino al film “A tempo pieno” di Laurent Cantet del 2001, per evidenziare il disegno psichico negli ambienti di lavoro e segnalandoci cosa è cambiato oggi e cosa è rimasto ancora da fare in tema di stress del lavoro. L’analisi del mondo del lavoro offre l’occasione a Roberto Lasagna di ripercorrere anche il cinema dei registi di cui si occupa, ricordandoci cosi titoli di film che sono entrati nella memoria dei cinefili ma anche di chi va al cinema guardando i film con attenzione. Vengono anche analizzate altre opere significative del mondo del lavoro come “Norma Rae”(1979) di Martin Ritt mettendo in rilievo cosi il ruolo delle donne nelle fabbriche e il loro impegno nel dibattito politico sociale. Ma Roberto Lasagna sottolinea altre problematiche del mondo del lavoro che emergono in film come “Kramer contro Kramer” (1977) di Robert Benton, “Mi piace lavorare” di Francesca Comencini per dedicare poi un ampio capitolo ai film di Ken Loach in cui le condizioni lavorative producono fratture e distorsioni sociali sottolineando il problema della precarietà.
L’attenzione di Roberto Lasagna è anche ai rischi del lavoro e le trasformazioni della scena socio – economica affrontata nei film di Daniele Segre, Francesca Comencini, Paolo Virzì, Calopresti. Il libro si conclude con alcune considerazioni sui film “Il capitale umano”(2014) di Paolo Virzi, “A tempo pieno”(2011) di Laurent Cantet e “La legge del mercato”(2015) e “In guerra”(2018) di Stèphan Brizè che, secondo Roberto Lasagna, ci ricordano l’esigenza di u n’etica sociale, affinché la vita dei lavoratori non sia affidata ai capricci del mercato finanziario secondo un frainteso senso di globalizzazione deprivato di etica sociale.
Un libro che affronta tante tematiche in maniera approfondita, con annotazioni anche di carattere filosofico, grazie alla conoscenza delle problematiche della vita sociale e politica.
Un’opera fondamentale per il rapporto cinema – mondo del lavoro.

BRIVIDI SUL DIVANO
di Beatrice Balsamo e Giorgio Simonelli
Editore Marietti, 2019
Pagg. 90. Euro 8
I “Brividi sul divano” che ci offrono Beatrice Balsamo e Giorgio Simonelli nel loro libro sono quelli trasmessi dai Telefilm di Alfred hitchcock. Gli autori tra i numerosi (440) prodotti televisivi hitchcochiani si concentrano su 20 Telefilm appartenenti alla prima Serie intitolata “Alfred Hitchcock Presents” comprendente 268 puntate di 23 minuti ciascuno, usciti in Italia a partire dal 1959 dei quali in Appendice vengono pubblicati i relativi crediti . Vi ritroviamo le caratteristiche del cinema del Maestro del Brivido, e cioè mistero, suspense, sottile ironia, un bizzarro umorismo. Di cui gli Autori sottolineano, come era loro intenzione, gli aspetti innovativi ed ancora attuali. Focalizzando, soprattutto, l’aspetto perturbante che caratterizza anche la società contemporanea riconducibile alla nostra vita. Il tutto con la presenza ineffabile dello stesso regista che sorprende lo spettatore quando meno se l’aspetta.
Sono queste, mi pare, le linee base dello studio dei 2 Autori che così ci immergono nell’universo hitchcockiano facendolo meglio conoscere ed apprezzare.
Una lettura utile a chi ama il cinema del Maestro del Brivido, ma utile anche a chi vuole accostarsi ad esso.
CREDITS
Carte di Cinema 20
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini
Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail:
paolomicalizzi@gmail.com)
Direttore editoriale: Lorenzo Caravello
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 19 della rivista online: Roberto Baldassarre, Laura Biggi, Vittorio Boarini, Enzo Bruno, Marcello Cella, Bianca Ferrigni, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Roberto Merlino, Paolo Micalizzi, Giovanni Ottone Alessandra Pighi, Paolo Vecchi, Xoxan Villanueva, Luciano Volpi, Marco I. Zambelli.