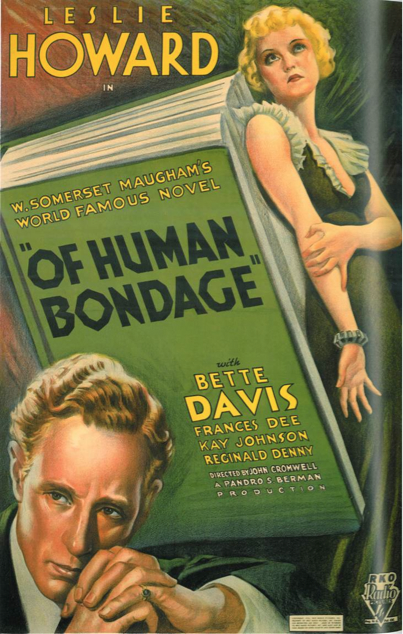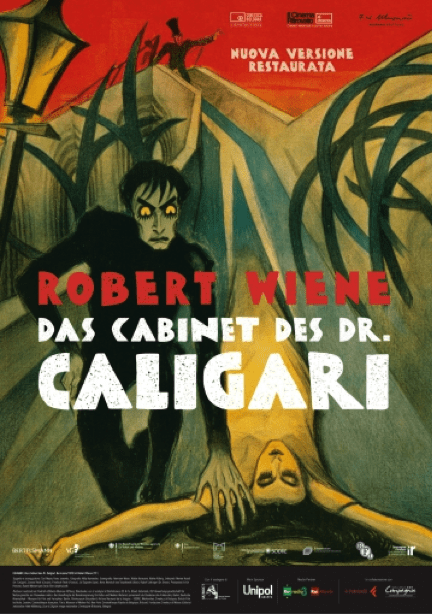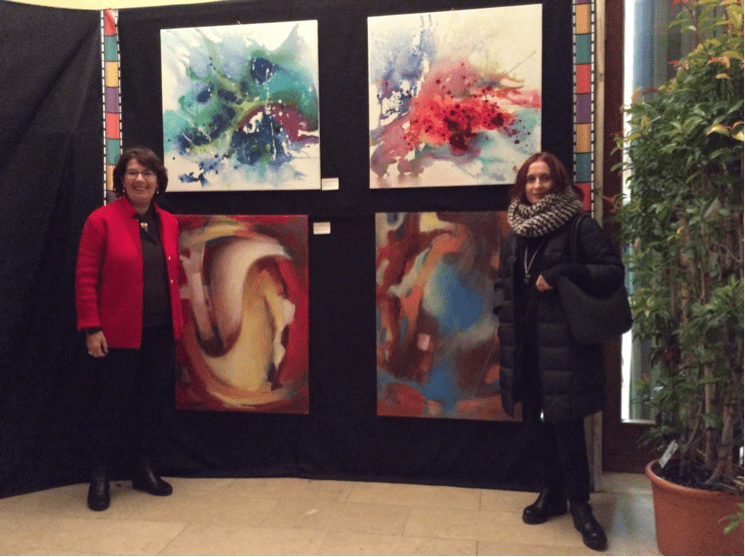Sommario
- 1 ABSTRACT
- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
- 3 SAGGI
- 3.1 IL CINEMA CRUDELE DI W. SOMERSET MAUGHAM di Orio Caldiron
- 3.2 TRE FILM TEATRALI DI DANIELE SEGRE di Tullio Masoni
- 3.3 SERIE TV E CINEMA: UNA STORIA (ARTISTICA) POSSIBILE (?) di Davide Parpinel
- 3.4 L’EREDITÀ È SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI CULTURA. ADELIO FERRERO E L’ATTUALITÀ DEL SUO PENSIERO di Roberto Lasagna
- 3.5 FENOMENOLOGIA DEL SEGRETO NEI “PERFETTI SCONOSCIUTI” DI PAOLO GENOVESE di Franco Di Giorgi
- 3.6 IL RESTAURO DEL FILM di Elio Girlanda
- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
- 5 FESTIVAL ED EVENTI
- 5.1 MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
- 5.2 LILIANA CAVANI E LE PROSPETTIVE DEL NUOVO CINEMA ITALIANO A “PRIMO PIANO SULL’AUTORE” DI ASSISI di Paolo Micalizzi
- 5.3 REGGIOCALABRIAFILMFESTIVAL: UNA MANIFESTAZIONE DA SOSTENERE di Paolo Micalizzi
- 5.4 TAGORE, UNA RELAZIONE PRIVATA di Maria Pia Cinelli
- 5.5 IL BALKAN FLORENCE FESTIVAL: I BALCANI OCCIDENTALI FRA STORIA E REALTÀ di Marcello Cella
- 6 OCCHIO CRITICO a cura di Marco Incerti Zambelli, Tullio Masoni, Paolo Vecchi
- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
- 7.1 RACCONTO E MEMORIA: IL CINEMA DI NICO GUIDETTI
- 7.2 Denominazione d’Origine Popolare. La vera o presunta storia dei Violini di Santa Vittoria di Marco Incerti Zambelli
- 7.3 Conversazione con Nico Guidetti
- 7.4 RICORDO DI DAVID BOWIE, LONDON BOY: “THE IMAGE” di Francesco Saverio Marzaduri
- 7.5 IL SALE DELLA TERRA
- 7.6 Immaginando un altro cinema e un’altra vita
- 8 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
- 9 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
- 10 AUTORI (new entries)
- 11 CREDITS n. 8
ABSTRACT
DAL SOGNO AMERICANO ALL’INCUBO – IL CINEMA DI JOHN CARPENTER di Riccardo Poma
Conosciuto principalmente come regista horror, John Carpenter è in realtà uno dei più interessanti cineasti americani degli ultimi anni, rinomato per l’originalità del proprio stile e per la capacità di riflettere lucidamente sugli abomini di una società in cui i sogni hanno lasciato il posto ai peggiori incubi.
PASSIONE E VISCERE: IL CINEMA DI ANDERZEJ ZULAWSKI di Sergio Naitza
Uno sguardo sul cinema del regista polacco Andrzej Żulawski, scomparso a 75 anni nel febbraio scorso. L’opera visionaria e barocca di un autore sempre provocatorio e mai banale che merita una seria riconsiderazione critica.
IL CINEMA CRUDELE DI W.SOMERSET MAUGHAM di Orio Caldiron e filmografia a cura di Chiara Supplizi
Il grande successo di W. Somerset Maugham (1874 -1965), prima nel teatro e poi nella narrativa, ne fa uno degli scrittori più popolari del Novecento, tradotto in decine di lingue e venduto in milioni di copie in tutto il mondo. Il cinema, soprattutto hollywoodiano, s’ispira a più riprese ai suoi romanzi più noti – da “Schiavo d’amore” a “Il velo dipinto”, da “La luna e sei soldi” a “Il filo del rasoio” – che sembrano offrire ruoli di grande risalto alle attrici più celebri e carismatiche come Greta Garbo e Bette Davis. Ma sono soprattutto due racconti, “Pioggia” e “La lettera”, che danno vita a una suggestiva galleria di remake che dagli anni Venti agli anni Cinquanti coinvolgono attrici come Gloria Swanson, Joan Crawford, Bette Davis, Rita Hayworth, Gene Tierney e registi come Raoul Walsh, Lewis Mileston, William Wyler, Curtis Bernhardt, Edmund Goulding nella rappresentazione di storie coloniali di singolare “crudeltà” che hanno al centro figure femminili di forte determinazione in grado di svelare le ipocrisie sociali e le dinamiche emotive della società borghese.
CINEMA E TEATRO. TRE FILM DI DANIELE SEGRE di Tullio Masoni
Daniele Segre ha operato per molti anni soprattutto con l’inchiesta, il reportage e il documentario “cosiddetto”. Non mancano però, nella sua filmografia, titoli a soggetto o, come quelli che vengono qui trattati, di taglio “teatrale”: camera fissa, attori non cinematografici, messa in scena convertibile per il palcoscenico. Digressioni, forse, ma sempre in nome della realtà.
SERIE TV E CINEMA: UNA STORIA ARTISTICA POSSIBILE? di Davide Parpinel
Relazione tra serie tv e cinema allo stato attuale prendendo in considerazione questione linguistiche, narrative e commerciali al fine di arrivare alla formulazione della mia tesi.
L’EREDITÀ È SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI CULTURA. ADELIO FERRERO E L’ATTUALITÀ DEL SUO PENSIERO di Roberto Lasagna
Ritorna anche quest’anno il Premio Adelio Ferrero. Gli aspiranti critici cinematografici potranno inviare, assieme alla quota di iscrizione, un saggio, un video saggio, o una recensione, entro il 20 settembre 2016, a: premioferrero@asmcostruireinsieme.it
Basterà avere compiuto 16 anni e non avere superato i 35. In questo articolo ricordiamo chi fu Adelio Ferrero e perché il suo nome è legato al più significativo e importante concorso di critica e saggistica cinematografica.
FENOMENOLOGIA DEL SEGRETO NEI “PERFETTI SCONOSCIUTI” DI PAOLO GENOVESE di Franco Di Giorgi
Apparentemente di facile ricezione, il film di Paolo Genovese, “Perfetti sconosciuti”, pur in tutta la sua freschezza e leggerezza, propone invece uno dei temi più drammatici e seri del mondo contemporaneo, quello dell’attrito tra tecnica e etica, tra nuovi mezzi di comunicazione di massa e privacy. Ne viene fuori una sorta di simpatica fenomenologia tragicomica del segreto generata dall’inevitabile intersecarsi di piani ermeneutici (logico, ontologico, gnoseologico, antropologico, etico).
IL RESTAURO DEL FILM di Elio Girlanda
L’uscita in sala, a cura della Cineteca di Bologna, di alcuni capolavori restaurati conferma il ruolo importante delle cineteche e dei festival ma rimette al centro del dibattito alcune questioni ancora non risolte sul restauro, oggetto, peraltro, di un Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nel nuovo Disegno di legge governativo sul cinema.
FILMMAKER ALLA RIBALTA: ROBERTO MERLINO di Paolo Micalizzi
Profilo di un filmmaker FEDIC ( medico, di professione) che ha al suo attivo oltre 150 cortometraggi, che da quasi vent’anni è Direttore Artistico del Cineclub “Corte Tripoli Cinematografica” dandogli un grande impulso con qualificate iniziative, che s volge attività di insegnante presso Scuole ed Università. Da tre anni poi è Presidente Nazionale FEDIC dimostrando, come gli viene riconosciuto, grandi capacità manageriali che hanno portato nella Federazione Italiana dei Cineclub un sereno clima di collaborazione e di fattiva attività. Al suo attivo anche una significativa esperienza di attore e regista teatrale e di pittore.
NESSUN UOMO E’ UN’ISOLA. L’ASSEMBLEA FEDIC A MONTECATINI di Vivian Tullio
L’Assemblea Nazionale dei Presidenti dei Cineclub affiliati alla FEDIC è un evento importante in ambito associativo, non solo per espletare le formalità burocratiche richieste, ma anche perché contribuisce a creare un clima favorevole ai rapporti interumani e, mediante lo scambio di opinioni e di idee, favorisce lo spirito di appartenenza.
MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
- PREMI, OPERE, OSPITI DEL MISFF66 di Paolo Micalizzi
Opere e premi del MISFF66 di Montecatini che nel 2015 ha manifestato rilevanti segnali di crescita dopo la Presidenza di Marcello Zeppi, nei cui intenti vi è anche quello di realizzare un Festival che dia un contributo alle nuove generazioni. Significativa la presenza di ospiti, tra cui l’attrice Sandra Ceccarelli e il pittore Silvano “Nano” Campeggi autore di oltre 3.000 manifesti di film di grandi registi a livello mondiale.
- MISFF – FEDIC SCUOLA: UN CONNUBIO VINCENTE di Laura Biggi
Laboratori al MISFF66 sul rapporto cinema e scuola, che vedono coinvolti studenti delle classi terminali delle scuole primarie di Montecatini terme. Convegno “Cinema e creatività” e Festival del Cinema per ragazzi, con la proposta di una selezione di film internazionali.
LILIANA CAVANI E LE PROSPETTIVE DEL NUOVO CINEMA ITALIANO A “PRIMO PIANO SULL’AUTORE” DI ASSISI di Paolo Micalizzi
Resoconto dello svolgimento di “Primo Piano sull’Autore” di Assisi dedicato alla Regista Liliana Cavani e del relativo Convegno con contributi critici e con un prezioso Catalogo in cui viene recuperato un testo di Pier Paolo Pasolini dal titolo “ La perfetta geometria” relativo al film “Milarepa”. Un resoconto completato da notizie sui dibattiti svoltosi che riguardavano il nuovo cinema italiano e il Web.
REGGIOCALABRIAFILMFESTIVAL: UNA MANIFESTAZIONE DA SOSTENERE di Paolo Micalizzi
Ripresa del “ReggioCalabriaFilmFestival” con film e workshop e l’assegnazione dei Premi intitolati a Leopoldo Trieste e Raf Vallone. Presenza da protagonista di Salvatore Striano, ex detenuto rivelatosi al grande pubblico come attore nel film “Cesare deve morire” di Paolo e Vittorio Taviani con proseguimento dell’attività al cinema, teatro e letteratura. Un Festival che merita di essere sostenuto per avere continuità.
TAGORE, UNA RELAZIONE PRIVATA di Maria Pia Cinelli
In Kadambari del regista Suman Ghosh, presentato al 15° River to River Florence Indian Film Festival, rivive su grande schermo fra mito e realtà la controversa liason fra il premio Nobel bengalese e la moglie di un fratello.
IL BALKAN FLORENCE FESTIVAL: I BALCANI OCCIDENTALI FRA STORIA E REALTÀ di Marcello Cella
Film e documentari, presentati al Festival di Firenze del 2016, dedicati alla realtà sociale e storica del Balcani occidentali.
OCCHIO CRITICO, a cura di Marco Incerti Zambelli, Tullio Masoni e Paolo Vecchi, su alcuni film recenti:
“STEVE JOBS” E “THE END OF THE TOUR” DUE BIOPIC INCONSUETI di Marco Incerti Zambelli
DUE FILM PREMIATI.” ROOM” E “FUOCOAMMARE” di Tullio Masoni
RAPSODIA UNGHERESE: “IL FIGLIO DI SAUL” E “MOZES, IL PESCE E LA COLOMBA” di Paolo Vecchi
VISIONI RECUPERATE: “SUSPIRIA” 40 ANNI DOPO di Paola Dei
Il connubio fra Dario Argento e Luciano Tovoli attraverso fascinazioni di colori e forme é riuscito ad unire bellezza e mistero, cinema degli sguardi e post moderno oltrepassando i confini che delimitavano i vari stili cinematografici per farci entrare negli aspetti visionari del regista. Nel saggio si intende analizzare l’opera del cineasta romano alla luce di questo fortunata unione cinematografica a partire una frase scritta sul suo sito ufficiale: il colore della paura é Argento, nel film Suspiria la paura si tinge di mille colori e fa sfoggio di sé senza una logica narrativa ma con la straordinaria capacità di far divenire l’opera una delle più conosciute all’estero. Argento per girare il suo film trasse spunto dalle capitali europee attraversate durante un suo viaggio: Torino Lione e Praga.
IL BUON SELVAGGIO E IL CATTIVO SAMARITANO. “GREEN INFERNO” DI ELI ROTH di Giorgia Pizzirani
“Cannibal Holocaust” nel Terzo Millennio: studenti dai buoni propositi al posto di una scaltra troupe di giornalisti e iPhone e Twitter che sostituiscono pesanti telecamere. Trama e intreccio di “The Green Inferno”, omaggio dell’horror-saver Eli Roth al violento cult dell’italiano Ruggero Deodato di cui si ripropone riflessione in chiave attuale, sempre feroce e controversa, si snodano tra squartamenti e macabri rituali di una cultura rimasta sconosciuta, ma anche – e soprattutto – tra la fobia mediatica e la malsana fame dell’uomo ricco occidentale, che nasconde la sua malattia morale dietro alla parola “civilizzato”.
RACCONTO E MEMORIA: IL CINEMA DI NICO GUIDETTI E CONVERSAZIONE CON IL REGISTA di Marco Incerti Zambelli
Nel mondo sempre più ricco del “cinema del reale” italiano, il lavoro di Nico Guidetti, giovane autore di Reggio Emilia, si segnala per la coerenza stilistica e la ricchezza della narrazione.
RICORDO DI DAVID BOWIE, LONDON BOY: “THE IMAGE” di Francesco Saverio Marzaduri
In ricordo di David Bowie, scomparso lo scorso gennaio, una lettura critica del suo esordio cinematografico, il cortometraggio sperimentale “The Image,” allegoria del rapporto tra arte e artista, ma soprattutto del legame artista-soggetto-quadro.
IMMAGINANDO UN ALTRO CINEMA E UN’ALTRA VITA di Marcello Cella
Riflessioni inattuali su “Il sale della terra” di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (Brasile/Italia/Francia, 2014) e “Dalla mia Terra alla Terra” di Sebastião Salgado.
VINYL (1a Stagione) di Giancarlo Zappoli
Analisi dei primi cinque episodi della Serie VINYL in cui si possono già individuare le strutture portanti della narrazione i l’imprinting autoriale.
PANORAMA LIBRI
Segnalazione- recensione , a cura di Paolo Micalizzi, di volumi su Pier Paolo Pasolini, Toni Servillo ed il rapporto cinema-antropologia. E recensione di Orio Caldiron del libro di Paolo Micalizzi “Fabio Pittorru: uno scrittore per il cinema e per la televisione”.
.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
DAL SOGNO AMERICANO ALL’INCUBO – IL CINEMA DI JOHN CARPENTER di Riccardo Poma
Nonostante un ritmo di lavoro decisamente blando (appena due film dal 2000 ad oggi) e un riconoscimento critico che ancora tarda ad arrivare, soprattutto oltreoceano, John Carpenter rimane senza dubbio uno degli autori più affascinanti del panorama cinematografico nordamericano. “Halloween – La notte delle streghe” (1978) resta forse il suo film più noto, apprezzato sia dal pubblico che dalla storiografia “ufficiale”, se non altro come capostipite della declinazione “slasher” del cinema dell’orrore. Ma John Carpenter non è solo “Halloween”. Anzi. È molto, molto altro. È, innanzitutto, un cineasta fortemente “politico”, nel senso più ampio e nobile del termine: i suoi film sono spesso parabole sugli abomini di questi tempi nostri, rappresentazioni grottesche – e non sempre velate – dell’incubo in cui è sprofondato il sogno americano; è poi l’inventore di un linguaggio espressivo originale che mescola la fantascienza e l’horror con gli stilemi (e le riflessioni “storiche” che ne derivano) tipici del cinema western; è, infine, un regista orgogliosamente “classico” che ha saputo riorganizzare il concetto di classicità secondo uno stile personalissimo che si adatta alla storia e al suo potenziale espressivo. Insomma, un regista da riscoprire.
Signor Presidente
Nel 1976 arriva nelle sale “Distretto 13 – Le brigate della morte”. È il secondo film di Carpenter, dopo il goliardico “Dark Star” (1974). Non un horror né tanto meno un film di fantascienza, quanto uno scattante film d’azione col vestito del thriller metropolitano e l’anima del western, e infatti si tratta di un remake dichiarato di “Un dollaro d’onore” di Howard Hawks: un gruppo di personaggi tenta di sopravvivere in un distretto di polizia semiabbandonato, mentre da fuori una numerosa e violentissima gang criminale tenta in ogni modo di entrare per vendicare un torto subito. Ciò che colpisce, e che lo distanzia in maniera considerevole dagli epigoni coevi, è un pessimismo di fondo che diventa precisa riflessione politica: non esiste più il proverbiale “arrivano i nostri”, l’istituzione (e quindi l’autorità) non è più reperibile, e l’unica cosa su cui i cosiddetti buoni possono contare è la loro moralità, sempre più anacronistica ma cristallina, che li spinge a solidarizzare nonostante un diverso ruolo all’interno della società (nel film, i due eroi positivi sono un poliziotto nero e un criminale bianco).
Dopo le parentesi thriller di “Halloween – La notte delle streghe” (1978) e “Pericolo in agguato” (1979, girato per la televisione), Carpenter torna a rilfettere sul sogno americano con il sottovalutato “The Fog”, in cui una “normale” storia di spettri che tornano dall’aldilà per vendicarsi di un vecchio torto, proprio durante i festeggiamenti per l’anniversario della fondazione del paese di San Antonio Bay, nasconde una metafora di quello che molti definiscono il “peccato originale americano”: cosa c’è da festeggiare, si chiede Carpenter, se questo paese è stato edificato attraverso il sangue dei suoi legittimi abitanti? È un passato scomodo e squallido che, come i marinai fantasma del film, torna a gridare la propria ingombrante presenza ad una società che sembra non voler fare i conti con le proprie colpe. Ma “The Fog” vale anche per la descrizione, dieci anni prima di “Twin Peaks”, della sonnacchiosa provincia americana che cela dietro una parvenza di normalità e cordialità una serie infinita di inconfessabili segreti.
Appena un anno dopo Carpenter torna alla ribalta con il suo film forse più esplicitamente politico, quello in cui maggiormente si scardina l’allegra convinzione di un’America pura e felice in cui – come recita il “sogno” – chiunque può realizzarsi e diventare ciò che desidera. Si tratta di “1997 – Fuga da New York”, da molti considerato il suo capolavoro, il film “che resterà”. Si racconta di una grande mela del futuro divenuta, a causa dei troppi episodi di violenza e criminalità, un vero e proprio carcere a cielo aperto circondato da un alto muro in cemento, in cui i detenuti sono (de)portati e lasciati al loro destino. Quando l’aereo presidenziale precipita, in seguito ad un attentato terroristico, proprio su New York, urge recuperare il “padre di tutti gli americani”. L’unico in grado di farlo è Jena (in originale “Snake”, un eccelso Kurt Russell) Plissken, ex eroe di guerra divenuto rapinatore cui, in caso di riuscita, viene promessa la grazia. Ma il Presidente è finito nelle mani di un folle di colore autoproclamatosi il Duca di New York…
Basta guardare i primi venti minuti del film per constatarne la geniale, crudele carica critica: New York, cuore economico degli Stati Uniti, simbolo del consumismo e dell’american way of life, diventa un carcere malfamato e cadente in cui, come in un cestino dell’immondizia, vengono stipati i rifiuti (umani) di tutta una nazione. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. A differenza che in “Distretto 13” le istituzioni sono presenti, ma hanno preso una pericolosa deriva autoritaria: nessuna rieducazione è prevista per chi sbaglia, e attraverso la paura del male si è potuto instaurare quello che fuori di dubbio è da considerarsi uno “stato di polizia”. Emblema di questa deriva è una figura insospettabile ed apparentemente nel ruolo della vittima, ovvero il Presidente degli Stati Uniti interpretato da Donald Pleasence. Vigliacco e opportunista, diventa nel finale una maschera negativa dal forte potere simbolico: non solo uccide il Duca e fa scempio del suo cadavere con compiaciuto sadismo, ma addirittura non è in grado di mostrare alcuna riconoscenza verso chi si è sacrificato per portarlo in salvo, preferendo anzi dedicarsi ai preparativi per una diretta televisiva e snobbando un dialogo sincero con Jena, l’unico altro sopravvissuto della spedizione.
A questo punto del film sembra ridotta al minimo la differenza tra i due “capibanda”, quello “riconosciuto” (il Presidente) e quello “criminale” (il Duca): entrambi basano il loro dominio sulla sopraffazione del debole, entrambi desiderano languidamente il potere, entrambi hanno edificato un regime dittatoriale in cui non vengono tollerati i dissidenti e gli oppositori. Il Presidente uccide il Duca, ma tutto sembra tranne che giustizia sia stata fatta: il secondo, pur indirettamente, non è che il prodotto della politica scellerata del primo. Novello Frankenstein, il Presidente uccide una creatura che lui stesso ha contribuito a creare. Michel Sinneux, all’uscita del film, scrisse che “il Presidente è descritto come uno psicopatico ansioso, irresponsabile, mentre la rappresentazione fisica del Duca unisce le caratteristiche del contro potere nero e quelle del dittatore africano sanguinario, ridicolo e totalmente folle, tipo Bokassa e Amin Dada”. Due facce della stessa medaglia che combattono su fronti opposti ma sono accomunate dalla bulimica sete di potere e dal totale disprezzo per la vita umana di chi le circonda.
Demistificando la figura del Presidente, ovvero raccontando una storia in cui il buono per eccellenza diventa il peggiore dei cattivi, la causa di tutti i mali, Carpenter continua il suo discorso su una società insanabile ed oramai malata a tutti i livelli, dalla base alla punta della piramide.
Non a caso anche nel sequel/remake di “Fuga da New York”, il sottovalutato “Fuga da Los Angeles” (1996), a fare le spese dello sguardo dissacratorio del regista è nuovamente la figura del Presidente, stavolta interpretato da Cliff Robertson. Si accentua certo il lato caricaturale e fumettistico, ma anche quello politico: il nuovo presidente è peggiore – se possibile – di quello vecchio, un uomo ignobile che addirittura, fiutando la mossa elettorale che ne può derivare, arriva ad ordinare l’esecuzione della figlia traditrice. Ma stavolta, come si suol dire, “ce n’è per tutti”. Si veda il trattamento che Carpenter riserva al bandito terzomondista Cuervo Jones, sosia di Che Guevara, epigono del Duca del primo film: non tanto un attacco “personale” ai danni del rivoluzionario argentino o del suo operato, quanto una crudele satira su una società “delle immagini” che riesce a fare cose inaudite come trasformare la figura di un uomo nemico del capitalismo in un marchio da vendere sulle t-shirt e, dunque, capitalista. Enfatizzandone alcuni elementi fino alla caricatura, Carpenter parla ancora una volta delle aberrazioni della società odierna: bisogno spasmodico di apparire (inquietante e geniale la tappa di Jena in un laboratorio di chirurgia estetica), paura del diverso che porta al razzismo, o peggio, a leggi razziali, compiacenza nel garantire ai media uno strapotere, consumismo sfrenato. L’America peggiore, per Carpenter, sembrava essere quella di Reagan: qui si accorge che a contendersi il primato c’è quella dei Bush.
A proposito dell’America reaganiana, urge fare un passo indietro nella filmografia carpenteriana per spendere qualche parola sul divertente “Essi vivono” (1988), una boutade fracassona e divertente che, tuttavia, riesce con semplicità a raccontare la crisi di valori degli anni ’80.
È la storia di un sottoproletario losangelino che, grazie a portentosi occhiali da sole, scopre che (quasi) tutti gli uomini di potere sono in realtà alieni scheletrici che, attraverso messaggi subliminali nascosti nelle pubblicità, nei giornali, in TV, addirittura sulle banconote, controllano le classi sociali meno fortunate e le sfruttano per vivere nell’agio e nella ricchezza. La trama è quella di un B-movie come tanti, e Carpenter non fa nulla per convincere gli spettatori che si tratti di altro, ma è palese il messaggio che il film vuole trasmettere: concepito come una rilettura moderna e fumettistica del mito della caverna di Platone, è un atto d’accusa verso la società dei media e un tentativo di scuotere le coscienze narcotizzate degli americani teledipendenti.
Mi chiamo John (Carpenter) e faccio western
Nessun film di Carpenter è ambientato nel selvaggio west, eppure il richiamo alla celeberrima frase di Ford rispetto al proprio cinema – “mi chiamo John Ford e faccio western” – è ben più che legittimo. Non soltanto perché uno dei suoi primi film è il remake di “Un dollaro d’onore” di Hawks o perché il protagonista di quello stesso film si chiama come il personaggio di William Holden ne “Il mucchio selvaggio”. L’amore di Carpenter per il genere va al di là della semplice citazione: piuttosto, esso concorre alla creazione di un originale stile cinematografico che proietta moltissimi elementi del western in due altri generi che ne sembrano lontanissimi, l’horror e la fantascienza.
A partire dalla scelta più basilare, quella del tipo di pellicola: quasi tutti i film di Carpenter sono girati in Cinemascope, un formato tipicamente “orizzontale” che, oggi come ieri, ha trovato la sua dimensione migliore proprio nell’incontro con i larghissimi spazi della terra di frontiera. Carpenter è tra i pochissimi registi in attività a saper sfruttare il formato panoramico in maniera espressiva.
Si pensi anche allo stile di molte sue opere. Un film come “Vampires”, a detta dello stesso Carpenter, è un western in cui al posto degli indiani ci sono i vampiri. Come dargli torto. Le prime inquadrature del film – la macchina da presa che vola su rosse radure e poi si posa su alcuni casali in abbandono – accompagnate da una musica country/rock sono inequivocabili. Certo, presto si intravedono un’auto e un furgone, e allora la temporalità della storia viene a galla. Ma tutto il resto potrebbe uscire direttamente da un film western di Leone (rievocato negli intensi, primissimi piani che il regista fa sul volto deciso e scolpito del cowboy James Woods) o di Peckinpah (l’iperbolica rappresentazione della violenza).
Ma le affinità di Carpenter con il western si materializzano soprattutto nella figura dell’eroe e nel constesto in cui esso agisce. L’eroe carpenteriano arriva dal nulla e nel nulla ritorna, e si sente ancorato a valori morali che sembrano estinti e che invece lui considera, pur non ammettendolo, imprescindibili. Tutto ciò, unito ai suoi gesti decisi, alle sue battute lapidarie, ad un bisogno quasi arcaico di solitudine, ne fa un cowboy fuori tempo massimo che potrebbe essere uscito dai film di Hawks e Ford, ma anche dalle “revisioni” di Peckinpah, Leone, Eastwood.
Perchè l’eroe di Carpenter è plasmato su TUTTI gli eroi western: egli è un compendio meta-cinematografico dei diversi tipi di eroe visti nel cinema dell’epopea, da quelli del cinema muto a quelli degli anni novanta. Nei tanti Jena Plissken creati da Carpenter si ritrovano le caratteristiche dell’eroe leggendario dei primi western, abilissimo e dai poteri quasi sovrumani, mosso sempre da intenzioni onorevoli e dalla parte della ragione anche quando si tratta di un fuorilegge (in questo caso è la legge che sbaglia); è il John Wayne di “Ombre rosse”, personaggio leggendario e non realistico, simulacro del bisogno tutto americano di narrare – ed esaltare – una qualche mitologia di proprietà.
Ma nell’eroe carpenteriano è ben presente anche l’eroe dei western revisionisti, degli “ultimi” western, quello che Letraut, nel suo studio “Le carte del western”, definisce l’eroe “separato”: stanco, disilluso, non più infallibile e soprattutto impossibilitato – per diverse ragioni – a conservare il proprio posto all’interno della civiltà. È il John Wayne di “Sentieri selvaggi”, un personaggio che racchiude tutta l’ipocrisia della nascente società americana: la sua indole violenta è stata prima convogliata per ottenere scopi precisi (sterminare gli indiani, unico vero ostacolo alla nascità della nazione), poi giudicata inadatta alla civiltà e dunque lasciata “fuori”. Fuori dalla porta, fuori dalla società civile.
Il governo premia Jena Plissken con la grazia, ma un suo eventuale rientro nella società non è nemmeno preso in considerazione: non si può mica raccontare al mondo che il Presidente è stato salvato da un ergastolano insofferente al potere. Una mancanza che egli non patisce, anzi: la civiltà è diventata così amorale e mostruosa da non conservare alcun interesse per uomini giusti/morali come lui. La stessa cosa che accade al Jack Crow (James Woods) di “Vampires”, assunto dalla chiesa come uccisore di vampiri ma tenuto nascosto perché non è “cristiano” uccidere per lavoro, o al Desolazione Williams (Ice Cube) di “Fantasmi da Marte”, sfruttato dalle autorità per risolvere un caso difficile nonostante sia considerato un bieco assassino. Non tutti gli eroi di Carpenter seguono queste logiche, ma in ognuno di essi è riscontrabile, pur in modi e quantità diverse, il sapore dell’eroe western.
Altro tema carpenteriano preso in prestito dal western è sicuramente quello della frontiera.
In “1997 – Fuga da New York” la civiltà sembra aver lasciato nuovamente il posto alla “wilderness”, la terra inospitale ancora da colonizzare. La società civile si è disgregata insieme alla città che ne portava la bandiera, quella New York “centro del mondo” che l’immaginario americano ha da sempre promosso a modello del proprio stile di vita. Gli edifici lasciati a sé stessi, privi di manutenzione o pulizia, ospitano al loro interno erbacce, piante, uomini spietati che, ritrovandosi al riparo da qualsivoglia istituzione, tornano ad essere dei selvaggi. In Carpenter la natura riprende il posto della civiltà, in una sorta di circolo vizioso che riporta immancabilmente indietro, in quel tempo in cui uomini bisognosi di una terra da abitare addomesticarono le manifestazioni naturali e imbastirono il mondo “civile”. Il disfacimento tecnologico – una costante nel cinema di Carpenter: dagli strumenti impazziti dell’astronave “Dark Star” a quelli non funzionanti de “La cosa” – coadiuvato dall’inarrestabile declino della società capitalista riporta ogni costruzione umana al suo status “paesaggistico”: essa abdica al suo ruolo, qualunque sia – istituzionale, pubblico o privato, ecc. – e si accomuna agli alberi, alle montagne, alle rocce.
Questo concetto è alla base di molti film di Carpenter, che proprio per questo tendono ad essere identificati come western moderni in cui la città decadente e “selvaggia” ha preso il posto dei villaggi, delle distese non conquistate, della natura. Durante il “vero” west la natura selvaggia ha lasciato il posto alla società civilizzata, nel west di Carpenter la società civilizzata, autodistruggendosi, ha ricreato la natura selvaggia. Tutto torna ciclicamente, senza cambiare mai.
Jena Plissken si aggira in un mondo inospitale che appare come una frontiera da (ri) conquistare, ma lui stesso non può (e forse non vuole) riprendersela. Nel momento in cui la frontiera arrestò il suo avanzamento, nel selvaggio West, i primi americani capirono di aver costruito una nazione. Ma appena cent’anni dopo, nel 1997 di Jena, tutto è tristemente da rifare: le zone da riconquistare per ricreare un Paese di onesti principi, tuttavia sono diventate troppe, e gli uomini valorosi che potrebbero impegnarsi nel processo, portatori dei precetti di giustizia e moralità (come Jena, appunto) sono considerati criminali o banditi dall’istituzione stessa.
L’idea di una “nuova frontiera” restia alla conquista si trova molto spesso nelle opere di Carpenter: si è già parlato del dittico “Fuga da New York”/ “Fuga da Los Angeles” (quest’ultima pellicola, più dell’altra, si lega perfettamente al discorso di una natura che torna, in questo caso tramite un devastante terremoto), ma non vanno dimenticate le scorribande dei criminali senza volto di “Distretto 13”, che avvengono in una periferia losangelina impervia e malfamata che ricorda da vicino i villaggi “senza vita” dei western di Leone.
Ne “La cosa”, remake del quasi omonimo film di Hawks, Carpenter riprende il tema dell’assedio caro al suo maestro, una componente che faceva capolino nella sua opera a partire proprio da “Distretto 13”. Ma ne “La cosa” questo tema appare quasi “rivoltato”: se in “Distretto 13” il pericolo veniva da fuori e all’interno si era in un certo qual modo al sicuro, qui – dato che l’alieno può insinuarsi in qualsiasi corpo umano – nemmeno tra i muri di un edificio si può essere in salvo. Il regista gira così l’ennesimo “western non western” della sua carriera, intuendo le analogie visive tra le lande desolate dell’epopea e quelle, gelide ma in egual misura selvagge e suggestive, che offre l’Alaska (spacciata, a fini narrativi, per il Polo Sud). Il “polare”, proprio come il far West, è una terra fascinosa ancora inesplorata, in cui una comunità (in questo caso una comunità di scienziati) cerca di creare una pur piccola società civile. Per questo Carpenter presenta il campo base come fosse un risicato villaggio di frontiera, illustrandolo con campi lunghi esaltati dall’orizzontalità del formato panoramico. Gli uomini, specialmente il protagonista MacReady (che indossa sempre un cappello da cowboy), si stagliano spesso nella loro solitudine su vaste porzioni di spazio, infinite, desolate ed “isolate”.
La frontiera carpenteriana torna dunque allo status dei primi western: terra inospitale e selvaggia che l’uomo deve conquistare. Ma il fatto che alla fine nessuno si salvi dimostra che, rispetto al passato, gli uomini non sono più in grado di unire le proprie forze per ottenere qualcosa di concreto. La “nuova frontiera” non è conquistabile, in quanto gli uomini che dovrebbero innestare il processo si fanno fuori a vicenda per la paura che uno di loro sia “contagiato”. Viene a galla l’inquietudine di una società che esalta l’individualismo e non ammette il “diverso”: nemmeno per un secondo i protagonisti del film tentano di trovare una cura per i loro simili, e la loro mancanza di fiducia nel prossimo li porta inequivocabilmente alla fine.
È proprio per questa “mancanza di umanità” che la frontiera moderna di Carpenter abdica al ruolo di “sogno” di una nuova civiltà e diventa, definitivamente e senza via di scampo, un incubo.
Questo concetto ritorna – in maniera egualmente “forte” – ben vent’anni dopo le avventure polari di MacReady. Nel 2001 esce infatti il già citato “Fantasmi da Marte”, un film in cui pubblico e critica sono concordi nell’annotare elementi di “Distretto” (il tema dell’assedio) e delle due fughe di Jena (il personaggio di Desolazione Williams). Carpenter fa del pianeta Marte un nuovo, inesplorato Far West: il deserto marziano viene ripreso come se si trattasse di una distesa dell’Arizona, in cui si possono trovare miniere e piccole comunità agli albori (“Fantasmi da Marte” è probabilmente l’unico film della storia del cinema ambientato su Marte che non comincia con un’astronave ma con un treno).
L’idea di frontiera diviene, in maniera maggiore rispetto al passato, un perfetto simbolo dell’arroganza umana: l’uomo non è mai sazio di terre, e questo lo spinge a combattere presuntuosamente contro chiunque gli neghi l’espansione voluta. A tal punto che, esauriti i territori terrestri, esso si sposta col suo colonialismo violento su un altro pianeta del sistema solare, pretendendo ovviamente che vada a far parte del suo dominio.
Il discorso di Carpenter raggiunge in questo film un apice inaspettato: gli esseri umani vengono infatti letteralmente “eliminati” dai legittimi abitanti di quelle terre, mostruosi fantasmi alieni assetati di sangue. Ed è qui che il film si presenta come una metafora del West, è qui che Carpenter immagina una sorta di “riscossa del nativo”. Il suo sembra quasi un ammonimento: è andata bene una volta, ma non è detto che sia sempre così. Il sogno americano della frontiera si infrange così contro la sua stessa arroganza, che lo spinge a non fermarsi e a continuare a spostare la linea che separa la civiltà dal selvaggio. Ogni vantaggio guadagnato dal “conquistatore” ha portato al danneggiamento “dell’altro”, ogni azione violenta spacciata per civiltà ha spropositatamente aumentato la rabbia sopita: una rabbia che, prima o poi, si presenterà alla porta di quella stessa civiltà per urlare giustizia.
La questione del “classico”
Sia la critica che la storiografia ufficiale hanno sempre parlato dello stile di Carpenter come di uno stile essenzialmente classico. Studiando l’opera del regista nella sua totalità sarebbe pretestuoso affermare che si tratti di una definizione errata: il suo cinema è quasi tutto costruito su sviluppi narrativi lineari, su un montaggio trasparente costruito sul binomio campo/ controcampo, su inquadrature funzionali in cui tutto ciò che viene mostrato è attinente all’azione.
Amante del western e, dunque, del cinema “di una volta”, Carpenter rifiuta le trasgressioni tipiche della modernità e della post modernità. Ma il suo cinema è classico anche perché, pur basandosi spesso sulla commistione, è pur sempre cinema di genere, e rimane tale nonostante il concetto stesso di genere cinematografico abbia subito diverse trasformazioni.
La differenza maggiore che si può trovare tra Carpenter e i cineasti coevi che si sono avvicinati all’horror e alla fantascienza è sostanzialmente la capacità di reinterpretare la classicità in chiave estremamente personale, proprio come parecchi anni prima avevano fatto grandi nomi del cinema di genere come Howard Hawks, Orson Welles, Alfred Hitchcock, John Ford.
Pensiamo al celeberrimo incipit di “Halloween – La notte delle streghe”. Un lunghissimo piano sequenza in soggettiva che mostra agli spettatori il primo, feroce omicidio operato dal perfido Michael Myers, poco più che bambino. Carpenter utilizza il procedimento classico per eccellenza, ovvero il raccordo tra chi guarda e ciò che egli sta guardando, tra un soggetto e l’oggetto del suo sguardo. Tuttavia, la scelta di anteporre la soggettiva all’oggettiva (l’oggetto dello sguardo prima del soggetto) è una scelta assai rara, molto poco utilizzata sia nel cinema americano che in quello europeo. Non gratuita: l’obiettivo principale della sequenza è quello di angosciare e scioccare lo spettatore, e il regista vi riesce spingendolo prima a temere sé stesso – il suo sguardo coincide con quello dell’assassino – poi portandolo a fare i conti col trauma legato alla scoperta dell’identità dell’omicida: un bambino biondo di dodici anni, un pargolo con capigliatura angelica e sguardo assassino. Carpenter ribadisce attraverso l’eccesso tutta la potenza espressiva della soggettiva, e lo fa dilatando i tempi (la sequenza dura circa quattro minuti) e garantendo allo stesso tempo una visione in “tempo reale”, sottolineata dall’uso del piano sequenza. Questo binomio soggettiva “rovesciata”/ piano sequenza crea una suspense infallibile, che segue la lezione di Hitchcock ma allo stesso tempo se ne distanzia: non soltanto lo spettatore sa qualcosa che le vittime non sanno, bensì addirittura egli osserva la scena come il testimone impotente di un omicidio, un omicidio messo in scena con una regia che tramite l’uso della soggettiva “obbliga” ad assistere a tutta la sequenza “dall’interno”. Quello di Carpenter è certo un gioco virtuoso atto a testare i nervi dello spettatore, ma è anche e soprattutto una interessante nota di stile, un perfetto esempio di come si possano sfruttare in modo non convenzionale i dettami del cinema classico rileggendoli.
Nel mostrarci ciò che vede questo temibile assassino, Carpenter dà luogo ad un’immedesimazione decisamente anomala: lo spettatore, per la prima volta, si ritrova nei panni dell’assassino invece che in quelli delle vittime o del buono di turno, e dunque la tensione aumenta non perché da un momento all’altro apparirà un assassino, ma perché apparirà nell’inquadratura una delle sue vittime. In “Halloween”, dice Fabrizio Liberti nel suo saggio per “Il Castoro”, lo spettatore arriva sostanzialmente ad avere timore di se stesso.
Questa rilettura carpenteriana dei codici del cinema classico contagia anche la maniera di concepire (e utilizzare) lo spazio del fotogramma.
Si pensi alle scene in cui Michael appare alle spalle delle giovani donne che vuole aggredire. La paura non deriva – come spessissimo accade nell’horror degli ultimi anni – da un montaggio convulso o da veloci movimenti di macchina, quanto dal modo di utilizzare tutto lo spazio offerto dal formato panoramico. La tensione si accentua perché, collocandosi in secondo piano rispetto alle sue vittime, Michael si mostra allo spettatore ben prima di mostrarsi alle giovani donne che uccide. Scatta così un nuovo meccanismo identificativo, e il povero spettatore patisce chiedendosi se anche le ragazze scorgeranno la minacciosa sagoma di Michael prima che egli ponga fine alle loro esistenze. Una tecnica che torna spesso nei film di Carpenter, da “Pericolo in agguato” (uno stalker fugge dall’appartamento di Laurie Hutton) a “Fuga da New York” (un criminale corre alle spalle di Jena quando l’eroe arriva nella grande mela).
Dunque è confermato: il cinema di Carpenter rimane cinema classico. Riletto, rivisto, pieno di suggestioni personali ma, senza ombra di dubbio, classico. Interessante però notare come non si tratti di una scelta fatta per partito preso, quanto della volontà di rappresentare in maniera perfettamente funzionale una certa storia. Ma se la storia in questione aspira ad una funzionalità diversa e lontana dai dettami del cinema classico, allora ha ancora senso optare sempre e comunque per uno stile classico? È il caso de “Il seme della follia”, considerato da molti uno dei capolavori carpenteriani. Senza ombra di dubbio, si tratta di un film che di classico ha davvero poco e niente. Si tratta di una riflessione sul potere della scrittura che diventa una riflessione sul potere dell’arte, ma anche di un allucinato viaggio nei meandri della follia umana. Come trasmettere, si chiede Carpenter, questo clima di allucinata follia? Semplice. Girando un film che traghetti lo spettatore dentro un clima onirico in cui non c’è più alcuna linea di confine che separi arte e vita, sogno e veglia, sanità e follia.
Innanzitutto Carpenter disgrega la normale continuità narrativa. Per rispecchiare la follia del titolo, il regista rinuncia a qualsiasi riferimento spaziale o temporale.
C’è una sequenza, a riguardo, davvero emblematica: il protagonista, l’investigatore privato John Trent, accetta di rintracciare lo scrittore scomparso Sutter Kane; vagando di notte in una via deserta, su di un muro vede alcuni poster dei libri di Kane; spostandosi, vede un grasso poliziotto che pesta un ragazzo e fugge quando il tutore dell’ordine incrocia il suo sguardo; va a casa, telefona al datore di lavoro e l’indomani mattina va a comprare alcuni libri di Kane per documentarsi; la regia mostra dunque il detective assorto nella lettura, quando ad un certo punto si torna alla sequenza del pestaggio: questa volta, però, il poliziotto che si volta a guardarlo è un mostro; vediamo ora il protagonista che si sveglia di soprassalto: si trattava dunque di un sogno; un primo piano del protagonista che legge lascia nuovamente il posto alla scena del pestaggio, ma stavolta il mostruoso poliziotto, coadiuvato da altri esseri, attacca l’investigatore che si sveglia di soprassalto; al suo fianco appare nuovamente il poliziotto, ma Trent si sveglia nuovamente: era di nuovo solo semplice sogno.
La sequenza appare piuttosto confusa per lo spettatore, difficile da codificare, anche perché non ci sono indicazioni spaziali o temporali: quanto tempo passa tra l’acquisto dei libri e gli incubi? Dove si trova, rispetto alla casa di Trent, la strada in cui avviene il pestaggio?
La scena del pestaggio è il fulcro della storia: quando la si vede la prima volta sembra che essa faccia parte del mondo “reale”, in quanto non c’è nulla di strano a livello di percezione e il poliziotto non è ancora “mostruoso”; la seconda volta essa fa parte di un sogno di Trent: lo dimostra il fatto che il detective si svegli per la paura; la terza ed ultima volta, però, appare come materia di un libro di Kane: la dissolvenza sul volto di Trent assorto nella lettura suggerisce che ciò che egli immagina arriva da quelle pagine. Carpenter confonde abilmente realtà, sogno e arte, e il fatto che Trent sia protagonista di tutti e tre i livelli prefigura in qualche modo la sorpresa finale: il personaggio, infatti, scoprirà di non essere altro che un personaggio inventato dalla sagace penna di Kane.
La sequenza dura piuttosto poco (circa tre minuti e mezzo), ma la sua costruzione anti-classica e priva di punti di riferimento convenzionali trasmette già un’ambiguità che si fa prefigurazione della follia. In questo momento della sua carriera Carpenter dimostra di essere molto più vicino alle disgregazioni spazio- temporali tipiche di un certo cinema europeo (il “sogno nel sogno” ricorda da vicino il cinema di Buňuel) piuttosto che alle convenzioni narrative del “suo” cinema classico.
Una sequenza analoga, dal punto di vista della “perdita dei riferimenti”, è quella in cui Trent torna dall’editore Harglow (Charlton Heston). Dopo aver attraversato la follia di Hobb’s End (il paese “inventato” dallo scrittore), il detective assicurativo torna dall’editore che l’ha assunto per informarlo di avere trovato Kane e di averne distrutto il manoscritto. Ma ecco il colpo di scena: Harglow dice che in realtà il manoscritto è già stato pubblicato – “sta per uscire il film” – e che, ad averglielo consegnato di persona è stato lo stesso Trent parecchi mesi prima. Il tempo di ciò che si è visto finora è dunque un tempo distorto (il viaggio di Trent sembra non sia durato più di qualche giorno), e la sorpresa del malcapitato detective è la stessa che prova lo spettatore: non potrebbe essere altrimenti, in quanto la regia ha sempre privilegiato il punto di vista del protagonista e, di conseguenza, lo spettatore ha seguito solamente la sua storia. Carpenter scaraventa chi guarda nella situazione in cui giace il suo personaggio, trasmettendo un senso di confusione e incomprensibilità che rappresenta alla perfezione “the madness”, la follia del titolo.
Un’altra affascinate sequenza che va in qualche modo contro i principi dello stile classico è quella in cui Trent guarda attraverso il corpo di Kane, “strappatosi” come la pagina di un libro: il protagonista – ci dice la narratrice Linda Styles, che sta leggendo il manoscritto di Kane – “rimase in piedi davanti allo strappo con lo sguardo perduto nell’abisso senza limiti dell’ignoto, nella palude stigia che si estendeva dall’altra parte. I suoi occhi rifiutarono di chiudersi, e non gridò. Ma le creature, orrende e abominevoli, gridarono per lui, nel momento in cui le vide avvicinarsi e uscire a frotte da quel pozzo nero di tenebre, con l’accecante bagliore delle ossa consumate da innumerevoli secoli di maledizione”. È interessante notare come la macchina da presa di Carpenter indugi soltanto sul volto terrorizzato di Trent senza mai mostrare una soggettiva che illustri ciò che si trova al di là dello squarcio. C’è una semisoggettiva, ma ciò che si vede è soltanto buio. Il regista prima “gioca” con le aspettative dello spettatore abituato a sapere sempre cosa guardano i personaggi, poi gli propone una semisoggettiva in cui non si vede nulla. Il terrore della sequenza è generato esclusivamente dall’accostamento del volto di Sam Neill (Trent) alle parole pronunciate da Styles, e mai dalle immagini delle creature. Una scelta certamente interessante, che da un lato annuncia una presenza (Trent sta guardando qualcosa), dall’altro la nega con un’assenza (lo spettatore non vede di cosa si tratti, ma sa che è terribile grazie alle espressioni di Trent).
Carpenter cessa dunque di essere un regista “invisibile” (come era il suo maestro Howard Hawks) e rivela la sua presenza, ribadendo il fatto che è lui a “scegliere cosa mostrare allo spettatore”. Con un certo sprezzo per le convenzioni dello stile classico, il regista non solo comunica la sua posizione privilegiata di direttore d’orchestra, bensì addirittura svela esplicitamente l’artificio cinematografico. Una scelta che “spezza” l’identificazione ma riporta ad una dimensione simbolica, decisamente più politica: come uno scrittore che sceglie il destino dei propri personaggi (come un Sutter Kane che scrive il personaggio di Trent) Carpenter – attraverso il cinema – sceglie il destino di entrambi, plasmandone gesta e azioni secondo il proprio volere. Un concetto che si trova in qualsiasi tipo di opera artistica, ma che nel cinema classico è velato, nascosto: il regista interviene nel suo lavoro, ma non lo dà a vedere, lo cela dietro il coinvolgimento, le emozioni, l’immedesimazione dello spettatore. Carpenter invece ribadisce la sua esistenza, il suo agire, e lo fa per garantire al film la sua dimensione metaforica (l’arte che crea la vita). Si pensi alla sequenza in cui, su un autobus, Trent sta tornando a casa dopo le “folli notti” di Hobb’s End: in un incubo vede Sutter Kane che cerca di convincerlo del suo status di personaggio inventato; ad un certo punto lo scrittore gli dice “ti ho mai detto che il mio colore preferito è il blu?”; quando Trent si sveglia, sulla macchina da presa c’è posizionato un filtro blu. La sequenza – che rivela che il rapporto tra lo scrittore e i suoi personaggi è lo stesso di un Dio col suo creato – svela senza ambiguità l’artificio cinematografico. Il che avvicina la figura di Kane a quella del regista: entrambi cercano di esplicitare la propria presenza, entrambi ribadiscono il loro potere creativo di fronte a chi guarda.
Ma è nel finale che tutta la potenza metaforica della pellicola raggiunge il suo apice visivo: Trent, ormai impazzito, vaga per una città apocalittica senza più legge e finisce in un cinema a vedere il film “Il seme della follia”, diretto ovviamente da John Carpenter e imperniato sulle sue gesta. Non c’è più alcuna distinzione tra la realtà del film e la “non realtà di Kane”, ma nemmeno tra la realtà dello spettatore e quella del cinema (Trent sta guardando lo stesso film che guardiamo noi). Carpenter mescola differenti piani di realtà e firma il suo film meno “classico”, meno lineare e meno convenzionale.
Riaffermando anche un’idea di liberta creativa che da un “vecchio classico” non ci si aspetterebbe: quella che permette di ripensare il proprio cinema per poter assecondare una storia che richiede emozioni diverse da quelle raccontate di solito.
Ecco dunque di cosa si parla quando si parla del cinema di John Carpenter. Ex criminali divenuti buoni, buoni diventati criminali, scenari western nello spazio, revisioni stilistiche estremamente personali. E molti eroi che preferiscono stare in disparte, ribadendo la propria estraneità rispetto ad un mondo diventato troppo feroce e complicato per essere in qualche modo compreso. Come il suo amato Jena Plissken, anche Carpenter ha sempre agito restando in disparte: rispetto alle convenzioni, rispetto ai grandi circuiti hollywoodiani, rispetto alle mode e agli schemi. Ma raccontando comunque in maniera lucida tutto ciò che accadeva li intorno, raccontando un sogno che pian piano ha lasciato il posto al peggiore degli incubi.
.
.
PASSIONE E VISCERE: IL CINEMA DI ANDRZEJ ŻUŁAWSKI
di Sergio Naitza
La scomparsa di Andrzej Żuławski (17 febbraio 2016, aveva 75 anni) impone una nuova, completa immersione nella filmografia del regista polacco (due cortometraggi e tredici film) necessaria per ricollocarlo, attraverso una lettura critica più profonda e articolata, in una posizione meno defilata rispetto a quella che finora gli è stata superficialmente assegnata, soprattutto in Italia: e cioè di un regista eccentrico e caotico mentre il suo percorso personale (censurato in Polonia e costretto all’esilio in Francia per lunghi anni) e la sua cifra creativa (ha scritto anche 25 libri, una produzione letteraria quasi sconosciuta) ne fanno un autore fedele ad una visione della vita e delle cose del cinema (1).
Lo stile di Żuławski è un marchio cinematografico riconoscibile dalle prime inquadrature: movimenti di macchina, barocchismi, simbolismi, recitazione isterica ma un’analisi e una riflessione più meditate rivelano al contrario una lucida personalità, dove ogni inquadratura è fortemente pensata e voluta, nessuna sequenza è strumentale o insignificante. Tutta la sua opera racconta la tensione e le inquietudini di un uomo perfettamente calato nelle contraddizioni e negli orrori della Storia della metà del secolo scorso, un autore fuori da ogni conformismo, costretto alla dissidenza, che si è cibato di contaminazioni culturali e ha osservato, in maniera ossessiva, il Male che artiglia il mondo. Non ci sono risposte nel cinema di Żuławski, ci sono solo domande – mai scontate, mai banali – rovesciate sullo spettatore, al quale il regista chiede di entrare nei rivoli sotterranei, negli anfratti narrativi, che popolano i suoi film, perché è in questa intercapedine, in questo magma fluttuante di immagini, che stanno le tante chiavi di lettura di un cinema non riconciliato, non omologato a mode e tendenze. Lo dice anche nel suo ultimo film, “Cosmos” (2015, premio miglior regia a Locarno) , tratto dall’ultimo romanzo del conterraneo Witold Gombrowicz, Cosmo, (coincidenza, questa, che ne aumenta gli incroci cineletterari e privati): siamo in un giallo filosofico che non racconta come la coscienza e la ragione scoprono la soluzione della realtà, ma come si forma in noi la coscienza della realtà. Nel susseguirsi di citazioni, da Dante a Pasolini, da Chaplin a Shakespeare, da “Star Wars” a Tintin, Żuławski costruisce un teatro dell’assurdo – molto dialoghi sono calembour – che ci racconta l’impossibilità di decifrare il mondo e di saper mettere ordine nei nostri sentimenti, cariati da nevrosi e gelosie. Segni e segnali ora surrealisti ora concreti (animali impiccati, immagini di terrorismo dalla tv, labbra deformi, simboli esoterici) sono seminati in questa “selva oscura” cinematografica che mette alla fine in discussione la stessa struttura narrativa del film, tanto che Żuławski, con un montaggio alternato, propone due finali – come “Smoking/No smoking” di Alain Resnais – anzi ne aggiunge un terzo quando sui titoli di coda svela il set, il backstage. I trucchi della macchina cinema erano mostrati anche in “Femme publique” o in “Boris Godounov”, il concentrare in una villa un’umanità variegata e far esplodere tensioni e passioni c’erano in “La nota blu” e questa rappresentazione teatrale della vita di Cosmos richiama l’irrompere del palcoscenico in “L’importante è amare”, “L’Amour braque-Amore balordo2, “Femme publique”.
Tutto questo per ribadire che “Cosmos” non è fatto di dettagli ma è figlio di precise e coerenti piste di comunicazione che i film di Żuławski rispettano, sempre dentro un primo comandamento: il movimento. Non solo quello della cinepresa ma anche quello dei personaggi dentro uno spazio ridotto: muoversi aiuta a cambiare, per non impigrire muscoli e mente. Il movimento serve per premere sui bordi dell’inquadratura, per suggerire allo spettatore che il cinema, il racconto, continuano anche oltre. Ogni movimento significa lotta e confrontarsi su un terreno di ricordi e conoscenza, dunque fare i conti con le proprie cicatrici del dolore e della guerra (“La terza parte della notte”, “Diabeł-Diavolo”), di un passato tormentato (“Sul globo d’argento”, “L’importante è amare”, “Boris Godounov”), di un’infanzia che ha lasciato ferite (“L’Amour braque”, “Le mie notti sono più belle dei vostri giorni”) di pulsioni (a)morali (“Possession”, “La sciamana”, “La fidélité”). È un cinema che rifiuta una didattica e una didascalica analisi dell’esistenza, l’essere umano nell’universo ontologico del regista polacco ha necessità di lacerarsi, denudare corpo e anima, costeggiare gli abissi della follia, interrogarsi laicamente sul senso religioso della vita. Temi che marchiano l’esordio del 1971 con La terza parte della notte dove una sequenza autentica di un parto significa indagare sulla propria nascita, sul perché stare al mondo, in un periodo cruciale della Storia, quello della Seconda guerra mondiale e del destino di Leopoli (la città dove è nato nel 1940) sotto l’occupazione tedesca. E in più il confronto col potere che vessa una famiglia e i segni dell’Apocalisse (dove coesistono Dio e il Diavolo), ovvero la costante presenza del Male, fulcro sul quale si declinerà tutto il suo cinema successivo. Tanto che il secondo film, “Diabeł-Diavolo”, del 1972, ritorna a un altro momento storico fondamentale del suo Paese, la spartizione della Grande Polonia del 1793, così carico di simboli e similitudini con il regime di allora (palesi le allusioni alla rivolta studentesca del ’68): e infatti venne censurato per 18 anni. Sorte peggiore accadde al film successivo “Sul globo d’argento”, opera di fantascienza filosofica tratta da un romanzo del fratello del nonno del regista, di una ricchezza visiva sontuosa e sorprendente, il racconto di alcuni transfughi dalla Terra in cerca di un pianeta in cui creare una società più giusta e libera.
Ma le cui riprese vennero bloccate, le scenografie mandate al rogo, il lavoro giudicato anticomunista e solo nel 1988 (il film era del 1976) quando Żuławski tornò in patria dall’esilio francese, il regista chiuse il film raccontando con la sua voce fuori campo le scene che avrebbe dovuto girare e che il regime comunista gli proibì. Dunque, soprattutto in questi primi tre film del periodo polacco, la politica è al centro del cinema żuławskiano analizzato sotto l’ottica di un potere che annichilisce le persone. E qui s’innestano altri pilastri narrativi, come il motivo del vagare e della fuga, l’innocenza dei bambini simbolo di speranze tradite, l’ambiguità e il doppio dei personaggi, l’esplorazione dell’universo coppia, la morte. Ossessioni in un labirinto nel quale non esiste una segnaletica in aiuto allo spettatore: ognuno deve rapportarsi al film, liberandosi della passività del proprio sguardo verso lo schermo, rendendosi anzi disponibile a dialogare col proprio inconscio.
Il doppio, si diceva. Non solo inteso come il personaggio che interpreta due ruoli, Isabelle Adjani (Anna/Helen), Malgorzata Braunek (Helena e Marta), Pawel Slaby (Grigori e Dimitri) ma anche l’insistere sui nomi, Helene- Helen (“La terza parte della notte” e “Possession”), Marta (“La terza parte della notte” e “Sul globo d’argento”) Lucas (“Femme publique2 e “Le mie notti…”), Michał (“Pavoncello”, “La terza parte della notte”, “La Sciamana”) come se ognuno fosse legato a doppio filo con l’altro, concetto rafforzato dalla presenza di burattini-sosia in La nota blu. Fino a “Cosmos” che sul doppio (si veda Léna e la cameriera col labbro leporino) ricama sottile variazioni sul tema.
Ma doppio significa anche doppiezza di linguaggio, cinematografico e teatrale; di un alter ego sia la piovra di “Possession” che lo scheletro de “La sciamana”, di una scena uguale con finale diverso (“Cosmos”). Significa sdoppiarsi, cioè prendere coscienza di sé, dell’altro che c’è in noi: e questo vuol dire che qualcuno dovrà morire. La Ethel de “La femme publique” passa attraverso tre momenti, simbolicamente situati nelle sedute fotografiche, ovvero la scoperta di non essere più solo un corpo, un feticcio ma di avere una personalità, quindi alla fine non ha più bisogno dell’apparecchio fotografico, cioè di un mezzo di riproduzione del doppio. E tra l’altro fotografia e fotografo sono spesso presenti nei film di Żuławski, da “L’importante è amare” a “La fidélité”: se nel primo l’immagine è rubata senza scrupoli (il fotografo Fabio Testi), nel secondo è immagine confusa e sfocata (gli scatti di Sophie Marceau) come la realtà di cui non riusciamo più a catturarne il senso. Il doppio trova in “Possession” la sua perfezione inquietante: è qualcosa che abbiamo dentro, che si estrae dal nostro corpo, un organismo parassitario (si veda la scena dei pidocchi in “La terza parte della notte”) che prende forma di una tentacolare piovra. Da una banale storia di tradimento, il film vola verso argomenti orrorifici, metafisici e spirituali: “Possession” è una indagine sulla degenerazione dell’amore, fin dentro le sue viscere, è la fusione tra pensiero allucinato e corporeità sanguigna. C’è un filo che unisce Isabelle Adjani a Iwona Petri, protagonista de “La sciamana”, e non è soltanto l’istinto carnale: i corpi sono separati, sono tutt’uno solo nell’illusione dell’orgasmo. Il doppio è separazione, riflesso amplificato di tutto quello che l’altro ha rappresentato nella vita. Siamo in una dimensione metafisica, mistico-irrazionale. E non è un caso che Żuławski affidi alle donne il ruolo di “sperimentat(t)rici”, lasciando agli uomini ruoli più marginali e fragili. Le donne si realizzano nella caparbietà dei loro sentimenti, sono capaci di gettare il corpo nella lotta, hanno tutte un’idea su come affrontare il destino: Żuławski ce lo mostra con le inquadrature del passo deciso e sicuro di Isabelle Adjani, Valerie Kapriski, Sophie Marceau, Iwona Petri, quasi sempre in apertura di film, una carrellata sui piedi che camminano svelti e sfrontati, come la volontà di percorrere una strada autonoma con slancio felino, imponendo un modello di indipendenza. L’uomo invece è sempre in uno stadio infantile, immaturo, spesso ripreso in posizione fetale: Dutronc che fa il piccolo Zorro in “L’importante è amare” o è sotto il segno di Tintin in “Le mie notti…”, i gangster hanno le maschere di Paperino, Pluto e Topolino in “L’amour braque”. In un cinema etichettato come adulto ed erotico, il bambino invece è la nicchia privilegiata, nascosta in ogni film, tentativo di trovare la luce in un mondo di tenebre: rivelatore, in questo caso, il suicidio nella vasca da bagno del piccolo Bob in “Possession”, che richiama quello più celebre di Heinrich in “Germania anno zero” di Rossellini: siamo sempre nella cupa Berlino, entrambi i gesti estremi dei bambini sono grida contro l’innocenza tradita e il Muro (allora, nel 1982, presente e spesso inquadrato) è l’evidente metafora della incomunicabilità della coppia.
Ecco: la coppia, altro cardine żuławskiano, inventata anche quando non c’era (“Boris Godounov”). Elemento che ne richiama un altro: l’amore. Che non è mai edulcorato, patinato, scontato: a Żuławski la banalità dei sentimenti non interessa, deve esserci sempre possesso, sensualità, strazio, parossismo, desiderio, impegno fisico e mentale, nudità, struggimento. Amore come demoniaco tormento purificatore. La realtà quotidiana c’è ma sono schizzi di immagini rapide, talvolta estranee al plot principale: sparatorie, inseguimenti, morti violente spesso risolte con toni grotteschi (il lanciafiamme ne “L’Amour braque”, il traffico di uranio ne “La sciamana”, l’assassinio di un cardinale in “Femme publique”, l’editore colluso con la mafia in “La fidélité2), in qualche caso affidate a un terzo occhio, lo schermo di una tv sempre accesa per ricordare anche a chi si autoemargina in una villa di campagna che la violenza e la tragicità del mondo ci inseguono sempre (“La fidélité”, “Cosmos”).
Entrare disarmati in questo mondo di fenomenologie dell’incoscienza, cioè senza un piccolo fardello culturale per decifrare le tante porte e botole che si aprono vedendo i suoi film, è smarrirsi nella superficialità di uno sguardo distratto, magari da qualche nudo femminile (anche se il tema dell’erotismo è molto presente e da approfondire). Si può “vedere” il mondo żuławskiano analizzando il suo linguaggio cinematografico. Movimento, dunque, è la parola chiave, la fluidità della cinepresa, sguardo mobile, curioso, impertinente, pedinatore, nevrotico. Quasi danzante, e infatti in “Diabeł” il diavolo è incapace di spiegare a parole le brutture del mondo e allora tenta di farlo con una danza. Nelle accelerazioni e nei ritmi sincopati c’è la voracità della scoperta. Ma non si tratta mai di movimenti di bravura tecnica o civetteria cinefila, tutti sono funzionali al racconto. “Possession” ha una struttura circolare, in cui la macchina da presa accerchia i personaggi; in “Diabeł” i movimenti sono di avvitamento; la camera a mano bracca i protagonisti nella prima parte di “Sul globo d’argento” mentre nella seconda si privilegiano gru e dolly hollywoodiani; la mobilità strappa all’immobilismo del teatro lirico il personaggio di Boris Godounov che il regista fa scappare fra i meandri del suo palazzo, come è memorabile la fuga nei sotterranei in “La terza parte della notte”. Anche il colore, le sue sfumature e la sua temperatura, ha una impronta psicologica netta, dal blu fosforescente di “Possession” al giallo tenue che emana “La nota blu”, ma è il rosso del sangue ad attraversare tutti i film, richiamando un carattere primigenio, legato al parto e alla morte. È il sangue sui tronchi sono dove impalati gli uomini (“Sul globo d’argento”), sull’abito bianco di una donna macchiato nel basso ventre (“Diabeł”), al sangue che invade la tastiera del pianoforte (“La nota blu”), giusto per fare qualche esempio: come se ogni film avesse un “patto di sangue”, una corrispondenza, un rimando l’uno con l’altro. Sangue significa vita: Żuławski in fondo col suo cinema chiede allo spettatore la disponibilità a ricevere una trasfusione di qualcosa di vitale, sotto forma di provocazione, un coinvolgimento di sensi e di intelletto. È la stessa richiesta che ha sempre fatto agli attori, dai quali pretende “tutto e tanto”, di andare oltre il personaggio, di immergersi totalmente. Non è un caso che quelli che hanno lavorato con lui gli hanno sempre riconosciuto d’essere un maestro nel dirigerli. In particolare le donne, Żuławski ha saputo trasformarle, con la tensione del demiurgo, ottenendo risultati eccezionali, da Romy Schneider a Malgorzata Braunek, alla trasformazione in attrici di acerbe teenager come Sophie Marceau, o di sconosciute esordienti come Valerie Kapriski o Iwona Petri.
C’è molto da scavare in questo cinema spirituale, anzi teologico, zeppo di simboli religiosi, in particolare la croce che compare in mezzo a marito e moglie in “La terza parte della notte”, negli uomini crocefissi come Cristo in “Sul globo d’argento”, nello sguardo muto della Adjani verso un crocefisso in “Possession”; e poi le tante croci di “Boris Godounov”, e il simbolismo ne “La sciamana” in cui i due amanti (anche nel manifesto del film) sono incorniciati da una croce. Tra l’altro in questo film c’è un prete (omosessuale) ma rappresenta la sconfitta della religione, e infatti si suicida. In Żuławski non esiste un Cristo che salva e redime, esistono Dio e Diavolo facce di una stessa medaglia. Il rituale religioso, o cattolico di cui è intrisa la Polonia in cui è nato, gli interessa nella sua devianza metafisica o nella similitudine più estrema: il rito della Comunione, il mangiare il corpo di Cristo, diventa ne “La sciamana” una pista divinatoria e soprannaturale, perché il gesto finale della protagonista Iwona Petri, che si ciba del cervello del professore di antropologia di cui è innamorata, non è un finale horror, è un gesto cannibale nasconde radici nelle teorie di Bataille. E che chiude il cerchio con la sequenza di “Possession” in cui Isabelle Adjani uccideva e metteva braccia e piedi in un frigo.
Si capisce che il cinema di Żuławski non ha verità in tasca, è un magma creativo affascinante e stravagante, visionario e inafferrabile; spesso parte da un testo letterario (il suo faro Dostoevskij o un autore minore), ma subito se ne allontana in una trasposizione che è sempre immagine forte e scioccante. E molto ci sarebbe da ragionare sul suo vulcanico talento di scrittore, dove la prosa è un fiume in piena, ricca e debordante, colta e sguinzagliata, come il moto perpetuo del suo cinema. Così “Cosmos”, essendo l’ultimo suo film è diventato anche il suo testamento: tornato dietro la macchina da presa 15 anni dopo “La fidélité”, Żuławski provoca un cortocircuito fra
cinema e letteratura, i suoi due amori, lo si capisce dal personaggio protagonista chiamato Witold, alter ego suo e di Gombrowicz, che vediamo spesso inquadrato a scrivere, dunque nell’attore creativo. E il creare ha a che fare con la libertà, che è anche quella di costeggiare generi diversi (melò, giallo, commedia, metacinema) senza sceglierne uno, e di giostrare abilmente fra cinema e vita, arte e finzione. Żuławski è stato un autore che ha sempre saputo osare, sperimentare, eccedere e che ha usato immagini e parole per scuotere spettatore e lettore dalla noia, dalla banalità, dall’indolenza. Oggi ci resta un cinema “urlato” che chiede di farsi sentire, un frammento di luce nell’oscurità del mondo.
NOTE
- L’unica retrospettiva completa su Żuławski è stata realizzata dal Trieste Film Festival nel 2003, che ha pubblicato una monografia curata da Sergio Naitza (dalla quale in questo articolo sono riprese alcune riflessioni).
.
.
SAGGI
 IL CINEMA CRUDELE DI W. SOMERSET MAUGHAM
IL CINEMA CRUDELE DI W. SOMERSET MAUGHAM
di Orio Caldiron
- Society Play
Se l’aveva cercato nella narrativa, il successo W. Somerset Maugham lo trova invece nel teatro. Nei primi decenni del secolo scorso ci mette poco a diventare uno dei protagonisti più gettonati dal pubblico e dalle attrici in cerca di nuovi testi. Si cimenta nei generi più diversi, dal melodramma alla farsa, ma dà il meglio nella Society Play, la commedia di costume ambientata nel mondo elegante di cui registra le convenzioni e i tic, le frivolezze e le ossessioni in dialoghi brillanti e amari sottotesti che lo rendono celebre. Il salotto londinese è lo spazio privilegiato dove si muove con la disinvoltura di chi fa del paradosso una strategia vincente. Lo scetticismo più cinico non esclude la denuncia delle ipocrisie sociali.
Si va da “Penelope” (1909), acuta radiografia della psicologia femminile dalla parte della donna, a “Terra promessa” (1914), dove la protagonista segue l’eroe nelle sterminate distese del Canada da colonizzare. “Il circolo” (1921) è l’ironica rappresentazione del matrimonio e del divorzio attraverso due generazioni di una stessa famiglia, mentre “La moglie fedele” (1926) va più in là e il lieto fine coincide con la dissoluzione del matrimonio. “La sacra fiamma” (1928) risente esplicitamente delle tesi sessuali lawrenciane e “Quello che guadagna il pane” (1930) fa il tifo per il banchiere che, stanco di mantenere la famiglia abituata al lusso, provoca volontariamente la bancarotta. Il suo testo più audace è “Per servizi resi” (1932), caustico quadro di amarezze postbelliche che indigna i benpensanti e lo induce a sospendere la sua attività teatrale per dedicarsi esclusivamente alla narrativa. Nel frattempo erano stati adattati per la scena anche “Pioggia” e “La lettera”, i due famosi racconti più volte riproposti dal cinema.
La fortuna italiana del teatro di Maugham comincia alla fine degli anni venti e esplode nei trenta con un décalage di almeno un decennio nei confronti delle messinscene inglesi e americane. La parola passa a Bagni-Ricci, Besozzi-Ferrati, Merlini-Cimara-Tofano, Benassi-Carli, Gramatica-Carini, Torrieri-Bernardi, che non sono misteriose formazioni dell’odierna calciopoli ma con Tatiana Pavlova, Marta Abba, Lamberto Picasso, Annibale Betrone e Paola Borboni il gotha della scena italiana dei trenta, la strepitosa compagnia di giro che supplisce alla mancanza di teatri stabili. Il successo delle commedie dello scrittore inglese è notevole in una stagione in cui gli attori che battono le piazze con un repertorio quantitativamente impressionante hanno un bisogno disperato di copioni. Nella scena italiana dell’epoca – che non si è ancora trasferita armi e bagagli a Budapest come succede di lì a poco con l’invasione di autori e commedie ungheresi, all’origine dei telefoni bianchi cinematografici – il teatro di William Somerset Maughan ha il suo momento di gloria se Renato Simoni , Silvio d’Amico e gli altri critici ne parlano con il sussiego che riservano agli autori importanti senza mai lasciar trapelare che spesso si tratta solo di piacevole teatro d’intrattenimento. Tra i pochi che non si fanno incantare c’è Alberto Savinio. Su “Omnibus” del 20 agosto 1938 non sembra per niente disposto a prendere sul serio “i sacrifici silenziosi, l’onore macchiato, il disonore che solo la morte in terra lontana può smacchiare” di “Lo scandalo Mackenzie”, dove “la retorica del gentiluomo inglese arriva a un asmatismo tale che, dopo il primo atto non ha più fiato di tirare avanti, e se ne giace a terra, molliccia e biancastra, come la trippa bollita”.
- Il Grande Gioco
Quando nel 1928 esce “Ashenden” o “L’agente inglese”, considerato oggi l’archetipo del moderno romanzo di spionaggio, la spy story si era conquistata già il suo spazio nello scaffale della paraletteratura anglosassone. Senza contare “Kim” (1901) di Rudyard Kipling, strepitosa celebrazione del Grande Gioco sullo sfondo esotico dell’India favolosa, in “L’agente segreto” (1907) di Joseph Conrad il genere aveva incontrato lo scenario della città mostruosa. Come dimenticare poi le suggestive anticipazioni di John Buchan, che in un gruppo di romanzi inaugurato nel 1915 da “I quarantanove gradini” e concluso solo nel 1924, s’era inventato la guerra santa contro la Gran Bretagna guidata da un giovane profeta musulmano e l’uso delle più spregiudicate tecniche di persuasione psicologica di massa?
Sin dalla prefazione l’autore mette le mani avanti, si sente più scrittore-agente che agente-scrittore, anche se si vanta di essere stato mandato in Russia nel 1917 per tentare di impedire lo scoppio della rivoluzione bolscevica. Nessuno più di lui ha contribuito a definire lo statuto della Spy Story in fieri, incentrato sulla figura dell’eroe senza illusioni, pedina di un gioco più grande di lui, che lucidamente non si nasconde gli aspetti più sgradevoli del mestiere: “Era solo una rotellina di un complicato ingranaggio e non gli era dato di vedere un’azione per intero. Interveniva all’inizio, o alla fine, o in qualche momento intermedio, ma di rado aveva modo di scoprire a cosa portasse il suo operato. I capi supremi del servizio segreto nei loro uffici londinesi forse facevano una vita eccitante, muovevano le loro pedine qua e là e vedevano il disegno che una moltitudine di fili veniva tessendo. Ma per i pesci piccoli far parte del servizio segreto non era l’esperienza avventurosa immaginata dal pubblico”. Sono molti i luoghi ormai classici di “Ashenden”, dai colloqui con “R.”, il colonnello del servizio segreto, alle descrizioni delle città svizzere dove le spie dei vari paesi stabiliscono tutti il quartier generale nello stesso albergo, alla metodica decifrazione dei messaggi in codice: ingredienti ormai canonici e rituali ma che sembrano qui fare le prove generali prima che Eric Ambler, Ian Fleming, Len Deighton, John Le Carré si passino il testimone.
Chi ha capito tutto, l’uomo che sapeva troppo, è Alfred Hitchcock che tra il ’35 e il ’36 prima di salpare per Hollywood fa in tempo a portare sullo schermo Buchan (“Il club dei trentanove”), Maugham (“Amore e mistero” o “L’agente segreto”) e Conrad (“Sabotaggio”), sintonizzandosi per tre volte di seguito sul thriller spionistico in formazione. Poco importa se dopo aver voluto un grande attore di teatro come John Gielgud per impersonare Ashenden, sul set sembra avere occhi soltanto per la bionda Madeleine Carroll, conflittuale oggetto del desiderio che la macchina da presa insegue con amore ma non esita a far vedere con la faccia coperta di crema. Il fatto è che il grande Hitch – ha raggiunto proprio allora il peso massimo di oltre centoquaranta chili – nel suo schizofrenico rapporto con gli attori, e soprattutto con le attrici, sembra più che mai deciso a cercare di capire cosa succede all’interno dei personaggi. Anche di se stesso? L’universo dello spionaggio e del controspionaggio con la sua ambiguità istituzionale lo fa incontrare con i grandi temi del suo cinema di autore in incognito, dall’instabilità delle relazioni umane ai complicati labirinti della colpa, dal gioco del doppio alla banalità del male.
- Tristi Tropici
Che cosa hanno in comune Gloria Swanson, Joan Crawford, Bette Davis, Greta Garbo, Gene Tierney, Rita Hayworth? Nulla. Se non fosse che tutte hanno impersonato sullo schermo le protagoniste dei libri di W. Somerset Maugham, lo scrittore inglese più saccheggiato dal cinema americano dagli anni trenta ai cinquanta. Nella grande stagione di Hollywood il personaggio stesso del romanziere di successo appare in più di un film con il proprio nome e cognome ma con il volto del compassato Herbert Marshall, il più inglese degli attori inglesi, il partner di Greta e Marlene. Il suo passo claudicante non sminuisce il fascino discreto dell’uomo di mondo. Nella debordante filmografia del narratore, piena di remake e riproposte, la danza la conducono le donne, in cui le frustrazioni romantiche non hanno attenuato i robusti appetiti sessuali. Nei loro confronti il perfido Maugham spesso rinuncia al suo sprezzante cinismo.
Sul finire del muto, “Tristana e la maschera” (1928) di Raoul Walsh è la prima versione di “Pioggia”, il bellissimo racconto ambientato a Pago Pago, l’isola del Pacifico dove, appena sbarcati da San Francisco, si affrontano Sadie Thompson e Mr. Davidson, la prostituta e il missionario deciso a redimerla. Gloria Swanson, che è stata l’acclamata protagonista delle commedie coniugali di Cecil B.DeMille e Jeanie McPherson, subito dopo il matrimonio con il marchese di La Falaise, si è innamorata del personaggio e, nonostante l’ostilità di Will Hays, riesce a spuntarla in barba al Codice. Il risultato è straordinario. Sin dalle prime immagini l’irruente vitalità della star inaugura lo scontro senza quartiere con un allucinato Lionel Barrymore, il fanatico religioso dai bagliori luciferini.
Quasi senza storia è la seconda “Pioggia” (1932) di Lewis Milestone con Joan Crawford, un flop clamoroso nonostante l’abilità del regista di “All’Ovest niente di nuovo”. Il pubblico delle dattilografe e delle commesse, che accorrono a vedere il film dell’attrice dalla grande bocca, si riconoscono nella ragazza che si è fatta da sé e non se la sentono di rinunciare alla facciata di rispettabilità. Non riescono a condividere l’esplicita spregiudicatezza di Sadie. Non era ancora arrivato per Joan il periodo Adrian, quando il grande costumista mette in rilievo le sue spalle quadrate dando vita allo Stile Crawford dall’inconfondibile gusto mascolino al centro degli aggressivi Women’s Film tra mélo e noir, dove l’eroina intraprendente e vulnerabile rivendica il proprio diritto alla felicità.
.
La terza “Pioggia” (1953) di Curtis Bernhardt è un film a corrente alternata che si affanna a aggiornare la vicenda alla seconda guerra mondiale, ma trova il principale motivo di interesse nella presenza di Rita Hayworth, l’estrema incarnazione del glamour hollywoodiano. Se lo spostamento cronologico enfatizza il ruolo del presidio dei marines aumentando il numero dei commilitoni del sergente O’ Hara, altrettanti boys di un quasi musical stregati dalla cantante di night dal torbido passato, il puritanesimo dell’ispettore delle missioni, un legnoso José Ferrer, diventa meno plausibile, tutto sbilanciato sul coté dell’ipocrisia. L’irriducibile vivacità dell’attrice rivitalizza il personaggio, assicurandole la naturalezza senza compromessi delle grandi performance. Certo, i tempi di “Gilda” sono lontani e l’altalena di matrimoni e divorzi lascia il segno e qualche ruga, ma non spegne mai del tutto l’incontenibile esuberanza sessuale della “Rossa Con Cui Vorrei Fare Naufragio”.
.
.
Negli anni trenta nessun’altra attrice si sottrae alle regole dello star-system come Bette Davis. Il suo singolare magnetismo è estraneo al richiamo sessuale se non addirittura ai canoni convenzionali della seduzione cinematografica. Non bella, le palpebre pesanti, gli occhi sporgenti, il mento aggressivo, è la ribelle cosciente di sé nella società dominata dagli uomini. I capi della Warner non riescono a capire perché voglia interpretare a tutti i costi un personaggio odioso come quello di Mildred, la cameriera di cui è ossessivamente innamorato lo studente di medicina Philip Carey/Leslie Howard.
.
.
.
.
..
Ma “Schiavo d’amore” (1934) di John Cromwell rivela la grinta dell’attrice, avviando la galleria di personaggi femminili perfidi, autoritari, sgradevoli, con lo strepitoso repertorio di occhiate oblique, labbra serrate, gesti insolenti, scatti nervosi e battute micidiali. Solo pochi anni dopo con “Ombre malesi” (1940) di William Wyler, tratto dal magnifico racconto La lettera, è ormai una star che può dimostrare a tutti di essere il maggior temperamento tragico dell’epoca. Basterebbe pensare alla sequenza in cui Leslie Crosbie, la gelida moglie del vip della colonia britannica di Singapore uccide l’amante, mentre la luce bianca della luna sembra inseguirla.
Greta Garbo in “Il velo dipinto” (1934) di Richard Boleslawski è ancora una volta enigmatica, inafferrabile, lontana. Il film arriva dopo una ventina di titoli diseguali che hanno cristallizzato il suo mito e prima dell’ultima fase conclusa nel ’39 dallo splendido “Ninotchka”. Nonostante i suoi film siano spesso modesti, affidati alle più logore convenzioni, quasi sempre il carisma dell’interprete vi si impone fino a brillare di luce propria. “Il velo dipinto” – una storia di tradimento e redenzione sullo sfondo della colonia inglese di Hong Kong – non fa eccezione. La bellezza misteriosa della sfinge svedese per sedurre le platee non ricorre al sex-appeal, ma alle segrete alchimie della sua strepitosa fotogenia. Il volto intenso, la camminata altera, il magnetismo della immedesimazione totale, a cui non sono estranee la tenerezza e l’ironia, fanno di lei una delle più alte incarnazioni del cinema in bianco e nero. Cecil Beaton l’ha paragonata a un sismografo capace di registrare la gamma più complessa e impercettibile di vibrazioni.
Nella sterminata cineteca personale di Maugham sarebbe bello avere carta bianca per vedere on demand i due remake con Eleanor Parker di “Schiavo d’amore” (1946) e “Il velo dipinto”/”Il settimo peccato” (1957), evitare il terzo, mediocre “Schiavo d’amore” (1964) con, ahimé, Kim Novak e rivedere la cattivissima Gene Tierney di “Il filo del rasoio” (1946) con un addormentato Tyrone Power del tutto fuori ruolo. I duetti tra Herbert Marshall e Clifton Webb, due espliciti alter ego dello scrittore, sono assolutamente imperdibili.
Biografia
William Somerset Maugham, nato a Parigi il 25 gennaio 1874 da genitori inglesi, è morto nella sua villa di Cap Ferrat sulla Costa Azzurra il 16 dicembre 1965. Si laurea in medicina, ma presto l’abbandona per dedicarsi all’attività letteraria. Nel corso della prima guerra mondiale è reclutato dal Secret Intelligence Service, il futuro M16, operando prima in Svizzera e poi in Russia. Si sposa con Syrie Wellcome, da cui nasce la figlia Liza. Quando nel 1928 divorziano, già da tempo viveva con il giovane americano Frederick Gerald Haxton, che muore nel 1944. Nel resto della vita gli è accanto Alan Searle. Il suo romanzo più noto è “Schiavo d’amore” (1915), dove si intrecciano autobiografia e finzione (la balbuzie di Maugham diventa il piede equino del protagonista). Scrittore di enorme popolarità tradotto in tutto il mondo (ha venduto circa cento milioni di copie), i suoi romanzi di maggior successo sono “Il velo dipinto” (1925), “Ashenden” o “L’agente inglese” (1928), “Acque morte” (1932), “La diva Julia” (1937), “Il filo del rasoio” (1944), tutti riproposti da Adelphi. Nella stima dei lettori, professionali e no, oggi sono molto alte le quotazioni dei racconti, forse l’aspetto più originale della sua produzione: non solo i due più celebri, e cioè “Pioggia” (1921) e “La lettera” (1926), ma anche le raccolte come “Storie ciniche e Honolulu”, anch’esse pubblicate da Adelphi. Sulla vita dello scrittore è fondamentale il libro del nipote Robin Maugham “Conversazioni con Zio Willie”, trad. it., Milano, 2008, anch’esso pubblicato da Adelphi.
Filmografia
a cura di Chiara Supplizi
La filmografia di W. Somerset Maugham è sterminata. Sono una quarantina i film tv delle sue opere da fine anni Trenta a oggi, e quasi duecento i programmi televisivi e le serie tratte dall’ attività letteraria e teatrale nel quarantennio compreso tra i Cinquanta e i Novanta. La filmografia che segue riguarda i film ispirati ai romanzi e ai racconti dal cinema muto a oggi. Non vi sono compresi la trentina di film dai testi teatrali, né la decina in cui appare lo scrittore stesso.
The Explorer (1915)
Regia: George Melford; soggetto: romanzo omonimo (1908) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: William C. de Mille; fotografia: Percy Hilburn (b/n); interpreti e personaggi: Lou Tellegen (Alec McKenzie), Tom Forman (George Allerton), Dorothy Davenport (Lucy Allerton), James Neill (Dr. Adamson), Horace B. Carpenter (McInnery); produzione: Jesse L. Lasky per Jesse L. Lasky Feature Play Company; origine: Stati Uniti.
The Magician (1926)
Regia: Rex Ingram; soggetto: romanzo “Il mago” (1908; “The Magician”) di W. Somerset Maugham; adattamento e sceneggiatura: Rex Ingram; fotografia: John F. Seitz (b/n); musica: Robert Israel; scenografia: Henri Ménessier; montaggio: Grant Whytock; aiuto regia: Michael Powell; interpreti e personaggi: Alice Terry (Margaret Dauncey), Paul Wegener (Oliver Haddo), Firmin Gémier (Dr. Porhoët), Iván Petrovich (Dr. Arthur Burdon), Gladys Hamer (Susie Boyd), Henry Wilson (servitore di Haddo); produzione: Rex Ingram per Metro-Goldwyn Pictures Corporation; origine: Stati Uniti; durata: 83’.
Vad kvinnan vill (1927)
Regia: Edvard Persson; soggetto: romanzo di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Edvard Persson; fotografia: Anders Lindkvist (b/n); interpreti e personaggi: John Ekman (Emanuel Wills), Olga Hellqvist (cantante), Adolf Jahr (Harry Wills), Jullan Kindahl (Amanda), Edvard Persson (Kalle Pettersson), Mim Persson (Maggi Wills); produzione: Nils Werner per Wernerfilm; origine: Svezia; durata: 76’.
Tristana e la maschera (1928; Sadie Thompson)
Regia: Raoul Walsh; soggetto: racconto “Miss Thompson” (1921, poi diventato “Rain”, tr. it. “Pioggia”) di W. Somerset Maugham e testo teatrale “Rain” (1925) di John Colton e Clemence Randolph; adattamento: Raoul Walsh; titoli: C. Gardner Sullivan; fotografia: George Barnes, Robert Kurrle, Oliver T. Marsh (b/n); musica: Joseph Turrin (versione del 1987); scenografia: William Cameron Menzies; montaggio: C. Gardner Sullivan; interpreti e personaggi: Gloria Swanson (Sadie Thompson), Lionel Barrymore (Alfred Davidson), Blanche Friderici (moglie di Alfred Davidson), Charles Lane (Dr. Angus McPhail), Florence Midgley (moglie di Angus McPhail), James A. Marcus (Joe Horn), Sofia Ortega (Ameena); produzione: Gloria Swanson, Raoul Walsh per Gloria Swanson Pictures, Raoul Walsh Production; origine: Stati Uniti; durata: 97’.
Pioggia (1932; Rain)
Regia: Lewis Milestone (non accreditato); soggetto: racconto “Miss Thompson” (1921, poi diventato “Rain”, tr. it. “Pioggia”) di W. Somerset Maugham e testo teatrale “Rain” (1925) di John Colton e Clemence Randolph; sceneggiatura: Maxwell Anderson; fotografia: Oliver T. Marsh (b/n); musica: Alfred Newman; costumi: Milo Anderson (non accreditato); scenografia: Richard Day; montaggio: W. Duncan Mansfield; interpreti e personaggi: Joan Crawford (Sadie Thompson), Walter Huston (Alfred Davidson), William Gargan (sergente O’Hara), Mary Shaw (Ameena), Ben Hendricks [Ben Hendricks Jr.] (Griggs), Frederic Howard [Fred Howard] (Hodgson); produzione: Lewis Milestone per Feature Productions; origine: Stati Uniti; durata: 94’.
The Narrow Corner (1933)
Regia: Alfred E. Green; soggetto: romanzo “Acque morte” (1932; “The Narrow Corner”) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Robert Presnell [Robert Presnell Sr.]; fotografia: Tony Gaudio (b/n); musica: Bernhard Kaun (non accreditato); costumi: Orry-Kelly; scenografia: Robert M. Haas; montaggio: Herbert Levy [Herbert I. Leeds]; interpreti e personaggi: Douglas Fairbanks Jr. (Fred Blake), Patricia Ellis (Louise Frith), Ralph Bellamy (Eric Whittenson), Dudley Digges (dottor Saunders), Arthur Hohl (capitano Nichols), Reginald Owen (Mr. Frith); produzione: Warner Bros. Pictures Inc.; origine: Stati Uniti; durata: 69’.
Schiavo d’amore (1934; Of Human Bondage)
Regia: John Cromwell; soggetto: romanzo omonimo (1915) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Lester Cohen; dialoghi: Ann Coleman (non accreditata); fotografia: Henry W. Gerrard (b/n); musica: Max Steiner; costumi: Walter Plunkett; scenografia: Carroll Clark, Van Nest Polglase; montaggio: William Morgan; interpreti e personaggi: Leslie Howard (Philip), Bette Davis (Mildred), Frances Dee (Sally), Kay Johnson (Norah), Reginald Denny (Griffiths), Alan Hale (Miller); produzione: RKO Radio Pictures; origine: Stati Uniti; durata: 83’.
Il velo dipinto (1934; The Painted Veil)
Regia: Richard Boleslawski; soggetto: romanzo omonimo (1925) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: John Meehan, Salka Viertel, Edith Fitzgerald; fotografia: William H. Daniels (b/n); musica: Herbert Stothart; costumi: Adrian; scenografia: Cedric Gibbons; montaggio: Hugh Wynn; interpreti e personaggi: Greta Garbo (Katrin), Herbert Marshall (Walter Fane), George Brent (Jack Townsend), Warner Oland (generale Yu), Jean Hersholt (signor Koerber); produzione: Hunt Stromberg per Metro-Goldwyn-Mayer (MGM); origine: Stati Uniti; durata: 85’.
Amore e mistero (1936; Secret Agent)
Regia: Alfred Hitchcock; soggetto: racconti “The Traitor” e “The Hairless Mexican” raccolti in “Ashenden: Or the British Agent” (1928) di W. Somerset Maugham e testo teatrale “Secret agent” (1936) di Campbell Dixon; sceneggiatura: Charles Bennett, Alma Reville (continuità narrativa); dialoghi: Ian Hay, Jesse Lasky Jr. (addizionali); fotografia: Bernard Knowles (b/n); musica: John Greenwood (non accreditato); costumi: J. Strassner [Joe Strassner]; scenografia: O. Werndorff [Oscar Friedrich Werndorff]; montaggio: Charles Frend; interpreti e personaggi: Madeleine Carroll (Elsa Carrington), John Gielgud (Richard Ashenden/Brodie), Peter Lorre (il generale), Robert Young (Robert Marvin), Percy Marmont (Caypor), Florence Kahn (signora Caypor); produzione: Gaumont British Picture Corporation; origine: Gran Bretagna; durata: 86’.
L’isola della furia (1936; Isle of Fury)
Regia: Frank McDonald; soggetto: romanzo “Acque morte” (1932; “The Narrow Corner”) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Robert Andrews [Robert Hardy Andrews], William Jacobs; fotografia: Frank B. Good (b/n); musica: Howard Jackson (non accreditato); costumi: Orry-Kelly; scenografia: Esdras Hartley; montaggio: Warren Low; interpreti e personaggi: Humphrey Bogart (Val Stevens), Margaret Lindsay (Lucille Gordon), Donald Woods (Eric Blake), E.E. Clive (Dr. Hardy), Paul Graetz (capitano Deever); produzione: Warner Bros.; origine: Stati Uniti; durata: 60’.
Aurora sul deserto (1937; Another Dawn)
Regia: William Dieterle; soggetto: Laird Doyle ispirato al racconto “The Ambassador’s Wife” di W. Somerset Maugham (non accreditato); sceneggiatura: Laird Doyle; fotografia: Tony Gaudio (b/n); musica: Erich Wolfgang Korngold; costumi: Orry-Kelly; scenografia: Robert M. Haas; montaggio: Ralph Dawson; interpreti e personaggi: Kay Francis (Julia Ashton Wister), Errol Flynn (capitano Denny Roark), Ian Hunter (colonnello John Wister), Frieda Inescort (Grace Roark), Herbert Mundin (Wilkins), Billy Bevan (soldato Hawkins); produzione: Warner Bros. Pictures Inc.; origine: Stati Uniti; durata: 73’.
Il vagabondo dell’isola (1938; Vessel of Wrath | The Beachcomber)
Regia: Erich Pommer; soggetto: racconto “Vessel of Wrath” (1931) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Bartlett Cormack, B. Van Thal (non accreditato); fotografia: Jules Kruger (b/n); musica: Richard Addinsell; arredamento: Thomas N. Morahan; montaggio: Robert Hamer, Jean Barker (non accreditato); interpreti e personaggi: Charles Laughton (Ginger ‘Ted’ Wilson), Elsa Lanchester (Martha Jones), Robert Newton (il controllore), Tyrone Guthrie (Dr. Owen Jones), Dolly Mollinger (Lia), D.A. Ward (Albert); produzione: Charles Laughton, Erich Pommer per Mayflower Pictures Corporation; origine: Gran Bretagna; durata: 92’.
Ombre malesi (1940; The Letter)
Regia: William Wyler; soggetto: racconto “La lettera” (1926; “The Letter”) e testo teatrale “La lettera” (1927; “The Letter”) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Howard Koch; fotografia: Tony Gaudio (b/n); musica: Max Steiner; costumi: Orry-Kelly; scenografia: Carl Jules Weyl; montaggio: George Amy, Warren Low; interpreti e personaggi: Bette Davis (Leslie Crosbie), Herbert Marshall (Robert Crosbie), James Stephenson (Howard Joyce), Frieda Inescort (Dorothy Joyce), Gale Sondergaard (signora Hammond); produzione: William Wyler per Warner Bros.; origine: Stati Uniti; durata: 95’.
La luna e sei soldi (1942; The Moon and Sixpence)
Regia: Albert Lewin; soggetto: romanzo omonimo (1919) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Albert Lewin; fotografia: John F. Seitz (b/n, c); musica: Dimitri Tiomkin; scenografia: Gordon Wiles; montaggio: Richard L. Van Enger; interpreti e personaggi: George Sanders (Charles Strickland), Herbert Marshall (Geoffrey Wolfe), Doris Dudley (Blanche Stroeve), Eric Blore (capitano Nichols), Albert Bassermann (Dr. Coutras); produzione: David L. Loew-Albert Lewin, in collaborazione con Stanley Kramer; origine: Stati Uniti; durata: 89’.
Vacanze a Natale (1944; Christmas Holiday)
Regia: Robert Siodmak; soggetto: romanzo omonimo (1939) di Somerset Maugham [W. Somerset Maugham]; sceneggiatura: Herman J. Mankiewicz; fotografia: Woody Bredell [Elwood Bredell] (b/n); musica: H.J. Salter [Hans J. Salter]; costumi: Vera West; scenografia: Robert Clatworthy, John B. Goodman; montaggio: Ted J. Kent; interpreti e personaggi: Deanna Durbin (Jackie Lamont/Abigail Martin), Gene Kelly (Robert Manette), Richard Whorf (Simon Fenimore), Dean Harens (tenente Charles Mason), Gladys George (Valerie De Merode); produzione: Felix Jackson, in collaborazione con Frank Shaw per Universal Pictures; origine: Stati Uniti; durata: 93’.
Un’ora prima dell’alba (1944; The Hour Before the Dawn)
Regia: Frank Tuttle; soggetto: romanzo “The Hour Before Dawn” (1942) di W. Somerset Maugham; adattamento: Lesser Samuels; sceneggiatura: Michael Hogan; fotografia: John F. Seitz (b/n); musica: Miklós Rózsa; scenografia: Hans Dreier, A. Earl Hedrick; montaggio: Stuart Gilmore; interpreti e personaggi: Franchot Tone (Jim Hetherton), Veronica Lake (Dora Bruckmann), John Sutton (Roger Hetherton), Binnie Barnes (May Heatherton), Henry Stephenson (generale Hetherton), W. Somerset Maugham (se stesso, non accreditato); produzione: Paramount Pictures; origine: Stati Uniti; durata: 75’.
Il filo del rasoio (1946; The Razor’s Edge)
Regia: Edmund Goulding; soggetto: romanzo omonimo (1944) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Lamar Trotti, Darryl F. Zanuck (non accreditato, scene addizionali); fotografia: Arthur C. Miller (b/n); musica: Alfred Newman; costumi: Charles LeMaire [Charles Le Maire], Oleg Cassini (per Gene Tierney); scenografia: Richard Day, Nathan Juran; montaggio: J. Watson Webb Jr.; interpreti e personaggi: Tyrone Power (Larry Darrell), Gene Tierney (Isabel Bradley), John Payne (Gray Maturin), Anne Baxter (Sophie MacDonald), Clifton Webb (Elliott Templeton), Herbert Marshall (W. Somerset Maugham); produzione: Darryl F. Zanuck per Twentieth Century Fox Film Corporation; origine: Stati Uniti; durata: 145’.
Schiavo d’amore (1946; Of Human Bondage)
Regia: Edmund Goulding; soggetto: romanzo omonimo (1915) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Catherine Turney; fotografia: J. Peverell Marley (b/n); musica: Erich Wolfgang Korngold; costumi: Milo Anderson; scenografia: Harry Kelso, Hugh Reticker, Max Parker (supervisione non accreditata); montaggio: Clarence Kolster; interpreti e personaggi: Paul Henreid (Philip Carey), Eleanor Parker (Mildred Rogers), Alexis Smith (Nora Nesbitt), Edmund Gwenn (Athelny), Patric Knowles (Harry Griffiths), Janis Paige (Sally Athelny); produzione: Henry Blanke per Warner Bros.; origine: Stati Uniti; durata: 105’.
Dirty Gertie from Harlem U.S.A. (1946)
Regia: Spencer Williams; soggetto: racconto “Miss Thompson” (1921, poi diventato “Rain”, tr. it. “Pioggia”) di W. Somerset Maugham (non accreditato); sceneggiatura: True T. Thompson; fotografia: John L. Herman (b/n); scenografia: Ted Soloman; interpreti e personaggi: Francine Everett (Gertie La Rue), Don Wilson (Diamond Joe), Katherine Moore (Stella Van Johnson), Alfred Hawkins (Jonathan Christian), David Boykin (Ezra Crumm); produzione: Bert Goldberg per Sack Amusement Enterprises; origine: Stati Uniti; durata: 65’.
Le donne erano sole (1947; The Unfaithful)
Regia: Vincent Sherman; soggetto: racconto “La lettera” (1926; “The Letter”) di W. Somerset Maugham (non accreditato); sceneggiatura: David Goodis, James Gunn; fotografia: Ernest Haller (b/n); musica: Max Steiner; costumi: Travilla; scenografia: Leo K. Kuter; montaggio: Alan Crosland Jr.; interpreti e personaggi: Ann Sheridan (Chris Hunter), Lew Ayres (Larry Hannaford), Zachary Scott (Bob Hunter), Eve Arden (Paula), Steven Geray (Martin Barrow), John Hoyt (detective Reynolds); produzione: Jerry Wald per Warner Bros.; origine: Stati Uniti; durata: 109’.
Passioni (1948; Quartet)
Regia: Ken Annakin (“La moglie del colonnello” / “The Colonel’s Lady”), Arthur Crabtree (“L’aquilone” / “The Kite”), Harold French (“Il seme alieno” / “The Alien Corn”), Ralph Smart (“I fatti della vita” / “The Facts of Life”); soggetto: racconti “The Facts of Life” (1939), “The Kite” (1931), “The Alien Corn” (1931) e “The Colonel’s Lady” (1946) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: R.C. Sherriff; fotografia: Ray Elton, Reginald H. Wyer (“La moglie del colonnello”) (b/n); musica: John Greenwood; costumi: Julie Harris; scenografia: Norman G. Arnold, Cedric Dawe, George Provis; montaggio: Jean Barker, A. Charles Knott; interpreti e personaggi: W. Somerset Maugham (se stesso, presentatore), Cecil Parker (Colonel Peregrine – “La moglie del colonnello”), Nora Swinburne (signora Peregrine – “La moglie del colonnello”), J.H. Roberts (West – “La moglie del colonnello”), George Cole (Herbert Sunbury – “L’aquilone”), David Cole (Herbert Sunbury bambino – “L’aquilone”), Hermione Baddeley (Beatrice Sunbury – “L’aquilone”), Dirk Bogarde (George Bland – “Il seme alieno”), Raymond Lovell (Sir Frederick Bland – “Il seme alieno”), Irene Browne (Lady Bland – “Il seme alieno”), Basil Radford (Henry Garnet – “I fatti della vita”), Naunton Wayne (Leslie – “I fatti della vita”), Ian Fleming (Ralph – “I fatti della vita”); produzione: Antony Darnborough per Gainsborough Pictures; origine: Gran Bretagna; durata: 120’.
Trio (1950)
Regia: Ken Annakin (“Mister Know-All”, “The Verger”), Harold French (“Sanatorium”); soggetto: racconti “Mr Know-All” (1924), “The Man Who Made His Mark” (1929, poi diventato “The Verger”) e “The Sanatorium” (1938) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Noel Langley, W. Somerset Maugham, R.C. Sherriff; fotografia: Geoffrey Unsworth, Reginald H. Wyer (b/n); musica: John Greenwood; costumi: Julie Harris; scenografia: Maurice Carter; montaggio: Alfred Roome; interpreti e personaggi: James Hayter (Albert Foreman – “The Verger”), Kathleen Harrison (Emma Brown Foreman – “The Verger”), Anne Crawford (Mrs. Ramsey – “Mister Know-All”), Nigel Patrick (Max Kelada – “Mister Know-All”), Jean Simmons (Evie Bishop – “Sanatorium”), Michael Rennie (maggiore Templeton – “Sanatorium”), W. Somerset Maugham (se stesso, presentatore); produzione: Antony Darnborough per Gainsborough Pictures, The Rank Organisation; origine: Gran Bretagna; durata: 91’.
Gigolò e gigolette (1951; Encore)
Regia: Harold French (“Gigolo and Gigolette” / “Gigolò e gigolette”), Pat Jackson (“The Ant and the Grasshopper” / “La cicala e la formica”), Anthony Pelissier (“Winter Cruise” / “Crociera d’inverno”); soggetto: racconti “Gigolo and Gigolette” (1935), “The Ant and the Grasshopper” (1924) e “The Captain and Miss Reid” (1943, poi diventato “Winter Cruise”); sceneggiatura: Eric Ambler (“Gigolo and Gigolette” / “Gigolò e gigolette”), T.E.B. Clarke (“The Ant and the Grasshopper” / “La cicala e la formica”), Arthur Macrae (“Winter Cruise” / “Crociera d’inverno”); fotografia: Desmond Dickinson (b/n); musica: Richard Addinsell; costumi: Julie Harris; scenografia: Maurice Carter; montaggio: Alfred Roome; interpreti e personaggi: Glynis Johns (Stella Cotman – “Gigolò e gigolette”), Terence Morgan (Syd Cotman – “Gigolò e gigolette”), David Hutcheson (Sandy Wescott – “Gigolò e gigolette”), Nigel Patrick (Tom Ramsay – “La cicala e la formica”), Roland Culver (George Ramsay – “La cicala e la formica”), Alison Leggatt (Freda Ramsay – “La cicala e la formica”), Kay Walsh (Molly Reid – “Crociera d’inverno”), Noel Purcell (Tom, il capitano – “Crociera d’inverno”), Ronald Squire (il dottore – “Crociera d’inverno”), W. Somerset Maugham (il narratore); produzione: Antony Darnborough per Two Cities Films; origine: Gran Bretagna; durata: 89’.
Pioggia (1953; Miss Sadie Thompson)
Regia: Curtis Bernhardt; soggetto: ispirato al racconto “Miss Thompson” (1921, poi diventato “Rain”, tr. it. “Pioggia”) di W. Somerset Maugham (non accreditato); sceneggiatura: Harry Kleiner; fotografia: Charles Lawton Jr. (Technicolor); costumi: Jean Louis; scenografia: Carl Anderson; montaggio: Viola Lawrence; interpreti e personaggi: Rita Hayworth (Sadie Thompson), José Ferrer (Alfred Davidson), Aldo Ray (sergente Phil O’Hara), Russell Collins (Dr. Robert MacPhail), Diosa Costello (Ameena Horn); produzione: Jerry Wald (non accreditato) per Columbia Pictures Corporation, The Beckworth Corporation; origine: Stati Uniti; durata: 91’.
Il grande flagello (1954; The Beachcomber)
Regia: Muriel Box; soggetto: racconto “Vessel of Wrath” (1931) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Sydney Box; fotografia: Reginald Wyer [Reginald H. Wyer] (Technicolor); musica: Francis Chagrin; costumi: Dorothy Sinclair; scenografia: George Provis; montaggio: Jean Barker; interpreti e personaggi: Glynis Johns (Martha Jones), Robert Newton (Edward Wilson), Donald Sinden (Ewart Gray), Paul Rogers (Reverendo Owen Jones), Donald Pleasence (Tromp); produzione: Sydney Box, William MacQuitty per London Independent Producers; origine: Gran Bretagna; durata: 82’.
Tre casi di assassinio (1955; Three Cases of Murder) – Ep. Lord Mountdrago
Regia: George More O’Ferrall, Orson Welles (non accreditato); soggetto: racconto “Doctor and Patient” (1939, poi diventato “Lord Mountdrago”) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Ian Dalrymple; fotografia: Georges Périnal (b/n); musica: Doreen Carwithen; scenografia: Paul Sheriff; montaggio: Gerald Turney-Smith; interpreti e personaggi: Orson Welles (Lord Mountdrago), Alan Badel (Owen), André Morell (Dr. Audlin), Helen Cherry (Lady Mountdrago); produzione: Ian Dalrymple, Alexander Paal, Hugh Perceval per Wessex Film Productions; origine: Gran Bretagna; durata: 99’.
Il settimo peccato (1957; The Seventh Sin)
Regia: Ronald Neame, Vincente Minnelli (non accreditato); soggetto: romanzo “Il velo dipinto” (1925; “The Painted Veil”) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Karl Tunberg; fotografia: Ray June (b/n); musica: Miklós Rózsa; costumi: Helen Rose (per Eleanor Parker); scenografia: Daniel B. Cathcart, William A. Horning; montaggio: Gene Ruggiero; interpreti e personaggi: Eleanor Parker (Carol Carwin), Bill Travers (dottor Walter Carwin), George Sanders (Tim Waddington), Jean-Pierre Aumont (Paul Duvelle), Françoise Rosay (madre superiora), Ellen Corby (sorella Saint Joseph); produzione: David Lewis per Metro-Goldwyn-Mayer (MGM); origine: Stati Uniti; durata: 94’.
Giulia tu sei meravigliosa (1962; Julia, du bist zauberhaft aka Adorable Julia)
Regia: Alfred Weidenmann; soggetto: romanzo “La diva Julia” (1937; “Theatre”) di W. Somerset Maugham e commedia teatrale “Adorable Julia” (1954) di Guy Bolton e Marc-Gilbert Sauvajon; sceneggiatura: Pascal Jardin, Eberhard Keindorff, Johanna Sibelius; fotografia: Werner Krien (b/n); musica: Rolf A. Wilhelm; costumi: Pierre Balmain, Margarethe Volters; scenografia: Leo Metzenbauer; montaggio: Renate Jelinek; interpreti e personaggi: Lilli Palmer (Julia Lambert), Charles Boyer (Michael Grosselyn), Jean Sorel (Tom Fennel), Jeanne Valérie (Avice Crichton), Ljuba Welitsch (Dolly de Fries), Tilly Lauenstein (Evie); produzione: Alfred Stöger per Production de l’Etoile, Wiener Mundus-Film; origine: Austria/Francia; durata: 97’.
Schiavo d’amore (1964; Of Human Bondage)
Regia: Kenneth Hughes [Ken Hughes], Henry Hathaway (scene addizionali); soggetto: romanzo omonimo (1915) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Bryan Forbes; fotografia: Denys N. Coop, Oswald Morris (b/n); musica: Ron Goodwin; costumi: Beatrice Dawson; scenografia: John Box; montaggio: Russell Lloyd; interpreti e personaggi: Kim Novak (Mildred Rogers), Laurence Harvey (Philip Carey), Robert Morley (dottor Jacobs), Siobhan McKenna (Nora Nesbitt), Roger Livesey (Thorpe Athelny); produzione: James Woolf per Metro-Goldwyn-Mayer British Studios, Seven Arts Pictures; origine: Gran Bretagna; durata: 100’.
Teatris (1978)
Regia: Janis Streics; soggetto: romanzo “La diva Julia” (1937; “Theatre”) di W. Somerset Maugham; adattamento: Janis Streics; fotografia: Harijs Kukels (col.); interpreti e personaggi: Vija Artmane (Julia Lambert), Ivar Kalnynsh [Ivars Kalnins] (Tom Fennel), Gunars Cilinskis (Michael Gosselin, marito di Julia), Peteris Gaudins (Roger, figlio di Julia), Elza Radzina (Dolly); origine: Unione Sovietica; durata: 136’.
Sadie (1980) [film hard]
Regia: Bob Chinn; soggetto: liberamente ispirato al racconto “Miss Thompson” (1921, poi diventato “Rain”, tr. it. “Pioggia”) di W. Somerset Maugham (non accreditato); sceneggiatura: Louise Cashman (supervisione), Marion Cronin (supervisione); fotografia: Ken Gibb (col.); musica: Gary Eberhart; costumi: Debbie Shine; montaggio: Lew Guinn, Ron Sexton; interpreti e personaggi: Cris Cassidy [Chris Cassidy] (Sadie), Jerome Deeds (Jock), Gary Dana [Gary Eberhart] (Bear), Deborah Sullavan (signora Daniels), Diahna Holt [Diana Holt] (Honoré), Joseph Darling (senatore Daniels); produzione: Larry Price per Mitam Productions; origine: Stati Uniti; durata: 74’.
Poniro thilyko… katergara gynaika! (1980)
Regia: Kostas Karagiannis; soggetto: ispirato al romanzo “La diva Julia” (1937; “Theatre”) di W. Somerset Maugham (non accreditato); sceneggiatura: Kostas Karagiannis; fotografia: Aris Stavrou (col.); musica: Giorgos Katsaros; interpreti e personaggi: Aliki Vougiouklaki (Elena Davari), Angelos Antonopoulos (Alexis Alexandrou), Haritini Karolou (Monika), Danis Katranidis (Takis Libas), Kaiti Lambropoulou (Ketty), Kostas Rigopoulos (Andreas); produzione: Karagiannis-Karatzopoulos; origine: Grecia; durata: 102’.
Il filo del rasoio (1984; The Razor’s Edge)
Regia: John Byrum; soggetto: romanzo omonimo (1944) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: John Byrum, Bill Murray; fotografia: Peter Hannan (Rankcolor); musica: Jack Nitzsche; costumi: Shirley Russell; scenografia: Philip Harrison; montaggio: Peter Boyle; interpreti e personaggi: Bill Murray (Larry Darrell), Theresa Russell (Sophie MacDonald), Catherine Hicks (Isabel Bradley), Denholm Elliott (Elliott Templeton), James Keach(Gray Maturin), Peter Vaughan (Mackenzie); produzione: Harry Benn, Robert P. Marcucci, Jason Laskay per Columbia Pictures Corporation, Colgems Productions Ltd., Marcucci-Cohen-Benn Production; origine: Stati Uniti/Gran Bretagna; durata: 128’.
Overnight Sensation (1984; cortometraggio)
Regia: Jon Bloom; soggetto: racconto “The Colonel’s Lady” (1946) di W. Somerset Maugham (non accreditato); sceneggiatura: Craig Buck; fotografia: col.; interpreti e personaggi: Louise Fletcher (Eve Peregrine – ‘E.K. Hamilton’), Robert Loggia (George Peregrine), Shari Belafonte-Harper [Shari Belafonte] (Daphne); produzione: Jon Bloom; origine: Stati Uniti; durata: 28’.
Mutamenti del destino (1987 Peremena uchasti)
Regia: Kira Muratova; soggetto: racconto omonimo (1926; tr. it. “La lettera”) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Kira Muratova; fotografia: Valeri Myulgaut (col.); scenografia: Oleg Ivanov, Umirzak Shmanov; interpreti e personaggi: Natalya Leble (Maria), Yuri Shlykov (l’avvocato), Vladimir Karasyov (Filippo, il marito di Maria), Leonid Kudryashov (Aleksandr, l’amante di Maria); produzione: Odessa Film Studios; origine: Unione Sovietica; durata: 109’.
Una notte per decidere (2000, Up at the Villa)
Regia: Philip Haas; soggetto: romanzo “In villa” (1941; “In villa” [“Up at the Villa”]) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Belinda Haas; fotografia: Maurizio Calvesi (Technicolor); musica: Pino Donaggio; costumi: Paul Brown; scenografia: Paul Brown; montaggio: Belinda Haas; interpreti e personaggi: Kristin Scott Thomas (Mary Panton), Sean Penn (Rowley Flint), Anne Bancroft (Principessa San Ferdinando), James Fox (Sir Edgar Swift), Jeremy Davies (Karl Richter), Derek Jacobi (Lucky Leadbetter); produzione: Geoff Stier, David Brown, Guido Cerasuolo, Davien Littlefield per October Films, Intermedia Films, Mirage Entertainment; origine: Gran Bretagna/Stati Uniti; durata: 115’.
La diva Julia (2004; Being Julia)
Regia: István Szabó; soggetto: romanzo “La diva Julia” (1937; “Theatre”) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Ronald Harwood; fotografia: Lajos Koltai (DeLuxe); musica: Mychael Danna; costumi: John Bloomfield; scenografia: Luciana Arrighi; montaggio: Susan Shipton; interpreti e personaggi: Michael Gambon (Jimmie Langton), Annette Bening (Julia Lambert), Leigh Lawson (Archie Dexter), Shaun Evans (Tom Fennel), Jeremy Irons (Michael Gosselyn), Juliet Stevenson (Evie); produzione: Robert Lantos, Sandra Cunningham, Mark Musselman, Julia Rosenberg per Serendipity Point Films, First Choice Films, Hogarth Productions, Myriad Pictures; origine: Canada/Stati Uniti/Ungheria/Gran Bretagna; durata: 104’.
Il velo dipinto (2006; The Painted Veil)
Regia: John Curran; soggetto: romanzo omonimo (1925) di W. Somerset Maugham; sceneggiatura: Ron Nyswaner; fotografia: Stuart Dryburgh (col.); musica: Alexandre Desplat; costumi: Ruth Myers; scenografia: Juhua Tu; montaggio: Alexandre de Franceschi; interpreti e personaggi: Naomi Watts (Kitty Fane), Edward Norton (Walter Fane), Liev Schreiber (Charlie Townsend), Diana Rigg (madre Superiora), Toby Jones (Waddington), Lu Yan (Wan Xi); produzione: Sara Colleton, Jean-François Fonlupt, Edward Norton, Naomi Watts, Bob Yari, Antonia Barnard, Yasmine Golchan, Ming Beaver Kwei per WIP, Stratus Film Co., Bob Yari Productions, Class 5 Films, The Colleton Company, Dragon Studios, Emotion Pictures, The Mark Gordon Company, Warner China Film HG Corporation; origine: Cina/Stati Uniti/Canada; durata: 125’.
W. Somerset Maugham’s the Bum (2014; cortometraggio)
Regia: Travis Mills, soggetto: racconto “A Derelict” (1929, poi diventato “The Bum”); adattamento: Travis Mills; fotografia: Michael Coleman [Michael G. Coleman] (b/n & col.); montaggio: Rolo Tomassi; interpreti e personaggi: Eric Almassy, Tenley Dene, Rohan Shetty, David Wellnitz, Steve Wilson; produzione: Travis Mills, Larry Fleming, Barbara A. Gresser per Running Wild Films, in associazione con 5J Media; origine: Stati Uniti; durata: 8’.
TRE FILM TEATRALI DI DANIELE SEGRE
di Tullio Masoni
Fra i cineasti indipendenti italiani Daniele Segre occupa un posto speciale e, per molti aspetti, unico. La sua esperienza, ormai lunghissima, ha dato forma a una vocazione politica e a uno stile che per anni, con caparbietà e sottile umanismo, ha privilegiato l’uso del “primo piano” inteso come costante, scambio, contrappunto e, in ultima istanza, “paradossale” variazione. Se infatti l’apparenza suggerirebbe una replica, il mutare dei volti, delle voci, e l’evocativa testimonianza che ciascun soggetto porta in relazione all’argomento, aiuta ad attribuire una personalità insostituibile al soggetto stesso; tanto che ogni volta, cioè a ogni cambiamento di tema, ci si accorge di uno “scavo” che solo il mezzo filmico, come tale, rende possibile.
Muovendo dalla fedeltà col rapporto che ciascuno dialogicamente compie nel vivere quotidiano, l’occhio della camera, poi l’inquadratura, possono andare oltre, ossia scoprire quel che sarebbe rimasto in ombra o impedito dalle circostanze volubili o dall’emotività. Un antico paradosso del cinema trova così applicazione nel lavoro di Segre: l’iperrealtà cui conduce la verosimiglianza del cinema è al tempo stesso svelamento dell’invisibile. Come l’occhio umano non può ingigantire il dettaglio che invece il cinema porta a tutto schermo, così il primo piano (e il controcampo) della relazione “naturale” non avrà mai la forza analitica di quello composto nell’inquadratura. Ma entrambi, ciascuno a suo modo e con ambiguità diverse, sono reali.
Spinto dalla propria sensibilità sociale Segre ha interrogato “agonisticamente” una quantità di persone e situazioni; vorrei dire che, in ciò paragonabile a un maestro come Chris Marker, è arrivato dove altri non potevano o non volevano arrivare: ai minatori del Sulcis in Sardegna, alle comunità di recupero (e riscatto), ai lavoratori della Fiat impegnati nel referendum sulla linea Marchionne, ai tossicodipendenti, ai tifosi degli stadi, ai travestiti, ai giovani marginali…Ma, al tempo stesso, ha lasciato aperte vie creative altre: qualche film a soggetto come “Testa dura”, “Vite di ballatoio”, “Una serata in casa” o “Manila paloma bianca” e, più recentemente, i tre film “teatrali” di cui, in sintesi, tratto di seguito.
“Morituri” esce nel 2015, del 2004 è “Mitraglia e il Verme”, e del 2002 “Vecchie”. Tre film immediatamente adattabili al palcoscenico. “Vecchie”, infatti, fu a suo tempo messo in scena per iniziativa di Cristina Pezzoli, direttrice artistica dell’Associazione Teatrale Pistoiese e anche “Morituri” ha già avuto una prova di teatro. D’altra parte attori non cinematografici sono tutti i protagonisti dei film, a cominciare proprio da “Vecchie” del quale Barbara Valmorin e Maria Grazia Grassini sono coautrici letterarie.
“Vecchie” è basato sulla continuità temporale e si svolge in un unico spazio sospeso, rarefatto. Due donne sui sessant’anni, Agata e Letizia, stanno trascorrendo una vacanza in un luogo imprecisato dell’Italia centro-meridionale. Però non lasciano mai il soggiorno; indossano la camicia da notte, e ogni volta che dovrebbero prepararsi e uscire trovano una scusa per cambiare discorso e rimanere nell’appartamento.
Segre fa notare come le tonalità e i colori abbiano una funzione primaria: il bianco serve a sospendere l’atmosfera e alludere alla luce estiva; il nero a delimitare i corpi e creare inquietudine. Corpi che talvolta tendono a sparire e, quindi, a porre domande sull’identità.
“Mitraglia e il Verme” è composto da tre scene: due giornate più un sogno, e tre stacchi di montaggio sui piani sequenza. Sceneggiato dal regista insieme ad Antonello Fassari, Stefano Corsi e Antonio Manca, è ambientato nei bagni pubblici dei Mercati Generali a Roma, dove il Verme lavora come custode. Poi c’è Mitraglia, che sfrutta il vizio del Verme per il gioco e le corse dei cavalli facendo l’usuraio. Il Verme teme di perdere il lavoro nell’eventualità che al suo posto sia adottata una porta a gettone; Mitraglia, è a sua volta indebitato con Bruto e subisce pressioni dal corrotto direttore dei Mercati Generali.
Questa vicenda di avidità oppressiva, sottomissione, vizio e raggiro, che si concluderà tragicamente, prende forma in un unico locale e, ripresa con la camera fissa restituisce un bianco e nero “decolorato”; il film è girato a colori, poi sottoposto a un trattamento che traduce i colori stessi in un bianco e nero inusuale, “espressionistico”.
Sembra legittimo – come anche per “Vecchie” (che risente di una certa tensione buñueliana) e poi per “Morituri”, richiamare il “teatro dell’assurdo”, cioè autori quali Ionesco e Beckett.
“Morituri” affida alla camera fissa l’inquadratura di un interno cimiteriale: tre pareti di loculi e lumini la cui luce cambia, quasi impercettibile, di tanto in tanto. Anche la parete “virtuale”, cioè il lato da cui la camera riprende, è immaginariamente una superficie di loculi e verso questa (cioè “in macchina”) guardano Nora, Aurora e Olimpia per parlare fra loro e coi defunti. Nei caratteri generali affine agli altri due titoli – il testo è dello stesso Segre (con la collaborazione di Antonio Manca), che si dimostra capace di intendere efficacemente i tempi della scena fissa, in qualche modo già teatrali per concezione – Morituri accentua il disagio dello spettatore nei confronti della tragicommedia a cui assiste perché la “quarta parete” può far pensare, poco per volta, a uno specchio simile a quelli usati per spiare i sospetti nei commissariati di polizia. Lo spettatore “spia” e i personaggi – forse consapevoli e per questo indotti ad accentuare istrionicamente la recitazione – sembrano talvolta appiattirsi contro il vetro divisorio.
Immediatamente adattabili al palcoscenico, come si diceva, i tre film conservano la propria “natura” per la variazione di piani che la camera consente rispetto alla messa in scena cui, in teatro, il pubblico assiste dalla platea. E’ dunque utile ricordare che la traduzione per il palcoscenico – è il caso di “Vecchie”, che si è mosso da un progetto di continuità – ha comportato un diverso e specifico impiego delle luci, delle scenografie, dei costumi, e della misura spaziale.
Viene spontaneo parlare di Trilogia, ma sembra che Segre abbia già in progetto un nuovo film: ancora un interno, ancora la camera fissa e, forse, l’umorismo nero che ha dato carattere a “Morituri” più ancora che a “Mitraglia” e “Vecchie”.
L’aspetto peculiare di queste opere e di quelle che verranno, credo però vada individuato in una esigenza professionale e poetica di svolta o, se si preferisce, di “digressione”.
Per riprendere il discorso di apertura, Segre si è dedicato soprattutto, finora, ai tanti aspetti della realtà; ha cioè messo il proprio istinto, la propria sensibilità, e la propria coerenza artistica, a servizio di una sfaccettata e ricchissima fenomenologia sociale.
Sua è l’espressione: “cinema con la realtà” che, al di là dell’apparenza, differisce non poco da quel che figurerebbe il “cinema della realtà”. Quest’ultima formula tende infatti a comprendere in generale e fissare prima possibile, mentre la prima suggerisce una realtà del farsi, e dichiara un intervento permeabile e modificabile in corso d’opera.
Seguendo negli anni tale inclinazione, Segre non ha dato fondo a ciò che fondo non ha, ma ha visto emergere nuove possibilità espressive. “Vecchie”, “Mitraglia” e “Morituri” vanno allora considerati come prove e approfondimenti “in astrazione” nei quali l’autore mette alla prova le proprie facoltà creative più intime e segrete ma, nel riflesso di finzione, non meno incisive socialmente.
Intendo dire che Segre, oltre che con i personaggi di volta in volta cercati e scoperti, ha sempre dialogato con se stesso; l’astrazione sulla quale vorrebbe ancora esercitarsi e sperimentare, gli permette di sondare altri valori poetici. E di confrontarli al medesimo tempo, dicevo, con “antiche” e solide scelte di stile.
.
SERIE TV E CINEMA: UNA STORIA (ARTISTICA) POSSIBILE (?)
di Davide Parpinel
Ciò che accomuna il cinema e le serie televisive è il racconto di una narrazione visiva. Ciò che le differenzia primariamente è la durata. Un film di un qualunque genere solitamente non supera i 120 minuti, mentre una serie tv racconta una storia che si sviluppa in stagioni, suddivise a loro volta in puntate di circa 60 minuti.
Questa è la differenza fondamentale, più immediata. Si possono individuare altre disuguaglianze tra questi mezzi espressivi oppure serie tv e cinema possono essere considerati due media visivi molto simili?
Un film, sempre in linea generale, è un unico racconto continuo, strutturato in questo modo: all’inizio è presentata una situazione che successivamente si evolve, fino ad arrivare al momento di rottura nella parte centrale, per infine giungere alla svolta nella conclusione.
Le serie tv presentano un’organizzazione narrativa e temporale più diversificata. Si possono, innanzitutto, suddividere in serie serializzate, miniserie e film per la tv, come distingue Giorgia Iovane nel libro “Fiction televisiva”, Carocci, 2009.
Con il primo termine si possono identificare quelle produzioni seriali in cui la storia si articola allo stesso modo in ogni puntata. Questa è autonoma rispetto alla linea narrativa generale dell’intera serie, in quanto ha un proprio inizio e una conclusione articolate nei tempi della puntata. Si possono identificare in un tale modello “C.S.I.” (2000-2015), prodotta dalla CBS, E.R. (1994-2009), prodotta da NBC e Warner Bros., Dr House- Medical Division (2004-2012), prodotta da Heel & Toe Fulms, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions. In questi casi inoltre, come nelle maggior parte delle serie serializzate la modalità di narrazione, la tecnica registica e la caratterizzazione dei personaggi è già definita nella sceneggiatura. Un tale modello espressivo pre-determinato permette la loro durata per molte stagioni.
Le miniserie, invece, sono più ridotte nel numero delle stagioni, solitamente due o tre, e la storia è unica a stagione: prende avvio alla prima puntata per concludersi nell’ultima, proponendo diversi elementi linguistici e narrativi, spesso definiti già nella sceneggiatura e in parte determinati anche dal regista, in grado di attrarre l’attenzione del pubblico. Le miniserie potrebbero essere definite come film lunghi più ore. Esempi sono “True Detective” (2014-), prodotta dalla HBO, Fargo (2014-), prodotta da MGM Television e FX Productions, The Knick (2014-), prodotta da Anonymous Content, House of Cards (2013-) prodotta da Media Rights Capital, Panic Pictures, Trigger Street Productions, Boardwalk Empire (2010-2014) prodotta da HBO.
“Breaking Bad” (2008-2013), prodotta da High Bridge Production, Gran Via Production, Sony Pictures Television e Lost (2004-2010), prodotta da Bad Robot, Touchstone Television, ABC Studios sono anch’esse miniserie, seppur durino entrambe sei stagioni.
I film per la tv, infine, presentano un’unica storia che a livello di tempo è più lunga di un film, ma non così tanto da rientrare nella categoria di una miniserie. Queste sono, perciò destinate alla televisione che permette una suddivisione in due puntate. Sono film un po’ più lunghi del prestabilito.
Ciò che si evince da questa differenziazione è che il tempo è la discriminante principale tra serie tv e cinema. Se un film durasse per più ore, suddivise in più momenti di visione, non sarebbe tale, bensì la narrazione si connoterebbe per essere seriale. Eppure nonostante il fattore temporale separi così nettamente questi due sistemi di visione, gli elementi linguistici che li compongono appaiono molto simili, comuni, i medesimi.
Si può riflettere a riguardo analizzando innanzitutto la caratterizzazione dei personaggi.
Una delle peculiarità di una pellicola è il rapporto empatico che si stabilisce tra i protagonisti e il pubblico. Chi osserva solitamente stabilisce una comunanza emotiva e caratteriale con i vari personaggi così da immergersi nella storia e capirne il significato. Tra i fattori linguistici che intervengono alla creazione di questa relazione si possono menzionare la tecnica registica, la struttura della narrazione, la musica, l’impianto scenico.
Per quanto riguarda le serie tv, sempre mantenendo valida la differenziazione narrativa-temporale sopra indicata, e più, quindi, nello specifico delle serie serializzate i protagonisti mantengono le medesime sfumature caratteriali in ogni puntata, così da essere immediatamente riconoscibili e identificabili da parte del pubblico. É possibile, inoltre, che un aspetto, un episodio della storia di uno dei personaggi possa evolversi per più puntate. Ciò accade per fornire una più precisa definizione al personaggio, conferirgli maggiore veridicità, pur rimanendo prestabilite le sue caratteristiche.
Nelle miniserie si assiste, al contrario, a un’evoluzione continua soprattutto dei personaggi principali. Nella prima stagione di “Fargo” Lester Nygaard, interpretato da Martin Freeman, si presenta come un sottomesso dalla famiglia e dalla società; un frustrato destinato a subire. Trova nella violenza, nell’inganno, nel sopruso la possibilità di redenzione, la sua catarsi, per affermare così, la sua vita. Allo stesso modo Walt, Bryan Cranstom, in “Breaking Bad” subisce la medesima evoluzione caratteriale: da sottomesso diviene nell’arco delle stagioni un brillante produttore di droga. Ciò che differenzia Lester e Walt è come avviene la loro evoluzione e, anche in questo caso, il tempo di svolgimento. Se Walt, quindi, utilizza l’ingegno, la sua intelligenza, la sua conoscenza della chimica, per affermarsi come mente criminale e così accrescere il suo potere sociale e familiare ed è da solo nel fare tutto ciò, Lester non ha la stessa brillantezza e cerca, pertanto, nell’inganno spiccio, nel raggiro, nella confusione e soprattutto nell’appoggio del sicario Lorne Malvo, interpretato da Billy Bob Thornton, di mantenersi a galla e non permettere di essere scoperto dall’astuzia e dalla bravura dell’agente Molly Solverson, interpretata da Allison Tolman.
Come detto, però, è anche una questione di tempo. L’evoluzione caratteriale di Walt in “Breaking Bad” si articola lungo tutte le sei stagioni. Le sue scelte come padre e come produttore di droga tengono vivo l’interesse di chi guarda nei confronti del personaggio. In “Fargo”, al contrario, il percorso nel male e nella redenzione di Lester si articola in una sola stagione, in otto puntate. In un tempo più breve il pubblico comprende e riflette sugli elementi evolutivi del personaggio, così da rimanerne più immediatamente coinvolto.
Come si può notare la caratterizzazione di un personaggio in una miniserie è molto simile a quella di un film in quanto la narrazione è più unita, intessuta al personaggio, tanto che il suo processo di maturazione, composto da situazione iniziale, evoluzione, crollo e situazione finale, è strettamente connesso al modificarsi della storia.
É una simbiosi cinematografica che avviene, proprio come in una pellicola anche grazie alla definizione dell’atmosfera narrativa.
Cary Joji Fukunaga, regista cinematografico che ha diretto interamente la prima stagione di “True Detective” è riuscito a fare del contesto, dell’aria che avvolge la storia, l’elemento di definizione primario della sua regia.
Le prime inquadrature di un suo film, “Sin Nombre” (2009), “Jane Eyre” (2011), “Beasts of no nation” (2015), o di “True Detective” (2014), infatti, focalizzano il luogo dell’azione, per permettere così al pubblico di chiarire le coordinate spaziali di narrazione, le caratteristiche fisiche e sensoriali del tessuto che circonda i personaggi. Questi contesti di Fukunaga sono quasi sempre di emarginazione, lontani dalla società civile, di luoghi che poco accettano la natura umana. L’aria che tira, di conseguenza, è pesante, opprimente, angosciante, quasi lugubre e malsana. Da qui prende avvio la storia.
Nello specifico di “True Detective” la narrazione si basa sull’indagine dei detective Rust Cohle, Matthew McConaughey, e Marty Hart, Woody Harrelson, su un caso di un omicidio di una ragazza. L’indagine si svolge in una lenta e pericolosa scoperta della Louisiana connotata da tinte scure, marce e macabre. La svolta avviene alla quarta puntata quando l’astuzia del detective Cohle e la sua capacità di ragionare come un criminale conducono i due protagonisti nelle puntata successiva a catturare e uccidere un pericoloso malvivente implicato nell’omicidio della ragazza. La missione narrativa di Fukunaga e dello sceneggiatore Nick Pizzolatto è, però, di proseguire l’indagine e scavare ancora più a fondo nelle viscere del contesto di decadenza. Il tempo della narrazione si sposta, quindi, dal passato della prima parte, al presente della storia nella seconda. Qui al termine delle otto puntate la situazione iniziale trova finalmente la sua spiegazione e l’evoluzione narrativa si completa. Per rendere questo intreccio narrativo credibile e vero agli occhi di chi osserva Fukunaga sviluppa le evoluzioni di contesto, atmosfera e personaggi unitamente, parallele, così da rendere la prima stagione di True Detective simile alla narrazione di un film. Ad avvalorare questa tesi è il fatto che solitamente le serie tv nascono da un lavoro di sceneggiatura preciso ed accurato che definisce anche lo stile della regia. Fukunaga, invece, come ha dichiarato lui stesso nell’articolo “How we got the shot: Cary Fukunaga on True Detective’s tracking shot” pubblicato su The Guardian il 17 marzo 2014 ha avuto la possibilità di sperimentare linguisticamente la sua regia, pur mantenendo l’unita della sceneggiatura. Il regista, infatti, ha proposto piani sequenza, movimenti di macchina avvolgenti sui personaggi, studio delle loro psicologie attraverso inquadrature particolari dei loro sguardi.
Il detective Rust Cohle (Matthew McConaughey) prende in ostaggio Ginger (Joseph Sikora) nella prima stagione di “True Detective” (2014)
Anche la serie tv “Fargo”, anch’essa miniserie, rappresenta un punto di contatto tra l’espressione seriale e quella cinematografica. L’elemento di congiunzione è il cinema stesso in quanto il progetto di Noah Hawley, sceneggiatore della maggior parte delle puntate, riprende la visione del film omonimo diretto de Ethan e Joel Coen del 1996. La storia in entrambi le formulazioni espressive tratta della riscossa di un personaggio ingenuo e poco furbo aiutato nel suo intento da figure losche, e allo stesso tempo braccato dall’astuzia, dall’intelligenza di un’agente di polizia a lui antagonista anche nei valori di vita. Questa contrapposizione si sviluppa in un clima congelato, anestetizzato da un inverno eterno, senza fine, gelido, rigido, implacabile. Tutto appare sommerso dalla neve che emargina dal mondo personaggi e luoghi, seppur ne siano citati i nomi. Il candore del colore bianco è, inoltre, sporcato dal sangue delle vittime delle violenza dei protagonisti che cercano di scappare al loro destino. La sceneggiatura di Hawley, quindi, si incardina sull’atmosfera di contrapposizione di vite e valori proposto dal film dei Coen e sull’idea di una giustizia che attanaglia chiunque, buoni o cattivi, esattamente come la neve.
La disuguaglianza tra le due narrazioni è individuabile nella finalità. Il film dei Coen è fantasticamente caustico e lucido, a tratti surreale e affascina l’essere estremamente fuori da ogni logica umana dei personaggi, soprattutto due sicari interpretati da Steve Buscemi e Peter Stormare. Questi sono due killer di professione, non ordinari, né convenzionali, ma buffi e folli. Lorne Malvo, interpretato da Billy Bob Thornton, il sicario della serie tv, invece, è un freddo calcolatore che non lascia scampo a nessuno. Sembra governato da una lucida e sana pazzia attraverso cui riesce sempre a farla franca. La sua astuzia si propone puntata dopo puntata, lasciando chi guarda nell’attesa di scoprire in che modo la sua “giustizia” possa ricadere sui diversi personaggi della serie.
Ciò che tiene viva l’attenzione del pubblico lungo le puntate di una miniserie oltre che la storia anche, quindi, il linguaggio della macchina da presa, la definizione del contesto e la fascinazione della narrazione per immagini. Questi elementi immergono il pubblico nel mondo visivo della serie.
Nella prima stagione di “Fargo” ciò che cattura l’attenzione di chi osserva è il contesto e i personaggi che nel loro sviluppo caratteriale portano la storia dalla situazione iniziale a quella finale. In “The Knick”, come in “Boardwalk Empire2, il legame è creato da elementi scenici come la scelta delle luci, delle scene, dei costumi, degli arredi oltre all’intreccio delle storie dei personaggi all’interno di un contesto storico di inizio Novecento in cui il malaffare e la criminalità governavano la società. Il malaffare, inoltre, è reso affascinante anche grazie alla macchina da presa del regista. La prima puntata della prima stagione di “Boardwalk Empire” è, infatti, diretta da Martin Scorsese, che risulta anche uno dei produttori esecutivi della serie. Il regista americano utilizza inquadrature dettagliate e movimenti di macchina che indagano la scena definendo le caratteristiche linguistiche delle puntate successive e quelle narrative di tutte le sei stagioni. Allo stesso modo Steven Soderbergh, regista unico di entrambe le stagioni di “The Knick”, organizza un impianto estetico composto da luci soffuse, abiti eleganti sporcati dal sangue delle operazioni e dei crimini e dalla definizione di una New York nella sua fase di transizione da città americana a capitale del mondo. Tutto questo tiene viva l’attenzione di chi osserva sul procedere della storia a cui concorre anche l’uso di una musica contemporanea di natura digitale, profonda e cupa, angosciante e sottile che sorprende perché in totale antitesi con la definizione temporale della scena.
L’elemento linguistico, infine, che lega le puntate della prima stagione di “True Detective” è, come detto, la macchina da presa di Fukunaga. Questa indaga la psicologia dei due detective protagonisti e spinge l’occhio dello spettatore dentro una realtà descritta accuratamente, precisa in ogni suo riferimento. Chi osserva percepisce ansia, timore, attesa, suspense. Ciò è aumentato dal fatto che Cohle e Hart sono gli unici protagonisti e quindi, il pubblico si concentra maggiormente su di loro, percependone direttamente il fiato sospeso, le preoccupazioni, i dubbi e le poche certezze anche grazie a una vocalità soprattutto del personaggio di Matthew McConaughey che è tagliente, rauca, polverosa e graffiante come l’atmosfera della serie.
Tutto ciò avviene anche perché in questa simbiosi il pubblico è portato, accompagnato dall’occhio di ripresa di Fukunaga.
Sembrerebbe, quindi, che le serie tv stiano diventando più cinematografiche, più attente a quegli aspetti caratterizzanti un film. A definire ciò, oltre agli elementi linguistici e narrativi, concorrono anche la maggiore definizione di un contesto reale, di storia vera, percepita da chi osserva, quindi, come vissuta.
La serie tv tedesca “Deutschland 83” (2015-) prodotta da RTL e Ufa Fiction racconta le strategie belligeranti tra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Federale Tedesca nei primi anni Ottanta. Il protagonista è il tenente Martin Rauch, interpretato da Jonas Nay militare della D.D.R. il quale sotto copertura si intrufola nella Germania Ovest per rubare informazioni e piani strategici. Per rendere veritiero il contesto della Guerra Fredda, le tensioni internazionali tra Stati Uniti e U.R.S.S. attraverso le relazioni tra le due Germania, la vita di due popoli posti in mezzo ai giochi internazionali, Anna Winger e Jorg Winger, creatori della serie, inframezzano la narrazione con spezzoni di telegiornali, registrazioni di discorsi pubblici dei leader politici, inquadrature dei titoli dei giornali, una colonna sonora che propone il meglio di quegli anni, oltre alla cura estetica della moda del tempo. Questi spunti narrativi e scelte linguistiche, mutuate anche in questo caso dal cinema, concorrono a inserire la serie tv in un contesto vero, esistito veramente, consolidato, quindi, nella memoria.
A volte è proprio la volontà di raccontare una storia passata a creare un collegamento con il presente reale di oggi. “The Knick” è ambientata a New York nei primi dieci anni del Novecento, Broadwalk Empire, invece, negli anni venti all’inizio del proibizionismo. Qui i dialoghi, le discussioni sui fatti di quel presente, i diversi modi di pensare, le contrapposizioni dialettiche sono il canale per comprendere come una tipologia di pensiero, riguardanti questioni sociali e politiche non si siano modificate nel corso degli anni.
Le serie tv, quindi, parlano di realtà e quindi affascinano di più.
Al cinema che rimane? Un insegnamento e la sperimentazione.
Il cinema per la sua capacità di riuscire a condensare nella visione tanti elementi visivi e percettivi in un tempo ristretto può ancora scoprire e condurre a sé linguaggi di espressione.
Ciò è chiarito dalle pellicole “Francofonia” di Alexsandr Sokurov e “Behemoth” di Zhao Liang.
Il primo film è un saggio di regia e narrazione di un maestro. Per parlare di un concetto, ossia quanto l’arte possa essere ancora oggi fonte di ispirazione e nutrimento per l’uomo, il regista russo prende spunto da un fatto reale, l’occupazione nazista del museo del Louvre durante la Seconda Guerra Mondiale, per lasciare andare parole e mente in interrogativi e considerazioni che si traslano sullo schermo in una macchina da presa che viaggia sopra l’uomo. Sokurov ha, quindi, un approccio quasi documentaristico. Non giudica, per invece proporre spunti di riflessione nati dalla fertile mente di un pensatore di oggi.
Il medesimo approccio lo propone Liang. Documenta e inquadra la vita di minatori, lavori sfruttati, operai di alcune zone della Cina più rurale con una definizione dell’immagine da video. La fotografia di Behemoth risalta i colori brillanti dello sviluppo tecnologico-economico-sociale di una Cina che lascia nell’oscurità del nero dei loro volti e mani i suoi cittadini.
Il cinema, pertanto, dimostra con questi due film di volersi contaminare visivamente e linguisticamente con altri mezzi espressivi riuscendo, comunque nell’intento di raccontare la realtà e il presente senza ripiegare su storie di finzione condite da sprazzi di verità, come le serie tv.
Eppure il cinema deve trarre spunto dal concetto di serialità. Fukunaga ne è un esempio. Le sue due regie prima di “True Detective” sono caratterizzate da una scarsa personalità che invece esplode in “Beasts of no nation”. Quest’ultimo film, infatti, porta sul grande schermo in particolare un elemento della serie tv ossia la ricerca infinita della violenza, della prevaricazione del più forte. Se in “True Detective” tutto questo apparato di brutalità si interrompe al termine dell’indagine, in “Beasts of no nation” sembra, al contrario, non avere fine attraverso gli occhi e la mente dubbiosa e corrotta di Agu, il giovane protagonista, interpretato da Abraham Attah.
In questo modo il cinema potrebbe riproporre all’interno delle sue coordinate temporali la durata temporale della serialità, senza la necessità di scandire le puntate. C’è anche da considerare, però, che il cinema di Wang Bing o di Lav Diaz o del thailandese Apichatpong Weerasethakul hanno già dimostrato, molto prima delle serie tv, come la dilatazione della narrazione, il liberarsi da un rigido schema narrativo possono essere elementi da sperimentare e rivoluzionare, pur mantenendo sempre viva la volontà di mostrare la vita vera.
Si può affermare, pertanto, che le frontiere del cinema sono ancora molto vaste e da indagare. Il cinema contenutisticamente non è in crisi. Subisce, però, la maggiore fascinazione del pubblico verso le serie tv, per la loro struttura a puntate e per la comodità di poterle visionare da casa, sulla tv o sul web, a prezzi più contenuti delle sale cinematografiche.
Al momento, infine, non si può trovare una convergenza artistica netta tra serie tv e cinema in quanto sono più le prime che guardano al cinema e alle sue ricerche linguistiche e visive. Si può affermare, contestualmente, che il cinema riflette e attende di capire come poter inserire tra i suoi generi le serie tv o se poterle utilizzare come una palestra di ampliamento e consolidamento della poetica di un regista, come è stato per Fukunaga, per la sua caratteristica di una narrazione lunga. Certo la serialità televisiva deve scoprire nuovi modi di narrazione che esulino dalla suspence, dalla situazione di pericolo o dalla narrazione di corruzione e malaffare. Deve anche in particolare lasciare che la macchina da presa del regista conduca lo spettatore all’interno della scena, non concedendo soprattutto all’atmosfera e alla definizione del contesto di affascinare.
La fonte per nuove riflessioni da parte della serialità potrebbe essere il cinema, ma fino a quando?
.
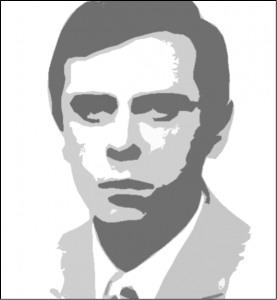 L’EREDITÀ È SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI CULTURA.
L’EREDITÀ È SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI CULTURA.
ADELIO FERRERO E L’ATTUALITÀ DEL SUO PENSIERO
di Roberto Lasagna
Adelio Ferrero esordisce ufficialmente a ventun anni e, attivo sino alla fine, si spegne a quarantadue anni (Alessandria, 1935 – Bologna, 1977). Chi lo ricorda nel periodo vicino all’uscita di scena, difficilmente coglie l’esatta età anagrafica di questo figlio della provincia che fu capace di portare il suo pensiero e la sua attività di critico e intellettuale alla ribalta nazionale (lui, così riservato, avrebbe sorriso per questa espressione), diventando, anche nella sua città, un riferimento di grande rilevanza grazie all’incrollabile amore per la cultura, un’attitudine declinata in sostegno e promozione mai banale per l’attenzione che i giovani potevano rivolgere alla proposta culturale voluta come formativa, cioè propositiva, didattica.
Cosa ha contraddistinto la generazione di Adelio Ferrero e cosa la stessa ha lasciato agli orfani culturali che per decenni a seguire hanno sostenuto il percorso del rigoroso critico cinematografico portando avanti con fiducia anche il Premio che dal 1978 ricorda il suo pensiero e la sua attività?
Di primo acchito verrebbe da rispondere: la serietà e il metodo, che si sono tradotti in ampiezza di vedute e di pensiero. Ferrero, figlio di un operaio di una fabbrica di stufe e di un’impiegata della Borsalino (genitori protettivi che egli amò e che furono per lui un riferimento solido), intrecciò amicizie, rapporti, contatti con personalità della cultura internazionale, animando contrasti e polemiche nel segno di una vis critica autentica e originale. Come ricorda Lorenzo Pellizzari, presidente del Premio Adelio Ferrero al quale si deve, tra le altre fondamentali cose, la sistemazione degli scritti di Ferrero in imperdibili lavori (citiamo qui almeno: la preservazione degli articoli apparsi tra il 1960 e il 1972 su “Mondo nuovo”, in una raccolta in cui sono contenuti gli esordi della sua produzione; il testo Dal cinema al cinema – Longanesi, 1980 – che raccoglie il lavoro sul teatro e la tv affiancandolo alla ricerca sul cinema; Per un altro cinema. Recensioni e saggi. 1956-1977 – Ed. Falsopiano, 2005 – che raccoglie e seleziona gli scritti per le riviste “Cinema Nuovo”e “Cinema e cinema”): “aveva una linea ben precisa, fatta di molte certezze e pochi dubbi, senza non per questo mai evolvere nel percorso, come è altrettanto naturale che sia” (L. Pellizzari, Adelante, Adelio, con juicio. Posftazione a Recensioni e saggi. 1956-1977, op. cit.).
Per Adelio, giovane critico, il cinema è fonte di enorme curiosità, di un’attenzione onnivora quanto selettiva, e le certezze cui Pellizzari fa riferimento non si traducono in esclusioni preconcette. Per la generazione di Ferrero (e di Lorenzo Pellizzari e Guido Fink, compagni di redazione durante l’esperienza formativa sulle pagine di “Cinema Nuovo”, che coinvolge il critico alessandrino dal 1956 al 1970) il cinema è un modo per realizzare il proprio discorso sul mondo, perché il cinema è un epifenomeno, preserva una prospettiva sul reale ed è espressione di un pensiero, che può e deve essere accolto come parte di un discorso più generale sulla società del proprio tempo. Nella consapevolezza condivisa che il cinema non avrebbe cambiato il mondo, era evidente a tutti che il discorso sul cinema e il discorso del cinema, in un mutuo interscambio, avrebbero poi potuto operare in direzione di un cambiamento formativo. Una volontà, quella di Adelio, mascherata di certezza, attitudine che difetta oggi non di rado ai nostri dubbiosi operatori culturali, espressione di una coscienza che ci pare preziosa quanto lontanissima.
Mentre Adelio e il Circolo del Cinema di Alessandria operano in città per formare e proporre percorsi di conoscenza del cinema attraverso rassegne e dibattiti in cui si vuole partecipe il pubblico più eterogeneo e principalmente i giovani, i suoi scritti per “Cinema Nuovo”, sotto la ferrea direzione dell’autorevole/autoritario/autoriale Guido Aristarco, non sono solo schede su film e autori, ma talvolta anche saggi di grande respiro, come si ripeterà per i non molti, purtroppo, interventi su “Cinema e cinema” prima della prematura scomparsa di Ferrero. La rivista trimestrale che nacque nel 1974 e fu diretta da Adelio Ferrero per i primi dodici numeri, rappresenta per il critico la piena affermazione di un’idea di critica: essa vede confluire antichi o più recenti “transfughi” da “Cinema Nuovo”, firme non più disposte ad assimilare le prescrizioni di Aristarco, ma si offre come rivista in movimento intenta a riesaminare e riproporre autori e tendenze, attraverso una formula intermonografica disposta all’approfondimento che, nei tre anni in cui la dirige Ferrero e anche nei successivi “mandati” di Lorenzo Pellizzari e Guido Fink, diventa un modello, in primo luogo per gli studenti del primo Dams di Bologna dove nel frattempo Adelio diventa il primo docente di materie cinematografiche quindi per i giovani partecipanti del Premio Adelio Ferrero. Quest’ultimo fu fortemente voluto da Lorenzo Pellizzari dopo la morte di Adelio e fu realizzato con il contributo dell’Ata e poi Aspal (i nomi delle aziende che gestiscono in quei decenni il teatro Comunale di Alessandria); esso rinnova sin dal 1978 il ricordo del critico alessandrino lanciando o segnalando moltissimi giovani critici con il proposito di sottolineare la serietà e il rigore di un’eredità che non si vuole lasciare abbandonata. Il Premio, con alti e bassi, viene difeso nel tempo da alcuni amici di Adelio e validi operatori culturali, diventando un punto di riferimento imprescindibile per la cultura cinematografica in Italia. Rifarsi ancora oggi a Adelio Ferrero, come succede ai sostenitori de “Le giornate del Premio Ferrero” (Alessandria, ottobre 2015) che, non senza spirito d’avventura e stoica fede nella cultura, rinnovano il Premio dopo quattro anni di assenza – dovuta in parte alla débàcle del Teatro Comunale e conseguentemente del festival Ring! (unico e prezioso festival della critica cinematografica nato ad Alessandria per rilanciare il premio che ebbe momenti di grande lustro e riportò il nome di Ferrero a quella notorietà che egli senz’altro meritava), in parte al grave abbandono in cui le istituzioni e la cultura vivono la loro impotenza in epoca recente – significa per il neonato Circolo del Cinema Adelio Ferrero che si costituisce nella città di Adelio nel 2013 e che riunisce alcune figure di riferimento della persistente cultura cinematografica alessandrina, ritrovare il senso della proposta formativa.
Il quadro di riferimento è, per fortuna, una nuova e rinnovata consapevolezza che, almeno in parte, si riallaccia al solco lasciato da Ferrero, cioè la consapevolezza che il cinema, in quanto epifenomeno, è un frammento del discorso comunicativo, ma un frammento importante che occorre accostare ad altre discipline, ad altri campi di discussione. Significa uscire dall’impotenza che una cultura dell’omologazione impone come egemone e riprendere l’attualità di temi e discorsi. Significa proporre percorsi e confronti, senza perdere quel rapporto con i giovani che a Ferrero stava particolarmente a cuore. Significa ritornare a quella “Nobile arte”, la critica cinematografica appunto, che nella ricerca dell’identità di uno sguardo necessita di sottigliezza, di confronti, di opposizioni. Adelio Ferrero non è stato mai dimenticato, nemmeno quando il suo archivio, opportunamente custodito nel Teatro Comunale, venne incautamente dissipato. Altri lo hanno ricordato nel corso di lunghi anni (si pensi alla compianta Giuliana Callegari e al professor Nuccio Lodato, e a quest’ultimo va riconosciuto il merito di avere contribuito alla riedizione del “Castoro” su Bresson con le riflessioni ultime di Ferrero). Molti giovani lo hanno studiato e nella storia della critica Adelio ha un suo posto di rilievo. Ma i tempi sono cambiati, e i modi di fruizione del cinema e dell’audiovisivo mutano in continuazione. Anche il cinema eredita nuove modalità di percezione e noi tutti siamo spettatori molto diversi da quelli di trenta-quarant’anni fa. Il mondo, la politica, sono drasticamente mutati.
Cosa potrebbe dire allora Ferrero, lui controllato e sottilmente ironico, del cinema italiano contemporaneo? Sicuramente avrebbe buone ragioni per dissentire, ma potrebbe anche registrare degli sviluppi interessanti, com’era nel suo spirito propositivo. La sua visione, in tal senso, egli la mise perfettamente in luce anche in due interventi su “Cinema nuovo”, che possono offrire oggi un’ulteriore prospettiva di riflessione e darsi come un quadro di quel “come eravamo”, anche per capire dove siamo arrivati. Il primo intervento s’intitola “Umberto D. e la crisi della rispettabilità borghese” (in “Cinema Nuovo”, n. 197, gennaio-febbraio 1969). L’occasione di rivedere il film di De Sica sul piccolo schermo televisivo colpisce Ferrero per l’intransigenza che l’autore definisce quasi bressoniana di una scelta stilistica perseguita con estremo rigore, della quale non è tuttavia estraneo un certo bozzettismo. Ferrero definisce Umberto D., con Paisà e La terra trema, il punto di maggior riuscita del “neorealismo”. E con la profondità e l’eleganza di discorso che lo contraddistinguevano, l’autore mette in chiaro i limiti della proposta degli autori del neorealismo. In Paisà, il il viaggio italiano di Rossellini in un paese sconvolto dagli stremi sussulti della guerra, era per Ferrero troppo legato alla violenza delle cose per consentire l’organizzazione e il ripensamento di una materia intollerante di freni e limitazioni: non a caso gli episodi pensati e costruiti risultavano i meno felici, sfasati rispetto alle “cose” e all’occhio dell’osservatore. E con l’amato Luchino Visconti de La terra trema, Ferrero è ancora meno assolutorio: “il rimando alla poetica e alla scelta di un autore formatosi nel decennio precedente e con tutta una sua storia ancora da percorrere, si sovrappone con la autorità e rischia di falsare le prospettive, inevitabilmente ‘medie’ o ‘minori’ rispetto all’esito viscontiano”. Con abilissima capacità di condensazione, il testo di Ferrero chiarisce limiti e tensioni della cinematografia neorealista individuando nell’originalità e nella consapevolezza dello sguardo sui protagonisti di una vicenda il punto cruciale del discorso: “Se parlare di neorealismo per Rossellini e Visconti può risultare pertanto discutibile, per eccesso e per difetto della ‘formula’ rispetto alle opere, il discorso cambia per Umberto D. che nel neorealismo è davvero il risultato più originale: il punto di maggior tensione e, nello stesso tempo, di esplicita chiusura di una possibilità. E non per una concomitanza negativa di fattori esterni e di istituti repressivi, che certo esistevano e proprio contro questo film ebbero modo di esplicarsi con non casuale durezza, ma per esaurimento di ragioni interne, come l’opera testimonierà a un livello così emblematico e dunque di gran lunga più probante dei cosiddetti ‘cascami’”.
Ferrero individua in Umberto D. il ritratto autentico del piccolo borghese, con tutte le inibizioni, i ritegni, i limiti: un individuo che si sente a disagio nel corteo in cui la sua voce non riesce a fondersi con quelle dei più disgraziati e ammutolisce dinanzi a coloro che “non hanno debiti”. In questo ritratto discreto e sommesso, che Ferrero definisce “di reticente riconoscimento”, s’inserisce il discorso di De Sica-Zavattini, alleggerito quasi del tutto di quella condiscendenza populistico-sentimentale (segno di estraneità politica e di classe) così percepibile in Ladri di biciclette e, soprattutto, in Miracolo a Milano. L’esemplarità di Umberto D. nella cinematografia neorealista è per Ferrero nel rapporto di “medesimezza umana” di De Sica e Zavattini con un tipo di personaggio molto più congeniale ai due autori di quelli di presunta estrazione proletaria. Questo individuo, un piccolo borghese anziano e declassato, sperimenta, con un senso di estraneità e di smarrimento angosciante, tutti i meccanismi di esclusione di una società immorale, dalla violenza dura e pura della polizia, che vieta a lui e a quelli come lui di protestare per le pensioni da fame che si ritrovano “dopo una vita spesa al servizio dello stato”, alla violenza subdola che lo mette al margine relegandolo in uno stato di impotenza la cui alternativa è il suicidio oppure la morte civile nei dormitori pubblici che somigliano a dei lager. Il rigore e la durezza inconsueti del discorso di Umberto D. sono per Ferrero un antidoto al populismo dilagante. Se questo è, in qualche modo, lo sguardo del nostro miglior cinema sulla società italiana all’indomani della Seconda Guerra Mondiale e della Repubblica, più articolata appare la valutazione che Ferrero delinea degli anni a seguire, nel saggio “Indulgenza e rivolta nel recente cinema italiano di contestazione” (in “Cinema Nuovo”, n. 200, luglio-agosto 1969).
Il discorso di Ferrero prende avvio dall’osservazione di Moravia secondo cui “il contrasto tra intellettuali e movimenti studenteschi si rivela radicale nella valutazione dell’arte e della cultura. Per i movimenti studenteschi, un po’ come per i nichilisti russi dell’Ottocento, l’arte e il pensiero debbono essere utlili. Per gli intellettuali, invece, arte e pensiero devono essere vivi” (Alberto Moravia, La contestazione studentesca, in “Nuovi argomenti”, n. 12, ottobre-dicembre 1968. Nda: i corsivi sono nostri). Per Ferrero, Moravia coglie un motivo ricorrente negli studenti ai quali finiva peraltro col dar ragione contrapponendo, in modo a dir poco meccanico, l’azione degli uni, alla contemplazione degli altri, secondo uno schema certo astratto e opinabile. A questo quadro dell’epoca sessantottina, che oggi ci pare antropologicamente lontana ma sulla quale ha sicuramente più di un motivo di necessità il ritornare a riflettere, Ferrero risponde con un’esplicita ammissione di fede per il ruolo degli intellettuali: “agli studenti che, nel rifiuto dell’autorità e della repressione esercitata da una certa cultura, rischiano spesso di coinvolgere tutta la cultura, non si può certo obiettare, come fa Moravia, che uno studente dura cinque anni, un intellettuale cinquanta”, ma invece, con Fortini, che “l’intellettuale ‘avanzato’ non deve, come diceva Guevara, suicidarsi. Deve lavorare a identificare e a produrre la propria ‘negazione determinata’” (Franco Fortini, Ventiquattro voci per un dizionario di lettere, Il saggiatore, 1968, pag. 29). Che è appunto ciò che questi, spesso, non vuole o non sa fare. Per Ferrero la responsabilità è ancora maggiore quando l’intellettuale usa la macchina da presa, uno strumento di comunicazione potente che si presta purtroppo molto bene alla manipolazione di tensioni e comportamenti antagonisti al sistema in cui opera e per conto del quale riafferma quello che Adorno chiama il “carattere suddito”. Ferrero contesta la voracità con cui i giovani registi Faenza, Liberatore, Brass si sono buttati sulla “contestazione”, svuotandola così di ogni significato eversivo e riducendola a innocuo “kitsch” (chissà se oggi avrebbe cambiato almeno in parte il suo pur centrato giudizio alla luce di altri percorsi ben più incoerenti, di promesse storiche non mantenute e soprattutto della sostanziale “alterità” dei percorsi di alcuni dei nomi citati, o forse proprio il suo giudizio, assieme a quello di altri, fu raccolto dagli autori come succedeva in un’epoca in cui la critica cinematografica aveva un suolo ruolo ascoltato). Il critico definisce “abominevole” Metti una sera a cena di Patroni Griffi, dove una certa borghesia italiana può compiacersi dei suoi atteggiamenti più “osati”. Coglie come pieno di autoindulgenza l’atteggiamento di molti giovani come Maurizio Ponzi che, ne I visionari, ha orrore del neorealismo e attraverso il gioco sempre più abituale, sovente esterno e meccanico, delle contaminazioni e dei rimandi, torna a un cinema antonioniano in senso riduttivo, sottile e fragile sino all’inconsistenza, mentre lo stesso Antonioni rimedita il proprio discorso in Blow-up e Zabriskie Point.
Ferrero parte da Adorno e conviene che “non c’è nessun contenuto, nessuna categoria formale che, per quanto trasfigurati misteriosamente, per quanto nascosti a se stessi, non derivino dalla realtà empirica da cui si sono staccati con un’aspra lotta. In tal modo, come attraverso il riordinamento dei movimenti attraverso la sua legge formale, la poesia si rapporta alla realtà”. Il discorso di Ferrero va dunque alla ricerca di quel momento di “aspra lotta”, di lacerazione e rottura, per verificare se e fino a che punto un dissenso sia presente e quale misura critica assuma. E’ nella portata riformulatrice o negatrice di questa “aspra lotta” che la lettura dell’esistente e il rapporto con il reale vanno sovente al di là dell’imprescindibile rapporto individuale per accogliere e interpretare la realtà in una prospettiva estranea alla pura e semplice affabulazione autobiografica. Nel suo intervento, Ferrero individua almeno tre percorsi originali che affiorano con vigore e gettano ancora luce sul presente di quegli anni. Sono i percorsi, e in particolar modo alcuni film, di Pasolini, Ferreri, Taviani.
Nel caso di Pasolini, esaurita la stagione sottoproletaria come avvio di un corrispettivo altro alla propria lacerazione personale e irregolarità ideologica ovvero messa sullo sfondo l’alternativa del “terzo mondo” – dai villaggi asiatici ai ghetti neri – quale proiezione mitica di un nuovo sottoproletariato del mondo, torna a rivolgersi a se stesso, a riascoltare i richiami della sua irriducibile diversità; citando il sentimento di crisi che la disperata esclusione e l’intransigente fedeltà al proprio destino di reietto avviavano nei versi de Il glicine (“qualcosa ha fatto allargare/l’abisso tra corpo e storia, m’ha indebolito, inaridito, riaperto le ferite”), Ferrero vede in Teorema la nota dominante della poetica pasoliniana. Opera personalissima, in essa Pasolini avverte l’esigenza di una mediazione, in questo caso una borghesia straniante e la sua crisi. Ma tutte le figure umane sono le proiezioni fantomatiche di una metafora lirico-autobiografica di cui Pasolini è l’assoluto autore. Ferrero nota come all’autore difetti forse ancora l’audacia di fare recitare il suo apologo davanti a fondali neutri, e avvalendosi del tramite di una situazione da “teatro della minaccia”, di un ambiente e di un milieu che evocano Deserto rosso di Antonioni, incarna le sue proiezioni in personaggi che hanno la provvisoria parvenza di una psicologia. Ma Ferrero riconosce anche che “bastano i pochi rapidi scorci di una quotidianità allontanata e sospesa su cui si apre il film, che figurativamente è forse il più composto e dominato di Pasolini, a far intendere allo spettatore che quella cui sta per assistere è una sorta di ‘allucinazione’, non meno di Edipo Re”.
Per Pasolini, e per i protagonisti di Teorema, le alternative risultano più apparenti che reali e mentre Edipo concludeva il suo vagabondaggio con la desolata consapevolezza che “la vita finisce dove comincia”, il protagonista di Teorema ritrova nell’urlo della sua disperazione l’autenticità dell’angoscia, quella carica di dolore che esclude ogni retorica e ogni autoindulgenza.
E’ poi soprattutto in Dillinger è morto di Marco Ferreri, che per Ferrero si verifica, nell’assenza di tante posticce giustificazioni sociologiche così come delle facili tipologie così frequenti nel cosiddetto cinema di contestazione, l’aspra lotta di cui parlava Adorno; qui il momento della scarto si verifica nel protagonista quando comincia a riconoscere la propria disumanità, “lo spreco della sua esistenza inerte e assorbita non attraverso una tormentosa presa di coscienza o un aspro confronto con gli altri, ma nella sorda scoperta, apparentemente la più occasionale e quieta possibile, di tutta una serie di rapporti, gesti, comportamenti nei quali non può più ritrovarsi”. Nella sua acre composizione dimostrativa, il film di Ferreri registra il processo disalientante, istintuale, prossimo al biologico, di una “regressione” domestica e culinaria, dove il protagonista esibisce la parodia della propria immagine codificata e si reinventa passando attraverso la divagazione del sadismo per ergersi a individuo altro e disponibile, fino alla progettazione dell’omicidio della moglie, simbolo e soggetto di nuova schiavitù tra le pareti domestiche. Al personaggio, perso nel meccanismo ripetitivo e consumistico che la parte gli assegna, non resta che rompere il meccanismo mimetico. Nessuna vera fuga e nessuna avventura è realmente possibile. Il motoscafo diviene alla fine il vascello spettrale che si accartoccia sotto il sole, eccessivo, ingombrante, di una catastrofe inevitabile quanto auspicabile.
Anche il sole de Sotto il segno dello scorpione, di Paolo e Vittorio Taviani, brucia ogni residuo di intreccio e di psicologia. Nella loro favola preistorica, gli autori colorano il racconto di suggestioni cadenzate dalla struttura atemporale dell’allegoria e traspongono la vicenda autobiografica nell’apologo “distanziato in cui due comunità scampate all’eruzione vulcanica e divise nei confronti del proprio destino cercano una via per il loro presente: l’una tutta rivolta alla sopravvivenza, l’altra aperta alla ricerca di una stabile e completa felicità, per quanto desiderata e lontana. Ferrero coglie con grande acume l’originalità stilistica del film: il respiro corale della metafora; la diseroicizzazione delle figure; i procedimenti ellittici e antinaturalistici del racconto; l’utilizzo della colonna sonora polifonica e a diversi registri. La sua analisi di Sotto il segno dello scorpione è, dunque, anche stilistica. E dinanzi a quello che per lui è in quegli anni il film più arduo e maturo dei Taviani, coglie un motivo filosofico, espresso nel dubbio che la dialettica storica, traccia viva e nervosa dell’apologo, dissolva sovente in una dialettica atemporale in cui “staticità e movimento verso il futuro, ‘saggezza’ ed ‘esagerazione’, schiavitù del quotidiano e apertura utopica tendano a definirsi come stagioni e ritmi inalterabili dell’esistenza, e le contraddizioni tendano a sfumare, se non a dissolvere, in quel flusso a senso unico che è la vita stessa, nei corsi e ricorsi dei suoi movimenti e conflitti elementari, che le varie situazioni storiche di volta in volta atteggiano in forme diverse senza modificarle profondamente”. Nel timore che l’allegoria non presenti la forza immaginativa ed eversiva per respingere e ribaltare l’esistente, sia pure nei modi, talora contestati, della poesia, Ferrero ci rammenta che negli anni della contestazione studentesca non ci furono solo astratti furori, ma a modo loro e a livelli ovviamente differenti, i personaggi dei film di Pasolini, Ferreri, Taviani (ma anche di altri, tra cui Orsini e, seppure con diversi accenti, Bernardo Bertolucci) conducono alla dialettica dell’esistente e della sua negazione che rappresenta per lui, e per altri del suo tempo, la linea portante di un nuovo cinema critico. Un cinema che interpreti la realtà fino a contribuire, seppure anche solo in minima parte, a plasmarla. E’ un motivo ricorrente della critica di quegli anni che permarrà in parte come retro-pensiero anche negli anni a venire, quando la critica sarà sempre di più uno strumento di analisi con il presupposto, nemmeno troppo mascherato, di ergersi a modello riflessivo, ambito di ricerca interpretante e multidisciplinare.
.
FENOMENOLOGIA DEL SEGRETO
NEI “PERFETTI SCONOSCIUTI” DI PAOLO GENOVESE
di Franco Di Giorgi

- – Intrigante e coinvolgente “Perfetti sconosciuti”, l’ultimo film appena uscito (2016) di Paolo Genovese. L’idea da cui si sviluppa l’intreccio potrebbe apparire mutuata da “Il nome del figlio” di Francesca Archibugi (2015), il quale è a sua volta un rifacimento italiano de “Le Prénom” (2012) di Alexandre de La Patellière e di Mathieu Delaporte, uscito in Italia con il titolo Cena tra amici e nato da un adattamento dell’omonima pièce teatrale scritta dallo stesso Delaporte. Questa prende le mosse da uno scherzo attorno alla scelta di un nome “scomodo” (Adolf o Benito) da attribuire a un figlio, da una beffa che consentirà a una commedia di trasformarsi gradualmente quasi in tragedia, e a una tranquilla e spensierata cena tra amici di diventare inevitabilmente uno psicodramma, durante il quale i commensali saranno reciprocamente costretti a tirare fuori e ad accettare verità che nessuno di loro si sognerebbe mai di confessare e di esplicitare. Tuttavia, se simili potrebbero apparire il contesto o il luogo situazionale, cioè la scena fissa in cui si svolgono quasi per intero entrambi i film, come pure il pretesto dello scherzo o del gioco da cui tutto muove (il nome del figlio o la lettura pubblica dei messaggi dei telefonini), diversi nell’opera di Genovese risultano essere invece gli ingredienti (i segreti conservati nei cellulari) e le modalità in cui questi motivi vengono sviluppati. Un motivo, peraltro, questo della moderna comunicazione elettronica, già ripreso dall’ultimo film di Giuseppe Tornatore, “La corrispondenza” (2016). Sicché, da questa prospettiva, sebbene con gradualità differenti e soprattutto senza ricorrere alle tanto mirabolanti quanto angoscianti e ipercinetiche scene di alcune pellicole americane, sia il film di Tornatore sia quello di Genovese mostrano chiaramente come e quanto la moderna tecnologia, riducendo al minimo nelle sue applicazioni lo spazio e il tempo e mettendone in luce in concreto la relatività, riesca a modificare in profondità la nostra concezione spazio-temporale sul piano ontologico e la nostra relazione intersoggettiva sul piano esistenziale.
È indubbio infatti che la mediazione e l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici finisce infatti per mutare la phýsis, l’essenza ontologica e antropologica dell’essere, e con essa anche, di conseguenza, il fondamento gnoseologico. Ne “La corrispondenza”, ad esempio, la tecnologia rende possibile che il non essere sia: consente cioè a una persona già morta di continuare a vivere e di apparire ai sensi, almeno virtualmente, sia come immagine visiva che come sostanza fonica. E ciò al punto da indurre a credere che un tale essere che appare sia ancora vivo. Come se l’apparenza virtuale possa sostituire in toto la realtà effettiva di una persona. Un escamotage cibernetico utilizzato qualche anno prima (2012) anche da Ferzan Özpetek in “Magnifica presenza”, allorché attraverso il mezzo tecnologico il regista riuscì a congiungere la finzione con la realtà e la realtà con la finzione, il presente con il passato e il passato con il presente, la vita dei morti con quella dei vivi. Attraverso il suo pc, Pietro – cioè la “magnifica presenza” che fa nel presente da punto mediano e medianico di collegamento – riesce insomma a far sì che dal passato i fantasmi degli attori già morti vedano il loro futuro, i loro discendenti.
Ovvio, questa possibilità di rivedere e di risentire è data già dalla televisione e dalla radio, specie oggi con i supporti informatici, come pure da un qualunque registratore di immagini e di suoni. Ma nel caso de “La corrispondenza” di Tornatore si tratta di sms, cioè di una corrispondenza resa possibile da un service di short message, come pure di e-mail, di posta elettronica, di messaggi che in ogni caso continuano ad arrivare nel presente di una persona vivente da parte di un mittente non più vivente, messaggi che però sono stati inviati “per tempo”, cioè in anticipo, prima che il mittente morisse. E ciò fa sì, ad esempio, che, anche se per un tempo breve, il sentimento dell’amore, che Tornatore ritorna ad analizzare in questo film, possa continuare a sopravvivere, grazie proprio alla tecnologia avanzata. Vi si avanza pertanto una soluzione in certo qual modo ottimistica rispetto al rapporto uomo-tecnica. E certo lo è se consideriamo la tesi finale, davvero drammatica e pessimistica, proposta invece ne “La migliore offerta” (2012), in cui la purezza del sentimento amoroso non sembra spuntarla sulla fame di denaro: Eros, il dio dell’amore, non può nulla in un mondo in cui domina Ploutos, il dio della ricchezza, unica e sola divinità riconosciuta dal potere finanziario-economico e dalle società che esso gestisce attraverso la politica.
Ad ogni modo, proprio la corrispondenza elettronica, resa possibile dai nuovi sistemi telefonici, è, come si è accennato, anche al centro dei “Perfetti sconosciuti” di Genovese. Qui però il piano su cui si compie la trasformazione della commedia in quasi tragedia non è più tanto quello spazio-temporale, bensì quello di un’altra categoria logica, quello della possibilità. L’espediente illusorio, il trompe-l’oeil cinematografico su cui si fonda l’intero sviluppo dell’opera consiste in una possibilità non realmente vissuta dai protagonisti, in una possibilità non realizzata e rimasta solo una mera possibilità. Ma non è facile analizzare ed esplicitare questa ingegnosa trovata, non solo perché il regista non ce ne dà la chiave (se non nel finale, solo in apparenza insignificante), ma soprattutto perché è costituita da una complessità di piani ermeneutici (logico, ontologico, tecnologico, etico, estetico, antropologico) che intersecandosi e compenetrandosi formano la bella tessitura filmica. Essa ripropone, ripresenta e rappresenta l’antico gioco dell’ambiguità tra essere e non essere, tra essere e apparire, tra realtà e apparenza, tra vita vera e vita apparente, tra cosa in sé e apparenza fenomenica, tra esistenza e possibilità. D’altronde il cinema è una sorta di lampada magica mediante la quale vengono proiettate sulla tela delle immagini in movimento (kínesis, da cui ta kinémata, i movimenti), e in quanto tale è riconducibile al fuoco del mito della caverna platonica, sulla parete della quale vengono mostrate le ombre ingannevoli delle cose reali che si muovono dietro e all’insaputa degli uomini legati davanti ad essa. Non solo. Proprio come fa Schopenhauer ne “Il mondo come volontà e rappresentazione”, l’arte cinematografica di Genovese, annullando lo scarto temporale tra una dimensione e l’altra, consente allo spettatore di assistere, da una prospettiva meramente ideale, allo svolgimento della vita “vera” dei personaggi, a quella vita a cui questi si sono sottratti per timore di svelare i loro segreti personali, preferendo mantenersi sulla soglia della possibilità e rinunciando così a portare avanti il moderno “gioco della verità” proposto da una delle protagoniste. Questo espediente artistico, insomma, permette allo spettatore di guardare come un voyeur nella vita intima dei personaggi del film e di conoscerne, come il Dio luterano, l’intenzionalità. Tendenza perversa, questa della scopofilia contemporanea, oggi com’è noto imperversante a tutti i livelli, in ragione del principio moderno di rintracciabilità, in una società che si è autoreclusa nella contraddizione insanabile tra la giusta esigenza della trasparenza e l’altrettanto legittima esigenza della privacy. Da qui peraltro l’elogio del segreto da parte, ad esempio, di psichiatri come Vittorino Andreoli o di letterati come Claudio Magris. Una vita intima, quindi, che, secondo quanto ci invita a pensare il titolo del film di Genovese, resterebbe “perfettamente sconosciuta” agli stessi personaggi.
Ma è davvero così? Non sembrerebbe. Giacché ognuno di essi – come ognuno di noi – singolarmente e interiormente conosce benissimo le pieghe e le contorsioni della propria vita e della propria anima, indipendentemente dal fatto che i loro segreti rimangano inespressi o che vengano esibiti agli altri. Sono questi altri piuttosto, o meglio, alcuni di questi, a non conoscere la vita segreta di ognuno dei loro amici. Si dovrebbe pertanto parlare non già di una vita ignota a se stessi, ma di una vita sconosciuta agli altri. E non a tutti gli altri, ma solo ad alcuni. Il film mette in scena infatti alcuni modi di darsi del segreto. È equiparabile a una fenomenologia del segreto. Anzitutto distingue tra segreto concernente relazioni preesistenti e segreto che nasce in itinere, cioè durante lo svolgimento della vicenda – ad esempio quello che matura tra Lele (Valerio Mastrandrea) e Peppe (Giuseppe Battiston), l’amico apparentemente single e in realtà omosessuale. Oppure discerne tra il segreto riguardante relazioni con figure assenti dalla scena e non facenti parte della ristretta cerchia degli amici e quello comprendente rapporti con personaggi presenti in scena. Nel primo tipo rientra la maggioranza dei casi: il segreto di Bianca (Alba Rohrwacher), che riceve ancora messaggi dall’ex fidanzato; quello di Peppe appunto (che ha una relazione con un amico amante); quello di Lele (che è in contatto con una ragazzina che continua inviargli fotografie seducenti); quello di Carlotta (Anna Foglietta), che continua ad intrattenere una relazione sentimentale puramente virtuale; quello di Rocco (Marco Giallini), che, all’insaputa della moglie, ma non di alcuni amici, è in cura da sei mesi da uno psicanalista, pur avendo una moglie psicanalista; quello di Cosimo infine (Edoardo Leo), che tradisce la moglie Bianca con una compagna di lavoro. Nel secondo tipo rientra ancora il segreto di Cosimo, che da tempo intrattiene una relazione segreta con Eva (Kasia Smutniak), la moglie di Rocco, oppure quello già citato tra Lele e Beppe, che sorge in itinere come un segreto del segreto, cioè come un segreto necessario a coprirne un altro.
Attraverso la finzione, dunque, anzi la doppia finzione filmica, il regista non solo svela la vita vera e segreta dei personaggi, ma ottiene altresì che lo spettatore la conosca, e, sebbene resti segreta, fa in modo che essa, attraverso la ricostruzione ideale e la finzione artistica, possa essere idealmente vissuta anche dagli stessi personaggi. Questa ricostruzione verosimile di una vita solo immaginabile e del tutto inesistente si pone dunque come trait d’union che rende possibile al personaggio e allo spettatore, su due piani diversi, di viverla e di conoscerla. Insomma, quello che il regista ha sviluppato nella finzione cinematografica è l’idea che per qualche secondo è balenata nella mente di ognuno dei personaggi nel preciso momento in cui Eva propone quel gioco e Rocco spegne sul nascere.
- – Risulta difficile, come si vede, inquadrare il film di Paolo Genovese, nel senso che non si lascia agevolmente afferrare, in quanto sfugge dalle mani come un’anguilla, proprio come la storia di Giobbe. Ma proviamo lo stesso ancora ad analizzarlo, seguendo una sorta di metodo galileano.
Cominciamo col dire che l’opera si può suddividere in due parti fondamentali e che questa suddivisione avviene in un punto ben preciso della storia, cioè nel momento in cui (come si scoprirà alla fine) uno dei sette personaggi (Rocco), decide, come si è suaccennato, di non voler dar seguito al gioco proposto dalla moglie Eva per quella serata. Il gioco consiste nel dimostrare che nessuno di loro ha segreti e che, almeno durante quella serata, tutti debbono leggere pubblicamente gli sms che arrivano e sentire a viva voce le telefonate. Questo momento separa nettamente il film in due parti. Ma il regista, con un artificio, con un inganno cinematografico, le cuce insieme e ce le lascia vedere senza soluzione di continuità, in un continuum. Di fatto lo spettatore non si accorge, non può accorgersi di questa disgiunzione, di una siffatta cucitura, dell’opportuna tessitura ed è portato a credere che i fatti si svolgano effettivamente nella sequenza in cui vengono proposti dalla maestria del regista. In questa originale retorica filmica, in questa sintassi iconografica consiste l’escamotage cinematografico su cui si struttura l’intera impalcatura dell’opera.
Bene. Quali sono queste due parti? Anche la loro individuazione risulta alquanto problematica. Difficile da mettere a fuoco. Proviamo. La prima in ordine temporale è anzitutto la parte esistente della storia o della realtà raccontata, ossia quella che ha effettivamente avuto luogo e che tutti i soggetti ermeneutici chiamati in causa (sceneggiatore, regista, protagonisti e spettatori) riconoscono sino alla fine come tale. In questa prima parte della vicenda viene presentata insomma una tranche de vie realmente vissuta dai personaggi. La seconda, invece, riguarda la parte possibile della realtà narrata: una parte insistente, ma che avrebbe potuto essere esistente se e solo se Rocco avesse acconsentito a dar seguito a quel moderno e tecnologicamente aggiornato “gioco della verità”. Così però non è stato. Nel senso che tutta la vicenda coinvolgente che il regista ci ha presentato in questa seconda tranche di fatto non è mai accaduta. Non ha mai avuto luogo. Se non, appunto, nell’immaginazione dell’autore, dello sceneggiatore e del regista. Cioè nel film, nella finzione dell’opera d’arte. Questa seconda tranche era dunque solo possibile. Era una possibilità che non si è mai potuta e voluto concretizzare e che, nonostante l’espediente artistico, è rimasta alla fine solo una possibilità. Solo un’idea. Ebbene, il regista, come ogni altro vero artista, ha provato lo stesso a sviluppare questa idea e a darle sostanza, a conferire esistenza al possibile, a mettere in atto ciò che era solo in potenza. Un po’ come faceva Klee con le sue opere. Come fa in effetti ogni compositore che sviluppa una sua idea musicale. Un po’ come fa anche San’Anselmo quando vuole provare l’esistenza di Dio aggiungendo realtà all’idea che lui ne ha come ciò di cui è impossibile pensare il maggiore.
Ma con ciò non abbiamo affatto risolto la complessità che questo film presenta. Dobbiamo infatti fare i conti ancora con i problemi che pone il rapporto esistenza/possibilità (relativo alla categoria kantiana della modalità) se lo mettiamo a confronto con il rapporto realtà/negazione (relativo alla categoria della qualità). E soprattutto se dal piano logico ci spostiamo su quello ontologico, concernente il rapporto fenomeno/cosa in sé: nel nostro caso storia esistente/storia in sé, parte prima e parte seconda del film. A questo livello, infatti, s’insinua un’ulteriore difficoltà, poiché qui la storia reale, fenomenica ed esistente deve essere intesa come una apparenza e una copertura della storia in sé, ossia della storia solo possibile, soltanto pensabile o noumenica, solamente immaginabile. Sicché ora, da questa prospettiva ontologica, sembra addirittura che la storia esistente e reale, in quanto fenomenica e apparente, sia meno vera della storia possibile, in quanto immaginabile.
Una scena del film. Si riconoscono- da sinistra, Alba Rohrwacher, Edoardo Leo, Giuseppe Battiston, Marco Giallini.
Dopo aver brevemente analizzato il film nelle sue due parti fondamentali, prendiamo ora in esame l’intreccio o la trama generale. Essa si può articolare e può essere intesa fondamentalmente in tre modi. 1. come intrico scenografico: la vicenda si sviluppa dall’interazione di tre coppie più un single. Questo intrico a sua volta presenta tre livelli tra loro ovviamente strettamente correlati e comunicanti: a) quello riguardante le relazioni segrete che ogni singolo intrattiene con altri soggetti non presenti nella scena; b) quello concernente le relazioni segrete che qualche singolo personaggio ha con altri personaggi presenti nella vicenda; c) quello che ogni singolo personaggio vive segretamente in se stesso, individualmente, dibattendosi tra una parte di sé che appare (la maschera) e un’altra parte che invece si vuole mantenere assolutamente nascosta (il volto); e ciò anche se (e in qualche caso soprattutto perché) si è tra amici di vecchia data, amici intimi e forse (anche qui, in qualche caso) perché troppo intimi. 2. Come raggiro o sotterfugio operato dal regista nel bel mezzo della trama, perché egli non ha avvisato lo spettatore dello scarto logico che in tal modo egli ha creato tra la parte esistente della storia e quella invece solo possibile. Chiaro: è proprio questo inganno la chiave di volta dell’intera opera. Perché si tratta di uno stratagemma e di uno scarto che possono essere generati solo con l’artificio dell’arte. Cioè sul piano della finzione cinematografica, in virtù di cui ogni aspetto dell’essere può venire manipolato, anche paradossalmente, per consentire una maggiore comprensione dell’essere stesso. Un essere che ha quindi bisogno di venire ingannato, trasfigurato, mitologizzato (Platone), trasceso (Kant), idealizzato (Hegel) e perfino negato (Schopenhauer) per essere maggiormente compreso. E ciò nella piena consapevolezza che nella vita concreta i due piani, quello dell’esistenza e quello della possibilità, quello dell’apparenza e quello della realtà, il volto e la maschera non sono e non possono essere mai nettamente separabili. Sicché, in un modo o nell’altro, gli uomini sono sempre, sia in scena sia fuori dalla scena, dei personaggi che, a seconda del contesto e della situazione in cui si trovano coinvolti, debbono recitare la parte che viene loro richiesta dalla circostanza, la parte più conveniente e più confacente. Questo significa, come ci hanno da sempre insegnato tutti i grandi drammaturghi, a partire naturalmente dagli antichi greci sino a Pirandello, passando ovviamente per Shakespeare e Calderón de la Barca, che il mondo per ogni singolo individuo, per riprendere il titolo di una celebre opera del drammaturgo spagnolo, è un gran teatro. E che la vita, intesa come possibilità cinematograficamente, teatralmente ma anche personalmente rappresentata, è solo un sogno. La vita “vera”, pertanto, è solo possibile, si può vedere o vivere solo sotto forma di possibilità, e mai come esistente. Le difficoltà che essa presenta può essere avvicinata solo attraverso la finzione. Ben lungi dall’essere leggero e di facile ricezione, il film di Genovese mette al contrario in luce proprio questa grave difficoltà umanamente ed esistenzialmente irrisolvibile. Tema questo, come sappiamo, che già il giovane Nietzsche aveva affrontato nel saggio sulla “Nascita della tragedia” (1872). L’esistenza è il prodotto della coesistenza mai totalmente armonizzata e conciliata degli incompossibili, cioè di Dioniso e di Apollo, della realtà e del sogno. Giacché se la realtà – come ci lascia vedere il film di Genovese – è nel suo fondo tragica, allora ben venga il sogno, l’arte che, con le sue innumerevoli forme possibili, ce la rende vivibile, accettabile. Non però come realtà esistente, bensì solo come possibilità pensabile, non come effettualità ma come idealità. Allora, se la vita è sogno, possibilità, finzione, è conveniente per l’uomo continuare a sognare, a recitare, a fingere. E la cultura – anche e soprattutto quella che ci propone Genovese col suo film – ha questo difficile ma necessario compito: lasciare intravedere la tragedia della vita attraverso le belle forme della commedia. Non per niente Dante fu il primo a introdurre nell’italiano questo termine greco per il suo capolavoro poetico: al di qua del suo aspetto “divino” (aggiunto da Boccaccio), la kóme oidía resta infatti il “canto del villaggio”, un canto che rende possibile al volgo apprendere le storie tragiche e terribili cui pur accenna. A questo tipo di kóme oidía si ispira il grande idillio leopardiano “Il sabato del villaggio”. Come pure la maggior parte delle canzoni di Fabrizio De Andrè. In particolare “Delitto di paese”, del 1965, che è una ripresa de “L’assassinat” di Georges Brassens (1962). E anche il film di Genovese, questo è: una tragedia trasposta in commedia. Mentre lo si guarda, infatti, non si sa bene se ridere o piangere.
.
IL RESTAURO DEL FILM
di Elio Girlanda
Le recenti uscite nelle nostre sale e in dvd, a cura della Cineteca di Bologna, di capolavori restaurati del passato come “Rocco e suoi fratelli” di Visconti, “Ascensore per il patibolo” di Malle, “Mouchette” e “Au hasard Balthasar” di Bresson, accanto alle opere del Progetto Chaplin e del Progetto Buster Keaton, se da una parte confermano il ruolo prezioso delle cineteche pubbliche come di alcuni festival italiani, che da tempo ripropongono i classici sul grande schermo, dall’altra rimettono al centro del dibattito questioni di rilievo circa il restauro del film, sia esso lungometraggio che corto, sia di fiction che di non-fiction. Il restauro, peraltro, è oggetto di particolare attenzione nel nuovo Disegno di legge governativo sul cinema che prevede, tra l’altro, un Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
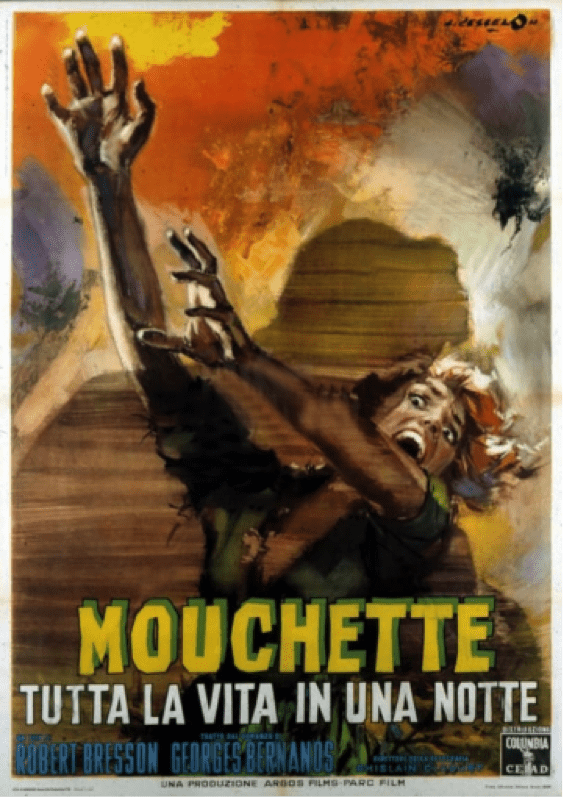 Sono le domande, per esempio, che si pone lo storico Paolo Cherchi Usai quando scrive di “eterna giovinezza”, grazie al restauro, ovvero di “nuova frontiera della chirurgia plastica” per film più o meno vecchi (L’eterna giovinezza, Segnocinema, n. 194, luglio-agosto 2015). Il digitale, infatti, accelerando le pratiche, fino a poco tempo fa conosciute, in tema di conservazione e recupero dei film su pellicola, ha posto alcuni problemi sul film inteso ormai come un “bene culturale”. Innanzitutto Cherchi Usai sottolinea come il deterioramento progressivo delle copie sia stato un fenomeno programmato e incoraggiato dall’industria per la quale il valore del film è stato quasi sempre nullo, dopo lo sfruttamento commerciale. In tale direzione le tecnologie digitali hanno offerto, sempre al sistema produttivo, la possibilità di lucrare ancora una volta sul cinema del passato. «Ne deriva un importante corollario: con buona pace dei musei e degli archivi, il loro ruolo nella resurrezione della storia del cinema è stato marginale. Le cineteche si sono fregiate del merito di avere inventato il restauro del film, ma l’impulso a trasformare quest’operazione in industria culturale non proviene da loro. La loro complicità nel promuoverla si è manifestata in primo luogo nello sforzo di riesumare un film nella sua forma più completa. Un film mutilato non è quasi mai un capolavoro, la Venere di Milo sì».
Sono le domande, per esempio, che si pone lo storico Paolo Cherchi Usai quando scrive di “eterna giovinezza”, grazie al restauro, ovvero di “nuova frontiera della chirurgia plastica” per film più o meno vecchi (L’eterna giovinezza, Segnocinema, n. 194, luglio-agosto 2015). Il digitale, infatti, accelerando le pratiche, fino a poco tempo fa conosciute, in tema di conservazione e recupero dei film su pellicola, ha posto alcuni problemi sul film inteso ormai come un “bene culturale”. Innanzitutto Cherchi Usai sottolinea come il deterioramento progressivo delle copie sia stato un fenomeno programmato e incoraggiato dall’industria per la quale il valore del film è stato quasi sempre nullo, dopo lo sfruttamento commerciale. In tale direzione le tecnologie digitali hanno offerto, sempre al sistema produttivo, la possibilità di lucrare ancora una volta sul cinema del passato. «Ne deriva un importante corollario: con buona pace dei musei e degli archivi, il loro ruolo nella resurrezione della storia del cinema è stato marginale. Le cineteche si sono fregiate del merito di avere inventato il restauro del film, ma l’impulso a trasformare quest’operazione in industria culturale non proviene da loro. La loro complicità nel promuoverla si è manifestata in primo luogo nello sforzo di riesumare un film nella sua forma più completa. Un film mutilato non è quasi mai un capolavoro, la Venere di Milo sì».
Si è stabilita, così, l’ideologia del “restauro perfetto” con la caratteristica di presentare il classico restaurato digitalmente ogni volta come una novità, rispetto alle riedizioni su pellicola che avvenivano in passato. «Il problema è che – continua Cherchi Usai -, a differenza del restauro su pellicola, l’intervento digitale sa partire con buoni propositi ma ha difficoltà a fermarsi, nel senso che non ci sono limiti al suo impiego se non la quantità di denaro da investire nell’operazione. La prova più evidente del suo abuso è la saturazione del colore, che obbedisce alla predilezione del pubblico per le tinte squillanti; Biancaneve e i sette nani è in Technicolor, ma la sua tavolozza cromatica originale prediligeva sfumature in pastello. Il digitale mal sopporta la moderazione, e dipinge Disney con pennellate molto più sature». Così, “La Voyage dans la lune” (1902) di Georges Méliès, è stato restaurato e ripresentato nel 2011 con colori anche inesistenti in origine, mentre “L’uomo con la macchina da presa” (1929) di Dziga Vertov, è stato ristampato a fotogramma pieno e non tagliato a sinistra, quando i classici muti erano riprodotti su pellicola sonora.
L’etica del restauro
Il dibattito rianimato dall’intervento di Cherchi Usai, al di là del superamento di certi limiti grazie alle tecnologie elettroniche, da una parte ripropone l’equivoco secondo cui il film merita di essere recuperato nella sua forma “originaria”, quella cioè voluta dall’autore o dal suo produttore, quando nelle altre arti, invece, il confronto riguarda sia il restauro conservativo (protezione dell’opera nelle condizioni in cui è stata trovata) sia quello integrativo (ripristinare l’opera allo stato originario), modalità, quest’ultima, accettata dal cinema senza discutere. Dall’altra, il nuovo dibattito offre al pubblico di oggi, abituato ormai all’alta definizione, l’adeguamento delle immagini di ieri a un gusto e a una percezione del presente, in una progressione crescente e forse infinita (prima il 2K, poi il 4K, il “superiore” 6K, e così via). Sul presunto progresso tecnologico oltre il supporto analogico, meccanico, quanto instabile, Cherchi Usai è tranchant. La superiorità crescente dei trattamenti digitali è una vera e propria menzogna. E quando i film nati digitali diventeranno, magari tra un secolo, oggetto di “restauro”, forse bisognerà cambiare terminologia e soggetto (cineteca): «Tanto vale prendere atto che il digitale è un’altra cosa”, e che il suo “restauro” del film è una contraddizione in termini. Meglio sarebbe definirlo come l’arte di trasformare il cinema in qualcos’altro che continuiamo a chiamare cinema».
Per tutti questi motivi, in sede di cineteche o di festival di tutto il mondo, ma il tema potrebbe riguardare anche associazioni, circoli, cineforum e scuole dove il film restaurato trova sempre più spazio, si sviluppa un dibattito anche sull’etica del restauro ovvero sui suoi limiti e sulle regole. Come è avvenuto alla Cinémathèque Française di Parigi nella conferenza dello storico, esperto di restauro e regista, Luciano Berriatùa, su “Problèmes éthiques et méthodologiques dans la restauration numérique”, nell’ambito del Festival Toute la mémorie du monde nel febbraio 2016, dedicato al film restaurato con incontri, dibattiti e proiezioni. Per l’occasione sono stati proiettati il restauro dei primi film di Chantal Ackerman, in Belgio, con il concorso della stessa cineasta (ormai scomparsa), l’opera di uno degli autori filippini tra i più sensibili e impegnati come Lino Brocka, a cura della World Cinema Foundation di Martin Scorsese che è principalmente impegnata nel restauro, e il lavoro del distributore indipendente Milestone per riscoprire il secondo film della regista afroamericana Kathleen Collins, Losing Ground (1982).
Anche la studiosa Stella Dagna, nel suo libro Perché restaurare i film? (Edizioni ETS, Pisa 2014), si pone gli stessi, radicali, interrogativi: «Il restauro del film è un’attività impegnativa, che richiede investimenti di tempo e di risorse non trascurabili. Per chi, come me, vi dedica una parte consistente della vita professionale, la domanda da cui non si può prescindere è quella universale: perché? In altre parole: a cosa serve restaurare i film?». E ancora. «La pratica e la politica (insisto su questo termine) del restauro contribuiscono in maniera determinante a scrivere la storia del cinema del futuro. Al tempo stesso, soprattutto oggi, costituiscono uno dei punti di osservazione privilegiati sul mutamento epocale della “rivoluzione digitale”». Ci s’interroga, cioè, sulla necessità oggi, fuori da ogni ambito specialistico, di informarsi bene circa le questioni tecniche e il mondo della conservazione dei film e del restauro: sia per avere altri strumenti di conoscenza del film come bene culturale sia per supportare con un dibattito pubblico su principi e metodologie il lavoro stesso degli specialisti in una fase, come quella attuale, di grandi cambiamenti.
Dagna, che è una professionista che si occupa del patrimonio cinematografico, segnala come il restauro susciti riflessioni sulle origini ma anche sul futuro stesso del film, in ogni formato e supporto: «Il restauro lavora sulla relazione con il tempo, interrogandosi sul rapporto con il futuro delle opere del passato: decidere cosa e come vogliamo trasmettere alla posterità significa, per parafrasare François Truffaut, portare avanti un’idea di mondo e un’idea di cinema. Sguardi e presupposti diversi comportano nella pratica conservare un film piuttosto che un altro, scegliere l’analogico piuttosto che il digitale, optare per una ricostruzione piuttosto che per una ristampa della copia, incentivare la fruizione dei film restaurati via internet piuttosto che considerare la sala il luogo esclusivo del Cinema con la “C” maiuscola. Decisioni destinate comunque a influire su cosa si guarderà tra dieci, venti, cento anni».
Quindi, data la natura ibrida del film (tra economia, spettacolo e cultura), ci si chiede se, al di là del restauro come opera di tutela, non si debba intendere il restauro anche come una forma di investimento commerciale e d’intrattenimento spettacolare. Sono domande ricorrenti quando i classici tornano in sala in versione restaurata, ancora nell’ambito del “Cinema Ritrovato al cinema” della Cineteca di Bologna, come “Il gabinetto del dottor Caligari” (1920) di Robert Wiene, con le musiche originali composte nel 1995 da Timothy Brock, o come il “Nosferatu” (1921) di F. W. Murnau.
Quali sono le finalità di un restauro cinematografico? «La disciplina del restauro cinematografico è un territorio dai confini incerti, ancora privo di regole codificate, di metodologie condivise, di luoghi di formazione in grado di creare nuove figure professionali capaci di agire in un settore che vive un’epoca di profonde trasformazioni», spiegano Gianluca Farinelli e Davide Pozzi della Cineteca di Bologna nella voce “Restauro e Conservazione” (2004) nella Treccani Cinema online. Oggi, con tanti film restaurati un po’ dappertutto nel mondo, si può dire che le finalità dipendono da vari fattori: il grado di reputazione del film, la storia precedente del film, le condizioni della copia disponibile, la storia dei precedenti restauri, le esigenze del mercato, l’utilità o meno di una riedizione anche per la sala. Per esempio sul “Caligari” la restauratrice Anke Wilkening dichiara: «Malgrado la sua importanza, per decenni si è continuato a proiettare il film in una forma alquanto vecchia e logora. Nonostante i restauri a cura del Filmmuseum München (1980), del Bundesarchiv-Filmarchiv di Coblenza (1984) e del programma europeo MEDIA (“Progetto Lumière”, 1995) avessero prodotto importanti miglioramenti estetici, tutti questi lavori si sono scontrati con limiti di natura fisica. Persistevano vari segni di degrado: la tipica patina da “vecchio film muto” fatta di sporcizia, graffi e righe che infestavano l’immagine come fantasmi; il forte contrasto, che spesso riduceva i volti degli attori a superfici bianche; l’instabilità dell’immagine e i frequenti salti; le didascalie di difficile lettura. Gli elementi su cui si basavano i tre restauri fotochimici erano diverse, ma tutte contenevano quei difetti. […] “Caligari” non è mai stato vittima di tagli imposti dalla censura o dal produttore: per questo motivo non ci si attendeva scoperte sensazionali e scene tagliate. Ciò nondimeno, il nuovo restauro presenta il film nella sua forma più completa: il conseguimento di questo risultato era una delle sfide cruciali del progetto».
Analogamente, il compositore Brock confida: «Nel 1919 il regista Robert Wiene aveva scelto Verklärte Nacht di Arnold Schönberg, un sestetto per archi appunto, per accompagnare il film quando possibile, e ciò legittimava ulteriormente la mia scelta. Non mi interessava adattare una composizione così nota di un genio della musica a un’opera altrettanto geniale della storia del cinema, e considerato anche che Schönberg non aveva in alcun modo sostenuto l’utilizzo della propria musica, decisi di realizzare un nuovo lavoro per accompagnare quella che all’epoca era la migliore versione disponibile del film». In quest’ultimo caso il restauro con l’aggiunta di nuove musiche mira a una vera e propria riproposta del film nelle condizioni originarie ma adattate ai nuovi tempi e a un nuovo pubblico, culturalmente più avvertito. Infatti al restauro, s’accompagna l’edizione in dvd con corredo di informazioni tecniche, antologia critica, e quant’altro possa essere utile per lo spettatore avvertito. È una sorta di “edizione definitiva” dell’opera, sulla scorta di quanto si fa normalmente nell’industria culturale e nella conservazione dei beni artistici per un libro, un quadro, un edificio o una partitura musicale.
Quindi, al di là dei problemi etici e metodologici che permangono circa il restauro digitale del film, è bene sottolineare come alcune istituzioni, come la Cineteca di Bologna e la Cineteca Nazionale di Roma, provvedono comunque a operazioni culturali di recupero e riuso a 360° dei classici in dialogo con il pubblico più vasto tra ricerca, divulgazione e diffusione delle opere, garantite dalla specializzazione e dalla professionalità degli operatori coinvolti. A tal proposito il direttore dell’Immagine Ritrovata, Davide Pozzi, in alcune interviste tratte dalla tesi di laurea di Francesca Bonvicini, Il restauro perfetto? Il Progetto Chaplin della Cineteca di Bologna (Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università Telematica Internazionale Uninettuno, marzo 2016), rimarca l’unicità del laboratorio bolognese: “La differenza tra noi e gli altri laboratori e che noi studiamo il film, facciamo ricerche, andiamo a comparare gli 8 millimetri. Noi siamo un laboratorio che nasce e si sviluppa per fare solo restauro, gli altri laboratori di cinema nascono per fare cinema e quindi fare postproduzione di film contemporanei e a latere hanno un piccolo settore di restauro ma la loro specialità non è il restauro”. Lo stesso Farinelli, quindi, definisce il vero punto di forza dell’Immagine Ritrovata: “Le persone che lavorano in questo laboratorio hanno una formazione culturale, conoscono la storia del cinema, conoscono i film che affrontano e quindi di volta in volta sono più capaci di misurarsi con quei film e con quelle tecnologie”.
.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
FILMMAKER ALLA RIBALTA: ROBERTO MERLINO
di Paolo Micalizzi
Il filmmaker pisano Roberto Merlino ha realizzato oltre 150 opere, ricevendo numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Da quasi vent’anni poi è Direttore artistico del Cineclub FEDIC di Pisa “Corte Tripoli Cinematografica”, con un’attività molto intensa anche come insegnante: più di 200 i laboratori condotti, con un’attività scolastica (dalle elementari alle superiori) che va avanti da trent’anni, con la direzione di tirocini formativi per studenti universitari. E’ stato docente a contratto per l’Università di Pisa, con 13 laboratori, tra “ripresa” e “montaggio”, anche se la sua professione è quella di medico (è laureato in medicina e chirurgia). Roberto Merlino ha ideato, e continua a condurre, varie trasmissioni televisive tra cui “I Corti di Corte” ( ad oggi quasi 200 puntate) con la quale fa conoscere le opere degli Autori FEDIC di ieri e di oggi. Un’attività che consente di approcciarsi alla Storia della FEDIC e dei filmmaker e stimolarne momenti di approfondimento. Tra le iniziative portate avanti, da evidenziare quella della direzione dello Stage Nazionale FEDIC di Formazione e Approfondimento, giunto alla quattordicesima edizione, che riscuote sempre più interesse. Sono Stage che contribuiscono alla formazione, relativa alla realizzazione di un film, dei filmmaker anche se già in attivo da anni, e che serve a creare nuove leve. Non per niente “Corte Tripoli Cinematografica” è uno dei Cineclub più attivi della FEDIC e tra quelli che conta più iscritti (circa 90).
L’attività di Roberto Merlino non si limita soltanto al cinema ma si estende anche nel teatro, come regista, attore, drammaturgo e insegnante. Ha diretto per 18 anni SCLAT & CIDOBO a La Spezia (Scuola-Laboratorio di Teatro e Cinema) e dirige da 25 anni “L’albero di Putignano”, Gruppo di teatro amatoriale.
Nella sua formazione teatrale, un posto di rilievo hanno avuto Maestri del calibro di Fiorenza Brogi, Giorgio Gallione, Bogdan Jerkovich, Bob Marchese, Mario Scaccia, Marco Sciaccaluga, Jerzy Sthur, ecc. Non meno importante poi in Roberto Merlino è l’attività di pittore: la sua ultima produzione riguarda le ” marine”, opere di grande poesia.
Un autore, Roberto Merlino, che ha dimostrato grandi capacità manageriali come testimoniato anche dai 3 anni di Presidenza FEDIC in cui ha portato i Soci a ricreare un sereno clima di collaborazione e di fattiva attività.
Un’attività poliedrica quindi che ci porta a chiedergli, all’inizio di una nostra conversazione, qual è il filo rosso che unisce tutte le discipline artistiche di cui si occupa.
“A me interessa, risponde, costruire, creare più che amministrare. Come in tutte le cose in cui mi impegno cerco di farle seriamente. Il filo rosso credo sia la creatività che c’è in tutte queste attività e la voglia di comunicare. E ciò si ricollega a un qualche cosa che sta all’inizio di tutto”
Cioè?
“Quando avevo 4 anni, mi chiedevano cosa volevo fare da grande, ed io rispondevo sicuro: il regista. Che è una risposta totalmente inconsueta perché I bambini semmai, in genere, dicono l’attore. Perché lo dicevo?, perché mi piaceva recitare e mi avevano spiegato che il regista è il capo degli attori”.
La prima cosa in cui ti sei cimentato è il Teatro, come attore e regista.
“Si, attingevo ad autori classici, soprattutto il teatro di Pirandello con il quale nel 1982 ho fatto una bellissima tournée in Sicilia. Ho scritto anche dei testi (sono autore SIAE da circa 35 anni), testi diversificati: da cose di tipo drammatico a cose più leggere che vogliono, comunque, avere dentro un messaggio. Come attore, ho vinto per due anni consecutivi la Borsa di studio al Festival Internazionale dell’attore di Firenze (oggi non esiste più) con grossi nomi come docenti”.
E la pittura?
“ Da bambino avevo la passione di dipingere, poi nel tempo ho fatto una mia crescita. Continuavo ad esercitare sempre una pittura figurativa con soggetti diversificati: paesaggi, nature morte, ritratti. Per un certo periodo avevo smesso con la pittura mentre continuavo con passione con il teatro. Poi, circa 10 anni fa, la passione per la pittura è riesplosa , e da lì ho dipinto esclusivamente marine.
All’ultima Mostra allestita a Bagni di Lucca hanno rubato un quadro ( si vede che piaceva, mi dice sorridendo). E la battuta di qualcuno è stata: i quadri di Merlino vanno a ruba”.
Veniamo all’attività di filmmaker.
“E’ iniziata nel 1982 con alcun i cortometraggi riguardanti la circolazione stradale. Come tante cose nella mia vita, è avvenuta per caso. Ero a Sarzana, dove sono nato, ed ho incontrato una signora che era la segretaria del direttore dell’Automobile Club di Massa Carrara. Sapeva che mi occupavo di cose artistiche e mi chiese se ero in grado di realizzare dei filmati educativi per ragazzi sulla circolazione per le strade. Non avevo la più pallida idea di come si facesse un film, ma in quel momento si è svegliato in me il bambino di 4 anni che diceva di voler fare il regista, per cui risposi di sì. Da lì è partita una serie di incontri con l’Automobile Club perché il mio obiettivo doveva essere quello di fare un prodotto coinvolgente ( anche divertente) da un lato e dall’altro rispettare rigorosamente le regole del codice stradale. Realizzai 5 cortometraggi sulla circolazione in bicicletta e 6 su quella in ciclomotore. Ebbero un successo incredibile: furono distribuiti capillarmente nelle scuole a scopo didattico con un grandissimo ritorno di consensi, ma la prova tangibile del positivo risultato ottenuto fu che l’Automobile Club di Massa Carrara rivendette il filmato ad altre varie sedi ACI in Italia, tant’è che alla fine, oltre al compenso pattuito, mi regalarono una medaglia d’oro e per me fu una grande soddisfazione.
L’opera successiva?
“ E’ stata ‘Amaro flauto dolce’, opera di 55’ realizzata nel 1991, in occasione della ricorrenza del 70° anniversario dei famosi fatti del ’21 a Sarzana (squadracce fasciste, giunte in “missione punitiva” a Sarzana, furono respinte dalla popolazione). Anche questo nacque casualmente. Mi contattò il PCI per chiedermi se era possibile fare una rappresentazione teatrale di quei fatti. Proposi, in alternativa, di fare un film. L’idea piacque, e cominciai subito uno studio approfondito, consultando tanti documenti su quei fatti, e la scrittura di una sceneggiatura che fu supervisionata dal partito stesso. Il lavoro era una sorta di docu-fiction: c’era una storia ambientata ai giorni nostri con l’inserimento di flashback del passato, c’erano attori e anche figure importanti come lo storico Adrian Littleton, considerato uno dei massimi esperti del fascismo, Intervistai anche Manlio Cancogni. Il film piacque e ne fecero un migliaio di copie che furono vendute.
L’attività di filmmaker di Roberto Merlino iniziò ad essere intensa. Guardando la sua filmografia si contano una quindicina di opere prima di arrivare ad “Arcola” del 1996. Film che lui considera importante. Perché?
“ Lo considero uno dei film più belli da me realizzati. Arcola è un paesino in provincia di La Spezia. Ho realizzato lì una docufiction incentrata su un signore anziano che torna al suo paese con il nipotino e, girando per i suoi vicoli, si “rivede” bambino impegnato nei giochi di allora. E’ un film di 7-8 minuti: finisce con il bambino che, completamente estraneo a ciò che vede l’anziano, gioca con uno strumento elettronico. Con quest’opera ho vinto, per la prima volta, il 1° premio ad un Festival: Premio Anthia per il Cinema, in provincia di Savona.
Ancora circa una ventina di film , e si arriva, nel 2.000, ad un film che ti ha fatto vincere tanti premi, “Ettore”.
“Si, è in assoluto il mio film più premiato. Anch’esso è nato per caso. Un’amica mi diceva da tempo di andare a trovare un personaggio che aveva creato un Museo della civiltà contadina: Ettore Guatelli. Lo andai a trovare, passammo insieme tutta la giornata, raccogliendo cosi 4 ore di filmato. Poi, con un lavoro mastodontico di montaggio, ne realizzai un film di 8 minuti. La cifra predominante di questo lavoro è che mi soffermo soprattutto sull’uomo andando a scavare nel suo intimo, tanto è che lui, personaggio burbero, al momento di salutarci mi ha detto: non so come hai fatto ma mi hai fatto dire cose che non avevo mai confessato a nessuno. A lui il film non piacque: si aspettava una maggior attenzione sul suo Museo (quasi una sorta di catalogazione del materiale raccolto). Invece nel cortometraggio il suo Museo diventa una scenografia dove lui è il protagonista”.
Delle opere successive a te piace poi ricordare di “Gnam Gnam”, realizzato nel 2001.
Si, è un lavoro nato come concorso interno al nostro Cineclub. E’ un cortissimo di 1 minuto sul cibo. Il protagonista sta per mangiare una bistecca, mentre in TV parlano della “mucca pazza”. La moglie, allora, gli toglie il piatto e al posto della carne gli mette un pesce. In quel momento la TV segnala una moria di pesci a causa dell’inquinamento da mercurio. La moglie, allora, gli toglie il pesce e gli mette un’insalata. A malincuore l’uomo si appresta a mangiarla ma, proprio in quel momento, la televisione segnala il pericolo di grave inquinamento da anticrittogamici. La moglie, a questo punto, non fa in tempo a togliere anche il piatto di verdura, perché il marito l’abbraccia e la porta fuori dalla cucina. In televisione, a questo punto, vediamo che l’uomo, a mo’ di cannibale, mangia la moglie che sta cuocendo -nuda- dentro un pentolone.
E’ un film cortissimo (un minuto) e ci vuol più tempo a raccontarlo che a vederlo. E’ tutto giocato sulle espressioni dei due interpreti e non ci sono parole, se non quelle della televisione.
Ha avuto riconoscimenti?
“Si, alcuni. Il più importante è stato quello di figurare tra i 24 finalisti del Concorso mondiale di Slow Food ,con migliaia di partecipanti. E mi sono trovato a Bra con autori da tutto il mondo: di italiani eravamo solo in 3. A distanza di anni, inoltre, ogni tanto mi viene richiesto. Cinque o sei mesi fa, per esempio, era interessata a “Gnam gnam” un paese dell’estremo oriente (mi sembra l’Indonesia).
Nella tua filmografia , dopo “Ettore” figurano altri titoli con dei nomi di personaggi. A chi si riferiscono?
“Si, sono “Giorgio” e “Renato” del 2006 e “Paolo” del 2008. Come “Ettore”, appunto, rientrano in un filone di ritratti di personaggi, per lo più artisti, di settori molto diversi. Giorgio è un artista della lavorazione del ferro.: per esempio, ha fatto le armature per tante contrade del Palio di Siena Lavori artistici e certosini nel contempo. Renato è un pittore molto particolare: per tanti anni ha lavorato esclusivamente sulla lettera “A”, dipingendola nei modi più impensati. Paolo, invece è uno che lavora con il ferro e l’acciaio inventando un nuovo modo di creare sculture, che è unico al mondo,”
Tra le opere successive ne figurano alcune in cui compare la parola Pisa: chiaramente un omaggio alla città dove abiti. Tra esse, “Pisa, Donne e Leopardi” del 2011.
“E’ un lavoro ambientato ai giorni nostri con flashback nell’800 nel periodo in cui Leopardi ha soggiornato a Pisa, dove ha scritto alcune delle sue liriche, e tra esse “A Silvia” che per me è la più bella di tutte. E’ importante dire che è un film di documentazione in cui vi è un’immagine di Leopardi diversa da quella che ci viene descritta: vediamo un Leopardi che frequenta feste, circondato da amici. Particolare importante del film è che vi sono state coinvolte 160 persone, una grossa impresa da un punto di vista organizzativo. E’ un’opera di circa 40 minuti”.
Una parte del cast di “Pisa, Donne e Leopardi”
Veniamo ad altri tuoi film che si distinguono in modo particolare, “Nutema”, per esempio, del 2011.
“E’ un lavoro di carattere scientifico, realizzato per un settore di ricerca dell’Università di Pisa, destinato ad essere portato in alcuni Congressi in giro per il mondo”.
Vi è poi , sempre del 2011, “Festa del Teatro”.
“E’ un film che rientra in una bellissima esperienza di Corte Tripoli Cinematografica, dove, oltre al cinema, vi è una Compagnia teatrale che è associata alla FITA che ogni anno organizza un Convegno nazionale. Quattro anni fa, all’Isola d’Elba, realizzammo un documento filmato di questo Evento. Abbiamo creato, utilizzando anche il dolly, un ottimo prodotto. Ma io lo ricordo, soprattutto, come esperienza umana molto bella, perfettamente in sintonia con quelli che dovrebbero essere i nostri obiettivi prioritari, cioè realizzare dei buoni prodotti divertendosi e in grande armonia”.
Nella tua filmografia figurano poi un’altra quindicina di opere. Tra esse, una riguarda “Montecatini e il cinema”, città in cui si svolge un Festival Internazionale FEDIC. Di che tratta?
“E’ un lavoro di mezzo minuto, realizzato nel 2012 nell’ambito ,appunto del Festival di Montecatini. Si riferisce ad un workshop che ha coinvolto 8 giovani italiani, 7 giovani ucraini e un russo. Abbiamo preso una musica di Giovanni Crocè utilizzata come sigla di “FilmVideo”. E su questa sigla abbiamo realizzato un mini film ambientato a Montecatini. La particolarità di questo lavoro consiste, al di là del risultato che comunque considero buono, nel percorso fatto per arrivarci. Un percorso fatto di mini gruppi( 4 gruppi di lavoro interscambiabili) in cui gli italiani venivano rigorosamente mescolati agli ucraini. Il risultato è stato che alla fine, al momento del commiato vi sono stati baci, abbracci e tante lacrime. Si erano create delle belle amicizie”.
Amicizia , una parola che è alla base dell’impegno di Roberto Merlino nella FEDIC. Lo hanno rilevato in tanti, soprattutto in occasione dei lavori assembleari annuali di Montecatini, esprimendo poi la propria testimonianza su Nuovo Fedic Notizie. Relativamente all’ultima Assemblea, le si può leggere, per esempio, nel numero 29( marzo 2016) del Notiziario FEDIC. In particolare, vi è Giorgio Ricci che sottolinea che “ si è respirata l’aria degli ultimi anni caratterizzata dal sorriso e dall’ottimismo”, mentre Maria Teresa Caburosso “ritornata in compagnia di vecchi amici “ ha rilevato che il Presidente Merlino ha saputo gestire il tutto, con serenità, pacatezza e amicizia”. Soddisfazione per l’andamento dei lavori all’ultima Assemblea hanno anche espresso Beppe Rizzo, Monique Martini, Lauro Crociani, Ettore Di Gennaro, Rossana Molinatti e Biagio Lammoglia che, in particolare, ha sottolineato di essere stato all’Assemblea come rappresentante di un piccolo Cineclub ( Certosa-Casteggio) ed essere ripartito sentendosi parte di un grande progetto.
I progetti, appunto.
Sono all’insegna dell’impegno di diffondere il cinema indipendente. Roberto Merlino lo ha sostenuto anche nell’ambito della 71.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, quella del 2015, al Forum FEDIC. Un impegno testimoniato da un’intensa attività volta innanzitutto “ a dare visibilità ai film FEDIC”. Attività che poi ha riassunto in alcune principali iniziative: la creazione del REFF(Rete Festival FEDIC), la trasmissione televisiva “Corti di Corte” ( trasmessa da “Di Lucca TV” e visibile anche su “Teleambiente”) che offre la possibilità di diffondere le opere degli autori FEDIC dagli anni ’50 ad oggi. Ed inoltre, favorire lo scambio di ”compilation” con i film dei propri Soci tra i vari Cineclub, accedere a un Sito FEDIC rinnovato e a You Tube con la possibilità di essere informati sulle attività della Federazione e di visionare parecchie centinaia di film di Soci, consentire agli autori FEDIC di rappresentare l’Italia, con una selezione di cortometraggi, al Festival Mondiale dell’ UNICA e far vedere alcune opere in occasione del Forum FEDIC alla Mostra del Cinema di Venezia, offrire la possibilità di far vedere i film FEDIC in differenti sedi internazionali: portoghesi, russe, ucraine, irlandesi, ecc., ma anche nello Stage Nazionale di Formazione, che è una delle attività importanti della FEDIC. Non meno importante, ha aggiunto, è l’attività dell’informazione che è esplicitata attraverso il Nuovo Fedic Notizie( bollettino mensile di una quarantina di pagine, che arriva ai Soci con notizie dei Cineclub) , la Rivista on line di approfondimento cinematografico “Carte di Cinema”, il Sito e il Facebook FEDIC. Parecchie cose buone ha sottolineato, aggiungendo che altre ne sono in cantiere. Si può essere appagati di tutto questo? ha concluso. L’impegno della Federazione , ha sostenuto, è quello di volere e di dover fare ancora di più. E tra gli obiettivi indicati, nell’ultimo numero (il 29) di Nuovo FEDIC Notizie dichiara di voler dare “un’accelerazione che porti con risultati tangibili sia all’aumento del numero di Cineclub sia ad accrescere e fortificare il senso di appartenenza FEDIC, perché se la FEDIC cresce, cresciamo tutti”.
E constatata, come ho avuto l’occasione di rilevare in più occasioni, l’energia, la volontà e la capacità con le quali porta avanti, con la collaborazione del Consiglio Direttivo e di vari collaboratori che è riuscito a coinvolgere in una fattiva attività, c’è da credere che la FEDIC di passi avanti, numerosi e qualificati, ne farà sicuramente. Le premesse ci sono tutte. E, a mio parere, la determinazione a raggiungere i migliori risultati possibili pure.
FILMOGRAFIA
1982
5 cortometraggi sulla “circolazione in bicicletta”
6 cortometraggi sulla “circolazione in ciclomotore”
1991
Amaro flauto dolce
1992
Di chi la colpa?
Il cognome della rosa
1993
Primavera
Vita insieme
Ali per volare
1994
Spot Istituto “Fossati”
Spot Istituto “Arzelà”
Spot Istituto “Cardarelli”
Rosa
1995
La bella Sarzana
Solidarietà è vita
Due rotelle per la vita
1996
Una lezione di vita
Fraintendersi
Prestito mortale
Da quel biglietto
Arcola
1997
Occhio (e orecchio) alla strada, Pierino
Kinzica
Lunigiana tra sogno e realtà
1998
Progetto Ambiente
Sarzana tra realtà e passato
Circoscrizione Cinque
Dove si incontrano gli angeli
Racconti partigiani
Documentazione-attività Scuola Elementare S. Lazzaro
Notte d’estate a Francoforte sul Meno
1999
Documentazione Lab.- teatrale Scuola Media “Poggi-Carducci”
Documentazione Lab.-cinematografico S. M. “Poggi-Carducci”
Documentazione Lab-teatrale Scuola Media “Gamerra”
Documentazione lab-cinematografico S. M. “Gamerra“
AUSER
Facciamo un film a Castelfiorentino
No,… Kulesciov no!
Ponticello borgo di Lunigiana
Interviste sul fumo
2000
Documentazione Attività teatrale alla Gamerra 1999-2000.
Ettore
L’ultimo svedese (in italiano) (co-regista con A. Vanello)
L’ultimo svedese (in gramelot) (co-regista con A. Vanello)
C.I.C.
Documentazione Attività teatrale alla Poggi-Carducci
Serata Livornese
Senza Storia
Gioco del Ponte
Museo di Montefoscoli
Didattica cinematografica a Vagli
Spot “Le Crete” Uno
Spot “Le Crete” Due
Coltano-Luce
2001
Cantando il Natale
La nonna
Gnam Gnam
Mosca
Rotella a Pisa
Sclat 2000-2001
Veleni alla Calandriniana
La Soffitta nella strada
Musica del Salento
Hotel Fiascherino
Poesia in concerto
Storia della vite e del vino in Sardegna
2002
Pisa per la solidarietà
Alfa Livorno
Ponte dei sospiri
Vincolo di amicizia
Otello a Vertigo (cast 1)
Otello a Vertigo (cast 2)
Mare generoso
Vernacolo a Calci
La più bella
2003
Concerto dell’Orchestra Hermitage di San Pietroburgo
Il sostegno
La vicenda der Conte ‘Golino
Mi musica es tu musica
Pisa e la terza età
Un artista tra i polli
2004
Ferrara, una città su due ruote
Genìo
La scelta di Elisa
Yambo
2005
Spot per Pubblica Assistenza di Pisa
Perle ai porci!
Back-stage ripresa 1
Back-stage montaggio 1
Back-stage Stage Nazionale FEDIC a Fauglia e S. Maria a Monte
L’Albero di Putignano
2006
Giorgio
Renato
HOT ICE
HOT FEVER
HOT PROVINO
HOT DREAMS
Back-stage S. Giovanni Valdarno del 2006
2007
Gita nel parco
Back-stage Sceneggiatura esperti
Back-stage Ripresa 2° Università
Back-stage Montaggio 2° Università
Back-stage Ripresa 3° Università
Back-stage Ripresa 4° Università
Il Maestro
Back-Stage de “Il Maestro”
Back-eros
2008
Molto utile! Nessun profitto (backstage foto)
Molto utile! Nessun profitto (backstage video)
Paolo
2009
“Il pittore delle marine”
“Bon Ton” 1’ di Marilena Checchi e Roberto Merlino
“Una troupe in Sicilia”
“Franco” 11’
“Characteri”
“Concorso di Montaggio creativo a Cascina”
“La scelta”
2010
Backstage Ripresa 6°
Backstage Montaggio 3°
B-S 7° Stage Nazionale Fedic
Un nodo nel legno
Par condicio
Backstage ripresa 7°
Il “teleracconto” applicato ad “Amore e Psiche”
Persone
Backstage “Persone”
Backstage Fotografico “Pisa, Donne e Leopardi”
Backstage Video “Pisa, Donne e Leopardi”
Backstage “Ripresa 5°”
2011
Pisa, Donne e Leopardi
Nutema
Festa del Teatro
Backstage Nazionale FEDIC 2011
Corte Tripoli Cinematografica
2012
Il naif dei fiammiferi
Saharawi a Cascina
Backstage Workshop Crocé
Montecatini e il Cinema
2013
Un ragazzo sfortunato
Brunero
Cassio
Filarmonica a Calci
Giornata mondiale del libro a Pisa
Newton
2014
La luminara
Una visita inattesa
Back-stage fabbrica
2015
Milano- EXPO 2015
Inno FEDIC
NESSUN UOMO È UN’ISOLA
L’Assemblea FEDIC a Montecatini
di Vivian Tullio.
Anche quest’anno si è svolta a Montecatini Terme l’Assemblea Nazionale dei Presidenti dei Cineclub affiliati alla FEDIC, appuntamento organizzato per riunire i Presidenti o i delegati dei Presidenti per espletare da parte della Federazione le formalità burocratiche obbligatorie: in particolare, la relazione morale del Presidente sull’attività svolta dal Consiglio Nazionale FEDIC, la presentazione e l’approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo, la Relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. A ciò si aggiungono le relazioni sulle ulteriori attività e opportunità che la FEDIC offre ai suoi associati. Anche quest’anno, come l’anno scorso, per alleggerire gli incontri dedicati alle questioni burocratiche sono stati organizzati momenti di intrattenimento sia per i Presidenti che per i loro accompagnatori, il tutto allo scopo di favorire l’aggregazione e la partecipazione alla vita della Federazione anche da parte dei semplici Soci.
Vivere in un’associazione non è un fatto puramente organizzativo: vi si partecipa sempre volentieri perché l’assemblea contribuisce attivamente a creare un clima sociale e intellettuale favorevole ai rapporti interumani e, mediante lo scambio di opinioni e di idee, favorisce lo spirito di appartenenza e stimola l’innovazione e il cambiamento.
Recita la famosa poesia di John Donne:
“Nessun uomo è un’isola
Appartenente interamente a se stesso.
Ogni uomo è parte della terra
Una parte del tutto”
Chi scrive, infatti, è convinta che incontrarsi per discutere delle tematiche che ci interessano e condividere le differenti esperienze, nel nostro caso sul cinema, sia importante per rafforzare le amicizie e di conseguenza ci faccia migliorare anche come persone: sarebbe bene che tutti i Presidenti vi partecipassero perché si troverebbero sicuramente bene e apprezzerebbero quanto viene fatto.
Ma vediamo come è stato il Programma dell’Assemblea di quest’anno che si rinnova di volta in volta. Innanzitutto, sempre nell’ottica di una piacevole accoglienza e, grazie alla tesoriera FEDIC, ci siamo incontrati in un albergo a Montecatini dove non eravamo mai andati, l’Hotel Adua & Regina di Saba e devo dire che il servizio è stato all’altezza delle aspettative, anzi nettamente superiore. Un bell’albergo dotato di SPA con piscina, ottima cucina, personale cordiale e premuroso. Mentre alcuni partecipanti, arrivati un giorno prima, si sono rilassati in piscina o hanno passeggiato per Montecatini, il Consiglio si è riunito per mettere a punto l’organizzazione dell’Assemblea e per sentire le relazioni dei Responsabili della Commissione Scientifica, della Cineteca e del Sito FEDIC su quanto è stato fatto e su cosa c’è da fare. Mentre i lavori relativi al Forum e al Premio FEDIC alla Mostra di Venezia, la pubblicazione di Carte di Cinema, la realizzazione del nuovo sito web della FEDIC (strutturato per permettere ai diversi Cineclub di pubblicare le loro notizie e per condividere le informazioni sulla Federazione) proseguono attivamente, purtroppo, per quanto riguarda la Cineteca ci sono al momento alcune problematiche da risolvere.
Il sabato, sono arrivati i diversi Presidenti e Referenti, provenienti da Genova, Milano, Venezia, Alassio, Brescello, Chianciano, Cagliari, ecc. Tra i partecipanti anche Nedo Zanotti, famoso e bravo cartoonist che non si vedeva da numerosi anni e che ha fatto piacere rivedere, così come avvenuto per Monique Martini, presidentessa del CC Filmcaravan di Imperia che mancava dall’incontro annuale da qualche anno, Maria Teresa Caburosso, ex Consigliere FEDIC, collaboratrice di FEDIC Scuola, venuta in rappresentanza del Presidente Onorario FEDIC Massimo Maisetti, e Presidente del CC ISCA di Milano, impossibilitato a partecipare per problemi di salute. Presente come ogni anno anche Beppe Rizzo del CC Alassio che non fa “mai un’assenza”, come i suoi allievi di inglese avranno fatto per tanti anni. Non poteva mancare Rossana Molinatti del CC Venezia, veneziana DOC e artista. Pregevoli le sue maschere per il Carnevale di Venezia che rappresentano ogni anno diversi quadri di pittori moderni e contemporanei.
Nel primo pomeriggio, dopo la visione del videoclip di Laura Biggi e Lorenzo Caravello, le cui immagini, accompagnate dall’Inno FEDIC, ci raccontano in breve la FEDIC di ieri, di oggi e di domani, è iniziata l’Assemblea dei Soci con la Relazione morale del Presidente Merlino che ancora una volta puntualizza l’importanza di diffondere la FEDIC, perché se la FEDIC cresce cresciamo tutti. “Inoltre – prosegue il Presidente Merlino – è fondamentale che i Presidenti comunichino ai propri Soci ciò che la Federazione mette a disposizione per gli affiliati e che stimolino i Soci a visitare il sito per vedere le opportunità che, spesso i Soci non conoscono!” Il sito FEDIC, curato e illustrato ai partecipanti da Ettore di Gennaro, Presidente del CC 3DProduction, è stato rinnovato, ampliato e reso più accattivante, con spazi utilizzabili e personalizzabili dai singoli Cineclub. Insieme al sito è stata attivata anche la pagina Facebook e Twitter, che permettono alla FEDIC di stare al passo con i tempi, sempre più tecnologici nel campo della comunicazione.
A fare da cornice alle formalità che l’Assemblea deve espletare per quanto riguarda i bilanci Consuntivo e Preventivo, i due Concorsi, uno relativo alle FOTO di SCENA e l’altro sugli STORYBOARD. Una ventina le opere presentate, votate dai Presidenti presenti che hanno consentito ai Cineclub vincitori di guadagnare alcune Tessere omaggio della FEDIC. Piacevole è stato anche lo Spazio Cineclub, dove alcuni Club hanno sia presentato la loro attività ma hanno anche potuto scambiarsi informazioni, trovare collaboratori e, soprattutto, conoscersi.
Nel frattempo l’Assemblea proseguiva il suo programma, con le brevi relazioni dei responsabili di settore che hanno presentato la loro attività presente e futura, aggiornando i Presidenti su quanto è stato fatto e su quanto potrà essere ulteriormente fatto. In particolare, Laura Biggi responsabile di FEDIC Scuola e Presidente del CC Cineamatori delle Apuane, conscia del fatto che non tutti sono a conoscenza delle possibilità che la Scuola possa offrire alla Federazione e viceversa, si è resa disponibile a visitare i Cineclub interessati per illustrare come portare avanti l’attività cinematografica in ambito scolastico. Anche in questo caso la diffusione e la condivisione delle informazioni e quanto si sta facendo è una carta vincente, come dimostrato dal fatto che il suo Cineclub è stato contattato da un Ente di Varese esterno alla FEDIC proprio a seguito della presentazione sul sito del Cineclub del Campus estivo per Ragazzi sul Cinema e della loro opera di divulgazione cinematografica nelle scuole. Gianluca Castellini, Presidente del CC Sedicicorto e organizzatore del Festival Sedicicorto di Forlì ha aggiornato i presenti sulla rete dei Festival FEDIC REFF di cui è responsabile e ha presentato la nuova iniziativa FEDIC Box, una piattaforma dove poter inserire materiale e filmati storici e recenti che riguardano la FEDIC, in una sorta di archivio dinamico che possa fungere da Memoria FEDIC. Paolo Micalizzi, responsabile di FEDIC Cinema e nuovo Direttore già da un anno della rivista on-line ‘Carte di Cinema’, ha relazionato su come stia organizzando, per la prossima Mostra del Cinema di Venezia, il Forum FEDIC associato al Premio FEDIC che porta avanti ormai con soddisfazione e successo da oltre 20 anni. Da qualche anno, inoltre, al Premio collabora anche Cir-Food ed è stata istituita appositamente una Menzione FEDIC – Il Giornale del Cibo al film dove viene dato un particolare risalto al cibo. Interviene poi, Rolf Mandolesi, Presidente del CC Super8&Videoclub di Merano, e Responsabile per l’Italia dell’UNICA da 19 anni, che racconta l’esperienza FEDIC a San Petersburg nel 2015 e illustra la nuova organizzazione “più economica” che il nuovo Presidente UNICA vorrebbe attuare alla prossima manifestazione del 2016 a Suceava (Romania), anche per dare maggior spazio e accessibilità ai giovani. Il Presidente Merlino, nel ringraziare, poi, moltissimo Angelo Tantaro, Presidente del CC Roma, per la sua attività di coordinamento tra FEDIC, Ministero (MIBAC) e le 9 associazioni di Cinema, legge il documento che egli ha inviato, in quanto impossibilitato a partecipare all’Assemblea. È la volta di Maurizio Palmieri, Responsabile dello STAGE FEDIC che annuncia l’argomento del prossimo stage, ovvero la REGIA. Lo stage riscuote anche quest’anno come gli altri anni molto successo, in quanto i posti si sono esauriti già dall’apertura del bando a gennaio. La novità dello stage è l’affidamento al giovane e affermato regista Alessandro Grande di un progetto biennale iniziato l’anno scorso con la stesura della sceneggiatura e che terminerà quest’anno con la regia di un breve corto. Interviene poi Giacomo Bronzi componente FEDIC del Comitato del Valdarno Cinema che comunica le date della 34ma edizione del Festival (3-8 maggio) e illustra brevemente il programma di massima.
Accolti poi con entusiasmo i nuovi Cineclub Vertigo della Toscana e Gooliver della provincia di Padova nelle persone di Sergio Brunetti, delegato del Presidente e Federico Massa, Presidente, che salutano cordialmente l’Assemblea. Accoglienza affettuosa anche per Biagio Lammoglia, nuovo Presidente del CC Certosa di Vigevano che ha dimostrato entusiasmo e, al contempo, rammarico perché il suo Cineclub non aveva mai partecipato all’Assemblea fino a quest’anno. Felice rientro in FEDIC anche da parte dell’amico Lauro Crociani, Presidente del CC Immagini e Suono di Chianciano che per un anno non aveva potuto essere presente, ed è tornato perché in FEDIC – sono parole sue – trova confronto e condivisione. Un calorosissimo benvenuto a tutti!
Anche Massimo Maisetti Presidente onorario FEDIC, purtroppo trattenuto in Puglia, saluta per telefono l’Assemblea e gli amici inviando un caloroso abbraccio, che tutti hanno contraccambiato con affetto.
Come di consueto si sarebbe dovuto proiettare il Videogiornale 2015, realizzato da Giorgio Sabbatini, Presidente del CC Piemonte e Consigliere, ma per ragioni di lunghezza e di spazio non è stato possibile. Il Videogiornale, infatti, raccoglie i momenti più significativi dell’attività dei Cineclub e quest’anno, poiché la partecipazione è stata più ampia, il video durava oltre 90’!!! In ogni caso, il DVD è stato distribuito ai singoli Cineclub affinché possano visionarlo nelle proprie sedi.
Chi scrive, anche quest’anno, in qualità di Segretaria FEDIC, ha ricordato ai Presidenti, in una breve lezione, come compilare in modo corretto gli obbligatori modelli Ministeriali, ostici ma, importanti e necessari per ricevere i contributi per i Progetti.
Altri momenti istruttivi (e piacevoli) dell’Assemblea sono stati quelli riguardanti la proiezione di alcuni video in un Concorso appositamente istituito per l’Assemblea con premi in tessere FEDIC, e una specie di gioco di doppiaggio da svolgersi in piccoli gruppi. Ad ogni gruppo, composto da un massimo di 4 persone è stata assegnata a sorte una breve clip tratta da diversi video di Soci FEDIC alla quale è stato tolto l’audio. Ogni gruppo in modo indipendente ha dovuto, nella notte dopo la fine dell’Assemblea, cercare di doppiare in modo plausibile la clip assegnata e consegnare la mattina dopo il lavoro svolto. Anche se non c’erano premi in palio i diversi gruppi si sono ampiamente dedicati al compito con molto impegno, sottraendo ore preziose al sonno ma divertendosi moltissimo. Rossana Molinatti ha dichiarato, infatti, di non essersi mai divertita tanto ad un’Assemblea FEDIC!
La mattinata di domenica è stata, inizialmente, dedicata alla distribuzione, ai Presidenti, delle Compilation dei Cineclub e dei film dei vari Festival (UNICA, Valdarno Cinema, MISFF) e poi lasciata a disposizione dei Presidenti dei Club per esporre le loro problematiche sul territorio, soprattutto per quanto riguarda la SIAE, o le difficoltà nel reperire Soci o nel portare avanti l’attività ma anche per esprimere pareri e suggerimenti, allo scopo di migliorare l’attività della Federazione.
Infine, anche quest’anno, c’è stata la Premiazione ai Cineclub che hanno totalizzato il maggior numero di punti, vuoi per numero di Soci, vuoi per le diverse attività effettuate. Anche quest’anno si è aggiudicato il 1° Premio (1.500 euro) il CC Corte Tripoli Cinematografica, mentre il 2° Premio è andato al CC Gruppo Cineamatori delle Apuane che ha vinto 1.000 euro, e il 3° Premio, di 500 Euro è andato al CC Super8&Videoclub di Merano.
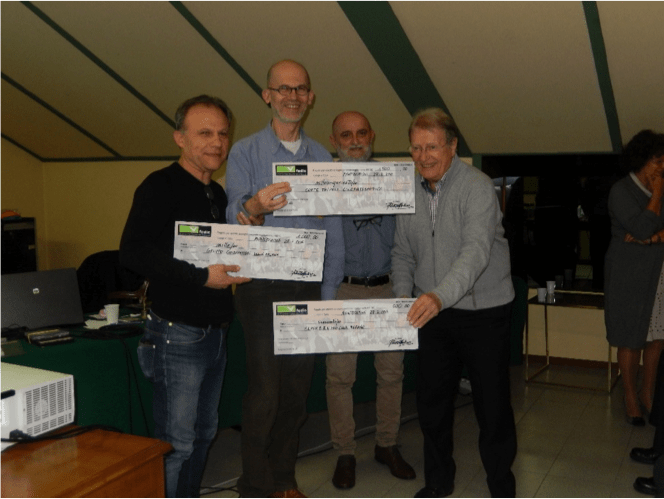
I vincitori del Premio ai Cineclub. Da sx Lorenzo Caravello, Sergio Brunetti Roberto Merlino, Rolf Mandolesi (foto G. Sabbatini)
Un’Assemblea positiva, dunque, fatta di dibattito costruttivo, di condivisione e di partecipazione che si conclude con una piccola storia raccontata dal Vice Presidente Giorgio Ricci che fa riflettere sull’importanza dello stare insieme in un’Associazione, e della capacità di tutti ma soprattutto da parte del Consiglio Direttivo, di sapere ascoltare le esigenze dei propri associati.
Il grillo del signor Fabre
Siamo a Londra. In una vasta e tumultuosa via alberata di Londra. Strepito di cavalli e di carrozze, vociare di mercanti e di strilloni. Trambusto di uomini e di mezzi. Chi corre perché ha fretta. Chi passeggia. Un po’ di tutto. Un via vai continuo. Ma ecco… quel signore che si è fermato. Pare in ascolto. Ma di che? Trattiene per un braccio l’amico e gli sussurra: “Senti? C’è un grillo!”. L’amico lo guarda stralunato: com’è possibile sentire il cri-cri di un grillo in quel mondo di rumori? “Ma cosa dice, professore? Un grillo?!”. E il signore, che si è fermato, come guidato da un radar, si accosta lentamente a un minuscolo ciuffo d’erba ai piedi di un albero. Con delicatezza sposta steli e dice: “Eccolo!”. L’amico si curva. E’ davvero un piccolo grillo. Stupore per il fatto del grillo a Londra. Ma doppio stupore per averlo sentito. D’accordo. Per avvertire certe “voci”, occorre grande capacità d’ascolto. E quel signore ce l’aveva.
Era il grande entomologo francese Jean Henry Fabre. E la sua grande capacità di ascolto era rivolta in modo specifico al mondo degli insetti.
“Ma come ha fatto a sentire il grillo in tutto questo chiasso?” domanda l’amico al signor Fabre, mentre riprendono il cammino.
“Perché voglio bene a quelle piccole creature. Tutti sentono le voci che amano, anche se sono debolissime.”
Il racconto è di Jean Henri Fabre – Entomologo
.
FESTIVAL ED EVENTI
MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
PREMI, OPERE, OSPITI DEL MISFF66
di Paolo Micalizzi
Un MISFF (Montecatini International Short Film Festival) sempre più in crescendo, in riferimento ai quattro anni di presidenza di Marcello Zeppi. Se ne è avuta testimonianza alla 66.a edizione , svoltasi nella tradizionale sede di Montecatini Terme dal 18 al 24 ottobre 2015. Un Festival che, secondo gli intenti del Presidente, si svolge all’insegna di dare un contributo alla formazione delle nuove generazioni. Per questo, l’occhio è a tematiche importanti in grado di poter coinvolgere il maggior numero di soggetti possibili: identità e appartenenza, volontariato, handicap, formazione, scuole, future generazioni, creatività. Tematiche sviluppate in alcuni workshop. Molto consistente, in particolare, il rapporto con le Scuole, come si può constatare dall’apposito articolo di Laura Biggi pubblicato in questo numero.
Consistente, più degli altri anni , è stato il Concorso Internazionale del Cinema che ha presentato nelle otto giornate di proiezioni del Festival 125 opere delle oltre 500 pervenute da tutto il mondo registrando una partecipazione di oltre 70 Nazioni: di italiane ne sono state selezionate 65. Significativa poi la presenza di ospiti stranieri, registi ma anche componenti della Giuria internazionale che era presieduta dal docente universitario spagnolo Alfonso Palazòn che, anche nella sua qualità di documentarista, ha tenuto un’interessante lezione sulla natura del documentario toccando le fasi importanti dell’ideazione, classificazione, motivazione e produzione.
La sezione Fiction ha visto vincitore “The Way of Tea” del francese Marc Fouchard, nomination all’Oscar per il cortometraggio. Protagonista un giovane skinhead che entra in un negozio di alimentari con l’intenzione di impadronirsi ,con arroganza ,di un po’ di merce. Viene affrontato con calma e sicurezza dal padrone del negozio, non con violenza ma con l’offerta di una tazza di tè. E, successivamente, userà la stessa “arma” con un gruppo di balordi che rimangono stupiti, e presi contropiede, dall’intervento del padrone del negozio. Un’opera, raccontata con ampio respiro, che la Giuria ha premiato “ per la capacità di cogliere i rischi e sapere andare oltre la propria identità per trovare nuove soluzioni per dialogre rispettando le differenze, anche quelle che non ci piacciono”: Il cortometraggio ha anche ricevuto il Premio del ”Workshop di Giuria” condotto da Roberto Merlino.
Per l’Opera Prima, premiato “Aidiyet” del turco Serkan Ertekin, incentrato su una vecchia nave rimasta bloccata a Istanbul sulla quale sono nate delle leggende. Un’opera dalle immagini affascinanti, ricca di simboli dai significati spirituali che, secondo la Giuria è” capace di catturare simboli ed emozioni irrazionali per raccontare e condividere il mondo di oggi”. Per il documentario il “The Best” è stato attribuito a “Tres mujeres “ dello spagnolo Alexis Delgado Burdade che è incentrato su tre donne detenute in un carcere che rivelano i loro pensieri intimi. Tre ritratti pieni di umanità con , secondo il parere della Giuria, “ un ritmo narrativo che sorprende ed è empatico alla realtà che racconta”. La Fiction è appannaggio di un corto francese, “Papa dans Maman” di Fabrice Bracq, dove due sorelline interpretano, con l’ingenuità della loro età, i gemiti della madre, che sentono dietro la porta, mentre fa l’amore con il marito, almeno cosi esse pensano fino a quando sentono il padre entrare in casa rivelando cosi allo spettatore che in fondo si trattava dell’amante. Un’opera, raccontata con tratti umoristici, che la Giuria giudica “capace di comunicare ai grandi come ai più giovani in piena sintonia con gli occhi dello spettatore che diventa complice appassionato della storia dei personaggi”.
L’animazione, ai russi per “The Hunt” di Andrew Katsuba , una caccia al cervo che potrebbe costare la vita al cacciatore ma soprattutto la sua umanità, quell’umanità che invece l’animale ha, il quale invece di spingerlo nel burrone, come potrebbe fare dopo una caccia estenuante, si allontana concedendogli di vivere. La Giuria lo ha premiato perché “ attraverso l’animazione cinematografica si possono umanizzare i personaggi”. Ma anche perché “lo short coglie l’obiettivo di far capire che il cervo ha più sensibilità e coraggio degli uomini. L’Italia s’impone con la sperimentazione. Il Premio dell’apposita Sezione è al Corto “Salt” di Alessandro Ingaria che ricorda il dramma dei migranti morti nel Mar Mediterraneo attraverso le vicende, metaforiche, di una lumaca. La Giuria lo ha premiato “ perché si può raccontare l’attualità senza cadere nella banalità. ’Salt’ riesce a farlo creando un universo nel quale gli elementi della natura mostrano tutta la loro forza come analogia dei drammi umani”. Per le “colonne sonore” premio a “Fangopolis”, film cecoslovacco d’animazione di Joanna Kozuch incentrato su un giovane violinista in procinto di esibirsi nel suo grande assolo nella Filarmonica della città di Fangopolis, ma nel viaggio in metropolitana viene sommerso dalla folla impaurita dal terrore che possa scoppiare una bomba. La motivazione del premio recita:” La musica è un personaggio capace di dare ritmo e gli elementi narrativi sono capaci di conquistare il narratore. L’immagine e la musica armonizzano in maniera perfetta apportando una narrativa stupenda”.
Altri i premi attributi da altre giurie: in particolare, quella popolare coordinata da Beppe Rizzo, ha dato la vittoria ad “Antoine” (Lussemburgo) di Cyrus Neshwad. Miglior Opera FEDIC è stata giudicata “Gli uraniani” di Gianni Gatti, presentato al Festival insieme all’attrice Sandra Ceccarelli che ne è la protagonista, dal Direttore Artistico Giovanni Bogani.
Sandra Ceccarelli è un’attrice che dopo il debutto nel 1984 con “Segreti segreti” di Giuseppe Bertolucci raggiunge la notorietà con il film di Ermanno Olmi “Il mestiere delle armi” (2001) e “Luce dei miei occhi” (2001) di Giuseppe Piccioni, per il quale vince la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. Conquista poi un “Nastro d’Argento” come attrice non protagonista nel film “Il più bel giorno della mia vita” (2002) di Cristina Comencini.
Nel film “Gli Uraniani” riveste il ruolo di una nota attrice degli anni ‘30 che va a curarsi l’artrite in una spiaggia poco frequentata, al riparo dalla fama e dalla notorietà ma soprattutto dall’ansia che le provoca l’inespresso rapporto amoroso che la lega alla sua dama di compagnia. Un sentimento che lega le due donne, la cui natura viene portata alla luce dall’arrivo di un eccentrico pittore, nei cui panni troviamo un intenso Pippo Delbono. Un’opera, questa di Gianni Gatti, che esplora il tema dell’omosessualità negli anni Trenta, epoca in cui non aveva una vera identità ed era negata dal regime. Un cortometraggio che dovrebbe diventare un film. Menzioni speciali hanno poi ricevuto altre tre opere di autori FEDIC: “Cibo, Amore, Identità” di Salvatore Occhipinti e Gaetano Scollo, “Margherita Aldobrandeschi una Donna di Maremma” di Antonella Santarelli e “Un Futuro da Gustare” di Lorenzo Caravello e Laura Biggi. Una menzione speciale per il tema Handicap è stata attribuita poi al cortometraggio “La Petite Casseruole”.
Tra gli ospiti importanti del MISFF66 anche le attrici Barbara Enrichi e Isabel Russinova e l’attore Edoardo Gabriellini. Uno dei temi portanti del Festival è stato il rapporto con le Associazioni del Volontariato, il cui coinvolgimento ha consentito un miglior rapporto con il territorio: i Lions di quattro città (Montecatini Terme, Pistoia, Pescia, Firenze), il Leo Club di Montecatini Terme, l’AVIS e la Croce Rossa della quale, in un’apposita iniziativa, è stato sottolineato, con filmati inediti e slide, il suo contributo nella “Grande Guerra”. Omaggio del Festival anche a Mario Monicelli ricordato, nel centenario della sua nascita, dal film “Il signor Monicelli” di Alberto Tempi che raccoglie una lunga intervista al regista ed all’attore Vittorio Gassman.
Tra le iniziative del Festival, da sottolineare il Salotto FEDIC in cui è stato fatto il punto su alcune problematiche che riguardano questa Federazione con l’intento di guardare alle sue prospettive future. Ma anche la Mostra “Arte&Cibo” con una cinquantina di opere, di vario stile, provenienti da diverse regioni d’Italia, dal Marocco, India e Ucraina.
con la cerimonia di premiazione e la consegna, tra gli altri, dell’Airone d’oro al pittore Silvano “Nano” Campeggi, artista di grande rilievo nella cartellonistica cinematografica italiana, autore di oltre 3.000 manifesti di film d grandi registi a livello mondiale. Un Premio alla carriera da sottoscrivere in pieno. “Nano” ha realizzato il suo primo Manifesto nel 1946 per il film “L’aquila nera” di Riccardo Freda. Molti successivamente i manifesti per film hollywoodiani tra cui opere mitiche come “Via col vento”, “Casablanca”, “Cantando sotto la pioggia”, “Un americano a Parigi”, “La gatta sul tetto che scotta”, “Exodus”, “Colazione da Tiffany”, “Ben Hur” e “Gigi” con il volto di Leslie Caron utilizzato come puntino sulla prima lettera “i”.
.
.
MISFF- FEDIC SCUOLA UN CONNUBIO VINCENTE
di Laura Biggi
Il rapporto tra cinema e scuola si può far risalire quasi alle origini del cinema.
All’inizio del secolo scorso, (nel 1913) infatti, Stefano Cremonesi proprietario di due sale cinematografiche e fondatore dell’associazione “CINEMA DOCET” pubblicava un opuscolo avveniristico dal titolo “La scuola dell’avvenire: ossia l’istruzione e l’educazione a mezzo del cinematografo”. La sua non fu un’esperienza isolata, ma inserita in una ricca rete di attività di promozione del linguaggio cinematografico sempre crescente sul territorio nazionale. Molti docenti con entusiasmo e motivazione avvicinarono il mondo della scuola a quello del cinema cercando di coniugare tradizione ed innovazione attraverso esperienze progettuali piuttosto ardite per il periodo storico.
A distanza di oltre un secolo e con l’avanzamento incalzante della tecnologia potremo credere che ormai il cinema sia una prassi consolidata nella didattica scolastica, ma in realtà non è proprio così. Ci sono scuole che hanno inserito il cinema nel POF (Piano dell’Offerta Formativa), ma non sono così numerose come potremo immaginare considerata la facilità con cui attualmente si possono effettuare videoriprese con apparecchiature alla portata di chiunque. Purtroppo, l’utilizzo del cinema nella scuola, rischia talvolta di rimanere relegato ad esplicare ancora e soltanto la funzione sussidiaria atta a favorire la maturazione del senso estetico e l’approfondimento tematico in ambito disciplinare. Il rapporto che nella scuola si deve creare con il linguaggio cinematografico è quello di lettura e scrittura, quindi la capacità sia di leggere, decodificare, analizzare un testo che di scriverne e realizzarne uno proprio. Il cinema non solo da vedere, ma da fare. Il cinema fatto dai ragazzi sarà quindi una libera espressione del se’ poiché non creato con finalità e vincoli commerciali.
FEDIC Scuola da sempre persegue l’obiettivo di conoscere e diffondere il linguaggio cinematografico inserendolo nella didattica quotidiana. Come nasce la collaborazione Fedic Scuola- MISFF? Le ultime due edizioni del Concorso di Cinematografia Scolastica SVMI (Scuola Video Multimedia Italia) si sono tenute proprio a Montecatini Terme nell’ambito del MISFF (Montecatini International Short Film Festival). Alunni e docenti dell’istituto Comprensivo Galileo Chini, invitati alla manifestazione, hanno prima assistito a proiezioni e premiazioni dei cortometraggi finalisti e vincitori, poi hanno partecipato attivamente ai laboratori di cinema.
Il MISFF ha allargato i propri orizzonti, non solo a livello geografico con la consueta impronta internazionale, ma rivolgendo l’attenzione alle esigenze formative del territorio coinvolgendo le istituzioni scolastiche. Sono stati organizzati incontri programmatici tra le varie componenti interessate: il presidente MISSF Marcello Zeppi, la dirigente scolastica AnnaMaria Pagni , la docente coordinatrice AnnaMaria Porciatti e la responsabile nazionale FEDIC Scuola Laura Biggi per concordare modalità di intervento nelle varie sedi scolastiche.
Nell’anno scolastico 2014/2015 sono state coinvolte tutte le classi terminali delle scuole primarie Casciani, De Amicis, Pascoli e Don Facibeni dell’istituto comprensivo Galileo Chini. L’intento era quello di far conoscere ai bambini strumenti e tecniche di base del cinema. Visione, analisi e realizzazione di diverse tipologie filmiche: fiction, documentario, spot, intervista (reportage), animazione. Conoscenza ed uso della videocamera con cenni su piani e campi di ripresa, inquadratura e regolazione fuoco manuale. Le riprese a circuito chiuso suscitano sempre sorpresa ed entusiasmo nei bambini. Esperienza di doppiaggio di brevi clip video tratte da film conosciuti, anche di animazione. Sonorizzazione e rumoristica. Animazione di materiali ed oggetti di uso comune. Effetti speciali (tecnica “Chroma key”).
Il laboratorio, della durata complessiva di circa 30 ore, si è svolto sia all’interno delle sedi scolastiche che in città alla scoperta di luoghi di interesse artistico – culturale di Montecatini.
L’esperienza cinematografica si è integrata perfettamente con le progettualità già esistenti nei vari plessi. Alla primaria Pascoli era in atto un percorso di conoscenza dello stile Liberty attraverso la scoperta e valorizzazione delle numerose e pregevoli opere dell’artista toscano Galileo Chini presenti in città. Si è pensato così di prendere accordi con l’insegnante Bruna Rossi coordinatrice del progetto per realizzare una sorta di documentario. I ragazzi si sono cimentati in ruoli tecnici usando a turno ed opportunamente microfono, cuffie, ciak ed altre strumentazioni di scena. Si sono alternati sia nel ruolo di reporter che in quello di “voice over” per descrivere e commentare le immagini filmate.
Nel mese di maggio 2015, presso il Palazzo del Turismo di Montecatini, alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe e delle autorità locali, sono stati presentati i video realizzati nell’ambito dei laboratori. Alunni, genitori ed insegnanti si sono dimostrati pienamente soddisfatti del risultato. La Dirigente Scolastica Dott.ssa Pagni ha espresso il proprio apprezzamento auspicando la prosecuzione del progetto cinema. Nello scorso mese di ottobre gli alunni dell’Istituto Comprensivo Chini sono stati coinvolti in workshop ed attività di formazione; hanno espresso il proprio parere su una selezione di cortometraggi in concorso nella veste di giovanissimi giurati.
L’esperienza “Giornalista per un giorno” ,in collaborazione con Barbara Sarri Presidente dell’associazione “Bambino sarai tu!” ,ha permesso agli studenti di elaborare quesiti sulla storia del MISFF ( in origine FilmVideo) e sottoporli ai passanti.
Al microfono dei mini-giornalisti anche personaggi noti tra cui Roberto Merlino Presidente FEDIC, il giornalista Paolo Micalizzi e lo stesso Marcello Zeppi Presidente del Festival.
I piccoli “reporter” hanno animato e movimentato la città, incuriosito e stupito, con la spontaneità delle loro domande residenti e turisti anche stranieri, con cui riuscivano a comunicare anche in inglese, francese e russo.
Nel corrente anno scolastico, in accordo con il Dirigente Scolastico ed il personale docente, i laboratori di cinema sono stati estesi anche a classi di scuola secondaria di primo grado dello stesso istituto. Il festival internazionale MISFF in collaborazione con FEDIC scuola offre opportunità formative e culturali durante l’intero anno. L’evento più recente è stato MISFF 4 YOU con il Convegno Cinema e Creatività ed il Festival del Cinema per ragazzi.
Il Convegno si è tenuto il giorno 18 marzo scorso presso la sala consiliare del comune di Montecatini Terme dalle ore 14,30 alle 17.
Dopo i saluti istituzionali di rito, Marcello Zeppi, presidente del festival, ha introdotto l’onorevole Silvia Costa Eurodeputato Presidente della Commissione Cultura che ha argomentato sulle prospettive di creatività a livello artistico, con particolare attenzione al mondo del cinema.
E’ intervenuta AnnaMaria Pagni Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Galileo Chini, sostenendo la grande valenza formativo- didattica del cinema nella scuola. Roberto Merlino Presidente FEDIC (Federazione Italiana Cineclub) ha ricordato con piacere ed emozione i suoi primi approcci nelle scuole del territorio pisano, ormai decenni fa. Ha inoltre sottolineato, come a livello scientifico, la drammatizzazione teatrale e cinematografica possa avere potere terapeutico in persone in situazioni di disagio personale e sociale. Laura Biggi Responsabile Nazionale FEDIC Scuola ha brevemente relazionato sulle modalità di svolgimento dei laboratori di cinema in corso, evidenziando l’importanza della continuità didattica tra i vari ordini di scuola, in particolare nel delicato passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. Il linguaggio cinematografico deve essere considerato traversale alle discipline di studio, in quanto concorre come ogni forma artistica allo sviluppo armonico della persona, affinando senso critico, estetico, creatività e cooperazione. L’assessore alla Cultura Bruno Ialuna, nella duplice veste di rappresentante dell’amministrazione comunale e di insegnante, ha fatto un escursus storico sul rapporto tra la città di Montecatini e grandi nomi del cinema internazionale. Sono intervenuti giovani autori che hanno presentato e proiettato i trailer dei loro film. Erano presenti inoltre musicisti, associazioni di volontariato, docenti, fondazioni, imprenditori, imprese culturali e sociali.
L’onorevole Costa ha concluso auspicando che la rete che si sta formando tra le varie categorie intervenute possa essere efficace e portare a rapporti proficui nel prossimo futuro.
Il giorno seguente, sabato 19 marzo, presso il cinema Excelsior di Montecatini, si è tenuta una rassegna cinematografica per le scolaresche della città. Nella prima parte della mattinata erano in programma film realizzati da FEDIC Scuola che hanno incontrato il favore della giovane platea di bambini e ragazzi. Nella seconda parte è stata proposta una selezione di film internazionali, in particolare animazioni, provenienti da tutto il mondo (Singapore, Ungheria, Cipro, Spagna, Italia).
Gli studenti, oltre un centinaio, sono stati chiamati ad esprimere il proprio parere sui film internazionali, decretandone i vincitori. Primo classificato: “Ciao, renna” una divertente animazione ungherese, al secondo posto il film italiano “La mosca”. I bambini hanno potuto porre domande e confrontarsi con Antonella Santarelli autrice di uno dei film in concorso. La conduzione della mattinata è stata affidata a Laura Biggi (FEDIC Scuola) e Mario Gilardi (Presidente AVIS e Vice Presidente MISFF). Conclusione e saluti a cura di Simone Gagliardi Presidente Commissione Cultura Comune di Montecatini Terme.
.
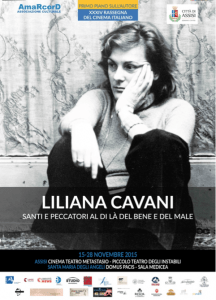 LILIANA CAVANI E LE PROSPETTIVE DEL NUOVO CINEMA ITALIANO
LILIANA CAVANI E LE PROSPETTIVE DEL NUOVO CINEMA ITALIANO
A “PRIMO PIANO SULL’AUTORE” DI ASSISI
di Paolo Micalizzi
“Primo Piano sull’Autore” ad Assisi per Liliana Cavani all’insegna del titolo “Liliana Cavani- Santi e peccatori: al di là del bene e del male”. Un titolo che riassume significativamente il cinema della regista di Carpi facendo riferimento alle tematiche che più hanno caratterizzato l’intera sua opera. E che si sono potute rivedere nei film della Retrospettiva a lei dedicata. Un’occasione quella della manifestazione diretta da Franco Mariotti con grande passione e capacità organizzative ma anche con signorilità che è giunta alla 34.a edizione, che quest’anno ha consentito di ripercorrere la filmografia di questa regista di primo piano del cinema italiano, e non solo perché i suoi film sono stati apprezzat e premiati anche a livello internazionale. Nel Convegno a lei dedicato, si è discusso poi, soprattutto, sulle tre opere che Liliana Cavani ha dedicato a San Francesco (1966, 1989, 2014) sottolineando, soprattutto, come “Francesco d’Assisi” del 1966 sia stato anticipatore del messaggio di fratellanza che caratterizza il Pontificato di Papa Francesco. Un’opinione che è stata ribadita anche nella motivazione dell’attribuzione della cittadinanza di Assisi “ come atto di riconoscenza per aver raccontato al pubblico internazionale la storia di San Francesco e per aver tracciato a più riprese e con profondità crescente il profilo del Poverello avvalendosi dell’energia e dell’equilibrio dell’indagine laica, riscontrando grande interesse di pubblico e di critica, oltre che valorizzando l’attualità del messaggio universale del Santo di Assisi, sulle strade del francescanesimo rinnovato da Papa Francesco”.
Una trilogia francescana, secondo Vittorio Giacci, che costituisce un caso, quello di un cineasta che per tre volte è tornato di seguito sul medesimo soggetto. E ciò, secondo lui, è motivato dall’essere una figura storica ed è la Storia che ne giustifica la reiterazione mentre “ sotto il profilo più specificatamente espresso, si tratta con ogni evidenza di una modalità che rientra a pieno titolo nella poetica di quest’autrice, i cui personaggi, come lei stessa ha più volte rimarcato, sono segno di contraddizione “in quanto contraddicono la retorica e i rituali del potere al quale tutti gli altri si adeguano” e qui Vittorio Giacci riporta un’analisi di Ciriaco Tiso contenuta nel suo libro sulla Cavani, edito nel 1975 da “Il Castoro”.
In quanto a Liliana Cavani, ha dichiarato che “San Francesco ha colto lo spirito dei tempi, in lui c’è una bellezza continua, coglie un’idea di fratellanza che c’è sempre stata negli uomini e continua ad essere raccolta”. Tre film su San Francesco, ma per lei ci sarebbe materiale anche per un quarto. Una figura, quindi, quella di San Francesco che l’ha segnata nel profondo. E in merito all’attribuzione della cittadinanza di Assisi ha dichiarato poi di “essere felice ed onorata di diventare concittadina di Francesco di Bernardone, inquieto giovane, quasi un ‘sessantottino’ che pareva troppo strano e confuso” cogliendo l’occasione per aggiungere:” Per anni il mio messaggio su di lui è sembrato troppo trasgressivo, ma grazie a Papa Francesco si sono chiariti equivoci secolari. San Francesco è il precursore di un’emancipazione intellettuale enorme quanto finalmente comprensibile a tutti”.
Nei contributi critici , che si potranno leggere nel prezioso Catalogo dedicato all’intera sua opera curato da Lilia Ricci per le edizioni Amarcord, si possono ripercorrere altri momenti filmografici importanti della regista: in particolare, “La pelle”(1981) tratto da Curzio Malaparte, “ I cannibali”(1970), “Il portiere di notte”(1974), “Il gioco di Ripley”(2002), “Dove siete? Io sono qui”(1994).
Viene recuperato anche un testo di Pier Paolo Pasolini dal titolo “La perfetta geometria” relativo al film “Milarepa”, un film bello, secondo lo scrittore, che tanto non appariva negli schermi e dove vengono esaltate con tanta evidenza le qualità espressive del cinema”. Non solo, afferma il regista che aggiunge:” La Geometria che sintetizza tutti i punti di vista possibili della vita (“vissuta e “vista vivere) di Milarepa, ha, come dire, tecnicamente , i caratteri della visione religiosa del reale, che è appunto sempre polivalente e onnicomprensiva( lo sguardo della santità ‘razionale’ è quello di un sublime e perfetto pittore cubista, che vede contemporaneamente tutte le superfici di una realtà oggettiva).
L’andirivieni di Milarepa, continua l’articolo di Pasolini, che cerca di sapere o un modello inaugurale di sapere attraverso cui interpretare la vita, nel film della Cavani si cristallizza in una serie di linee quasi rigidamente ritmiche: una successione di inquadrature ferme, di panoramiche per lo più irregolari( in cui si giustifica anche qualche movimento di zoom) su un mondo ‘profilmico’ stranamente geometrico anch’esso: un Abruzzo brullo e azzurro, spesso con nuvole o nebbie vaganti su distese di rocce perdute in una solitudine particolarmente profonda. Anche nella parte moderna, che fa da cornice e da fondamento all’esperienza religiosa di Milarepa, e che ha la funzione di renderla esplicitamente onirica, la “Geometria” (ripeto tecnicamente irregolare) è perfetta. Onirica anch’essa. Un sogno su cui si impianta un altro sogno”. Se la Cavani è stata la protagonista di “Primo Piano sull’Autore”, altre le iniziative collaterali di questa XXXIV Rassegna di Assisi, ed in particolare la sezione “Dove va il cinema italiano? Oltre la commedia, le nuove proposte “ dove si sono potute vedere alcune opere prime e seconde e cortometraggi di giovani autori italiani alquanto “invisibili” sugli schermi. Oppure quelle viste che hanno comunque evidenziato il ritorno del genere da parte delle nuove generazioni di registi italiani al fine di trovare un contatto con il pubblico attraverso una forma narrativa prioritaria: cinema di impegno sociale e civile, commedia, melodramma.
In questa sezione il film “A Napoli non piove mai” di Sergio Assisi, popolare attore che qui esordisce nella regia cinematografica, si è aggiudicato il premio speciale del pubblico con la seguente motivazione:” Per l’abilità di rieditare la migliore commedia all’italiana, arricchendola con notazioni di puro divertimento per lo spettatore.
Da sottolineare poi che a dimostrazione che la manifestazione di Assisi si è ben radicata nel territorio, significative sono state le proiezioni avvenute in altri luoghi della città.
Un dibattito ha poi affrontato il tema “Il cinema nel Web e nel Social Network fino alla rivoluzione di Netflix” che ha portato ad alcune riflessioni sugli scenari futuri del cinema e sulle nuove tendenze della comunicazione. Un dibattito a cui hanno partecipato alcuni direttori dei maggiori siti internet di settore, addetti ai lavori, giornalisti e critici. Un fenomeno controverso che ha avuto opinioni favorevoli come quella di Alberto Farina di Rai Movie che pensa che in generale i social “ esprimono il desiderio di poter vedere ciò che vuoi quando vuoi. Cecare di impedire tutto questo è come tentare di svuotare il mare con una forchetta”. Secondo altri, Federico Pontiggia per esempio, c è invece” il rischio di un drammatico ridimensionamento del ruolo e della funzione della critica cinematografica poiché arrivando direttamente al pubblico potrebbe venir meno il ruolo del critico”.
Conclusione di “Primo Piano sull’Autore” con la tradizionale consegna, giunta al XXIV anno, dei Premi Domenico Meccoli- Scrivere di Cinema che ha visto tra i premiati anche Angelo Tantaro, Direttore di Diari di Cineclub per il Magazine on line di Cinema con la seguente motivazione: “Per l’impegno profuso da anni nell’opera di approfondimento della cultura cinematografica, in particolare nei confronti del cinema indipendente”.
.
REGGIOCALABRIAFILMFESTIVAL:
UNA MANIFESTAZIONE DA SOSTENERE
di Paolo Micalizzi
A Reggio Calabria ha ripreso l’attività un Festival del Cinema, grazie all’iniziativa di Michele Geria che, malgrado azioni di boicottaggio e inutili polemiche, lo ha portato avanti dal 2 al 5 dicembre 2015 con il contributo di validi collaboratori. Teatro delle proiezioni l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti in cui si sono svolti anche dei Workshop. Uno ha riguardato “Il gusto del cinema” con Stefano Mileto( fotografia e video Food) e Filippo Cogliandro (Chef Gourmet), ed un altro “Scrittura e Creatività” con Mimmo Gangemi (scrittore e sceneggiatore). Quello di regia e Scenografia poi è stato tenuto da Giancarlo Muselli, scenografo de “Il giovane favoloso” di Mario Martone ed altri importanti film, e da Sandro Dionisio, regista e sceneggiatore del film “La volpe a tre zampe” che è stato proiettato alla presenza dell’autore.
Un film, tratto dall’omonimo romanzo di Francesco Costa, ambientato nella Napoli del 1956 dove in un campo di sfollati il piccolo Vittorio si divide tra lo squallore di una realtà su cui pesano ancora i danni dell’ultima guerra e il sogno di una vita felice in America che è alimentata dalla visione del film americano “Piangerò domani” con protagonista la splendida Susan Hayward. In America , a New York, si svolge anche “Sp1ral” del pugliese Orazio Guarino che racconta di un regista di successo (Marco Cocci) che vive e lavora oltre oceano dove è anche in riabilitazione per curare un disturbo borderline di cui soffre da anni. La morte del padre lo richiama al suo paese, In Italia, dove si rifugia nella casa al mare della sua infanzia e, malgrado l’affetto di una giovane e bella ragazza, riaffiorano i fantasmi che lo trascinano in una spirale di ricordi e ossessioni, difficili da sconfiggere. Altro film in programma, ”Mirafiori Lunapark” di Stefano Di Polito interpretato da Giorgio Colangeli, Antonio Catania e Alessandro Haber. Sono tre pensionati della Fiat Mirafiori, in cui sorgeva un tempo la Fabbrica Fiat, che a un certo punto decidono di occuparla con l’intento di ridarle ,ormai dismessa e dimenticata, respiro e dignità per ripopolare il quartiere e riavvicinare ad esso figli e nipoti. Ma i loro sogni dovranno confrontarsi, e scontrarsi, con la volontà dei nuovi padroni. Un’altra opera prima è l’esordio nella regia del popolare attore Sergio D’Assisi che realizza una commedia farsesca in cui la protagonista è la bellezza di Napoli, che fa da sfondo alle vicende di tre curiosi personaggi che superano con ottimismo e positività le loro sindromi come se nella città partenopea ci fosse sempre il sole. Ambientato a Napoli anche “Take five”( un titolo che rievoca il jazz ) di Guido Lombardi. Protagonisti cinque “irregolari” (un idraulico, un gangster depresso, un ricettatore, un pugile suonato ed un ex rapinatore) alle prese con una rapina milionaria. Una banda sgangherata che fa fatica ad armonizzarsi. Tra gli interpreti, Salvatore Striano un attore, con un passato di detenuto al carcere di Rebibbia, rivelatosi nel cinema grazie a Matteo Garrone che lo ha voluto in “Gomorra”(2008) ma soprattutto ai fratelli Paolo e Vittorio Taviani che gli hanno affidato il ruolo da protagonista , Bruto, in “Cesare deve morire” (2012) giurato all’interno del penitenziario romano dove protagonisti erano alcuni detenuti in veste di attori nell’allestimento del “Giulio Cesare” di Shakespeare. Per la sua interpretazione, Salvatore Striano ottenne il Premio FIPRESCI (Critica Internazionale) ad un Festival in America e un Nastro d’Argento in Italia insieme a tutto il cast. Un’attività di attore scaturita dalla sua passione per il teatro, soprattutto shakesperiano, alimentata dalla frequentazione in carcere di corsi di recitazione.
Oggi, Salvatore Striano, noto anche come Sasà, che ha raccontato la sua vita nel libro “Teste matte” insieme a Guido Lombardi, ha al suo attivo una decina di film ed una qualificata attività in televisione ed in teatro. Al “ReggioCalabriaFilmFestival” è stato un simpatico protagonista presentando “Take five” ed intervenendo ai Workshop. E da protagonista ha partecipato alla Cerimonia conclusiva al Teatro Cilea in cui sono stati consegnati a nuovi talenti calabresi i Premi intitolati ai celebri attori Leopoldo Trieste e Raf Vallone che in terra calabra hanno avuto i natali. Una manifestazione, questa di Reggio Calabria, che merita di avere continuità attraverso i giusti appoggi istituzionali, e non solo, per evitare che ancora una volta, per “litigi” Interni ,iniziative culturali che potrebbero dare prestigio alla Calabria vadano in fumo. E la Calabria non lo merita.
.
TAGORE, UNA RELAZIONE PRIVATA
di Maria Pia Cinelli
Abbiamo già avuto modo di sottolineare come la condizione muliebre sia lo strumento ideale per testare lo stadio evolutivo di una civiltà, cartina di tornasole a rivelare strascichi atavici anche nel progressismo avanzato (per restare nel cinema, pensiamo alla disparità di ingaggio fra attori e attrici nella Hollywood contemporanea, denunciata fra le altre da Jennifer Lawrence e Meryl Streep) e a maggior ragione nervo scoperto in contesti meno emancipati.
Insieme ai problemi connessi all’emigrazione, la discriminazione della donna è un topos ricorrente nella cinematografia indiana più impegnata, particolarmente caro – fatto già di per sé indicativo – a registe/i cresciuti e/o formatisi altrove, trend confermato anche dal programma del 15° River to River Florence Indian Film Festival (Firenze – 5/10 dicembre 2015) dove non sono mancati esempi di disagio femminile legato ad usi e costumi duri a morire a certe latitudini: il matrimonio combinato – pratica tuttora comune persino in aree urbane e in caste elevate – è al centro di “Tehzeeb”[1] dell’euro-pakistana Myriam Raja, di isolamento domestico parla invece l’indiana Aban Bharucha Deohans nella commedia “Teaspoon” [2], mentre, com’è noto, la segregazione delle vedove indù in apposite case è alla base di “Water”, riproposto dal festival nell’omaggio alla regista/sceneggiatrice Deepa Mehta[3].
Quanto la tradizione e le convenzioni sociali incidano sulla vita dell’altra metà del cielo è evidente anche nell’interessante lungometraggio in concorso “Kadambari” [4], che per la prima volta porta su grande schermo una vicenda intima del premio Nobel Rabindranath Tagore con protagonista la cognata Kadambari Devi, morta suicida nel 1883. L’episodio, avvenuto 4 mesi dopo il matrimonio dell’autore di “Sadhana” creando un rapporto di causa-effetto, venne inizialmente tenuto nascosto data la posizione della casata e del suo ruolo nel Rinascimento del Bengala a fine ‘800, per poi sedimentare nell’immaginario del paese, imparentandosi con il mito e restando negli anni oggetto di discussioni, congetture, studi, seppur con la deferenza tributata a una figura di culto.
Portare un po’ di luce nell’oscurità dei fatti non è stato quindi un compito facile per il regista Suman Ghosh[5], che ha privilegiato la ricostruzione dell’ambiente intellettuale del tempo, uno sviluppo melò e l’introspezione rispetto alla componente documentaria, pur basandosi per la sceneggiatura su studi specifici[6] nonché sugli scritti dello stesso Tagore, la cui esistenza fu senza dubbio scalfita dal tragico evento, tanto da proiettarla nel romanzo Nastanirh (The broken nest), dove non compaiono suicidi ma pur sempre una donna con ambizioni letterarie e un affiatamento particolare con un cugino del marito presto trasformatosi in amore, coincidenze troppo evidenti per non parlare di autobiografismo.
Nastanirh fu magistralmente tradotto in immagini in “Charulata” (“La sposa solitaria”,1964) da Satyajit Ray, il cineasta che grazie a un’affinità di stile e contenuti meglio di ogni altro ha compreso e trasposto in pellicola[7] il pensiero del grande innovatore della prosa bengalese, poeta, scrittore, drammaturgo, musicista, pittore, filosofo, che ha influenzato in maniera radicale tutta la cultura indiana, settima arte inclusa.
Il film di Ghosh, di impianto classico, inizia con Kadambari agonizzante per poi partire con un lungo flashback a ripercorrerne la storia. Entrata in casa Tagore a 9 anni come sposa di Jyotirindranath, un fratello maggiore di Rabindranath (chiamato familiarmente Robi) che ne ha solo 7, giocoforza trova nel piccolo un compagno ideale. Con il passare del tempo il loro rapporto si fa sempre più stretto, complice il comune interesse per la letteratura, colmando la mancanza di una vera intesa con il marito – molto preso dagli affari, da velleità drammaturgiche e dalla passione per un’attrice – e di figli, se si esclude la bambina ‘donatale’ da una cognata. Quando i parenti turbati dalla loro intesa organizzano il matrimonio di Robi con una ragazzina decenne, Kadambari entra in un vortice di tristezza che la porterà al gesto finale.
Il regista non propende per una tesi prestabilita, in tono con l’aura di controversia che avvolge l’accaduto, mettendo a fuoco in primo luogo il malessere esistenziale di Kadambari nel contesto domestico e socio-culturale dell’epoca. Infatti, nonostante i Tagore fossero una famiglia nobile, abbiente e intellettualmente progressista, con fra le sue fila altre personalità eminenti, anche femminili[8], dove il sapere era il pane quotidiano e tutti i membri venivano incoraggiati ad esprimere i propri talenti, evidentemente per le donne restava comunque difficile affrancarsi da ruoli prestabiliti e regole circoscritte.
Uno spaccato non dissimile ad altre società del periodo – nonché successive – con l’aggravante delle spose bambine, pratica alla quale neppure l’avanguardia erudita riusciva a opporre resistenza, se perfino lo stesso Tagore, sensibile alle istanze umane, politiche, sociali e attento alla condizione femminile, non solo prese in moglie una bimba, ma dette in sposa in tenera età anche le due figlie, pur essendosi più volte espresso pubblicamente contro tale usanza. Una contraddizione fra abitudini ancestrali e rinnovamento che ancora oggi permea la civiltà indiana e tanto caratterizza il suo cinema.
Nel film il legame affettivo fra i cognati appare senz’altro evidente, alimentato da una complicità artistica – che però vede la donna fungere più da musa mentre il futuro premio Nobel si costruisce la carriera – da lei vissuta come uno spazio-tempo elettivo dove potersi esprimere e coltivare la propria personalità, un percorso di crescita a due simbolicamente interrotto dal quaderno vergine che Robi mostra alla moglie per scrivervi assieme e iniziare così una nuova avventura e che relega in soffitta quelli fino ad allora condivisi con Kadambari (ricordiamo che anche in “Charulata” un simile taccuino rivestiva un valore metaforico del sentimento fra i protagonisti). Se la rivelazione del quaderno segno del novello sodalizio culturale-affettivo viene mostrato come un fattore decisivo per la crisi della donna, altri elementi drammaturgici mettono tuttavia in evidenza probabili con-cause del suicidio, commesso la sera dell’inaugurazione della società marittima del marito in piena solitudine: la morte della nipotina affidatale in un incidente domestico e la scoperta casuale che l’amante di Jyotirindranath è in attesa di un figlio sono portatrici di un forte senso di colpa e di un sentimento di inadeguatezza, ai quali si aggiunge una sorta di isolamento dovuto ai rapporti da sempre non facili con il resto della famiglia.
Amalgamando dati biografici assodati e aspetti leggendari tramandati di generazione in generazione Suman Gosh maneggia con misura e rispetto una vicenda complessa e alquanto delicata per i bengalesi, tratteggiando una figura femminile tormentata, non solo con il cuore infranto, ma in primo luogo segnata da una vita priva di direzione, definitivamente persa allorché l’unico faro si era ormai spento.
[1] (UK, 2015 - 16') [2] (India, 2014 - 20') [3] originaria del Punjab e laureata a Delhi ma da anni stabilitasi in Canada, D.Mehta è con Mira Nair la regista indiana più nota a livello internazionale. “Water” (Canada/India, 2005) - parte di una trilogia insieme a “Fire” e “Earth” - scatenò l'ira dei fondamentalisti indù che minacciarono di morte il cast e incendiarono il set, ragion per cui la lavorazione fu spostata in Sri Lanka. Fra i film della Mehta ricordiamo anche “I figli di mezzanotte” tratto da Salman Rushdie e co-sceneggiato con l'autore. A Firenze la regista ha presentato in anteprima il suo ultimo lungometraggio, il gangster-movie “Beeba Boys”. [4] (India, 2015 - 90') [5] regista piuttosto noto in India, dove ha ottenuto numerosi premi, affianca l'attività artistica a quella di professore aggiunto di Economia alla Florida-Atlantic-University [6] tra le fonti citate da Suman Ghosh troviamo: Prothom Alo di Sunil Gangopadhyay, Kabir Bouthan di Mallika Sengupta e le biografie di Tagore curate da Prasanta Kumar Pal e Prabhat Kumar Mukhopadhyay [7] oltre a “Charulata” – il film prediletto di Ray – si contano “Teen Kanya” (“Tre figlie”, 1961) dove il regista assembla tre racconti di Tagore, e “Ghare Baire” (“La casa e il mondo”, 1984) tratto dal romanzo omonimo. Ray ha inoltre realizzato un documentario biografico sul suo celebre conterraneo (“Rabindranath Tagore”, 1961). [8] oltre a Rabindranath si ricordano il padre Debendranath, riformatore e mistico, una sorella scrittrice (Swarnakumari Devi) un nipote pittore (Abanindranath) mentre una cognata (Jnanadanandini Devi) rivoluzionò il modo di vestire delle donne bengalesi.
.
IL BALKAN FLORENCE FESTIVAL:
I BALCANI OCCIDENTALI FRA STORIA E REALTÀ
di Marcello Cella
Fra il 25 e il 27 febbraio scorso si è svolta a Firenze la quarta edizione del Balkan Florence Festival, una piccola, ma interessantissima manifestazione culturale organizzata da Oxfam, onlus internazionale fra le più attive a livello sociale nei Balcani e in altre parti del mondo, in collaborazione con la Regione Toscana, Quelli della Compagnia, il Sarajevo Film Festival e il Tirana Film Festival, dedicata al cinema dei Balcani Occidentali. La tre giorni è stata una intensa full immersion nella realtà sociale e nella storia di Serbia, Croazia, Kosovo, Slovenia e Bosnia, con rimandi molto forti a quanto sta succedendo nei Balcani anche in questi giorni. I film presentati hanno rivelato anche cinematografie molto vive sia sul piano linguistico, che produttivo, e molto interessate a riflettere sulla propria storia e sulle proprie realtà in modo molto aperto e poco ortodosso. Sul piano linguistico è difficile in molti casi fare una distinzione netta fra cinema di finzione e documentario perchè entrambi i generi vengono utilizzati dai cineasti di questi paesi in modo molto libero e personale per raccontare realtà in cui la storia viene vissuta ancora in modo molto viscerale e il passato non sembra mai passato davvero con risultati di grande qualità espressiva.
E’ il caso del bellissimo documentario della regista croata Tiha Gudac, “Goli/Naked Island” (2014), in cui la riflessione storica della giovane autrice sui lati oscuri della Jugoslavia di Tito nasce a partire dalla sua vicenda personale: la storia dell’amatissimo nonno scomparso per quattro anni dalla vita della nipote perchè incarcerato nella famigerata prigione di Goli Otok, un’isola vicino alla costa croata, in cui venivano rinchiusi gli oppositori politici del regime di Tito. Un viaggio oscuro e tormentato all’interno di una storia familiare e pubblica condotta con grande intensità dalla regista croata con la collaborazione fondamentale del montatore serbo Dragan Von Petrovic, a dimostrazione di quanto siano fittizi gli steccati nazionali e culturali imposti dalla storia.
Un altro grande film presentato all’interno della rassegna fiorentina, il serbo “Krugovi/Circles” di Srdjan Golubovic (2013) racconta invece una storia abbastanza nota a chi si occupa di Balcani, avvenuta nel 1993, durante la guerra civile in Bosnia Erzegovina, quando, in una piccola cittadina, Treblinje, venne ucciso un soldato delle milizie serbo-bosniache dai propri commilitoni perchè aveva difeso un suo amico musulmano dalle loro angherie. Più che il fatto in sé, che comunque viene raccontato in un suggestivo flashback dilatato dalla memoria dei protagonisti, il regista serbo si sofferma sulle conseguenze dolorose di questo avvenimento sulle vite di chi è sopravvissuto, il padre del soldato, indurito dl dolore, il figlio di uno dei commilitoni assassini che si è suicidato poco tempo dopo, l’ex fidanzata emigrata in Germania insieme al figlio piccolo, in fuga da un matrimonio sbagliato e da un marito violento, aiutata proprio dall’amico musulmano salvato a suo tempo, a prezzo della vita, dalla violenza delle squadracce serbo-bosniache, e l’amico di un tempo, anch’esso emigrato in Germania, che, medico, ritrova in ospedale come paziente proprio il capo di tali famigerate milizie. Il confronto fra questi personaggi, condotto magistralmente da Golubovic, è un viaggio fra le macerie ancora fumanti di un passato che rifiuta di essere rimosso e nascosto nelle soffitte della storia.
Una storia di vendette dalle motivazioni oscure che continua a perseguitare una madre e i suoi due figli è anche quella raccontata dal film sloveno “Drevo/The Tree” (2014) di Sonja Prosenc, raccontata dal punto di vista dei tre protagonisti, costretti a vivere una vita da reclusi in un piccolo villaggio a causa dei pericoli, mai esplicitati chiaramente, che circondano le loro vite dopo un incidente in cui è morto un amico del figlio più grande. L’incidente innesca il desiderio di vendetta della famiglia del ragazzo morto che non avrà pace fino a quando non sarà soddisfatta. Un film di grande impatto visivo e dagli intensi risvolti psicologici e simbolici grazie anche alla bella prova attoriale dei tre protagonisti.
Oltre alla riflessione dolorosa sulla storia recente la rassegna di film presentata dal Balkan Florence Festival ha offerto anche un altro elemento tematico molto forte, quello dell’emigrazione, quella di chi dai Balcani è emigrato nei paesi del Nord Europa e quella attuale di chi dall’Africa o dai paesi arabi fugge nei Balcani o li attraversa con la speranza di approdare anch’esso in Germania o in altri paesi ricchi.
E’ questo il caso di documentari come il bellissimo “Logbook_Serbistan”(2015) del vecchio regista serbo Zelimir Zilnik, già vincitore di un Orso d’oro a Berlino nel 1969 con il film “Opere giovanili” (e autore, nell’ambito del festival, di un incontro su “Il cinema jugoslavo da Tito ai giorni nostri”) o il kosovaro “Trapped by law” (2015) di Sami Mustafa, ma anche di film di finzione anch’essi molto intensi come “Babai” (2015) del kosovaro Visar Morina o il montenegrino “Djecaci iz ulice Marska i Engelsa” (“The kids from Marks and Engels street”, 2014) di Nikola Vukcevic.
In “Logbook_Serbistan”, girato l’anno scorso prima di quella che poi è diventata l’emergenza migranti nei Balcani, Zilnik, con uno stile registico che ricorda molto quello del “cinema verità”, segue il viaggio irto di ostacoli di due giovani emigranti africani e di un mediatore siriano lungo la strada che dalla Serbia li dovrebbe portare verso l’Ungheria, un viaggio che fornisce molti punti di riflessione dolorosi, ma spesso anche spiazzanti e umoristici, allo spettatore sulla condizione dei migranti e di chi li accoglie.
Film dai risvolti kafkiani, se non fosse drammaticamente reale, è l’incredibile vicenda, raccontata dal documentario “Trapped by law”, di due fratelli kosovari, cantanti rap, residenti con la loro famiglia in Germania da almeno 20 anni, che da un giorno all’altro a causa di un permesso di soggiorno non del tutto in regola, vengono letteralmente deportati in Kosovo, paese in cui non hanno mai vissuto, e da cui cercano disperatamente di partire e ritornare in Germania. Fra concerti, frammenti di quotidiana vita precaria e follie burocratiche si dipana la vicenda tragicomica di questi due fratelli che per la prima volta si trovano a confrontarsi con le proprie radici familiari e culturali, prima di decidere, dopo tre anni di scontri con il muro di gomma della burocrazia migratoria, di ritornare a Germania da clandestini.
Un percorso simile a quello dei due fratelli di “Trapped by law”, è quello seguito dal protagonista di “Babai”, un bambino di 10 anni che decide di raggiungere il padre emigrato per lavoro dal Kosovo in Germania negli anni ’90, affrontando un viaggio in cui la sua caparbia ingenuità si scontra con un mondo adulto spietato.
Mentre del tutto inverso è il viaggio affrontato da Stanko, il giovane protagonista montenegrino del film di Vukcevic, che dall’Inghilterra è costretto, dopo vent’anni, a tornare nel proprio paese d’origine a causa della morte del padre e scopre che è tutto cambiato: i suoi amici sbarcano il lunario con la malavita di Podgorica e anche la via in cui è cresciuto, “Via Marx e Engels”, ha cambiato nome e della storia comunista a nessuno importa più niente, immersi tutti in sogni straccioni di capitalismo degenerato.
Infine della bella rassegna fiorentina vanno citati almeno altri due film documentari, “Lijepo mi je s tobom znas” (“I like that super most the best”, 2015) della regista croata Eva Kraljevic, e il bosniaco “Rus/Russian” di Damir Ibrahimovic e Eldar Emric, che preferiscono raccontare storie più intime o di personaggi che vivono ai margini della società. Il documentario della Kraljevic racconta in modo molto intenso e poetico la storia del suo rapporto bello e doloroso al tempo stesso con la sorella down fino all’inevitabile separazione.
Mentre “Rus/Russian” è la storia tragicomica di un personaggio dagli incredibili risvolti esistenziali e narrativi: maltrattato da bambino dal padre diventa ladro e tossicodipendente fino a fuggire in Russia dove diventa milionario in modo rocambolesco per poi ritrovarsi pressochè senza dimora e vessato dagli strozzini in una malinconica Sarajevo dove ritrova sé stesso attraverso l’amore e il teatro.
.
OCCHIO CRITICO
a cura di Marco Incerti Zambelli, Tullio Masoni, Paolo Vecchi
“Steve Jobs” e “The End of the tour”: due biopic inconsueti
di Marco Incerti Zambelli
“un libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, nella vita sociale, nei nostri visi”
Marcel Proust – Contro Saint Beuve
”tuttavia, la nostra vita non è separata dalle nostre opere…”
Marcel Proust -Jean Santeuil
Torna alla mente la forte polemica di Marcel Proust contro Saint Beuve nel ripensare ai due biopic di maggior interesse usciti recentemente sugli schermi, “Steve Jobs” di Danny Boyle e “The end of the tour – un viaggio con David Foster Wallace” di James Ponsoldt: è fuorviante esaminare i particolari biografici degli autori di portenti come l’Iphone e l’Imac o di uno sterminato capolavoro come il romanzo Infinite Jest, oppure , come ha confessato lo stesso Proust , inevitabilmente quello che si crea è inestricabilmente legato a quello che si è?
Questione di difficile soluzione e probabilmente mal posta nel caso di due icone che hanno segnato il passaggio di millennio, vere rockstar della cultura americana e non solo.
I due film sono accomunati dalla scelta di non volere tratteggiare l’intera vita dei protagonisti, concentrandosi su momenti significativi dai quali dedurre la complessità dei personaggi, da sceneggiature solidissime, da prove attoriali , che pur muovendo da scelte diverse, sorreggono ottimamente la narrazione.
L’opera di Boyle , ma è più corretto attribuirne la vera paternità allo sceneggiatore Aaron Sorkin ( “The social network”, “West Wing”, “Newsroom”) , è strutturata in tre atti, ognuno dei quali narra i quaranta minuti precedenti la presentazione di mirabolanti nuove invenzioni, il Macinthos (84), Next (88) e l’Imac(98): incontri, conversazioni, litigi su fatti che non sono mai direttamente narrati , che sono rimasti fuori campo, come mai sono mostrati gli Steve speeches dei prodotti. Attorno a Jobs ruotano i collaboratori più stretti, la devota ma decisa esperta di marketing, la madre di sua figlia e la figlia stessa, in un susseguirsi di scontri su questioni che circolarmente ritornano. I fitti, eccellenti dialoghi, a volte in classico campo/controcampo, spesso in quel walk and talk che é cifra stilistica di Sorkin, costringono, fortunatamente, Boyle a misurare quegli eccessi che hanno segnato molte delle sue opere precedenti e permettendogli di firmare la sua opera migliore.
Non è la mimesi la preoccupazione degli autori: Fassbender è efficace nel ricordare Jobs senza imitarlo, la possibilità che veramente tutti e sette i protagonisti si incontrassero ad ogni presentazione è decisamente remota, le vicende narrate solo a tratti corrispondono alla realtà dei fatti. Se pure vengono messe in scena la personalità, le ossessioni e le idiosincrasie del Ceo Apple (la necessità di un sistema informatico chiuso, la maniacale attenzione all’eleganza dei prodotti, la sgradevole ruvidezza nei confronti dei sottoposti, la sicumera visionaria accanto alla approssimazione tecnica, la capacità di creare RDF (1), dal racconto emerge il ritratto indiscreto, intimo di un uomo il cui titanico ego ( “io sono come Giulio Cesare, circondato dai nemici”, “ io sono il direttore dell’orchestra”) non riesce a cancellare il lutto dell’amore non ricevuto ( l’abbandono dei genitori biologici, il rifiuto della prima coppia adottiva, il “tradimento” di Sculley) e la difficoltà di dimostrarlo , di viverlo (Steve a Johanna: “Perché non siamo mai andati a letto insieme, noi due?” e lei: “ Non siamo innamorati”, per poi aggiungere, quattro minuti dopo “ Ti amo Steve. Sai quanto”). E’ soprattutto il rapporto con la figlia, che attraversa tutti e tre gli atti del film, a rivelare il senso di inadeguatezza, di incapacità affettiva di cui è pure cosciente ( “Sono fatto male” risponde a Lisa quando gli chiede perché ha negato di essere suo padre). E poco importa che il finale, in cui la strepitosa intuizione dell’Ipod si sposa con la speranza di una serenità finalmente raggiunta, sia del tutto inventato, per conoscere l’esattezza dei fatti storici esistono centinaia di fonti, il cinema è un’altra cosa.
Anche “La fine del tour” nulla mette in scena della vita di Wallace se non i cinque giorni delle lunghe conversazioni con David Lipsky, collaboratore free lance della rivista Rolling Stones, in occasione del tour di presentazione di Infinite Jest, il monumentale romanzo capolavoro dello scrittore nel 1996. L’intervista non venne mai pubblicata se non più di venti anni dopo sotto forma di libro (2) nel quale Lipsky trascrive fedelmente le registrazioni effettuate durante quei giorni. Donald Margulis, praticamente esordiente al cinema , ma vincitore di un premio Pulitzer ed autore di numerose opere teatrali di successo, ne trae una sceneggiatura arguta e commovente, che nella regia di James Ponsodlt ( “Off the rock- Gioco forzato”, “Something new)” , autore indipendente habitué del Sundance Film Festival, si concretizza in un road movie sensibile e coinvolgente.
Jason Segel ( “How i Meet your mother”), sorprendentemente realistico ed efficace nell’impersonare Wallace, ed il ritrovato Jesse Eisenberg ( “The social network”), un adeguato e persuasivo Lipsky, danno vita ad un pas de deux intrigante, che assume i toni , di un volta di volta della condivisione e dello scontro, della complicità e dell’incomprensione, del gioco di squadra e della partita a tennis.
Tra abbuffate di junkie food e sigarette, incontri con vecchie amiche e passeggiate con i cani, viaggi in macchina ed in aereo, il rapporto tra i due si evolve, si approfondisce, si tende al limite della rottura, si rafforza in un reciproco seppur cauto rispetto.
Negli scenari innevati del Midwest il gigantesco (in tutti i sensi) David svela, seppur con timida ritrosia, la sua visione sul mondo, dal sex appeal di Alanis Morissette ( “ha quel tono stridulo che ricorda l’orgasmo”) alle dipendenze ( “ la principale dipendenza della mia vita è stata la TV”), dalla sua immagine pubblica ( “ Mi va bene finire su Rolling Stone, ma non voglio apparire su Rolling Stone come uno che vuole a tutto i costi essere su Rolling Stone”) all’uso della bandana (“impedisce al sudore di finire sulla macchina da scrivere…. una specie di rimedio alla paura che la testa mi stia per esplodere”), dalla sua opera ( “ ho scritto un libro sul potere seduttivo dell’immagine”) agli abissi esistenziali ( “ quando uno salta da un grattacielo in fiamme non è che non abbia più paura di lanciarsi. E’ che l’alternativa è davvero orribile e sei portato a credere che l’unico modo per sfuggirle sia gettarsi a capofitto nella morte” , e questo detto cinque anni prima dell’11 Settembre).
Il piccolo David, che ha voluto fortemente quella intervista, oscilla tra la volontà di fare bene il suo “sporco” mestiere ( il registratore sempre acceso, spiare i medicinali nell’armadietto del bagno, annotare scrupolosamente oggetti ed arredamento, carpire informazioni dalla famiglia e dalle amiche) e la fascinazione rispettosa che lo frena nel porre domande imbarazzanti, tra l’inevitabile invidia per l’immenso talento del compagno e la sincera devozione per il nuovo amico.
Ponsodlt e Margulis governano con sensibilità l’impetuoso fluire dei dialoghi, con un messa in scena solo apparentemente dimessa, confezionando un’opera emozionante e coinvolgente, attraversata da una vena di struggente malinconia.
Un tratto comune ai due film è la centralità della musica, non tanto le colonna sonore originali, eleganti ma non memorabili, quanto le canzoni come elemento di narrazione vero e proprio, addirittura raccontate e non ascoltate come capita a Both sides now di Joni Mitchell nel film di Boyle e a You Otta Know di Alanais Morissette in La fine del tour, o il ritornare delle citazioni di Bob Dylan in Steve Jobs e le preferenze musicali di D.F. Wallace, felice sintesi della sua esplorazione tra paccottiglia e raffinatezza. Un ulteriore elemento che contribuisce a fare delle due opere non solo un ritratto non convenzionale di personalità irripetibili, ma anche un affresco dell’America nel passaggio del millenio.
(1) Real Distorsion Field, campo di distorsione della realtà, termine coniato da un collaboratore della Apple per definire il carisma di Jobs, che induceva i suoi sviluppatori ad impegnarsi nella costruzione di progetti apparentemente impossibili. Nel film Jobs lo attribuisce a Joan Baez, con la quale ebbe una relazione, forse attirato anche dalla lunga relazione di lei con Bob Dylan , vero guru e punto di riferimento del creatore della Apple.
(2) Although of course you end up becoming yourself . A road trip with David Foster Wallace. Broadway Books 2010.
Trad. italiana. Come diventare se stessi, David Foster Wallace si racconta. Minimum fax. 2010
.
DUE FILM PREMIATI. “ROOM” E “FUOCOAMMARE”
di Tullio Masoni
L’attrice Brie Larson ha ottenuto l’Oscar, e il premio ovviamente si riflette sul film che ha interpretato. C’è poi da considerare il regista, l’irlandese Lenny Abrahmson, che si era già fatto notare con titoli poco distribuiti come il notevole “Garage”, vincitore del Festival di Torino nel 2007. Sceneggiato da Emma Donoghue da un proprio romanzo, “Room” rimanda liberamente a fatti di cronaca; in particolare al caso Fritzl, quello della ragazza austriaca imprigionata dal padre, che ne aveva abusato facendole mettere al mondo sei figli. Il film si potrebbe suddividere in tre parti di lunghezza diversa: la prigionia nella stanza dove Jack è nato quando la madre era già rinchiusa da tempo, l’avventurosa e pericolosissima fuga, il mondo fuori con tutte le sue pesanti incognite. Abrahmson sottopone la storia a una regia efficace e talvolta inventiva: primi piani a rompere il soffocamento dello spazio chiuso, cadenze giuste, dilatazioni plastiche per accompagnare il tentativo di una madre che vuol dare un mondo al figlio, e lo sguardo con cui questi risponde.
Ciò riconosciuto, “Room” mi sembra si collochi tra le opere che soffrono lo “strapotere” della sceneggiatura. Se la regia funziona come tale, non altrettanto può dirsi della scrittura, che impone una “terza parte” trascinata, ambiziosa sul piano psico-sociologico, ma alla fine semplificatoria e dubbia per credibilità. Fino alla fuga lo spettatore condivide la sofferenza claustrofobica e, quasi come accade coi thriller, segue trepidante l’evasione; in seguito assiste a un lungo, meccanico e talvolta superficiale giustapporsi di vicende. Troppi compromessi drammatici, forse, che lasciano percepire un poco equilibrato rapporto fra i probabili tempi del romanzo e quelli del film.
Dopo il Leone d’oro del 2013 con “Sacro Gra”, Gianfranco Rosi ha vinto il primo premio a Berlino. A parte l’alto valore del film mi sembra un bene sia confermata l’attenzione verso il documentario, e la docu-fiction, anche fuori dagli eventi di nicchia. “Fuocoammare” è dedicato all’isola degli sbarchi, cioè a Lampedusa, ai suoi abitanti e all’immigrazione.
Il metodo usato dal regista è lo stesso di “Sacro Gra”: un lungo periodo di preparazione in loco – oltre un anno – e l’osservazione di una variegata umanità. Da questa egli ha scelto alcuni personaggi, o meglio li ha “creati”, cercando però di essere il meno invasivo possibile. Un lavoro a distanza, insomma, sostenuto da limpide suggestioni estetico-visive (il mare, il paesaggio, i notturni) e da un montaggio impeccabile. Per tornare alla discrezione del metodo, Rosi ha provato a rendersi “invisibile”, cioè ad abituare le persone alla presenza della camera. Ne è uscito un insieme antiretorico e asciutto – cioè lontano dalla vulgata televisiva – ma in certo modo partecipe. La tragedia esige lucidità, rigore e dolente distacco; su questa regola Rosi si è mosso senza dimenticare le esperienze del reportage, del documentario d’inchiesta e del “cinéma verité”; del quale ultimo, però, supera certi limiti di freddezza e formalismo. “Fuocoammare” propone la vita degli indigeni di Lampedusa e il dramma degli emigranti secondo una netta alternanza; non cerca o stabilisce rapporti – salvo che attraverso la figura del medico – ma vuole servire la critica attraverso una speciale, personalissima contemplazione. A tale proposito Lee Marshall (www.internazionale.it) ha scritto: «…questo viaggio cinematografico bello e straziante è anche un film sulla rimozione…un difetto di empatia della mente umana, che ci porta a non mettere a fuoco certe cose… se non come un miraggio … “Fuocoammare” racchiude tutti e due questi significati – miraggio e messa a fuoco – in un documentario che schiera più simboli, e crea più risonanze di molti film di fiction…».
.
RAPSODIA UNGHERESE
di Paolo Vecchi
Nonostante le difficoltà in cui versa l’Ungheria, il suo cinema ha conosciuto negli ultimi due anni un soprassalto di notorietà sui nostri schermi. Sono infatti stati distribuiti in Italia i notevoli “Il Grande Quaderno” di Szasz e “White God – Sinfonia per Hagen” di Mundruczo, autori con una loro storia già ben delineata, mentre le opere prime di due trentenni, il generazionale, gracilino “Van valami furcsa és megmagyarazhatatlan” (t.l.: Per qualche inspiegabile ragione) di Gabor Reisz è stato premiato a Torino e il duro, sociologico-melodrammatico “A szerdai gyerek”(t.l.: Il figlio del mercoledì) di Lili Horvath ha vinto a Trieste.
Trentotto anni ha Laszlo Nemes, figlio d’arte (suo padre, Andras Jeles, è stato uno dei registi più importanti della sua generazione) e di buona scuola (ha lavorato come assistente di Béla Tarr). Il suo lungometraggio d’esordio, ”Il figlio di Saul”, ha fatto incetta di premi a partire da Cannes dove era in concorso, giungendo fino all’Oscar, il secondo nella storia ungherese dopo “Mephisto”.
Raccontando l’orrore di Auschwitz, il giovane cineasta focalizza il racconto sul primo piano o sulla semisoggettiva del protagonista, con il contesto in cui si muove affidato a particolari appena sfiorati, la cui evidenza passa soprattutto attraverso il lavoro sui rumori fuori campo e la babele dei linguaggi. La tragedia viene così interiorizzata, quasi assorbita dall’ ossessiva ricerca di dare esequie a un figlio forse solo presunto. A scarnificare ulteriormente la narrazione Nemes sceglie i mezzi ormai arcaici della pellicola, del formato 1:1.33 e della macchina a spalla, per togliere quell’impressione di fluidità che ad esempio la steadicam avrebbe dato al piano-sequenza, in favore di uno sguardo mosso, sporco e senza compiacimenti. Il protagonista poi appartiene ai Sonderkommando – Primo Levi li chiama «i corvi neri del crematorio» -,una sorta di intermediari nella fabbrica della morte. Di questi esseri umani, certo non irreprensibili da un punto di vista etico, il regista non nasconde sgradevoli attitudini come la pratica del furto, della corruzione e del tradimento. Tutti elementi che gli servono a rendere l’idea della complessità e a sottrarre il film alle secche di facili stereotipi pietistici. Pur senza parlare di riscatto, il regista offre alla loro ambiguità l’occasione di una rivolta che effettivamente ebbe luogo il 7 ottobre 1944 ad Auschwitz, lasciando fuori campo secondo il suo stile la sanguinosa rappresaglia e puntando l’obiettivo, nell’unica inquadratura luminosa e attraversata da un barlume di speranza, su un bambino biondo che si allontana correndo nel bosco.
Un’altra trentenne, Virag Zomboracz, ha vinto il Bergamo Film Meeting 2015 con “Mozes, il pesce e la colomba”, da febbraio distribuito sui nostri schermi. Si tratta di una commedia di altro spessore rispetto a “Il figlio di Saul”, ma che presenta più di un interesse a partire dalla definizione di un contesto poco consueto per il cinema ungherese. Il protagonista è infatti figlio di un pastore protestante, dunque espressione di una minoranza in un paese prevalentemente cattolico. Un giovane con seri problemi di comportamento, da attribuire in buona parte al devastante rapporto con un padre autoritario, la cui personalità ha ridotto anche la moglie a una sorta di larva remissiva. A dispetto di questi presupposti, “Mozes, il pesce e la colomba” non è un film bergmaniano. La Zomboracz, infatti, sceglie il registro fantastico: il padre muore d’infarto, il suo spettro si aggira nei luoghi che lo avevano ospitato in vita, almeno fino a quando non gli sarà data pace, secondo i dettami della più classica ghost story. Da un certo momento in avanti, Mozes comincerà a dialogare con lui, prendendone le distanze ma anche cogliendone la dimensione malinconica, consapevole della necessità di concludere questa del tutto particolare elaborazione del lutto.
 Il magico e il fantastico non appartengono alla tradizione cinematografica ungherese, con qualche eccezione come l’incantevole “Il mio XX° secolo” di Ildiko Enyedi. Quanto al senso dell’umorismo, che dà respiro e leggerezza a questo film garbato e originale, fa invece parte costitutiva della cultura del Paese danubiano, in quanto ineludibile scudo difensivo per chi è sempre stato ai margini della Storia.
Il magico e il fantastico non appartengono alla tradizione cinematografica ungherese, con qualche eccezione come l’incantevole “Il mio XX° secolo” di Ildiko Enyedi. Quanto al senso dell’umorismo, che dà respiro e leggerezza a questo film garbato e originale, fa invece parte costitutiva della cultura del Paese danubiano, in quanto ineludibile scudo difensivo per chi è sempre stato ai margini della Storia.
.
VISIONI RECUPERATE
“SUSPIRIA” 40 ANNI DOPO di Paola Dei
Un’esperienza estetica a 360 gradi per un film ancora attuale nella forma e nel linguaggio dove si fondono contenuti intrisi di mistero e atmosfere dal sapore surreale e metafisico. Il cinema degli sguardi dal sapore hitchcockiano si trasforma sotto i nostri occhi in pura sensorialitá e si ibrida di tematiche care al post moderno, grazie all’abilità del regista che in ogni scena riesce a condensare fantasia, scompensi logici, macabra bizzarria, cartoon e riflessioni originali aiutato dalla maestria dei suoi collaboratori.
Dario Argento alla regia, Luciano Tovoli alla fotografia, Giuseppe Bassan alle scenografie, i Goblin alle musiche, fra gli attori una gelida Alida Valli, Flavio Bucci, Jessica Harper, nelle vesti di una ingenua e stupita fanciulla, Joan Bennet, Udo Kier, Stefania Casini.
Ambientato in una scuola di ballo di Friburgo che evoca la Villa ottocentesca del Conte Felice de Vecchi, anche chiamata la “Casa Rossa” o “Villa delle Streghe”, il film nella prima scena dove si fondono opache trasparenze ci mostra l’arrivo al college della ragazza americana in macchina sotto la pioggia con un chiaro richiamo al maestro del brivido e al film “Rebecca”, ma l’affinità é soltanto di carattere esteriore e subito dopo attraverso un gioco combinatorio fatto di allusioni e contaminazioni i movimenti della macchina da presa ci conducono in un mondo surreale di matrice magrittiana e la scena della ragazza che corre nel bosco fuggendo dal college appare come la quintessenza dell’opera Firma in bianco del pittore surrealista, dove la figura che attraversa il bosco ci appare parzialmente nascosta dagli alberi, per poi riapparire, senza lasciare alcun dubbio sulla sua unità mentre i due livelli vedo non vedo si fondono in un’unica immagine trasformando così una visione reale in una astrazione.
Inchiodati alla sedia fin da questa prima scena e costretti a vedere la realtà sia dal punto di vista dell’assassino che insegue la ragazza fra gli alberi, sia da quello della ragazza che arriva al college, in un’ambiguità che insegue le ambiguità e le fa eco, entriamo poi dentro stanze sontuose dagli arredi delegati quasi totalmente ai colori ed ai dipinti delle pareti che in un gioco continuo fra figura e sfondo, richiamati dai disegni di Escher, diventano essi stessi osservatori della realtà e al tempo stesso osservati, surreali nella surrealtà, mentre noi ci trasformiamo da assassini in detectives e l’ambiguità formale diviene ancora una volta ambiguità di vissuti contrastanti fino a condurci a vedere le scene con l’occhio del fantasma che si alterna in brevi momenti a soggettive di Susy, interpretata da Jessica Harper o di Sarah interpretata da Stefania Casini La narrazione tende asparire, come accadrà anche nei successivi film del cineasta, per lasciare qui completamente posto al colore che diventa elemento dominante insieme alla percezione dello spazio e veniamo immersi in universo fatto di fascinazioni visuali con richiami a Mondrian dove strutture elementari segnano l’apertura per ulteriori dimensioni o De Chirico evocato degli archi dipinti alle pareti e dalla piazza senza tempo dal sapore neo-classico dove la figura del cieco é schiacciata dalla macchina da presa che con una caduta dall’alto ci incolla di nuovo alla sedia in un clima agorafobico sostenuto dall’energia e dal ritmo delle musiche dei Goblin.
Atmosfere che ricordano momenti della cinematografia di matrice antonioniana, quando il maestro dell’incomunicabilità traeva spunto dalla pittura metafisica e dal colore per rendere ancora più incisivo il suo cinema. Gli Iris di matrice vangogghiana, invece fanno mostra di sè fra le pareti del palazzo e nascondono verità sconvolgenti fra i corridoi di architetture che imprigionano i personaggi dentro spazi quasi sempre dalle linee rettangolari, ora finestre, ora porte, in un clima questa volta claustrofobico che li incarcera dentro i loro pensieri e ce li mostra attraverso specchi in mezzo ad un’orgia di colori che ci trasporta nel mondo di Max Ernst fra rossi, blu, verdi dove emergono di tanto in tanto animali anch’essi ambigui, che si alternano nelle varie scene. Le protagoniste più volte vengono schiacciate dalla macchina da presa in stanze segrete dalle prospettive vertiginose che riflettono gli abissi dell’anima e fanno da sfondo agli oggetti enigmatici scoperti nelle peregrinazioni fra le architetture labirintiche del luogo o inseguite dal nostro sguardo lungo corridoi misteriosi che conducono a una verità assurda e inquietante che riassume il percorso della pittura surrealista in uno sdoppiamento di costanti contraddizioni di senso, di forme e di situazioni e ancora di vedo-non vedo. Un epilogo affidato ad una ingenua, angelica e spaurita ragazza, la cui vita é appesa ad un filo per tutta la durata del film, che, come nella mitologia classica, dopo l’attraversamento degli elementi acqua, fango, aria, sangue, ci permette di giungere al fuoco purificatore.
Primo film della trilogia definita dal regista delle tre madri, dove l’orrore si fonde al mistero ed al surreale, il film venne girato durante il periodo degli anni di piombo quando il terrore incombeva sulla vita dei cittadini che, visto il successo dell’opera, (come é accaduto in altri periodi storici), sembrano cercare una catarsi combattendo il terrore attraverso il terrore stesso, fattore che ci permette di definire il film omeopatico e capace di curare ed esorcizzare momentaneamente paure e stress individuali e collettivi ad un costo relativamente basso.
.
IL BUON SELVAGGIO E IL CATTIVO SAMARITANO – “GREEN INFERNO” DI ELI ROTH
di Giorgia Pizzirani
L’Amazzonia viene lentamente deforestata. Studenti americani ecoattivisti volano dal loro campus fino alle foreste per protestare contro la multinazionale dietro alla vicenda, postando le loro azioni sui social media. Funziona, ma nel viaggio di ritorno l’aereo si schianta nel folto della foresta, abitato da autoctoni cannibali che catturano i sopravvissuti facendone carne da macello.
La gabbia in cui sono rinchiusi non è solo strutturale e fisica, ma anche psicologica; chiusi in un acquario come piccoli pesci queruli ma ammutinati, questi prigionieri ricchi ma ora inermi vengono spiati con sana curiosità e sprazzi di umorismo nero che per un attimo fanno sorridere lo spettatore; e i pali di canne che li trattengono sono le stesse sbarre che imprigionano gli animali in uno zoo, o l’aragosta di Foster Wallace. Questa è la trama dell’ultimo horror-splatter del regista americano Eli Roth, uscito nelle sale italiane il 24 settembre 2015.
L’accostamento bizzarro tra le scene truculente e una ironia straniante in cui la paura e lo schifo lasciano il posto a una risata storta che allenta la tensione di un film che disturba e lascia un malsano sarcasmo anche quando scorrono i titoli di coda. Fino a qui niente di nuovo, il meccanismo è molto simile a quello che stava alla base del film di Ruggero Deodato del 1980. Quello che fa Roth è prendere un cult e riscriverlo in chiave contemporanea, creando un “Cannibal Holocaust” 3.0. Entrambi sono figli del proprio tempo: perché se Deodato critica la società moderna e i mass media, veicolando piuttosto chiaramente chi sono i veri selvaggi, attraverso il suo film Roth lancia allo spettatore una serie di sassolini difficili da togliere dalle scarpe.
Roth, come Deodato, sfata dèi contemporanei.
I social network: l’esserci ovunque a ogni costo, motore propulsivo delle azioni del gruppo di studenti che va ben oltre l’essere nel mondo heideggeriano. Studenti che si legano agli alberi che la squadra di deforestazione sta abbattendo, postando in diretta – sport mondiale – il massacro naturale e imbracciando le armi e la fede di Twitter, Facebook e Instagram.
E poi la cucina: l’amorevole cura con cui gli autoctoni cucinano lo sventurato Jonah non ha nulla a che vedere con le faide culinarie televisive, al primo posto dei palinsesti, bensì è un inno – sanguinolento ma dalle buone intenzioni – allo slow food.
La loro ingenuità nei confronti di tutto quello che esula dal mondo in cui vivono, il loro universo.
I nativi celebrano i nuovi venuti come un dono del cielo, che permette di essere sfamati o di acquisire un nuovo membro nella tribù, onorato e sottoposto ai rituali che prevede la tradizione.
Il valore dello straniero è ancora quello del martire, come fu il pastore Howie in “Wicker Man”, (1973); quello del tacchino nel giorno del Ringraziamento. Nonostante ciò, il supremo cannibale appare l’occhio dei mezzi tecnologici, pronti a sbattere in prima pagina azioni e parole riprese.
Non sfugge che nel film dramma vero non è tanto l’essere prigionieri di una cultura che non si comprende né si condivide, quanto il fatto di essere condannati a morte proprio da chi si desidera salvare. Gli studenti non sono che prede di un ipocrita sogno intellettuale cosmopolita, ciechi di fronte all’evidenza della diversità e pluralità del mondo senza realmente volerlo conoscere.
L’alternativo in giacca, mocassini e sciarpa morbida convince la sua brava massa di fedeli a seguirlo per una missione. È molto facile identificare nel fascinoso Alejandro lo statista che ha fatto dei media la sua bandiera; ma anche l’eroe di turno delle assemblee liceali e universitarie durante le occupazioni studentesche, in cui gli annoiati figli del campus-bene vedono il deus ex machina del prossimo week-end fuori porta, politically correct quanto basta, autoritario con i timidi e ingenui proseliti di quel dio ormai morto che è il dovere civile.
“Now stand up and make history”, redarguisce ai fedeli ormai in trance, una volta arrivati nelle foreste peruviane. Ma la sua autorità, e questo non era nell’iniziale patto convenuto, viene meno nel momento in cui si delocalizza la vicenda, e un altro gruppo sociale ne prende il posto: di nuovo una donna che, questa volta, prende il timone della santificazione sociale, nella società stessa di cui è già capo indiscusso. Una donna, personaggio-chiave sia nel bene che nel male che si mescolano nelle sembianze di Justine e della matriarca della tribù: Roth riprende il mito della strega già reimpastato in altri horror della new wave francese e americana – basti pensare a “Martyrs” di P. Laugier (2008), a “Alta tensione” di A. Aja (2008) – e farne questa volta assumere le sembianze estetiche e ancestrali, creando una santona inquietante e solenne.
L’ingenua Justine è l’unica del gruppo a salvarsi. Nomen omen?
Che porti il nome dell’eroina creata da de Sade, salva e ricompensata con denaro e prestigio sociale dopo avere subito le peggiori angherie, non è un caso. Ma allora è meglio mantenere le proprie virtù, comportarsi bene e subire affidandosi a un destino che forse ci dà il resto di un cifra troppo alta già pagata, come farebbe un protestante, mantenendo la propria verginità morale, intellettuale e – come nel caso della protagonista – anche fisica… oppure diventare leader di una bandiera insozzata dalle apparenze?
È un bel dilemma, per dirla come la sfortunata protagonista del “Candido” di Voltaire.
Justine si salva perché agisce credendo nel bene, e non perché figlia di un funzionario delle Nazioni Unite. Non è stupida buona fede recidiva, la sua, né furbizia sviluppata – anche a sue spese – durante il week-end fuori porta. Lei infatti è l’unica che non solo rischia di essere duramente punita dall’uomo civilizzato, nei panni della squadra di deforestazione, mentre compie una scelta dettata dall’infatuazione per l’idolo delle masse che potrebbe anche chiamarsi Benito, o Matteo; è anche l’unica a essere oggetto di scherno della sua stessa tribù di studenti perbene, dai quali verrebbe immolata senza rimorso pur di glorificarsi.
Nonostante soffra la sua prigionia, continua instancabile a cercare il contatto con l’unico soggetto tribù cannibale che sembra disposto a darle ascolto, un bambino; senza porlo indistintamente al di sopra del bene e della menomazione di spirito di cui poetava William Blake nel più dorato romanticismo inglese.
Il piccolo le lancia l’unico salvagente possibile per tornare al suo mondo: una traccia della superiorità dell’innatismo verso comportamentismo e strutture sociali, Leibniz che vince la partita contro Thorndike, una pura di cuore nonostante l’ambiente in cui cresce la spinga verso perbenismo radical-chic, competizione sociale e vittoria del più forte come più classica tradizione della scala sociale vuole. La mancata denuncia della sventurata protagonista non è una colpevole omissione della verità, ma una osservazione critica e non aprioristica di ciò che vede, cogliendo in essa un oggettivismo che le impone di proteggere i cosiddetti “selvaggi”, chiudendo idealmente il cerchio della storia e compiendo di fatto il destino della disavventura.
In maniera analoga al comportamento di Justine, che si dimostra paradossalmente amica degli autoctoni evitando di denunciarli alle autorità e condannandoli di conseguenza all’annientamento, il piccolo indigeno si ribella alle regole del proprio gruppo perché le supera, vedendo nella sofferenza di chi gli sta di fronte un giusto motivo per agire di testa propria.
Vince il bene, allora? Non proprio, o forse non sempre. E, una volta scalfita la roccia, chi resta in vita – priorità all’interno di qualunque film dell’orrore – è la persona che occupa nel mondo il posto più privilegiato: in questo caso Justine, che è la figlia di un funzionario delle Nazioni Unite.
Ancora una volta, Roth ci ricorda come le regole del denaro e del potere sociale tirino i fili di ogni umana situazione, decidendo il bene o il male: Justine decreta direttamente la morte del traditore Alejandro non avvertendo l’equipaggio dell’elicottero che la soccorre, né raccontando al comitato che la scolta al suso rientro delle sanguinose tradizioni della tribù.
Mentre il ritratto di Alejandro, per tutti ormai morto campeggia sulla maglietta di chi è già pronto a prenderne il posto, creando un eterno ritorno dell’imbecille. Mentre ancora una volta nei film di Roth vince il privilegiato, che può comprarsi la libertà e il silenzio dei (quasi) innocenti.
.
.
DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
RACCONTO E MEMORIA: IL CINEMA DI NICO GUIDETTI
Denominazione d’Origine Popolare.
La vera o presunta storia dei Violini di Santa Vittoria
di Marco Incerti Zambelli
Nico Guidetti è nato e cresciuto a Reggio Emilia, dove tuttora vive e lavora. Dopo la laurea in filosofia, tra il 1999 e il 2002 collabora, come critico cinematografico, con la rivista Cineforum. In quegli anni frequenta corsi di regia cinematografica a Bologna, specializzandosi nel documentario. Tra il 2000 e il 2001 collabora con L’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma, prima come assistente di regia, poi come operatore. E’ tra i fondatori del Centro studi R60 a Reggio Emilia, di cui è responsabile della sezione audiovisivi e per cui realizza numerosi documentari sul tema del lavoro e della sua storia in terra emiliana. Sempre sul tema della memoria e della riscrittura della storia locale attraverso il cinema documentario, da alcuni anni lavora insieme a Matthias Durchfeld di Istoreco (l’istituto storico per la Resistenza di Reggio Emilia), con cui ha realizzato “Ragazzi di Vezzano” (2008), “Primavera di bellezza” (2011), “Il violino di Cervarolo” ( 2012) e “Sabotatori” ( 2015 ). Nella sua vasta filmografia “Il mago del cinema , l’incredibile storia di Mr. Corman, regista low budget” (2006), “I giorni dell’amore nascente, il mondo di Franco Piavoli” (2007), “Note a margine – Appunti per un film sul 7 luglio” (2010) , “DOP: la vera o presunta storia dei Violini di Santa Vittoria” ( 2015).
“Socialismo a passo di valzer”
Carmelo Mario Lanzafame
All’alba del secolo scorso, i braccianti, poco più che servi della gleba, di una piccola frazione di un villaggio della Bassa Reggiana, scoprirono il socialismo, crearono una cooperativa e ben presto riuscirono ad acquistare la tenuta ed il settecentesco palazzo che la dominava dal loro datore di lavoro. E poterono affacciarsi al balcone dal quale il Conte, fino a poco tempo prima, gettava monetine ai braccianti, per “Grazia Natalizia”. La nuova situazione permise loro una diversa organizzazione del lavoro e la conquista di piccoli spazi di tempo libero, che occuparono ben presto organizzando musica e balli, osteggiati dai benpensanti frequentatori della prospiciente Chiesa Parrocchiale. Scoprirono che c’era la possibilità di affrancarsi dal faticoso lavoro nei campi, dedicandosi a suonare. Nacquero tredici orchestre di strumenti ad arco e sui cinquecento abitanti del luogo, comprese donne e bambini, almeno cento suonavano il violino ed alcuni addirittura si trasformarono in liutai per fornire gli attrezzi del mestiere.
I complessi erano organizzati per famiglie, alcune delle quali con una genealogia che ha poco da invidiare a quella dei Buendia, a volte in collaborazione, spesso in competizione tra di loro.
Negli anni ’60, i mutati gusti musicali portarono rapidamente all’estinzione di queste esperienze, che sfumarono progressivamente nell’oblio.
Nel 2001 cinque musicisti decidono di rinverdire quella esperienza, fondano “I violini di Santa Vittoria” e iniziano a ripercorrere quei sentieri. Nel 2014, il gruppo decide di arricchire i concerti con una narrazione , memore dei filoss di stalla, che accompagni gli spettatori alla scoperta di quel pezzo di storia. Parte una ricerca sul campo, ad ascoltare i ricordi dei discendenti ed i racconti dei pochi che hanno continuato a coltivare quella memoria, che fa emergere un tessitura complessa e affascinante.
Vedono la luce così uno spettacolo musical-teatrale “D. O. P. Denominazione di Origine Popolare. L’incredibile storia dei musicisti braccianti di Santa Vittoria” ed un Cd , realizzato grazie ad una campagna di crowfunding avventurosa come spesso capita a questo tipo di finanziamento.
Il film di Nico Guidetti “D.O.P.: la vera o presunta storia dei Violini di Santa Vittoria” racconta tutto questo, intersecando passato e presente, leggenda e realtà, spettacolo e testimonianze, vicende dei musicisti di ieri e di oggi.
Orfeo Bossini, il violinista filosofo, è il filo che lega le diverse sfaccettature del racconto e ci accompagna, nel percorso che porta alla ideazione dello spettacolo, in una atmosfera di realismo magico, tra il surrealismo poetico zavattiniano e l’espressionismo pittorico di Antonio Ligabue. Si dipanano le storie e le rievocazioni degli ultimi testimoni, impreziosite da qualche raro materiale d’archivio, foto ingiallite o vecchi giornali, i preziosi artigianali strumenti che il liutaio si era costruito da se , spartiti quasi illeggibili scritti a mano, magari sul retro di bigliettini di cartone ricavati dalle confezioni di pasta. Narrazioni da cui traspare a tratti lo stupore per l’interesse suscitato, spesso l’orgoglio per quelle esperienze, microstorie che si inseriscono nelle ricostruzioni dei pochi appassionati che hanno tenacemente coltivato e studiato queste vicende.
E, contemporaneamente, si seguono le tappe della creazione dello spettacolo, lo svelarsi delle storie dei musicisti, il lavoro di preparazione, le prove, i luoghi dove queste avvengono, l’attività con gli strumenti, l’emozionante vicenda del crowfunding per la realizzazione del CD
Un prezioso lavoro di scrittura e di montaggio intreccia i diversi piani, che si fondono armoniosamente nella sequenza del concerto nella sala di rappresentanza di Palazzo Greppi, sedie di plastica tra raffinati affreschi settecenteschi, ed ancor più nella festa del Primo maggio nella piazza del paese, tra antichi vessilli e nuovi immigrati, tra Bandiera rossa eseguita dalla banda del paese e l’Internazionale eseguita dal violinista leggendo la spartito sullo smartphone, tra lambrusco e torta fritta.
“Noi siamo la nostra memoria, cioè la memoria è l’anima, se si perde
completamente la memoria si diventa un vegetale, non si ha più l’anima”
Umberto Eco
Guidetti conferma nel suo lavoro la necessità della memoria e del suo incrociarsi, fondare il nostro presente. Una memoria che non si limiti però a testimoniare un passato a cui guardare con rimpianto, venato di nostalgia, ma che diventi ispirazione, guida, sostegno alle storie del presente, che sono il vero soggetto dei suoi film, come già aveva raccontato nei “Sabotatori”, nell’intreccio delle vicende, quella del partigiano Toni che sabotava concretamente le operazioni dei nazisti e dei fascisti e quelle di Tanja, Steffen e Stefano, che in diversi paesi Europei traducono nella loro vita quotidiana quelle azioni, opponendosi a tutto ciò che oggi non rispecchia più quei valori di uguaglianza, democrazia e partecipazione per cui lottarono i partigiani di allora.
Il loro ritrovarsi sui Sentieri Partigiani, una camminata sui percorsi dei combattenti delle Resistenza sull’Appennino Reggiano, che vede ogni anno una folta partecipazione da tutta Europa, salda generazioni diverse, crea una continuità su valori inalienabili, dà vigore alle scelte odierne, ed è messo in scena con un utilizzo attento di preziosi documenti d’epoca, una fotografia capace di cogliere la struggente bellezza delle piste appenniniche, una evocativa colonna sonora originale.
La sequenza finale, la festa collettiva di compleanno di Toni, suggella, con poetica commozione, il passaggio di testimone.
Il viaggio dal presente al passato per poi ritornare all’oggi con maggior consapevolezza, la ineluttabilità del confronto con chi ci ha preceduto, la risonanza tra le storie contemporanee e gli avvenimenti passati, accanto all’attenzione al territorio nel quale vive e lavora, sono tematiche fondamentali delle opere dell’autore, come dimostrano film precedenti quali “Il violino di Cervarolo”, e “Note a margine- Appunti per un film sul sette luglio”..
.
Conversazione con Nico Guidetti
Come vedi il panorama del cinema documentario oggi?
In Italia vengono realizzate molte opere che si possono classificare come documentari, credo che sia una frontiera della ricerca, anche se rimane il fatto che questo cinema fa’ fatica a trovare un pubblico, se non di nicchia, anche se vince i festival. Gianfranco Rosi ne è un esempio: ha vinto a Venezia e qualcuno aveva pensato ad una forzatura ma poi ha vinto anche a Berlino e “Fuocoammare” è veramente una delle sue cose migliori. E ci sono altri autori molto interessanti come Pietro Marcello, che è un altro molto bravo, con opere forse più visionarie, di ricerca.
Il documentario si è evoluto negli anni, è diventato sempre più di narrazione, quello che adesso si definisce cinema del reale. Io credo che sia un modo di fare cinema molto bello, stimolante anche per chi lo fa’, un corpo a corpo con la realtà che è anche un modo per sperimentare delle costruzioni narrative con un linguaggio innovativo. Poi ovviamente c’è anche chi si muove nella “tradizione”, Wiseman, ad esempio, al quale pare interessare poco la narrazione, cerca di costruire dei documenti molto ben riusciti, molto forti, su delle istituzioni, come Berkeley e National Gallery, che sono importantissimi, ma io non mi sento molto vicino a quel modo di fare cinema: si dice che il documentario deve essere un osservazione il più possibile neutra, se ci si mette una costruzione del racconto c’è un intervento scorretto, invasivo; ecco a me questi confini non interessano. Diceva Vittorio de Seta, che ho avuto la fortuna di conoscere, che per lui non esisteva questa distinzione tra finzione e documentario, io mi sento vicino a questo tipo di idea.
Il documentario offre la la possibilità di raccontare storie con le persone vere, in un modo molto più agile, si fanno opere che hanno un budget molto più ridotto, a volte sei addirittura da solo, e questo facilita molto proprio la sperimentazione sul linguaggio che io credo avrà ripercussioni anche su miglior cinema di finzione. Penso ad esempio a Joshua Oppenheimer: in “Act of Killing“, il suo mettere in scena la ricostruzione dei delitti da parte degli assassini in forma di genere cinematografico è molto interessante per questo rapporto tra finzione e realtà.
Nel tuo cinema la struttura della narrazione è molto accurata, le vicende narrate si intrecciano, , passato e presente si rimandano l’un l’altro.
Io amo molto la costruzione del racconto, presto molta attenzione, molta cura alla scrittura. C’è molto lavoro prima, a tavolino, ed anche durante le riprese. E’ naturale che poi la realtà ti condizioni, il confrontarti con situazioni magari inaspettate, può essere limitante o stimolante, se riesci ad affrontarlo nel modo giusto credo che questo sia il bello.
In “Dop” la stesura del testo è stata molto accurata, la ricostruzione del percorso di creazione dello spettacolo, il suo intrecciarsi con frammenti dello spettacolo stesso, ha richiesto molta meditazione, alcuni spunti narrativi sono nati appositamente per il film. La vicenda del crowfunding, invece è documentata in tempo reale, nella prima stesura della sceneggiatura proposta per il finanziamento della Film Commission non c’era, anche perché all’epoca l’idea di realizzare un CD e di finanziarlo con un raccolta di fondi non era prevista. Ed è stata la benvenuta, dato che mi interessava legare al presente la vicenda dei Violini e non sapevo bene come farlo, ed innestare un secondo racconto dava alla storia una struttura a flashback propriamente cinematografica.
In “Sabotatori “ le cose sono andate un poco diversamente, io sapevo che avrei incontrato i personaggi, ma non li conoscevo prima delle riprese. L’idea di utilizzare le interviste come voce narrante, fuoricampo, per accentuare l’aspetto riflessivo, l’avevo già in mente fin dall’inizio, ma molto si è costruito sugli eventi. La struttura ad incastro tra i personaggi e gli eventi rimane comunque il risultato di una ricerca sulla costruzione della narrazione.
“Il violino di Cervarolo” per me poteva anche essere un racconto di finzione, c’è un protagonista, l’avvocato, che persegue un suo obiettivo: se si fosse trattato di un puro documentario sulla strage di Cervarolo non lo avrei realizzato, non è la memoria in sé, la mera testimonianza di un fatto che mi interessa, ma quanto questa mi dia l’occasione di costruire un racconto di un certo tipo, non sono mai stato un contenutista.
Il lavoro è un tema che torna spesso nelle tue opere
Io sono figlio di operai, per me il lavoro è stato sempre quello in officina. La mia collaborazione con la CGIL, iniziata ormai quindici anni fa con una ricerca su Cinema e Lavoro nel territorio, ha poi portato alla realizzazione di alcune opere sulla condizione operaia. In “Presidio” mi ha attirato questa unità di luogo, questa capanna che avevano costruito gli operai, io sono stato lì ed è proprio il racconto di una giornata, ho respirato quello che loro facevano. Mi piacciono le facce degli operai, i volti di quel mondo, quelli che ci sono ancora, e i nuovi, gli immigrati. Ken Loach, nelle sue cose migliori, per me continua ad essere un punto di riferimento, per come sa fare il casting sulle facce e poi per come le mette in scena, quella giusta distanza; non gli interessano, come ha dichiarato, i dettagli, i primissimi piani, i personaggi sono inquadrati in mezzobusto, in una dimensione umana.
Poi mi sono allontanato da quel tipo di impostazione sindacale, una rappresentazione epica di un mondo operaio che in realtà si è molto ridotta ed è anche più complessa.
Il lavoro, la sua rappresentazione rimangono un tema che mi interessa, adesso sto lavorando ad un’opera su di una compagnia di danza, Aterballetto, che sta preparando una nuova coreografia nella sua sede, la Fonderia, un’architettura industriale ristrutturata con tre sale, Fucina , Fusione, Formatura. Il film dovrebbe essere scandito in questa forma, creatività, corpi, sviluppo della coreografia, l’arte come lavoro, come mestiere, un processo quasi industriale, nel senso nobile del termine. Un lavoro sui “ corpi” , alla fine quello torna.
Anche il cinema è un soggetto che hai esplorato
Il film su Roger Coman è nato come lavoro d’occasione. Solares stava organizzando questa rassegna sulla sua opera ormai 13 anni fa, con il regista ospite e Luigi Sardiello che allora era il direttore di Film Maker Magazine, ha organizzato una lunga intervista chiedendoci di filmarla e tempo dopo c’è stata l’occasione di montarla e metterla in circolo E’ stato piacevole anche se Corman non è uno dei miei autori di riferimento, al li là della sicura importanza che ha nella storia del cinema , anche come produttore.
“I giorni dell’amore nascente”, invece, nasce proprio dalla voglia e il piacere di raccontare quello che invece, almeno nella mia formazione , è stata una figura di autore importante. Con Federico Baracchi siamo partiti per fare questo racconto un po’ particolare, per entrare nel suo mondo, quel fare cinema in forma domestica, in un ristretto ambito geografico. Piavoli è sicuramente l’autore italiano che più mi ha ispirato.
Anche nei miei gusti cinematografici ho sempre sentito affini autori dal taglio “neorealistico” come Cassavetes e Rohmer. Amo molto comunque il cinema , il piacere del racconto, alla fine è tutto lì.
E’ nei tuoi progetti provare a realizzare film di finzione?
Mi interessa, mi piacerebbe sempre farlo con budget ridottissimi. Piavoli è un esempio di film di finzione , puoi chiamarlo cinema di poesia, cinema d’autore puoi chiamarlo come vuoi, comunque è cinema di finzione.
.
.
RICORDO DI DAVID BOWIE, LONDON BOY: “THE IMAGE” di Francesco Saverio Marzaduri
“The Image” è un cortometraggio di quattordici minuti, scritto e diretto da Michael Armstrong, che segna il debutto cinematografico di David Bowie. Girato nel 1967 in appena tre giorni, viene distribuito sul grande schermo solo due anni dopo e a causa del suo contenuto, ritenuto violento, figura tra i pochi cortometraggi contrassegnati con la “X” dalla censura inglese.
Il soggetto recita a study of the illusionary reality world within’ the schizophrenic mind of the artist at his point of creativity (“uno studio sulla realtà illusoria all’interno della mente schizofrenica dell’artista nel momento creativo”). Nel 1983, star ormai affermata, Bowie definisce lo short “roba d’avanguardia underground, in bianco e nero, fatta da un certo tizio. Voleva fare un film su un pittore che fa un ritratto a un teenager, ma il ritratto prende vita, e in pratica lo si scopre essere il cadavere di qualcuno. Non ricordo bene la trama… Era terribile.”
Dopo una brevissima uscita “The Image” scompare, per essere poi riscoperto e restaurato negli ultimi anni con l’aggiunta di tre minuti precedentemente sforbiciati. Il principale motivo della riscoperta si deve alla presenza di Bowie, unico elemento degno di nota. Per la parte del ragazzo-modello, Armstrong pensa subito a Bowie, essendone un estimatore. Il regista ha già tentato di collaborare con lui in una precedente occasione: Bowie avrebbe dovuto scrivere le musiche e impersonare Orfeo in un progetto mai portato a termine. Nel mese di giugno, inoltre, esce il suo primo album da solista, “David Bowie,” che attira l’attenzione del coreografo e mimo Lindsay Kemp, di cui la futura rockstar, in luglio, diviene allievo.
Le riprese di “The Image” iniziano il 13 settembre presso una casa abbandonata, appena fuori Harrow Road: Bowie è pagato trenta sterline, indotto per ore a resistere al freddo durante la scena che lo vede fuori dalla casa, aggrappato al telaio di una finestra, abbigliato con una camicia leggera e un paio di jeans; intanto, un forte getto d’acqua fredda gli viene sparato contro, simulando una pioggia battente. Come ricorda Armstrong, Bowie era tutto bluastro, e solo quando tornò all’interno della casa cominciò a riprendersi.
Lo short non soltanto segna l’esordio cinematografico di Bowie, ma anche il primo lavoro di Armstrong e uno dei primi ruoli interpretati da Michael Byrne, perlopiù noto per le sue partecipazioni (“Indiana Jones e l’ultima crociata,” “Braveheart,” “Gangs of New York”). In “The Image” Byrne interpreta, col massimo impegno, il ruolo dell’artista inquieto, ossessionato dal giovane e spettrale modello. Dal canto proprio, il ventenne Bowie mette in pratica le lezioni del maestro Kemp, nei gesti, nel modo di cadere, come una composta marionetta inanimata (eco della Biomeccanica teatrale di Mejerchol’d), o quando affronta i vari corpo a corpo col pittore.
Secondo alcuni, il rapporto tra i protagonisti è di natura omoerotica, laddove, almeno per chi scrive, all’autore preme di più indagare il filo che unisce creatura e creatore: un’allegoria del rapporto fra arte e artista, ma sopratutto del legame artista-soggetto-quadro. Molteplici sono i riferimenti mitologici, letterari e psicologici sulla vivificazione dei manufatti artistici, dal mito di Pigmalione a “Il ritratto ovale” di Poe, sino a “Il ritratto di Dorian Gray” di Wilde. Nell’ambito del cortometraggio, ritroviamo il pattern della magia dell’arte nel primo lavoro di un giovane Martin Scorsese, “What’s a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This?”. Qui, un giovane aspirante scrittore si tuffa dentro un dipinto raffigurante un paesaggio marino: l’esatto contraltare di quanto avviene in “The Image,” dove il pittore è inseguito da ciò che esce dal quadro, pur rimanendo un dipinto, e per fuggire alla propria magnifica ossessione sceglie di farne strame. Non meno importante, il tema della distruzione dell’opera amata – al contempo simulacro di un modello esecrato – per mano del suo creatore, topos attraversato in una moltitudine di titoli: uno su tutti, il breve film “Vita d’artista,” del 1910, prodotto dalla Cines di Roma, in cui un pittore distrugge il ritratto della propria modella e amante avendone scoperto il tradimento.
Oltre a spunti letterari e di psicologia dell’arte, Armstrong tenta di includere elementi riconducibili a movimenti artistici e cinematografici del Novecento, attraverso la totale assenza di dialogo, l’impiego di una colonna sonora firmata da Noel Janus e costituita da brevi inserti musicali, pioggia e respiri affannosi, ripetuti passi che si fanno pulsanti battiti di cuore. Ancora, la livida fotografia in bianco e nero ad opera di Ousama Rawi, l’utilizzo di inquadrature fugaci o dilatate sino allo spasmo, fotogrammi ossessivamente ripetuti e ralenti. Ma ciò non è sufficiente a conseguire quell’impronta claustrofobica, tipica dell’Espressionismo (Wiene e non solo), e certe violente atmosfere surrealiste, proprie del Buñuel prima maniera. Per tacere della tendenza del cinema sperimentale americano anni Quaranta, pulsante di spunti psicanalitici, o presunti tali, che in Maya Deren trovano la propria eponima icona.
Più in generale, le atmosfere paiono maggiormente debitrici dell’Hitchcock del periodo londinese, dei B-movie della Hammer intorno alla fine degli anni Cinquanta, della moda dell’horror mainstream (che apre il varco a insospettabili cineasti, come il Michael Powell de “L’occhio che uccide”), del kitchen sink realism ripetutamente presente nel Free Cinema (e adottato anche dal Losey de “Il servo” o dal Polański di “Repulsione”), della New Wave britannica. Tendenze che assimilano e rielaborano i citati movimenti, e che purtroppo l’operina di Armstrong non riesce a ripetere né a sintetizzare in forma nuova e diversa. Il climax che vi si respira sembra epigono di un format televisivo più che cinematografico (si pensi alla stagione 1959-64 della serie statunitense “Ai confini della realtà”), e anche in questo caso il lavoro di Armstrong appare come un pallido facsimile.
.
IL SALE DELLA TERRA
Questa rubrica nasce dalla passione di chi scrive per un cinema, ma anche una fotografia, una narrativa che abbia come suo fine principale quello di raccontare e di riflettere sulla realtà. O, meglio, sulle realtà, perchè il concetto di realtà è necessariamente plurale, Soprattutto nel mondo di oggi. Poi che cosa sia la realtà è questione che riguarda le culture e i punti di vista che esse producono nelle società da cui emergono. Quindi “Il sale della terra” è una rubrica che si occuperà di realismo/i a 360° gradi, di documentarismo, cinema della realtà, fotografia sociale e in generale di quelle forme narrative che fanno del rapporto con la realtà il loro punto di riferimento.
Immaginando un altro cinema e un’altra vita
“E’ il desiderio di fotografare che mi spinge di continuo a ripartire. Ad andare a vedere altrove”. Sebastião Salgado
Era destino forse che un instancabile viaggiatore del cinema e della vita come il regista tedesco Wim Wenders incontrasse sulla sua strada un uomo di immagini e di viaggi come il famoso fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Un uomo che ha sempre usato la luce come lo scrittore usa l’inchiostro, ma senza la frenesia industriale di produrre necessariamente qualcosa per un ipotetico mercato. Ciò che ha sempre mosso Salgado e Wenders è sempre stata la ricerca del senso profondo delle cose, osservando e ascoltando la realtà senza la necessità di avere preventivamente un punto di vista da difendere e dimostrare attraverso la propria opera. Il che non vuol dire produrre immagini
senza etica, ma costruendo una morale delle immagini a contatto diretto con le realtà con cui si viene a contatto, condividendo modi di vita e riflessioni sul mondo che non diventano mai dogmi, ma nuovi punti di partenza da cui riprendere il viaggio. Senza fretta. Prendendosi tempo. Aspettando che qualcosa accada. Perchè qualcosa accade sempre.
“Chi non ama aspettare non può diventare fotografo (…) Bisogna saper assaporare la pazienza”. Sebastião Salgado
Il tempo è un elemento dirimente nell’intera opera del regista tedesco che ha sempre fatto di una certa lentezza realizzativa e narrativa una cifra stilistica imprescindibile. Perchè la velocità è nemica della profondità e se si vogliono realizzare storie e immagini cariche di senso l’attesa non è mai inutile, soprattutto se si tratta di realtà che non condividono la dittatura del fare e del produrre a tutti i costi, tipiche del pensiero e della prassi dominanti nella cultura occidentale. La lentezza non significa pesantezza, ma soprattutto rispetto per ciò che si intende fotografare o filmare, oltre che per sé stessi. “Bisogna adattarsi alla velocità degli esseri umani, degli animali, della vita. Anche se il nostro mondo va molto velocemente, la vita segue un altro ordine di grandezza. E la vita va rispettata, quando la si vuole fotografare”, afferma Salgado nella sua autobiografia.
“Le storie a lungo termine mi appassionavano più delle notizie dell’ultimo momento”. Sebastião Salgado
Il risultato di questa ricerca è necessariamente un atteggiamento verso la realtà che rifugge l’estetica ipercinetica delle cosiddette “news” che rispondono esclusivamente non solo ad una logica di mercificazione della vita, ma soprattutto ad un paradigma che si potrebbe definire “pornografico”, dominante nel mondo odierno dei media e nella percezione comune del mondo e delle immagini. Nel senso che, come nei film e nelle immagini del porno, le news hanno l’ossessione del tempo presente (niente passato e niente futuro) e dell’azione fine a sé stessa (assenza di tempi morti).
Mentre la vita dell’uomo e della natura è fatta soprattutto di tempi morti, perchè è proprio in quella dimensione spazio-temporale apparentemente vuota che ogni cosa emerge nella propria essenzialità, nella propria inalienabile individualità, nel proprio essere necessariamente sé stessa e non altro. Come un uomo fra le dune di un deserto. O una barca in lontananza sulla superficie piatta del mare.
“Un giorno, senza sapere come, né perchè, mi sono ritrovato ad occuparmi di temi sociali”. Sebastião Salgado
In questo rispetto dei tempi e degli spazi in cui la vita umana (ma anche animale e vegetale) si svolge consiste anche la profonda eticità, e quindi politicità, delle immagini realizzate da Wenders e da Salgado. “Ogni fotografia è una scelta. Anche nelle situazioni difficili bisogna volerci stare e assumersi la responsabilità di esserci”, afferma Salgado nella sua autobiografia, svelando la propria scelta di campo che non consiste nel dimostrare una qualche tesi ideologica, ma nel mostrare nel modo più onesto possibile la realtà che si trasforma davanti ai suoi occhi. Senza far finta di essere oggettivi, perchè l’oggettività assoluta non è qualità appartenente al mondo umano e la fotografia, come il cinema, è sempre un linguaggio soggettivo. L’eterna dialettica fra ciò che sta in campo e ciò che sta fuoricampo attiene a questa continua tensione fra la soggettività di chi usa la macchina fotografica o la macchina da presa o la videocamera e la realtà in continuo movimento in cui l’autore (o gli autori) si trova immerso. La scelta quindi di mostrare la vita quotidiana dei lavoratori sfruttati, le drammatiche condizioni dei rifugiati o raccontare la vita di personaggi ai margini della società piuttosto che le magnifiche sorti e progressive divulgate quotidianamente dal potere e dai suoi media compiacenti ha molto più a che fare con un modo di elaborare immagini e raccontare storie più vicino al fuoricampo, in qualsiasi modo lo si voglia intendere, che ad un campo, recinto o prigione del pensiero che deresponsabilizzi l’individuo dal dovere morale di scegliere (altro che la “libertà di non scegliere”, decantata con enfasi da una pubblicità in onda su tutti i teleschermi in questi giorni). “Nessuno ha il diritto di mettersi al riparo dalle tragedie del proprio tempo, perchè siamo tutti responsabili in un certo modo di quello che succede nella società in cui abbiamo scelto di vivere”, afferma ancora Salgado.
“Volevo fare reportage senza seguire la stretta attualità, ma per mostrare le trasformazioni in corso nel mondo”. Sebastião Salgado
Il viaggio diventa quindi un elemento fondamentale sia per Wenders che per Salgado in questa spasmodica ricerca di un incontro con il mondo fuori dalle regole narrative e dalle logiche del mercato. Per entrambi raccontare il mondo significa, secondo una certa suggestione romantica da sempre intellettualmente presente in Wenders, più istintiva in Salgado, entrare nel mondo, farne parte, fondersi con esso, magari anche perdersi in esso. “Quando si fonde con il paesaggio e con la situazione che vive, la costruzione dell’immagine finisce per emergere davanti ai suoi occhi. Ma per riuscire a vederla, il fotografo deve far parte di ciò che accade. Allora tutti gli elementi si mettono a giocare con lui (…). Questa è la fotografia. A un certo punto gli elementi si collegano, le persone, il vento, gli alberi, lo sfondo, la luce”. E’ allora che il racconto può cominciare, secondo una struttura che non diventa mai una gabbia in cui i personaggi muoiono nello stereotipo, ma in cui essi continuano a dialogare con ciò che sta fuoricampo, con un prima e con un dopo che impedisce di chiuderli in una monodimensionalità asfissiante e profondamente falsa. Forse per questo sia le fotografie di Salgado che i film di Wenders si ricordano soprattutto per la grande quantità di immagini di paesaggio, per i campi lunghi in cui i personaggi ritratti si immergono nello spazio circostante, alternati a primi piani mai casuali in cui essi sembrano in qualche modo rivolgersi direttamente allo spettatore in un dialogo muto, ma ricco di suggestioni. Immagini spesso in bianco e nero…
“La vita è a colori, ma il bianco e nero è più realistico”, Samuel Fuller in “Lo stato delle cose” (1982).
La scelta del bianco e nero è una costante nel lavoro di entrambi gli autori. Il regista tedesco ne ha fatto una sua peculiarità, mai rinnegata, fin dai suoi primi film, ma anche Salgado lo ha sempre preferito al colore, almeno fino agli anni Duemila, quando utilizzando anche il digitale ha cominciato a lavorare anche sulle immagini a colori. Indubbiamente questa scelta non ha solo a che fare con una scelta stilistica, ma per entrambi rispecchia una posizione etica rispetto alla realtà, una particolare predilezione a concentrare la propria attenzione e quella dello spettatore sull’intensità, sulla profondità delle immagini e di ciò che ritraggono, mentre il colore tende a distrarre l’occhio dello spettatore su dettagli magari molto godibili a livello visivo, ma inevitabilmente dispersivi. E’ lo stesso Salgado a spiegare bene le ragioni di questa scelta. ”Con il bianco e nero e tutta la gamma dei grigi posso concentrarmi sull’intensità delle persone, sui loro atteggiamenti, sui loro sguardi, senza che siano disturbati dal colore. Certo, nella realtà niente è in bianco e nero. Ma quando guardiamo un’immagine in bianco e nero, questa entra a far parte di noi, la assimiliamo e inconsciamente la coloriamo. Penso che il potere del bianco e nero sia davvero straordinario e per questo l’ho utilizzato senza alcuna esitazione per rendere omaggio alla natura: fotografarla così era per me il modo migliore di mostrare la sua personalità, far emergere la sua dignità. Bisogna sentire la natura, bisogna amarla e rispettarla per poterla fotografare, come per le persone e gli animali. E tutto questo per me è veicolato dal bianco e nero”. Ed è questo che da sempre fornisce una particolare qualità documentaria al cinema di Wenders che in tempi recenti sembra sempre più orientato a frequentare il documentarismo anche come genere cinematografico, peraltro già ben presente nella sua cinematografia (“Lampi sull’acqua – Nick’s Movie“, “Tokyo-Ga”, “Buena Vista Social Club”, “Appunti di viaggio su moda e città”, “I fratelli Skladanowsky”, “Pina”).
“Il sale della terra” sintetizza bene le riflessioni e i temi sparsi finora in queste righe: il viaggio, il bianco e nero, il rapporto dell’uomo con il paesaggio, la dialettica fra campo e fuoricampo, tra immagini fisse e in movimento, l’importanza dell’ascolto del mondo, dell’osservazione della natura, della lentezza, il rapporto fra bellezza e giustizia sociale. Wenders lo fa utilizzando in qualche modo Salgado come suo alter ego, il quale a sua volta sembra rispecchiarsi perfettamente nella concezione cinematografica aperta, cosmopolita e profondamente libertaria del regista tedesco. In questo affascinante gioco di specchi cinematografico i due autori dialogano e si scambiano spesso i ruoli a tal punto che spesso non si sa bene chi ritrae chi. Ma forse non è così importante saperlo. In fondo, citando ancora una volta Salgado, “una foto non parla solo di chi è ritratto, ma anche di chi ritrae”.
.
.
QUALITA’ IN SERIE
a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
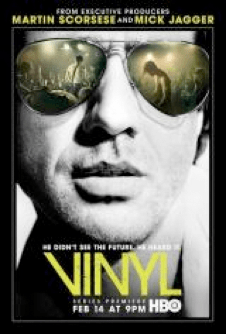 “VINYL” (1^ stagione)
“VINYL” (1^ stagione)
Regia: Martin Scorsese, Allen Coulter, Mark Romanek, S.J. Clarkson, Peter Sollett, Nicole Kasell, Jon S. Baird, Carl Franklin
Soggetto: Martin Scorsese, Mick Jagger, Rich Cohen, Terence Winter
Sceneggiatura: Terence Winter, George Mastras (ep.1), Terence Winter (ep.2), Jonathan Tropper, Debora Cahn, Adam Rapp (ep.3), Debora Cahn (ep.4), Adam Rapp (ep.5), Carl Capotorto, Erin Cressida Wilson (ep.6), David Matthews (ep.7), Riccardo Di Loret, Michael Mitnick (ep.8), Debora Cahn (ep.9), Terence Winter (ep.10)
Interpreti: Bobby Cannavale (Richie Finestra), Paul Ben-Victor (Maury Gold), P.J. Byrne (Scott Leavitt), Max Casella (Julian ‘Julie’ Silver), Ato Essandoh (Lester Grimes), James Jagger (Skip Stevens), J.C.MacKenzie (Skip Fontaine), Jack Quaid (Clark Morelle), Ray Romano (Zak Yankovich), Birgitte Hjort Sørensen (Ingrid), Juno Temple (Jamie Vine), Olivia Wilde (Devon Finestra)
Produzione: Paramount Television, Jagged Productions, Sikelia Productions, Cold Front Productions
Durata: 550 min. ca.
Numero episodi: 10.
Origine: Stati Uniti 2016
Episodio 1. “Pilot”
Episodio 2. “Yesterday Once More”
Episodio 3. “Whispered Secrets”
Episodio 4 : “The Racket”
Episodio 5: “He in Racist Fire”
Episodio 6: “Cyclone”
Episodio 7: “The King and I”
Episodio 8: “E.A.B.”
Episodio 9: “Rock and Roll Queen”
Episodio 10: “Alibi”
In apertura di questo articolo è bene chiarire subito un dato: mentre scrivo la prima stagione è giunta al 5° episodio che viene messo in onda contemporaneamente negli Usa e in altre nazioni fra cui l’Italia (dove si può vedere su Sky Atlantic anche in versione originale con i sottotitoli). Perché occuparsi allora di una serie di cui non si è ancora completato il primo ciclo? Perché si tratta di un caso del tutto particolare e perché già nei primi cinque episodi si possono individuare le strutture portanti della narrazione e l’imprinting autoriale.
Ci volevano due fuoriclasse come Martin Scorsese e Mick Jagger per far andare in porto un progetto come quello di raccontare gli Anni ’70 nel mondo musicale americano in una serie che non si risolvesse in una compilation più o meno occulta di canzoni rètro. Valutando a partire dai primi cinque episodi si può affermare che l’obiettivo sia stato raggiunto non solo sul piano produttivo ma anche su quello della qualità (come impone il titolo di questo appuntamento fisso).
 Il plot di partenza è riassumibile come segue.
Il plot di partenza è riassumibile come segue.
Richie Finestra è il fondatore nonché il presidente dell’American Century Records che non naviga in buone acque e sta per essere venduta alla Polygram ma un evento inatteso gli fa cambiare radicalmente idea spingendolo a rilanciare un’etichetta che molti nell’ambiente ritengono un cimitero per gli artisti che finiscono con l’andarvi a morire. Ciò crea inevitabili contraccolpi sia sul piano familiare che su quello lavorativo. La moglie Devon aveva contato sul ricavo dalla vendita per mutare stile di vita e i colleghi avevano fatto, ognuno per proprio conto, dei progetti per il futuro. Solo la ragazza addetta alla consegna dei caffè e dei panini si è invece data da fare scoprendo un gruppo che anticipa il punk, i Nasty Bits. Ma c’è un altro e ben più grave evento che tormenterà la vita di Richie accelerando il suo ritorno alla dipendenza da alcol e droga. In un incontro in cui il proprietario di una catena di emittenti radiofoniche molto importanti, Buck Rogers, in preda a una sorta di raptus ha cercato di baciarlo, Richie lo ha ucciso devastandogli il cranio. L’ultima telefonata di Rogers aveva lui come destinatario e ora la polizia nutre più di un sospetto sul suo coinvolgimento nell’omicidio a cui ha partecipato anche il braccio destro di Buck, Joe Corso.
 Chi scorra anche solo superficialmente il cast & credits che apre questa recensione può verificare come a guidare le riprese sia stato chiamato un cospicuo numero di registi che hanno lavorato sulla base di sceneggiature i cui autori cambiavano spesso. Tra i registi spicca il nome di Marc Romanek che molti ricorderanno per “One Hour Photo” che vedeva Robin Williams protagonista in un ruolo per lui insolito. Questo è uno degli elementi di rilievo della New Wave delle serie tv che hanno visto in più di un’occasione un regista famoso dirigere il pilot e poi, una volta dato l’imprinting, lasciare il campo ad altri. Scorsese lo aveva già fatto con “Boardwalk Empire-L’impero del crimine”. Intendiamoci: si tratta di una modalità di lavoro consueta nella serialità ma quando il ‘la’ è stato dato da un Maestro allinearsi al suo stile di narrazione richiede una sensibilità particolare.
Chi scorra anche solo superficialmente il cast & credits che apre questa recensione può verificare come a guidare le riprese sia stato chiamato un cospicuo numero di registi che hanno lavorato sulla base di sceneggiature i cui autori cambiavano spesso. Tra i registi spicca il nome di Marc Romanek che molti ricorderanno per “One Hour Photo” che vedeva Robin Williams protagonista in un ruolo per lui insolito. Questo è uno degli elementi di rilievo della New Wave delle serie tv che hanno visto in più di un’occasione un regista famoso dirigere il pilot e poi, una volta dato l’imprinting, lasciare il campo ad altri. Scorsese lo aveva già fatto con “Boardwalk Empire-L’impero del crimine”. Intendiamoci: si tratta di una modalità di lavoro consueta nella serialità ma quando il ‘la’ è stato dato da un Maestro allinearsi al suo stile di narrazione richiede una sensibilità particolare.
E’ facile comprendere, anche dopo soli 5 episodi, quali siano i temi che hanno interessato Scorsese. Perché qui l’ambiente discografico si propone come il coacervo di molti dei ‘luoghi’ del suo cinema. A partire dall’italoamericanità del protagonista che, in risposta a chi apprezza la sua competenza nel campo del blues, chiedendogli se sia sicuro di essere un bianco risponde “Sono italiano”. Questo comporta, scorsesianamente, rapporti con mafiosi da cui cerca, non sempre con successo, di tenersi a distanza divenendo invece causa indiretta della brutale interruzione della carriera di un cantante di valore. Ci sono poi i demoni creati dall’abuso di alcol e cocaina (l’eroina viene lasciata al frontman punk) con il precipitare progressivo in una dipendenza pericolosa. Ovviamente non manca la violenza, anche se visivamente concentrata sull’omicidio di Buck che ritorna come un incubo destabilizzante mentre si cerca di sfuggire alle indagini andando a cercare un alibi proprio da chi si vorrebbe tenere maggiormente a distanza: la figura paterna.
 Non è assente poi la ricostruzione filologicamente accurata di un’epoca che consente anche flashback sul decennio precedente grazie alla narrazione di come è iniziata la carriera di Richie. Qui il contributo di Mick Jagger deve essere stato prezioso sia nel ricostruire gli ambienti sia nel caratterizzare alcuni personaggi dell’ambiente discografico. Ovviamente la colonna sonora è attenta ad offrire delle citazioni così come sono presenti degli inserimenti di personaggi che hanno fatto storia come Alice Cooper o Andy Warhol. Se i personaggi maschili dominano, come spesso accade con Scorsese, le due figure femminili principali si vedono affidato il compito di emergere progressivamente.
Non è assente poi la ricostruzione filologicamente accurata di un’epoca che consente anche flashback sul decennio precedente grazie alla narrazione di come è iniziata la carriera di Richie. Qui il contributo di Mick Jagger deve essere stato prezioso sia nel ricostruire gli ambienti sia nel caratterizzare alcuni personaggi dell’ambiente discografico. Ovviamente la colonna sonora è attenta ad offrire delle citazioni così come sono presenti degli inserimenti di personaggi che hanno fatto storia come Alice Cooper o Andy Warhol. Se i personaggi maschili dominano, come spesso accade con Scorsese, le due figure femminili principali si vedono affidato il compito di emergere progressivamente.
.
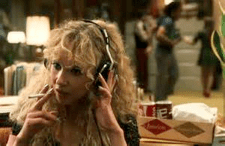 La Jamie Vine di Juno Temple passa da cameriera di studio pronta anche a procurare droghe di qualsiasi tipo ai membri dello staff a talent scout che sa comprendere la forza dirompente dei Nasty Bits offrendo loro un’opportunità che metterà però in crisi il frontman Skip Stevens nel momento in cui Richie gli chiederà di licenziare il suo migliore amico.
La Jamie Vine di Juno Temple passa da cameriera di studio pronta anche a procurare droghe di qualsiasi tipo ai membri dello staff a talent scout che sa comprendere la forza dirompente dei Nasty Bits offrendo loro un’opportunità che metterà però in crisi il frontman Skip Stevens nel momento in cui Richie gli chiederà di licenziare il suo migliore amico.
.
.
.
 Sul fronte familiare invece Olivia Wilde, nei panni di Devon Finestra, ha il complesso ruolo di una moglie che è stata fortemente voluta come compagna e che ora non ha più voce in capitolo e, seppure ignara, dell’omicidio commesso da Richie, è combattuta se chiedere o meno il divorzio. Con lei viene descritta, con accenti più sfumati rispetto al personaggio del marito, il mutare dei tempi e della condizione femminile. Ciò che si rivela però particolarmente interessante è l’attenta caratterizzazione di tutti i personaggi, anche di quelli che hanno un rilievo minore, che offre alla serie un alto livello di scrittura unito alla creazione di un mood sul piano visivo in grado di immergere lo spettatore in un’epoca così lontana eppure così vicina mostrando il lato B (oscuro) dell’industria discografica (con scippi di artisti e colpi bassi) ma anche la sensibilità indispensabile per cogliere le potenzialità nascoste di futuri possibili hitmen.
Sul fronte familiare invece Olivia Wilde, nei panni di Devon Finestra, ha il complesso ruolo di una moglie che è stata fortemente voluta come compagna e che ora non ha più voce in capitolo e, seppure ignara, dell’omicidio commesso da Richie, è combattuta se chiedere o meno il divorzio. Con lei viene descritta, con accenti più sfumati rispetto al personaggio del marito, il mutare dei tempi e della condizione femminile. Ciò che si rivela però particolarmente interessante è l’attenta caratterizzazione di tutti i personaggi, anche di quelli che hanno un rilievo minore, che offre alla serie un alto livello di scrittura unito alla creazione di un mood sul piano visivo in grado di immergere lo spettatore in un’epoca così lontana eppure così vicina mostrando il lato B (oscuro) dell’industria discografica (con scippi di artisti e colpi bassi) ma anche la sensibilità indispensabile per cogliere le potenzialità nascoste di futuri possibili hitmen.
Giancarlo Zappoli
.
PANORAMA LIBRI
a cura di Paolo Micalizzi
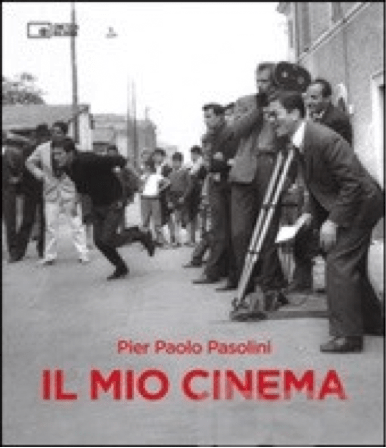 PIER PAOLO PASOLINI
PIER PAOLO PASOLINI
IL MIO CINEMA
a cura di Graziella Chiarcossi e Roberto Chiesi
Edizioni Cineteca di Bologna, 2015 ,
pagg. 280, Euro 29
Un volume elegante e ricco di fotografie, comprendente anche manifesti del Fondo Maurizio Baroni. Contiene testi di Pier Paolo Pasolini, già pubblicati in varie occasioni, relativi a tutti i suoi film. Un’occasione importante per conoscere il pensiero del suo autore, origini e sviluppi della realizzazione delle idee in film: sia quelli realizzati che quelli, purtroppo, che non è riuscito a portare a termine.
Il volume è introdotto dallo scenografo Premio Oscar Dante Ferretti che conobbe PPP nel 1964 sul set del film “Il Vangelo secondo Matteo” dove era assistente scenografo di Luigi Scaccianoce. Una collaborazione che proseguì con altri film di Pasolini fino ad arrivare a “Medea” del 1969 dove lui firma la scenografia. Ferretti ricorda che una delle prime cose che lo colpirono di Pier Paolo Pasolini fu ”la particolare autorevolezza che aveva, silenziosa e determinata. Arrivava sul set con la sicurezza di chi si è già posto le domande ed ha già trovato le risposte per quanto riguardava le modifiche alla sceneggiatura, le opzioni estetiche, i volti più adatti per le parti anche piccole. Rimanevano aperti tanti problemi tecnici o pratici, perché aveva poca esperienza, ma non se ne preoccupava di certo. Credo che in fondo non gli dispiacesse se i suoi film contenevano delle ‘sgrammaticature’, che non fossero lisci e levigati. Del resto, la sua idea di cinema non era certo quella”. Molte poi le caratteristiche di PPP rilevate da Ferretti: rifletteva rapidamente sul da farsi, era molto sicuro di quello che voleva ottenere ma al tempo stesso lasciava un ampio margine di permeabilità ai cambiamenti che potevano essere apportati dalla spontaneità dei non attori o dalla natura dei luoghi, dai mutamenti della luce, dei tanti fattori casuali dell’effettuazione delle riprese. Rifletteva rapidamente sul da farsi, precisa Ferretti e prendeva subito una decisione, non perdeva mai tempo, anzi sfruttava il tempo fino all’osso e aveva un’energia fuori dal comune, per cui riusciva a lavorare a ritmi incessanti senza mai fermarsi. Tante altre le caratteristiche di PPP indicate da Ferretti che con il regista aveva una perfetta sintonia, durata fino alla sua morte, anche se avevano gusti pittorici differenti. Interessante poi quanto dichiara Dante Ferretti quando afferma che Pasolini dava importanza al rapporto diretto con la realtà, e ciò lo si ritrovava anche nella scelta dei luoghi dove effettuare le riprese. Pasolini aggiunge poi Ferretti viaggiava molto e farlo con lui erano esperienze di vita e non solo di lavoro. Leggendo questo intervento di Dante Ferretti significa penetrare in maniera significativa nel mondo creativo di Pier Paolo Pasolini.
Interessante è anche il testo di Roberto Chiesi “Pasolini, dentro la realtà” in cui ci fa ripercorrere quella che indica come la vera chiave di lettura dell’opera pasoliniana. “Una realtà, quella cui alludeva Pasolini, che si identificava al mondo popolare, ai corpi e ai luoghi di quel mondo, al suo linguaggio verbale e corporale, che egli andava a cercare e filmare dove ancora sopravviveva, dove continuava a distinguersi dalla ‘normalizzazione’ borghese, nelle periferie romane, nel Sud d’Italia, in Africa o in Oriente”.
.
.
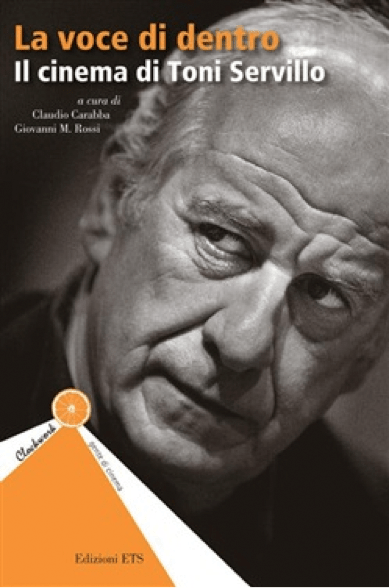 LA VOCE DI DENTRO
LA VOCE DI DENTRO
IL CINEMA DI TONI SERVILLO
a cura di Claudio Carabba e Giovanni M. Rossi
Edizioni ETS-Pisa, 2012,
pagg. 124, Euro 13.00
Un volume edito in occasione del Premio Fiesole ai “Maestri del Cinema” promosso da alcuni enti tra cui il Gruppo Toscano del SNCCI. Un volume, che si apre con un ‘introduzione di Giovanni M. Rossi dal titolo “La politique des acteur “ in cui l’autore parte dal famoso saggio- manifesto di Alexandre Astruc sulla camèra-stylo che riconosceva all’Autore il titolo del diritto di firma. Per poi riferirsi al “volumetto” di Luc Moullet del 1993, mai tradotto in italiano, che rovesciava la filosofia della Nouvelle Vague per parlare di una “Politique des acteurs” specificandola in Gary Cooper-John Wayne- Cary Grant- James Stewart. In esso Moullet partiva dal presupposto che un grande attore può essere autore dei suoi film al pari di un grande cineasta, . Rossi rifacendosi a Stanislawskij arriva a Toni Servillo “ che a più riprese si è dichiarato ‘stanislavskiano’ “. Da queste premesse parte l’analisi della statura scenica, del suo lavoro ”artigianale” al servizio del film e di altre caratteristiche che fanno di Toni Servillo la dimostrazione che “l’attore, il grande attore, può essere il veicolo primario delle nostre emozioni di spettatori, interprete ed autore di ogni film. Cosi come trent’anni prima il personaggio di Klaus Brandauer in “Mephisto” (1981) di Istvàn Szabò braccato da una selva di luce in un anfiteatro vuoto e notturno, con ancora sul volto una mezza maschera faustiana e in gola un grido straziante esclama: ”Che cosa vogliono da me? Io sono solo un attore”. Una significativa introduzione ad una serie di Saggi dovuti a Claudio Carabba, Gabriele Rizza, Marco Luceri, Massimo Tria e Marco Vanelli che precedono alcune “Letture filmiche” da parte loro e di altri critici del Gruppo Toscano del SNCCI. Molto utile poi la filmografia di Toni Servillo commentata da dichiarazioni dello stesso attore.
.
.
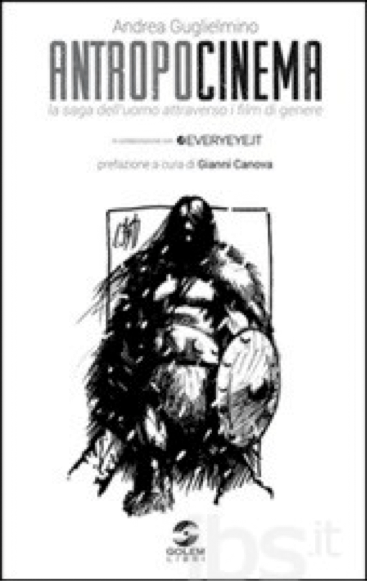 ANTROPOCINEMA
ANTROPOCINEMA
di Andrea Guglielmino
Golem Libri 2015,
pagg.206,Euro 15,00
Un volume interessante sul rapporto Cinema e antropologia. Il libro si pone la domanda se è possibile conciliare queste due discipline che apparentemente sono diverse. Oggetto di “Antropocinema” è il cinema seriale o di “genere”: un cinema commerciale, che attrae maggiore interesse. E attraverso questo ampio pubblico capire quali sono i gusti e le tendenze che caratterizzano la nostra società. E ciò può essere utile anche se il cinema si propone di farlo. Questo libro si propone di seguire la saga dell’uomo attraverso i film di genere . E lo fa con una serie di saggi che focalizzano alcuni film che hanno generato dei serial: Jurassic Park, King Kong, Il pianeta delle scimmie, Conan, Sherlock Holmes fina ad arrivare a Star Wars. Cercando, come sottolinea Gianni Canova nella prefazione, alcune inattese connessioni. Un libro che costituisce un contributo utile in un settore, l’antropocinema appunto, poco frequentato dalla pubblicistica cinematografica. E questo studio ne è un importante punto di riferimento.
.
.
.
.
.
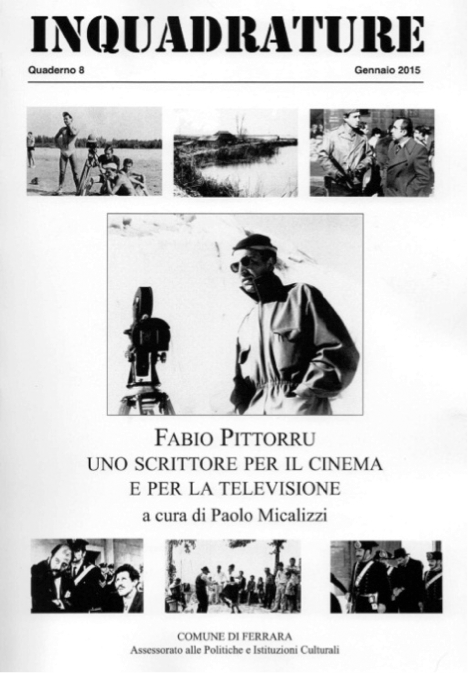 Una recensione di Orio Caldiron
Una recensione di Orio Caldiron
FABIO PITTORRU TRA CINEMA, TV, E LETTERATURA
Non dirò che l’ho letto come un romanzo, ma da quando ho cominciato a sfogliare il bel libro curato da Paolo Micalizzi su “Fabio Pittorru. Uno scrittore per il cinema e la Televisione” (pp. 230, Comune di Ferrara, 2015) non l’ho lasciato più fino alla fine. La storia municipale legata a una città o a una regione viene spesso trattata con sussiego dagli storici nazionali e transnazionali, mentre sono proprio lavori minuti, precisi, documentatissimi come questi di Micalizzi – che da decenni ha fatto di Ferrara e dell’Emilia il punto di partenza di studi e di ricerche di grande interesse – a far conoscere meglio il panorama complessivo del cinema italiano, percorso e ripercorso negli aspetti più inediti o meno noti, solitamente disdegnati dalle ambiziose sintesi accademiche.
Non è possibile seguire qui l’intera operosità di Fabio Pittorru, attivo come sceneggiatore, aiuto regista e poi regista sin dall’inizio degli anni Cinquanta in quella Ferrara che richiama subito alla memoria le figure straordinarie di Michelangelo Antonioni e Florestano Vancini, quasi numi tutelari di una passione che ha segnato profondamente il cinema e la cultura italiana. È proprio con Vancini che il giovane Pittorru collabora come aiuto regista per “Delta Padano” (1951), una inconsueta ricognizione tra le popolazioni del Delta da Goro a Gorino a Scardovari, dove il fiume si divide in tanti rami, fotografata dal grande Sturla. Solo pochi mesi dopo avviene nello stesso anno l’esordio nella regia con il documentario “Comacchio piange”, che ricostruisce la vita della città lagunare dove viene ucciso un sindacalista durante una manifestazione di protesta. La partecipe solidarietà dell’autore è così esplicita che il breve film sarà bloccato dalla censura.
L’approdo a Roma moltiplica gli impegni dello sceneggiatore che collabora tra l’altro a “La violenza: quinto potere” (1972) di Vancini, dedicato alla collusione fra mafia e politica, e a “Mussolini ultimo atto” (1974) di Carlo Lizzani, che ripropone i tragici avvenimenti della fine del regime fascista: altrettante occasioni importanti di quel cinema politico che era negli interessi più radicati del cineasta ferrarese.
Nel cinema di genere – di cui lo sceneggiatore si occupa a più riprese – prevale il poliziesco, in cui spiccano “Concerto per pistola solista” (1970) di Michele Lupo e “La polizia accusa: il servizio segreto uccide” (1974) di Sergio Martino, due vivaci esempi di cinema popolare dal forte impatto. Non è meno importante l’attività televisiva che svolge nello stesso periodo e prosegue fino agli anni Ottanta. Sono numerosi gli sceneggiati di argomento storico – la storia è per tutta la vita una delle sue passioni più tenaci e durature – scritti da solo o a quattro mani con Massimo Felisatti, per i più noti registi tv dell’epoca come Mario Ferrero, Alberto Negrin, Salvatore Nocita, Mario Landi, Piero Schivazappa. Ma la grande popolarità arriva con le due serie di “Qui Squadra Mobile” del 1973 e del 1976, scritte assieme a Felisatti. Sono andato subito a rileggere i libri che nello stesso periodo escono per Garzanti, da “Violenza a Roma” a “Qui Squadra Mobile”, per ritrovare una stagione particolarmente felice del giallo italiano, attento allo scenario sociale e politico di quegli anni, che sul piccolo schermo aveva i volti di Giancarlo Sbragia, Orazio Orlando, Luigi Vannucchi. Il lavoro di Micalizzi sembra cogliere qui i suoi risultati più significativi riproponendo il fitto intreccio tra i media, nel momento in cui getta nuova luce sull’industria culturale italiana in formazione.
.
AUTORI (new entries)
Nella sezione dedicata agli autori troverete la biografia di ognuno.
CREDITS n. 8
Carte di Cinema
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: info@cartedicinema.org
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi (E-mail: paolomicalizzi@gmail.com )
Direttore editoriale: Roberto Merlino
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 8 della rivista online: Laura Biggi, Orio Caldiron, Marcello Cella, Luisa Ceretto, Maria Pia Cinelli, Paola Dei, Elio Girlanda, Marco Incerti Zambelli, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Tullio Masoni, Paolo Micalizzi, Sergio Naitza, Davide Parpinel, Giorgia Pizzirani, Riccardo Poma, Chiara Supplizi, Vivian Tullio, Paolo Vecchi, Giancarlo Zappoli.