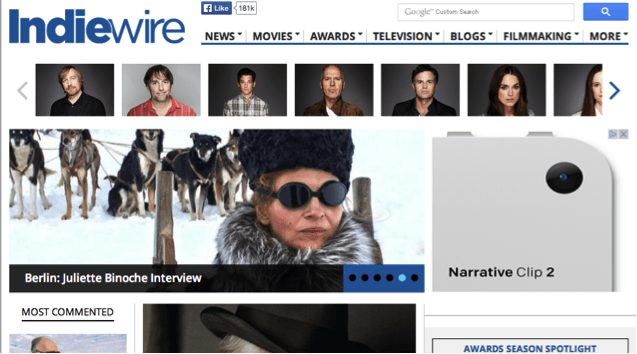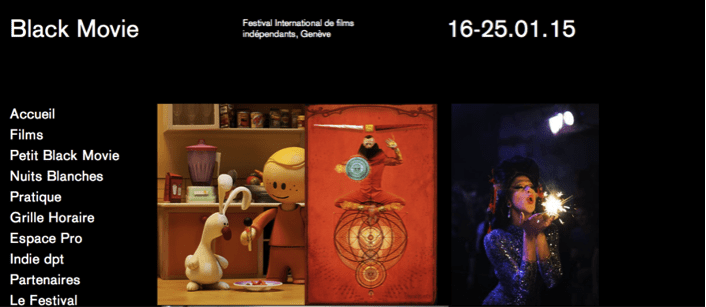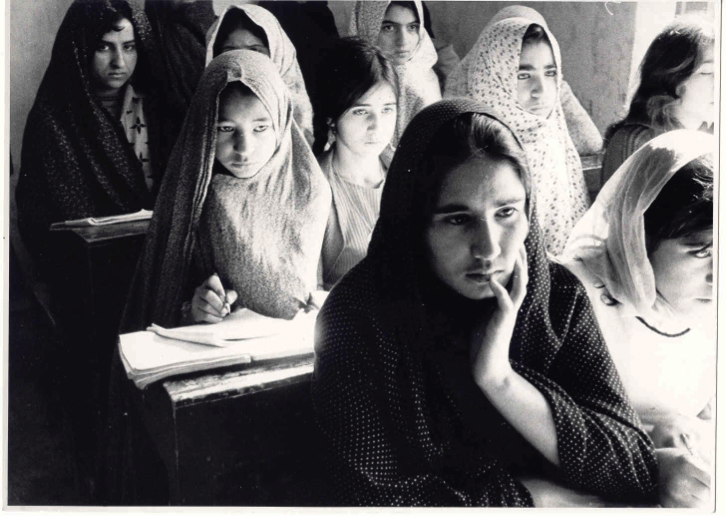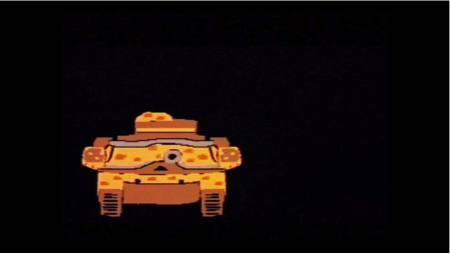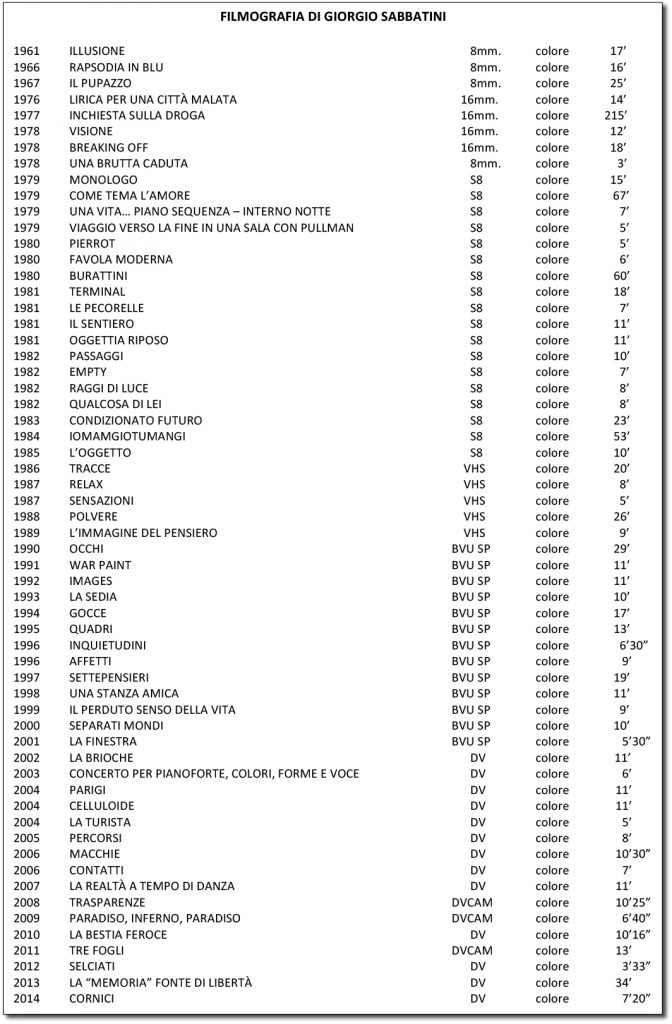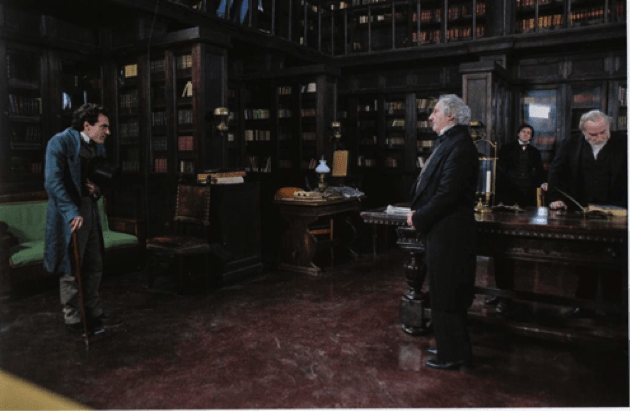Sommario
EDITORIALE
Nell’assumere la Direzione della Rivista sento il dovere, e il piacere, di ringraziare sentitamente Giancarlo Zappoli, Luisa Ceretto e Giulia Zoppi con i quali ho condiviso la responsabilità di portarla avanti sia nella edizione cartacea che nell’attuale veste on line. Validissimi colleghi che hanno lasciato tale ruolo per impegni importanti nel loro lavoro professionale. Mi fa, comunque, molto piacere che essi continueranno a collaborare alla Rivista i cui propositi terranno fede ad una linea concordata con loro in precedenza. Un ringraziamento sincero va anche al Presidente Fedic Roberto Merlino che a nome della Federazione mi dà fiducia nel nuovo incarico di Direttore responsabile, ed a Maurizio Villani, appassionato di cinema, che mi affiancherà come Redattore in questa prova impegnativa. Il cinema e i cineasti indipendenti, ma anche il documentario e l’attività dei filmaker, saranno motivi portanti della Rivista.
Già in questo numero s’inizia a parlare di momenti innovativi del cinema indipendente con l’ampio Saggio di Elio Girlanda e con il profilo di Ugo Brusaporco su un regista libero come pochi altri: Augusto Tretti. Nella sezione “Saggi”, Giulio D’Amicone sottolinea come il cinema americano ha trattato la figura del Presidente degli Statti Uniti, mentre Roberto Lasagna analizza alcuni film che si sono interessati di criminali nazisti. In “Fedic, le persone e i fatti”, rubrica da me curata sin da lungo tempo, porto alla ribalta un filmaker storico come Giorgio Sabbatini, mentre Roberto Merlino presenta la sua iniziativa di dare visibilità agli Autori Fedic grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva “DILUCCATV”. Viene anche pubblicato l’elenco delle puntate elaborate, onde dare la possibilità ad appassionati, cinefili e studiosi di poter conoscere l’interessante produzione Fedic.
Appuntamento anche con i “Festival” e “Occhio critico” su alcuni film di particolare rilievo dell’ultimo periodo.
Infine, mentre si continua con “Visti da lontano” su film poco visibili per colpa del mercato cinematografico, con “Qualità di Serie”, con la quale Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli continuano la loro collaborazione alla Rivista, viene posta l’attenzione su serie tv che in effetti sono anche lungometraggi.
E dal prossimo numero si riprenderà con “Panorama Libri”, si darà vita ad altre Rubriche e spazio a nuovi collaboratori, per portare avanti l’intento della Rivista di essere uno strumento di arricchimento culturale per tutti coloro che amano il Cinema.
BUONA LETTURA.
Paolo Micalizzi
.
CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
Il CINEMA INDIPENDENTE. Cenni storici
di Elio Girlanda
Scrivo queste note mentre si svolge l’appuntamento annuale del Sundance Festival, che testimonia la vitalità non solo della famosa rassegna del cinema indipendente internazionale ma di un ambito di produzione e distribuzione ormai di lunga tradizione nel mondo. Per l’occasione Robert Redford ha dichiarato: «Il cinema indipendente e gli artisti che sono tali riflettono il nostro tempo con creatività irriverente e con intenti sociali e umanistici rispetto agli anni che stiamo vivendo tra lacerazioni, dilemmi e attentati. Il Sundance Festival, più che mai in tempi di globalizzazione e di attacchi alla libertà di espressione, resta un baluardo di ogni diversità». Infatti al Festival di Salt Lake City approdano piccoli film e opere prime, anche di registi italiani com’è il caso quest’anno di Cloro di Lamberto Sanfelice con l’attrice Sara Serraiocco come protagonista.
 Questioni di definizione tra industria e autorialità
Questioni di definizione tra industria e autorialità
Che cosa intendiamo per cinema “indipendente” o “indie”, come si usa nel gergo anglosassone? Esistono concezioni diverse del cinema indipendente? O si tratta soprattutto di storie e tradizioni diverse secondo le aree continentali e le cinematografie nazionali? Nella sua storia del cinema indipendente dagli anni Ottanta del Novecento (“Il cinema americano indipendente”, Einaudi, Torino 2006), Geoff King, riferendosi a quello americano e pur riconoscendone varietà di forma e di sfumature, fissa tre punti principali di orientamento ovvero «la posizione dei singoli film o dei cineasti per quanto riguarda: 1) la loro collocazione all’interno dell’industria, 2) i tipi di strategie formali ed estetiche adottate e 3) il loro rapporto con il più vasto panorama, sociale, culturale, politico o ideologico» (pp. 3-4). Ancora King sottolinea come nel cinema americano indie l’elemento produttivo-industriale sia prioritario, anche alla luce dei grandi mutamenti avvenuti negli ultimi anni, oggetto di continuo aggiornamento bibliografico (www.gkindiefilm.com).
Sull’elemento produttivo-industriale, in riferimento al cinema indipendente internazionale, concordano i nostri Serafino Murri e Bruno Roberti: «Con l’espressione cinema indipendente si definisce un insieme di modalità realizzative, produttive e distributive, e un ambito creativo il cui sviluppo avviene al di fuori, e spesso in alternativa, alla logica del mercato cinematografico ufficiale e dell’industria oligopolistica delle grandi compagnie di produzione. Lo sviluppo del cinema indipendente si è andato articolando e diversificando in modo parallelo in quei Paesi le cui strutture cinematografiche si sono organizzate su scala industriale, per es. negli Stati Uniti a partire dagli anni Trenta-Quaranta e in Europa dagli anni Sessanta-Settanta, rappresentando un contraltare anzitutto produttivo rispetto ai procedimenti realizzativi dei film ad alto budget, cui sono state contrapposte l’economicità di mezzi e di pianificazione del basso budget, e la ricerca di soluzioni indipendenti dal mercato consolidato» (www.treccani.it).
Comunque sono gli anni Ottanta, e non solo per il cinema americano, a segnare un altro inizio, perché proprio nel periodo si moltiplica un nuovo pubblico, di condizione urbana e d’istruzione superiore, ovvero gli adulti della generazione “baby boom” dei Sessanta, «caratterizzato in genere da una migliore “perspicacia” rispetto a chi era attirato dai prodotti del filone commerciale dominante di Hollywood». Accanto a tale fenomeno avviene lo spostamento del mercato verso il sell-through (le vendite dei film fatte direttamente al consumatore) che cresce più rapidamente dei noleggi, grazie all’home-video, come accadrà anche in Europa.
Tuttavia è lo stesso storico del cinema americano a individuare nella forte volontà estetica dell’autore la spinta non solo a produrre direttamente il singolo film ma anche a far durare nel tempo questa tipologia di cinema. Oggi, infatti, questo tipo di cinema è ancora molto diffuso nel mondo, peraltro incrementato dall’innovazione e dal basso costo delle tecnologie digitali oltreché dalla compatibilità dei formati digitali con il canale di distribuzione più economico e accessibile: internet.
Continua King: «I piccoli film indipendenti, fuori dagli schemi, non convenzionali e talvolta radicali, esistono ancora e vengono distribuiti, nonostante tutte le pressioni causate dalle pellicole prodotte all’estremità costosa della filiera che dominano gli schermi. La scena delle produzioni a basso costo è di una natura tale che probabilmente non scomparirà mai, anche se può attraversare periodi di alterna fortuna. I cineasti continueranno ad avere progetti di film che non potranno essere immessi nel filone commerciale dominante e si ostineranno tuttavia a realizzarli, anche se non sempre raggiungono un grande pubblico. Una formula mantrica spesso ripetuta a manifestazioni come l’IFP Market annuale è la misura dell’“esigenza” compulsiva che spinge un regista a realizzare un prodotto a basso costo, indipendentemente dagli ostacoli che deve affrontare. Specialmente nella zona estrema della produzione, la cinematografia indipendente può essere un’attività intensamente personale, meno soggetta a capricci commerciali del mercato».
C’è da ricordare però, volendo segnalare solo la peculiarità economica del cinema indipendente, che la modalità del low budget, prima negli Stati Uniti dagli anni Quaranta-Cinquanta e successivamente altrove, come nel cinema orientale, in particolare giapponese, è diventata la caratteristica di una produzione anche commerciale (b-movie), basata su generi molto popolari e rivolta a un pubblico di massa. Si pensi al caso di Roger Corman e della sua factory che hanno rilanciato il cinema americano di genere e favorito il ricambio generazionale degli stessi studios con la New Hollywood.
Quindi lo storico King individua nella creazione di un’infrastruttura o di reti di supporto (festival, marketing, listini, circuiti distributivi e di noleggio, agenzie, riviste specializzate e online, in una pratica diffusa oggi in molti Paesi) un elemento importante della base istituzionale e di prestigio del cinema indipendente americano, che si può far risalire agli ultimi anni Cinquanta e ai primi Sessanta, in una direzione che si può estendere al cinema europeo contemporaneo. Per le origini si pensi agli statunitensi San Francisco International Festival nel 1957 e New York Film Festival nel 1962 dove, come nei cinema d’essai, i film maggiormente proiettati erano stranieri più che americani indipendenti. «Altri sviluppi seguirono negli anni Settanta, tra cui l’istituzione del Telluride Festival in Colorado nel 1973, a Toronto e Seattle nel 1975 e a Montreal nel 1977» (p. 27), fino al Sundance Film Festival nel 1990 ovvero il Festival Salt Lake City (Utah) del 1978, dove si proiettavano “piccoli film regionali”, rilevato nel 1984 dal Sundance Institute di Redford che sosteneva cineasti indipendenti, e alle pubblicazioni come “Filmmaker” e alle riviste online come ‘indieWIRE’. Sono prototipi di ciò che ormai è accessibile in Rete anche in Euroa e Italia tra siti informativi, agenzie di distribuzione, di streaming e i Festival specializzati come quello di Ginevra, “Black Movie”.
Oggi tutto ciò comporta, soprattutto per il cinema americano, non solo il coinvolgimento degli studios e dell’industria nel settore delle etichette indipendenti, in generale visto come un buon investimento finanziario, ma l’attribuzione al film stesso di una sorta di “marchio di qualità” che trapassa dal mercato di nicchia all’export internazionale, premiato anche dagli Oscar oltreché dagli equivalenti Independent Spirit Awards, conferiti dall’agenzia IFP di Los Angeles. In tal senso King, che pubblica il libro succitato nel 2005, anticipa lucidamente lo sviluppo attuale del settore (titolato poi in un altro suo libro più recente: “Indie 2.0: Change and Continuity in Contemporary American Indie Film”, I. B. Tauris, London 2013), quando profetizza sia che «la distribuzione autonoma di film su internet è destinata probabilmente ad aumentare, seguendo il modello che si è imposto nella musica, in cui le garage bands hanno distribuito le loro esecuzioni direttamente in rete usando il firmato MP3» (p. 75), sia che «i nuovi modi di distribuire film in DV a basso costo in luoghi vanno dalle piccole sale specializzate ai caffè pubblici» (p. 76), ai musei e i centri d’arte dello spettacolo ovvero in luoghi diversi, dotati di sistemi di proiezione digitale e satellitare.
Nel secondo decennio del XXI secolo, aggiunge King nel suo nuovo libro, nonostante l’apparizione di film con ambizioni superiori a quelle del mainstream commerciale, il cinema americano indie, cosiddetto 2.0, esplora nuove opportunità con l’uso del video digitale a low budget e la ricerca su internet e i social network di mezzi alternativi di finanziamento, distribuzione, promozione e vendita. Lo studioso analizza alcuni casi interessanti di ultra-low budget e di nuovi generi: dal mumblecore delle commedie di Judd Apatow (in uscita nel 2015 per la Universal con Trainwreck) al realismo sociale di Kelly Reichardt e Ramin Bahrani, dall’estetica del “desktop digitale” di Susan Buice e Arin Crumley (Four Eyed Monsters) e di Jonathan Caouette (Tarnation), fino alla distinzione della nozione di “vero” indie con i successi cross-over come Little Miss Sunshine e Juno.
 Nel 2005 lo stesso King sembra però sottovalutare l’elemento della ricerca formale o dell’innovazione narrativa degli indipendenti, pur sottolineando che i film tendono in generale a negare, bloccare, ritardare o complicare, lo sviluppo narrativo classico hollywoodiano. In alcuni casi tali film aumentano l’autoreferenzialità narrativa e spesso (come dimostra la recente storia di successo di Boyhood di Richard Linklater) riscoprono una forma diversa o alternativa di “motivazione” del materiale rappresentato, più “autentica” o “realista”, lungo una linea ideale che dalla critica formalista russa degli anni Venti giunge fino a oggi attraverso le sperimentazioni di Andy Warhol e Stan Brakhage o i film di Harmony Korine (Gummo) o Kevin Smith (Clerks), fino a Jim Jarmush, Paul Thomas Anderson e David Lynch.
Nel 2005 lo stesso King sembra però sottovalutare l’elemento della ricerca formale o dell’innovazione narrativa degli indipendenti, pur sottolineando che i film tendono in generale a negare, bloccare, ritardare o complicare, lo sviluppo narrativo classico hollywoodiano. In alcuni casi tali film aumentano l’autoreferenzialità narrativa e spesso (come dimostra la recente storia di successo di Boyhood di Richard Linklater) riscoprono una forma diversa o alternativa di “motivazione” del materiale rappresentato, più “autentica” o “realista”, lungo una linea ideale che dalla critica formalista russa degli anni Venti giunge fino a oggi attraverso le sperimentazioni di Andy Warhol e Stan Brakhage o i film di Harmony Korine (Gummo) o Kevin Smith (Clerks), fino a Jim Jarmush, Paul Thomas Anderson e David Lynch.
Nota ancora King: «Il materiale “acquista significato” in quanto rivendica una prossimità con il modo in cui la vita si svolge nel mondo esterno invece del modo in cui si accorda con le convenzioni dominanti nella narrativa di finzione. Le due posizioni sono spesso viste come diametralmente opposte: la misura in cui il materiale è motivato dalla verosimiglianza spesso coincide esattamente al grado di deviazione dalle forme narrative canoniche, e viceversa» (p. 91).
Tuttavia è proprio attraverso l’innovazione formale che il cinema indipendente negli Stati Uniti, e non solo, s’identifica spesso con il cinema d’autore e può stabilire legami con gli estremi costituiti dal cinema di sperimentazione o d’arte e d’avanguardia. Citando lo studioso americano David E. James, specialista di cinema indipendente, ancora King spiega: «La specificità del film autoriale come modalità di produzione sta nel tentativo di collegare le operazioni industriali degli studios con le pratiche artigianali delle avanguardie estetiche e politiche per conciliare le funzioni commerciali e quelle di espressione personale».
A tal proposito gli studi dello stesso David E. James, autore, fra l’altro, di una mappa “geocinematica” e sociologica di Los Angeles con le sue innumerevoli piccole sale indipendenti come gli amateur filmmaking clubs (cfr. “The Most Typical Avant-Garde. History and Geography of Minor Cinemas in Los Angeles”, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 2005), hanno portato alla scoperta di una vasta rete di sale nonindustrial nella regione californiana, esistente già dal primo decennio del secolo scorso. James ne riconosce anche la funzione sociale: i primi film d’avanguardia americana, infatti, furono realizzati da un gruppo che seguiva i principi dell’estetica socialista in opposizione al monopolio industriale (From Dusk to Dawn di Frank E. Wolfe, 1914) oppure dalla comunità GLBT di Hollywood (Salomé di Charles Bryant, 1923), fortemente interessata alle narrazioni sperimentali. Quindi James sottolinea l’influenza reciproca e complessa (multidirezionale e multilivello) tra l’industria hollywoodiana e i “molteplici produttori alternativi periferici”, intesi come forma di resistenza alla cultura del capitalismo, e non solo negli Stati Uniti.
È la stessa influenza, di tipo anche sociale, spesso di genesi politica, che stata fissata da Walter Benjamin nelle riflessioni sugli scambi tra avanguardia e cultura di massa, e che porta fino alla piena assimilazione commerciale di prototipi e innovazioni da parte della cultura mainstream. Poi ancora James introduce una riflessione che meriterebbe di essere approfondita, pensando soprattutto ad anni più recenti. Ribaltando un vecchio assioma che riconosce al cinema sperimentale americano di aver poco in comune con l’industria mainstream (Lewis Jacob, 1948), James afferma che di fatto innovazioni, ispirazioni e cross-pollination nelle procedure formali, nei codici di rappresentazione e nelle strategie produttive, hanno circolato con reciprocità nell’intero settore del cinema» (p. 14). Ma tutto questo può valere anche nel contesto europeo? E in Italia?
Arte, avanguardia e sperimentazione
Per il contesto europeo restano comunque centrali le esperienze delle avanguardie storiche, della sperimentazione e del cosiddetto amateur. La lezione delle avanguardie, comprendendo la nascita dei cineclub e i film d’arte prodotti da mecenati per gli esponenti di movimenti artistici come il Surrealismo o vicini all’esperienza didattico-estetica del Bauhaus in Germania, abbraccia infatti la vasta area della sperimentazione perché la sua tassonomia intende fondamentalmente il film come libero ancora e solo dai vincoli della filiera commerciale.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuttora nel cinema indipendente europeo, pur risalendo alle avanguardie storiche degli anni Venti come alla caméra-stylo di Alexandre Astruc (1947), fino all’underground americano vecchio e nuovo, si ritrova il sistema concettuale strutturato dal fondatore della critica cinematografica francese, Émile Vuillermoz, intorno al 1918, che mette in opposizione l’arte con la produzione standard:
- mancanza di sceneggiatura, dialoghi, interpreti e messa in scena;
- totale autonomia produttiva dell’autore (secondo la definizione di Stan Brakage il film sperimentale è quasi sempre opera di una sola persona);
- particolare attenzione all’immagine in sé (a partire dal singolo fotogramma (immagine vissuta in tutta la sua immensa portata percettiva ed emozionale, capace sia di rappresentare il reale con immediatezza e autenticità, sia di manipolarlo, attraverso tecniche di vario tipo, in fase di ripresa e/o durante il processo di sviluppo e stampa;
- uso di supporti non necessariamente professionali (8mm, super8, 16mm) e in alcuni casi perfino assenza di dispositivi tecnologici;
- uso del montaggio particolarmente creativo e non lineare, ovvero discontinuo, oppure rifiuto del montaggio, che viene fatto direttamente ”in macchina”;
- stretta relazione con altre discipline quali pittura, musica, danza, fotografia ecc.;
- estraneità rispetto ai normali canali produttivi e distributivi, quindi non sottomissione alle regole della censura né a quelle del mercato.
Occorre dire poi che molte caratteristiche del film sperimentale, come si può notare dallo schema, coincidono con quelle del film indipendente. E viceversa. Inoltre emerge la forte propensione alla “ricerca” o all’”espansione” del cinema stesso, come teorizzato dal libro di Gene Youngblood nel 1970, oltre le regole o i confini fissati dal mercato e dall’industria. D’altronde sappiamo con Burch che il sistema industriale hollywoodiano si è espresso con un codice di convenzioni e stereotipi formali, il Sistema di Rappresentazione Istituzionale (MRI), che vige come dominante nel cinema occidentale almeno fino alle soglie della modernità (neorealismo). Il cinema indipendente di ieri come di oggi, esattamente come quello d’avanguardia (fino all’ultima ovvero Dogma 95 di Lars von Trier e Thomas Vinterberg, non a caso anche polo produttivo indipendente scandinavo) e di sperimentazione, più o meno radicale, è quindi sostanzialmente polimorfico e policentrico, costituendosi, come notato prima con Benjamin, in un enorme serbatoio a cui da sempre attinge il cinema industriale con prestiti e omaggi più o meno riconosciuti.
Dunque è solo ripartendo dalla lezione delle avanguardie europee come dalla rivoluzione estetico-produttiva del neorealismo che si può rileggere anche la storia degli scambi con il cinema americano indipendente, dando cioè il giusto valore all’esperienza di Maya Deren come al rinnovamento narrativo fuori dagli studios e dai teatri di posa (sull’esempio neorealista, appunto), avvenuto negli anni Cinquanta sulla costa occidentale americana, soprattutto a New York. È una storia che arriva fino all’esperienza anti-hollywoodiana del New American Cinema e alla “scuola di New York” dove la ricerca di un nuovo realismo combina l’osservazione documentaria con segni di finzione, con l’attenzione a temi civili e politici d’attualità negli Stati Uniti. E ritorno.
Infatti, se negli ultimi decenni il decentramento produttivo ha favorito stili più personali e autonomi negli Stati Uniti come quelli di David Lynch, Quentin Tarantino o Wes Anderson, coinvolti peraltro in coproduzioni europee, rilevante è il fenomeno generazionale europeo delle Nouvelles Vagues, dove la stessa filiera produttiva ha una genesi culturale e sempre più internazionale o transcontinentale. «In generale l’Europa cinematografica degli ultimi decenni ha prodotto opere di qualità il cui valore artistico si rivela connesso a un’idea produttiva alternativa rispetto alle confezioni industriali e ai moduli del cinema commerciale. In questo senso cineasti ‘apolidi’ quali Raúl Ruiz, Amos Gitai, Atom Egoyan e produttori indipendenti come il portoghese Paulo Branco o la francese Martine Marignac hanno lavorato indifferentemente in vari Paesi, mostrando una ferma predilezione per l’indipendenza produttivo-distributiva, nell’ambito della quale hanno saputo inventare soluzioni e sinergie diversificate» (Murri, Roberti). Per quel che riguarda lo stigma culturale del cinema indipendente europeo valga per tutti l’esempio di François Truffaut con il suo milieu di formazione ovvero il “periodo critico”, celebrato recentemente per il trentesimo anniversario della morte da una grande mostra documentaria alla Cinémathéque française di Parigi.
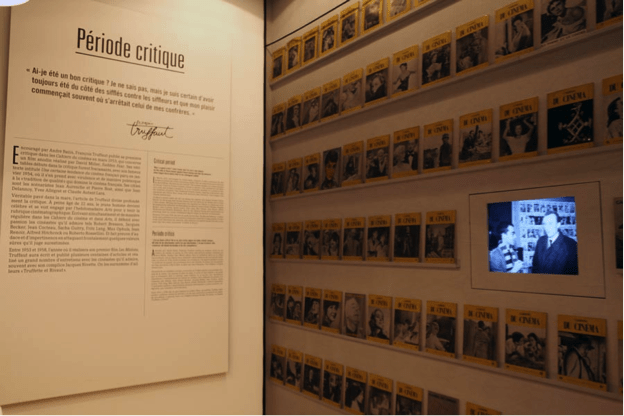 A tal proposito accenno all’importante teoria della studiosa Malte Haneger (cfr. “Moving Forward, Looking Back. The European Avant-garde and the Invention of Film Culture, 1919-1939”, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007), che potrebbe diventare la base di una rilettura della storia del cinema d’avanguardia (quindi indipendente), intesa come l’origine della concezione culturale del film e del cinema in Europa. Nel libro Hagener sostiene infatti, con dati documentali, che proprio il nesso tra il cinema transnazionale delle avanguardie tra le due guerre e le trasformazioni tecnologiche, con la produzione di teorie, festival, scuole e scrittura critica, ha “inventato la film culture” ovvero la concezione del film come opera artistica, politica e sociale, da cui noi tutti (spettatori compresi) in qualche misura discendiamo.
A tal proposito accenno all’importante teoria della studiosa Malte Haneger (cfr. “Moving Forward, Looking Back. The European Avant-garde and the Invention of Film Culture, 1919-1939”, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007), che potrebbe diventare la base di una rilettura della storia del cinema d’avanguardia (quindi indipendente), intesa come l’origine della concezione culturale del film e del cinema in Europa. Nel libro Hagener sostiene infatti, con dati documentali, che proprio il nesso tra il cinema transnazionale delle avanguardie tra le due guerre e le trasformazioni tecnologiche, con la produzione di teorie, festival, scuole e scrittura critica, ha “inventato la film culture” ovvero la concezione del film come opera artistica, politica e sociale, da cui noi tutti (spettatori compresi) in qualche misura discendiamo.
Il cinema sperimentale italiano
In Italia si è realizzata la sintesi di quasi tutti i fattori succitati, comprendendo la filiera nella sua completezza, tuttora perseguita con mezzi e modalità diverse: dai festival alle riviste, fino alle sale o cineclub come lo storico Filmstudio di Roma ancora attivo, dal nuovo ruolo finanziario-logistico delle Film Commission regionali alle distribuzioni o nuove piattaforme social dedite solo al cinema indipendente (come Cineclub Internazionale, Distribuzione Indipendente, IndiCinema, Microcinema o cineama.it). Ancora Murri e Roberti per la Treccani Cinema ci ricordano: «Il cinema indipendente italiano è stato caratterizzato da una connotazione sperimentale, artistica o di militanza poetico-politica che ha estremizzato le logiche del cinema d’autore e ha reagito contro la normalizzazione narrativa, spesso supinamente ripetitiva, del periodo più florido dell’industria cinematografica italiana, quello degli anni Cinquanta-Sessanta. Fu a metà degli anni Sessanta che autori ‘fuori dall’ufficialità’ come Tonino De Bernardi, Alberto Grifi, Adamo e Antonio Vergine, Romano Scavolini, Piero Bargellini, Mario Schifano, Luca Patella si riconobbero in un’idea di cinema indipendente formando gruppi di lavoro o cooperative e sperimentando formati e stili (il film d’artista, il super 8, i primi videotape) oltre che modelli produttivi ‘contro’ e fuori dal mercato. Negli anni Settanta cineasti radicalmente innovatori sul piano linguistico e d’intransigente militanza estetico-politica come Carmelo Bene o la coppia costituita da Jean-Marie Straub e Danièle Huillet furono punti di riferimento per il c. i. italiano, così come, successivamente, una personalità quale quella di Nanni Moretti (il cui lungometraggio d’esordio, Io sono un autarchico, 1978, fin dal titolo vuole sottolineare una cifra produttiva e stilistica non omologata al prodotto medio dell’industria cinematografica italiana) ha emblematicamente rappresentato, anche per il suo impegno di produttore-distributore-esercente, l’esempio più significativo, a livello europeo, di un’operatività indipendente non disgiunta da un’idea di cinema d’impronta fortemente autoriale». Non a caso, quindi, si tratta di autori che continuano ad essere attivi anche nel mercato oppure sono celebrati ancora da mostre ed eventi come modelli artistici a tutto campo, che nati in un contesto culturale-territoriale locale hanno poi sviluppato un’influenza interartistica e intermediale a lungo termine di livello internazionale. È il caso recente di Gianfranco Baruchello in mostra alla Triennale di Milano nel 2015.
Chiudo queste note proprio mentre giunge un corrispondenza dagli Stati Uniti di Alessio Lana per ‘Nòva 24’ de ‘Il Sole 24 Ore’ intitolata “Oculus al Sundance Festival e Amazon al cinema?”. La novità dell’anno cinematografico è costituita dalla distribuzione in Rete di contenuti multimediali a basso costo (anche film e serie tv) con tre “superpotenze” come Netflix, Amazon e Facebook: «Da meri veicoli esse diventano fabbricanti di contenuti. Il mercato a cui puntano è il cinema e lo scopo dichiarato è battere le major offrendo prodotti freschi, ben fatti, che non si trovano in televisione ma soprattutto fare cassa con tutti quegli utenti che girano sulle loro piattaforme. E a quanto pare funziona». È come dire che stavolta è la stessa industria del multimediale ad essere “indipendente” o a voler produrre secondo una logica da “indipendente” (basso costo, autorialità del prodotto, personalizzazione del consumo).
E ancora. «Amazon produrrà 12 film l’anno, indipendenti, solo di medio budget (tra i 5 e i 25 milioni di dollari) e con una nuova formula di distribuzione: anteprima nelle sale e uscita in streaming da quattro a otto settimane dopo contro le solite 40-52. I primi frutti della strategia dovrebbero vedersi nel corso del 2015 per entrare poi a pieno regime nel 2016». E ancora. Il cinema indipendente è sempre stato attento sperimentatore delle nuove tecnologie, ieri analogiche, oggi digitali. Il futuro presente non può essere altrimenti. «Passando dalle piattaforme ai dispositivi ecco Facebook e la sua Oculus VR, l’artefice dei visori Oculus Rift. A quanto pare Zuckerberg si è reso conto che senza contenuti i suoi occhialoni sono solo un simpatico ma inutile accessorio e così, sempre al Sundance, ha presentato Lost, la prima fatica del neonato Oculus Story Studio. Realizzato da un ex Pixar e diversi game designer, il corto offre un’esperienza interattiva in cui lo spettatore è al centro di una foresta e gli elementi si muovono solo quando li guarda. Cambia così il modo di intendere il film, come lo si scrive e lo si realizza, andando sempre più vicino al videogioco. Visuale a 360° e interazione daranno del filo da torcere a sceneggiatori e designer ma gli offrono anche nuove opportunità espressive. Non si sa se sarà un successo ma intanto ci si prova visto che ci sono 1,4 miliardi di utenti a cui fare pubblicità gratuita. Dal punto di vista artistico invece la prima rottura di rilievo al predominio delle telecamere è Tangerine, pellicola girata interamente con l’iPhone, per la precisione tre 5S. Grazie a una steadycam per evitare tremolii, lenti anamorfiche da 20 dollari e ai controlli manuali dell’app Filmic Pro, lo sceneggiatore e regista Sean Baker riesce a raccontarci di una prostituta transgender (vedi la serie tv di Amazon, Transparent) ricevendo anche il plauso per la fotografia. Non sappiamo come verrà distribuito ma i colossi hanno già gli occhi puntati. Il cinema sta cambiando, meglio salire sul carro dell’innovazione finché si è in tempo». Si sottolinea ormai come il nuovo secolo sia segnato dal trend dello small business e dal boom della produzione indipendente in tutti i settori economici e, in particolare, in quello culturale dalle librerie al cinema (cfr. Anna Guaita, “Saperi e sapori piccolo è bello”, ‘Il Messaggero’, 5 febbraio 2015). Dunque, se il futuro sarà ancora cinema, questo non potrà che essere ancora e sempre ‘indipendente’.
.
 DIMENTICARE TRETTI
DIMENTICARE TRETTI
di Ugo Brusaporco
Mi sono voltato, a cercarlo, per l’ultima inquadratura del video che stavamo girando su lui io dovevo lasciarlo davanti la porta e camminare allontanandomi sul grande piazzale della sua villa di campagna, a Colà, sulle tranquille colline moreniche dl basso Lago di Garda. Mi sono voltato e non l’ho più visto. Pochi giorni dopo con alcuni amici siamo stati sulla sua tomba, in un piccolo cimitero, tra le sue colline, avevamo dell’amarone di Meroni, e volevamo brindare sulla sua tomba, come si usa nell’est, ma c’erano tre tombe fresche e senza nome, sembrava di essere in un suo film, così abbiamo brindato su ognuna delle tre tombe, in onore tuo Augusto, in onore della nostra amicizia e dei film che ci hai regalato, pochi a dire il vero, ma di più non te ne hanno fatti fare. Tu, Augusto Tretti, il matto di cui ha bisogno il cinema italiano, ma quando mai il cinema italiano ha avuto bisogno dei matti se anche Pasolini si è dovuto inchinare alle necessità dell’industria cinematografica. Il cinema non è la musica, te lo spiegava bene, tuo cognato il grande Giacomo Manzoni, musicista superbo, che poteva permettersi, lui che aveva studiato a Darmstadt, di fare la musica che gli piaceva. Anche tu hai provato a fare il cinema che ti piaceva, e tua madre vendeva i quadri di famiglia per fartelo fare, ma che fatica, che delusioni, quanti sogni sprecati. Mentre camminavo sentivo che mi guardavi, Augusto, avevamo tanto parlato di te e del cinema, e avevamo lasciato fuori la vita, la vecchiaia che improvvisa ti ammalava e la morte che unica forse ha ben recitato la sua parte, e tu che non credevi e avevi cantato la becera illusione della fede umana, forse ha fatto in tempo a applaudirla. Più di vent’anni fa nel 1991 sulla presentazione del catalogo dell’unica edizione del Garda Film Festival scrivevo: “Ci sono registi famosi, acclamati, adulati e ci sono rari uomini che al cinema si sono rivolti per raccontare, attraverso il gioco delle immagini, la poesia che vive in loro. Augusto Tretti è un poeta. Ama il cinema come linguaggio libero. Non è mai riuscito ad entrare nel mondo del commercio cinematografico per paura di perdere la possibilità di essere se stesso. Ha pagato con i silenzio, con lo schermo vuoto, con i sogni che si accumulano, con il tempo che passa”. Poi continuavo con delle parole che non sapevo sarebbero diventate profetiche per entrambi: “Iniziando il suo cammino, il Garda Film Festival aveva l’obbligo di ricordarlo, perché Augusto Tretti ha la stessa anima di questa manifestazione: vuole il cinema come canto di libera poesia”. Tretti sognava ancora di girare un film sulla battaglia di Lissa, sapeva che il destino della nostra Italia era leggibile in quel conflitto navale, che era inutile ogni volta far finta di girare pagina, con i problemi del Risorgimento, con quelli della mafia, con quelli del colonialismo, delle banche, del fascismo, della democrazia cristiana del terrorismo, dei giornali ruffiani e della televisione puttana. Tretti sapeva che il problema era il Potere, le Leggi della Tromba, le droghe e l’alcool, i mediatori di carrozze. Sapeva che il suo compito era risvegliare le menti atrofizzate di un popolo senza bandiera e privo di ideali. Un popolo dove si deridono cultura e intellettuali, dove si disprezzano comunismo e comunisti. Un popolo che confonde il proprio destino con quello dei padroni restandone travolto. Tretti sapeva che non avrebbe girato il film su Lissa e noi sapemmo che non avremmo dato seguito alla prima edizione del Garda Film Festival. Moriva con le speranze di Tretti. Scrivevamo: “Pochi i titoli della sua filmografia: tre lunghi ed un corto, ma tutti importanti anche se il regista non li ama tutti con pari intensità. Sorprende la sua lucidità di giudizio, mai esaltazione, mai falsa modestia, solo la coscienza di un autodidatta che cerca ancora di fare cinema”. Sapevamo di morire con lui. Nello stesso catalogo l’amico Sauro Borelli domandava: ” Dimmi Augusto, come t’é venuto in mente di fare cinema? E quando?” e annotava: “Sorride tutto, strizzando gli occhi, sbirciando di lato, come colto da subitaneo pudore. Poi racconta noncurante” e questa era la risposta: “Niente. É stato tutto per caso. Quasi uno scherzo. Secondo la tradizione di famiglia, anch’io ho studiato da avvocato. Senza alcuna inclinazione, né voglia. Gli esami, l’ambiente universitario mi esasperavano. Ero quasi sempre sull’orlo della nevrosi. Mi capitò allora tra le mani una cinepresa, poco più di un giocattolo. Così per gioco, cominciai a filmare brevi scorci, dettagli e scampoli di ciò che mi stava intorno. Ma vittima e complice privilegiata fu subito la cuoca (e tata) che girava per casa. Truccata grottescamente o, più meno, al naturale divenne l’incontrastata protagonista di sbilenchi parodistici, farsesche trasfigurazioni del reale che io andavo realizzando, l’uno dopo l’altro, senza alcun progetto definito, né tantomeno unitario”. Tretti fu contento di quella retrospettiva, fu la prima, poi ne vennero altre, tutte difficili, perché è difficile trovare i film di Tretti, anche se sono pochi: La legge della tromba (1960), Il potere (1971), Alcool (1980) e il medio metraggio Mediatori di carrozze (1985). Era stato aiuto regista di Federico Fellini per Il bidone, ma, battuta facile, fu il cinema italiano a bidonarlo. non sapeva cosa farne di uno che girava film per non venderli.
TRETTI I FILM
Antefatto
In un’intervista concessa a Enrico Soci e pubblicata nel “Quaderno n° 5” di Ipotesi Cinema nel 1962, Augusto Tretti ricorda i cortometraggi da lui girati prima che alcuni di loro confluissero ne La legge della tromba e spiega: “Mi sono fidato del consiglio, non ricordo più di chi, di conservare le pellicole “dove si conserva il vino”, in cantina. E così, in breve, la muffa e l’umidità li hanno distrutti. Non ne resta più nulla. Erano tutti a sfondo comico-grottesco, li giravo qui intorno (alla sua casa a Colà vicino al Lago di Garda, ndr), con la vecchia cuoca come interprete ed alcuni amici. Ricordo che un po’ tutti li trovavano divertenti, pazzi, tanto da incoraggiarmi a realizzare un vero e proprio film”. Nell’ultimo incontro che ebbi con lui, pochi mesi prima della sua morte, stavamo girando un corto su lui con Matteo Ierimonte, egli si ricordò di quei film e non era proprio sicuro che fossero scomparsi, anzi ci invitò a tornare per recuperarli e vedere come erano. Poi non siamo più riusciti a incontrarlo per cui resta il mistero di quei corti, di sicuro visti da Federico Fellini e Fernanda Pivano.
La legge della tromba
regia, soggetto, sceneggiatura: Augusto Tretti
fotografia (b/n): Carlo Pozzo, Franco Bernetti
montaggio: Mario Serandrei
musica: Angelo Paccagnini, Eugenia Tretti Manzoni
scenografia: Josef Bassan
effetti sonori: Marino Zuccheri
interpreti: Maria Boto (gendarme, generale, industriale, scienziato, leone M.G.M.), Angelo Paccagnini (Celestino), Diego Peres (Faccia d’Angelo), Carlo Muzzi (il Conte), Guido Bassi (Dum Dum), Giovanni Gusmeroli (Ufficiale), Vittorio Tato (primo consigliere)
produzione: Augusto Tretti – Botofilm
anno: 1960
35mm
durata: 85’
Nazionalità: Italia
La legge della tromba viene doppiato dagli attori del piccolo Teatro di Milano (Gastone Moschin, Nana Noschese, Ottavio Fanfani, Giulia Lazzarini). Tretti spiega: «perché non volevo le solite voci ‘romane’ della commedia all’italiana».
 “Mia sorella Eugenia, studiava musica col maestro Ghedini. Incidentalmente capitò che lo stesso maestro vedesse quei miei sproloqui cinematografici. Ne fu subito attratto, edificato. Per ragioni del tutto sue, ma comunque gli piacquero. Tanto che ebbe a dichiarare più tardi: Io non mi intendo di film, perché, tra l’altro, sono un cattivo frequentatore di cinematografi, però le orecchie le ho buone e nel film La legge della tromba ho gustato come raramente, e forse mai, la parte, chiamiamola così, musicale … le trovate rumoristiche e sonore per la loro essenzialità ingenua ed elementarietà fanno centro in certe situazioni e diventano elemento intrigante con quello che arriva sullo schermo. Oltretutto Ghedini sollecitò amici, quale l’autorevole, civilissimo critico cinematografico Filippo Sacchi, l’americanista e traduttrice di valore Fernanda Pivano a vedere, valutare debitamente le cose che io andavo facendo al di fuori d’ogni regola o poetica” (da “Tretti” GardaFilmFestival 1991)
“Mia sorella Eugenia, studiava musica col maestro Ghedini. Incidentalmente capitò che lo stesso maestro vedesse quei miei sproloqui cinematografici. Ne fu subito attratto, edificato. Per ragioni del tutto sue, ma comunque gli piacquero. Tanto che ebbe a dichiarare più tardi: Io non mi intendo di film, perché, tra l’altro, sono un cattivo frequentatore di cinematografi, però le orecchie le ho buone e nel film La legge della tromba ho gustato come raramente, e forse mai, la parte, chiamiamola così, musicale … le trovate rumoristiche e sonore per la loro essenzialità ingenua ed elementarietà fanno centro in certe situazioni e diventano elemento intrigante con quello che arriva sullo schermo. Oltretutto Ghedini sollecitò amici, quale l’autorevole, civilissimo critico cinematografico Filippo Sacchi, l’americanista e traduttrice di valore Fernanda Pivano a vedere, valutare debitamente le cose che io andavo facendo al di fuori d’ogni regola o poetica” (da “Tretti” GardaFilmFestival 1991)
Celestino e quattro amici (Faccia d’angelo, il Conte, Dum Dum e Bimbo) tentano di rapinare il furgone portavalori di una banca, finiscono in prigione. In seguito ad un’evasione e usufruendo di un’amnistia riacquistano la libertà. Dopo essere finiti in un campo dove si svolgono manovre militari, Celestino si reca dal prof. Liborio ottenendo insieme agli amici, l’assunzione presso una fabbrica di trombe. Celestino conosce Marta e se ne innamora, ma Liborio circuisce la donna e la sposa perché ha saputo che il padre della ragazza possiede una miniera in Sudamerica. Liborio chiude la fabbrica di trombe e si trasferisce all’estero per sfruttare la miniera del suocero. Celestino amareggiato, trova lavoro in una fabbrica di razzi. In qualità di collaudatore sale su un razzo, ma dopo un’esplosione va a cadere a cavalcioni su un albero.
«La legge della tromba è il film più strabiliante che abbia mai visto, il più fuori dal comune. Io credo che dietro questo film ci sia una personalità» (Florestano Vancini); «… siamo di fronte ad un’opera assolutamente nuova di un regista che domani sicuramente diventerà un autentico autore. Vengono in mente le fantasie di Charlot, i films di Tati, intere sequenze sono rette da un miracoloso equilibrio di ironia e di lirismo» (Valerio Zurlini); «Qualcuno obietta che il film ricorda Chaplin e Tati. Può darsi. Ma Tretti non disponeva né di Chaplin né di Tati, disponeva soltanto di una cuoca settantenne, e tuttavia è riuscito a fare un film di alto livello comico. Vi sembra poco, in un paese dove il comico ha quasi sempre il tono della farsa dialettale? In questo giovane e nel suo film c’è estro da vendere» (Michelangelo Antonioni); «È un atto di meditata ripulsa dei modi del cinema corrente fondato sul divismo, la bassa lettura e i falsi problemi. É una piccola lezione di cui ammiro il candore e l’astuzia» (Ennio Flaiano).
«Signore e Signori io sono Maria Boto, di professione cuoca. In tutta la mia vita non ho mai visto un film, non me ne intendo; nonostante questo mi hanno pregato di lavorare nel cinema, ho accettato e sono andata in un teatro di posa: ho visto i riflettori, la macchina da presa, con la paralasse, gli attori, l’operatore, gli elettricisti, gli archi. Cose interessantissime, però… Troppa confusione! e poi sempre pasticci. Ve ne dico una: mentre stavamo lavorando, fermano il film! i produttori non volevano più dare un soldo perché dicevano che io non ero commerciale. (ride) Ho sgobbato, ma sono contenta di aver fatto anche questa esperienza. Ed ora cari Signore e Signori, vi saluto, perché devo preparare il pranzo», così si apre La legge della tromba un film che vive ancora oggi clandestino, seppur celebrato dai Festival internazionali, condividendo il destino con tutta l’opera di Tretti. Proprio queste parole spiegano l’idea di cinema di un regista unico nel panorama italiano e il film le vive in pieno. Come un monello che imita deridendolo un adulto, diventando inimitabile, Tretti affronta il suo racconto, qualcuno lo ha definito “sghembo”, in realtà sono rari i film italiani con un simile rigore di linguaggio. Il cinema di Tretti è un cinema sonoro, nel senso vero del termine, sono i suoni e la musica che dettano i ritmi del film, l’azione ne é determinata ne é il risultato. Il sonoro più forte della sceneggiatura, ed é questo che spiazzava anche i grandi maestri del cinema, che si ritrovavano a amarlo non riuscendo però ad andar oltre a un “geniale” che ne determina la rarità. Non esisteva e non esiste in Italia un film così internazionale nella sua concezione, il legame forte con l’idea musicale della scuola di Darmstadt, sua ispirazione più che altri film, costringono su binari precisi l’immagine di Tretti e se a questo si aggiunge la scelta costretta di usare attori non professionisti, e quindi faticosi da dirigere, si comprende la complessità del dettato del regista veronese. Una complessità che finalmente sfugge allo spettatore travolto dalla ventata del caustico umorismo che percorre e percuote un film che irride all’idea di essere un capolavoro ben sapendo di essere solo fondamentale per dire del cinema mondiale.
Il potere
titolo internazionale: Power
regia, soggetto, sceneggiatura: Augusto Tretti
fotografia (b/n): Ubaldo Marelli
montaggio: Giancarlo Rainieri
musica: Eugenia Tretti Manzoni
suono: Giuseppe Donato
scultore delle maschere: Mario Gottardi
interpreti: Paola Tosi (donna dell’età della pietra, indiana, visitatrice azienda agricola), Massimo Campostrini (Tiberio Gracco, indiano, deputato socialista), Ferruccio Maliga (Cardinal Concordato, vescovo), Giovanni Moretto (uomo dell’età della pietra, indiano, operaio), Diego Peres (uomo dell’età della pietra, indiano, operaio), Augusto Tretti (Mussolini, il potere militare, il potere commerciale, il potere agrario).
produzione: Federico Pantanella e Mario Fattori per la Aquarius audiovisual
distribuzione: Italnoleggio
anno: 1971
formato: 35mm
durata: 90’
Nazionalità: Italia
 “Se con La legge della tromba avevo voluto fare un film contro l’abitudine dell’attore impostato, con Il potere ho voluto mettere in ridicolo le strutture formali del cinema di consumo: i colori sfolgoranti, la bella fotografia, il lusso e lo sfarzo”. Tretti
“Se con La legge della tromba avevo voluto fare un film contro l’abitudine dell’attore impostato, con Il potere ho voluto mettere in ridicolo le strutture formali del cinema di consumo: i colori sfolgoranti, la bella fotografia, il lusso e lo sfarzo”. Tretti
” Altro che film d’autore: questo eccentrico geniaccio veronese ha fatto da solo proprio tutto, anche il velivolo di D’Annunzio ricavato da una bicicletta, anche la parte di Mussolini sotto il mascherone di gomma, anche il verso della gallina che nel primo episodio fugge impaurita davanti al fondatore del potere clericale che vuol carpirle l’uovo. Augusto Tretti meriterebbe di essere conosciuto non meno di Carmelo Bene anche perché il suo discorso, ottenuto sempre col minimo dei mezzi, è assai più limpido e popolare. In cinque episodi – l’età della pietra, l’epoca romana, il Far West, il fascismo, la società dei consumi – egli vuol dimostrare che il potere è rimasto sempre praticamente nelle stesse mani. (…) Per quanto elementare sia la polemica, essa ha il pregio di venire espressa da un talento cinematografico solitario e irregolare, ma tutt’altro che comune. Il grottesco comico è un genere estremamente arduo e Tretti è tra i pochissimi (lo dimostrava anche il suo primo film del 1961, La legge della tromba) a saperlo affrontare e risolvere. Se si pensa alla sua pluriennale tenacia, alle difficoltà incontrate, agli scarsi mezzi a disposizione, al disinteresse commerciale con cui il film, nonostante la presentazione alla mostra veneziana (o meglio grazie a essa), viene ora lanciato, tutte le riserve critiche, anche legittime, cadono di fronte all’urgenza dell’invito che si rivolge ai lettori di non lasciarselo scappare”. (Ugo Casiraghi – L’Unità, 7 ottobre 1971)
“Negli scaffaloni della cinematografia italiana, Augusto Tretti, coi suoi due film, La legge della tromba e Il potere (due film in dieci anni, e il primo mai visto, se non da pochi amici), è difficile da collocare. Bisogna rinunciarvi. Resterà un fenomeno isolato o, peggio, da isolare. Forse avrà, in questo paese di manieristi, degli imitatori, ma sicuramente goffi o soltanto furbi. Il dono di Tretti è una semplicità che non si copia, presuppone la superba innocenza dell’eremita. E’ una semplicità che riporta l’immagine fotografica alle composizioni di Nadar, di Daguerre, e anche al non-realismo, cioè agli spazi e al nitore dell’affresco. Eppure Tretti non è un esteta, né chiede all’immagine se non di sostenere un suo elementare discorso. Lo si può, volendo, liquidare con due definizioni: goliardico, naif. Alcuni lo fanno. Ma sono definizioni sbagliate. I goliardi e i naifs non hanno rigore, si fermano alle prime osterie, si divertono, riempiono le domeniche. Tretti non si diverte, benché sia difficile non divertirsi anche, vedendo i suoi films. Egli ha fatto sua la lezione di Brecht, ma la svolge senza grandi apparati e con estro vernacolo. Il suo discorso è «papale papale», come si diceva una volta a Roma, cioè franco, diretto. La sua comicità è veneta, se si pensa al Ruzzante e ai suoi attori presi dalla strada (ma, intendiamoci, proprio strada, di paese e di campagna), e dalle osterie. E’ fantastica, iperletteraria, se si pensa ad Alfred Jarry. Altri nomi non suggerisce. Bisogna accettarlo e tener presente che niente in lui è ingenuo o copiato, ma viene da una cultura ben digerita, strizzata alla radice, e da un naturale apparentemente benevolo. Non lascia niente al caso. La ricerca della bellezza, dell’effetto, che rovina tanti nuovi autori e li spinge continuamente a cercare salvezza nel kitsch del giorno, (nel criptokitsch), cioè nelle immagini dettate dalla moda, dal vento che tira, dalle esperienze riuscite degli altri, dalla loro presunzione di registi che «vedono bene», è in Tretti una ricerca della cosa essenziale, adrammatica, messa in vitro e osservata alla macchina da presa, che diventa una specie di microscopio. Si potrebbe citare anche Hogarth per certi effetti di pomposità caricaturale, ma è meglio non farlo. I suoi personaggi non sono mai burattini, esistono nel momento in cui si realizzano e ritornano sotto altre vesti al momento opportuno. Per ritrovare certe immagini grottesche del fascismo, la sua complessa stupidità, credo che potrebbe soccorrerci soltanto Mino Maccari. Tretti fa un cinema didascalico da sillabario, vuol dire una sua idea della società, e perché non gli piace. Ci riesce per una sua forza derisoria che si avvale d’impassibilità, di non-compiacimento. I volti esemplari, il modo di muoversi, la solitudine dei suoi attori (folle di otto persone, eserciti di dodici soldati), riportano il cinema a un eden dimenticato; a grandi spazi fatti di paesi, monti e campagne della memoria. Quando vuol colpire lo fa con la rapidità dell’evidenza. Si serve di un discorso volutamente dimesso perché ha le idee chiare. E’ anche difficile collocarlo nello scaffale di sinistra. Egli si ritiene anarchico, di linea veronese, cioè un po’ folle. Le sue bombe scoppiano con un enorme rispetto della vita umana, ma non a vuoto”. (Ennio Flaiano – L’Espresso, 14 novembre 1971)
“Il film è composto di vari episodi che illustrano le origini e le manifestazioni del potere attraverso il tempo, dall’età preistorica su su attraverso la romanità classica e la colonizzazione puritana in America, fino al fascismo e al neocapitalismo. Il tema del potere che non sarebbe che rapacità mascherata con motivazioni ideali, non è certo nuovo. La novità di Tretti sta tutta nel parodistico approccio di specie paesana e casalinga a questo argomento così elevato e così logoro. Un po’ come Jarry quando in “Ubu Roi” (1) rifà il verso alla tragedia scespiriana, Tretti, nella sua scorribanda attraverso i secoli, mette in parodia la concezione determinista della storia per cui il motivo economico si nasconde sempre dietro i cosiddetti ‘ideali’. Ma, a differenza di Jarry, Tretti crede nella propria parodia; anche perché essa è un mezzo, per lui, di esprimere una visione del mondo, un suo sentimento”. (Alberto Moravia – L’Espresso, 25 marzo 1973)
Tre belve, il leone (il potere militare), la tigre (il potere commerciale) e il leopardo (il potere agrario), dialogano tra loro per dimostrare che il potere, pur assumendo fisionomie diverse nei secoli, rimane sempre nelle stesse mani. Nell’età della pietra, il potere si fa forte della paura, e finisce nelle mani di un furbo che si fa credere Dio. Nell’epoca romana, per vincere l’avanzante coscienza degli agrari,il potere assassina il tribuno Tiberio Gracco. Al tempo del Far West, aumenta la propria potenza, ricorrendo a coloni, soldati e galeotti inglesi per il genocidio degli indiani. Nell’Italia uscita dalla Grande Guerra, il potere viene arraffato dal fascismo che ottiene l’appoggio dei borghesi che lo finanziano purché distrugga le libertà democratiche e si allei con il Vaticano. Nell’epoca moderna, il neocapitalismo si impone mediante il consumismo, nonostante le forti resistenze popolari, vinte grazie alle forze dell’ordine e alla copertura del socialismo craxiano. «Ma chi non sa che ai nostri giorni ogni furfante ama pavoneggiarsi in un vestito rosso? (Lenin) » è la didascalia che conclude il film.
«Il film di Tretti ricorda lo spirito di certe commediole goliardiche allestite nel clima di festa della matricola…» così scriveva “La Rivista del Cinematografo”. La critica cattolica e filosocialista fu crudele con Il potere, non tutta, lo stesso Tretti si ricordava delle parole di Gianluigi Rondi che a Venezia protesse e promosse il film, ma in generale i militanti vescovili e i baciapile craxiani avevano tutti i motivi per “sputare” su un film che derideva i loro ideali con uno slancio impudico. Facile definire l’autore del film “naif” ma che direbbero tutti se sapessero che l’intero episodio della pubblicità nel film fu girato da un signore che si chiama Ermanno Olmi. Olmi e Tretti erano amici, il pluripremiato maestro era sul set dell’amico che lo invitò a girare la scena, non perché era naif, ma perché aveva un concetto anarchico e, mi si permetta, comunista del fare cinema, lui che aveva scelto la cuoca come attrice de La legge della tromba, perché non poteva lasciare a un regista come Olmi un po’ di lavoro? Infatti l’ha fatto. Dunque rileggere il film è semplicemente doveroso almeno per capire la forza artistica di Augusto Tretti, vero maestro, non solo di cinema, un maestro veneto, fondamentale questa distinzione, come fondamentale è la villa veneta sul Lago di Garda in cui viveva. Come tutti i grandi pittori, scrittori, artisti veneti egli si è nutrito del territorio e nei suoi film lo ha raccontato, con le facce, i vizi, l’ironia di un Ruzante, con la forza paesaggistica di un Tiepolo che sa rinnegare il colore, e poi l’uso della maschera il richiamo al Gozzi e il rifiuto del Goldoni. Come potevano leggere questo milanesi e romani e altri, Giovanni Grazzini, mio grande maestro, diffidava dei critici cinematografici che non conoscevano e frequentavano le arti. Senza i giusti richiami come leggere un’opera così complessa come quella di Tretti. Certo in questo Il potere parlava di fascismo, di impero romano, di uomini della pietra, dei pellerossa ma tutti erano sul palcoscenico della provincia veneta, dove la recita era ambientata. Il potere é insieme a La legge della tromba la miglior opera d’arte prodotta nel Veneto nel tempo del cinema. Peccato che sia Verona che il Veneto non se ne siano ancora accorti. Per il resto che dire, ogni regione ha i suoi prodotti regionali, parliamo di film e ognuno sa accettarli, la novità di Tretti era quella, cedimento goldoniano, di far parlare i suoi veneti in italiano ed ecco lo spavento di un film che non era più regionale, non era la solita commedia trita che ancor oggi si ripete, era il cinema che sfidava la grande produzione romana in un campo nuovo che spaventava, che portava una insopportabile aria nuova che nessuno voleva respirare, e nessuno vuole respirare oggi. Per questo politica e cinema italiano lo hanno voluto morto.
Alcool
regia, soggetto, sceneggiatura: Augusto Tretti
fotografia (colore e b/n): Ubaldo Marelli
montaggio: Iolanda Adamo
musica: Eugenia Tretti Manzoni
consulenza: Prof. Dario De Martis (Direttore dell’Istituto Psichiatrico di Pavia)
interpreti: Mario Grazioni (Francesco) e attori non professionisti
produzione: Augusto Tretti per l’Amministrazione Provinciale di Milano
anteprima: 20 marzo 1980, Sala congressi di via Corridoni a Milano
anno: 1980
formato: 35mm
durata: 100’
Nazionalità: Italia
 “Dopo aver concluso Il potere io ho trovato porte chiuse ovunque. Ho proposto il film sull’alcoolismo alla RAI, dove non è stato preso in considerazione. Ne ho parlato all’assessore alla Cultura della Provincia, Novella Sansoni, tanto per dirlo a qualcuno: a lei è piaciuto subito, l’ha proposto in Giunta dove è stato approvato all’unanimità. A quel punto, la lavorazione è proceduta senza intoppi, e la Provincia mi ha ripagato di tutte le grane precedenti. È una via produttiva che va seguita, incoraggiata”. (Augusto Tretti in un’intervista a Alberto Crespi – L’Unità, 27 agosto 1980)
“Dopo aver concluso Il potere io ho trovato porte chiuse ovunque. Ho proposto il film sull’alcoolismo alla RAI, dove non è stato preso in considerazione. Ne ho parlato all’assessore alla Cultura della Provincia, Novella Sansoni, tanto per dirlo a qualcuno: a lei è piaciuto subito, l’ha proposto in Giunta dove è stato approvato all’unanimità. A quel punto, la lavorazione è proceduta senza intoppi, e la Provincia mi ha ripagato di tutte le grane precedenti. È una via produttiva che va seguita, incoraggiata”. (Augusto Tretti in un’intervista a Alberto Crespi – L’Unità, 27 agosto 1980)
“Quel che conta è il rivelarsi di Tretti come un tenace e puntiglioso osservatore di una vita quotidiana che invano da anni, anzi da decenni, cerchiamo nei film fatti da quelli di Roma. Dalla giornata di una casalinga ossessionata dalla solitudine elettrodomestica a quella di un padre di famiglia che porta a casa il salario consegnando e installando bombole a gas, a una festa contadina che vede la campagna come un mondo grottesco e lugubre di sfruttati, ignoranti, vinti, a un raduno di reduci che si trasforma in sbronza collettiva; a uno scorcio breve ma impagabile d’un cinema d’essai, Tretti inonda lo schermo di descrizioni, ritrattini, schizzi, allusioni, con una vitalità e comprensione umana perfino inedita in lui, finora dilettante spiritoso più incline al gioco scettico che al ragionare prendendo sul serio la società e i suoi problemi. Certamente, è un uomo non più giovanissimo che ha fatto soltanto tre film, e la sua ispirazione è eclettica per natura, non sempre paziente nel rifinire, a volte indulgente alla battuta, qua e la un po’ lenta e apatica nel costruire. Ma forse è meglio così, nel cinema italiano d’oggi, ridotto a discutere seriamente, sulle terze pagine dei quotidiani, un’ignobile patacca come La terrazza di Ettore Scola, non c’è bisogno di tecnica quanto di vitalità e diversità, di Ratataplan e di Alcool, di Olmi e Bellocchio, insomma, di vento del nord”. (G.D. La Repubblica, 22 marzo 1980)
“Il regista ha intelligentemente strutturato il film sulle situazioni tipiche e sui luoghi comuni, ottenendo lo scopo di demistificarli grazie alla carica corrosiva con la quali li ha messi in scena. Peraltro va detto che i personaggi non sono mai visti con occhio impietoso e accusatorio, anzi. A differenza di quanto fa l’uomo della strada, che tende virtuosamente a scansare e a disprezzare, l’ «ubriacone», il regista descrive i suoi personaggi come vittime di una situazione sociale e storica, come esseri umani che proprio in quanto tali si dimostrano degni di comprensione e di aiuto. Al punto che taluno ha anche avanzato il dubbio se il film, dal punto di vista della propaganda dissuasiva nei confronti della dipsomania, sia un’arma davvero affilata. Ma certo il dubbio, di per sé legittimo, va respinto: il film ha infatti il prestigio di lasciare aperta la discussione, di non essere insomma manicheo: di fungere da stimolo e da ‘sasso nello stagno’, evitando le approssimazioni e la ristrettezza mentale di una presa di posizione esclusivamente accusatoria”. (Tempo Medico n. 181, aprile 1980)
“Il film: è così vero, con tutti i suoi luoghi comuni così ben piazzati, evidenti, parlanti, che si rimane accecati da tanta capacità di comunicazione. Il quotidiano di ognuno di noi appare segnato dalla maschera del grottesco: le facce della casalinga, del fattorino, del prete, dell’attore, della bella ragazza, dell’alpino, dei ragazzi-bene sono davvero, per una volta, senza cerone sulla pelle e senza lo smalto dei personaggi; nessuno di loro è un attore professionista, e si vede. Così, a parte l’intento pedagogico dell’opera, c’è da rimanere ammirati delle sue qualità cinematografiche”. (Anna Del Bo Boffino – Amica, aprile 1980)
Il garzone Francesco trasportatore di bibite, poi trasportatore di bombole a gas, infine muratore perché gli piace bere ed é convinto che il vino faccia beve ma non i liquori. Lo stesso finirà in preda al delirium tremens. Non é solo una casalinga frustrata che beve, i camionisti bevono “l’alcool tiene svegli”, i giovani bevono perché in questa Italia cosa c’é di diverso da fare, gli alpini si ubriacano perché che alpini sono altrimenti e anche l’attore beve, non si stonava con alcool e droghe anche Jim Morrison?
Se per Tretti Alcool è un film “ibrido” in realtà è un vero manifesto del suo cinema, un colpo di genio, inaspettato e inaspettabile. Dopo Il potere aveva cercato per anni, inutilmente, di girare un film sulla battaglia di Lissa, me lo aveva raccontato decine di volte, era il suo sogno, mostrare l’infingarda Italia e i suoi degni figli. Un progetto ambizioso politicamente ma non economicamente, lo avrebbe girato alla sua maniera sul Lago di Garda. Un progetto che con gli anni vedeva appassire, ed ecco l’occasione per, cambiato il panorama, rileggere quella storia, quel paese, l’Italia dove si beve perché nulla di meglio c’é. Ed ecco un film intenso, potente, dove l’ironia lascia il posto alla pietà, perché altro sentimento non può esistere di fronte alla condanna cui un paese obbliga i suoi figli. L’alcool come Lissa, come inevitabile Caporetto di un paese senza identità nemico del suo popolo. E il film é terribile canto, di violenta bellezza, in nome della generosità di un popolo incapace di rivoluzione ma pronto al martirio per non deludere chi lo comanda. Film di rara potenza fratello della Legge e del Potere, ma cosa sarebbe stato il film su Lissa, niente di più di questo che dice del naufragare della vita.
Mediatori e carrozze
regia, soggetto, sceneggiatura: Augusto Tretti
fotografia (colore): Maurizio Zaccaro
montaggio: Maurizio Zaccaro
produzione: Ipotesi Cinema e Istituto Paolo Valmarana per la Rai TV – Rete 1
anno: 1985
16mm
durata: 39’
«Per me è stato un esperimento nuovo. I miei film non sono veristi, sono tutti ‘costruiti’, sono brechtiani: hanno una recitazione burattinesca. Così ho voluto vedere se ero capace anch’io di fare un film con la ‘presa diretta’ del sonoro e con attori presi dalla strada. Infatti è un film diverso rispetto ai miei soliti, non è un film che amo. Ho girato Mediatori e carrozze con una tecnica da telefilm, con un linguaggio più piano e lineare. Anche il montaggio, che è stato seguito dai giovani del gruppo, non rispecchia il mio stile. L’unica parte che sento veramente mia è il finale: lì sì c’è Tretti, infatti ho imposto che non ci fosse la musica, come qualcuno aveva proposto.». Augusto Tretti
Augusto Profili, insegnante, ha messo da parte un buon gruzzolo che vorrebbe investire in una casa, ma il mercato immobiliare gli riserva qualche sorpresa, non solo quella di incontrare dei disonesti venditori, ma di doverla vendere in cambio di qualche carrozza.
Anche se l’autore non lo ama, questa, che é l’ultima delle sue opere, è degna di lui, innanzitutto perché suo è il respiro, l’umanità, la violenza del messaggio, il gioco ironico che qui si fa amaro sarcasmo. Non è il problema della speculazione immobiliare che lo interessa, ancora una volta é l’uomo al centro della sua attenzione e questa volta non é un uomo qualunque, Mediatori e carrozze è il suo autoritratto. Infine chi é quell’uomo che é imbrogliato nell’acquisto della casa, quella casa sognata che è il cinema, e quali sono le carrozze se non quello che si é dovuto accontentare. C’é un po’ di autocommiserazione leopardiana in questo, ma Tretti la risolve da quel gran maestro che è: la processione di carrozze che chiude il film è l’omaggio a Bunuel, al grande cinema, di cui egli stesso fa parte, ora per sempre.
.
L’INDIPENDENTE IRANIANO KAMRAN SHIRDEL
di Paolo Micalizzi
La FICC (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema), dall’11 al 14 dicembre 2014, ha svolto a Cagliari la XXVIII Assemblea Nazionale arricchendola di una serie di iniziative interessanti. Una di queste indubbiamente è stata la Retrospettiva dedicata al regista iraniano Kamran Shirdel che ha consentito di conoscere i primi cortometraggi di quest’autore Si è potuto vedere, in anteprima nazionale, l’edizione restaurata del film The night it rained (La notte che piovve,1967,38’) che parte da un fatto di cronaca, relativo alla notizia su un giovane che scongiura un grave incidente fermando un treno prima che rischiasse di deragliare a causa di un fortissimo temporale che aveva danneggiato la ferrovia, per mostrare il comportamento della società che con il pettegolezzo e la menzogna crea sedicenti eroi. Ma anche Women’s Prison (1965,10’) che, sul registro del “ cinéma-vérité”, documenta la vita di alcune donne in prigione ed i problemi che le loro famiglie devono affrontare nella lotta per sopravvivere; Tehran is the Capital of Iran (1966/1967,14’), sul degrado nelle zone povere di Teheran, dove troviamo un contrappunto tra immagini e suono che rafforza il malessere sociale denunciato nel film.
In programma anche Women’s Quartier (Il quartiere delle donne, 1966,18’) sulla vita delle prostitute nei bordelli di Teheran. Sono opere che esplorano la realtà iraniana degli anni Sessanta che diventano oggetto di discussione sotto il regime iraniano e gli valsero censura( con ritiro dei film),espulsione ed inserimento nella lista nera. Del 2001 è poi Solitude Opus 1 (19’), un “Aspettando Godot” ambientato nell’isola di Kish.
Nell’occasione è stato conferito a Kamran Shirdel il Premio FICC 2014 alla Carriera con la seguente motivazione: “Per aver trasposto la lezione neorealista appresa nel nostro paese documentando le problematiche sociali della sua terra, per la passione nei confronti dell’associazionismo culturale cinematografico, per la dedizione verso la didattica filmica. La sua filmografia attesta come la settima arte possa diventare uno straordinario strumento di riflessione per il cambiamento sociale e culturale dell’umanità, per lo sviluppo della pace tra le nazioni, senza mai tralasciare il rigore e l’interesse per la pura sperimentazione formale”.
.

Kamran Shirdel (a sinistra) riceve il Premio (una scultura riproducente la Dea Madre) dal Presidente FICC Marco Asunis (Foto di Franco Montis)
Una motivazione che riassume la figura di questo coraggioso cineasta iraniano che ha affrontato anche momenti difficili per poter realizzare le sue opere in piena libertà. Opere che hanno assimilato la lezione neorealista italiana applicandola in Iran nei suoi cortometraggi a sfondo sociale, visti al Congresso FICC. La formazione cinematografica di Kamran Shirdel, infatti, è avvenuta in Italia cosi come lui ci precisa. Era arrivato a Roma nel 1956 per frequentare la Facoltà di Architettura perché il padre voleva che diventasse, come tradizione familiare, dottore o ingegnere.
“Si, afferma Kamran Shirdel. Però in quel periodo ebbi modo di vedere Il grido (1957) che mi impressionò molto sia per il suo soggetto, era affine al mondo che conoscevo perché mio padre è stato il fondatore delle fabbriche di zucchero in Iran, sia per il linguaggio del suo autore. Da quel giorno Antonioni divenne il simbolo di un certo cinema che amavo. Poi quando vidi L’avventura di Michelangelo Antonioni e A bout de souffle di Jean-Luc Godard decisi di dimettermi dalla Facoltà di Architettura e iscrivermi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per diventare regista. Operazione un po’ difficile perché ero bravo ed il professore non condivideva questa mia decisione”.
- Però ci riuscisti?
“Si, ed ero il primo iraniano ad essere iscritto al CSC. Per entrare al Corso di Regia dovevo scrivere una tesi di almeno 100 pagine. La scrissi di 132 ed era incentrata su Michelangelo Antonioni, che poi incontrai due volte quando venne a parlare agli studenti. Ebbi modo in seguito di conoscerlo meglio e nel 1975 lo invitai al Festival Internazionale di Teheran, definita la “Cannes dell’Oriente”, dove presentò “Professione: reporter”. Ricevette una delle più grandi medaglie della Regione. In quell’occasione disse che aveva conosciuto in Italia un ragazzo iraniano che era andato a casa sua a portargli una tesi su di lui che gli era molto piaciuta. Chiese che quel giovane, che appunto ero io, gli facesse da interprete in quanto conosceva il suo mondo. Fu per me un grande onore e mi fece vivere momenti emozionanti. Tra essi, il momento in cui l’autista ci portò al Festival: c’era una grande folla ed Antonioni rimase meravigliato di essere tanto conosciuto in Iran. Anche oggi è molto amato nel mio Paese”.
- Altri registi ai quali s’ispira il tuo cinema?
“Il neorealismo in generale, specialmente Roberto Rossellini più che Vittorio De Sica che però ho molto amato. Oltre ad Antonioni amo anche il cinema di Pasolini e Rosi, che ho avuto anche l’onore di conoscere. Uno dei registi che mi ha toccato in tutti i sensi è poi Luis Bunuel. Quando ho visto Las Hurdes (Terra senza pane, 1932) ne rimasi totalmente sconvolto”.
- In Italia hai anche lavorato con John Huston per La Bibbia. Come è stata quell’esperienza?
“Zero, ma mi pagavano bene e quella collaborazione mi è servita a portare a casa 14 bauli di libri. Da quel momento il cinema americano l’ho messo da parte. In effetti, io mi sento un uomo del Neorealismo e adesso lo sto insegnando anche in Iran sottolineando anche come esso abbia influenzato il cinema americano”.
- I tuoi documentari sono stati proibiti in Iran. Sono stati anche confiscati e sei stato messo nella lista nera.
“E’ cosi, ma oggi ho un certo rapporto con il cinema iraniano, anche se non è come vorrei che fosse”.
- Alla Mostra di Venezia 2014 è stata premiata alla carriera la regista e sceneggiatrice iraniana Rakhshan Bani-Etemand. La conosci?
“E’ stata una mia allieva cosi come lo sono stati Jafar Panahi ed Abbas Kiarostami. Ma anche Amir Naderi che per me è come un figlio. Ha vissuto con me per undici anni. Era uno che dormiva per la strada, non aveva né padre né madre. Avevo capito che era molto dotato, e cosi in effetti si è dimostrato. Oggi, ci sono molti giovani documentaristi che vengono a casa mia o in ufficio a farmi vedere le loro opere, a chiedermi consigli. Ed io ho montato molti dei loro film”.
- Nel 2006 hai organizzato un Festival del documentario, ma è durato soltanto un anno. Come è andata?
“Si, all’isola di Kish : venne anche Vittorio De Seta, che era un mio Maestro. Era il primo Festival di Cinema indipendente organizzato in Iran. Ma dopo un anno lo chiusero, chiusero anche gli uffici”.
- Il tuo cinema è rivolto al documentario sociale: hai altri interessi?
“Soprattutto quello sociale e politico dedicato ai problemi del popolo. Ho poi realizzato finora un centinaio di documentari sui problemi industriali dell’Iran, e li ho realizzati anche per una formazione familiare essendo cresciuto in un ambiente di tecnocrati. Per me era un piacere farli, e sono anche abbastanza famosi”.
- Si dice che al centro della produzione iraniana siano i bambini anche per poter superare i problemi della censura. E’ cosi?
“Io, comunque, nel mio cinema mi sono occupato dei bambini per far vedere altre cose, soprattutto la povertà nei villaggi”.
- Alcuni registi iraniani non riescono a lasciare il Paese nemmeno per partecipare a Festival dove vengono presentate le loro opere. Qual è il vostro comportamento nei confronti di questi registi?
“Una grande solidarietà, e ciò li aiuta a poter lavorare”.
- In che modo l’architettura è importante nel tuo cinema?
“Antonioni diceva che il mio cinema è molto architettonico. E’ vero, per me lo è come costruzione ritmica e spaziale”.
.
SAGGI
SIGNOR PRESIDENTE
di Giulio D’Amicone
- L’ultimo imperatore
Il presidente degli Stati Uniti d’America è stato rappresentato sullo schermo parecchie volte, e senza dubbio lo sarà ancora. Innanzitutto, per l’industria hollywoodiana proporre tale figura significa consolidare la propria egemonia. Inoltre, il fascino esercitato sul pubblico si spiega perché al momento attuale il presidente rappresenta l’ultima personificazione dell’imperatore (non a caso uno dei film a lui dedicati s’intitola Absolute power). In verità, nobili e regnanti hanno sempre goduto di gran prestigio nel mondo dell’arte, spesso per piaggeria ma a volte anche per irrisione (si pensi alla camera degli sposi del Mantegna). Il cinema mitizza, e nel rappresentare l’uomo più potente del mondo trova terreno fertile; però anche in questo caso la medaglia ha due facce. Proviamo a esaminarle.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mito
Cominciamo da lontano. Nel 1944 Henry King s’imbarcò in un’avventura biografica che non gli portò molta fortuna: Wilson, sceneggiato dal morchioso Lamar Trotti, risultò lento, di eccessiva durata e palesemente agiografico (mostra Woodrow Wilson prevalere su Clemenceau e insiste sul suo tentativo di mettere in piedi la Società della Nazioni, ma omette per esempio che al termine della Grande Guerra gli statisti convenuti a Versailles dovettero attendere un’intera settimana il suo arrivo per nave).
Tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta la tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, conseguente allo sgancio delle bombe atomiche sul Giappone, indusse molti a ritenere probabile un conflitto che avrebbe condotto la specie umana alla totale distruzione (1). L’ipotesi è data per sicura o altamente probabile – oltre che in qualche film di fantascienza – nell’Ultima spiaggia di Stanley Kramer (uscito nel 1959 ma ambientato nel 1964), e in alcune pellicole singolarmente concentrate proprio nel 1964: Il Dottor Stranamore di Kubrick (di cui parlerò nel paragrafo successivo), Sette giorni a maggio di John Frankenheimer e A prova di errore (Fail safe) di Sidney Lumet. In quest’ultimo abbiamo il primo dei due presidenti interpretati da Henry Fonda: elegante, composto, riflessivo, tutto come ci si può aspettare da un interprete di tal fatta. Ma proprio questo suo aplomb contribuisce a rendere più agghiacciante la successione degli avvenimenti. Mentre infatti nel modesto Meteor (Ronald Neame, 1979) l’intervento presidenziale contribuisce a salvare la situazione, nel film di Lumet Fonda si trova costretto a cancellare New York dalla faccia della terra per compensare la distruzione di Mosca operata per sbaglio dai suoi bombardieri. Di un possibile conflitto russo-americano si occupa anche Sette giorni a maggio diretto da John Frankenheimer su sceneggiatura del grande Rod Serling (il responsabile della serie televisiva Ai confini della realtà). Qui ci troviamo di fronte a un presidente (Fredric March) anziano e non in perfetta forma. Pur non risparmiando al personaggio di Lyman tratti di debolezza, noi lo vediamo dedito anima e corpo al suo gravoso incarico; inoltre al termine della narrazione egli riesce a prevalere sul duro generale Scott (Burt Lancaster) scongiurando così un colpo di stato militare. Dispiace che il film, alquanto serrato, sia compromesso da una banale storia d’amore evidentemente inserita per carpire (senza successo) una fetta di pubblico femminile.
Peraltro non tutte le pellicole relative al suddetto periodo dispiegano prospettive così catastrofiche: sempre nel 1964 Gore Vidal scrive la sceneggiatura di The best man (in Italia trasformatosi nel cadenzato L’amaro sapore del potere), la cui regia viene affidata a Franklin Schaffner. Stavolta due candidati, il cinico Robertson e l’idealista Fonda, si affrontano per succedere al malandato Hockstader (Lee Tracy) il quale, benché malato terminale, non manca di presenziare alle riunioni e dispensare saggi consigli fino all’ultimo momento, quando è costretto al ricovero. Peraltro il finale vedrà la contesa risolversi a vantaggio di una terza persona.
Iper-mitizzante è senza dubbio il fantascientifico Independence day (1996) di Roland Emmerich, che inizia con una scena in cui il divo mai nato Bill Pullman telefona affettuosamente alla moglie: solo qualche minuto dopo verremo a sapere che si tratta del presidente. Il bravo ragazzo è putacaso anche pilota: e nel finale, di fronte alla minaccia dei feroci extraterrestri, egli non si periterà di mettere a rischio la sua stessa esistenza (nessuno del suo staff pare lo costringa a desistere) guidando uno dei velivoli destinati a contrastare la minaccia aliena. Non ci viene risparmiato neppure il pistolotto in divisa.
Non più di un accenno merita il fracassone Airforce one (1997) di Wolfgang Petersen, film nato vecchio in cui l’inverosimiglianza della trama ben si sposa con la mediocre interpretazione di Harrison Ford il cui unico pensiero, nella catastrofe dell’aereo dovuta ai soliti spietati terroristi asiatici, consiste nel salvare la first lady… L’anno dopo esce il catastrofico Deep impact per la regia di Mimi Leder, in cui Morgan Freeman conferisce al personaggio le caratteristiche di sobrietà ed eleganza che gli sono proprie, forse però sovrapponendo al personaggio la propria statura di interprete.
Thirteen days (2000) di Roger Donaldson apre il nuovo millennio non più che decorosamente. Bruce Greenwood interpreta Kennedy, ma la storia si accentra piuttosto fastidiosamente sulla figura (oleografica) dell’assistente interpretato da Kevin Costner (non per nulla coproduttore). Il film po-trebbe definirsi melodramma bellico: la crisi cubana relativa al 1962 è trattata come un giallo. Non un solo rigo di sceneggiatura è dedicato ai problemi economici derivanti dalle spese belliche, e la vita privata di Kennedy è appena accennata. Il ritiro delle forze navali statunitensi viene scaltramente presentato come una vittoria conseguita da un responsabile meditativo e ragionevole, solo un tantino nervoso.
Alquanto simili sono Attacco al potere (Olympus has fallen) di Antoine Fuqua e Sotto assedio (White House down) di Roland Emmerich, usciti a poco distanza nel 2013: in entrambi i casi l’invincibile eroe solitario riesce ad avere la meglio su di una agguerritissima squadra di terroristi salvando la vita al capo di stato. Invero qui la mitizzazione riguarda sopratutto la figura del protagonista, anche perché non diremmo che Aaron Eckhart e Jamie Foxx disegnino figure memorabili (forse non a caso in Attacco al potere largo spazio è riservato al sostituto Morgan Freeman).
Ovviamente al termine di questo paragrafo, iniziato con un film biografico, ci si aspetterebbe di trovare qualche osservazione su Lincoln, l’ultimo film di Spielberg: ma devo confessare di non averlo visto, forse per l’antipatia suscitatami dal protagonista (2).
- Antimito
Senza alcun dubbio, Tempesta su Washington (Advise and consent, 1962) va considerato uno dei capolavori del cinema americano degli anni sessanta. La densa sceneggiatura di Wendell Mayes, incentrata sulla nomina di un nuovo segretario di stato, è messa in scena da Otto Preminger con una tempistica perfetta e una direzione di attori da manuale. Il presidente è l’ex bello Franchot Tone, che alla confessione di Leftingwell (Henry Fonda) “Ho giurato il falso” risponde: “Lo sa nessuno?”. Malaticcio, introverso, debole e dispotico al tempo stesso, il personaggio ci appare carico di ambiguità fino alla sua improvvisa fine.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A distanza di cinquant’anni, il celebratissimo Dottor Stranamore appare statico e tutt’altro che esente da cadute di gusto; vale più che altro per le straordinarie performance di Peter Sellers, il cui capo di stato costituisce probabilmente la più riuscita delle sue tre caratterizzazioni. L’attore inglese disegna un personaggio di esilarante anonimato tanto nel fisico quanto nel comportamento, tale da formare un pesante contrasto con la recitazione goliardicamente esagitata di George Scott e Sterling Hayden. La lucida calvizie, gli occhiali da impiegato, i gemelli e l’anello concorrono a formare una figura d’innegabile grigiore che l’interprete rassoda con una recitazione controllata al millimetro.
.
Fatta una citazione en passant per Tutti gli uomini del presidente (All the president’s men, 1976) di Pakula pur se il capo di stato non vi compare (se la memoria non mi inganna), passiamo al 1979, anno in cui il romanziere polacco Jerzi Kosinski trae una sceneggiatura dal suo romanzo Being there (in it. Presenze), che diverrà un film diretto da Hal Ashby (come al solito in Italia il titolo originale non sarà rispettato e si tramuterà in Oltre il giardino). In questa grottesca avventura troviamo – accanto ad un Peter Sellers in gran forma – un vigoroso presidente interpretato da Jack Warden; ma alla fine del film si ipotizza che il protagonista, semplice giardiniere con problemi mentali, possa divenire addirittura il suo successore…
La previsione sbagliata (comune a molte opere) non impedisce di apprezzare 1997: fuga da New York (un po’ meno il successivo Fuga da Los Angeles) diretto da John Carpenter nel 1981. In questo film il personaggio incarnato da Donald Pleasence, che una squadraccia capitanata da Snake Plissken riesce a liberare, non fa gran figura, dimostrandosi cinico e indifferente a tutto tranne che alla sua salvezza personale. Il pessimismo dell’autore risulta tanto più radicale in quanto l’ipotesi narrativa è futuribile.
Nel 1993 esce Dave – Presidente per un giorno diretto da Ivan Reitman: un sosia prende il comando per 24 ore e dimostra di saper governare meglio del capo vero. Il copione di Gary Ross concede largo spazio ai rapporti tra marito e first lady, presentandoli come profondamente conflittuali. Il tema del sostituto che utilizza il buon senso per varare provvedimenti governativi riecheggia un bellissimo capitolo del Don Chisciotte di Cervantes, in cui il potere è temporaneamente gestito da Sancho Panza. Lo stesso anno vede uscire anche Nel centro del mirino (In the line of fire) diretto dal tuttofare Wolfgang Petersen: qui il capo di stato è poco di più di una presenza che le guardie del corpo spostano di peso in presenza di allarmi.
 Forse il nadir si tocca col citato Potere assoluto (1997) diretto da Eastwood su sceneggiatura del grande David Goldman: la figura di Richmond interpretata da Gene Hackman è probabilmente la più ripugnante del nostro elenco. Non una sola inquadratura è destinata agli affari di stato, e la first lady non è presente: il film è interamente concentrato sulla squallida vicenda che vede Richmond implicato in un omicidio. Sebbene il film soffra di un montaggio non impeccabile, l’ipocrisia regnante alla Casa Bianca su cui regia e copione intendono porre l’accento è evidenziata sopratutto nella bellissima scena del ballo, in cui lui e la sua assistente si scambiano frasi minacciose pur continuando a mantenere un contegno impeccabile. D’altronde il crimine viene commesso sotto gli occhi di un casuale ladro, che vi assiste attraverso un vetro-specchio.
Forse il nadir si tocca col citato Potere assoluto (1997) diretto da Eastwood su sceneggiatura del grande David Goldman: la figura di Richmond interpretata da Gene Hackman è probabilmente la più ripugnante del nostro elenco. Non una sola inquadratura è destinata agli affari di stato, e la first lady non è presente: il film è interamente concentrato sulla squallida vicenda che vede Richmond implicato in un omicidio. Sebbene il film soffra di un montaggio non impeccabile, l’ipocrisia regnante alla Casa Bianca su cui regia e copione intendono porre l’accento è evidenziata sopratutto nella bellissima scena del ballo, in cui lui e la sua assistente si scambiano frasi minacciose pur continuando a mantenere un contegno impeccabile. D’altronde il crimine viene commesso sotto gli occhi di un casuale ladro, che vi assiste attraverso un vetro-specchio.
Totalmente privo di valori d’immagine come quasi tutto il cinema di Oliver Stone, W. (2008) ricostruisce la biografia di Bush junior (l’interprete è Josh Brolin) con intenti dichiaratamente polemici, dalla giovinezza scapestrata fino al raggiungimento del potere. La demistificazione operata dal regista, su copione di Stanley Weiser, è tanto plateale quanto superficiale: questo Bush che non ne fa mai una giusta, tracagnotto e complessato, affetto da manie religiose e non privo di problemi con l’alcol si annulla da sé.
Nella parte del padre troviamo James Cromwell, che sei anni prima aveva già sostenuto il ruolo del presidente in Al vertice della tensione per la regia di Phil Alden Robinson, un capo di stato umano che riesce a scongiurare la guerra nucleare: una conclusione, grazie al cielo, diametralmente opposta alle succitate pellicole degli anni sessanta.
Concludiamo la breve rassegna antimitica col Royal weekend (Hyde Park on Hudson, 2012) diretto da Roger Michell, che descrive un incontro avvenuto nel 1939 tra Franklin Roosevelt e Giorgio VI d’Inghilterra. Bill Murray si cala nel ruolo mostrandoci un uomo invero non dotato di gran polso, anzi circondato e quasi soffocato da un entourage femminile.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Colpo di coda
Al termine di questo breve e senza dubbio non esaustivo elenco vorrei concludere, imprevedibilmente, con una performance tra le meno considerate: quella del collerico ma umanissimo Stevens intepretato da Charles Durning nel sottovalutato film di Aldrich Ultimi bagliori di un crepuscolo (Twilight last gleaming, 1976). Questo grande attore, scomparso nel 2012, non ha mai ricevuto l’attenzione che avrebbe meritato: ma chi lo ha apprezzato in Fury o in Quando chiama uno sconosciuto non disapproverà che si approfitti di quest’occasione per spezzare una lancia in suo favore.
_____
(1) Questo tema peraltro non si esaurì in quel periodo: si pensi al ciclo Mad Max con Mel Gibson realizzato negli anni ottanta.
(2) Un presidente Lincoln post mortem è presente in uno degli episodi della serie Ai confini della realtà intitolato The passersby (La via del ritorno, 1961) per la regia di Elliot Silverstein.
.
SULLE TRACCE DEL “QUARTO REICH”
di Roberto Lasagna
Mentre la filosofa Hannah Arendt si interrogava sulle radici profonde del razzismo e sulle ragioni possibili di quella dismisura travolgente che è stato l’Olocausto, il cinema, fatta salva qualche eccezione, solo in parte ha prestato il fianco alla discussione. La mancata riflessione sul totalitarismo non ha tuttavia impedito che anche attraverso il cinema sopravvivessero espressioni di quella diffusa angoscia che nel ritorno degli spettri totalitari, talvolta declinati in chiave fanta-apocalittica, vedevano il protrarsi della più abietta corruzione umana nella società moderna. I non molti film dedicati alle figure dei criminali nazisti in fuga, apparsi soprattutto grazie al cinema americano “di genere” degli anni Settanta, pur non rientrando direttamente nella corrente del cinema fanta apocalittico (con la parziale eccezione de I ragazzi venuti dal Brasile), spiccano per essere robusti film d’intrattenimento davvero informatissimi sulle figure dei famigerati criminali nazisti rievocati.
In film come Il maratoneta (1976) e I ragazzi venuti dal Brasile (1978), inoltre, al fantasma del nazista ricercato si accompagna la figura, non meno fantasmatica, di Simon Wiesenthal, il più noto cacciatore di nazisti della Storia pronto a raffigurare l’angelo della giustizia in uno scenario in cui il vivere pare regolato, quasi come durante il nazismo, da oscuri mercenari votati al culto del Dio di turno.
 Grazie a questo cinema di genere, che un tempo si sarebbe definito cinema di spionaggio a tratti sensazionalistico, fa capolino, se non la riflessione storica, una raffigurazione della mitologia attraverso la quale si staglia la figura del famigerato nazista.
Grazie a questo cinema di genere, che un tempo si sarebbe definito cinema di spionaggio a tratti sensazionalistico, fa capolino, se non la riflessione storica, una raffigurazione della mitologia attraverso la quale si staglia la figura del famigerato nazista.
Così Dossier Odessa, tratto dal racconto di Frederick Forsythe e diretto con efficace progressione drammatica dal veterano Ronald Neame, cala un convincente John Voight reduce dai passi di L’uomo di marciapiede (1968), nella Vienna del 1963, dove, malgrado una perenne atmosfera natalizia in cui trova letargia l’occidente, ci si può ancora accorgere che J.F. Kennedy è stato ucciso e che forse il diario lasciato dall’ebreo Salomon Tauber contiene allarmanti messaggi per il presente in corso. Spetterà al reporter Peter Miller interpretato John Voight di non far cadere nell’oblio i diari dell’anziano Tauber e di mettersi sulle tracce della fantomatica organizzazione Odessa, per qualche storico soltanto una leggenda, per altri un fronte ramificato ed efficiente di cui fu possibile scrivere l’organigramma.
Nei diari di Salomon Tauber, il cui contenuto letterario inventato trova plausibilità nelle testimonianze di Wiesenthal, Peter Miller riconosce la descrizione della figura del padre, un ufficiale delle SS che fu ucciso senza pietà dal famigerato macellaio del lagher di Riga, il comandante Roschmann. Questi, nei resoconti dei lagher, traeva particolare diletto dall’uccidere le vittime spaventandole, dividendo mogli e mariti, madri e figli, disgregando le più costitutive e naturali cellule della socialità ebraica.
Un film come Dossier Odessa, visto oggi, ha il fascino del racconto che “denuncia”, che “scopre” spolverando gli archivi di un’Europa che si appresta ad essere chiamata moderna, ma che rifiuta, proprio come un film di James Bond, di operare un ripensamento ovverosia una qualche riflessione, non diciamo profonda, sul genocidio. La detection del film di Ronald Neame si intreccia con l’attualità della condotta egiziana del presidente Nasser ipotizzando un fantomatico collegamento tra l’organizzazione di Odessa e la minaccia, sempre annunciata, della fine di Israele, qui per opera di nuovi missili a contenuto battericida preparati apposta per gli egiziani da una fabbrica oltre la cortina di ferro. In questo teatro ideale per una trama di Ian Fleming, Peter Miller è il cronista inascoltato che, in linea con alcuni giornalisti idealisti del cinema degli anni Settanta (tra cui i personaggi interpretati da Redford e Hoffman in Tutti gli uomini del presidente di Alan Pakula), ha evidentemente un conto in sospeso con Roschmann e con le nuove milizie pronte a difendere quel che resta del Terzo Reich. Più volte Miller si sente ripetere che le storie sugli ebrei sono acqua passata, che non interessano più a nessuno e non fanno notizia (saranno le stesse parole che dovrà ascoltare Simon Wiesenthal nel film e ne I ragazzi venuti dal Brasile, durante le sue numerose ricerche). Esiste dunque una trama oscura dietro la “cortina di ferro” di un’ufficialità che non vuole saperne di mettere in mostra gli scheletri di una nazione.
Così Miller conduce da solo la sua indagine; raggiunge Max, che fu al fianco di Salomon Tauber durante l’internamento nel lagher di Riga, e scopre da questi che Roschmann è ancora vivo e risiede ora in Germania, protetto dall’organizzazione segreta. L’indagine lo condurrà a visitare le feste di nostalgici nazionalisti omaggianti il ritorno di un nuovo Sigfrido. La sua fidanzata, come lui, rischierà la vita. Tra peripezie e travestimenti finirà per lavorare nell’organizzazione dei resistenti per la liberazione del pericolo imperialista (Mossad), in quella che è certamente la parte più azzardata del film, diventando, sotto mentite spoglie e dietro un duro addestramento, un fantomatico reduce nazista a sua volta clandestino nella nuova società. Gli sarà così possibile inserirsi nella rete di insospettabili figure che difendono i vessilli della nostalgia hitleriana. Fino al faccia a faccia, tanto atteso, di Miller con Roschmann (interpretato con perfetta ambiguità da Maximilian Schell) quando, in un finale rivelatore, Miller scopre le carte e accusa Roschmann di avere ucciso suo padre con un colpo alle spalle, mentre Roschmann nega assicurando che lui non conobbe mai quell’uomo. Si profila così nel film un discorso di gerarchia di colpe e responsabilità storiche.
Il padre di Peter era intento a salvaguardare la sopravvivenza dei “suoi” soldati feriti nel momento preciso in cui Roschmann ordinò al collega ufficiale, senza averne l’autorità, di lasciare libero il convoglio che intendeva utilizzare per i suoi scopi. Dinanzi alla condotta di un ufficiale “serio”, il colpo di pistola di Roschmann fu l’ennesima sopraffazione operata da un nazista-cultore della violenza gratuita, un individuo che, proprio come Hitler, preferiva di gran lunga i ciarlatani alle persone serie, i Rosenberg ai veri scienziati o pensatori scomodi. La stessa irriducibile serietà di Miller, che colora di idealismo un personaggio che in una simile luce è molto distante dal modello bondiano, è avvertibile nella corsa salvifica del personaggio di Thomas “Babe” Levy/Dustin Hoffman, il protagonista de Il maratoneta diretto da John Schlesinger nel 1976.
Ecco uno di quei film che rimangono impressi nella memoria ma che la critica si è presto premurata di sottostimare, tanto che ancora oggi il film di John Schlesinger è quasi totalmente relegato nel novero del cinema di genere di buona fattura ma privo di sostanziali qualità fuorché le interpretazioni dei principali interpreti.
Realizzato da uno dei cineasti inglesi più interessanti degli anni Sessanta, Il maratoneta, terzo film hollywoodiano del regista, è sin dal titolo la raffigurazione di un personaggio chiave nella ricerca di una verità che galleggia sotto gli occhi di tutti, bisognosa però di individui capaci di prendersi carico delle responsabilità che essa reclama. Dustin Hoffman interpreta con abituale candido dinamismo la figura dello studente di Storia prossimo alla laurea con una tesi sulla società totalitaria.
 Come in Dossier Odessa, fa la sua apparizione ne Il maratoneta Simon Wiesenthal, ma in una variante istituzionalizzata (un docente universitario invece del cane sciolto) dal nome simile (prof. Biesenthal). Nel film di Ronald Neame l’attore che interpreta Wiesenthal (Shmuel Rodensky) gli somiglia e si presta a interpretare il perfetto consulente di Peter Miller nella caccia ai nazisti, invece, ne Il maratoneta Biesenthal è un insegnante di Storia della Columbia University, la stessa università in cui si laureò il padre di Babe, un rigoroso idealista che si tolse la vita perché non riuscì a resistere alle umiliazioni del maccartismo.
Come in Dossier Odessa, fa la sua apparizione ne Il maratoneta Simon Wiesenthal, ma in una variante istituzionalizzata (un docente universitario invece del cane sciolto) dal nome simile (prof. Biesenthal). Nel film di Ronald Neame l’attore che interpreta Wiesenthal (Shmuel Rodensky) gli somiglia e si presta a interpretare il perfetto consulente di Peter Miller nella caccia ai nazisti, invece, ne Il maratoneta Biesenthal è un insegnante di Storia della Columbia University, la stessa università in cui si laureò il padre di Babe, un rigoroso idealista che si tolse la vita perché non riuscì a resistere alle umiliazioni del maccartismo.
Il Wiesenthal/Biesethal de Il maratoneta è dunque una figura bizzarra, una sorta di fantasma della coscienza o di rivisitazione carismatica del reale Wiesenthal, in un film che di spettri e fantasmi farà ampio sfoggio.
Tetro e oscuro, il thriller di Schlesinger è la raffigurazione di un incubo. Straordinaria, in questo senso, la sequenza del bagno, con Hoffman che ascolta i bisbigli e le voci provenienti dalle stanze attigue. Un incubo ribadito con i toni dell’indecifrabilità per un Dustin Hofmann presto legato alla sedia e torturato dal nazista Zsell al suono della frase inesplicabile “è sicuro!?!”. Un incubo che presenta i toni del Mistery intrecciato magistralmente con le atmosfere dell’Horror moderno, che in quegli anni furoreggia grazie agli esiti espressivi di William Friedkin e Dario Argento. Babe, l’idealista che vorrebbe riaprire l’indagine sul padre, non sa che suo fratello è coinvolto in traffici rischiosissimi e lo crede invece un affarista del petrolio. Il fratello è “in realtà” un agente segreto in contatto con Zsell, un temibile nazista rifugiato in Paraguay, ovvero il dentista sanguinario che fa il verso a Joseph Mengele, in quegli anni ancora vivo e di cui si credeva fosse rifugiato in Paraguay (mentre successivi rilievi, anche a dispetto delle convinzioni di Wiesenthal, ne decretarono la morte per annegamento in Brasile).
Babe corre perché come il suo regista Schlesinger ha sempre in mente la figura dello sportivo che ce la fa con le sue stesse gambe, così come uno storico deve poter contare su di una fiducia incrollabile nella verità per combattere le ambiguità e permettere di aver chiaro l’orizzonte. Il professore di Storia, il Wiesenthal del film, ricorda che gli Stati Uniti sono diventati una fabbrica di laureati di Storia, ma che questo è il progresso, mentre a qualcuno questo progresso non va proprio a genio. Non va a genio ad esempio al fratello di Babe, che ogni giorno rischia la vita e si “sporca” con traffici inquietanti come quello dei gioielli trafugati agli ebrei da Zsell durante il loro internamento ad Auschwitz. Il fratello, attratto dalla bella vita, si accorge di essere ad un guado e vorrebbe mettere sull’avviso Babe in merito alla circostanza che gli uomini di Zsell stanno per portarsi sulle sue tracce per cercare di carpire da lui il segreto di una cassetta di gioielli gestita dal fratello di Zsell (morto inaspettatamente tra le fiamme dell’incendio con cui prende avvio il film).
Agli occhi di Babe la realtà appare, ad un certo punto, una ragnatela confusa, dove i nemici paventano toni cortesi (il Mengele/Zsell di Laurence Olivier ha il garbo sinistro di un individuo che sfoggia superiorità perfino nelle mansioni più efferate come la tortura attraverso il trapano per i denti) e gli amici o le amanti si rivelano infingardi doppiogiochisti, mercenari travestiti da confidenti. La verità si svela lentamente e gli individui hanno più volti, più aspetti che non permettono un giudizio univoco o categorico. Sarà la società urbana, in quanto di tribale essa possiede, a interagire con Babe (i dirimpettai che prendono sempre in giro il maratoneta pronti a rivelarsi salvifici come un esercito di guerrieri della notte da contrapporre ai ben più pericolosi criminali adulatori dei gioielli di Zsell), a portare nella solitudine delle strade un impeto di appartenenza, a riequilibrare il destino di Babe e a far pensare che i ladruncoli per necessità sono ben altra cosa a confronto con i nazisti e le banche che conservano tesori tanto compromettenti.
La società, con i suoi retaggi tribali e i suoi personaggi misconosciuti, ha in serbo individui che, per fortuna, possono rivelarsi in forte collisione con le aberrazioni sistematiche del sistema istituzionale, che per opportunismo ed equilibri politico-finanziari dimentica l’etica sociale ed i suoi propositi.
In conclusione, il gran duello finale tra un nazista terrorizzante e uno studente di Storia disinteressato al valore dei soldi, è anche il riscatto della morale sul crimine mercenario. I gioielli finiranno nella discarica, volutamente per mano di Babe (qui senza alcuna accentuazione del caso come destino, come per il denaro finito al vento nel finale kubrickiano di Rapina a mano armata) e il nazista perirà per sua stessa mano (nella foga di recuperare i gioielli si ucciderà con la stessa lama retrattile con cui aveva ucciso il fratello di Babe).
Abilissimo nel definire i personaggi, Schlesinger ha ragione nel disegnare figure umane di contorno che paiono ambigue e che non riusciamo pienamente a giudicare. Il suo talento è anche nel tratteggio di figure ambivalenti, di cui ci piacerebbe sapere alla fine un po’ di più (così, ad esempio, per il fratello di Babe interpretato perfettamente da Roy Scheider). Dietro la realtà c’è un’immagine più vera, dietro il comportamento di un personaggio ci sono motivazioni profonde che solo a tratti si rivelano e proiettano una luce chiarificatrice.
Dietro le atmosfere del thriller cova la tensione espressiva di un autore ben altrimenti apprezzato per film quali Billy il bugiardo o L’uomo da marciapiede.
Altro thriller affine, di fattura però più grezza, è il fantapolitico I ragazzi venuti dal Brasile (1978), diretto da Franklin Schaffner, il regista de Il pianeta delle scimmie che qui ci racconta un pianeta abitato da una minaccia non meno “regressiva”, quella del ritorno del Reich millenario voluto da Adolf Hitler.
Questa volta i volti chiamati a rapporto sono direttamente quelli del nazista Joseph Mengele e del cacciatore di nazisti Simon Wiesenthal, cui prestano il volto un accigliato Gregory Peck e un credibile perché umanissimo Laurence Olivier (che si toglie, per così dire, i panni del nazista appena portati in scena ne Il maratoneta, a riprova di un coerente percorso di autore dei propri ruoli).
Laddove, ne Il maratoneta, Schlesinger portava il nazista Zsell nel quartiere del mercato finanziario di New York, tra le strade di astanti in cui il famigerato “angelo bianco” rischiava di essere riconosciuto da ebrei sopravvissuti, ne I ragazzi venuti dal Brasile Mengele è parte di una rete di reduci che progetta la fondazione del Quarto Reich attraverso il perfezionamento di un programma di eugenetica che farà nascere in varie parti del mondo numerosi cloni di Adolf Hitler ricreando attorno a loro analoghe condizioni esistenziali suscettibili di scatenare il “genio” del Fuhrer. Un programma folle e strampalato che esprime nondimeno l’arrogante mancanza di limiti del progetto nazista, noncurante della disfatta storica e orientato a perseguire la sua logica appoggiandosi a opzioni per nulla scientifiche ma colme di fanatismo.
Di quanto folle sia il progetto di Mengele si accorge presto il camerata interpretato da James Mason, attore sopraffino che con un’occhiata obliqua è in grado di ridimensionare la statura di Mengele, qui tratteggiato come un borioso fanatico sempre sopra le righe. Più interessante il ritratto di Wiesenthal affidato a Laurence Olivier, attore che in quegli anni lotta veramente contro un “male oscuro”.
Il Wiesenthal di Olivier è un gran viaggiatore, sempre in bolletta come l’istituto che difende, sostenuto però dalla fidata collaboratrice. Un anziano con grande esperienza, totalmente deluso dalle istituzioni (nella realtà fu più volte candidato al Nobel per la pace ma non sembrò degno assegnare il premio ad un “cacciatore di nazisti” che, oltre ad inchiodare Eichmann, fu responsabile dell’arresto di almeno altri millecento fuggiaschi), cui Olivier infonde stoica rassegnazione, vivacità d’animo, e una punta di dolente amarezza. In questo film a tratti grottesco e magniloquente, si dà ragione alla tesi di Wiesenthal che Mengele sul finire degli anni Settanta fosse rifugiato in Paraguay. Ciò fu vero fino ad un certo punto, fino a quando la copertura governativa lo rese possibile. Soltanto nel 1985 si seppe che Mengele finì i suoi giorni in Brasile nei primi mesi del 1979.
In questo film, come in molte altre leggende e in racconti sulla figura del famigerato medico di Auschwitz, Mengele è uno spettro che si aggira indisturbato nell’America del Sud, dove vive circondato da guardie e progetta di rifondare il Reich millenario.
Niente di più fantomatico, nondimeno Mengele, dopo la fuga in Sudamerica, sentendosi almeno in parte sicuro in quelle terre, non sempre scelse la via dell’anonimato (per un certo periodo il suo nome vero comparve addirittura nella guida telefonica) e i suoi interessi scientifici poterono trovare proprio in Sudamerica le condizioni per nuovi studi, come ci ricorda opportunamente un film del 2012 di Luisa Puenzo: Il medico tedesco.
.
FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
FILMMAKER ALLA RIBALTA: GIORGIO SABBATINI
di Paolo Micalizzi
Il filmmaker torinese Giorgio Sabbatini è una figura storica della Fedic: ha all’attivo una sessantina di opere, tra cui un mediometraggio e 3 lungometraggi, nei vari formati 8mm.,16mm., super8, VHS, BVU e DVCAM. Opere che gli hanno fatto ottenere un ricco palmares di premi, a livello nazionale e internazionale.
Il suo primo film a soggetto risale al 1961 è in 8mm., e s’intitola Illusione, una storia basata sulle difficoltà incontrate da una persona nel modificare la propria situazione sociale. La passione per il cinema, Giorgio Sabbatini la deve alla nonna. “Mi portava regolarmente a vedere film, ha avuto occasione di ricordare di recente al Forum Fedic alla Mostra di Venezia e, quasi sempre, si trattava di film ‘western’ o di qualche ‘commedia’ americana. La passione per quelle immagini proiettate su uno schermo cosi grande mi affascinava e mi fecero vivere, più volte, le situazioni che i protagonisti affrontavano con tanto impegno e coraggio. Finché il buio della sala mi avvolgeva diventavo un personaggio di quelle vicende e vivevo in diretta ogni azione raccontata dal susseguirsi delle inquadrature. Poi le luci si accendevano e quella splendida ‘magia’ svaniva in una realtà non sempre piacevole. Questa provocò in me il desiderio di possedere un piccolo proiettore per poter avere la possibilità di fare il ‘cinema in casa’ e poter analizzare i singoli fotogrammi di un film e comprendere meglio come i diversi movimenti fossero gestiti nelle riprese cinematografiche”.
Nel 1956 il suo desiderio venne esaudito dai suoi genitori e un piccolo proiettore a manovella e a “passo ridotto” (nove e mezzo, quello con la perforazione al centro della pellicola, tra un fotogramma e l’altro) fece il suo ingresso nella famiglia Sabbatini, dando al quattordicenne Giorgio la possibilità di un suo primo contatto con la pellicola. Il passo successivo fu il regalo di una cinepresa (CIMA) in 8 mm. e, dopo alcuni cambi di cineprese e sperimentazioni tecniche, arrivò a realizzare film familiari e racconti fino a giungere, finalmente, nel 1961 a Illusione.
Sperimentare è alla base del “fare cinema” di Giorgio Sabbatini. Un interesse che lo porta ad approfondire tutto ciò che concerne l’immagine e la sua estetica, interessandosi alla fotografia non solo dal punto di vista della ripresa ma anche nelle elaborazioni delle immagini attraverso processi di laboratorio come lo sviluppo e la stampa in b/n e a colori. Oggi, tale interesse è rivolto principalmente al digitale. Inoltre, si interessa da diversi anni anche alla registrazione audio, sia in presa diretta che in studio.
Nel 1966 il primo film sperimentale, Rapsodia in blu, realizzato sulla nota musica di George Gershwin, ”dove le attese e il tempo che passa rappresentano i ‘tempi’ della vita” afferma Giorgio Sabbatini. Del 1967 la fiction “Il pupazzo” che una nota riferisce essere “una storia complessa sui sentimenti tormentati di una giovane donna”.
 Un’opera molto impegnativa è il lungometraggio Inchiesta sulla droga che nel 1977 viene presentato al Concorso Fedic di Montecatini: una fiction nella quale si alternano alcune interviste realizzate a Torino. Per questo film scrive anche le musiche originali ed una canzone, che commenta i titoli di testa.
Un’opera molto impegnativa è il lungometraggio Inchiesta sulla droga che nel 1977 viene presentato al Concorso Fedic di Montecatini: una fiction nella quale si alternano alcune interviste realizzate a Torino. Per questo film scrive anche le musiche originali ed una canzone, che commenta i titoli di testa.
La musica è un’altra passione di Giorgio Sabbatini che, va sottolineato, è l’autore completo delle sue opere perché le realizza partendo dall’idea fino all’edizione finale passando per tutte le fasi della loro realizzazione.
Con queste prime opere Giorgio Sabbatini incomincia a farsi conoscere e, dal 1978, come si evince dal suo curriculum, si registrano i primi riconoscimenti ai Festival.
Inizia a conquistarli Visione che, dopo l’attribuzione della Coppa dell’Ente Provinciale per il Turismo in una Rassegna del Cineclub Piemonte, viene presentato al Festival Fedic di Montecatini. Visione è un ‘opera sperimentale nella quale, si legge nel soggetto, attraverso le immagini e i simboli, si cerca di rendere evidente, nel momento in cui siamo avvolti dall’abbraccio della morte, la “visione” di ciò che è la vita.
 Nello stesso anno realizza altre opere, anch’esse presentate a Montecatini: Breaking off sulla difficoltà di vivere insieme che viene sottolineata dalla critica alla coppia e alla società, il cui commento è affidato alla voce delle radio libere; Una brutta caduta che in tono grottesco “ridicolizza la trasmissione di una radio privata dalla quale vengono lanciati continui messaggi di fede”. E’ un cinema di idee, quello di Giorgio Sabbatini, che focalizza aspetti esistenziali dell’umanità, che prosegue con altri cortometraggi fino a realizzare nel 1979 il lungometraggio Come tema …l’amore che si sviluppa attorno alla confessione di tre giovani donne sul tema dell’amore secondo le diverse esperienze vissute. In quest’opera Giorgio Sabbatini continua a sperimentare realizzando singolari riprese, come quella che sottolinea che il ciclo di vita si è compiuto in un ipotetico spazio di tempo, sottolineato da un movimento rotatorio della cinepresa, che dalla terra ci riporta alla terra. Tutto si conclude nel ritorno alla natura come in un “grembo materno” che racchiude amore, vita e morte.
Nello stesso anno realizza altre opere, anch’esse presentate a Montecatini: Breaking off sulla difficoltà di vivere insieme che viene sottolineata dalla critica alla coppia e alla società, il cui commento è affidato alla voce delle radio libere; Una brutta caduta che in tono grottesco “ridicolizza la trasmissione di una radio privata dalla quale vengono lanciati continui messaggi di fede”. E’ un cinema di idee, quello di Giorgio Sabbatini, che focalizza aspetti esistenziali dell’umanità, che prosegue con altri cortometraggi fino a realizzare nel 1979 il lungometraggio Come tema …l’amore che si sviluppa attorno alla confessione di tre giovani donne sul tema dell’amore secondo le diverse esperienze vissute. In quest’opera Giorgio Sabbatini continua a sperimentare realizzando singolari riprese, come quella che sottolinea che il ciclo di vita si è compiuto in un ipotetico spazio di tempo, sottolineato da un movimento rotatorio della cinepresa, che dalla terra ci riporta alla terra. Tutto si conclude nel ritorno alla natura come in un “grembo materno” che racchiude amore, vita e morte.
.
.
Nel 1980 un altro lungometraggio, Burattini, con protagonista una giovane e bella donna, Anna, succube di un destino poco felice che la vede vittima di persone e problemi che condizionano continuamente la sua vita, rendendola una burattina. Attraverso la narrazione l’autore sviluppa il tema della libertà, difficile, secondo lui, da conquistare sul piano personale, specie se si è donna. Dello stesso anno è Favola moderna sul degrado dell’ambiente operato dagli adulti che alterano anche gli aspetti più naturali. Un tema che Giorgio Sabbatini affronta anche in altre opere, tra cui Lirica per una città malata (1976) sul degrado ambientale di Venezia.
Quattro le opere realizzate nel 1981, tra cui Le pecorelle che gli porta il conferimento del Primo Premio al “Gattamelata d’Oro” di Padova. Venne scelto dalla giuria tra una rosa di 54 opere (corto, medio e lungometraggi): un filmato di 7 minuti in cui l’autore esprime angosce, delusioni e speranze vissute in sogno (o realmente vissute?) “con modestia ma con un rigore stilistico decisamente notevole”, come afferma la Giuria.
.
.
.
.
.
La filmografia di Giorgio Sabbatini si arricchirà di altre 7-8 opere, poi nel 1983 arriva la fiction Condizionato futuro in cui attraverso una storia che coinvolge anche la moglie e il figlio si esprime la paura di una guerra nucleare. Un incubo causato anche dai giochi del figlio che preferisce robot, astronavi e conflitti spaziali nei quali si distinguono gli eroi fantastici visti in sconfinate serie di avventure televisive. Le ansie di un genitore per il futuro della generazione del proprio figlio sono poi espresse in Images (1992) dove, secondo P.T. (“Cineclub”, n°14/aprile-maggio 1992) “in un confronto serrato fra immagini contrastanti, astratte e concrete, e con una buona miscelatura tra suono ed immagini, l’autore è riuscito nel suo intento (che poi dovrebbe essere quello di ogni opera “cinevisiva”): creare un significato che si disnoda e si approfondisce frame dopo frame”.
In una mia recensione (“Cineclub, n°6-aprile 1983) sottolineo il linguaggio sperimentale con il quale Sabbatini realizza il film: “Di loro, cioè il protagonista e la moglie, vediamo le mani e i movimenti del corpo in alcuni gesti quotidiani come dormire, lavarsi, far da mangiare, consumare i pasti. E in questi gesti, come conseguenza dei sogni che si tramutano in incubo, l’ossessione dell’uomo continua in un dialogo insistente con la moglie alla quale sottolinea come il mondo non faccia nulla per risolvere questi problemi perché, in fondo, a tutti piace vivere tranquilli. L’unico volto che si vede è quello del figlio”. E più avanti annoto che si tratta di “un film dal contenuto di pregnanza attuale, espresso più nel commento parlato che non nelle immagini. Se ad esse fosse stato dato più spazio, il film avrebbe acquistato maggiore intensità e drammaticità come l’argomento affrontato e, forse, come le intenzioni iniziali dell’autore richiedevano”. Scrivevo, inoltre, che era “da sottolineare poi l’impegno creativo dell’autore: sue, anche le musiche, molto funzionali peraltro, di stile elettronico-concreto”. L’opera fu premiata con l’Airone Fedic (1° premio) al “Valdarno Cinema Fedic 1983” mentre nel 1985 al Concorso di Villa di Chiesa (Iglesias) Giorgio Sabbatini si meritò la Coppa per la migliore musica originale: un’altra caratteristica positiva dell’attività di filmmaker di questo autore. Da aggiungere che la Giuria, presieduta dal regista Massimo Mida Puccini, ha premiato il film per “l’originale stile narrativo raggiunto attraverso l’ottimo equilibrio delle vaie componenti del film: sceneggiatura, recitazione, montaggio e sonoro”. Dal canto suo Cinzia Baldazzi (“Cineclub”, n° 7-aprile 1984) scrive che “Sabbatini conferma la sua attenzione verso il mondo dell’infanzia e i condizionamenti che a questo derivano dall’essere inserito, sin dai primissimi anni, in quel villaggio planetario dove l’apparecchio televisivo riveste un ruolo centrale nel film Iomangiotumangi dove, annota ancora Cinzia Baldazzi, “in un’opera che risente di qualche prolissità riserva piacevoli sorprese la colonna di musiche e rumori, e in particolare la registrazione in diretta davvero molto studiata e pulita”.
 Nel 1986 Giorgio Sabbatini con Tracce passa dalla pellicola al Video VHS. Si tratta, secondo il sottoscritto di un’opera che vuole essere una riflessione per cercare la chiarezza necessaria a comprendere la propria esistenza onde non essere sopraffatti da un mondo crudele. ”Un ‘opera rileva Giampaolo Bernagozzi (“Ciennepi”,1986) in cui in un duello con se stessi, l’io si sdoppia e, sdoppiandosi, costruisce il gioco subdolo di una strana ricerca della verità, costruita nello scontro ideologico, sulla parola, sugli oggetti, sui gesti rivissuti entro lo spazio angosciante ed esplosivo di una unica stanza. La coabitazione della violenza, potrebbe essere definito questo Tracce dove lo sdoppiamento del personaggio porta a confessioni laceranti e a verità allucinanti. Il rifiuto di se stessi oppure dell’altro da sé, l’esclusione di ogni possibile equivoco, la disperata ricerca di un senso della vita, la fede, la noia (“…non ti sopporto più…mi annoi…”) s’intrecciano con il politico e il personale, con il sociale e il privato, di sogno e la realtà; tutto nel confine dell’improbabile e, nello stesso tempo, del possibile. Il dialogo con se stessi diventa anche il dialogo con le cose e allora questo tipo di cinema, cosi caro a Sabbatini, si traduce in un acuto, insistito pedinamento degli oggetti: alcuni emblematici degli spostamenti narrativi, altri esasperati come contrappunto al vario rincorrersi psicologico dei personaggi (o del personaggio)”.
Nel 1986 Giorgio Sabbatini con Tracce passa dalla pellicola al Video VHS. Si tratta, secondo il sottoscritto di un’opera che vuole essere una riflessione per cercare la chiarezza necessaria a comprendere la propria esistenza onde non essere sopraffatti da un mondo crudele. ”Un ‘opera rileva Giampaolo Bernagozzi (“Ciennepi”,1986) in cui in un duello con se stessi, l’io si sdoppia e, sdoppiandosi, costruisce il gioco subdolo di una strana ricerca della verità, costruita nello scontro ideologico, sulla parola, sugli oggetti, sui gesti rivissuti entro lo spazio angosciante ed esplosivo di una unica stanza. La coabitazione della violenza, potrebbe essere definito questo Tracce dove lo sdoppiamento del personaggio porta a confessioni laceranti e a verità allucinanti. Il rifiuto di se stessi oppure dell’altro da sé, l’esclusione di ogni possibile equivoco, la disperata ricerca di un senso della vita, la fede, la noia (“…non ti sopporto più…mi annoi…”) s’intrecciano con il politico e il personale, con il sociale e il privato, di sogno e la realtà; tutto nel confine dell’improbabile e, nello stesso tempo, del possibile. Il dialogo con se stessi diventa anche il dialogo con le cose e allora questo tipo di cinema, cosi caro a Sabbatini, si traduce in un acuto, insistito pedinamento degli oggetti: alcuni emblematici degli spostamenti narrativi, altri esasperati come contrappunto al vario rincorrersi psicologico dei personaggi (o del personaggio)”.
La produzione di Giorgio Sabbatini vira decisamente verso il video. Particolarmente interessante è Polvere (1988) la cui vicenda è costruita su una telefonata che arriva nel cuore di una notte come tante, dove dall’altra parte del telefono c’è una voce disperata costretta a vendere per sopravvivere. ”Una telefonata, annota Piero Pruzzo (“Cineclub, luglio 1987), che porta a riflessioni sulla vita, testimonianza, confidenza”. Un omaggio al cinema di Roberto Rossellini e alla stupenda interpretazione di Anna Magnani in La voce umana, episodio del film L’amore (1948). Un film premiato al “Cinè” di Nave per la migliore interpretazione dello stesso Sabbatini.
Apprezzamenti critici riceve War paint, una proposta convincente sul tema “guerra” secondo Giuseppe Barbanti (Cineclub, n°10-giugno 1991), che fanno annotare allo stesso critico che “le immagini ci portano assieme ai simboli della guerra (bombardamenti, carri armati, scontri aerei) quelli del ricordo dei tempi di pace, lo struggente pensiero del soldato al fronte tutto rivolto alla donna che ama”, il quale, infine, sottolinea che “anche l’accompagnamento musicale è indovinato”. Un’opera dove il disegno grafico è parte integrante del discorso narrativo che si avvale anche dell’uso della parola scritta.
I temi dei suoi film sono vari e rispecchiano la curiosità culturale di Giorgio Sabbatini che su di essi fa approfondite riflessioni. Quello della pena di morte è affrontato nel film La sedia (1993) dove partendo da questo oggetto che si trova in una stanza, il pensiero, attraverso una serie di immagini oniriche, giunge alla realtà drammatica della sedia elettrica, simbolo di tortura e violenza. Un’opera che si stacca dalle forme narrative tipiche del cinema dando un linguaggio autonomo all’immagine elettronica che si esprime (come sottolinea P.P. in occasione della Rassegna “Corto di Sera”, novembre 1997-giugno 1998 del CGS Zoom di Ferrara) “in una successione di immagini, apparentemente disarticolata e incoerente, che alla fine giunge ad una sua unitarietà; la sua forma è quella del flusso di coscienza, dell’associazione libera, ma il video, misteriosamente, ci restituisce una sua traccia precisa: specularmente, è come quando ci sorprendiamo a ripercorrere, nel flusso apparentemente ‘liscio’ dei nostri pensieri, le irruzioni delle immagini più bizzarre”. Un linguaggio di cui Luigi Serravalli (“Cineclub” n°19/luglio-settembre 1993) sottolinea l’effetto concettuale nella maniera di presentare certi cartigli volanti ai quali è affidato lo sviluppo del racconto. Per il critico si tratta di un ‘opera di grande maturità e di ottimo sfruttamento dei mezzi tecnici. Piccolo, raffinato, capolavoro”.
Continuando la sua ricerca nel campo del linguaggio filmico Giorgio Sabbatini arriva a Quadri (1995) dove, ancora secondo Luigi Serravalli (“Corriere di Arezzo”, 30 aprile 1995)” indaga più sul mezzo cinematografico che sul racconto: questa, secondo me, è la strada più importante per tutto il cinema, sulle tracce famose dei Godard, Truffaut, Wenders ed altri. Il linguaggio deve studiare se stesso. ”Un film sugli errori quotidiani causati da schemi della vita che ci obbligano a vivere in spazi ridotti, limitati da semplici cornici all’interno di comuni quadri”. E’ stato premiato al XXVII Concorso Nazionale di “Villa Chiesa” di Iglesias con la Medaglia d’Oro del Presidente della Regione Sarda con la seguente motivazione: “Per aver saputo rappresentare, attraverso immagini sfuocate ed incerte, ora lente, ora veloci, il dramma delle coscienze individuali e collettive, coinvolte in spaventose decisioni di responsabilità all’interno di un disegno che sovrasta. Dal film traspare la lotta tra sofferenza e insensibilità che, spesso, porta l’individuo alla solitudine ed all’isolamento all’interno di…’spazi ridotti delimitati all’interno di comuni quadri’”.
Di particolare interesse poi La Finestra (2001) che è stato anche scelto per rappresentare l’Italia in un Festival che si è svolto in Cina. Una finestra come pretesto per cercare di vedere oltre, per Imparare a “guardare” e capire. E il regista lo fa mettendo a confronto situazioni di ricco benessere e di vita povera, fatta di duro lavoro e ai margini di un mondo civile. Immagini da capire e vedere, aprendo le finestre della mente. Per poter bene riflettere sul mondo in cui viviamo, e agire.
 Interesse anche per Parigi (2004) dove, come rileva la recensione di Ermanno Comuzio (“Carte di Cinema”, n°14/2004), “le bellezze di una città come Parigi sono contaminate dalla violenza, dai disastri, dalla morte”. Un forte e inquietante messaggio “fatto di immagini eloquenti, trattate con un efficace montaggio e con manipolazioni elettroniche che compiono incursioni da guastatori nel dominio della Bellezza”.
Interesse anche per Parigi (2004) dove, come rileva la recensione di Ermanno Comuzio (“Carte di Cinema”, n°14/2004), “le bellezze di una città come Parigi sono contaminate dalla violenza, dai disastri, dalla morte”. Un forte e inquietante messaggio “fatto di immagini eloquenti, trattate con un efficace montaggio e con manipolazioni elettroniche che compiono incursioni da guastatori nel dominio della Bellezza”.
Quindi, nel 2005, Percorsi in cui “immersi in una Natura selvaggia, i pensieri prendono forma attraverso rumori e suoni che risvegliano immagini di vita e sensazioni vissute nel tempo. E che fanno riaffiorare momenti belli vissuti dove i rumori continuano ad essere incubo e paura di un passato e di un presente, protesi verso un futuro incerto.” Sensazioni, come sottolinea Enrico Basaldella (“Il Giornale del Filmmaker”, n° 52-ottobre 2012) recensendo Selciati (2012) che fanno capire quanto la musica, il suono, un bel quadro, un film possano far suscitare critiche, emozioni, gioia, rabbia, che solo chi è un artista in sé, dentro sé, può, senza parlare, farsi capire”.
La guerra è al centro delle angosce di Giorgio Sabbatini. Un tema trattato più volte e che ritorna anche in Macchie (2004), che sono quelle insanguinate, generate, in una Terra abitata da popolazioni diverse, dal proliferare di guerre per la conquista del potere. “Ma, riflette l’autore, se il sangue accomuna tutte le popolazioni, il desiderio di un mondo senza macchie, piuttosto utopico, o con meno macchie, più realistico, ci dà modo di sperare in un futuro, forse migliore, attraverso lo sguardo di una nuova generazione che, dagli errori ed orrori del passato, sappia cogliere il vero significato della vita rispettandola, e possa cogliere la vitalità di una rosa rossa come simbolo indiscusso di un amore, al quale ogni essere umano dovrebbe ispirarsi”.
Gli orrori della guerra ritornano nella mente di Giorgio Sabbatini in La realtà a tempo di danza (2007) vedendo la scena di una danza tragica del film Tango di Carlos Saura. Dalla sua analisi l’autore rileva che in essa si accentrano gli orrori della guerra nel Vietnam, nella scansione ritmica della musica che sottolinea le azioni violente, che vengono vissute contemporaneamente sia nella danza che nella realtà di una guerra che ha prodotto innumerevoli perdite umane. Ed esprimendo la sua riflessione pensa, come si rileva dalla trama del film, che “la speranza, che dagli errori del passato ognuno possa trarre la consapevolezza che la vita umana è un bene che non si può perdere cosi facilmente di fronte ad una pallottola sparata in nome di una inqualificabile ‘democrazia’, viene vanificata dal perpetrarsi di una insistita violenza che non può giustificare la ‘giusta causa’ di eliminazione di fautori del ‘male’, poiché l’eliminazione della vita attraverso la condanna pone l’uomo giudicante’ sullo steso piano dell’uomo assassino’”.
 Il mondo della violenza ed intolleranza occupa uno spazio rilevante nella produzione di Giorgio Sabbatini: ritorna anche in Trasparenze (2008) dove sottolinea che per dimostrare quanto sia grande la crudeltà umana e inefficiente la giustizia, talvolta è bene ritrovare il contatto con la natura, insieme ad amici, per ridimensionare l’affannosa corsa della vita e abbandonarsi ai tempi della “riflessione”, per non dimenticare le ingiustizie e le sofferenze inflitte a popoli oppressi da menti dissennate in cerca del potere assoluto.“ Il potere, continua ancora l’autore, vaga senza soste e le immagini riaffiorano nella memoria con il terrore che tutto possa, un giorno, ripetersi per una strana alchimia di menti rabbiose e animalesche, capaci di creare odio, lontane dalla possibilità di amare ed apprezzare il valore della vita”. Il ritornare alla natura lo ribadisce anche in Paradiso Inferno Paradiso (2009) affermando l’importanza di “Tuffarsi per qualche istante in una natura ancora incontaminata dove potere assaporare quei rumori reali che la foresta sa trasmettere. Il luogo suggerisce una tranquillità insolita e in contrasto con quei pensieri che non ci abbandonano e dai quali vorremmo fuggire, sempre, per non essere costretti a guardare il volto della realtà”.
Il mondo della violenza ed intolleranza occupa uno spazio rilevante nella produzione di Giorgio Sabbatini: ritorna anche in Trasparenze (2008) dove sottolinea che per dimostrare quanto sia grande la crudeltà umana e inefficiente la giustizia, talvolta è bene ritrovare il contatto con la natura, insieme ad amici, per ridimensionare l’affannosa corsa della vita e abbandonarsi ai tempi della “riflessione”, per non dimenticare le ingiustizie e le sofferenze inflitte a popoli oppressi da menti dissennate in cerca del potere assoluto.“ Il potere, continua ancora l’autore, vaga senza soste e le immagini riaffiorano nella memoria con il terrore che tutto possa, un giorno, ripetersi per una strana alchimia di menti rabbiose e animalesche, capaci di creare odio, lontane dalla possibilità di amare ed apprezzare il valore della vita”. Il ritornare alla natura lo ribadisce anche in Paradiso Inferno Paradiso (2009) affermando l’importanza di “Tuffarsi per qualche istante in una natura ancora incontaminata dove potere assaporare quei rumori reali che la foresta sa trasmettere. Il luogo suggerisce una tranquillità insolita e in contrasto con quei pensieri che non ci abbandonano e dai quali vorremmo fuggire, sempre, per non essere costretti a guardare il volto della realtà”.
 Tra i misfatti della Storia, quello dell’Olocausto segna un tragico periodo della storia dell’umanità. Il film La ’memoria’ fonte di libertà (2013) ci porta a riflettere su questa immane tragedia, che Giorgio Sabbatini ci ripropone dopo una visita al ‘Centro Ana Frank’ di Buenos Aires. Il video si avvale di alcuni filmati storici oltre alle poche fotografie della famiglia Frank per ricostruire gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza di Anna, oltre alla cruda testimonianza dell’avvento del nazismo che fu causa della Seconda Guerra Mondiale. Attraverso alcune riflessioni di
Tra i misfatti della Storia, quello dell’Olocausto segna un tragico periodo della storia dell’umanità. Il film La ’memoria’ fonte di libertà (2013) ci porta a riflettere su questa immane tragedia, che Giorgio Sabbatini ci ripropone dopo una visita al ‘Centro Ana Frank’ di Buenos Aires. Il video si avvale di alcuni filmati storici oltre alle poche fotografie della famiglia Frank per ricostruire gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza di Anna, oltre alla cruda testimonianza dell’avvento del nazismo che fu causa della Seconda Guerra Mondiale. Attraverso alcune riflessioni di
Anna, tratte dal suo celebre “Diario”, paure, emozioni, sentimenti e speranze si alternano in un‘atmosfera nella quale la parola “libertà” può appartenere solo al proprio pensiero. Con la straordinaria forza interiore che Anna possiede riesce a cogliere in ogni istante la tragica ”verità” che appare di fronte ai suoi occhi, lasciando attraverso le sue parole la testimonianza di un momento storico dominato dalla malvagità umana. Recensendo questo film ho espresso l’opinione che si tratta di una ricostruzione accurata (…) per sviluppare un racconto storicamente valido che commuove, indigna e induce a non dimenticare. Stigmatizzando anche come ancora oggi altre guerre rinnovano tragedie di immani perdite umane. E sottolineavo, che ancora una volta Giorgio Sabbatini dimostra di conoscere e utilizzare bene il linguaggio del cinema rendendo vive immagini che altrimenti potrebbero risultare statiche.
L’attività di Giorgio Sabbatini si amplia con la realizzazione di numerosi film industriali per qualificati committenti. Ed anche con la collaborazione con un Museo del Cinema prestigioso come quello di Torino, di cui è socio da oltre venticinque anni, per il quale ha curato il restauro di alcune apparecchiature cinematografiche e di alcuni film della Cineteca da essere poi proiettati in occasione di Mostre a Pordenone, Annecy e Parigi. E’ una valida testimonianza del riconoscimento di una professionalità al servizio dell’amato cinema. Una professionalità che Giorgio Sabbatini mette anche al servizio di altri autori, collaborando alla realizzazione dei loro film e che gli consente di esprimere in numerosi Corsi di tecnica cinematografica trasmettendola cosi ad appassionati di Cinema. Permettendo altresì la formazione cinematografica di nuovi talenti. Ed è un merito che gli fa molto onore.
Giorgio Sabbatini poi è molto attivo, cosi come la moglie Vivian Tullio che ha anche realizzato alcuni interessanti cortometraggi, nella FEDIC dove fa parte da anni del Consiglio Direttivo ed ha anche ricoperto dal 2006 al 2008 la carica di Presidente dell’Associazione Montecatini Cinema che organizza, insieme al Comune di Montecatini, il Festival Internazionale del Cortometraggio FilmVideo. Un’attività intensa nel campo del cinema, la sua, che lo impone come uno dei filmmaker più significativi del cinema indipendente italiano.
.
PER UNA CONOSCENZA E VISIBILITÀ DEGLI AUTORI FEDIC
di Roberto Merlino (Presidente FEDIC)
con Elenco delle Puntate dei “Corti di Corte” su DILUCCATV
L’aspettativa principale di chi ha realizzato un cortometraggio è quella di “farlo vedere”! Mi riferisco, ovviamente, a quella marea di cinevideoautori (o videomaker che dir si voglia) appagati non certo dal denaro (non lo fanno di mestiere) ma dalla voglia di raccontare, comunicare, trasmettere emozioni…
Purtroppo le occasioni di “avere un pubblico” non sono molte e, al di là della cerchia di parenti-amici-conoscenti, si aggiungono -ma solo per i più bravi!- alcuni Festival, qualche Rassegna e poco altro ancora.
In un panorama di questo tipo la Federazione Italiana dei Cineclub (FEDIC), che mi onoro di presiedere, ha creato un’opportunità veramente allettante per i suoi Soci, realizzando un accordo di collaborazione con due diverse emittenti televisive: DiLuccaTV (da Tassignano-Lu) e TeleAmbiente (da Roma).
Tutto è cominciato all’inizio del 2012, incontrando Manuele Moriconi, ottimo fotografo e proprietario di DiLuccaTV. Da lì ad entrare in simpatia e collaborare il passo è stato breve: lui ha cominciato a scrivere e realizzare cortometraggi (veramente originali e di qualità), ha partecipato ad un nostro Stage di cinema ed è diventato nostro Socio; al contempo abbiamo progettato e fatto partire “I Corti di Corte”, una trasmissione televisiva settimanale, inaugurata il 7 giugno 2012.
L’obiettivo è quello di creare una sorta di “vetrina” per i film dei Soci FEDIC che sia al contempo anche un “contenitore-archivio”, consultabile in qualunque momento e da qualunque parte del mondo. Ogni puntata, infatti, può essere fruibile in tre diverse maniere: 1) alla televisione, in diretta, sul canale 89 del digitale terrestre (seppur in una zona geografica limitata del territorio nazionale); 2) in streaming, su internet, al sito www.dilucca.it (fruibile ovunque); 3) “on-demand” (in ogni momento, con il link http://www.dilucca.it/listatrasmissioni/approfondimenti/corti-di-corte?start=20, è possibile consultare tutte le puntate realizzate e archiviate).
Ogni nuova puntata, della durata di circa mezzora, va in onda la domenica, in prima serata, e viene replicata il lunedì mattina.
Le modalità per realizzare le differenti puntate sono abbastanza semplici: i Soci FEDIC mi inviano per posta, su dvd, i loro lavori; io li raccolgo, li archivio, faccio degli assemblaggi (in base ai diversi Cineclub di provenienza, alla durata, alle tematiche, ecc.) e poi, ogni due o tre mesi, vado a lavorare coi tecnici della televisione (in particolare con l’eccezionale Marco Stefanini) per preparare 10-15 puntate ogni volta.
Oltre ai “normali” lavori dei Soci, abbiamo trasmesso svariate serie per i giovanissimi, con film realizzati nelle scuole pubbliche (dalle elementari all’università), grazie anche alla collaborazione con FEDIC Scuola. Numerose puntate, inoltre, sono dedicate a film di 40-50-60 anni fa, provenienti dalla Cineteca Nazionale FEDIC e realizzati da Autori “storici” della nostra Federazione.
Tutto questo materiale contribuisce a far conoscere aspetti molto variegati del linguaggio cinematografico non professionistico ed ha, a mio giudizio, un valore storico e didattico molto importante. Come già detto, tutto è visibile -in ogni momento e in qualunque parte del mondo- sul sito www.dilucca.it.
Sulla scia dell’ottimo lavoro con DiLuccaTV, nella primavera dello scorso anno sono stato contattato, per conto di TeleAmbiente, da Salvatore Alù (allora “Responsabile dei Programmi”) e, dal maggio del 2014, i “Corti di Corte” sono sbarcati anche in Lazio, Umbria ed Abruzzo (sul canale 78 del digitale terrestre); da qualche mese anche in Lombardia (sul canale 218 del digitale terrestre). Anche con TeleAmbiente le puntate possono essere viste su internet in diretta streaming (www.teleambiente.it). Per alcuni mesi i film FEDIC sono andati in onda tutti i giorni; ora le puntate dei “Corti di Corte” sono visibili per 5 giorni la settimana.
Altre televisioni ci hanno contattato e non è da escludere che, in futuro, le collaborazioni vengano ulteriormente allargate.
Quel che conta, in concreto, è la visibilità che abbiamo fornito ai film dei nostri Soci, nell’ambito di due emittenti serie e qualificate, con un rapporto stabile nel tempo.
A suffragare la concretezza del progetto c’è l’oggettività dei numeri: oltre 140 puntate su DiLuccaTV, oltre 40 su TeleAmbiente.
PUNTATE DEI “CORTI DI CORTE” SU DILUCCATV
7 giugno 2012 1.a puntata
“Corte Tripoli Cinematografica” di Domenico Zazzara (esterno)
14 giugno 2012 2.a puntata
“Culturalmente Pisa 2011” di Autori vari
21 giugno 2012 3.a puntata
“Rosato installatore di campane”, “Sonia – Acquario di Cattolica” e “Il ladro di biscotti” di Giorgio Ricci (Cineclub Pesaro)
28 giugno 2012 4.a puntata
” Pisa, Donne e Leopardi” di Roberto Merlino
5 luglio 2012 5.a puntata
“Fumo negli occhi” , “Regina della notte” , “Arte” , “Ombre di luna piena” , “Mr Dennis” di Pierantonio Leidi
12 luglio 2012 6.a puntata
“Tre fogli” , “La brioche” , “La finestra” di Giorgio Sabbatini
19 luglio 2012 7.a puntata
Alessandro Baccini (trailer e interviste di “Una ragione per combattere”, film in programmazione)
26 luglio 2012 8.a puntata
“Delirium demens” , “Oltre la porta” di Francesco Giorgi
2 agosto 2012 9.a puntata
“Respirare” , “Tiritera dell’amore di un minuto” , ” Bere troppo
può essere fatale” , “Who’s who?” , “Un fallimento” di Davide Abate
9 agosto 2012 10.a puntata
“Aman Iman”, “Un pettirosso non fa differenza”, “Insegnare la felicità” di Andrea Olindo Bizzarri
16 agosto 2012 11.a puntata
“Un fisico statuario” , “Il miracolo del latte” di Antonio Fabbrini
23 agosto 2012 12.a puntata
“Il vitello grasso” di Roberto Carli (32’)
30 agosto 2012 13.a puntata
CTC 1: “No,…Kuleschiov no!” (13’) “Bon Appetit” (1’) “Raptus collettivo” 1’ “Gnam gnam” (1’) “Blu notte” (10’)
6 settembre 2012 14.a puntata
CTC 2: “Ettore” (9’) “Le baiser” (5’) “Spirali di fumo” (6’40”) “Retone a bocca d’Arno” (7’17”)
20 settembre 2012 15.a puntata
CTC 3: “L’ultimo svedese” (7’30”) “Cesare Borsacchi” (6’) “I sogni nelle mani” (5’) “Rotella a Pisa” (6’15”)
27 settembre 2012 16.a puntata
CTC 4: “Libero” (8’30”) “Giorgio” (12’) “L’eroe mai cantato” (6’)
4 ottobre 2012 17.a puntata
CTC 5: “Fidio” (3’) “La nonna” (6’23”) “Dolce fuggevole
giovinezza” (2’25”) “Fuori onda” (15’)
11 ottobre 2012 18.a puntata
“Prima di dopo” , “La mente” , “Movente” , “Imparate a comportarvi 2” , “Cat” di Marco Rosati
18 ottobre 2012 19.a puntata
“Chi siamo, Videoclub di Brescello fino a 17” “Brixellum Romanorum” (27’33) (Cineclub Brescello)
25 ottobre 2012 20.a puntata
“Innocenze perdute” (13’) “L’uomo dei suoni” (17’) di Francesco Giusiani
1 novembre 2012 21.a puntata
“Donne di sabbia” (29’) di Rita Colantonio
8 novembre 2012 22.a puntata
“Lo sguardo dei bambini” (16’26”) “La lettera scarlatta” (13’30”) di Guido Daidone
15 novembre 2012 23.a puntata
“Buon compleanno, mamma!” (13’) “Così come sono” (20’30”) di Daniele Santonicola
22 Novembre 2012 24.a puntata
“Sono sempre stata Chiara” (5’) “Il nuovo che avanza” (9’08”) “Il maestro di musica” (15’) di Alessandro Daquino
29 novembre 2012 25.a puntata
“Chi siamo, Videoclub di Brescello da 18” fino a 51” “Pictures” (8’16”) “La Palestra” (17’) (Cineclub Brescello)
6 dicembre 2012 26.a puntata
“La notte dei due innamorati” (27’) di Francesco Giusiani
13 dicembre 2012 27.a puntata
“Autointervista” (1’38”), “Arma Micidiale” (20’28”), “Una Preda
stupefacente” (2’19”), “Il trucco” (2’18”) (3D Production)
20 dicembre 2012 28.a puntata
“Radio audience” (35’) di Raffaele Totaro
27 dicembre 2012 29.a puntata
“Rumori dalla memoria” (29’) di Agostino Vincenzi
3 gennaio 2013 30.a puntata
1.a puntata didattica “Back Stage Caimi” (32’33”)
10 gennaio 2013 31.a puntata
“Autointervista”, “Io credo” (5’), “Achille Ginnetti” (15’17”), “Il domatore di serpenti” (8’) di Giorgio Ricci
17 gennaio 2013 32.a puntata
“Intrusion” (15’32”), “Giorni perduti” (14’11”) di Guido Daidone
24 gennaio 2013 33.a puntata
“Trasparenze” (10’30”) di Giorgio Sabbatini
“Agnese” (22’) di Guido Daidone
31 gennaio 2013 34.a puntata
“Selciati” (3’33”) di Giorgio Sabbatini “Beyond Perception” (12’40”) di Alessio Biagioni, “Persone” (11’20”) di Roberto Merlino
7 febbraio 2013 35.a puntata
“Presentazione” (6’22”), “Tre leggende di Istanbul” (16’25”), “Amantea bombardata” (8’20”), “Milleduecento circa” (2’), “Alice, una storia infelice” (3’20”) di Claudio Metallo
14 febbraio 2013 36.a puntata
“Chi siamo”, Videoclub di Brescello da 52” fino a 1’11”, “Brescello il paese di don Camillo e Peppone” (12’), “One day in Brescello” (23’30”) (videoCLUB Brescello)
21 febbraio 2013 37.a puntata
“L’altro lato della strada” (19’) di Agostino Vincenzi, “Chiattestein” (10’04”) 3D Production
28 febbraio 2013 38.a puntata
“Precontinente II” (9’), “Gloria e Jenny” (4’), “Poesie per Chiara” (15’35”) di Giorgio Ricci
7 marzo 2013 39.a puntata
2.a Puntata didattica Back Stage Ferlito e film “L’altro” (27’37”)
14 marzo 2013 40.a puntata
3.a puntata didattica Back Stage Benvenuti, Bertola e film “The contact” (26’)
21 marzo 2013 41.a puntata
“Memorie dal sottosuolo” (28’40’’) di Nicola Raffaetà
28 marzo 2013 42.a puntata
Lauro Crociani: “Allegro alloro” (8’25’’), “Battisti è Battisti” (8’), “Amare, signore” (1’), “Ri-ciclo sospetto” (3’), “Pietro Carbonetti, vagabondaggio” (12’36’’)
4 Aprile 2013 43.a puntata
“Un bicchiere a metà” (23’) di A. Tosi, “Fidio” (3’) di Hulya Oren
11 Aprile 2013 44.a puntata
Cineclub Montecatini “Il sogno della vita” (4’40’’) di Roberta Mucci e Marco Esposito, “La belle epoque” (7’27’’) di Marco Esposito, “Raduno Nazionale delle Harley Davison” (7’04’’), di Giancarlo Previato, “Golf Trofeo città di Montecatini” (12’20’’) di Giancarlo Previato.
18 Aprile 2013 45.a puntata
“Anno zero” (25’23’’) di Nicola Raffaetà
25 Aprile 2013 46.a puntata
“Orgoglio e sensualità” (26’) di Alessio Biagioni
2 Maggio 2013 47.a puntata
“La strada” di Chiara Pontuali e Benjamin Sougne (34’22’’)
9 Maggio 2013 48.a puntata
“O mio prometeo!” (18’), “I sette dormienti” (19’) di L. Serasini
16 Maggio 2013 49.a puntata
“Just a tape” (14’31”), “Mr. Love” (10’26”), “No Mercy” (6’51”) di Alberto Antonini
23 Maggio 2013 50.a puntata
“Il rifugio” (1’16’’), “No birds” (3’), “Bruciata w!” (9’40’’), “Buonanotte” (2’18’’), “D’uomo” (6’40’’), “Dì ferita” (7’) di Marco Rosati.
30 Maggio 2013 51.a puntata
“Enigma club” (37’20’’) di Francesco Giusiani
6 Giugno 2013 52.a puntata
“Ab fonte di vita” (25’) di Nicola Raffaetà
13 giugno 53.a puntata
“Way of life” (’10), “Apples” (8’), “Mala Tempora” (8’), “Replay” (2’) di Rolf Mandolesi
20 giugno 54.a puntata
“Il resto di niente” (6’08”), “Homo faber” (12’25”) di Raffaele Totaro; “Albarella” (8’46”) di Marco Rosati; “ Lui non ci sarà” (3’10’’) di Alessio Biagioni.
27 giugno 55.a puntata
“Primaria e fatale” (6’) di Stefano Terraglia; “Il luogo dell’anima” (8’), “Ginevra” (10’), “Il profumo dei fiori” (5’) di Jacopo Mancini
4 luglio 56.a puntata
Back-Stage 9° Stage Nazionale FEDIC: La Sceneggiatura (12’15”); 3 Corti Toscana 2012 (21’22” in tutto): “Il naif dei fiammiferi”, “Saharawi a Cascina”, Backstage “Workshop Crocé”, Montecatini e il Cinema
11 luglio 57.a puntata
“Vicine” (’23), “L’unico saggio” (’7) di Rolf Mandolesi
18 luglio 58.a puntata
“Visitazione” (1958, 18’08”) di Piero Livi; “Il maestro” (9’20”) di Roberto Merlino
25 luglio 59.a puntata
“Reikajeski” (7’) autori vari; “Un ragazzo sfortunato” (12’) di Roberto Merlino; “L’inizio della fine” (12’) di Laura Biggi
1 agosto 60.a puntata
“L’eterna partita” (27’) di Nicolò Trunfio
.
.
.
.
.
9 agosto 61a puntata (slittata dall’ 8 al 9)
“Duemilaeunanotte” (’9), “Cake” (’14), “Uomini” (’7) di Rolf Mandolesi
15 agosto 62.a puntata
4° Stage Nazionale Fedic: Backstage “Sceneggiatura per esperti” (17’22”); 5° Stage Nazionale Fedic: Backstage “Facciamo un film” 14’45”; di Roberto Merlino
22 agosto 63.a puntata
“Fauci di belva” (9’), “L’Uomo nello specchio” (3’), “Windows” (6’), “Il neologismo che uccide” (10’) di Nicolò Trunfio
.
29 agosto 64.a puntata
“Sala d’attesa” (’10), “Nero su bianco” (10’), “Circuito chiuso” (10’) di Rolf Mandolesi
5 settembre 65.a puntata
Cineamatori delle Apuane: “La scuola dei mostri” (12’25”), “Il tesoro nascosto” (14’08”)
12 settembre 66.a puntata
Gabriella Vecchi: “Gli anni della polvere” (5’01”), “Finestra di dialogo” (6’04”), “Le stelle di Antonella” (5’40”), “L’albero di meloni” (5’55”), “Sinfonia in verde” (3’53”)
19 settembre 67.a puntata
“Una storia sarda” (1962, 34’20”) di Piero Livi
26 settembre 68.a puntata
di Antonio Di Palo: “I bambini hanno gli occhi” (20’)
di Paola Bruno: “The deaf Ring” (6’10”), “Verso una vita vera” (3’21”)
2 ottobre 69.a puntata
Cineamatori delle Apuane: “Dove ti porta la vita?” (5’40”), “Pioggia d’inverno” (3’37”), “Il mistero della IIIB” (19’18”)
9 ottobre 70.a puntata
di Andrea Olindo Bizzarri “B-S sul 9° Stage-Scarpelli” (6’)
“Persistenza delitto al Mauriziano” (9’) videoCLUB Brescello
“Un gioco da ragazzi” (13’) videoCLUB Brescello
16 ottobre 71.a puntata
“Marco del mare” (17’), “Il faro” (16’40”) di Piero Livi
23 ottobre 72.a puntata
Roberto Merlino: “Cassio” (8’38”); Marco Rosati: “Figlia” (4’), “Fra il tempo un torpore” (10’), “Bruciata w!” (5’20”)
30 ottobre 73.a puntata
Gabriella Vecchi: “Lezione di tai-chi” (5’39”), “Un giorno da cani” (5’40”), “La fine del mondo” (4’(
Cineamatori della Apuane: “Una biblioteca da salvare” (11’)
6 novembre 74.a puntata
Cinema delle scuole: “Bob il pipistrello” (3’22”), “Il paese del sorriso” (4’04”), “Elmer the sad elephant” (4’58”), “Goccialina” (2’35”), “Che idea!!!” (3’52”), “Biofuturo” (2’08”)
13 novembre 75.a puntata
Daniele Riccioni: “La giostra” (12’20”), “Innamorati fritti” (14’30”)
20 novembre 76.a puntata
Cinema delle scuole: “I problemi della vita” (7’50”), “Sarzana la mia città” (9’03”), “Tra storia e leggenda” (10’06”), “Mettiamoci daccordo” (3’29”)
27 novembre 77.a puntata
Lorenzo Bianchi Ballano: “Una vita dedicata al Cinema” (15’30”),
Sauro Benvenuti: “Le ultime parole famose” (13’04”)
4 dicembre 78.a puntata
Luigi Mezzacappa: “Amo esta isla” (29’24”)
11 dicembre 79.a puntata
Beppe Rizzo: Warum? (5’), “Per non dimenticare” (13’40”), “Ligustro” (9’)
18 dicembre 80.a puntata
Valerio Cibrario: “E se tutto non finisse…” (11’10”)
Roberto Merlino: “Newton?” (5’23”); AA vari:“Intervalli di confidenza” (4’26”); Andrea Olindo Bizzarri: “Impressioni oniriche” (4’11”), “Odio alma irata” (3’45”);
25 dicembre 81.a puntata
Cinema delle scuole: “Intervista a Cecino” (3’06”), “Pozzo dei ricordi” (2’53”), “Arianna e Gedeone” (4’28”), “Nel paese dei millegusti” (4’15”),
“La paura” (5’20”)
1 gennaio 2014 82.a puntata
Cinema delle scuole: “L’avventura di Gigetto e Nocciolina” (5’57”), “La leggenda del polpo campanaro” (5’24”), “Che pulizia con una magia!” (2’44”), “Don Chisciotte” (3’06”), “Giannino all’ospedale” (2’17”), “Il mio corpo è il mio corpo!” (2’36”), “Insieme è meglio” (2’41”)
8 gennaio 2014 83.a puntata
Giorgio Sabbatini: “Inquietudini” (6’30”),
Vivian Tullio: “Colori d’Italia” (7’35”),
Luigi Mezzacappa: “Per fortuna non è malato” (14’34”)
16 gennaio 2014 84.a puntata
Cinema delle scuole: “W la frutta” (3’16”), “I gatti” (2’32”), “Colori in rima” (3’04”), “Pippi il pipistrello” (5’45”), “Lola la balena dal fiocco viola” (4’30”), “Fatina spazzolina” (2’18”), “Animali da salvare” (3’02”),
22 gennaio 2014 85.a puntata
Daniele Riccioni: “Vivere” (4’30”), “Costanza” (17’54”),
Manuele Moriconi: “Rapiti” (1’)
Susanne Ratschiller: “Meet you all the way…” (3’30”)
29 gennaio 2014 86.a puntata
Marco Conte: “Il divino spuntino” (36’27”)
5 febbraio 2014 87.a puntata
Luigi Mezzacappa: “Soy Cuba, solo una stranissima storia” (22’18”),
“Lungo la strada” (5’18”)
12 febbraio 2014 88.a puntata
Cinema delle scuole: “Girotondo” (1’39”), “Storia di un chicco di grano” (2’46”), “Il regno di Mangiastrano” (5’57”), “Virgilio il coniglio” (3’58”), “Germ il dolce… inventore” (3’42”), “Le storie di Anansi” (10’58”)
19 febbraio 2014 89.a puntata
Luigi Mezzacappa: “Fammi sognare” (16’45”)
Luigi Mezzacappa: “Un salto nella vita” (10’50”)
26 febbraio 2014 90.a
Cinema delle scuole: “La nostra leggenda del giorno e della notte” (3’40”), “I problemi della vita” (7’50”), “Cambia che ti cambia” (3’48”), “Antoshka e i fiori dell’amicizia” (1’41”), “Aria di paese” (3’48”), “Avventura a Boscorosso” (3’27”), “La TV è buona o cattiva?” (3’28”), “Tu… possibile polpetta!” (3’)
5 marzo 2014 91.a
Beppe Rizzo: “’A livella” (‘9), “Incontro” (‘3), “Alfred (il re del brivido si confessa)” (15’)
.
.
.
.
.
12 marzo 2014 92.a
1.a puntata x Concorso Critica
“Delitto passional” di Nicolò Zaccarini (32’30”)
19 marzo 2014 93.a
2.a puntata x Concorso Critica
“La memoria fonte di libertà” di Giorgio Sabbatini (21’25”)
“E se tutto non finisse” di Valerio Cibrario (11’10”)
.
26 marzo 2014 94.a
3.a puntata x Concorso Critica
“Rescue me” di Franco Valtellina (3’40”)
“Nowhere” di Davide Abate e Enrico Caroti Ghelli (4’51”)
“Cose vere” di Lorenzo Caravello (3’18”)
“Blue lady” di Gabriella Vecchi (6’30”)
“La frenetica Londra” di Giorgio Savio (4’40”)
“Vendetta” di Andrea Lato (6’30”)
2 aprile 2014 95.a
4.a puntata x Concorso Critica
“Questa valle è la nostra valle” di Luigi Mezzacappa (5’44”)
“Una promessa è una promessa” di Massimo Alborghetti (7’30”)
“Contrasti” di Giuseppe Leto (8’00”)
“Craco” di Giuliano Iemmi (2’33”)
“Laboratorio cinema scuola materna” di Laura Biggi (4’44”)
9 aprile 2014 96.a
Pio Bruno “Tourada” (35’24”)
16 aprile 2014 97.a
Cinema delle scuole: “Pinco dottoricchio” (4’46”), “Rirì e la sua casa” (2’43”), “Le avventure di Alice” (2’45”), : “Pierino e il lupo” (18’07”)
23 aprile 2014 98.a
Piero Livi: “Moto Uta – L’isola lontana” (44’50”)
30 aprile 2014 99.a
Luigi Mezzacappa: “Il mio testamento” (20’47”), “Torino una storia diversa” (10’40”)
7 maggio 2014 100.a
1° videogiornale FEDIC 2013 (67’)
14 maggio 2014 101.a
Pio Bruno: “Era uma vez uma malandreca” (8’15”)
Franca Todde: “Lai’ssan”( 7’50”)
Rita Rozzo e Mariangela Onni: “Il profumo del nuovo fiore” (9’26”)
21 maggio 2014 102.a
Beppe Rizzo: “Il sipario magico di Emanuele Luzzati” (6’39”), “Gibba nella città di cartone” (20’)
28 maggio 2014 103.a
Tore Ximenes “Fragu of Manhattan 3” (55’10”)
4 giugno 2014 104.a
“Rapiti” di Manuele Moriconi (1’)
“Una visita inattesa” di Roberto Merlino (1’)
“21:21” di Alessandro Brucini (1’)
“Una visita inattesa” di Manuele Moriconi (1’)
“Vuoto a perdere” di Gigi Corsetti (1’)
“Vuoto a perdere” di Stefano Vannelli (1’)
Giorgio Ricci: “10° Stage Nazionale FEDIC” (20’35”)
.
.
.
.
.
.
.
.
11 giugno 2014 105.a
Vecchia FEDIC:
“Il cieco” di Fiorentino e Gorruso CC Avellino (1956, 4’)
“Il violino portentoso” di G. Parenti CC Siena (1955, 16’)
“Un giorno” di N. Rizzotti CC Milano (10’)
18 giugno 2014 106.a
“Il trenino dello zio diritto” (8’50”), “AAA Aria autentica cercasi” (2’48”); “La leggenda del marmo bianco” di Angelo Abate (17’32”)
25 giugno 2014 107.a
Vecchia FEDIC:
“Venezia e le morte stagioni” di G.Vianello CC. Venezia (1967,14’)
“Città come me” di Giansiracusa/Rigo CC Milano (1965, 15’15”)
2 luglio 2014 108.a
“Segni dell’anima” di Paolo Fantini CC ISCA MI (21’15”)
“Energia” di Paolo Fantini CC ISCA MI (1’20”)
“Fluxus” di Paolo Fantini CC ISCA MI (1’02”)
“Silenzi” di Paolo Fantini CC ISCA MI (3’14”)
“GPS” di Paolo Fantini CC ISCA MI (1’)
9 luglio 2014 109.a
Vecchia FEDIC:
“Caprera” di Bernagozzi e Bugané CC Bologna (1970, 13’33”)
“Caso difficile” di N. Rizzotti CC Milano (1968, 13’)
16 luglio 2014 110.a
“La discesa” di Alessio Biagioni (19’06”)
“Red” di Marco Rosati (5’30”)
“Il serpente del Nilo” di Franco Valtellina (3’40”)
23 luglio 2014 111.a
Vecchia FEDIC:
“Natale fra noi, poi in Sicilia dallo zio Salvatore” di Rigo/Rigo CC Milano (34’)
30 luglio 2014 112.a
“Italia Italia” di Daniele Riccioni (2’)
Luigi Mezzacappa: “Un altro mondo” (15’50”)
6 agosto 2014 113.a
Vecchia FEDIC:
“Nel bosco” di F.Farneti e M.Sordi CC Livorno (1952, 13’)
“Fin de siecle” di G. Parenti CC Siena (1966, 12’)
13 agosto 2014 114.a
Vecchia FEDIC:
“Risveglio” di G. Parenti, CC Siena (1958, 10’)
“Le sirene” di G. Carraresi, CC Milano (1955, 16’)
20 agosto 2014 115.a
Vecchia FEDIC:
“Armonie” di F.Farneti e M.Sordi CC Livorno )1962, 12’)
“Racconto di un pomeriggio” di C. Corti CC Milano (1952, 14’)
27 agosto 2014 116.a
Vecchia FEDIC:
“Incantesimo di mezzogiorno” di Candiolo/Moreschi/Porre, CC. Sanremo (1957, 9’)
“Angela” di L. Frollo e S. Fenzo CC Venezia (1965, 11’22”)
“Maldoror: ieri… oggi” di Micheli/Parenti CC Siena (1963, 11’)
3 settembre 2014 117.a
“Magic moment” di Marco Esposito (30’19”)
10 settembre 2014 118.a
Vecchia FEDIC:
“Nazarè eterno oceano” di E. Ferettini CC Roma (1968, 25’)
17 settembre 2014 119.a
“Odessa adesso” di Paolo Fantini CC ISCA Milano (4’20”)
“Le voci umane” di Stefano Dei CTC Pisa (23’24”)
24 settembre 2014 120.a
Vecchia FEDIC:
“La corsia” di Luigi Mochi CC Montecatini (1965, 11’26”)
“Andare” di Paolo Capoferri CC Bergamo (1967, 17’)
1 ottobre 2014 121.a
“Biglietti da visita” di Rolf Mandolesi (18’)
“La luminara” di R. Merlino (6’)
“Appuntamento al buio” di N. Trunfio (6’)
8 ottobre 2014 122.a
Vecchia FEDIC:
“La volpe” di Barzizza/Porre/Moreschi CC Sanremo (1954, 20’)
“Sette minuti” di P. Capoferri CC Bergamo (1959, 9’)
15 ottobre 2014 123.a
“Aldo Gastaldi (Bisagno)” di M. Ciampolini/C. Serra/E. Turati, CC Fotovideo Genova, (30’)
22 ottobre 2014 124.a
Vecchia FEDIC:
“Francesco Dell’amore” di N. De Rinaldo CC Napoli (1965, 14’)
“O. P. 67” di L. Mochi CC Montecatini (1967, 14’)
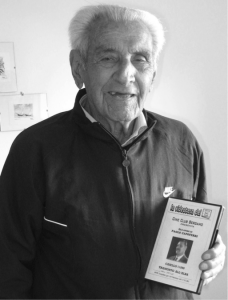
125 Il protagonista di Casello 11090 di Paolo Capoferri (1960) intervistato da Pierantonio Leidi in Casello 11090 52 anni dopo
2 novembre 2014 125.a
“Casello 11090” di Paolo Capoferri (1960, 7’40”)
“Casello 11090 52 anni dopo” di Pierantonio Leidi (7’20”)
“La vendetta” di Manuele Moriconi (1’)
“Giornata mondiale del libro a Pisa” di R. Merlino (12’25”
9 novembre 2014 126.a
Vecchia FEDIC:
“Ecce lignum” di P. Capoferri CC Bergamo (1957,19’)
“La strada di sabbia” di C. Ceccarelli CC Massarosa (1964, 11’)
16 novembre 2014 127.a
“Torna domani” di Marco Rosati (2’30”)
“Once upon a time in Summer 2010” di Tore Ximenes (5’47”)
“Il rospo” di Beppe Rizzo (5’50”)
“XI Stage Nazionale FEDIC” di Giorgio Ricci (12’35”)
23 novembre 2014 128.a
Vecchia FEDIC:
“L’Italia s’è destra” di Calvini/Moreschi CC Sanremo (1972, 20’)
“Nein” di Bernagozzi/Buganè CC Bologna (1965, 10’)
30 novembre 2014 129.a
“Solitudine inerte” di Valerio Cibrario (12’30”)
“Attività 2013 Cinevideo Club Bergamo” di Pierantonio Leidi (15’56”)
7 dicembre 2014 130.a
Vecchia FEDIC:
“Anna” di Rolandi/Cardellini CC Regina Margherita (1967, 20’)
“Un uomo sbagliato” di Nedo Zanotti (1967, 10’)
14 dicembre 2014 131.a
“Andata al Calvario” di Giovanni Meola (20’)
“Bambini d’Italia” di Paolo Fantini CC ISCA MI (9’)
21 dicembre 2014 132.a
Vecchia FEDIC:
“Lettera a mia figlia” di Nino Rizzotti CC Milano (1971, 13’54”)
“Due amiche” di Sandro Roggero CC Sanremo (1967, 16’07”)
28 dicembre 2014 133.a
Vecchia FEDIC:
“L’attesa” di Costantino Ruggiu CC Sassari (1962, 14’30”)
“Ragazze che dipingono un muro” di Leone Frollo CC. Venezia (1970, 11’35”)
4 gennaio 2015 134.a
Vecchia FEDIC:
“Tapum – Storia delle armi” di Bruno Bozzetto (1954, 11’30”)
“Photo shock 68” di G. Montemezzi CC Verona (1969, 16’)
11 gennaio 2015 135.a
Vecchia FEDIC:
“Domenica sera” di Franco Piavoli CC Brescia (1962, 12’)
“Italicus” di Bernagozzi/Buganè/Zambon (15’15”)
18 gennaio 2015 136.a
“42,195” di Paolo Fantini CC. ISCA MI (11’)
“Flexus +” di Paolo Fantini CC. ISCA MI (1’30”)
“Uomo in mare” di Antonella Santarelli CC CTC Pisa (17’)
25 gennaio 2015 137.a
Vecchia FEDIC:
“Le avventure dell’altro io” di Candiolo/Moreschi, Cineclub Sanremo (1955, 18’30”)
“Nozze d’argento” di Sani/Pecora, Cineclub Ferrara (1956, 12)’
1 febbraio 2015 138.a
Rosanna Molinatti, Cineclub Venezia:
“Convivenze” (2006, 9’)
“Caleidoscopio” (2006, 9’)
“Mio zio Oscar Marziali” (1998, 9’50”)
8 febbraio 2015 139.a
Vecchia FEDIC:
“I cavatori” di Giannini/Tarabella, Cineclub Pietrasanta (1961, 14’38”)
“Nel quadro” di Luigi Nucci, Cineclub Firenze (1963, 14’54”)
15 febbraio 2015 140.a
Antonio Fabbrini, Cineclub San Giovanni Valdarno:
“Comida frugal” (3’10”)
“Dummy dietro le quinte” (8’50”)
“Fermate Superman!” (18’25”)
22 febbraio 2015 141.a
Vecchia FEDIC:
“Fiera minore” di Oliviero Sandrini (1954, 11’34”)
“Camera ammobiliata” di Corrado Farina (11’)
“S.685” di Bonfante (1963, 7’)
1 marzo 2015 142.a
“Sulle tracce di Antiglia” di Antonella Santarelli, Cineclub Corte Tripoli Pisa (13’26”)
“Resto in piedi” di Salvatore Siragusa, Cineclub Alassio (4’30”)
“Trentamenosei” di Andrea Mugnai, CC. San Giovanni Valdarno (7’46”)
“Zucchero” di Paolo Fantini e Maricla Tagliaferri CC. ISCA MI (3’)
“Viceversa” di Paolo Fantini CC. ISCA MI (1’25”)
8 marzo 2015 143.a Vecchia FEDIC:
“Claudio… un amico” di Vincenzo Rigo, Cineclub Milano (1970, 12’)
“Anna e il divo” di Calvini/Lorenzelli/Candiolo/Moreschi, Cineclub Sanremo (1962, 11’46”)
“Quaranta cavalli e un cane”, di Carletto Manzoni (1950, 5’45”)
15 marzo 2015 144.a
“Cinespazio” di Stefano Dei, Cineclub Corte Tripoli Pisa (8’20”)
“Non gettate alcun oggetto dal finestrino”, di Guido Daidone, Cineclub Sassari (11’)
“Il pittore delle marine” di Roberto Merlino, CC Corte Tripoli Cinematografica Pisa (4’20”)
“Cena per sette” di Vivian Tullio, CC Piemonte TO (5’50”)
.
22 marzo 2015 145.a
Vecchia FEDIC:
“Emigranti” di Franco Piavoli, Cineclub Brescia (1963, 11’36”)
“Il cero” di Giuseppe Fina, Cineclub Milano (1955, 11’15”)
“Pietà per i deboli” di Luigi Nucci, CC. Firenze (1964, 7’16”)
29 marzo 2015 146.a
“Nascita di una chiglia” (Il Bucintoro del Terzo Millennio) di Rossana Molinatti, CC. Venezia (23’53”)
“Mancavi solo tu” di Lorenzo Caravello, CC. Cineamatori delle Apuane (MS) (6’)
5 aprile 2015 147.a
Vecchia FEDIC:
“Responsabilmente, oggi” di Mino Crocé, CC. Casale (1970, 29’)
12 aprile 2015 148.a
“La mia notte” di Claudio Venanzini, CC Pesaro (10’30”)
“Il giardino dei giusti” di Giorgio Ricci, CC Pesaro (16’49”)
“Versus” di Paolo Fantini, CC. ISCA MI (35”)
19 aprile 2015 149.a
Vecchia FEDIC:
“Milano 70” di Luigi Santagostino, CC. Milano (1969, 19’30”)
“Hitler… lo conosco” di Parenti/Micheli, CC. Viareggio (1964, 10’15”)
26 aprile 2015 150.a
“Musica e immagini sotto le stelle” di Marco Esposito, CC Montecatini (33’48”)
.
E in seguito …

Lezione del regista Francesco Giusiani, dal corto 1. a Festa del Cinema Corto (avrete la possibilità di vederlo nella 156a puntata)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
FESTIVAL ED EVENTI
QUO VADIS, DOC ? di Maria Pia Cinelli
Il film documentario sperimenta sempre più nuove forme, anche a rischio d’identità. Mantenere intatto il principio di fondo resta comunque un presupposto irrinunciabile per il genere , come ci insegnano tre nuovi lungometraggi di portata internazionale.
Al termine ‘genere cinematografico’ si sente sempre più legare il concetto di obsolescenza o di artificiosità e in particolare l’asserzione che di film tout-court si debba parlare non nega mai la sua comparsa qualora entri in ballo il documentario.
In effetti il cinema del reale registra negli ultimi anni notevoli sconfinamenti, con la confluenza di prodotti spuri ad alto tasso di contaminazione, così come opere intrinsecamente a soggetto (ascrivibili a una sorta di ‘neo-neorealismo’) alle quali il minor impegno economico-strutturale della categoria permette comunque di venire alla luce. Anche dal punto di vista formale l’ibridazione è più evidente qui che altrove, unitamente all’aspirazione a una cifra autoriale, alimentata si presume dalla necessità di smarcarsi dall’anarchia estetica di massa figlia della deriva imagorroica del mondo 2.0.
Di conseguenza questo settore sta inglobando di tutto e di più, dal reportage canonico alla video-arte, tanto che, per dirla con il regista Isaki Lacuesta[1], ora come ora ‘Il documentario è come uno zoo dove abitano tutti gli animali più strani che ancora non si sa se siano mammiferi o rettili. Al momento sono come l’ornitorinco di Kant.’ [2]
Una nuova poetica si fa dunque strada, abbattendo i paletti aristotelici a colpi di codici rubati all’animazione, al mélo, alla commedia, al thriller, al film astratto e al film d’arte e così via, consentendo un non disprezzabile incremento numerico e distributivo del cinema del reale, con opere mutanti e ambiziose, anche se non mancano i risvolti negativi, quali una certa inclinazione estetizzante dove non ve ne è alcun bisogno e costanti stilistiche talmente abusate da perdere valenza significativa – un esempio su tutti: primi piani di volti immobili e muti montati in sequenza, spesso in bianco e nero, ormai assurti a figura retorica così comune da risultare un cliché quasi fastidioso – che danno luogo a una specie di format ‘d’autore’ alquanto spersonalizzato.
Ben lungi dal non considerarlo uno sviluppo positivo e concordando sulla difficoltà di ricondurre un prodotto filmico entro un recinto stabilito – seppur di comodo – non si può tuttavia non intravedere in questa metamorfosi il rischio che la natura originaria di per sé nobile del documentario venga in un certo qual modo svilita, deprezzata, o per meglio dire se questi debba per forza vestire panni altrui per acquisire la cittadinanza di film ed essere assimilato da una platea più vasta.
Niente a che vedere con un’ipotetica purezza da salvaguardare, né con il concetto di ‘realtà’ (se il racconto di finzione, cinematografico e non, grazie a un maggior potere di immedesimazione faciliti un accesso più diretto al racconto, o se il senso ultimo delle cose emerga più da una ripresa senza filtro o da una sofisticata messa in scena sono questioni che esulano dal contesto). Tanto meno entra in causa l’avvalersi di codici altri in maniera funzionale al discorso e legittimato dall’oggetto, bensì l’accento si pone sui film – in sé apprezzabili – la cui la derivazione finzionale, astratta o quant’altro è organica e predominante, tanto da offuscare se non cancellare l’aspetto documentario.
Pertanto accogliamo con piacere il palmarès del 55° Festival dei Popoli (Firenze, 28-11 / 05-12, 2014), contraddistinto da opere che di tale aspetto fanno invece l’asse portante, seppur declinato in modi differenti.
Miglior lungometraggio è stato infatti eletto Maidan [3] di Sergei Loznitsa[4] – già negli Eventi Speciali di Cannes – incentrato sul noto movimento popolare sorto in Ucraina in seguito alla decisione del premier filo-russo Viktor Yanukovych di ricusare gli accordi con l’Europa, che ha avuto come teatro la Maidan Nezalezhnosti (Piazza Indipendenza) di Kiev. Raccontando gli eventi succedutisi dal dicembre 2013 al febbraio 2014 il documentario registra l’escalation da protesta pacifica a rivolta a insurrezione, senza una posizione apparente, sebbene l’orgoglio ucraino sia palese e il negarsi dell’autore alla stampa russa a Cannes piuttosto indicativo.
L’intento non è di scavare sui perché o riempire i vuoti d’informazione, ma di ancorare la fruizione a un punto di vista universale su un evento collettivo globale, per mezzo di una precisa e rigorosa scelta registica: solo piani fissi in campo lungo (con l’eccezione di un singolo zoom), nessuna voce di commento, né materiale di repertorio, né interviste, né storie individuali che sovrastino l’insieme, solo poche didascalie a informare degli avvenimenti politici, ottima qualità audiovisiva lontana dalla sciatteria dei tanti contributi estemporanei di simili frangenti.
E, naturalmente, il popolo. Protagonista assoluto, spesso retorico, corpus attoriale inconsapevole a riempire totalmente l’inquadratura iniziale mentre intona commosso l’inno nazionale, osservato in focale corta nei comizi, nella scuola adibita a cucina da campo, sui palchi insieme a poeti e religiosi, mentre manifesta pacifico, canta Chervona Ruta [5] o invita il premier a dimettersi parodiando la nostra Bella Ciao (‘Ciao Vitya ciao ...’). Quando il clima cambia, l’obiettivo si alza per meglio abbracciare i primi disordini, le barricate, l’arrivo della polizia, le maschere antigas, gli scontri a fuoco. Un vero e proprio scenario di guerra, con appelli ai medici per curare i feriti, le veglie funebri nel buio ancora pregno di fumo e le richieste di aiuto per le famiglie dei caduti, al grido di ‘Heroes never die!’.
Una forma pura di documentario che trasforma un particolare accadimento in simbolo universale di rivolta dall’afflato epico, che non chiarisce la crisi geopolitica fra l’aspirazione euro-asiatica di Putin e gli interessi occidentali né l’entità del dissenso a livello nazionale, ma che fornisce un’esperienza filmica paradigmatica del processo d’identificazione primaria dello sguardo dello spettatore con l’obiettivo della macchina da presa, imprescindibile affinché una sequenza di fotogrammi colpiti dalla luce diano luogo alla visione cinematografica[6].
E’ ancora l’osservazione alla base di Toto and his sisters [7] di Alexander Nanau [8] – premio del pubblico di MyMovies – dalle parti del Bildungsroman: una spacciatrice nel penitenziario di Targsor che si vede aumentare la pena per l’incapacità di migliorarsi e socializzare; tre figli di 17, 15, 10 anni con un padre all’estero, in teoria affidati agli zii spacciatori tossicodipendenti ma in pratica abbandonati a se stessi; tutt’intorno lo squallore dei quartieri fatiscenti della Bucarest periferica, simbolo della disfatta sociale di un paese a un quarto di secolo dalla caduta di Ceausescu, dove “in carcere si mangia tre volte al giorno e al mattino con burro e marmellata, qui mai”.
Anche in questo caso, nel seguire per 15 mesi i tre giovani, ai quali Nanau affida il compito di auto-rappresentarsi con una piccola videocamera inserendo il loro girato in varie scene, il regista sceglie di non intervenire, colloca però il punto di vista molto vicino all’ – per non dire nell’ – oggetto, consentendo di esperire un percorso evolutivo direttamente attraverso l’emozione dei ragazzi, che permea il film in modo fresco e spontaneo. L’obiettivo sempre alla loro altezza nelle visite in carcere o al centro sociale, nel ménage quotidiano in un misero appartamento senz’acqua mentre rassettano, si truccano, giocano, ricevono gli zii, si bucano, ci restituisce non personaggi ma persone, né mostri né eroi, che pur incarnando un topos del degrado mantengono una propria singolarità.
Ana, la maggiore, non sfugge alla tradizione familiare di droga e spaccio, finita in cella ne esce per mancanza di prove, diventa sieropositiva, non trova il coraggio di cambiare. Andreea, la secondogenita, figura portante che si fa carico di una presa di coscienza non scevra da tormenti interiori, inizia un cammino di emancipazione affidandosi a una struttura pubblica e trasferendosi in un orfanotrofio. La segue il fratellino Toto, come lei semi-analfabeta, che non appare abbruttito dalla marginalità e con serenità infantile si appassiona al ballo diventando un piccolo campione di hip-hop. Si intravede la speranza. Poi, dopo anni, la madre lascia il carcere. In treno chiede al bambino se la ama ancora. Lui, allevato dalle sorelle, dice di no. Lei intende riprendersi i figli. Il futuro, ahimé, (non) è scritto.
Il premio Cinemaitaliano.info – CG Home Video per la distribuzione è andato invece a Smokings di Michele Fornasero [9]. Presentato nella sezione Panorama, ripercorre la storia di due self-made men, i fratelli Carlo e Giampaolo Messina i quali, dopo aver iniziato in Russia e Svizzera a inizio millennio un commercio online di sigarette sottocosto grazie a un sistema di tassazione limitato al paese destinatario, vengono citati dalla Philip Morris per 550 milioni di dollari e nel 2004 sono obbligati a chiudere il sito. Con i proventi ricavati nel 2005 mettono su una piccola fabbrica in Svizzera trasferita nel 2007 a Settimo Torinese, la Yesmoke, con una produzione annua intorno ai 10 miliardi di sigarette, trovandosi ben presto in contrasto anche con lo Stato Italiano, che arrivano a citare in giudizio[10].
Strutturato come un classico documentario d’inchiesta con interviste a economisti, funzionari, esponenti di organizzazioni e politici alternate al racconto dei protagonisti, ricorre tuttavia a un registro ironico e leggero e al ritmo incalzante di un gangster movie con echi tarantiniani, offrendo un felice esempio di commistione di generi tradottasi nella forma ideale per rendere fluido e accattivante un materiale di per sé complesso sul sistema economico mondiale.
Uno stile che ben si sposa ai Messina, imprenditori sui generis, una via di mezzo fra bucanieri senza scrupoli e crociati perennemente impegnati in una guerra al ribasso contro la lobby del tabacco, senza motivazioni etiche, spinti solo dal gusto di affossare un mercato in cui le multinazionali fanno il bello e il cattivo tempo in concerto con i vari governi, raggiungendo utili stratosferici (fino al 600%).
Da non sottovalutare l’aspetto informativo del film su questioni di primaria importanza, quali la possibilità di aggiungere additivi senza problemi, visto che gli organi preposti al controllo si concentrano soltanto sulle percentuali di nicotina e catrame. Oppure l’opinabile decisione dell’Italia, che in passato deteneva sul nostro territorio il 95% della produzione, di svendere tutto alle aziende estere con relativa delocalizzazione e perdita di posti di lavoro, lasciando attiva solo la manifattura di Chiaravalle (chi con spirito patriottico acquista solo marche del Belpaese guardi bene i lati del pacchetto). Per non parlare del fatto che le nostre tasse sul tabacco sono fra le più basse al mondo, quindi ogni puntuale ritocco sul prezzo delle bionde a ogni manovra finanziaria finisce con tutta probabilità nelle tasche dei produttori americani.
Tanto basterebbe a tenerci lontani dal vizio. Se la razionalità servisse a qualcosa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[1] nato nel 1975 a Girona (Spagna) in una famiglia di origine basca, autore di installazioni, corti e lungometraggi sospesi tra finzione e non
[2] cfr. “Catalogo Ufficiale Festival dei Popoli”, 2011, pag. 114
[3] produzione Ucraina/Paesi bassi, 2014
[4] nato bielorusso e cresciuto in Ucraina, il regista ha ottenuto visibilità internazionale grazie al Festival de Cannes, dove esordì nel 2010 con Schaste moe (My Joy), primo film di finzione dopo vari documentari, e dove ottenne il premio Fipresci con V tumane (In the fog) nel 2012
[6] canto popolare ucraino molto diffuso, scritto da Volodymyr Ivasyuk nel 1968
[5] ricordiamo inoltre che con identificazione secondaria si intende l’identificazione dello spettatore con il rappresentato o elementi di esso (p.e. un personaggio), cfr. “Estetica del Film”, di J. Aumont/A. Bergala/M. Marie/M. Vernet, Ed. Lindau 1999, pp 182 sgg
[7] tit.orig. Toto si surorile lui, prod. Romania, 2014
[8] nato in Romania ma di origine e formazione tedesca, è salito alla ribalta con The World according to Ion B, insignito di un Emmy Award
[9] torinese, con un passato in campo pubblicitario e cinematografico, ha fondato la casa di produzione Indyca. SmoKings, una coprod. italo/svizzera del 2014, uscirà nelle sale italiane nel febbraio 2015
[10] gli sviluppi della vicenda vedono i due fratelli arrestati il 27-11-2014 e in attesa del processo. L’accusa è di contrabbando di tabacchi lavorati ed evasione fiscale (90 mln di Euro)
.
 HA FESTEGGIATO I VENT’ANNI
HA FESTEGGIATO I VENT’ANNI
IL SAN GIO’ VERONA VIDEO FESTIVAL
di Paolo Micalizzi
Ci tiene Ugo Brusaporco a sottolineare che quello da lui organizzato con il Cineclub Verona e con la fattiva collaborazione, soprattutto, del suo Presidente Michael Benson e di Giuseppe Genovese, è un Festival povero, ma questo, come andiamo constatando da anni, porta gli organizzatori a industriarsi affinchè lo si possa realizzare dignitosamente malgrado non ci siano grandi supporti finanziari. Ed ecco quindi che gli invitati vengono ospitati, grazie alla generosità ed amicizia verso il festival di aziende vinicole del territorio e di enoteche veronesi. Ed è un’ospitalità di stampo familiare, piacevole e squisita come è avvenuto dal 23 al 27 luglio 2014. Gli invitati, soprattutto giurati, sono di anno in anno di varia provenienza, USA, Iran, Giappone, Germania, Spagna, Cina, Francia, oltre che dall’Italia naturalmente, frutto di conoscenze personali del direttore artistico Brusaporco, giornalisti ma anche appassionati cinefili. Un Festival di qualità che non mira al red carpet e che ha luogo nel centro storico di Verona, in una ex chiesa per il concorso lungometraggi e nel cortile del vecchio Tribunale, adiacente alla Piazza dei Signori, per la proiezione dei cortometraggi, vera vocazione del Festival. Il 2014 il San Giò Video Festival, che è nato per iniziativa di Ugo Brusaporco e Carlo Rossi a San Giovanni Lupatoto per trasferirsi successivamente a Verona, ha festeggiato il ventesimo compleanno. E’ stato tra i primi a pretendere lavori soltanto in digitale, comprendendo da subito che era un fenomeno che coinvolgeva creatività, tecnologia e sperimentazione, diventando immediatamente un punto di riferimento in Italia per poter visionare lavori provenienti da moltissime Nazioni. Si sono viste nel tempo opere che raccontano il nostro oggi nel mondo. Il rammarico degli organizzatori è di non poter dare più spazio ai lungometraggi, data la povertà di mezzi con i quali devono fare i conti. Della loro qualità e interesse sono testimonianza per il 2014 quei pochi proiettati tra cui Sangue di Pippo Delbono che è stato giudicato il miglior film o il cinese The Time To Live and The Time To Die del cinese Han Shuai premiato per la miglior regia. Del valore loro e di altre opere in Concorso, sia lungometraggi che cortometraggi, ne dà significative valutazioni il Palmares che viene pubblicato di seguito. Da sottolineare, infine, che la ventesima edizione del Festival aveva come Evento Speciale un Omaggio a Corso Salani, un amico del Festival, un vero talento di regista, scomparso prematuramente, di cui sono stati proiettati due documentari della serie “Ai confini del mondo” che ci portano a scoprire in Chisinau la Moldova, piccolo paese appartato e sconosciuto confinante con la Romania e in Yotvata, entrambi del 2007, la vita del Kibbutz che un’attrice israeliana ha voluto sperimentare per sfuggire alla frenesia metropolitana di Tel Aviv. Ed è stata una scoperta umana e ideologica di grande valore.
Il Palmares
Concorso San Giò in Corto
Giuria presieduta da Cuini Amelio Ortiz e composta da Sirakan Abroyan, Ida Travi, Asal Emami, Andrea Crozzoli, Nino Battaglia, Paolo Micalizzi, Marco Ongaro
Miglior film
Avec le temps (Spagna – 2013) di Iván Díaz Barriuso: “Per aver saputo coniugare con grande senso cinematografico una canzone di forte impatto emozionale con immagini che restituiscono pienamente il sentimento malinconico del tempo che passa”.
Miglior Regia
Clément Tréhin-Lalanne per Aïssa (Francia – 2014): “Partendo da un semplice controllo burocratico di routine, mette a fuoco con precisione ed essenzialità la violenza quotidiana che colpisce le fasce più deboli e meno garantite della società europea”
Miglior Fotografia
Damian Horan per il film In passing (Usa / Canada – 2013) di Alan Miller: “Per aver saputo usare la fotografia in termini narrativi, sottolineando con leggerezza il dramma di un momento estremo: non è mai troppo tardi per innamorarsi”
Miglior Sceneggiatura
Wouter Bongaerts per il suo Mia (Belgio/Olanda – 2013): “La sceneggiatura scolpisce il senso di smarrimento nella frenesia di una grande metropoli senz’anima, e la capacità di ritrovarsi”.
Miglior Interpretazione
Andrea Simonetti attore nel suo Alle corde (Italia – 2013): “Per la sfida vincente di una recita misurata e efficace attorno a un dramma devastante sotto il profilo umano e sociale”.
Miglior Musica
Shoefiti per Zima (Russia – 2013) di Cristina Picchi: “Perché la musica entra nl film come elemento che riesce a legare narrativamente il sottile confine tra la vita e la morte in quei luoghi russi estremi”.
Premio “Nikolai Mikhailovich Borodachev – Gosfilmfond”
Ab Ovo(Polonia – 201) di Anita Kwiatkowska-Naqvi: “Opera che segna un passaggio fondante del’arte dell’immagine”.
Concorso Lungometraggi
Giuria presieduta da Héctor Navarrete con: Cristiana Albertini, Federico Brambilla, Abbas Gharib, Davide Rossi, Simone Villani, Guido Zauli
Miglior Film
Sangue (Italia, Svizzera/2013) di Pippo Delbono: “Per la forza con cui il regista, grande uomo di teatro, con mezzi squisitamente cinematografici declinati nelle forme di una regia fortemente
innovativa coniuga il dolore intimo e personale della perdita della madre con i tempi nei quali vive, simboleggiati nel film dalle rovine struggenti della città de L’Aquila”.
Miglior Regia
Han Shuai per The Time To Live And The Time To Die (Cina / 2012): “Per la grande capacità di intersecare una storia individuale con quella generale della Cina, realizzando con sobrietà e passione una asciuttezza carica di immagini ed emozioni”.
Miglior Interpretazione
Dina Tukubayeva per il film Nagima ( Kazachstan – 2013) di Zhanna Issabayeva: “Per la capacità di esprimere con un’apparente freddezza una sofferenza lacerante e profonda che si esplica in una scelta individuale e catartica, e offre uno sguardo particolare al femminile sulla possibilità di sopravvivenza”
Premio “Nikolai Mikhailovich Borodachev – Gosfilmfond”
Yo Decido, El Tren De La Libertad (Spagna – 2014) del Colectivo de mujeres contra la reforma de la ley del aborto: “Per la capacità innovativa del linguaggio cinematografico in una lotta per la
riaffermazione, mai scontata, dei diritti delle donne nella capacità della loro azione collettiva che è idea antica e anche nuovissima”
Premi Speciali
Premio “Mario Dall’Argine” assegnato dal Cineclub Verona al personaggio internazionale che più si adopera alla diffusione della cultura cinematografica: Nikolai Mikhailovich Borodachev General director of the Russian National Film Foundation (Gosfilmofond): “Per l’opera di conservazione e diffusione dell’Arte Cinematografica condotta con ostinato e fruttuoso amore”
Premi della Giuria Social Club
Giuria composta da amiche e amici del Festival, guidati dal segretario Giuseppe Genovese, con Chiara Bottacini, Marta Covre, Flavia Marani,Maria Suanna Marogna, Simonetta Pellini, Susanna Serafin, Roberto Altichieri, GiampietroArlandi, Maurizio Carmeli, Michele Martocci, Umberto Polazzo, Giovanni Spellini, Giampaolo Veronese
Premio “Solidarietà FEVOSS” per il video carattere sociale
Darovete Na Vlahvite (The gift of the Magi – Bulgaria- 2013) di Ivan Abadiev: “A film that tells how the solidarity for the other starts from oneself. A film that has the ability to describe as an intimate gesture, and individual is a prerequisite for building a deep sense of solidarity”.
Premio “Soave Ways”, del Consorzio per la tutela del Soave e del Consorzio per la tutela del Monte Veronese Dop per il video che meglio esprime la soavità della vita
Pedro Malheur (Francia / Messico – 2013) di Camila Beltrán
Premio “Dino Coltro” al video che meglio esprime i valori della tradizione Very Good Dirt (Canada – 2013) di Catharine Parche: “Attraverso un uso sapiente della fotografia sa proporre una valorizzazione del territorio e delle tradizioni aperte al cambiamento”.
Premio “Logan” al video che meglio esprime l’eleganza delle immagini in movimento
Avec le temps (Spagna – 2013) di Iván Díaz Barriuso
.
OCCHIO CRITICO
COME PUÒ UN GIOVANE ESSERE FAVOLOSO?
di Rita Castaldi
Il titolo dell’ultimo film di Mario Martone, su indicazione esplicita dell’autore, è tratto da un testo di Anna Maria Ortese, “Pellegrinaggio alla tomba di Leopardi”. La scrittrice, sua la definizione «giovane favoloso», si accosta alla figura e all’opera del poeta recuperando l’interezza del suo vissuto, ma chi non ha letto Leopardi con gli occhi della sua propria sensibilità ed esperienza di vita? Il poeta degli «ameni inganni della … prima età», della fugace «bella giovanezza», del dolore e della noia, destinato a rimanere giovane per sempre, tocca unanimemente il cuore. Ma andando oltre lo scritto della Ortese, bisogna ricercare nei testi leopardiani quanto possa guidare la riflessione su cosa sia “favola” e cosa significhi essere “favoloso”.
Nel 1818 il giovane Leopardi interviene nel pieno della polemica fra Classicisti e Romantici con un saggio in risposta alle idee già sviluppate da Ludovico di Breme (il «Cavaliere» della situazione) ma destinato, come una lettera scritta due anni prima ai compilatori della ‘Biblioteca Italiana’, a rimanere all’epoca sconosciuto perché la rivista ‘Lo Spettatore italiano’, a cui era stato inviato, non lo pubblicò: è il “Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica”. Il testo ha valore soprattutto letterario, ma le idee manifestano una sensibilità non solo poetica o estetica, concentrandosi sul rapporto natura-ragione e sulla posizione dell’uomo come singolo e come umanità nel ruolo di “connivente” dell’una o dell’altra forza in gioco. «La natura è grande e la ragione è piccola», ma la ragione ha la capacità di fare disastri nel suo sforzo di penetrare segreti che meglio sarebbe se restassero inviolati. Di qui la contrapposizione tra antichi e moderni, a sua volta riconducibile al confronto tra fanciulli e adulti, caratterizzati i primi elementi delle due coppie da immaginazione e passione nel loro contatto con la natura, «gran madre di illusioni», e i secondi da riflessione e calcolo nel loro legame esclusivo e utilitaristico con la ragione: «… quello che furono gli antichi, siamo stati noi tutti, e quello che fu il mondo per qualche secolo, siamo stati noi per qualche anno, dico fanciulli e partecipi di quella ignoranza e di quei timori e di quei diletti e di quelle credenze e di quella sterminata operazione della fantasia». L’immaginazione di quei tempi remoti induceva a fingere «a talento nostro» il perché delle cose e ad abbellirlo, «ad amare e desiderare». Era questo il regno delle «favole antiche», popolato dai miti greci e dalle storie dei grandi patriarchi; il regno dei veri poeti che, ingannando i sensi e non l’intelletto, indulgono al bello e dilettano, a differenza del filosofo, tutto incentrato sul vero e l’utile ma capace di produrre danni quando voglia convincere al falso, in particolare difendendo l’idea di un futuro progressivo miglioramento delle condizioni di vita dell’umanità. La legge di natura «scritta nel diamante» non permette alterazioni del suo corso meccanicistico e presenta la tragica negazione del principio di non contraddizione, perché in natura con evidenza «potest idem simul esse et non esse» (“Zibaldone”, 5-6 aprile 1825).
Su tutto domina la forte esaltazione della vita (che non è mera esistenza), intesa come ambito entro cui si afferma l’amor proprio dell’individuo («l’amore di sé» privo di limiti), quello che per Leopardi induce al piacere, in sostanza alla ricerca della felicità. Qui gran parte hanno i giovani, che per loro natura favoleggiano sul loro avvenire, accarezzando sogni e desideri e ricavandone un senso di pienezza che li spinge all’azione generosa. La forza e la bellezza dei corpi si accompagnano, per loro stesse, al coraggio di agire, all’ardore della passione, alla generosità degli intenti.
Attorno al «piacere» Leopardi costruisce nel suo “Zibaldone” una teoria, incentrata su «la gran misericordia e il gran magistero della natura» che «non volea che sapessimo» (luglio 1820) e per questo ha gratificato l’uomo primitivo delle illusioni. Il giovane Leopardi di Martone vaga fra i prati, occhieggia il paesaggio, coglie i raggi luminosi, guarda le cose spostando il punto di vista privilegiato. L’uomo moderno, però, conosce i limiti delle cose e sa che il piacere non può trovare nel presente soddisfazione adeguata all’amore di sé: solo l’indefinito del ricordo o la presunzione circa il futuro possono avvolgere l’anima con la vaghezza del sentimento («Ed io infatti non divenni sentimentale, se non quando perduta la fantasia divenni insensibile alla natura, e tutto dedito alla ragione e al vero, in somma filosofo», 1 luglio 1820). La poesia moderna, non più di immaginazione come quella degli antichi, è un sentire, rappresentare, riflettere: nasce dalle sensazioni corporee, fonte prima di ogni conoscenza, ma si interroga sulla verità.
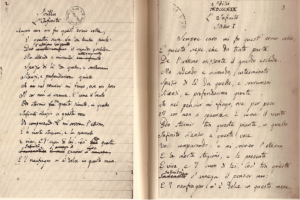 È la ribellione l’atteggiamento predominante in Leopardi? Certo, l’insofferenza dei limiti angusti entro cui vive la giovinezza (ma Recanati accoglie in grembo l’intera sua vita, ma la sua casa stessa è l’intero suo mondo conoscitivo e favoloso) spiega punte di rivolta evidenti in alcuni testi e non ignare della scelta del suicidio fatta da tanti, ma nella sostanza superate dalla consapevolezza di sé nella convinzione costante e tenace della falsità delle idee prevalenti nella sua epoca. A “favoleggiare” in modo drammatico sono i contemporanei, inerti e a volte maligni dissipatori della propria intelligenza e delle proprie vite. Non è questione di contrasto fra pessimismo dell’uno (solitario e malinconico) e ottimismo dei più (quelli di tendenza), ma della necessità di guardare il mondo com’è. Per questo nell’accostare l’opera è meglio in qualche modo liberarsi della nota suddivisione dei “pessimismi” leopardiani (storico psicologico sensistico cosmico), come meglio sarebbe non soffermarsi sul compianto di una Silvia in carne e ossa, come se non fosse ipostasi della vaga e fiduciosa bellezza, «fiore gentile» destinato come la ginestra a soccombere sulle pendici del Vesuvio. Il nucleo portante delle idee insiste quasi dalle origini, sennò non capiremmo il valore forte di pensieri giovanili sulla grandezza delle «opere di genio» e non ne coglieremmo il rapporto con scritti più tardi: «Hanno questo di proprio le opere di genio, cioè le opere del genio, che quando anche rappresentino al vivo la nullità delle cose, quando anche dimostrino evidentemente e facciano sentire l’inevitabile infelicità della vita, quando anche esprimano le più terribili disperazioni, tuttavia, ad un animo grande che si trovi anche in uno stato di estremo abbattimento, disinganno, nullità, noia e scoraggimento della vita, o nelle più acerbe e mortifere disgrazie, […] servono sempre di consolazione, raccendono l’entusiasmo, e non trattando né rappresentando altro che la morte, le rendono, almeno momentaneamente, quella vita che aveva perduta. […] E lo stesso conoscere l’irreparabile vanità e falsità di ogni bello e di ogni grande è una certa bellezza e grandezza che riempie l’anima, quando questa conoscenza si trova nelle opere di genio. […] Oltracciò il sentimento del nulla è il sentimento di una cosa morta e mortifera. Ma se questo sentimento è vivo, come nel caso ch’io dico, la sua vivacità prevale nell’animo del lettore alla nullità della cosa che fa sentire, e l’anima riceve vita, se non altro passeggera, dalla stessa forza con cui sente la morte perpetua delle cose e sua propria. (“Zibaldone”, 4-5 ottobre 1820)». Certamente il pensiero leopardiano qui considera in particolare il valore della letteratura («Gran cosa, e certa madre di piacere e di entusiasmo, e magistrale effetto della poesia, quando giunge a fare che il lettore acquisti maggior concetto di se [sic] e delle sue disgrazie, e del suo stesso abbattimento e annichilamento di spirito»), ma è un pensiero denso di esperienze e contenuti. Nel passaggio non solo degli anni ma quasi dei giorni, cambia il riferimento emotivo alla domanda su quale sia il valore del rapporto natura – ragione, anche se la condanna esplicita della malignità di Natura è dichiarata solo nel 1824 in una celebre Operetta pubblicata solo tre anni dopo (nel film il volto di donna «mezzo tra bello e terribile» che si mostra all’Islandese nell’«interiore dell’Africa … sotto la linea equinoziale» vuole essere quello di Adelaide Antici Leopardi). A produrre allentamento della tensione sta sempre la forza dell’illusione, che non è autoinganno, ma capacità di vedere oltre i limiti di ciò che è presente e vivo. Fondamentalmente, Leopardi non è solo ribelle, ma un ostinato uomo “contro”.
È la ribellione l’atteggiamento predominante in Leopardi? Certo, l’insofferenza dei limiti angusti entro cui vive la giovinezza (ma Recanati accoglie in grembo l’intera sua vita, ma la sua casa stessa è l’intero suo mondo conoscitivo e favoloso) spiega punte di rivolta evidenti in alcuni testi e non ignare della scelta del suicidio fatta da tanti, ma nella sostanza superate dalla consapevolezza di sé nella convinzione costante e tenace della falsità delle idee prevalenti nella sua epoca. A “favoleggiare” in modo drammatico sono i contemporanei, inerti e a volte maligni dissipatori della propria intelligenza e delle proprie vite. Non è questione di contrasto fra pessimismo dell’uno (solitario e malinconico) e ottimismo dei più (quelli di tendenza), ma della necessità di guardare il mondo com’è. Per questo nell’accostare l’opera è meglio in qualche modo liberarsi della nota suddivisione dei “pessimismi” leopardiani (storico psicologico sensistico cosmico), come meglio sarebbe non soffermarsi sul compianto di una Silvia in carne e ossa, come se non fosse ipostasi della vaga e fiduciosa bellezza, «fiore gentile» destinato come la ginestra a soccombere sulle pendici del Vesuvio. Il nucleo portante delle idee insiste quasi dalle origini, sennò non capiremmo il valore forte di pensieri giovanili sulla grandezza delle «opere di genio» e non ne coglieremmo il rapporto con scritti più tardi: «Hanno questo di proprio le opere di genio, cioè le opere del genio, che quando anche rappresentino al vivo la nullità delle cose, quando anche dimostrino evidentemente e facciano sentire l’inevitabile infelicità della vita, quando anche esprimano le più terribili disperazioni, tuttavia, ad un animo grande che si trovi anche in uno stato di estremo abbattimento, disinganno, nullità, noia e scoraggimento della vita, o nelle più acerbe e mortifere disgrazie, […] servono sempre di consolazione, raccendono l’entusiasmo, e non trattando né rappresentando altro che la morte, le rendono, almeno momentaneamente, quella vita che aveva perduta. […] E lo stesso conoscere l’irreparabile vanità e falsità di ogni bello e di ogni grande è una certa bellezza e grandezza che riempie l’anima, quando questa conoscenza si trova nelle opere di genio. […] Oltracciò il sentimento del nulla è il sentimento di una cosa morta e mortifera. Ma se questo sentimento è vivo, come nel caso ch’io dico, la sua vivacità prevale nell’animo del lettore alla nullità della cosa che fa sentire, e l’anima riceve vita, se non altro passeggera, dalla stessa forza con cui sente la morte perpetua delle cose e sua propria. (“Zibaldone”, 4-5 ottobre 1820)». Certamente il pensiero leopardiano qui considera in particolare il valore della letteratura («Gran cosa, e certa madre di piacere e di entusiasmo, e magistrale effetto della poesia, quando giunge a fare che il lettore acquisti maggior concetto di se [sic] e delle sue disgrazie, e del suo stesso abbattimento e annichilamento di spirito»), ma è un pensiero denso di esperienze e contenuti. Nel passaggio non solo degli anni ma quasi dei giorni, cambia il riferimento emotivo alla domanda su quale sia il valore del rapporto natura – ragione, anche se la condanna esplicita della malignità di Natura è dichiarata solo nel 1824 in una celebre Operetta pubblicata solo tre anni dopo (nel film il volto di donna «mezzo tra bello e terribile» che si mostra all’Islandese nell’«interiore dell’Africa … sotto la linea equinoziale» vuole essere quello di Adelaide Antici Leopardi). A produrre allentamento della tensione sta sempre la forza dell’illusione, che non è autoinganno, ma capacità di vedere oltre i limiti di ciò che è presente e vivo. Fondamentalmente, Leopardi non è solo ribelle, ma un ostinato uomo “contro”.
 Dopo la vita di Recanati, il film di Martone si concentra sui periodi trascorsi nelle grandi città italiane. Il mondo paesano, con il suo idillio (pur turbato dalla incomprensione del volgo), attira in modo particolare lo spettatore, che si ritrova facilmente nelle immagini note a tutti, fra torri palazzi piazzette aperture naturalistiche. Roma e Firenze, poi, mettono il giovane ansioso di vita a contatto con la piccineria diffusa delle idee dominanti e con il rifiuto della sua diversità, e si tratta di atteggiamenti che riguardano il privato e il valore intellettuale del poeta. Del suo desiderio di rapporti positivi, costantemente avversate le sue aspirazioni di affermazione nella società letteraria, è famosa testimonianza la lettera scritta da Firenze all’amica Antonietta Tommasini, giustamente ricordata nella pellicola nella sua struggente espressione: «Io non ho bisogno di stima, né di gloria, né di altre cose simili; ma ho bisogno d’amore.» (5 luglio 1828). Anche a ben altro e passionale amore ambiva Leopardi, pure questo tenacemente deluso fino al disastro prodotto da Fanny Targioni Tozzetti: «Or poserai per sempre,/ stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,/ ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,/ in noi di cari inganni,/ non che la speme, il desiderio è spento./ Posa per sempre. Assai/ palpitasti. Non val cosa nessuna/ i moti tuoi, né di sospiri è degna/ la terra. Amaro e noia/ la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo./ T’acqueta omai. Dispera/ l’ultima volta. Al gener nostro il fato/ non donò che il morire. Omai disprezza/ te, la natura, il brutto/ poter che, ascoso, a comun danno impera,/ e l’infinita vanità del tutto.» (“A se stesso”, databile fra il 1833 e il 1835).
Dopo la vita di Recanati, il film di Martone si concentra sui periodi trascorsi nelle grandi città italiane. Il mondo paesano, con il suo idillio (pur turbato dalla incomprensione del volgo), attira in modo particolare lo spettatore, che si ritrova facilmente nelle immagini note a tutti, fra torri palazzi piazzette aperture naturalistiche. Roma e Firenze, poi, mettono il giovane ansioso di vita a contatto con la piccineria diffusa delle idee dominanti e con il rifiuto della sua diversità, e si tratta di atteggiamenti che riguardano il privato e il valore intellettuale del poeta. Del suo desiderio di rapporti positivi, costantemente avversate le sue aspirazioni di affermazione nella società letteraria, è famosa testimonianza la lettera scritta da Firenze all’amica Antonietta Tommasini, giustamente ricordata nella pellicola nella sua struggente espressione: «Io non ho bisogno di stima, né di gloria, né di altre cose simili; ma ho bisogno d’amore.» (5 luglio 1828). Anche a ben altro e passionale amore ambiva Leopardi, pure questo tenacemente deluso fino al disastro prodotto da Fanny Targioni Tozzetti: «Or poserai per sempre,/ stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,/ ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,/ in noi di cari inganni,/ non che la speme, il desiderio è spento./ Posa per sempre. Assai/ palpitasti. Non val cosa nessuna/ i moti tuoi, né di sospiri è degna/ la terra. Amaro e noia/ la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo./ T’acqueta omai. Dispera/ l’ultima volta. Al gener nostro il fato/ non donò che il morire. Omai disprezza/ te, la natura, il brutto/ poter che, ascoso, a comun danno impera,/ e l’infinita vanità del tutto.» (“A se stesso”, databile fra il 1833 e il 1835).
Allo spettatore pare generalmente più ostico il riferimento al periodo napoletano di Leopardi e alcuni (critici) hanno storto il naso di fronte al poeta goloso di gelati o visto con sospetto la discesa agli inferi nel bordello truculento. Qui entra, dopo quella iniziale della Ortese (ed è Martone ancora a dirlo), l’interpretazione di Enzo Moscato, attore e autore di una Napoli che conferma nel suo stesso essere il drammatico congiungimento di anelito vitalistico e senso della morte nell’umana realtà. Eppure, eppure… . Il vivere quasi “animale” di creature che sono tutta natura, attaccate ai bisogni primari del corpo, di cui sfogano l’urgenza con i piaceri più semplici e rudi ma pieni di energia, attira per prima l’inclinazione del poeta pensatore, malato anche di troppo studio. Si vedono nel film giocatori di pallone, più volgari di quel primo dedicatario della lirica datata 1821, eroe mitico animato da virtuosa passione, come gli antichi in lotta per rinnovare l’onor di patria (non pensiamo al presente, i tempi sono molto cambiati), a dimostrazione che vivere per uno scopo, per un sia pur limitato piacere, anche nel pericolo, distrae da pensieri vacui e funesti.
Ma il tanto studio non impedisce all’animo malinconico e solitario di cullarsi in idee vaste e indefinite, ricche di suggestione: il poeta segue la ragione con sentimento. L’uomo di genio conosce la sterminata e incombente grandezza del mondo fisico e sente che la sua vita, lungi dall’essere luogo del piacere, è il suo contrario: è male. Ma l’uomo di genio ha la capacità di fare sua questa grandezza: il poeta e il filosofo, non più fra loro antitetici, partecipano l’uno della capacità dell’altro nell’avvicinare il bello e il vero (che proprio bello non è) «per un quasi entusiasmo della ragione» (“Zibaldone”, 8 settembre 1823). Nel film di Martone questa capacità prende contemporaneamente parola e immagine dai versi della Ginestra (proposti dalla “favolosa” voce di Elio Germano) e dalla visione di un cielo notturno fitto di stelle, un infinito che può non “spaurare” se accostato intellettualmente, nella inevitabile coscienza della piccolezza dell’uomo, forti della vera comprensione della realtà delle cose, lontana da ogni dannosa finzione, e con il coraggio della resistenza, aperta all’amore e all’aiuto verso gli altri. Concetti in modo più malinconico anticipati nelle “Operette morali” dal “Dialogo di Plotino e Porfirio” (1827), quando il filosofo Plotino, che cerca di dissuadere l’amico Porfirio dal suicidio, avanza l’ultima possibilità: «Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Si bene attendiamo a tenerci compagnia l’un l’altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo questa fatica della vita.» «Tutto è nulla, solido nulla», «vanità delle vanità» (come recita il ““Qoèlet”), dal nulla veniamo e al nulla torneremo, ma, finché c’è, la nostra vita è il nostro tutto.
 È meglio farlo il percorso nel Parco Virgiliano di Napoli, misera e nobile città «di lazzaroni e pulcinelli». Dopo l’incontro con la cosiddetta tomba del poeta latino e la famosa iscrizione (Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua rura duces), si giunge al monumento d’impronta classica dove nel 1939 furono traslati i resti di Leopardi. Un itinerario dove tutto, tutto parla di lui e con lui e dell’ammirazione (benché postuma) per lui; un paesaggio che pone davanti allo splendore della natura, alla vastità del mare con i segnacoli belli e brutti (le isole, il vulcano); una salita che sarebbe da percorrere con qualche ramo di ginestra in mano, perché è proprio così: «Leopardi produce l’effetto contrario a quello che si propone. Non crede al progresso, e te lo fa desiderare; non crede alla libertà, e te la fa amare. Chiama illusioni l’amore, la gloria, la virtù, e te ne accende in petto un desiderio inesausto.» (Francesco de Sanctis)
È meglio farlo il percorso nel Parco Virgiliano di Napoli, misera e nobile città «di lazzaroni e pulcinelli». Dopo l’incontro con la cosiddetta tomba del poeta latino e la famosa iscrizione (Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua rura duces), si giunge al monumento d’impronta classica dove nel 1939 furono traslati i resti di Leopardi. Un itinerario dove tutto, tutto parla di lui e con lui e dell’ammirazione (benché postuma) per lui; un paesaggio che pone davanti allo splendore della natura, alla vastità del mare con i segnacoli belli e brutti (le isole, il vulcano); una salita che sarebbe da percorrere con qualche ramo di ginestra in mano, perché è proprio così: «Leopardi produce l’effetto contrario a quello che si propone. Non crede al progresso, e te lo fa desiderare; non crede alla libertà, e te la fa amare. Chiama illusioni l’amore, la gloria, la virtù, e te ne accende in petto un desiderio inesausto.» (Francesco de Sanctis)
.
IL GIOVANE (FILOSOFO) FAVOLOSO
di Maurizio Villani
In queste note intendo richiamare l’attenzione dello spettatore su alcune scene del film di Mario Martone Il giovane favoloso[i] per evidenziare come il regista, nella ricostruzione della biografia intellettuale di Giacomo Leopardi, abbia rappresentato aspetti e temi della dimensione filosofica del poeta di Recanati.
Va detto che la collocazione di Leopardi tra i filosofi italiani è rimasta incerta per molto tempo, sebbene Leopardi stesso nello Zibaldone usi l’espressione «il mio sistema filosofico», le Operette morali fossero considerate «libro filosofico» dai lettori contemporanei e nell’epigrafe sepolcrale, dettata da Pietro Giordani, egli sia nominato «scrittore di filosofia». È stato più volte osservato che la difficoltà maggiore nell’accostarsi al pensiero filosofico leopardiano è costituita dal carattere frammentario del suo «pensiero in movimento», che mai assume un carattere sistematico. Ma al di là di questo aspetto, per molto tempo è prevalsa un’interpretazione che ha privilegiato il valore estetico della poesia e sottovalutato quello speculativo delle prose filosofiche. La cultura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento ritiene scarsamente significativa, non originale né profonda la filosofia di Leopardi. Così la pensano De Sanctis e Croce, che convengono nel rivalutare la forza del sentimento e la vitalità della poesia a discapito del pessimismo teoretico della ragione. Su questa linea anche Gentile parla di Leopardi, che «pessimista di filosofia, e quasi alla superficie, fu invece ottimista di cuore, e nel profondo dell’animo». Nel secondo dopoguerra si assiste ad una rivalutazione della filosofia leopardiana, grazie agli apporti della critica di orientamento storicistico-marxiano (Cesare Luperini) e materialista (Sebastiano Timpanaro). Opposte a queste letture sono le più recenti interpretazioni “ontologiche”, come quella di Emanuele Severino, che colloca Leopardi al culmine del nichilismo occidentale, grazie al suo stupore di fronte al nullificarsi del mondo e alla sua consapevole rinuncia a cercare un inesistente fondamento assoluto cui aveva teso la metafisica occidentale.
 Il primo testo che propone in forma strutturata le meditazioni filosofiche di Leopardi sono Le Operette Morali, progettate dal 1819-20 e stampate a Milano dall’editore Angelo Stella nel 1827 (l’edizione completa uscirà nel 1835 a Napoli). In esse, scritte in forma di dialogo, l’autore ricorre all’immaginazione e all’ironia per descrivere la condizione umana, condannata a sperimentare quanto sia vana e illusoria l’aspirazione alla felicità. Sono messi a tema il nichilismo, la noia esistenziale, l’angoscia, ma l’esito di queste riflessioni non è mai una disperazione assoluta, bensì la ricerca di una forza virile che consenta di affrontare con coraggio il male di vivere.
Il primo testo che propone in forma strutturata le meditazioni filosofiche di Leopardi sono Le Operette Morali, progettate dal 1819-20 e stampate a Milano dall’editore Angelo Stella nel 1827 (l’edizione completa uscirà nel 1835 a Napoli). In esse, scritte in forma di dialogo, l’autore ricorre all’immaginazione e all’ironia per descrivere la condizione umana, condannata a sperimentare quanto sia vana e illusoria l’aspirazione alla felicità. Sono messi a tema il nichilismo, la noia esistenziale, l’angoscia, ma l’esito di queste riflessioni non è mai una disperazione assoluta, bensì la ricerca di una forza virile che consenta di affrontare con coraggio il male di vivere.
Alle vicende connesse alla pubblicazione delle “Operette morali” Il giovane favoloso dedica due scene, entrambe ambientate a Firenze all’interno del Gabinetto Vieusseux. Va ricordato che nel 1826, su interessamento di Giordani, erano state pubblicate sull’”Antologia” tre delle “Operette morali” e che, in seguito a ciò, Vieusseux aveva proposto a Leopardi una collaborazione fissa con scritti satirici di impegno sociale. Proposta respinta dal destinatario che si era detto «nella filosofia sociale […] un vero ignorante» e la cui filosofia non era del «genere che si apprezza ed è gradito in questo secolo». A Firenze, oltre a Vieusseux, Leopardi conobbe i cattolico-liberali della sua cerchia, in particolare Capponi, Montani, Niccolini, Colletta, Tommaseo (che gli fu sempre ostile) e Antonio Ranieri, compagno nell’ultima parte della vita.
.
.
.
.
La prima delle due scene cui ho fatto riferimento è cosi descritta nella sceneggiatura: «Un salone pieno di libri, siamo nel Gabinetto letterario di Giovan Pietro Vieusseux. Un circolo devoto alla causa dell’unità italiana in cui intellettuali e uomini dotti discutono problemi politici, legislativi, pedagogici, letterari, scientifici, dando vita a un’importante rivista, ‘Antologia’. Alla sua scrivania Vieusseux parla con Giordani che gli ha consegnato l’articolo, in un altro angolo si parla animatamente di politica. Giacomo, seduto accanto a un signore che legge un giornale, se ne sta per conto suo rigirandosi tra le mani la scatolina del tabacco che fiuta ossessivamente quando si trova in società. Viene avvicinato da un editore». L’editore, rivolgendosi a Leopardi, dice: «Conte ho saputo che il governo vi ha impedito di pubblicare ‘Lo Spettatore’. Era un bel nome per il giornale». Al che Giacomo risponde: «Un’idea di Ranieri, bella, sì, ma io avrei preferito ‘Le Flâneur’: tra i tanti giornali utili al progresso, il nostro non avrebbe avuto utilità alcuna»[i]. Il tema della conversazione è il divieto imposto dal Governo del Granducato di Toscana di pubblicare la rivista citata. La lettera in cui la richiesta viene respinta è del maggio del 1832, per cui la conversazione rappresentata nella scena deve essere posteriore a questa data. L’osservazione cronologica merita attenzione perché dopo alcune sequenze di altra ambientazione, il film di Martone ritorna al Gabinetto Vieusseux.
Così recita la sceneggiatura, a proposito di questa seconda scena: «Piazza Santa Trinità, palazzo Buondelmonti, sede del Gabinetto Vieusseux. L’editore che aveva scambiato qualche parola con Giacomo ora guarda dalla finestra in attesa dell’arrivo del poeta, mentre intorno c’è un’aria da funerale. Tra i molti signori dall’aria contrita, Pietro Colletta sta parlando sottovoce a Gino Capponi». E queste sono le battute del dialogo:
COLLETTA – Lo sai quanto mi sono adoperato nei suoi confronti, siamo riusciti a fargli avere un sussidio per un anno intero! Ma, ti dico la verità, ho riletto i suoi componimenti e niente mi è piaciuto. La medesima eterna, insopportabile, malinconia, gli stessi argomenti, nessuna idea, nessun concetto nuovo. Certo, lo stile è bello…
EDITORE – Tschh! Sta arrivando.
VIEUSSEUX – Mio buon amico, nulla di molto consolante abbiamo da dirvi intorno all’affare del premio: l’ha ottenuto il Botta. Le vostre “Operette morali” sono state difese da Capponi e da Niccolini e, sappiate, nonostante Colletta non se lo aspettasse, lo stesso Zannoni si è mostrato giusto a vostro riguardo. Ma cosa sperare da tutti quei preti che formavano il resto del consesso? Potevano mai essere capaci di apprezzare il merito dei vostri scritti?
GIORDANI – I preti… I preti sono gli autori di ogni male, andrebbero scacciati a sassate! Quanto meno dalle giurie letterarie.
CAPPONI – Lasciamo stare i preti. La questione è un’altra e riguarda noi,
di questi tempi è dannosissimo ostentare una disperazione come la vostra. Il nostro secolo ci insegna che la condizione umana si può migliorare di gran lunga da quel che ella è, come è già migliorata indicibilmente da quello che fu.
MORMORII TRA GLI AMICI – Bravo! E giusto!
GIACOMO – Amici miei, lasciamo stare. Il mio libro… bruciarlo è il meglio. E se no serbarlo come un libro di sogni poetici, d’invenzioni e di capricci malinconici. Come un’espressione dell’infelicità dell’autore. Perché in confidenza’, mio caro amico (si rivolge a Capponi), io credo felice voi, e felici tutti gli altri, ma in quanto a me, con licenza vostra e del secolo, sono infelicissimo e tale mi credo. (andandosene) E tutti i giornali dei due mondi non mi persuaderanno mai del contrario.
TOMMASEO – Che arrogante mediocrità.
VIEUSSEUX – Andiamo, Tommaseo… Leopardi non è quel che si credeva, ma così esagerate.
TOMMASEO – Voi dite? Nel Novecento non ne resterà nemmeno la gobba[ii].
La conversazione fa riferimento al premio di 1000 scudi, bandito dall’Accademia della Crusca nel 1830. Leopardi partecipò al concorso presentando le “Operette morali”, ma l’esito fu per lui deludente: vinse la “Storia d’Italia” di Carlo Botta e Giacomo pare che abbia avuto l’appoggio del solo Capponi.
A proposito dell’ordine secondo cui queste due scene sono presentate nel film, mi permetto di osservare che la loro successione non corrisponde alla cronologia degli eventi; infatti la prima delle due si riferisce a fatti accaduti nel 1832, mentre la seconda allude alla mancata assegnazione del premio dell’Accademia della Crusca, che è del 1830.
Il terzo riferimento importante del film alla posizione filosofica di Leopardi si ritrova in una delle scene finali. Siamo a Napoli nel corso degli Anni Trenta dell’Ottocento e assistiamo ad un dialogo tra Giacomo e un interlocutore, seduti al caffè a Largo di Palazzo. La conversazione riguarda un’opera di Rossini vista la sera prima. Da un tavolino accanto un nobiluomo, seduto accanto a un altro signore dall’aria intellettuale, si rivolge a Leopardi con sarcasmo, irridendo il pessimismo del poeta. Il signore al tavolino, ad un certo punto interloquisce con un’osservazione che manda su tutte le furio Leopardi: «Scusate, ma non vedete che Don Giacomo è sofferente? Come fa a non essere infelice? Perciò è irritato con la natura e con gli uomini». La replica del poeta è feroce: « Le mie opinioni non hanno niente a che fare con le mie sofferenze personali, fatemi la grazia di non attribuire al mio stato quel che si deve solo al mio intelletto! (nel silenzio che è calato nel Caffè per le sue urla) E se proprio vi appassiona, dedicatevi a demolire i miei ragionamenti piuttosto che ad accusare le mie malattie»[iii]. Di quali “ragionamenti” si tratta? Essi vanno dalla filosofia della conoscenza a quella della natura, dalla morale alla religione, dall’antropologia alla filosofia politica.
A questi ragionamenti della maturità Leopardi era pervenuto dopo un lungo tirocinio, iniziato negli anni giovanili, contraddistinti dallo «studio matto e disperatissimo». Si era formato su testi di impianto aristotelico che svariavano dalla metafisica alla filosofia della natura alla morale. A queste prime letture aveva poi fatto seguito lo studio della filosofia classica e moderna, da Lucrezio a John Locke, da Cicerone a Pierre Bayle e ai filosofi illuministi. Ne derivò una svolta teorica che lo portò ad abbandonare il pensiero cattolico della prima giovinezza per aderire alla istanze critiche della filosofia moderna (dal “dubbio metodico” di Cartesio all’empirismo di Locke). In un passo dello Zibaldone (1820) Leopardi scrive: « Considero che la ragione, la quale si vuole avere per fonte della nostra grandezza, (…) qui non ha che far niente, se non per distruggere; per distruggere quello che v’ha di più spirituale nell’uomo, perché non c’è cosa più spirituale del sentimento né più materiale della ragione». La conoscenza razionale, esaltata dalla scienza moderna, è la forza volta alla distruzione delle illusioni naturali. Leopardi vede nel contrasto tra ragione e natura l’origine dell’infelicità umana: la dimensione naturale dell’uomo è quella legata al sentimento, una condizione originaria ma illusoria, che il «troppo conoscere e il troppo uso della ragione» distruggono, generando l’infelicità del genere umano.
Dalle tesi intorno alla teoria della conoscenza discendono due conseguenze: la prima è quella di uno «scetticismo ragionato e dimostrato» che perviene a un radicale relativismo conoscitivo («Non v’è quasi altra verità assoluta se non che Tutto è relativo. Questa dev’esser la base di tutta la metafisica»); la seconda è quella di un rigoroso materialismo, che arriva ad ammettere l’esistenza della «materia pensante» e che conduce ad una visione disincantata dell’uomo che sa di non essere più al centro del mondo e che sperimenta tragicamente la sua limitatezza e impotenza di fronte alla sterminata estensione dell’universo.
Queste ultime considerazioni di filosofia della natura introducono ai temi della filosofia pratica, al centro della quale si trova la domanda se per l’uomo sia possibile o impossibile una vita felice. La risposta va ricercata nel nesso tra la concezione cosmica della natura e visione antropologica. Per Leopardi la condizione umana è caratterizzata da due forme di amore: l’amore di sé, che assicura l’autoconservazione dell’individuo, e l’amor proprio, che coincide con la tendenza umana verso il piacere. Tra queste due forme di amore vi è un conflitto, che è generato dallo scontro tra il desiderio infinito di amore e i limiti della natura e che è all’origine delle illusioni religiose immaginative e poetiche. La condizione umana rivela tutta la sua insensatezza e fragilità, imputabili alla presenza ineliminabile del male nell’ordine cosmico: risulta impossibile dare un fondamento ontologico positivo a tutti gli enti, e quindi all’essere in generale; e così pure il bene, il vero e il bello restano privi di ogni presupposto e ridotti a pure illusioni. La modernità ha portato alla dissoluzione di tutte le certezze metafisiche, lasciando gli uomini in un mondo insensato, ai limiti di un baratro in cui possono sperare di non precipitare solamente se sanno riscoprire profondi legami solidaristici. Nell’ultimo decennio di vita Leopardi approfondisce il nesso tra filosofia naturale e filosofia pratica e sociale,, arrivando a formulare un giudizio di radicale condanna non solo dei regimi politici tradizionalisti e assolutisti, ma anche delle ideologie liberali e progressiste del primo Ottocento.
A Napoli egli incontra vari intellettuali napoletani che, per ragioni di convenienza, erano passati dal radicalismo materialistico giovanile di stampo illuministico e ateo a posizioni cattolico-liberali, moderatamente progressiste, che confliggevano radicalmente col pessimismo leopardiano.
La rivendicazione decisa del valore dei propri ragionamenti, rappresentata nella scena al caffè a Largo di Palazzo, bene documenta la lucida intransigenza filosofica di un pensatore che ha sempre rifiutato compromessi ideologici, certezze dogmatiche e asservimento alle posizioni politiche dominanti, in nome di un impegno morale volto ad affermare il “valore sociale del vero”.
.
.
[1] Il giovane favoloso di Mario Martone. Con Elio Germano, Michele Riondino, Massimo Popolizio, Anna Mouglalis, Valerio Binasco. durata 137 min.- Italia 2014.
[2] M. Martone, I. di Majo, “Il giovane favoloso. La vita di Giacomo Leopardi” (sceneggiatura), Mondadori, Milano2014, pag. 52.
[3] Ibidem, pagg. 60-61.
[4] Ibidem,, pag. 84.
.
È ANCORA TEMPO DI EROI?: AMERICAN SNIPER
di Francesco Saverio Marzaduri
“Non me lo merito… di morire in questo modo… stavo costruendo una casa…”
. . . . . “I meriti non c’entrano in questa storia…”
GENE HACKMAN e CLINT EASTWOOD, Gli spietati
“Ed ora io vi lascio, ho addosso una stanchezza infernale
La confusione che provo, non può essere descritta da nessuna lingua
Le parole riempiono la mia testa e cadono sul pavimento
Se Dio è dalla nostra parte fermerà la prossima guerra”
BOB DYLAN, With God on Our Side
.
Superato, ma non troppo, il tam-tam mediatico di una pellicola che ha suscitato clamori e dissensi ancor prima della sua uscita in sala, chi scrive coglie l’occasione per fare il punto su una constatazione, etica e cinematografica. Ognuno può pensarla come crede, e scrivere che un’opera sia artisticamente riuscita o moralmente deprecabile, a meno di non incappare nella perversa spirale di quello stesso tam-tam. Si correrebbe il rischio di esprimere pareri negativi riconducibili più a idealità personali (e a brucianti frustrazioni) che all’oggettività dell’opera. E se tali pareri fungono da monito trovando una vasta rete di consensi, per esempio attraverso i social network, sono guai: s’impone allora il dubbio che il consenso, solidale con lo sfogo, non sia altro che una marchetta e i buoni propositi si riducano a una manciata di belle parole, tese in ultima analisi a sponsorizzare gli autori della pelosa polemica.
Quel che colpisce è che i suddetti siano spesso firme autorevoli della critica cinematografica, e dispiace che certe loro ragioni si spieghino con interpretazioni che poco hanno in comune con l’esegesi, e sembrino dettate piuttosto da motivi ideologici. O forse, peggio, da egolatria e narcisismi. Sono però pur sempre ragioni, con legittimo diritto a essere espresse, anche nella cupezza di giorni in cui, come i presenti, per la libertà di espressione è notte fonda e per un’opinione disegnata (stampata? filmata?) si può morire ammazzati. A giustificazione di chi non vuol prendere posizione, corre l’obbligo di dire che la realizzazione di un film incentrato su di un eroe di guerra americano non è già di per sé un fatto neutro, figurarsi se l’american hero è un cecchino dei Seals, in breve tempo divenuto una leggenda per il maggior numero di bersagli centrati in Iraq. E accertati.
Se poi dietro la macchina da presa c’è un grande artigiano del cinema statunitense, l’ottantacinquenne Eastwood, l’appunto da muovere, onde non incappare in spiacevoli fraintendimenti, potrebbe e dovrebbe essere solo filmografico. Chi conosce la recente produzione del vecchio Clint, ed è disposto a ribadirne la seconda giovinezza anche in opere ove lo stile è meno indovinato, sa da sempre che questo regista fa di ogni lavoro un discorso inerente la cultura nordamericana, la sua storia e i suoi eroi, i suoi costumi e i suoi miti. E i suoi fantasmi. In American Sniper, si gioca a carte scoperte sin dai primi fotogrammi: il protagonista, Chris Kyle (Bradley Cooper), è intensamente mostrato nell’atto di tenere sotto tiro un’irachena e il suo bambino, intenti a passarsi un’enorme granata da scagliare verso il nemico. L’uomo e il (suo) mirino, verrebbe da dire. Ma un secondo prima che il grilletto di Kyle sia premuto, la m.d.p. stacca su di un flashback teso a condensare in poche scene l’infanzia, l’adolescenza e la presa di posizione dell’uomo.
 Chris è un american boy, educato agli usuali valori “a stelle e strisce” (famiglia-chiesa-Stato) e all’uso delle armi in difesa di essi, pungolato dai discorsi a tavola di un padre che, cinghia sul tavolo, declama versetti della Bibbia distinguendo le umane categorie, etichettate come agnelli, lupi e cani da pastore. In quest’incipit c’è tutto quel cinema, e quei solidi valori tradizionali, che altrove Eastwood non ha fatto mistero di difendere. E se è facile inventare un accostamento tra il cecchino Kyle e un’altra figura del Clint del passato, Scorpio, esso è rapidamente smentito dall’opposta scelta di campo. Scelta che, per l’intera durata di American Sniper, mette in costante discussione il suo eroe: più volte lo sentiamo chiamare “leggenda” dal plotone cui appartiene, e da eroe lo saluta un reduce mutilato alle gambe che lo ringrazia per avergli salvato la vita, e rammenta al figlioletto di questi quanto sia fortunato ad avere un simile genitore.
Chris è un american boy, educato agli usuali valori “a stelle e strisce” (famiglia-chiesa-Stato) e all’uso delle armi in difesa di essi, pungolato dai discorsi a tavola di un padre che, cinghia sul tavolo, declama versetti della Bibbia distinguendo le umane categorie, etichettate come agnelli, lupi e cani da pastore. In quest’incipit c’è tutto quel cinema, e quei solidi valori tradizionali, che altrove Eastwood non ha fatto mistero di difendere. E se è facile inventare un accostamento tra il cecchino Kyle e un’altra figura del Clint del passato, Scorpio, esso è rapidamente smentito dall’opposta scelta di campo. Scelta che, per l’intera durata di American Sniper, mette in costante discussione il suo eroe: più volte lo sentiamo chiamare “leggenda” dal plotone cui appartiene, e da eroe lo saluta un reduce mutilato alle gambe che lo ringrazia per avergli salvato la vita, e rammenta al figlioletto di questi quanto sia fortunato ad avere un simile genitore.
Come in centinaia di altri war movies, anche in questo caso l’azione bellica è mostrata nel suo peggio: ma si tratta di un discorso ribadito già molte volte. E mentre alcuni segmenti risultano comunque poco sostenibili (l’uccisione di un collaboratore iracheno, freddato mentre cerca di salvare il figlio cui i fondamentalisti trapanano il cranio), più interessante è il discorso relativo alla psicologia di Chris, alla sua incapacità di dare a sé stesso, e alla propria scelta di esistenza, una giustificazione. La coazione dell’uomo a ripetere, a tornare ogni volta in trincea senza assaporare la gioia della famiglia o la nascita dei figli, quasi ne fa una figura à la Scorsese. Come scorsesiani erano i Jersey Boys, scanzonati e un po’ picchiatelli, dell’omonima opera immediatamente precedente di Eastwood (lo ribadisce, anzi, la macchietta di uno scugnizzo Joe Pesci, ma persino l’inclusione della celebre battuta “Ti sembro buffo?” pronunciata dalla futura star in Quei bravi ragazzi).
Se poi nel genere bellico citazioni e prestiti non mancano, e nel caso di Eastwood la riproposta del modello classico è la specifica firma, la parentela di Kyle è col capitano Willard di Apocalypse Now: Kyle è figura morta fin dall’inizio, e il suo atteggiamento da finto cowboy – quando è solo un bovaro da quattro soldi, scatti d’ira e cazzotto facile – è spogliato di qualsivoglia connotazione, elegiaca o mitologica, propriamente “americana.” Tra i Seals il Nostro sembra trovare un ruolo e una dimensione, il dovere di servire la Patria è più importante che festeggiare in tranquillità le proprie nozze: il suono di una sirena lo mette sull’attenti e lo consegna al proprio Destino. Ma siamo lontani dalle ironie con cui Eastwood rileggeva il mito militare tutto macho e bicipiti in Gunny – non a caso aspramente criticato dagli stessi marines – per quanto le scene d’addestramento siano la riproposta di tanti analoghi prodotti, da Ufficiale e gentiluomo a Full Metal Jacket.
 La missione brava del soldato Kyle, in verità una missione interminabile senza tregue, conosce scoppi e boati, mirini e sangue come nel più truce tiro al piattello, soffiate e tradimenti, tragici incidenti di percorso e inattesi colpi di fortuna, solitudini morali e legami spezzati. Un nuovo inferno, dove, per parafrasare il Ron Kovic di Nato il 4 luglio, non si dovrebbero uccidere donne e bambini. In un mondo perfetto, si sa, cose come queste non succederebbero nemmeno. Qui, però, le une e gli altri sono figure infide, prive d’innocenza come nel miglior Peckinpah, e la reiterata presenza di un cane funge da monito, al contempo, mitologico e inquietante. Ogni traccia di gioia o di sentimentalismo è abolita: quando la moglie Tara (Sienna Miller) gli telefona per trasmettergli la più felice delle notizie, Chris è ricondotto di peso alla realtà, e i citati valori “a stelle e strisce” sono rimessi in discussione in tutta la loro precarietà. Complice un serrato montaggio alternato, i coniugi Kyle sono ambedue al centro di una tensione psicologica: Chris deve pensare a combattere (e a uscirne vivo), non avendo tempo per godere della notizia; la consorte è in lacrime, in comprensibile ansia, non sapendo se l’uomo tornerà. Il rumore degli spari fa da contrappunto, lo spettatore assiste all’episodio con impotente complicità. E due esequie fanno capolino nel film, alla prima delle quali il dead man walkin’ Kyle assiste, Tara al fianco, con glaciale sofferenza: proiezione di quella dipartita cui – non esattamente in gloria ma per mera fatalità – egli va incontro senza che sia mostrata, e si scelga di rappresentare un secondo funerale. Il suo.
La missione brava del soldato Kyle, in verità una missione interminabile senza tregue, conosce scoppi e boati, mirini e sangue come nel più truce tiro al piattello, soffiate e tradimenti, tragici incidenti di percorso e inattesi colpi di fortuna, solitudini morali e legami spezzati. Un nuovo inferno, dove, per parafrasare il Ron Kovic di Nato il 4 luglio, non si dovrebbero uccidere donne e bambini. In un mondo perfetto, si sa, cose come queste non succederebbero nemmeno. Qui, però, le une e gli altri sono figure infide, prive d’innocenza come nel miglior Peckinpah, e la reiterata presenza di un cane funge da monito, al contempo, mitologico e inquietante. Ogni traccia di gioia o di sentimentalismo è abolita: quando la moglie Tara (Sienna Miller) gli telefona per trasmettergli la più felice delle notizie, Chris è ricondotto di peso alla realtà, e i citati valori “a stelle e strisce” sono rimessi in discussione in tutta la loro precarietà. Complice un serrato montaggio alternato, i coniugi Kyle sono ambedue al centro di una tensione psicologica: Chris deve pensare a combattere (e a uscirne vivo), non avendo tempo per godere della notizia; la consorte è in lacrime, in comprensibile ansia, non sapendo se l’uomo tornerà. Il rumore degli spari fa da contrappunto, lo spettatore assiste all’episodio con impotente complicità. E due esequie fanno capolino nel film, alla prima delle quali il dead man walkin’ Kyle assiste, Tara al fianco, con glaciale sofferenza: proiezione di quella dipartita cui – non esattamente in gloria ma per mera fatalità – egli va incontro senza che sia mostrata, e si scelga di rappresentare un secondo funerale. Il suo.
 American Sniper, e qui risiede il suo aspetto non tanto più riuscito quanto più apprezzabile, è un’opera in bilico tra il retorico e l’asciutto, in perenne sospensione sul fil rouge della demarcazione, della sottile linea (rossa) in cui termina il più ottuso conservatorismo e comincia il più singolare idealismo. Soprattutto, Chris Kyle è una maschera eastwoodiana: quello che muove la sua psicologia non è la vanagloria, né la mera volontà di difendere ideali e Paese. Neppure è il desiderio di essere un eroe, e quando si ritrova ad essere tutt’e tre gli aspetti insieme, non può che accettarlo perché la circostanza bigger than life glielo impone. Chris è alla ricerca di un fantasma, una presenza invisibile. “C’è il Male laggiù,” sono le sue parole, e quest’invisibile spettro è la dark (in)side raffigurata dal nemico: un cecchino, come lui, da scovare in differenti tappe di missione come al centro di un videogame o, stando al regista, di un ennesimo duello western. Debellato il “doppio,” un campione di tiro prezzolato dagli iracheni tradito da una futile casualità, non restano che i simulacri: gli spettri che Kyle si porta appresso per un bel po’, sia quando, a missione conclusa, non torna a casa e guarda lo sport al tavolo di un bar con un bicchiere di whisky, sia quando, sulla poltrona di casa, riascolta i boati di guerra davanti a un apparecchio televisivo spento.
American Sniper, e qui risiede il suo aspetto non tanto più riuscito quanto più apprezzabile, è un’opera in bilico tra il retorico e l’asciutto, in perenne sospensione sul fil rouge della demarcazione, della sottile linea (rossa) in cui termina il più ottuso conservatorismo e comincia il più singolare idealismo. Soprattutto, Chris Kyle è una maschera eastwoodiana: quello che muove la sua psicologia non è la vanagloria, né la mera volontà di difendere ideali e Paese. Neppure è il desiderio di essere un eroe, e quando si ritrova ad essere tutt’e tre gli aspetti insieme, non può che accettarlo perché la circostanza bigger than life glielo impone. Chris è alla ricerca di un fantasma, una presenza invisibile. “C’è il Male laggiù,” sono le sue parole, e quest’invisibile spettro è la dark (in)side raffigurata dal nemico: un cecchino, come lui, da scovare in differenti tappe di missione come al centro di un videogame o, stando al regista, di un ennesimo duello western. Debellato il “doppio,” un campione di tiro prezzolato dagli iracheni tradito da una futile casualità, non restano che i simulacri: gli spettri che Kyle si porta appresso per un bel po’, sia quando, a missione conclusa, non torna a casa e guarda lo sport al tavolo di un bar con un bicchiere di whisky, sia quando, sulla poltrona di casa, riascolta i boati di guerra davanti a un apparecchio televisivo spento.
 Chris Kyle è un morto (morale) che cammina, la cui mente, come già per Bird, non è mai dove dovrebbe essere, perché la propria superomistica, eppure (in)spiegabile missione (“Non so nemmeno io perché lo faccio,” stigmatizzava “Dirty” Harry Callahan) è troppo importante perché egli possa concedersi la serenità dell’alveo familiare. È un fantasma, la cui richiesta, dal vetro di una porta d’ospedale, di soccorrere la sua neonata è una voce non udita. Come lo sguardo che gli restituisce chicchessia, viceversa, è uno sguardo assente, alieno: uno sguardo altro. Kyle, si diceva, è una figura eastwoodiana la cui solitudine, a un tempo morale e fattuale, ha luogo perché a squadernargliela sono la scelta e la circostanza. Perfino in mezzo ai compagni di guerra – i quali fraternizzano con lui, impressionati dalla sua tecnica – egli è “solo” (dice di non voler essere toccato dopo che ha centrato un obiettivo), e benché lui pure si mostri solidale coi commilitoni, da solo, strategicamente, smaschera un collaborazionista trovando un arsenale nel sottosuolo del suo accampamento. Ancora, in un momento d’insostenibile tensione, riesce in extremis a rimettere piede su un velivolo prima che questo decolli: l’ultima figura rimasta sola in un inferno di sabbia indistinguibile, dove i buoni e i cattivi (ma chi sono gli uni e chi gli altri?) si mescolano senza (possibilità di) distinzione. I meriti, si sa, in certe storie non c’entrano.
Chris Kyle è un morto (morale) che cammina, la cui mente, come già per Bird, non è mai dove dovrebbe essere, perché la propria superomistica, eppure (in)spiegabile missione (“Non so nemmeno io perché lo faccio,” stigmatizzava “Dirty” Harry Callahan) è troppo importante perché egli possa concedersi la serenità dell’alveo familiare. È un fantasma, la cui richiesta, dal vetro di una porta d’ospedale, di soccorrere la sua neonata è una voce non udita. Come lo sguardo che gli restituisce chicchessia, viceversa, è uno sguardo assente, alieno: uno sguardo altro. Kyle, si diceva, è una figura eastwoodiana la cui solitudine, a un tempo morale e fattuale, ha luogo perché a squadernargliela sono la scelta e la circostanza. Perfino in mezzo ai compagni di guerra – i quali fraternizzano con lui, impressionati dalla sua tecnica – egli è “solo” (dice di non voler essere toccato dopo che ha centrato un obiettivo), e benché lui pure si mostri solidale coi commilitoni, da solo, strategicamente, smaschera un collaborazionista trovando un arsenale nel sottosuolo del suo accampamento. Ancora, in un momento d’insostenibile tensione, riesce in extremis a rimettere piede su un velivolo prima che questo decolli: l’ultima figura rimasta sola in un inferno di sabbia indistinguibile, dove i buoni e i cattivi (ma chi sono gli uni e chi gli altri?) si mescolano senza (possibilità di) distinzione. I meriti, si sa, in certe storie non c’entrano.
Se di presa di coscienza da parte del protagonista si può discutere, essa giunge dalla necessità di voler stare accanto a moglie e figli e di non poterlo fare. Di essere un marito e un padre, anziché una “leggenda” di guerra. Tanto che il concetto di “cane da pastore” impartitogli, in difesa di quelli che ama, gli sfugge di mano e si riduce a un mucchio di belle parole: per due volte non gli riesce di difendere dalle botte (cioè dai “lupi”) il fratello, “agnello” troppo poco uomo e incapace di essere un Seal come lui. Il doppio familiare di Chris è frustrato e tradito, la vaga idea di un focolare domestico è sempre più lontana. Ma a dispetto della scena d’apertura, qualcosa si rompe nella glacialità del Nostro, che suda freddo, come finora non gli era capitato, all’idea di uccidere un altro bambino quando questi raccoglie il kalashnikov di un islamico appena abbattuto dall’uomo. Solo adesso, con tutta probabilità, Kyle sembra convincersi di quanto sia roba grossa uccidere. Il sentimentalismo patriottico cede al sentimento personale: nella mente del cecchino s’accende la lampada di una vendetta senza esclusione di colpi, dovuta alla perdita di due affezionati compagni. Ma questa volta la vendetta privata – seppur in nome di un’etica – è un errore che mette a repentaglio lui e il resto del plotone, durante l’azione conclusiva. Il cerchio sempre più si restringe.
 Lo avevamo già visto ne Il cacciatore di Cimino: nel rimorso che attraversava Mike-Bob De Niro di fronte al cervo, cui rifiutava di sparare, e nell’identica logica dell’eroe di Eastwoood (one shot, un colpo solo). E American Sniper inizia (e quasi si chiude) con una caccia al cervo, in due diverse occasioni di relazione padre-figlio. Vero è che la parentela fra entrambi i film, putativa e cinematografica, è un po’ la medesima che ha visto Eastwood talent scout per il giovane Cimino per due pellicole di cui Clint era interprete, dai titoli italiani quasi affini: Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan e Una calibro 20 per lo specialista, dei quali Michael fu rispettivamente sceneggiatore e regista. E l’hit Can’t Take My Eyes Off of You, con cui si semi-concludeva Jersey Boys, era già la colonna musicale de Il cacciatore, così come di ambedue le pellicole la presenza di Christopher Walken.
Lo avevamo già visto ne Il cacciatore di Cimino: nel rimorso che attraversava Mike-Bob De Niro di fronte al cervo, cui rifiutava di sparare, e nell’identica logica dell’eroe di Eastwoood (one shot, un colpo solo). E American Sniper inizia (e quasi si chiude) con una caccia al cervo, in due diverse occasioni di relazione padre-figlio. Vero è che la parentela fra entrambi i film, putativa e cinematografica, è un po’ la medesima che ha visto Eastwood talent scout per il giovane Cimino per due pellicole di cui Clint era interprete, dai titoli italiani quasi affini: Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan e Una calibro 20 per lo specialista, dei quali Michael fu rispettivamente sceneggiatore e regista. E l’hit Can’t Take My Eyes Off of You, con cui si semi-concludeva Jersey Boys, era già la colonna musicale de Il cacciatore, così come di ambedue le pellicole la presenza di Christopher Walken.
Quel Jersey Boys che, come American Sniper, era attraversato da un topos ricorrente nella filmografia eastwoodiana: il rapporto tra padri e figli già presente in titoli come Potere assoluto, Mystic River o Million Dollar Baby. Ma pure in quello specifico caso, la nostalgia e il rimpianto per un’America all’indomani dell’assassinio Kennedy, o dallo scoppio della guerra in Vietnam, erano l’aura di una generazione di sgallettati “puliti,” e persino di una mafia pulita, dove l’allegria e la volontà di sfondare senza crederci troppo erano mero pretesto per intonare motivi spensierati, abbandonarsi a passi di danza, fare scherzi o scambiare bacetti innocenti. Happy days prima dell’amaro ripensamento, del rancido bilancio, della maturità adulta atta a sostituire di peso la giovinezza fugacemente dissoltasi nel nulla, come in un novello american graffiti: il tempo segnava i protagonisti, facendone lentamente simulacri anacronistici. Ma in un musical d’altri tempi dove il revival e la tristezza cedevano il passo a un’estrema occasione di sogno, gli anziani ex giovinetti erano restituiti nel finale alla loro immagine primigenia: quella di eterni fantasmi, come il fotogramma di un imberbe Clint Eastwood in Rawhide, diffuso da un apparecchio tivù in un momento del film. L’epoca è ancora quella, scanzonata, della positività, lungi dal sangue e dal ricordo, doloroso e indelebile, della più odierna Storia. E in quest’altro biopic ch’è American Sniper, l’ennesima doppietta (l’opera conseguente a un’altra in un breve lasso di tempo) con cui il cineasta di Carmel corona la carriera è la speculare metà – necessariamente tragica – di una medesima pagina: a una giovinezza quasi totalmente imbevuta di retorico materialismo si affianca una graduale presa di coscienza ch’è segnale di una dolorosa (adulta) consapevolezza.
“Ho ucciso tutto quello che si muoveva o strisciava in tempi lontani,” affermava il “fantasma” Will Munny de Gli spietati. Chris Kyle uccide cose che si muovono o strisciano in tempi recenti. E a turni diversi – cinque in totale – ogni volta torna a casa col morale a brandelli, esattamente come il protagonista di una dimenticata pellicola di Fred Zinnemann, Teresa. E se la similarità con Zinnemann annovera altri titoli, da Uomini – Il mio corpo ti appartiene (l’ospedale per reduci da reintegrare nella società) a Da qui all’eternità (il dovere del soldato di essere in trincea, corpo e mente), è con la psicologia di Philip-John Ericson che Chris reca un’eco, tanto da far pensare che, di Teresa, American Sniper sia una sorta di rifacimento: anche qui c’è la figura di uno psicanalista, che consiglia a Kyle di adoperarsi come guida per i reduci ai poligoni di tiro.
Da questo punto di vista, American Sniper non è solo un film brillantemente ambiguo. Non è solo una macchina spettacolare tesa ad accalappiare, a creare consensi o indignazioni – in ogni caso, in una maniera o nell’altra, dei complici. È un film indovinato perché “studiato,” giacché la scelta ideologica dell’autore (la medesima che da sempre si conosce di lui) è riscattata da un senso dell’azione e del ritmo che compensa la sua opinabile ideologia. Come la riscatta, di nuovo, la scelta di appoggiarsi a quell’archetipo di cinema, che non si può né si sa più fare, di cui Clint è il solo prosecutore. Magari anche per furbo escamotage, in questo e in qualche precedente caso: ma con un’onestà, narrativa e filmica, che solo i vecchi mestieranti del cinema classico mostrano di detenere. Benché i mezzi di produzione per poterselo permettere, a differenza di un Peckinpah o di un Fuller, siano più elevati.
Azione e tensione non cessano di ritrovarsi anche in episodi ilari o innocui: Chris Kyle si mostra per l’ultima volta alla moglie per divertirla, abbigliato da bounty killer in nero con la pistola in pugno, come lo Yul Brinner de Il mondo dei robot (un automa, vedi caso). Ma anche quella è la reiterazione di un fantasma: di quello ch’egli è sempre stato, dello stesso prototipo eroico-mit(olog)ico che da sempre, sin dai tempi di Leone, accompagna il cinema di Eastwood. La morte si legge sull’acconciatura di Kyle, è dietro l’angolo. Una dicitura informa che l’ex leggenda sarà ammazzata da un reduce che cercava di aiutare. Ma la morte, come impartisce la cultura nordamericana, non può e non deve essere ostentata. Ci si abbandona alle vere immagini del funerale di Kyle, con tutti gli onori, per restituire al film l’aura di un’opera retorica: ma di un’opera classica in senso fordiano. E dunque di un’opera concettualmente onesta (assente il commento musicale sui titoli di coda). Probabilmente, con American Sniper, Eastwood ha girato la pellicola più programmatica ed aritmetica della sua filmografia. Comunque la si valuti, in un momento di tensione col mondo tout court in cui è più facile dividere che (non) unire, quella che ci ha fregati tutti. Aficionados o meno.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VISTI DA LONTANO
Film importanti e difficili da trovare ma che meritano il tempo speso per la ricerca
L’ALBA DELLA LIBERTÀ
di Andreina Sirena
Regia di Werner Herzog, con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies.
Titolo originale Rescue Dawn.Durata 126 min. – USA 2006.
Se Werner Herzog ha spesso dichiarato di considerare il suo documentario Little Dieter needs to fly (1997) come il suo migliore film di fiction, potremmo specularmente affermare come il film di fiction L’alba della libertà sia il suo documentario migliore (benché il regista assegni questo primato a Fitzcarraldo). Documentario inteso – dalla cosiddetta Dichiarazione del Minnesota – come visione di una dimensione profonda dietro la mera forma della natura. Il regista stesso ama definirsi il ‘becchino’ del cinéma vérité. D’altronde, i suoi film si dipanano spesso sul crinale dei due generi, e lui stesso si è ripetutamente preso gioco di qualsiasi netta separazione tra di essi, poiché – quantunque possa raccontare con estrema asciuttezza e realismo i dettagli di una storia effettivamente accaduta – ciò che lo interessa non è il fatto in sé ma la verità che vi si cela. Una verità colta in virtù di un’illuminazione interiore, una rivelazione: la cosiddetta ‘verità estatica’.
La vicenda narrata nei due lungometraggi è la medesima: cattura, prigionia ed evasione di Dieter Dengler, pilota statunitense di origini tedesche, abbattuto nel 1965 nel corso di una missione segreta di bombardamento sul Laos, durante la Guerra del Vietnam. Nel film il protagonista era Dengler stesso, che in tal modo riviveva da attore quegli episodi drammatici e terribili che aveva vissuto in prima persona. Qui l’aviatore è invece impersonato da un eccezionale Christian Bale, grazie al quale il regista è riuscito a ricevere i finanziamenti di una casa di produzione americana.
 Tutto è magneticamente vero, in questo film: il verde elettrico, vivido della giungla, l’umidità che pare penetrare nelle ossa dello spettatore in un miracolo di immediatezza espressiva. Ma questa verità cinematografica ’ non è quella dei piccoli contabili e burocrati; è caos, conflitto e morte.
Tutto è magneticamente vero, in questo film: il verde elettrico, vivido della giungla, l’umidità che pare penetrare nelle ossa dello spettatore in un miracolo di immediatezza espressiva. Ma questa verità cinematografica ’ non è quella dei piccoli contabili e burocrati; è caos, conflitto e morte.
Ironicamente, il filmato all’inizio del film che viene proposto ai piloti prossimi a partire in missione, è tutto teso a dimostrare il contrario: la natura non è una forza avversa – assicura il commentatore – bensì è amica, può significare addirittura la salvezza, se solo sai farne uso. Gli aviatori, e forse il regista con loro, si fanno beffe di questa sorta di catechesi militare dal tono propagandisticamente, crassamente ottimista, ma sarà quello che Dengler riuscirà a fare: trasformare una potenzialmente mortale nemica, la natura appunto, in un’alleata. Perché se un compagno di prigionia di Dengler sostiene che è assurdo evadere dal campo per ritrovarsi nella giungla, che in fin dei conti è ‘la vera prigione’, essa d’altra parte, con le infinite possibilità di nascondersi che offre, può effettivamente rappresentare la salvezza, almeno fino a che un elicottero di salvataggio non si accorga finalmente di lui, sottraendolo definitivamente al pericolo.
 Il film diviene così una inevitabile glorificazione dell’eroe americano e dell’homo faber in generale, una sorta di Robinson Crusoe artefice del proprio destino, che stride talmente con gli scenari cupi e pessimistici cui ci ha abituato il regista da essere certi che per lui deve essersi trattato di un divertissement tutto particolare, un gioco ironico e compiaciuto.
Il film diviene così una inevitabile glorificazione dell’eroe americano e dell’homo faber in generale, una sorta di Robinson Crusoe artefice del proprio destino, che stride talmente con gli scenari cupi e pessimistici cui ci ha abituato il regista da essere certi che per lui deve essersi trattato di un divertissement tutto particolare, un gioco ironico e compiaciuto.
Criticato come film “metà Herzog e metà Hollywood” (Rick Groen su The Globe and Mail), in realtà è proprio in questo ibrido – in fondo apparente- che il film trova la sua originalità e la sua forza. La celebrazione finale dell’eroe, che a molti è parsa convenzionale, è al contrario quasi un’esigenza viscerale, fisica, imprescindibile per uno spettatore che per due ore è diventato lo stesso Dengler, tanto Herzog è capace di annullare la distanza tra lo spettatore e il personaggio che si muove a agisce sullo schermo, in modo ben più consistente e reale di quanto avvenga in favole come La rosa purpurea del Cairo o simili.
Anche la scelta del genere, la storia di fuga, è stata considerata convenzionale (“un nobile sforzo, incapace di imporsi per originalità in un genere ormai saturo”, scrive Paula Nechak sul Seattle Post-Intelligencer). Certo, i racconti di spettacolari evasioni sono un topos fondamentale della cultura occidentale, e trovano il loro archetipo fondante in Odisseo, nell’episodio del ciclope. Mentre i suoi compagni non fanno che piangere, nella passiva, straziata attesa di una morte certa – Polifemo infatti li sta divorando uno ad uno – Odisseo al contrario non si dà per vinto, non si rassegna. La situazione sembra disperata e senza uscita, ma è solo la mente che la rende tale, e i compagni di Odisseo, oltre a quella cui li costringe il ciclope, sono vittime di un’altra prigionia, ben più fatale, quella della loro mente. “Perché te ne stai in prigione, quando la porta è aperta?” chiede il mistico persiano Rumi. Ecco, la freschezza, la presenza mentale di Odisseo, la sua inesauribile creatività aprono porte che sembravano sprangate per sempre.
Paradigma stesso dell’uomo occidentale, ben lontano da atarassiche quiescenze di ispirazione orientale (“In principio era l’Azione”, sintetizza mirabilmente Goethe nel suo Faust) l’Odisseo che escogita l’evasione dalla grotta di Polifemo si incarna nei corso dei secoli in innumerevoli forme, in vicende reali o letterarie. E’ quest’archetipo ad incarnarsi nell’eroe di Werner Herzog, senza diventare una stanca riproposizione, come farebbe credere il sopracitato commento di Paula Nechak: si tratta, al contrario, di una sua autentica ricreazione, che racconta un tipo umano profondamente herzoghiano, che abbiamo imparato a conoscere nella sua lunga cinematografia: il puro folle, il sognatore di sogni smisurati, colui per il quale “le montagne esistono soltanto nell’immaginazione”, come dice il vecchio nell’ultima visione di Kaspar Hauser prima di morire. Ed è proprio in questa illuminazione che si cela la ‘verità estatica’.
.
QUALITA’ IN SERIE
Ci sono serie tv che sono a pieno titolo dei (lunghi) film. Quella di cui preponiamo la recensione ne è la prova. La sua prima è stata alla Mostra del Cinema di Venezia 2014.
A cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli
OLIVE KITTERIDGE
di Giancarlo Zappoli
Regia: Lisa Cholodenko
Interpreti: Bill Murray – Frances McDormand – Richard Jenkins – John Gallagher Jr. – Zoe Kazan – Martha Wainwright – Ken Cheeseman – Devin Druid – Amanda Good Hennessey – John T. Mullen – Mary Wright
Durata: 233 minuti in 4 episodi
Origine: Usa
Anno: 2014
Henry Kitteridge, sua moglie Olive e il figlio Christopher . Una famiglia americana come tante in una cittadina marittima del Maine. Ne seguiamo la vita per un quarto di secolo. Hanry è il farmacista, amato e benvoluto dai suoi clienti a cui non lesina mai la sua gentile attenzione. Olive è insegnante di matematica, severa con gli altri e con se stessa, apparentemente incapace di un sentimento che non sia di rigore e di controllo su chi le sta intorno. Christopher vive male la dimensione familiare e, non appena potrà, cercherà di liberarsene con alterni risultati. Mentre Henry è dolcemente invaghito della giovane commessa Olive si tormenta nel desiderio, che resta inappagato, per un collega.
 Questa è solo l’impostazione iniziale di una miniserie prodotta dall’HBO (che vede Tom Hanks tra i produttori esecutivi) ed ispirata al’omonimo ‘romanzo per racconti’ di Elizabeth Strout, vincitore del Premio Pulitzer nel 2009. Non capita così spesso che un film (possiamo definire così e a pieno titolo questa serie) sia in grado di rispettare non la lettera (cosa che non deve avvenire per la diversità dei linguaggi utilizzati) ma lo spirito di un libro. E’ quanto è accaduto in questa occasione in cui il senso profondo dello scorrere di una vita di coppia, la profonda introspezione psicologica delle motivazioni che inducono ognuno ad essere così com’è, vengono restituiti con forza e delicatezza al contempo. Ci voleva la volontà di un’attrice determinata come Frances McDormand per ottenere una fusione così ben riuscita di sceneggiatura (affidata a Jane Anderson) e di interpretazioni messe a disposizione di una regista capace di cogliere ogni minima sfumatura dei volti e dei gesti (non solo dei protagonisti). Ci voleva una regista come Lisa Chodolenko (I ragazzi stanno bene) per riuscire a individuare il modo giusto che amalgamasse le recitazioni di attori così diversi (tra loro un Bill Murray a cui è riservato un ruolo di rilievo nel quarto episodio) ma che sembrano aver vissuto in quelle case in cui domina il senso del dovere insieme allo spleen di ciò che si perde e si è perduto per tener fede a quella scelta. Senza che però questo faccia venir meno un amore profondo che ognuno esprime come può e sa. McDormand costruisce inquadratura dopo inquadratura, gesto dopo gesto, il ritratto di una donna tormentata interiormente dal dubbio di dover soffrire per linea ereditaria di depressione che non è in grado di mostrare il bene che vuole ai suoi cari nascondendosi sempre dietro una maschera fatta di rigidità e giudizi taglienti.
Questa è solo l’impostazione iniziale di una miniserie prodotta dall’HBO (che vede Tom Hanks tra i produttori esecutivi) ed ispirata al’omonimo ‘romanzo per racconti’ di Elizabeth Strout, vincitore del Premio Pulitzer nel 2009. Non capita così spesso che un film (possiamo definire così e a pieno titolo questa serie) sia in grado di rispettare non la lettera (cosa che non deve avvenire per la diversità dei linguaggi utilizzati) ma lo spirito di un libro. E’ quanto è accaduto in questa occasione in cui il senso profondo dello scorrere di una vita di coppia, la profonda introspezione psicologica delle motivazioni che inducono ognuno ad essere così com’è, vengono restituiti con forza e delicatezza al contempo. Ci voleva la volontà di un’attrice determinata come Frances McDormand per ottenere una fusione così ben riuscita di sceneggiatura (affidata a Jane Anderson) e di interpretazioni messe a disposizione di una regista capace di cogliere ogni minima sfumatura dei volti e dei gesti (non solo dei protagonisti). Ci voleva una regista come Lisa Chodolenko (I ragazzi stanno bene) per riuscire a individuare il modo giusto che amalgamasse le recitazioni di attori così diversi (tra loro un Bill Murray a cui è riservato un ruolo di rilievo nel quarto episodio) ma che sembrano aver vissuto in quelle case in cui domina il senso del dovere insieme allo spleen di ciò che si perde e si è perduto per tener fede a quella scelta. Senza che però questo faccia venir meno un amore profondo che ognuno esprime come può e sa. McDormand costruisce inquadratura dopo inquadratura, gesto dopo gesto, il ritratto di una donna tormentata interiormente dal dubbio di dover soffrire per linea ereditaria di depressione che non è in grado di mostrare il bene che vuole ai suoi cari nascondendosi sempre dietro una maschera fatta di rigidità e giudizi taglienti.
 Al suo fianco uno straordinario Richard Jenkins, un Henry Kitteridge uomo di natura profondamente gentile ma non per questo ciecamente sottomesso ai voleri muliebri, capace di attenzioni spesso non recepite ma anche in grado di mostrare il proprio disagio. Non è facile realizzare una serie che offra al contempo lo spaccato di un microcosmo di provincia, una lettura sociologica di alcune realtà statunitensi (le differenze di concezioni di vita tra gli Stati e il divario metropoli/piccola città) insieme a una profonda riflessione sul senso e sulla fatica (ma anche sulle gioie) del vivere in famiglia e dell’essere genitori a cui è chiesto di fare sì che i figli possano davvero prima o poi volare via dal nido che sentono angusto. Ognuno ‘facendo le cose giuste’ ma anche commettendo errori in questo complicato e quasi pavesiano mestiere di vivere.
Al suo fianco uno straordinario Richard Jenkins, un Henry Kitteridge uomo di natura profondamente gentile ma non per questo ciecamente sottomesso ai voleri muliebri, capace di attenzioni spesso non recepite ma anche in grado di mostrare il proprio disagio. Non è facile realizzare una serie che offra al contempo lo spaccato di un microcosmo di provincia, una lettura sociologica di alcune realtà statunitensi (le differenze di concezioni di vita tra gli Stati e il divario metropoli/piccola città) insieme a una profonda riflessione sul senso e sulla fatica (ma anche sulle gioie) del vivere in famiglia e dell’essere genitori a cui è chiesto di fare sì che i figli possano davvero prima o poi volare via dal nido che sentono angusto. Ognuno ‘facendo le cose giuste’ ma anche commettendo errori in questo complicato e quasi pavesiano mestiere di vivere.
.
Credits n.4
Carte di Cinema
Sede c/o FEDIC dott.ssa Antonella Citi, Via E.Toti, 7 – Montecatini Terme (PT)
E-mail: cartedicinema@hotmail.com
Carte di Cinema è edito dalla FEDIC -Federazione Italiana dei Cineclub
Direttore responsabile: Paolo Micalizzi
Direttore editoriale: Roberto Merlino
Redazione: Maurizio Villani
Progetto grafico e impaginazione: Lorenzo Bianchi Ballano
Hanno collaborato al numero 4 dalla rivista online: Ugo Brusaporco, Rita Castaldi, Maria Pia Cinelli, Giulio D’Amicone, Elio Girlanda, Roberto Lasagna, Francesco Saverio Marzaduri, Roberto Merlino, Paolo Micalizzi, Andreina Sirena, Maurizio Villani, Giancarlo Zappoli.