IL CUBO DI RUBIK (ovvero le molteplici facce di un film)
Contributi di Paolo Micalizzi, Valeria Mannelli, Andreina Sirena, Maurizio Villani
Sommario
- 1 “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino
- 2 FEDIC, LE PERSONE ED I FATTI
- 2.1 SARDINA FILM FESTIVAL. LA IX EDIZIONE TRA ANTEPRIME NAZIONALI E DIBATTITI SUL CINEMA IN SARDEGNA
- 2.2 SUPERARE MANTENENDO – 32° VALDARNO CINEMA FEDIC
- 2.3 PRIMA FESTA DEL CINEMA CORTO Laboratori di studio e proiezioni di corti dedicati ai soci Fedic
- 2.4 Il FESTIVAL DEL CINEMA DI BRESCELLO ha i numeri per essere un riferimento nel panorama italiano
- 3 FESTIVAL
- 4 LIBRI
- 5 SAGGI
“La grande bellezza” di Paolo Sorrentino
LA DOLCE VITA NO, LA DOLCE VITA SI
di Paolo Micalizzi
La dolce vita no, La dolce vita si. Una ridda di dinieghi e poi di assensi dello stesso Paolo Sorrentino a proposito del riferimento della stampa del suo “La grande bellezza” al film di Federico Fellini. A noi, ma non solo a noi, il riferimento è sembrato, dopo aver visto il film, subito plausibile. Certo, in un primo tempo il regista Paolo Sorrentino lo ha negato in previsione forse del probabile successo al botteghino e della corsa all’Oscar: il riferimento al film di Fellini, grande successo a livello mondiale, pensava forse potesse nuocergli. Cosa che non è avvenuta perché “La grande bellezza” ha incassato molto al botteghino, e non solo, e l’Oscar lo ha ottenuto. Anche se il film di Paolo Sorrentino al Festival di Cannes non aveva avuto successo e non era stato gratificato di giudizi tutti positivi da parte della critica: non aveva quindi avuto quei consensi che, soprattutto, regista, produzione e distribuzione si aspettavano. Occorreva, quindi per raggiungere gli obiettivi preposti, una vera e propria operazione di marketing. Che, con molta professionalità, chi ne era preposto ha realizzato con ottimi risultati. Comunque, perché negare il riferimento al film di Federico Fellini quando ciò ai più è evidente? E che male c’è ad ammettere che “La grande bellezza” è da considerarsi un affresco della società romana di oggi ,cosi come quella di Fellini lo era stato degli anni Sessanta? Lì, una Roma da sogno per chi la guardava con gli occhi di chi ambiva a poterla frequentare perché vi era, come i giornali strombazzavano, una “dolce vita” e la Roma rappresentata era veramente di una “grande bellezza”. E non soltanto per i monumenti o i luoghi frequentati dai protagonisti ma anche per l’atmosfera gioiosa, di grande divertimento che la permeava. Oggi, invece, nel film di Sorrentino Roma è di una grande tristezza, frequentata come risulta da grandi cialtroni che ne “degradano” la grande bellezza. Per cui il titolo, a nostro parere, sarebbe stato meglio fosse riferito ad un’attenzione ironica sulla città eterna da parte del regista, che però non sembra possa rilevarsi. Ciò che si coglie nel film di Sorrentino è però un grande senso dello Spettacolo. E basterebbe per farne un grande film e per considerare Paolo Sorrentino un regista di grande valore. Anche se noi, e non solo noi, preferiamo il Paolo Sorrentino regista d film intimi ma intensi come “L’uomo in più”, “Le conseguenze dell’amore”, “L’amico di famiglia”, anche se apprezzabile nei suoi intenti è anche “Il divo”. Condividendo poi l’ambizione di Paolo Sorrentino di realizzare film che possano avere un grande impatto mediatico lanciandolo in una dimensione nuova, più hollywoodiana, del suo cinema; e un segnale significativo è dato dalla realizzazione del film, con Sean Penn “This Must Be the Place”. Quindi, ci rimane ancora oscura la ragione per cui Paolo Sorrentino negava, in un primo tempo, il riferimento al film di Fellini: sappiamo che alla premiazione agli Oscar lo ha poi indicato come uno dei registi (l’altro è Martin Scorsese) che lo hanno ispirato. Perché, in fondo, non ammettere l’ispirazione felliniana sin dall’inizio e farne prendere coscienza?
LA CRISI DI UN UOMO
di Valeria Mannelli
“Abbiate rispetto della vostra curiosità” sottolinea in una scena tagliata, il maestro-regista, intervistato da Jep Gambardella (Tony Servillo), sessantacinquenne, protagonista del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Film vincitore dell’Oscar per la migliore opera straniera, già in possesso del Golden Globe e presentato all’ultimo Festival del film di Cannes.La curiosità, mista all’infelicità e la miseria umana; il vuoto di una società, sfasciata nella volgarità di corpi e volti rifatti, in una Roma dalla luce e dalla bellezza straziante, da San Pietro in Montorio, all’acqua increspata del Fontanone, i resti dell’Acquedotto Claudio, le Terme di Caracalla, Villa Medici, Villa Spada e tanto altro più o meno riconoscibile agli occhi di chi Roma, la conosce davvero, sembra essere l’oggetto di questo film “incredibile” dal punto di vista visivo, povero di narrazione, perché proprio ciò che racconta è l’assenza e la perdita dell’innocenza, che gli occhi di Jep Gambardella ritrovano solo nei bambini e nella bella Ramona (Sabrina Ferilli). “ La grande bellezza” non è nella gente ma nei quadri, le statue dei palazzi barocchi, i giardini ornamentali, i resti archeologici della città eterna. Inquadrature rubate ad un tempo e uno spazio “altro”, che sogna lo sguardo di Jep, che vede il mare sul soffitto della sua bella camera da letto nell’attico sopra il Colosseo.
Jep Gambardella è stato (e sembra esserlo ancora) “il re dei mondani”, arrivato a Roma a 26 anni. Scrive su un importante giornale, di cui gli importa poco. Trascorre le sue notti tra feste, mostre, allestimenti e performance di arte contemporanea varia. Ha scritto un solo libro ‘L’apparato umano’, molti anni prima, vincendo il Premio Bancarella, in compagnia di “un improbabile circo” di amici : Viola (Pamela Villoresi), donna molto ricca, con un figlio psicodepresso, che si toglierà la vita, Stefania (Galatea Ranzi) prolifica scrittrice, radical chic “d’impegno civile”, Romano (Carlo Verdone), autore teatrale sconfitto dalla grande città, che farà ritorno al suo paese, poi Lello (Carlo Buccirosso) il venditore di giocattoli e la moglie Trumeau (Iaia Forte) e la nana Dadina (Giovanna Vignola), direttrice del giornale su cui scrive Jep.
“La grande bellezza” non racconta una storia, ma la crisi di un uomo che vorrebbe ancora scrivere, il vuoto esistenziale che lo circonda, l’assenza di spiritualità e di fede, così fortemente cercata nei tanti preti, suore, cardinali, che abitano il film; basti pensare al cardinale Bellucci (Robert Herlizka), che sciorina una ricetta dietro l’altra, “esperto conoscitore” della tenuta Tebaldi, molto poco interessato alla cura dello spirito. Solo verso la fine del film viene mostrata “La Santa” (Giusy Merli), l’unico personaggio “vero” dal punto di vista spirituale, che va a cena da Jep, insieme al suo assistente-impresario pelato, le cui uniche parole ricordano che ‘La povertà la si vive’, non la si può raccontare. E’ l’unica in grado di richiamare gli aironi e di ricordare a memoria il loro nome di battesimo. La Santa dorme per terra, si nutre solo di radici, perché sono importanti per l’uomo e non averne significa essere senza memoria. Sicuramente la seconda visione fa apprezzare maggiormente il film, abbandonata la ricerca di rintracciare a tutti i costi una storia, ci si affida alle immagini e alle parole di Jep e dei personaggi a cui di volta in volta si accosta, Ramona, il marito di Elisa, l’unica donna amata molti anni prima. I suoi ricordi e le sue riflessioni sul vuoto della vita che conduce. “Una cosa l’ho capita”, dice Jep : “ A sessantacinque anni, non voglio fare le cose che non mi va più di fare” . Così con una colonna sonora che alterna sacro e profano dal ‘Dies Irae’ di Zbigniew Preisner (ovvio richiamo a Kieslowski) a Raffaella Carrà, si consumano le immagini di una città torbida e meravigliosa ormai al tramonto, dal sapore dolciastro e stucchevole. Citazioni continue di tanto cinema d’autore, “Otto e mezzo” di Federico Fellini con le lunghe carrellate nel Parco delle terme, dove uomini di fede , vecchi, donne, corpi in declino aspettano “la cura delle acque”, mentre i personaggi del film di Sorrentino, aspettano l’atteso turno, come dal macellaio, la puntura miracolosa del chirurgo del botox, che non perdona chi l’ha tradito. Ieri le acque, oggi il botox per risanarsi dentro e fuori; ma non si salva nessuno in questa società sull’orlo della disperazione, senza pietà se non per qualche anima ingenua, che non sa ancora nuotare a quarant’anni, ma che ancora un posto non ha in questo mondo di truffatori, ipocriti e buffoni. E la fine è nota, Jep Gambardella accetta di fare il servizio sui resti della Costa- Concordia ancora al largo dell’isola del Giglio, luogo magico e sogno di un altrove, dove si è lentamente consumato il suo primo amore.
DAL DOLORE DELLA NOIA AL RITROVARE SE STESSI
di Andreina Sirena
Il cannone del Gianicolo che spara un colpo a mezzogiorno inaugura “La grande bellezza” con suggestioni e reminiscenze risorgimentali; seguono infatti la statua equestre di Garibaldi e il busto di Gustavo Modena.
Ma il tempo delle passioni politiche e civili è tramontato per sempre.
L’uomo risorgimentale si infiammava sulle note delle opere di Verdi, ma una volta consumata l’orgia nazionalistica, dopo l’Unità d’Italia, si era ritrovato improvvisamente destituito di senso, privo di mete e scopi. L’eroe andava ripiegandosi su se stesso, scoprendovi un mondo sconfinato, quello della propria interiorità: ne troviamo traccia già nelle opere del tardo Verdi, e – per eccellenza – in Puccini, dove la dimensione civile sparisce completamente – unica eccezione la Tosca, ma siamo ad anni luce dalla vis politica verdiana – , sostituita da un’intimissima ‘teoria degli affetti’, da una struggente disamina del mondo del sentimento. Ma il mondo in cui vive Jep Gambardella, di cui lui stesso è espressione, e sul quale può vantare una sorta di superiorità solamente in quanto la miseria che lui stesso incarna diviene in lui cosciente, ebbene quel mondo ha smarrito qualsiasi dimensione: privo di passioni civili, è altrettanto incapace di ripiegarsi su stesso.
La volgarità televisiva, la mondanità alienante – l’esclusività della quale non la rende per questo meno massificata e massificante – l’ha estraniato a se stesso. E alla domanda: “chi sono io?”, che Jep riprende da “Nadja” di Breton (1928) non c’è alcuna risposta. Il Peer Gynt di Ibsen sfogliava una cipolla -in analogia con l’Io – di strato in strato, alla ricerca di un inesistente nocciolo: alla fine non gli restava in mano nulla. Lo stesso vale per Jep. “Chi sei?” “Io sono…” “No, tu non sei nessuno”, sentenzia lapidaria la bambina che Jep incontra nel chiostro di San Pietro in Montorio, irraggiungibile, separata da lui da una grata: una voce che emerge dalle viscere della terra come quella dell’oracolo di Delfi, una bocca della verità incarnata dal candore dell’infanzia, come il bambino che smaschera il re nella favola di Andersen “I vestiti nuovi dell’imperatore”.
Jep Gambardella ha trascorso una vita totalmente incurante dello splendido monito di Constantinos Kavafis: “E se non puoi la vita che desideri/ cerca almeno questo/ per quanto sta in te: non sciuparla/ nel troppo commercio con la gente/ con troppe parole in un viavai frenetico./ Non sciuparla portandola in giro/ in balìa del quotidiano/ gioco balordo degli incontri/ e degli inviti,/ fino a farne una stucchevole estranea”, e se anche pretende di aver compiuto, a sessantacinque anni, la “sorprendente scoperta… che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare”, eppure di fatto continua a perdere tempo, e a farle.
La sua dimora è posta simbolicamente innanzi al Colosseo, sede di quegli spettacoli – i proverbiali “panem et circenses” di Giovenale – che, in perfetta analogia con l’odierna televisione e le ributtanti feste mostrate nel film, ottenebravano e sedavano la coscienza degli antichi. I personaggi del film di Sorrentino non riescono ad aderire alla ‘grande bellezza’ nemmeno se vi dimorano: sembrano sempre degli intrusi, degli abusivi, dei corpi estranei. Così accade per eccellenza con la vacua, annoiata Orietta, che abita addirittura dentro la chiesa di Sant’Agnese in Agone in piazza Navona – un colpo di genio del regista, tanto la cosa è ovviamente visionaria, inverosimile. E questa impossibilità di adesione trova la sua espressione iperbolica e paradossale nella perfomance ‘artistica’ di Talia Concept nel Parco degli Acquedotti, dove il prendere a testate l’Acquedotto Claudio può essere visto come un tentativo estremo quanto patetico, velleitario di “adesione alle cose”, come lo è il colpo di pistola alla tempia nel finale di “Fuoco fatuo” (1931) di Drieu La Rochelle (“Una pistola, è solida, è d’acciaio. E’ una cosa. Aderire, finalmente, alle cose”). E il nulla, ancora una volta, che Jep Gambardella mette a nudo aldilà delle mistificazioni confuse dell’artista durante l’intervista successiva alla performance, ricorda un altro confronto demistificatorio nella storia del cinema, quello di Antonius Block con la strega prossima ad essere bruciata sul rogo ne “Il Settimo sigillo”. Assetato com’è di risposte su Dio, il cavaliere vorrebbe interrogare a questo proposito il diavolo. La strega lo rassicura sulla facilità della cosa, basterà fissarla negli occhi per mettersi in contatto col maligno. Ma anche questa è l’ennesima menzogna che nasconde solo il terrore (“Guardami fisso negli occhi… guarda, guarda bene… non lo vedi?” “Vedo solo il tuo disperato terrore, nient’altro… ecco ciò che vedo.”).
Allorché, dopo tanti prima di lei, persino Suor Maria, la Santa, chiede a Jep come mai non abbia più scritto un libro, lui risponde: “Cercavo la grande bellezza, ma non l’ho trovata”. Eppure vi passa accanto, pressoché ogni mattina, di ritorno dalle sue feste mondane. E’ la Roma sfolgorante di luce quanto intima e raccolta. Nascosta, deserta e pura. Vibrante di una religiosità dal sapore arcaico, agreste. Si avverte una sorta di presenza numinosa nel bosco del Gianicolo, quasi una epifania del dio Pan. (Nell’antichità, il mezzogiorno, e non la mezzanotte, era l’ora degli spiriti, dei sortilegi e della morte. L’ora panica per eccellenza. E a mezzogiorno tuona il cannone del Gianicolo, con cui si apre il film. E un turista muore). O l’immagine di candore e innocenza dei bambini dietro le sbarre del portico di Santa Sabina. Una suora li richiama, loro abbandonano il cancello, ma una bambina indugia, lo sguardo fisso su Jep: due universi completamente differenti si osservano, tra loro vi sono solo pochi metri di distanza, ma l’inferriata che li divide simboleggia un limite invalicabile, un’irredimibile alterità, come nel finale de “La dolce vita”, quando Marcello – reduce da un festino notturno – ritrova Paola sulla spiaggia antistante la villa in cui si è consumata la festa, una ragazzina umbra conosciuta in precedenza, incarnazione di purezza e innocenza. Sono molto vicini, divisi soltanto da un fiumiciattolo, Paola gli rivolge la parola – l’offerta di una speranza in extremis, di una redenzione – ma Marcello, a causa del rumore del mare, non comprende. Allora le fa un cenno di saluto e si allontana. Lei lo segue con lo sguardo. Al pari di questa scena, lo scambio di sguardi tra Jep e la ragazzina è una potente icona dell’incomunicabilità tra due mondi. La Basilica di Santa Sabina assurge a metafora di uno spazio di bellezza incontaminata, un hortus conclusus, a Jep fatalmente precluso. Spesso nel film si scorgono suore che ridono divertite e furtive. Quasi possedessero un segreto e se ne compiacessero. Quasi guardassero con ironico compatimento coloro che, là fuori, rincorrono e si affannano a vuoto come criceti nella ruota. E l’irriducibilità del contrasto tra la ‘grande bellezza’ che pure è a un passo da lui e lo sfacelo morale (ma anche estetico: i volti deformati dal botulino alla festa di compleanno) del mondo in cui vive Jep è magistralmente illustrato dallo stacco – brutale e violento – tra la scena in cui un coro femminile canta le note ipnotiche, ascetiche e sublimi di David Lang all’interno dell’edificio della Fontana dell’Acqua Paola, e l’urlo sguaiato e osceno con cui si apre la festa sul terrazzo di un palazzo in via Bissolati n.5: una impressionante epifania del brutto, esasperata dall’improvviso passaggio da “I lie” di Lang al ributtante remix di Bob Sinclair “A far l’amore comincia tu”.
Vi sono momenti nel corso del film in cui il torpore spirituale di Jep riesce ad essere finalmente scosso: quando apprende della morte di Elisa, l’unico amore della sua vita, quando – di contro alla sua visione del funerale come “l’evento mondano per eccellenza”, dove ogni atteggiamento deve essere artefatto e studiato – scoppia in un pianto disperato mentre trasporta la bara di Andrea… momenti, questi, di autenticità – “il silenzio e il sentimento, l’emozione e la paura” – che però vengono poi irrimediabilmente sedimentati “sotto il chiacchericcio e il rumore”. Perché qualcosa finalmente cambi davvero, occorre che “la grande bellezza” stessa si chini su di lui e “venga a casa sua”, come già Gesù con Zaccheo: e la grande bellezza si manifesta nel volto iperbolicamente vecchio e rugoso di Suor Maria, la Santa – così lontano dai volti deformati della festa sul terrazzo, così lontano dal volto gonfio e sfracellato di una irriconoscibile Serena Grandi. E’ soltanto attraverso le parole della Santa che Jep ritrova in Elisa – fino ad allora solo un ricordo struggente, una bruciante nostalgia – un senso, per vivere e scrivere. “Sa perché mangio sempre radici?” “No. Perché?” “Perché le radici sono importanti”. Jep rievoca la prima volta in cui ha amato Elisa, all’Isola del Giglio. Solo allora, grazie alle parole della Santa, comprende che Elisa è la sua radice, lo è sempre stata. Ha trascorso una vita vuota, da sradicato, ma ora non perderà più tempo. Si è ritrovato. E’ un ritrovarsi doloroso, certo. Del resto, ha passato tutta la vita cercando di soffocare, di assordare il dolore nella noia. Ma ora non ha più intenzione di continuare ad ottundersi, di sfuggire a se stesso. “Il chiacchericcio e il rumore” non seppelliranno più “il silenzio e il sentimento, l’emozione e la paura”. Anche lui percorrerà dolorosamente – a modo suo – la sua scala santa, come fa la Santa. Il suo terrazzo si popola di fenicotteri. La Santa li congeda con un soffio. Essi sono simbolo del passaggio dell’anima dalle tenebre alla luce: “Dunque, che questo romanzo abbia inizio!”.
JEP GAMBARDELLA ESISTE?
di Maurizio Villani
La domanda del titolo suggerisce alcune considerazioni sulla statuto ontologico di un personaggio cinematografico. Il riferimento al protagonista de “La grande bellezza” è pertinente alla dedicazione monografica di questo numero della rivista, ma costituisce un’esemplificazione particolare di una riflessione generale sull’esistenza dei personaggi immaginari.
La dimensione all’interno della quale si sviluppa il ragionamento è quella della finzione. Il personaggio immaginario è tale perché è presente nel film, in quanto opera di finzione. Tra i molti significati di questo termine qui interessa l’accezione della “finzione senza inganno”, ossia l’invenzione dell’artista che costruisce una realtà “altra” rispetto a quella normalmente esperita, intorno alla quale, però, sia l’artista che i fruitori dell’opera d’arte sono d’accordo nell’accettare la finzione. Coleridge parlava di “fede poetica” a proposito della “volontaria e momentanea sospensione dell’incredulità” che accompagna lo spettatore di fronte alla realtà “altra” creata dall’artista.
A proposito della finzione artistica Aristotele, in un celebre passo della ‘Poetica ‘(1451 a-b) sostiene tre tesi: che l’oggetto della rappresentazione artistica è costituito da cose e fatti possibili, che potrebbero accadere “secondo verosimiglianza e necessità”; che l’arte non dipende dal contenuto di verità del suo oggetto, ma soggiace al criterio della verosimiglianza (può sganciarsi dalla realtà effettuale, rappresentando cose, fatti e personaggi non come sono, ma come potrebbero essere); che l’artista non imita semplicemente cose o fatti particolari, ma nel riprodurre i loro modelli rappresenta ciò che c’è di universale in quei modelli.
Da queste brevi notazioni risulta evidente come la natura del personaggio immaginario di una finzione filmica contenga in sé una complessità di questioni, ciascuna delle quali richiederebbe una trattazione autonoma. Ci limitiamo a quella essenziale, indicata nel titolo: l’esserci del personaggio. Ogni altro carattere può essergli attribuito a condizione che ci sia o esista. Di ciò intendiamo parlare.
Possiamo iniziare dicendo che Jep Gambardella, come ogni personaggio immaginario, non è un ente reale. Se ente reale è tutto ciò che esiste nella realtà di cui abbiamo esperienza, allora Toni Servillo è un ente reale ed esiste, mentre Jep Gambardella non è un ente reale e non esiste.
Però questa soluzione temporanea non ci può soddisfare, perché ogni critico o spettatore del film di Sorrentino parla di Jep Gambardella come se esistesse.
Molti filosofi si sono posti la domanda relativa all’esistenza o meno dei personaggi immaginari. Scartata per loro la definizione di “enti reali”, è stata proposta quella di “enti fittizi” (l’aggettivo ha la stessa radice di “fingere” e rimanda alle considerazioni sulla “finzione” fatte in precedenza). Come va inteso lo statuto ontologico di questi enti? Una risposta radicale – a mio parere non condivisibile – è quella chiamata “eliminativista”, che compare per la prima volta in un saggio di Bertrand Russell del 1905 (tr. it. Sulla denominazione, in ‘La struttura del linguaggio’, Bompiani, Milano 1973) e poi ripresa da altri. Secondo questa tesi le entità fittizie non hanno statuto ontologico, non esistono, e noi possiamo rapportarci ad esse solo all’interno di un gioco in cui si fa finta che esse abbiano un riferimento, anche se in realtà non è così. Jep Gambardella non è vero che esiste, ma noi facciamo finta che la finzione di cui fa parte sia vera, e allora, nella finzione, Jep Gambardella esiste.
Un secondo tipo di risposta, elaborato da vari filosofi analitici (Lamarque, Van Inwagen, Salmon) considera le entità fittizie come oggetti astratti e, come tali, esistenti nel mondo reale anche se in forma diversa da come esistono gli oggetti concreti. Secondo questa tesi Jep Gambardella non avrebbe un’esistenza concreta di scrittore-giornalista-mondano, ma sarebbe un oggetto astratto, simile ad un ente matematico.
Un’altra risposta, a mio parere assai più convincente, è quella che muove dalle posizioni del filosofo austriaco Alexius Meinong (1853-1920), autore di un celebre trattato ‘Sulla Teoria degli Oggetti’ (1904). In quest’opera Meinong intende fondare una scienza che studi tutti gli oggetti in quanto oggetti, non solo quelli esistenti,, ma anche quelli non-esistenti (tali sono gli oggetti ideali come i numeri o i criteri di giudizio). Ai fini del nostro ragionamento, la distinzione tra oggetti esistenti e non-esistenti (ripresa nel tardo Novecento da altri autori) è illuminante, perché consente di affermare che le entità fittizie (come, ad esempio i numeri) non esistono, ma ci sono. Se accogliamo questa distinzione tra “esistere” ed “esser-ci”, molte delle difficoltà che ci si sono presentate possono venir superate e Jep Gambardella – e con lui tutti i personaggi immaginari del cinema (o della letteratura) – acquistano una solida consistenza ontologica che ci consente di attribuire loro i caratteri rappresentativi e le proprietà simboliche che sostanziano ogni discorso critico sulle storie e i protagonisti delle opere cinematografiche.
Se accettiamo la conclusione cui siamo pervenuti, ossia che Jep Gambardella c’è, possiamo tentare di verificarne la validità utilizzando il cosiddetto paradosso della finzione. Con questa espressione si intende la situazione paradossale in cui viene a trovarsi lo spettatore che prova reazioni emotive o cognitive reali a fronte dello svolgimento di una finzione, i cui protagonisti non esistono nella realtà.
Ne “La grande bellezza” il protagonista è scrittore di un solo libro giovanile, poi giornalista tuttologo, è il re dei mondani che non voleva solo partecipare alle feste, ma voleva avere il potere di farle fallire; è circondato da «un bestiario umano senza speranza, a un passo dall’abisso, prossimo all’estinzione, eppure ancora sguaiatamente vitale fatto di poeti muti, attrici cocainomani fallite in procinto di scrivere un romanzo, cardinali-cuochi in odore di soglio pontificio, imprenditori erotomani che producono giocattoli, scrittrici di partito con carriera televisiva, drammaturghi di provincia che mai hanno esordito, misteriose spogliarelliste cinquantenni, sante oracolari pauperiste ospiti di una suite dell’Hassler. Jep Gambardella tutti seduce e tutti fustiga con la sua lingua affilata, la sua intelligenza acuta, la sua disincantata ironia» (Dario Zonta).
La reazione emotiva dello spettatore di fronte a questa serie di situazioni e di personaggi costituisce da sempre un elemento essenziale del rapporto con l’opera d’arte. Ancora Aristotele, nelle pagine già citate della ‘Poetica’, parlando della tragedia la definisce come un genere poetico che imita azioni nobili, che si esprime in un linguaggio elaborato, che mette in scena un’azione drammatica, che suscita emozioni di pietà e di terrore, purificando lo spettatore dalle passioni.
Che si provino emozioni, anche forti, assistendo ad una finzione cinematografica pare un fatto accettato da tutti i principali filosofi che si sono occupati del problema, Come spiegarle è questione dibattuta.
Tra le varie soluzioni proposte ne riportiamo due: la soluzione finzionalistica e quella irrazionale.
Secondo i finzionalisti, di fronte ad una finzione non si può provare un’emozione autentica (possibile solo in una situazione della vita reale); si provano solo quasi-emozioni, simili alle emozioni autentiche, ma differenti perché avvertite da chi partecipa ad un gioco di fare finta. Ossia, il coinvolgimento emotivo in una situazione di finzione è dissimile da quello autentico che si prova nella realtà, ed è riconducibile alla reazione a quanto sta accadendo nel gioco al quale stiamo partecipando. Si vedano al riguardo le tesi di Kendall Walton in ‘Mimesi as Make-Believe’ (1990).
La soluzione irrazionale non distingue tra emozioni (reazioni a situazioni reali) e quasi-emozioni (reazioni a situazioni fittizie). Considera tutte le emozioni dello stesso tipo. I filosofi di questa tendenza – ad esempio Colin Radford – credono che l’intera sfera emotiva della psiche umana rientri nell’ambito dell’irrazionale, onde l’irrazionalità dell’oggetto che provoca l’emozione provoca l’irrazionalità dell’emozione stessa.
Abbiamo dato conto di due delle risposte date nel recente dibattito filosofico agli interrogativi posti dal paradosso della finzione. Anche se sono soluzioni che possono offrire utili piste di ricerca, a noi paiono poco convincenti perché entrambe ci imporrebbero dei costi teorici insostenibili. Infatti, se accettassimo la tesi finzionalista, dovremmo rinunciare all’autenticità delle emozioni che proviamo alla visione di un film; se accettassimo la tesi irrazionalista, dovremmo ritenere irrazionali le reazioni emotive che abbiamo davanti ad una finzione cinematografica.
FEDIC, LE PERSONE ED I FATTI
SARDINA FILM FESTIVAL.
LA IX EDIZIONE TRA ANTEPRIME NAZIONALI E DIBATTITI SUL CINEMA IN SARDEGNA
di Giulia Marras
Si è svolta dal 23 al 28 Giugno a Sassari la IX edizione del Sardinia Film Festival, non una semplice rassegna cinematografica, come tengono a sottolineare il direttore artistico Carlo Dessì e il presidente Angelo Tantaro, ma un vero e proprio Premio Internazionale di Cortometraggi dedicato ai registi emergenti di tutto il mondo e alla terra che lo ospita, che di cinema vorrebbe vivere di più. Sono stati mostrati al pubblico più di 200 corti selezionati tra gli oltre 700 iscritti al concorso, numeri che attestano la posizione di rilevanza raggiunta dal Festival negli anni, e anche organo di preselezione per i migliori corti dei Nastri d’Argento nazionali.
La vasta selezione ha offerto una panoramica sui temi urgenti e più sentiti dai filmakers i quali, nonostante provenissero da angoli opposti del mondo, sia fisicamente che culturalmente, sono sembrati convergere attraverso il cinema in anime simili, con la paura per la precarietà, lavorativa e affettiva, la fragilità e la forza dell’ambiente familiare, la distanza delle istituzioni, la vita connessa ai social, l’affermazione della propria identità, compresa quella sessuale. Divisi in generi, i corti non sono solo stati proiettati all’interno del Quadrilatero dell’Università di Sassari (nel quale si sono visti soprattutto Fiction e Documentari) ma anche all’Accademia delle Belle Arti, nella quale sono stati programmati i corti di Animazione, Sperimentazione e VideoArte, e alla Biblioteca Comunale dove, in un pomeriggio completamente dedicato ai bambini, si è svolto il lavoro della Giuria Kids, coinvolgendo in questo modo diverse aree della vita cittadina e diverse fasce di pubblico.
Ma oltre al concorso, sono stati tanti gli eventi speciali che hanno caratterizzato questo nono Sardinia Film Festival: a partire dalla prima giornata, che ha visto l’omaggio a Fabio Masala, operatore culturale tra i fondatori della Cineteca Sarda, e in serata la proiezione del documentario “140. La strage dimenticata” di Manfredi Lucibello, racconto per testimonianze e ricostruzioni audio-visive del disastro della Moby Prince del 1991: durante la serata è intervenuto anche il deputato SEL Michele Piras, primo firmatario per l’apertura di una Commisione d’Inchiesta per il caso ancora senza soluzione.
Due giornate poi sono state interamente dedicate a Moviementu- ReteCinemaSardegna: esattamente un anno fa infatti, nello stesso SardiniaFilmFestival, gli operatori dello spettacolo avevano preso la decisione di associarsi a fronte delle difficoltà in cui si era (o è) fossilizzato il settore cinematografico in Sardegna, dopo il blocco delle Legge Cinema e le indecisioni di una giovane e inesperta Film Commission. Il 26 e 27 Giugno i soci di Moviementu si sono così riuniti in assemblee pubbliche e gruppi di lavoro per dibattere sugli obiettivi raggiunti, e non, nell’anno di attività e sul ruolo che l’associazione intende darsi nel prossimo futuro; importante anche la breve presenza “d’ascolto”durante una mattinata di dibattiti dell’on. Gavino Manca, Presidente della Commissione Cultura e Lavoro regionale, che non solo ha potuto inquadrare le entità dei problemi e sentire le ragioni delle voci interne al settore, ma anche promesso al più presto un tavolo di riunione con la Film Commission, l’Assessorato e i soci del movimento, per poter finalmente lanciare il cinema come un’industria culturale che smuova l’economia dell’isola. Nella serata del 26 sono stati proiettati in anteprima corti e teaser dei prossimi lavori dei soci, tra cui Enrico Pau con il suo “Due destini”, “Bella di notte” di Paolo Zucca e “Terzo tempo”, lungometraggio in uscita sugli effetti del set cinematografico de “L’arbitro” sulla popolazione coinvolta e sul territorio dove è stato girato il film. Qui è intervenuto anche l’Assessore alla Cultura Claudia Firino, che ha ribadito l’importanza del Festival per i giovani, per la formazione culturale e per la crescita economica di tutta l’isola.
Ma gli autori sardi sono stati i protagonisti anche dell’ultima serata di proiezioni, con “La vita adesso” di Salvatore Mereu, “Un atto di dolore” di Joe Bastardi (che ha vinto il Premio Vetrina Sardegna) e “Culurzones” girato da Francesco Giusiani ma scritto da Federico Lubino, filmaker emergente scomparso prematuramente, a cui è andata la tessera onoraria di Moviementu, consegnata ai genitori dal presidente dell’associazione Marco Antonio Pani.
E a proposito di corti vincitori, giudicati da una giuria ufficiale formata dal regista Malachi Bogdanov e dal produttore Simon Woods e da Marco Asunis, presidente della FICC (Federazione italiana circoli del cinema); la giuria speciale degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti e delle Facoltà di Scienze della Comunicazione e di Scienze Politiche; gli altri maggiori premi sono andati a: Michela Anedda con “Cogas” per Miglior Animazione; a Francesco Segrè con “Non sono nessuno” come Miglior Fiction Italiana; a “The Wires” di Marina e Tatiana Moshkova come Miglior Animazione Internazionale; a “My Strange GrandFather” di Dina Velikovskaya il Premio della Giuria Kids; la Medaglia del Presidente della Camera è stata assegnata a “L’ultima volta” di Simeone Latini, sul tema della violenza sulle donne.
Sbanca tutto “Minerita”, documentario di Raul De La Fuente che si è aggiudicato la Medaglia del Presidente della Repubblica, il Premio Miglior Documentario e il Premio “Cinit-Ficc” delle associazioni nazionali di cultura cinematografica Cineforum Italiani e Circoli del Cinema. Infine è stato assegnato il premio “Diari di Cineclub” che è andato a “Come foglie…” per la regia di Theo Putzu.
Infine, a coronare una settimana di vivace scoperta culturale, l’esibizione di Romeo Scaccia, pianista e compositore di colonne sonore, cagliaritano di fama internazionale, a cui è andata la Medaglia del Senato della Repubblica consegnata dal presidente Angelo Tantaro.
Il Sardinia Film Festival si riconferma così come catalizzatore dei migliori esempi cinematografici in Italia, con un occhio di riguardo agli autori della Regione che lo ospita; un Festival che si immerge nell’attualità, senza tirarsi indietro rispetto al dibattito sulle problematiche del settore e che spera in una maggiore considerazione del cinema da parte della politica locale; un Festival che, se coadiuvato da tutte le forze che riesce a unire, istituzioni, arte, cultura, e soprattutto persone, continuerà a crescere. Ma prima della decima edizione si continua con il Festival “Life Afetr Oil” a Martis dall’1 al 3 agosto e a a Villanova Monteleone dal 21 al 23 dello stesso mese con la seconda edizione del “Premio Villanova Monteleone per il Documentario”. Insomma, un festival che si espande.
SUPERARE MANTENENDO – 32° VALDARNO CINEMA FEDIC
di Jacopo Favi
Gli applausi del pubblico concludono il Valdarno Cinema Fedic, ma non c’è un Kafka in lacrime all’uscita dalla sala cinematografica come nel cortometraggio di Edgar Reitz presentato a Venezia. O forse c’è e discute emozionato di “Umberto D.” capolavoro mai dimenticato, probabilmente mai dimenticabile, di Vittorio De Sica. La presentazione del libro del figlio Manuel – ‘Di figlio in padre’, edizione Bompiani – è un’occasione per alimentarsi ancora una volta delle immagini di un pilastro del Neorealismo italiano e del Cinema tutto. Proprio questa visione porta a una riflessione sulle opere in concorso e sull’assenza di intimità. L’occhio sfoglia i fotogrammi di “Umberto D.” e si immerge nelle emozioni più sofferte e nascoste dei personaggi dimenticandosi la condizione che le provoca. Non è importante che sia una crisi economica, uno tsunami o un omicidio, l’attenzione va immediatamente ai paesaggi interiori dell’Uomo, non solo dell’uomo Umberto.
Molti i lungometraggi e cortometraggi in concorso che puntano proprio alla dinamica sociale – a quello che dovrebbe essere solo un pretesto per motivare azioni e reazioni – per emozionare ed empatizzare con lo spettatore, che, egocentrico e pauroso, è turbato dall’immaginarsi al posto dei protagonisti. In un momento in cui il genere documentario è tornato prepotentemente in auge, i lungometraggi e cortometraggi presentati al Valdarno Cinema Fedic sembrano tendere a una documentaristica formato televisivo, quello che porta allo zapping compulsivo, per intenderci. Raramente ci si divincola dalla parola e dalla narrazione di una storia e ci si lascia sorprendere e sopraffare dall’immagine. Si pensi a “Emmaus” – storie di tre uomini dentro e fuori una comunità terapeutica per le dipendenze patologiche – di Claudia Marelli, a “Centoquaranta. La strage dimenticata” – strage del Moby Price – di Manfredi Lucibello, a “Ring People” – storie della comunità dei senzatetto di Venice Beach – di Alfredo Covelli, ma anche a “Bimba a pugno chiuso” del gruppo TodoModo e a “Tempo vivo Tempo morto” di Francesco Barozzi. Film tutti accomunati dalla “troppa” attenzione dedicata alla dinamica sociale. Come sostiene uno degli homeless di Ring People: “I had a good cry about it” (Ci ho fatto un bel pianto a riguardo).

Manuel De Sica insieme al Sindaco di San Giovanni Valdarno Maurizio Viligiardi e il co-Direttore artistico Simone Emiliani
Spicca invece “I fantasmi di San Berillo” di Edoardo Morabito, giovane regista catanese. L’intreccio tra passato e presente, bianco, nero e colore, mito e realtà, per presentare il quartiere di San Berillo – borgo siciliano che viene raso al suolo nel 1958 e, rimasta solo una piccola porzione, diventa uno dei quartieri a luci rosse più importanti del Mediterraneo, che verrà chiuso dalle forze dell’ordine nel 2000 – risulta essere una miscela azzeccata che invita a passeggiare tra luoghi e personaggi diroccati guidati da una poesia sporca, di un odore acre ma delicata. “Il poeta inizia dove l’uomo finisce” affermava Ortega y Gasset e, a parer di chi scrive, Morabito interpreta alla perfezione le parole del filosofo spagnolo disinteressandosi delle vite strappalacrime dei “fantasmi”, ma, allo stesso tempo, lasciando ampio spazio alla parola e mimica di questi, di gran lunga più comunicative delle loro storie. Il film, premiato come miglior lungometraggio, va al di là del mero racconto di una realtà disagiata, e lo fa con violenza, finezza e ironia. Influenza di Franco Maresco con il quale Morabito ha collaborato nel recente passato? Anche fosse, un motivo in più per apprezzarlo.
Tra i cortometraggi si fanno notare “Closed Box – A scatola chiusa” (premiato dalla giuria giovani) di Riccardo Salvetti e Gianfranco Boattini, anche attore protagonista, e il vincitore della 32esima edizione del Valdarno Cinema Fedic, “Lezuo” di Giuseppe Boccassini.
“Closed Box”, tratto da una storia vera, rivela il rifiuto totale di Enrico per la propria condizione apparentemente perfetta, la famiglia da copertina e una patinata quotidianità che uccide l’istinto vitale. La scatola, all’interno della quale si rinchiude, è solo il rimando al corpo umano, contenitore di paure e desideri repressi. Attraverso scenografie surreali (Antonio Rezza e Flavia Mastrella approverebbero) e gestualità soffocate i registi riescono a immortalare la violenza inespressa dei sentimenti del protagonista.

Riccardo Salvetti e Giacomo Boattini ricevono la medaglia del Presidente della Repubblica assegnata dalla Giuria Giovani per CLOSED BOX- A SCATOLA CHIUSA
“Lezuo” concede pochissimi punti di riferimento al fruitore, a partire dalle immagini, distorte grazie all’utilizzo di filtri e alla quasi totale assenza di linguaggio parlato. Un esperimento in videoarte non nuovo, quindi ancora più complesso da maneggiare, nel quale Boccassini riesce comunque a imprimere il proprio timbro poetico con gestualità e volti che esprimono forza, movimenti liquidi distensivi e un leggerissimo richiamo a L’Atalante di Jean Vigo.
Anche tra i (molti) cortometraggi in concorso, si presenta la stessa tendenza a fissare il reale; peccato, perché il cortometraggio permetterebbe di allontanarsi con facilità dalla linearità e dal senso, virtù che i due sopracitati hanno compreso e attuato con ottimi esiti. Ci si perde tra le vie di Taranto, con l’Ilva chiaramente protagonista (“Alle corde” di Andrea Simonetti e “Sacre zolle” di Giuseppe Giusto), tra i campi di pomodori nel nord della Puglia (“Destination de Dieu” di Andrea Gadaleta Caldarola), tra gli spazi siderali dell’hinterland milanese (“La bici” di Giorgio B. Borgazzi), tra le voci dei malati serbi (“Le voci umane” di Stefano Dei) ma, nonostante la volontà di fare del disagio un protagonista principe, si finisce col mettere in primo piano solo la condizione causale di quest’ultimo, lasciando lo spettatore lavorare di memoria e deduzione. Una menzione da dedicare a un cortometraggio non in concorso, “Marital Session” di Giovanni “Mito” Possemato (probabilmente l’unico a visionare tutto ciò che il programma proponeva dimostrando uno sconfinato amore per il cinematografo), dove il regista-protagonista va alla ricerca delle radici della moglie straniera in un Paese in regime di autarchia, opera di grande delicatezza e astrazione.
Non solo schermo cinematografico al cinema Masaccio. Oltre al già nominato incontro con Manuel De Sica, troviamo la masterclass webseries con la presentazione di due opere, “Assenti all’appello” di Chiara Luccianti e “Sipario!” Di Francesco Marini e Niccolò Crulli. Durante la masterclass sale in cattedra il critico amatoriale (definitosi così lui stesso anche se probabilmente non apprezzerà il termine in bocca ad altri) Federico Frusciante, noto personaggio del web e proprietario della videoteca Videodrome, omaggiando uno dei capolavori di David Cronenberg, a Livorno. Spazia dal cinema alla musica, alternando costantemente opinioni tutt’altro che scontate a motti degni del proprietario del circolo Arci di San Piero a Ponti in “Berlinguer ti voglio bene”. Tutto voluto, d’altronde, come afferma proprio Frusciante “se volete parlare con un critico cinematografico, andate da Ghezzi”. Negli anni del “feedback per ogni evenienza” è facile concordare. È intervenuto anche Mimmo Calopresti, che ha ricevuto il Premio Marzocco. Il regista si sofferma su un ipotetico futuro del cinema vuoto e dello spettatore statico, proponendo un quesito ricorrente in questi anni, quello del come tornare a riempire le sale e rendere “nuovamente” il fruitore partecipativo. Conclude con una piccola tirata d’orecchie ai giovani, colpevoli, a suo dire, di non comprendere il valore e lo spirito del tempo.
Terminata l’escursione tra le numerose proposte del festival, al di là della qualità delle singole opere, si nota da un lato la difficoltà diffusa di svincolarsi dalla realtà, e dall’altro la diversificazione di prospettive e canoni utilizzati dai partecipanti. “L’arte è la promessa di felicità che non viene mantenuta” direbbe Adorno, eppure il Valdarno Cinema Fedic e il Cinema in generale continuerà a provarci.

L’Assessora Carola Baruzzo del Comune di Ortonovo (SP) impegnata nel dibattito della serata inaugurale. Sullo sfondo il Presidente FEDIC Roberto Merlino
PRIMA FESTA DEL CINEMA CORTO
Laboratori di studio e proiezioni di corti dedicati ai soci Fedic
di Vivian Tullio
“Ringrazio i docenti, con i quali abbiamo affrontato argomenti molto diversi, tutti interessanti, passando attraverso “regole”, aneddoti, esempi, momenti di riso e momenti di commozione… Tutto condito da professionalità e generosità (come solo i veri “maestri” sanno fare). E poi ringrazio tutti i partecipanti, che hanno saputo coinvolgersi con lo spirito giusto, costruttivo, curioso, amichevole, propositivo…”
Con queste parole del Presidente Roberto Merlino ampiamente condivise anche da tutti i partecipanti e dai docenti invitati si è conclusa la 1° Festa del Cinema Corto, una sorta di vacanza-studio a numero chiuso, organizzata da Corte Tripoli Cinematografica e dalla Fedic, che ha avuto luogo da sabato 28 giugno a mercoledì 2 luglio di quest’anno in parte a Luni Mare, frazione di Ortonovo (La Spezia) e in parte a Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Una ventina i partecipanti, provenienti da diverse Regioni e città italiane, tutti appassionati di cinema e dell’immagine e tutti molto incuriositi e desiderosi di mettersi in gioco in questa nuova esperienza, pur essendo molto eterogenei nell’età (dai 16 anni agli ultra settantenni), e nella propria occupazione lavorativa (studenti, pensionati, insegnanti, professori universitari, imprenditori, giovani filmmaker, ecc.). Nei cinque giorni dell’evento si sono susseguiti 8 Laboratori teorico-pratici su vari aspetti del Cinema e quattro serate di proiezioni di Cortometraggi di filmmaker partecipanti alla Festa, con dibattito ed interventi del critico cinematografico Paolo Micalizzi. Ad Ortonovo è stata, inoltre, presentata una videoinstallazione di Luca Serasini dal titolo Presente! Scuola e resistenza a Ortonovo, mentre, a Villafranca in Lunigiana, è stata inaugurata la Mostra su Michelangelo Antonioni, a cura di Paolo Micalizzi.

Paolo Micalizzi, nel Chiostro di S. Francesco a Villafranca Lunigiana (MS), illustra la Mostra su Michelangelo Antonioni che lui stesso ha curato
Il 1° Laboratorio che ha dato il via alla Festa è stato quello sulla Video-Arte a cura di Luca Serasini, artista e fotografo pisano, che ci ha condotto nel mondo delle installazioni e delle videoinstallazioni, e ci ha illustrato come si è avvicinato e appassionato a questo tipo di arte. Serasini ha poi coinvolto, in un esercizio creativo, tutti i partecipanti che si sono cimentati nella realizzazione di una semplice videoinstallazione: dall’idea alle riprese video alla proiezione dei brevi filmati su materiali diversi (lampade, muri, tessuto non-tessuto, ecc.). Una breve ma interessante esperienza didattica che ha appassionato tutti!
Dopo cena, nel giardino della Scuola di Isola di Ortonovo, la prima serata di proiezioni ci ha offerto alcuni cortometraggi sia di Luca Serasini (“Le baiser” e “Attese/Dinamiche/Genesi”) che di filmmaker Fedic, quali Giorgio Sabbatini che ha presentato “La memoria fonte di libertà”, un documentario che unisce animazione, interviste, documenti storici, elaborazioni grafiche sulla triste vicenda di Anna Frank, Marco Rosati con la sua breve ma efficace fiction, “Torna domani”, sul malessere giovanile ma anche sulla solidarietà, Gabriella Vecchi con “Blue lady”, una fiction sul tema dei non-vedenti che riescono “a far vedere” i vedenti a tutti gli effetti, Beppe Rizzo con “A livella”, sul tema della morte che non fa distinzione tra poveri e ricchi. Alla fine della serata un acceso e costruttivo dibattito, condotto da Paolo Micalizzi, ha permesso al pubblico presente uno scambio di idee e opinioni sui temi trattati con gli Autori presenti.
Il 2° e il 3° laboratorio sono stati condotti dal regista e sceneggiatore siciliano Beppe Ferlito che ha realizzato numerosi documentari e cortometraggi di fiction, premiati nei più importanti festival di Cinema indipendente, tra i quali “Compagno che sei nei cieli”, “Doppio petto” e molti altri. Il tema affrontato è stato il lavoro che un regista deve fare sul set e sugli attori. Ferlito, che è anche Direttore della Scuola di Cinema di Firenze, IMMAGINA, ha raccontato e spiegato come si lavora in un set professionale e il relativo ruolo del Regista, la conduzione degli attori, l’importanza delle luci e del direttore della fotografia, illustrando le differenze sostanziali con quanto avviene quando si realizza un film tra amici, quello che un tempo si definiva di stampo amatoriale. Fare un film senza mezzi costa molta più fatica, è come se si volesse “arare un campo con la forchetta” – ha spiegato Ferlito – ma non è certo il mezzo tecnico che produce l’artista e per fare del vero cinema ci vuole la poetica ovvero la voglia di interpretare il mondo attraverso i propri occhi. Il cinema deve avere contenuti, la tecnologia non è sufficiente. Anche se i giovani fanno stilisticamente degli ottimi lavori, spesso mancano però di contenuti. I giovani faranno dei buoni lavori solo se riusciranno a raccogliere i messaggi della società. Ferlito ha, inoltre, sottolineato che, con l’avvento delle nuove tecnologie, il cinema si sta trasformando ma non morirà mai perché è “un giocattolo nelle mani di un adulto” e come tale potrà subire tutte le trasformazioni immaginabili ma non tramonterà perché fa parte delle necessità dell’uomo che, fin dai tempi della preistoria, ha sentito il bisogno di rappresentare ciò che faceva e vedeva intorno a sé. Fare cinema è dunque una esigenza e un bisogno… per farlo c’è bisogno dei mezzi e i mezzi ci sono… anzi oggi sono a disposizione di tutti ma non tutti quelli che riprendono diventano registi… la differenza sta nelle idee, nella fantasia e nella capacità di esprimersi con le immagini.
Seconda proiezione di corti, domenica dopo cena, al Comune di Ortonovo con due video di Ferlito, “Jackpot”, sul tema della dipendenza dal gioco e della violenza alle donne e “Il cappotto”, un crudo thriller fine a se stesso. Terzo video della serata il breve ma intenso documentario di Giorgio Ricci “Poesie per Chiara”, che ritrae le opere su vetro dedicate a Chiara, musa ispiratrice del pittore statunitense di Cincinnati Garner Tullis che ora abita nelle Marche.

Nel salone della Residenza Alberghiera Italia di Luni Mare (SP) Giorgio Ricci (sullo sfondo) fa le riprese per il backstage
Il 4° e ultimo Laboratorio a Luni Mare, lunedì mattina, è stato quello sul Documentario condotto da Giorgio Ricci. Ricci, Filmmaker e Vice Presidente Fedic ama il documentario perché è Il nostro modo migliore di mostrare e conservare la realtà nel momento in cui accade e metterla a disposizione di tutti, nel tempo, quando ciascuno ne ha bisogno… Pertanto poiché il documentario nasce dalla necessità di comunicare è cinema a tutti gli effetti e come tale deve seguirne le regole di realizzazione: tuttavia, secondo Ricci non si può fare una sceneggiatura troppo dettagliata, ma è meglio limitarsi solo alla scaletta per poter lasciare aperto il discorso affinché, in fase di ripresa o durante eventuali interviste, possano essere inserite idee diverse e/o nuovi spunti per la realizzazione. Precisa Ricci: “Poiché in un documentario l’obiettività nel raccontare i fatti e la realtà devono essere prioritari, la responsabilità che abbiamo nel produrre i nostri piccoli corti è enorme!” Anche in questo laboratorio i singoli partecipanti sono stati invitati ad effettuare un breve esercizio nel quale bisognava ipotizzare delle immagini da associare al commento di un documentario sul problema delle case popolari nel Pesarese. A turno ognuno ha esposto le proprie idee su come avrebbe realizzato il breve filmato e tutti hanno dimostrato fantasia e capacità di astrazione, requisiti fondamentali di un buon filmmaker!
Dopo pranzo, tutti i partecipanti si sono trasferiti a Villafranca in Lunigiana, luoghi bellissimi, ricchi di colline, borghi medioevali, fiori, castelli, ecc. Dopo aver sistemato i bagagli nei rispettivi alberghi, tutto il gruppo si è trasferito al Castello di Malgrate, una fortificazione del 1300, dove tra le mura, il giovane regista pisano Francesco Giusiani ha tenuto il 5° Laboratorio e ci ha parlato del Punto di vista: – … è fondamentale sentire la storia secondo il punto di vista di chi la racconta, il punto di vista della sceneggiatura.. Ci vuole la consapevolezza di ciò che facciamo, sapere che cosa stiamo raccontando ci aiuta nella sceneggiatura. Poi si può passare alla regia. Rossellini avrebbe voluto bruciare le sceneggiature anche se in realtà Rossellini teneva molto alla sceneggiatura. Ma quali sceneggiature avrebbe voluto bruciare Rossellini? Quelle di ferro perché diventano ostacolanti sul set, diventano rigide e ci ingabbiano: la realtà stessa ci dice dove mettere la macchina da presa! E il regista cosa fa? Sceglie….Sceglie attori, location, ecc. Come si fa a sapere se si è scelto bene? Non ci sono regole fisse.. Molte cose sono istintive….” Questo il Punto di vista di Giusiani che, fin da bambino ha manifestato la sua passione per il cinema. Cresciuto tra le fila di Corte Tripoli Cinematografica e, attualmente, dottorando al Dipartimento di Storia delle Arti di Pisa, ha vinto nel 2010 il Premio Marzocco al Valdarno Cinema Fedic con il corto “Innocenze perdute”, video con il quale ha ottenuto la nomination ai Nastri d’Argento, ha partecipato al David di Donatello e alla 64° edizione del Festival di Cannes nella categoria court-metrage dello Short Film Corner nell’ambito del Forum Fedic all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Alla sera, dopo la cena alla Locanda Garavini in Loc. Mocrone, con una suggestiva “luce a cavallo”, ci siamo nuovamente trasferiti al Castello di Malgrate per assistere alla proiezione di quattro video, due documentari e due fiction. Alla fine delle proiezioni Paolo Micalizzi ha condotto il consueto dibattito con il pubblico, che ha espresso considerazioni e opinioni sui video presentati. Il primo video, “Le voci umane” di Stefano Dei è un’opera essenziale che documenta la situazione dei malati di mente in Bosnia, condotta con stile classico estremamente coinvolgente; il secondo documentario, “Colori d’Italia” di Vivian Tullio, è un omaggio all’Unità d’Italia e al difficile cammino per raggiungerla, realizzato con un linguaggio moderno che alterna riprese a elaborazioni fotografiche. “Innocenze perdute” di Francesco Giusiani è una ottima fiction realizzata con rigore metodologico senza sbavature, protagonisti i bambini di quartieri difficili della periferia di Roma che “vivono secondo uno schema della paura che porta a sopprimere i sentimenti più belli”, mentre “Uomo in mare” di Antonella Santarelli, ricorda le atmosfere, le angosce e le problematiche esistenziali dei film di Antonioni.
Martedì mattina al Teatro della Misericordia di Villafranca ha avuto luogo il 6° Laboratorio sul Montaggio cinematografico che ha suscitato estremo interesse soprattutto nei più giovani partecipanti. Il Laboratorio è stato condotto da Giorgio Sabbatini, filmmaker proveniente da Torino e Consigliere Fedic che fin dall’adolescenza, prima con la pellicola e poi con il video, si è occupato di cinema corto e dei vari aspetti del linguaggio cinematografico e della sperimentazione. Il montaggio è un’arte e richiede impegno e competenza perché se si sbaglia il montaggio delle scene o delle inquadrature si rovina un film. Sabbatini ci ha illustrato quindi la tecnica del campo/controcampo, la differenza tra il montaggio parallelo e quello alternato, come evitare nel montaggio gli errori di continuità, come rendere più accattivante una scena utilizzando le ellissi e le microellissi, ecc. il tutto accompagnato da sequenze tratte da celebri film.
Nel primo pomeriggio, il penultimo Laboratorio, il 7°, a cura di Claudio Marmugi sul Cinema comico e sulla difficoltà oggigiorno di far ridere in modo intelligente. Per arrivare alla comicità occorre una buona preparazione e per decodificare la comicità occorre avere dei codici appropriati. Marmugi è un giovane comico e attore livornese che ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra le quali Zelig ed è un esperto del cinema demenziale americano sul quale ha preparato la sua tesi di laurea.
Alla fine del Laboratorio, alle 17, la Festa si è spostata al Chiostro di San Francesco, dove alla presenza delle autorità locali, la Young Band di Villafranca, composta da giovani musicisti, ci ha fatto ascoltare alcuni brani tratti da colonne sonore di film celebri. Al termine, il critico cinematografico Paolo Micalizzi di Ferrara ha inaugurato la Mostra dedicata a Michelangelo Antonioni allestita con documenti e locandine della sua collezione e ha illustrato ai presenti il percorso creativo e cinematografico del Regista.
Dopo cena, ancora proiezioni di cortometraggi, questa volta all’aperto nella Piazza Bonatti di Villafranca. Anche se la temperatura non era propriamente estiva, la piazzetta era gremita di gente. Sono stati proiettati due interessanti corti di Alessandro Izzo, ironici e accattivanti, interpretati da Marmugi: il primo, “Donazione da Tiffany” ricco di citazioni cinematografiche, è un appello a donare il sangue,. il secondo “Il brutto, brutto mondo del signor Mario”, tratta in modo divertente il riutilizzo e riciclo dei rifiuti. Giorgio Sabbatini ha presentato “La finestra”, video sperimentale realizzato con immagini statiche (fotografie), sulle differenti condizioni umane in continuo contrasto, e Gabriella Vecchi con l’opera “E se tutto non finisse”, fiction di riflessione sulla ipotetica fine del Mondo annunciata dai Maya. Poi è stata la volta di due video di animazione: “Il rospo” di Beppe Rizzo, dall’omonimo racconto di Hugo e con i disegni di Gibba e “No birds” di Marco Rosati realizzato con ingegno e pochi mezzi a disposizione ma con molta fantasia. Per finire una docu-fiction di Roberto Merlino per valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali della Lunigiana: Lunigiana tra sogno e realtà. Nonostante il freddo, la serata si è conclusa con un ampio dibattito tra il pubblico ed Autori, condotto da Paolo Micalizzi.
L’ultimo giorno della Festa, mercoledì mattina, abbiamo assistito all’8° Laboratorio, a cura di Paolo Micalizzi, sul Cinema di Michelangelo Antonioni. Micalizzi ci ha presentato alcune opere e sequenze tratte dai più importanti film di Antonioni, illustrandone le caratteristiche e le innovazioni del linguaggio filmico. Prerogativa di Antonioni, primo regista sensibile ed umano nel documentario, è stata l’analisi dei sentimenti, la poetica dello sguardo che ritroviamo in tutte le sue opere. Abbiamo visto il primo breve documentario in b/n, “Gente del Po”, fatto dal Regista a 31 anni e l’ultimo documentario sul Mosè, “Lo sguardo di Michelangelo”, realizzato a 92 anni. Si nota già nel primo corto la mano sapiente del Regista che attraverso l’estetica delle inquadrature, molto ricercate e ricche di significati, ha saputo trasmettere e ricreare l’atmosfera del fiume e della sua gente. Colpisce una frase del commento parlato: Dalle finestre si affaccia sempre qualcuno a guardare il fiume… a indicare il forte legame con il Po che, con il suo lento scorrere, rappresenta il punto di riferimento di questa gente e ne scandisce i diversi momenti della vita. Nell’ultimo lavoro, Lo sguardo di Michelangelo, il Maestro si avvicina alla monumentale opera con grande rispetto e delicatezza commovente dando ampio spazio ad un’estetica dell’immagine ancora una volta particolarmente ricercata con l’utilizzo appropriato di un’illuminazione sorprendente che coinvolge emotivamente lo spettatore.
Dopo l’ultimo laboratorio la 1° Festa del Cinema Corto si è conclusa a pranzo, tutti insieme tra amici, in un ambiente confortevole e con un’ottima cucina, nella speranza che questa manifestazione possa ripetersi nel futuro.
Le foto di questo articolo sono di Vivian Tullio e Giorgio Sabbattini
Il FESTIVAL DEL CINEMA DI BRESCELLO
ha i numeri per essere un riferimento nel panorama italiano
di Lorenzo Bianchi Ballano
Si è concluso lunedì 23 giugno 2014 il Festival del Cinema di Brescello, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, sono stati quattro giorni in cui prestigiosi protagonisti del Cinema Italiano e della Radio sono intervenuti presentando i propri libri e parlando di cinema con il numeroso pubblico intervenuto.
Ha preso il via venerdì 20 giugno con l’omaggio allo scomparso Carlo Mazzacurati, ospite d’onore del nostro Festival nel 2008, in una piazza gremita di giovani, famiglie ed affezionati appassionati di cinema la dodicesima edizione del Festival. Ospite della serata l’attore Roberto Citran che ha ripercorso la propria carriera al fianco di Mazzacurati, a seguire la visione di “Notte Italiana” esordio alla regia di Mazzacurati vincitore del Nastro d’argento e Ciak d’ore nel 1987 che rivisto vent’anni dopo, non soltanto resiste, ma ci guadagna fornendo uno sguardo lucidamente critico sulla società italiana dei rampanti e imbecilli anni ’80.
Sabato 21 la serata ha visto protagonista Il Cinema Dimenticato nella provincia di Reggio Emilia con la presenza di Marco Incerti Zambelli (critico cinematografico e socio del videoclub brescello) che ha sintetizzato il progetto con queste parole “Alexandre Astruc, in un famoso articolo del 1948 (sessanta anni prima di Youtube) coniò il termine di Camera-Stylo, ad invocare un cinema nuovo, in totale possesso dell’autore e, grazia all’agilità che i nuovi mezzi produzione permettevano , alla portata di chiunque volesse esprimersi con la settima arte: quell’intuizione fotografava quanto sarebbe successo negli anni successivi, con il super 8, il vhs, il digitale, fino a che il racconto per immagini (e suoni) è divenuto paesaggio costante del contemporaneo. Nella seconda metà del secolo scorso, tra i filmini domestici ed il cinema professionale, si sviluppò una tendenza che fece nascere una miriade di piccole opere, ora pressoché dimenticate , testimoni di una felicità creativa che vale la pena di riscoprire. Innanzitutto nel territorio di Reggio Emilia, particolarmente ricco di autori e di opere.
Il Festival Del Cinema di Brescello intende promuovere questo lavoro di ricerca, affiancandosi a meritorie iniziative che già stanno esplorando quel fenomeno, quali Home movies , cui partecipa l’Università di Modena e Reggio Emilia ed il lavoro di catalogazione portato avanti dalla Biblioteca Panizzi di Reggio Emila, a cui si deve anche la importante recente mostra dedicata al lavoro di Franco Cigarini. Già quest’anno sarà possibile un primo assaggio di questo lavoro, con la proiezione di “Papà Cervi” di Franco Cigarini, tra i maggiori autori cinematografici reggiani e la testimonianza di Gianni Barigazzi, che rifondò negli anni 80, anche in seguito all’appassionata rassegna ‘Come Eravamo, Memorie del cinema a Reggio Emilia’, il glorioso circolo Fedic di Reggio Emilia, vera fucina per giovani autori”.
Questa edizione del festival brescellese è stata inoltre caratterizzata dalla presenza del premio Cir-Food “Il giornale del cibo”: proprio il cibo di strada che è protagonista del cortometraggio vincitore “Mangiare in dialetto” di Vincenzo Cascone è stato preparato dagli chef di Cir-Food Danilo Lo Curto e Daniele Coqueraut e fatto assaggiare al pubblico presente.
“La tavola è uno dei maggiori sensali del racconto, della comunicazione, della socialità creativa, del nostro umanesimo. E non c’è arte migliore di quella cinematografica che racchiude racconto, visione ed emozione per rappresentare questa “cosa bellissima” che è il cibo – afferma Giuliano Gallini, Direttore Commerciale e Marketing CIR food – Per questo il Giornale del cibo, sito grazie al quale CIR food promuove la cultura dell’alimentazione, è lieto di partecipare al Festival di Brescello e dedicare un premio al corto che meglio valorizzerà il cibo e la cucina.”
A seguire è stato consegnato il Premio “Dazzi” al reggiano Cristiano Travaglioli, montatore dei film di Paolo Sorrentino “La grande bellezza”.
Vincitore del Premio “Pace e Solidarietà” promosso dal Rotary Club Brescello Tre Ducati è stato il cortometraggio Spagnolo “Una hora, un paso” di Aitor Iturriza e Bernat Gual che descrive la vita di Juan uno spagnolo che è stato rinchiuso in un carcere egiziano per 17 anni. Durante questo periodo, ha scritto due volumi di poesia, si è sposato e ha avuto una figlia, sognando sempre di tornare in Spagna. Un team di giornalisti entra nella prigione per intervistarlo, ignari che qualcosa di terribile stia per accadere.
Il “Don Camillo d’Oro”, premio assegnato al cortometraggio vincitore nella sezione “Così lontano, così vicino: Storie dal mondo piccolo” è andato al regista Adriano Giotti per il suo lavoro “Piume”.
Domenica 22 ospiti d’onore sono stati Giuliano Montaldo e Steve Della Casa che nel tardo pomeriggio hanno presentato i loro ultimi libri pubblicati, ‘Un marziano genovese a Roma’ e ‘Splendor. Storia (inconsueta) del cinema italiano’. Dopo la consueta cena in piazza, dove le Rezdore di Brescello hanno preparato Tortelli d’erbetta e Spalla Cotta nella migliore tradizione emiliana, il regista Giuliano Montaldo ha incontrato il numeroso pubblico prima della proiezione del film “Sacco e Vanzetti”; numerosi gli aneddoti e le riflessioni del grande regista sul Cinema Italiano degli ultimi 50 anni, interessante è stata la dichiarazione in cui Montaldo ha affermato che il successo avuto dai film di Peppone e Don Camillo ha permesso a registi esordienti come lui negli anni ’60 di poter realizzare film importanti finanziati dai Produttori resi euforici dagli incassi avuti.
Lunedì 23 sulla piazza di Brescello, come nella migliore tradizione gastronomica, si è tenuta la “Tortellata di San Giovanni”, protagonisti della serata sono stati i ragazzi del progetto “Il Cinema e Brescello per i giovani” laboratorio di Cinema che da vari anni il videoclub Brescello in collaborazione con l’Amministrazione Comunale realizza presso la locale Scuola Secondaria di I Grado e che porta alla creazione di un soggetto originale da parte dei ragazzi legato a problematiche giovanili o scolastiche. Quest’anno il cortometraggio realizzato è Scuola Dolce Scuola dove i ragazzi combattono contro la sparizione delle risorse fondamentali per poter studiare in una scuola al passo con i tempi e ne escono vincitori.
La serata ha visto la consegna del Premio FEDIC al regista Giorgio Ricci per il cortometraggio “Il Giardino dei Giusti”, altro progetto realizzato con i ragazzi di una scuola dove attraverso una ricostruzione storica si rivivono nel documentario i momenti e i motivi per cui una famiglia di ebrei si è salvata dallo sterminio perpetrato dai Tedeschi.
Degna conclusione della serata, in attesa della “Rugiada di San Giovanni”, è stata la proiezione del film “Don Camillo e l’On. Peppone” nel ricordo di Gino Cervi a 40 anni dalla scomparsa. La suggestione di poter vedere il film sulla piazza in cui si snodano le vicende di Don Camillo e Peppone è un’esperienza che non ha eguali, vedere il campanile della Chiesa sullo schermo posto proprio sotto lo stesso campanile ed alzando appena la testa vedere lo stesso è un’esperienza di coinvolgimento totale irripetibile. Il pubblico che durante le scene del film commenta come si faceva nei cinema di una volta, chi si riconosce perché è stato protagonista di una scena come comparsa oppure nascosto ne ha visto la realizzazione, pertanto si respirava un’aria di immersione totale nel film. Queste sensazioni si possono provare solo in un paesino posto fra il fiume e la collina dove il sole picchia in testa alla gente ….
.
.
.
.
FESTIVAL
FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO LECCE
15° edizione (28 aprile – 3 maggio 2014)
di Catia Urbinelli
Solitamente, pensiamo di andare a vedere un film, sederci comodamente su una poltroncina e goderci la storia, stavolta al Festival del cinema europeo a Lecce, è successa una cosa insolita, non sono io che ho guardato il film ma sono stati gli attori che hanno guardato me. Attraverso lunghe sequenze i protagonisti hanno bucato letteralmente lo schermo e hanno trasferito in modo diretto allo spettatore le loro angosce, le loro riflessioni, speranze e paure, attraverso i loro sguardi. A volte così interminabili da non poter fare a meno di prenderti a cuore i loro drammi, il potente effetto catartico del cinema. Di storie gioiose se ne sono viste poche, come dire – c’è poco da ridere, ma molto a cui pensare-. indubbiamente il cinema è sempre stato il riflesso del periodo storico in cui opera, e se dovessi riassumere in una parola questo periodo sceglierei Smarrimento. Simo, Anna, Fredi, tre nomi, tre storie, tre sguardi rivolti ad un mondo dove solitudine, mancanza di punti di riferimento, angoscia e senso di morte fanno da padroni. Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, gli sguardi di questi personaggi lasciano intravedere un animo abbandonato a se stesso, a volte vuoto come quello di Simo, protagonista del film “Concrete Night” di Pirjo Honkasalo. Una madre debole, un fratello che ha una visione distruttiva dell’umanità, plasmano la mente di Simo che vede il mondo senza colori, senza speranza, dove l’unica differenza tra vita e morte è la presenza o la mancanza del silenzio. La società in cui vive, le immagini che vede e le parole che sente diventano così assordanti che sceglie la morte come liberazione. Nella vita di Anna invece di silenzio ce n’è fin troppo soprattutto dopo la morte del suo cagnolino Manu. “September” Penny Panayotopoulou è il titolo del film che affronta il tema della solitudine, una malattia dell’anima che per guarire sembra abbia bisogno di nutrirsi delle vite degli altri. Abituata alla compagnia del suo cane, Anna non riesce a rapportarsi con il mondo degli umani, il suo diventa un desiderio ossessivo, al punto d’invadere e appropriarsi dell’intimità dei suoi vicini di casa. Anche lo spettatore si sente soffocare da questi sguardi, questi occhi che spiano di continuo la famiglia per riempire il vuoto dentro. Anna ad un certo punto capisce che il suo modo di fare non è più accettato , non le resta che prendersi una vacanza da sola, ed è proprio lì sulla spiaggia deserta che incontra un nuovo amico a quattro zampe. Fredi ha un dono che gli ha lasciato sua madre, le sue mani guariscono, “One of a Kind” di François Dupeyron , questo il titolo del terzo film preso in esame. Gli sguardi di Fredi delicati e fuggevoli, occhi perennemente semichiusi, quasi a non voler incontrare altri occhi poiché tanta è la sua capacità di entrare dentro l’anima delle persone che lo spaventa. E’ un uomo buono, vorrebbe solo una vita normale, ma non può sottrarsi al suo destino di guaritore. Durante il film vi sono dei momenti in cui sembra chiedere aiuto, conforto allo spettatore che lo sta guardando, in fondo lui ha un solo desiderio, quello di poter dire ti amo a qualcuno. E senza amore è più facile smarrirsi … e se fosse proprio questa la soluzione per ritrovare la strada?
.
LIBRI
Fabrizio Fogliato
ABEL FERRARA. UN FILMAKER A PASSEGGIO TRA I GENERI
Sovera Edizioni, Roma 2013, Pagg. 458, Euro 16
 Fabrizio Fogliato, docente e coordinatore didattico presso Starting Work-Como nonché referente e docente di “Storia del cinema e linguaggio audiovisivo” per il progetto triennale 2011-2014 I.F.T.S. della Regione Lombardia non è sicuramente un autore che ama perdersi in inutili o comunque ridondanti premesse e/o saggi introduttivi. Chi apre questo interessante volume si trova dinanzi a pagina 9 a “Nicky’s Film” il primo cortometraggio attualmente visibile di Abel Ferrara. Da lì in avanti sarà un susseguirsi di titoli di film ad ognuno dei quali verrà dedicato uno spazio adeguato che vedrà riproporsi uno schema efficace. Ad un’accurata e documentatissima analisi dell’opera segue una recensione che si completa con un ampia parte dedicata ai ‘Sondaggi critici’ che raccoglie stralci di recensioni di non facile reperibilità. Fogliato ama il cinema di Ferrara e ne coglie con anche le dinamiche linguistiche. A titolo di esempio così si esprime nei confronti di una delle opere più discusse del regista Go Go Tales: “ Il Paadise è un luogo ‘magico’ percorso da una tensione erotica costante che trasferisce la sua potenza perfino nella forma filmica in una pellicola dove i fotogrammi si enetrano l’uno con l’altro e dove le dissolvenze incrociate determinano un orgiastico sovrapporsi di corpi.”
Fabrizio Fogliato, docente e coordinatore didattico presso Starting Work-Como nonché referente e docente di “Storia del cinema e linguaggio audiovisivo” per il progetto triennale 2011-2014 I.F.T.S. della Regione Lombardia non è sicuramente un autore che ama perdersi in inutili o comunque ridondanti premesse e/o saggi introduttivi. Chi apre questo interessante volume si trova dinanzi a pagina 9 a “Nicky’s Film” il primo cortometraggio attualmente visibile di Abel Ferrara. Da lì in avanti sarà un susseguirsi di titoli di film ad ognuno dei quali verrà dedicato uno spazio adeguato che vedrà riproporsi uno schema efficace. Ad un’accurata e documentatissima analisi dell’opera segue una recensione che si completa con un ampia parte dedicata ai ‘Sondaggi critici’ che raccoglie stralci di recensioni di non facile reperibilità. Fogliato ama il cinema di Ferrara e ne coglie con anche le dinamiche linguistiche. A titolo di esempio così si esprime nei confronti di una delle opere più discusse del regista Go Go Tales: “ Il Paadise è un luogo ‘magico’ percorso da una tensione erotica costante che trasferisce la sua potenza perfino nella forma filmica in una pellicola dove i fotogrammi si enetrano l’uno con l’altro e dove le dissolvenze incrociate determinano un orgiastico sovrapporsi di corpi.”
Giancarlo Zappoli
SAGGI
HITCHOCK SUL NASO DI LINCOLN.
La perdita e la riconquista di una Nazione sul Mount Rushmore.
di Mathias Balbi
1. Premessa.
 A voler tentare una rapida catalogazione dell’opera cinematografica hitchcockiana in relazione al leitmotiv del cosiddetto “run for cover” (trad. “corri a nasconderti”), si dovrebbero distinguere titoli quali “Strangers on a Train”, “The Wrong Man” e “Frenzy” dalla nutrita compagine dei film che pongono al centro della loro trama un “subject matter” direttamente legato alla guerra o allo spionaggio o, per usare un’espressione calzante al caso, all’“intrigo internazionale”: insomma, il corpo di opere più caratterizzanti l’universo poetico del cineasta inglese.
A voler tentare una rapida catalogazione dell’opera cinematografica hitchcockiana in relazione al leitmotiv del cosiddetto “run for cover” (trad. “corri a nasconderti”), si dovrebbero distinguere titoli quali “Strangers on a Train”, “The Wrong Man” e “Frenzy” dalla nutrita compagine dei film che pongono al centro della loro trama un “subject matter” direttamente legato alla guerra o allo spionaggio o, per usare un’espressione calzante al caso, all’“intrigo internazionale”: insomma, il corpo di opere più caratterizzanti l’universo poetico del cineasta inglese.
Elemento comune a tutti questi “soggetti” e loro collante naturale, inutile dirlo, è (o sarebbe) la politica, verso la quale però l’ancora giovane Hitchcock aveva prematuramente dimostrato scarso interesse e volontà di coinvolgimento attivo, appartandosi nella tranquillità della vita privata e famigliare e arrivando altresì a rifiutare, nel 1936, l’invito a presiedere il sindacato di sinistra dei tecnici del cinema inglese. Questo personalissimo costume è parte di una biografia che si conferma nel trasferimento americano di Hitchcock e anzi diventa una cifra e un segno importante nella comprensione dell’uomo e dell’artista, che ritarda fino al 1955 la richiesta della cittadinanza americana preferendo “guardare la nuova patria con la distanza che una diversa educazione gli consentiva […] per sviluppare una impietosa analisi sociologica e culturale del Nuovo Mondo”.
Complementari a questo personale ‘studio’ sociologico, l’indifferenza e il manifestato distacco da qualsivoglia implicazione politica, tanto nella vita quanto nella prassi della costruzione di una sceneggiatura e poi di un film, conducono ad una precisa dichiarazione di poetica che è poi il cuore del cinema di H.: l’utilizzo della materia spionistica (e, intrinsecamente, della sua sostanza politica) nelle trame dei suoi “run for cover” è il fondale utile ad una essenziale rappresentazione delle vicende umane, in cui “gli episodi storici ven-gono posti al servizio della finzione e della creazione: si attua così un uso artistico del passato, delle vicende politiche”; e in cui inoltre, come diceva Fabio Carlini, “mentre interroga se stesso, il cinema hitchockiano ripropone, attraverso i misteriosi fantasmi che popolano il film, i risultati di un agghiacciante sguardo sul mondo”: e un mondo che era in buona parte quello borghese.
2. “North by Northwest” (1959).
Alla confluenza ideale di un’opera cinematografica che “si configura come dialettica del libero arbitrio, tra corruzione della natura umana e aggressioni della concupiscenza” ed in cui il meccanismo dell’“intrigo” agisce per “unificare il molteplice e scompaginare l’unitario, per trasformare ogni certezza in dubbio” il maestro inglese colloca un film che funge da pièce de resistance di questo assunto: North by Nortwest.
E’ poi molto interessante ed utile, ai fini di una tracciatura delle premesse e della genesi del film, recuperare alcune considerazioni di Hitchcock, che in un’intervista al ‘New York Times’ del 1950 esponeva le sue convinzioni in merito al meccanismo dello spionaggio, sorprendentemente affermando che al tempo presente (all’inizio dei Cinquanta, dunque) non aveva “nulla di affascinante”; H. ne parlava in relazione a un’idea embrionale di sceneggiatura riportata anche nel paradigmatico libro-intervista con Truffaut, ovvero la scoperta che un delegato delle Nazioni Unite creduto addormentato durante una conferenza è in realtà morto per una coltellata alla schiena: circostanza giudicata dal maestro però problematica, poiché innescante una serie di implicazioni troppo “vicine alla sgradevole realtà”:
“Come si potrebbe evitare di realizzare un noioso documento politico, invece che una storia di suspense? Nella mia opinione, la miglior trama di suspense è quella che pone una persona comune nel bel mezzo di una situazione che sembra normale, fino a che non si scopre (e anche piuttosto presto) che questa è un enigma stupendamente pericoloso […] Credo che le storie di suspense debbano essere stanate dai loro vecchi nascondigli. Penso che occorra dimenticarsi lo spionaggio e riscoprire tipi di minacce molto più personali. Ritengo che oggi si possa raccontare una storia di suspense seguendo la vecchia tradizione, mettendo al centro della vicenda la lotta contro il crimine internazionale, con i suoi agenti, piuttosto che occuparsi di documenti scomparsi”
Dopo il 1950, la società americana che il maestro inglese andava già da un decennio osservando in maniera “distaccata” e con occhio da entomologo, avrebbe offerto l’occasione
per un’ulteriore elaborazione e precisazione di quella poetica profeticamente espressa in brevi concetti: da lì a poco il maccartismo sarebbe andato a scavare nelle convinzioni più acquisite del popolo americano e a instillare il germe del dubbio e della diffidenza (nonché della delazione), mentre la guerra fredda in atto modificava anche lo statuto della paura, infiltrando nuove fobie nel quotidiano, su una scala che ora, forse per la prima volta, si poteva definire “globale”: e sicuramente “internazionale”.
Quei “tipi di minacce molto più personali” a cui si riferiva Hitchcock nell’intervista del 1950 sono un corollario a questo novus ordo globale: ma diversamente dallo scambio dei ruoli di onesto/malfattore che in “The wrong man” (1957) sovrappone il probo (e cattolico) Manny Balestrero ad un consueto rapinatore di drugstore (documentaristicamente reale e uno tra i tanti che hanno già popolato il noir e il poliziesco dei due decenni precedenti), lo slittamento incolpevole e refrattario di Roger Thornhill nel finzionale (teorico) George Kaplan è il corpo di una metafora che avverte il sensibile spossessamento dell’identità dell’individuo nella nuova America fine anni Cinquanta, il furto simbolico di un corpo sostituito con un altro politicamente-culturalmente-geneticamente difforme come sottrazione-perdita identitaria di una Nazione: attraverso l’esercizio di nuove forme (anti-)culturali germinanti sul dubbio, la delazione, la calunnia (che scambia l’individuo da una identità sana ad un’altra inassimilabile: si veda, il rosso, il comunista), nonché sulla mercificazione (internazionale, certamente) di fatti, parole, numeri, notizie, segreti, insomma di conoscenza e sapere.
La perdita è dunque una cifra di “North by Northwest”: Roger Thornhill perde progressivamente le parti costitutive e acquisite della sua abitudinaria vita agiata nel farsi di uno spostamento non solo identitario ma anche geografico che lo disallinea progressivamente dalla realtà che conosceva, costringendolo, en route, ad una nuova codifica della medesima; la sua stessa credibilità, canone irrinunciabile per il cittadino Thornhill (si veda l’atteggiamento di poliziotti e conoscenti di fronte alla sua ubriachezza dopo l’incontro con il falso Lester Townsend di James Mason) come per il professionista Thornhill (il pubblicitario, colui che deve convincere un pubblico/popolo a guardare la realtà e il prodotto/merce in una modalità diversamente codificata), viene progressivamente erosa e poi annullata dai fautori del nuovo ordine di regole criminalmente votate al pervertimento e al tradimento (alla perdita) della Nazione e dei suoi valori fondanti. Certo, al graduale inabissamento della sua identità Thornhill partecipa colpevolmente anche con la sua incosciente e istintiva audacia, o per meglio dire con l’inesatta cognizione del pericolo che gli si oppone, ma proprio attraverso questa strada (e in una guisa tutta americana, marchiata d’orgoglio e di individualismo temerario) la vittima recupera a piccoli passi lo status di uomo ricongiunto alla sua identità nonché di vincitore. Ma il tragitto geografico e umano di questo recupero sarebbe molto più arduo e probabilmente privo di esito senza l’introduzione di una clausola importante, non solo narrativamente, ma da un punto di vista anche simbolico e che introduce ad una riflessione storica e politica.
3. Mount Rushmore e l’eroina della democrazia americana.
La presenza femminile, in ogni opera hitchcockiana, è una forte presenza dallo sfaccettato spessore simbolico (psicologico, sessuale, etc.), ma in “North by Northwest” è inoltre parte costitutiva di un valore morale e democratico, che contribuisce alla rinascita del personaggio di Roger Thornhill e ben si conforma alla tematica “politica” (con buona pace del disinteresse hitchcockiano) della riconquista etica della Nazione.
La Eve Kendall interpretata da Eve Marie Saint gioca il ruolo di sintesi di “North by Northwest”: incorpora in se stessa l’ambivalenza di segno tra verità e menzogna, positività e negatività, salvezza e dissoluzione ed è la canonica manifestazione della Grazia che concilia l’introduzione del romance nel racconto, ma è anche l’ortodossa garante della rinascita etica (e della salvezza fisica) del protagonista. L’agnizione e la scoperta dell’“intrigo” che la vuole dalla parte sbagliata per giusti fini (agente del controspionaggio in incognito ufficialmente amante di Vandamme) comporta una rottura temporanea del rapporto tra lei e Thornhill (ordine perturbato), che viene riconciliata con una menzogna utile a non vanificare quei giusti fini che conducono alla equa punizione del vilain interpretato da James Mason (ordine ristabilito): questo attraverso una rappresentazione o, si potrebbe dire, una pantomima che, come nel teatro greco, agisce più attraverso gesti efficaci (lo sparo a salve, quindi falso, di Eva contro Thornhill) che attraverso le parole, inflazionate ormai da un utilizzo fin troppo disinvolto della menzogna e quindi inaffidabili, ridotte a un grado zero di veridicità.
Una menzogna con finalità ed effetti fecondi, risanatori e catartici, si potrebbe azzardare: ma quel che è più interessante è che la femminea presenza di Eva Kendall sul Rushmore, nel finale e celebrato redde rationem che ricostituisce tutti gli equilibri, riecheggia anche il compimento ideale di un traguardo democratico lungo un quarantennio. Nel 1934, ovvero quattro anni dopo la solenne inaugurazione della prima delle teste di Mount Rushmore (quella di George Washington), la suffragetta Rose Arnold Powell cominciava una lunga battaglia condotta contro il governo degli Stati Uniti per fare inserire nel grande progetto celebrativo del Rushmore, insieme ai presidenti maschi, la testa di una donna altrettanto illustre, ovvero quella Susan Brownell Anthony che fu l’eroina della crociata per il suffragio femminile.
Invece, la crociata della Powell trovò un avversario diretto nello scultore Gutzon Borglum, responsabile materiale del grande progetto del “Tempio nazionale alla democrazia”, come da lui stesso venne definito: personalità particolare quella di Borglum, convinto sostenitore di una tesi secondo la quale “il guaio dell’America era il suo rammollimento” come il “guaio dell’arte moderna nella sua degenerazione” e dalla quale muovevano le sue discutibili convinzioni politiche, a partire dalle ossessioni razziste, che lo avevano portato ad essere membro della prima ora del Ku Klux Klan (e sodale di alcuni membri del “Kloncilium”) fino alla totale immersione nel “culto degli eroi-cavalieri di razza pura”. Eppure, come sottolinea Simon Schama, “La cosa curiosa è che Borglum era sinceramente convinto di essere un democratico, nonostante avesse il carattere e i pregiudizi di un ingenuo fascista” e che parallelamente “il suo gigantismo architettonico ricorda quello di Albert Speer”. Curiosa coincidenza è anche l’infatuazione di Borglum per il cinema e per David Wark Griffith in particolare, cineasta-patriarca realizzatore di Nascita di una nazione (1915), che non solo fonda la grammatica cinematografica americana, ma compone anche una “storia romanzata a sfondo razzista” di quel Ku Klux Klan di cui Borglum era fervente membro.
Dunque, cosa esprime la figura dello scultore Borglum? In sintesi, il senso di un progetto artistico errato nelle sue premesse e nella sua realizzazione materiale, codificato su di un profondo travisamento della nozione di democrazia (certo meglio rappresentabile con le “monotone e spesso meschine zuffe del Congresso che da quattro colossi di granito scolpiti nel fianco di una montagna”, come diceva Schama), declinato sull’ossessione della grandiosità epica (e ideologica) del monumento, sull’urgenza di sfuggire dalla meschinità della nuova “arte degenerata” in nome di una maniera puramente americana che poteva generarsi solo con il distacco dai modelli stranieri (europei e classicheggianti) e il rifugio nell’“immensità del suo territorio”, nella grandezza e nell’altezza, canoni dall’alto dei quali “apprezzare quella fondamentale verità imperialistica”.
Nel recupero della temporanea perdita d’identità di Roger Thornhill e della Nazione, schiacciati sotto il giogo di forze antidemocratiche (e antiamericane), l’ascesa hitchcockiana al Mount Rushmore di “North by Northwest” mette in scena il risarcimento artistico del complesso monumentale: al quale, inoltre, si arriva attraverso un’invenzione scenica e architettonica che mette in gioco un altro riferimento (cosciente o casuale?) in stretta parentela con la vicenda realizzativa del Monte, ovvero la maliziosa e ammiccante collocazione in cima ad esso della villa della spia Vandamme, nella presumibile prossimità del versante ovest, quello “sul retro del monumento, accanto al programmato (ma mai costruito) tempio della Rimembranza che avrebbe dovuto contenere un più ampio pantheon delle figure eminenti della Nazione”; e nel quale avrebbe dovuto essere collocata la riproduzione scultorea (promessa e mai realizzata) dell’eroina suffragista sognata da Rose Powell. Ed è utile e curioso sottolineare che la villa scelta da Hitchcock e dal fido scenografo Robert Boyle è una copia/modellino di una casa di Frank Lloyd Wright, del cui coinvolgimento nell’esecuzione del suddetto tempio della Rimembranza Borglum si era in più occasioni vantato.
E così il Mount Rushmore illuminato dalla messinscena hitchcockiana del 1959 sembra rinascere in un nuovo valore artistico e soprattutto ad un riconquistato significato etico, ad una ricodificata presenza monumentale e storica; ed Eve Kendall, nella sua eroica scalata al fianco dell’eroe-Roger Thornhill in difesa dei valori democratici, nel continuo rischio della caduta nel precipizio (ricorrente ossessione nell’odissea americana del maestro inglese, da Saboteur a Vertigo) e nella sottesa dedizione al sacrificio d’amore (ricompensata con una maliziosissima allusione al matrimonio), onora quantomeno visualmente l’ideale bigger than life dell’eroina Rose Powell portando una figurina femminea sul tetto del “Tempio nazionale alla democrazia”, un anno soltanto prima della sua morte, avvenuta nel 1961: confermando un commento di Frank Lloyd Wright, secondo il quale “le teste di Mount Rushmore davano l’idea che la montagna avesse risposto alle preghiere umane”.
[1] Come sottolinea John Russell Taylor, il rifiuto a dirigere l’ACTT nel 1936 sembra coincidere con l’immagine di un Hitchcock che “temeva di essere identificato con una fazione da molti considerata turbolenta; èperòprobabile che a suo parere un’attivitàdel genere fosse fuori dal suo campo d’interessi e significasse solo perdita di tempo e di energie che potevano essere impiegati con maggior profitto, per lui e per chiunque altro, lavorando a dei film”, cfr. John Russell Taylor, Hitch. La vita e le opere di Alfred Hitchcock, Milano, Garzanti, 1980, pp. 158-159. Per un’approfondita discussione sull’argomento e sul cinema “politico”di Hitchcock, si veda: Giorgio Grimaldi, Guerra fredda e spionaggio nel cinema di Alfred Hitchcock, in: Marco Cipolloni – Guido Levi (a cura di), C’era una volta in America. Cinema, maccartismo e guerra fredda, Alessandria, Falsopiano, 2004, pp. 115-132.
[1] Cfr. Giorgio Gosetti, Alfred Hitchcock, Milano, Il Castoro, 1996, p. 24.
[1] Si veda anche il racconto che fa sempre Russell Taylor della reazione distaccata di Hitchcock alla notizia dell’appena avvenuto bombardamento di Pearl Harbour (dicembre 1941) ricevuta sul set di Saboteur, uno dei titoli “politici”della filmografia del regista, cfr. Russell Taylor, cit., p. 226.
[1] Grimaldi, cit., p. 125.
[1] Fabio Carlini, Alfred Hitchcock, Milano, Il Castoro, 1995, pp. 56-57.
[1] Carlini sottolineava anche le diffidenze sia del “sistema borghese che [del]la cultura progressista”nei confronti della ambiguitàpolitiche del cinema di Hitchcock, il quale “ha continuato a lavorare a Hollywood solo apparentemente ‘separato’dai drammi che il mondo stava vivendo, compiendo accuratamente il lavoro che si era proposto: mostrava l’individuo borghese medio a se stesso”, Ibidem, p. 82.
[1] Natalino Bruzzone – Valerio Caprara, I film di Alfred Hitchcock, Roma, Gremese, 1982, p. 21.
[1] Cfr. Master of Suspense: Being a Self-Analysis by Alfred Hitchcock, apparso in «New York Times», 4 giugno 1950, p. 4, ora in traduzione italiana in: Sidney Gottlieb (a cura di), Hitchcock secondo Hitchcock. Idee e confessioni del maestro del brivido, Milano, Baldini & Castoldi, 2000, pp. 151-152.
[1] A partire dal titolo, una teoria riproposta in varie occasioni voleva che North by Northwest fosse una variazione criptica sull’Amleto shakespeariano, nata da un passaggio di dialogo tra il protagonista e il personaggio di Guildernstern (“I am but mad north-north-west: when the wind is southerly I know a hawk from a handsaw”, Hamlet, Atto 2, Scena 2); ipotesi sostanzialmente smentita da Hitchcock nella famosa intervista del 1963 con Peter Bogdanovich, rintracciabile alla URL: http://www.industrycentral.net/director_interviews/AH03.HTM
[1] Simon Schama, Dinocrate e lo sciamano: altitudine, beatitudine, magnitudine, in ID., Paesaggio e memoria, Milano, A. Mondadori, 19982, §7, pp. 402-403 (corsivo mio).
[1] Schama riporta inoltre che “il progetto di un tempio della Rimembranza lungo trenta metri, con vasti soffitti, lucenti pavimenti di granito […] derivava da La donna eterna, epica hollywoodiana alla maniera di Griffith, tratta dal romanzo Lei di Henry Rider Haggard”; e aggiunge: “Nell’annus mirabilis di Griffith, 1915, in cui apparve Nascita di una nazione, […] Borglum stava lavorando a Stone Mountain. Vi fu perfino il tentativo di persuadere la distribuzione del film a devolvere il ricavato di alcune matinée al finanziamento dell’opera”, Ibidem, p. 402.
[1] Per una panoramica sul lavoro di Borglum a Mount Rushmore si rimanda a: Albert Boime, Patriarchy Fixed in Stone: Gutzon Borglum’s Mount Rushmore, «American Art», 5, nn. 1-2, Winter-Spring 1991.
[1] Schama, cit., p. 400 (corsivo nel testo).
[1] Cfr. Lincoln Borglum – June Culp Zeitner, Borglum’s Unfinished Dream, Aberdeen (South Dakota), North Plains Press, 1976, p. 68.
FUORI E DENTRO IL PALAZZO:
LE MALEFICHE BENEFICHE DEL CINEMA CONTEMPORANEO
di Roberto Lasagna
 Come la rediviva Biancaneve cinematografica delle scorse stagioni, rivista e bistrattata in molteplici lungometraggi, anche la bella addormentata risvegliata dai venti del cinema contemporaneo porta con sé significati allusivi al presente in corso. Il cinema, quello mainstream, si confronta con la favola, e dimostra di avere consapevolezza di quanto essa sia radicata tra gli umori e i nervi scoperti degli spettatori, che accorrono a gran frotte per rispolverare le corna archetipiche di Malefica, strega fatata quanto mai ingiustamente relegata da Disney a disperare nel limbo dei cattivi. Ora, come vuole un antimanicheismo di facciata, non ci sono solo buoni contro cattivi, ma cattivi-buoni oppure buoni malefici che si confrontano con il reale come se esso implicasse una sfida sempre aperta e dominata da uomini ingannatori. Uomini al cui fianco si rischia molto, garanti di una morte che non necessariamente ti fa bella. Il destino delle nuove principesse è scandito dal tempo, e la loro parabola è incorniciata tra un antefatto che rinvia alla caduta e la fine terrena che prelude ad una fama duratura. I film si mostrano dei biopic, ma, al contempo, del biopic ripercorrono maldestramente tratti poco probabili, offrendosi come incerti tentativi di riscrittura della storia con la S maiuscola.
Come la rediviva Biancaneve cinematografica delle scorse stagioni, rivista e bistrattata in molteplici lungometraggi, anche la bella addormentata risvegliata dai venti del cinema contemporaneo porta con sé significati allusivi al presente in corso. Il cinema, quello mainstream, si confronta con la favola, e dimostra di avere consapevolezza di quanto essa sia radicata tra gli umori e i nervi scoperti degli spettatori, che accorrono a gran frotte per rispolverare le corna archetipiche di Malefica, strega fatata quanto mai ingiustamente relegata da Disney a disperare nel limbo dei cattivi. Ora, come vuole un antimanicheismo di facciata, non ci sono solo buoni contro cattivi, ma cattivi-buoni oppure buoni malefici che si confrontano con il reale come se esso implicasse una sfida sempre aperta e dominata da uomini ingannatori. Uomini al cui fianco si rischia molto, garanti di una morte che non necessariamente ti fa bella. Il destino delle nuove principesse è scandito dal tempo, e la loro parabola è incorniciata tra un antefatto che rinvia alla caduta e la fine terrena che prelude ad una fama duratura. I film si mostrano dei biopic, ma, al contempo, del biopic ripercorrono maldestramente tratti poco probabili, offrendosi come incerti tentativi di riscrittura della storia con la S maiuscola.
 “Grace di Monaco” oppure “Diana – La storia segreta di Lady D.”, per dire dei più discussi film biografici sulle principesse del secolo scorso, sono due momenti “scandalosi” di una scrittura volutamente sottratta alla veemenza immaginativa; giocando sull’intima adesione delle interpreti ai personaggi di Grace Kelly e Lady Diana, Nicole Kidman e Naomi Watts inscrivono il loro portamento nei contorni di un’immagine che si fa memore di un passato sfiorato ma mai davvero riportato a galla. Se Grace di Monaco accenna a tinte glamour, i suoi movimenti e le sue ombre sono quelli di un film opaco sulla Monaco che diviene presto eremo di una sfida tra il bello e l’ingiusto, avamposto di sopravvivenza di un teatro delle meraviglie che al favoloso ha sostituito l’abile istinto di sopravvivenza della principessa che, scegliendo di rinunciare al ritorno sui set con Hitchcock, recita diventando regista in extremis della propria vita. Il volto di Nicole Kidman, che doppia una principessa destinata a non recitare più a Hollywood, chiaramente ci fa pensare a come lei stessa, dopo qualche ritocco ad un volto opalescente, rischi di restare immolata tra le statue dei ricevimenti regali, tra le figure postmoderne che i film celebrano con beata baldanza. Il volto di Naomi Watts invece, brava nel disegnare una Lady D. a cui non somiglia, restituisce candore e fragile immediatezza ad una “principessa della porta accanto”, figura cara alle donne di tutto il mondo che hanno visto in lei l’angelo tradito o la perseguitata dal gran potere. Nel film di Oliver Hirschbiegel Lady D. cerca l’amore, e lo trova nel chirurgo pakistano che non le chiede nulla ma che pretende di vivere la sua vita e la sua passione per la medicina lontano dai riflettori della notorietà. La regia di Hirchbiegel, che già si era preso le sue belle licenze “poetiche” raccontandoci con un Bruno Ganz tremolante gli ultimi giorni di Hitler ne La caduta, qui si inventa che nella realtà la madre del medico pakistano non avrebbe accettato un matrimonio tra il figlio e Lady Diana, per rimarcare così in una direzione inattendibile i secolari conflitti tra le culture e sottolineare una volta di più come Diana sarebbe divenuta un simbolo di conciliazione. La famiglia dei reali di Monaco ha rifiutato di presenziare a Cannes a Grace di Monaco e per il film su Lady D. non sono mancate critiche dai diretti coinvolti nel racconto. Al di là delle manipolazioni storiche, non sorprende che due film, dagli esiti umili su due argomenti non umilissimi, avvicinino le icone di desiderio e umanità, di seduzione e attitudine filantropica, rappresentate dalla fulgida Grace Kelly e dalla moderna Diana Spencer, all’immagine più intima e fragile, meno teatrale e indisponente, facendo scendere le due celeberrime donne dal loro piedestallo di leggenda e seguendo il loro percorso fuori dalle mura del palazzo, dove si consuma ed evolve la loro vita. Nei termini del filosofo e psichiatra americano James Hillman, la loro è una crescita che corrisponde con la discesa, alla ricerca del loro daimon, quell’immagine innata che, come una ghianda originaria, imprime un movimento di luce alle loro traiettorie e imprime un senso ad un agire sovente segnato dall’inquietudine. Grace, lontana da Hollywood, giocherà una partita politica imparando a recitare nelle alte sfere della diplomazia, mentre Lady D., lasciando il palazzo, girerà il mondo per portare un messaggio di tolleranza che avrà il suo più tangibile riconoscimento nella scomparsa delle mine antiuomo lungo le lande più desolate e abbandonate da uno sguardo umanistico. Queste donne, ebbre di un amore immaginato, desiderato, sognato, ritrovano le loro ali come le ritrova alla fine anche Malefica, splendida fata notturna avvinghiata ad una solitudine cui diede man forte il tradimento del suo amato. In “Maleficent” muore l’innocenza della bella Aurora, che anzi ci pare intollerabile al cospetto di Malefica, la fata madrina che ritratta il suo incantesimo mostrandosi capace del vero amore che, guarda caso, non sarà quello del principe azzurro, ma quello di una madre madrina pronta a restituire alla sedicenne figlia del re traditore, anche un futuro di vita improntato alla piena consapevolezza dei sentimenti. Il bacio che Malefica dona ad Aurora sul letto di morte, nel finale altamente drammatico di una vicenda fantasy, ridesta Aurora ma anche un immaginario di figure femminili doppie, duali, scisse, che recano dietro la maschera lo sgomento di un sentimento davvero troppo umano. Singolare che sia proprio la Disney, la casa madre degli archetipi cinematografici più edulcorati, a rammentarci con un nuovo lungometraggio dall’estetica avatariana che l’icona della principessa deve essere rivitalizzato e che l’innocenza non pare così scontata. Parte del merito di questa “risignificazione” della favola e della fanciulla va ad Angiolina Jolie, figura altéra e nobile, attrice impegnata nel sociale e icona del coraggio, garante di una femminilità non scalfitta dai seni asportati chirurgicamente e dagli zigomi di gesso, madrina di tutte le giovani adolescenti, principesse più del vero ricreato nei set hollywoodiani, madre forte e “fuori dal tempo” come splendidamente riassunto in “Changeling”, il film diretto da Clint Eastwood in cui la Jolie si confrontava con la perdita del figlio e con il fantasma di un’assenza-presenza destinato a riverberare sul suo profilo iconico e mitopoietico.
“Grace di Monaco” oppure “Diana – La storia segreta di Lady D.”, per dire dei più discussi film biografici sulle principesse del secolo scorso, sono due momenti “scandalosi” di una scrittura volutamente sottratta alla veemenza immaginativa; giocando sull’intima adesione delle interpreti ai personaggi di Grace Kelly e Lady Diana, Nicole Kidman e Naomi Watts inscrivono il loro portamento nei contorni di un’immagine che si fa memore di un passato sfiorato ma mai davvero riportato a galla. Se Grace di Monaco accenna a tinte glamour, i suoi movimenti e le sue ombre sono quelli di un film opaco sulla Monaco che diviene presto eremo di una sfida tra il bello e l’ingiusto, avamposto di sopravvivenza di un teatro delle meraviglie che al favoloso ha sostituito l’abile istinto di sopravvivenza della principessa che, scegliendo di rinunciare al ritorno sui set con Hitchcock, recita diventando regista in extremis della propria vita. Il volto di Nicole Kidman, che doppia una principessa destinata a non recitare più a Hollywood, chiaramente ci fa pensare a come lei stessa, dopo qualche ritocco ad un volto opalescente, rischi di restare immolata tra le statue dei ricevimenti regali, tra le figure postmoderne che i film celebrano con beata baldanza. Il volto di Naomi Watts invece, brava nel disegnare una Lady D. a cui non somiglia, restituisce candore e fragile immediatezza ad una “principessa della porta accanto”, figura cara alle donne di tutto il mondo che hanno visto in lei l’angelo tradito o la perseguitata dal gran potere. Nel film di Oliver Hirschbiegel Lady D. cerca l’amore, e lo trova nel chirurgo pakistano che non le chiede nulla ma che pretende di vivere la sua vita e la sua passione per la medicina lontano dai riflettori della notorietà. La regia di Hirchbiegel, che già si era preso le sue belle licenze “poetiche” raccontandoci con un Bruno Ganz tremolante gli ultimi giorni di Hitler ne La caduta, qui si inventa che nella realtà la madre del medico pakistano non avrebbe accettato un matrimonio tra il figlio e Lady Diana, per rimarcare così in una direzione inattendibile i secolari conflitti tra le culture e sottolineare una volta di più come Diana sarebbe divenuta un simbolo di conciliazione. La famiglia dei reali di Monaco ha rifiutato di presenziare a Cannes a Grace di Monaco e per il film su Lady D. non sono mancate critiche dai diretti coinvolti nel racconto. Al di là delle manipolazioni storiche, non sorprende che due film, dagli esiti umili su due argomenti non umilissimi, avvicinino le icone di desiderio e umanità, di seduzione e attitudine filantropica, rappresentate dalla fulgida Grace Kelly e dalla moderna Diana Spencer, all’immagine più intima e fragile, meno teatrale e indisponente, facendo scendere le due celeberrime donne dal loro piedestallo di leggenda e seguendo il loro percorso fuori dalle mura del palazzo, dove si consuma ed evolve la loro vita. Nei termini del filosofo e psichiatra americano James Hillman, la loro è una crescita che corrisponde con la discesa, alla ricerca del loro daimon, quell’immagine innata che, come una ghianda originaria, imprime un movimento di luce alle loro traiettorie e imprime un senso ad un agire sovente segnato dall’inquietudine. Grace, lontana da Hollywood, giocherà una partita politica imparando a recitare nelle alte sfere della diplomazia, mentre Lady D., lasciando il palazzo, girerà il mondo per portare un messaggio di tolleranza che avrà il suo più tangibile riconoscimento nella scomparsa delle mine antiuomo lungo le lande più desolate e abbandonate da uno sguardo umanistico. Queste donne, ebbre di un amore immaginato, desiderato, sognato, ritrovano le loro ali come le ritrova alla fine anche Malefica, splendida fata notturna avvinghiata ad una solitudine cui diede man forte il tradimento del suo amato. In “Maleficent” muore l’innocenza della bella Aurora, che anzi ci pare intollerabile al cospetto di Malefica, la fata madrina che ritratta il suo incantesimo mostrandosi capace del vero amore che, guarda caso, non sarà quello del principe azzurro, ma quello di una madre madrina pronta a restituire alla sedicenne figlia del re traditore, anche un futuro di vita improntato alla piena consapevolezza dei sentimenti. Il bacio che Malefica dona ad Aurora sul letto di morte, nel finale altamente drammatico di una vicenda fantasy, ridesta Aurora ma anche un immaginario di figure femminili doppie, duali, scisse, che recano dietro la maschera lo sgomento di un sentimento davvero troppo umano. Singolare che sia proprio la Disney, la casa madre degli archetipi cinematografici più edulcorati, a rammentarci con un nuovo lungometraggio dall’estetica avatariana che l’icona della principessa deve essere rivitalizzato e che l’innocenza non pare così scontata. Parte del merito di questa “risignificazione” della favola e della fanciulla va ad Angiolina Jolie, figura altéra e nobile, attrice impegnata nel sociale e icona del coraggio, garante di una femminilità non scalfitta dai seni asportati chirurgicamente e dagli zigomi di gesso, madrina di tutte le giovani adolescenti, principesse più del vero ricreato nei set hollywoodiani, madre forte e “fuori dal tempo” come splendidamente riassunto in “Changeling”, il film diretto da Clint Eastwood in cui la Jolie si confrontava con la perdita del figlio e con il fantasma di un’assenza-presenza destinato a riverberare sul suo profilo iconico e mitopoietico.
HA BALLATO UNA SOLA ESTATE
di Giulio D’Amicone
Pur rendendomi conto di adottare un punto di vista personale e tutt’altro che privo di punti scoperti, ho deciso di dedicare quest’articolo ad alcuni interpreti rimasti nella memoria per una sola interpretazione (o al massimo due) a dispetto di una carriera più o meno lunga.
1. Possiamo iniziare dall’area angloamericana. La scelta di Anthony Perkins nel ruolo di Norman Bates (“Psycho”, 1960) non si può che definire da parte di Hitchcock un colpo di genio. L’attore, figlio d’arte, aveva in precedenza ricoperto diversi ruoli (anche al fianco di Sofia Loren), ma solo il regista inglese comprese che il fisico del giovane si adattava perfettamente alla parte del solitario ed incompreso assassino. Una scelta talmente azzeccata da condizionare la carriera dell’interprete per tutta la vita a dispetto di successive partecipazioni illustri come quella nel Processo di Welles. Infatti nel 1983 appare uno “Psycho II”, tre anni più tardi uno “Psycho III” e nel 1990 addirittura un’ultima puntata per la televisione. Più che séguiti o antefatti sono parafrasi, certo superflue ma decisive per dimostrare la dipendenza totale dell’attore dal suo personaggio; e in fondo anche il suo “Dr. Jekyll-Mr. Hyde” (1989) risente non poco della figura di Norman.
A metà dicembre dell’anno passato è scomparso Peter O’Toole. Tra cinema e televisione, il sito IMBD elenca quasi cento interpretazioni dell’attore irlandese, ma nella memoria collettiva egli si è sempre identificato col colonnello Lawrence, l’ambiguo e narcisista guidatore della rivolta araba nella prima metà del Novecento (“Lawrence d’Arabia”, 1962). Nessuno dei personaggi successivi (quasi tutti segnati da accentuata neuropatia) è riuscito a rimuovere il ricordo del protagonista della rivolta antiottomana: non un lungo e sfibrante “Lord Jim” (“filmone elefantiaco e pretenzioso” secondo Massimo Bertarelli); non la doppia incarnazione del sovrano
Enrico II; non l’ufficiale assassino de “La notte dei generali” e men che meno il perdente del dimenticato “L’uomo che venne dal nord”. A titolo di omaggio postumo per un grande attore che collezionò ben otto candidature al premio Oscar senza mai ottenere la vittoria, vorremmo ricordare di lui un ruolo brillante: il ladro-poliziotto interpretato in uno degli ultimi film di William Wyler, “Come rubare un milione di dollari e vivere felici”, in coppia con un’impagabile Audrey Hepburn.
Restiamo in Inghilterra per aggiungere Malcolm Mac Dowell, che dopo l’exploit kubrickiano in “Arancia meccanica” non riuscì mai a riemergere e dovette accontentarsi di produzioni di nicchia (“Royal Flash”, “Oh Lucky Man…”). Infine, a dispetto di una buona partecipazione al famoso film di Oshima “Furyo”, lo scozzese Tom Conti salta alla memoria solo per la simpatica performance del loser nel film di Miller” Reuben Reuben” (1983).
2. La voce eccezionale di Shirley Bassey riempiva la sala durante i titoli di testa di “Agente 007 missione Goldfinger” (1964), terzo appuntamento con James Bond che portò alla ribalta l’attore tedesco Gert Frobe, interprete fino ad allora di parti secondarie: il suo Auric Goldfinger si impresse a tal punto nella memoria da provocarci un certo imbarazzo quando lo stesso interprete compariva in successive produzioni (per esempio il veggente nel film di Chabrol “Profezia di un delitto”).
Sono poi esistiti alcuni professionisti che hanno indovinato due colpi in un limite alquanto ristretto di tempo. Le prime opere che saltano in mente quando si pensa a Charlton Heston sono due: “I dieci comandamenti” e “Ben Hur”, entrambe separate da soli quattro anni; ed è un peccato se si pensa non tanto all’improbabile messicano di Welles (“L’infernale Quinlan”) quanto ai suoi western (“Sierra Charriba”) e sopratutto alla frequente presenza nei film fantascientifici degli anni settanta (tra i quali porremmo al primo posto “Occhi bianchi sul pianeta Terra”). Ancor più limitati nel tempo i due centri messi a segno da Sidney Poitier: “La calda notte dell’ispettore Tibbs” (1) e soprattutto “Indovina chi viene a cena”, entrambi risalenti al 1967. Poitier cercò di replicare il risultato con due successivi Tibbs senza rendersi conto che il personaggio, privato della fondamentale tematica razziale, non sarebbe più stato in grado di conquistare il pubblico.
Il nostro malevolo elenco non può non comprendere Tom Hulce, legato vita natural durante alla sua interpretazione del blockbuster ante litteram “Amadeus” (1984). Dispiace inserire anche il bravo Edward Norton, che ruba la scena a Richard Gere in “Schegge di paura! ma in seguito sembra voler proseguire pervicacemente lungo la strada Jekill-Hyde con minor successo (“The score”, “The Illusionist”). Nessuno scrupolo, invece, nel porre in lista Dennis Hopper, mediocre interprete assurto alla notorietà a causa di una produzione apparsa al momento giusto (“Easy Rider”, 1968) e poi vissuto di rendita più o meno dignitosamente per quarant’anni. Menzione speciale poi per Jobeth Williams e Craig T. Nelson, la simpatica coppia coinvolta nella storia di fantasmi casalinghi “Poltergeist” (1982, poi ampliata in due inutili seguiti) che non giovò alla loro carriera; mentre in tempi più recenti l’elenco non può non arricchirsi del nome di Eddie Murphy, poliziotto hollywoodiano per antonomasia.
3. Passando ora al versante femminile, diremmo che il primo posto debba spettare a Vivien Leigh. Ricusata da Hitchcock per la parte della protagonista in “Rebecca”, l’ex Rossella O’Hara si barcamenò fino alla prematura fine senza mai riuscire a recuperare l’acquisita popolarità; la sua partecipazione al Tram tennessiano nella parte della sfiorita Blanche si tinge di malinconia se si pensa che l’attrice aveva appena compiuto 38 anni. Se poi pensiamo a Mercedes McCambridge (il volto forse più antipatico di Hollywood) non possiamo che riferirci alla Emma di “Johnny Guitar”.
Un posto d’onore va riservato a Kim Novak, accettata di malavoglia dallo stesso Hitchcock per la difficile doppia parte di “Vertigo” (in Italia assurdamente divenuto “La donna che visse due volte”). A questa interpretazione si potrebbe aggiungere quella sostenuta ne “L’uomo dal braccio d’oro” premingeriano, film la cui popolarità è però imparagonabile al capolavoro hitchcockiano. E sempre a proposito di “Vertigo”, dispiace che a un’attrice graziosa e simpatica come Barbara Bel Geddes non siano più state offerte buone occasioni dopo il ruolo dell’aspirante fidanzata di Scottie. Non si può omettere la figlia d’arte Liza Minnelli, dalla quale era lecito aspettarsi grandi cose dopo la straordinaria performance di “Cabaret”; ben poco invece, riteniamo, ci sarebbe stato da aspettarsi da Maria Schneider dopo i solitari giochi erotici d’oltralpe… Similmente, chi ha visto “Space Vampires” di Tobe Hooper (il falso titolo italiano nasconde l’autentico “Lifeforce”) non avrà dimenticato Mathilda May, magari sperando negli anni successivi di rivederla in una parte altrettanto interessante…
Meno glamour ma più grazia possedeva invece Carrie Fisher – oggi quasi scomparsa dagli schermi – quando interpretava la principessa Leia (non Leila) nel ciclo “Star Wars”; tutt’altro che scomparsa invece è Mia Farrow, che tuttavia non ha lasciato segno dopo la perfetta interpretazione della ragazza qualsiasi nel film di Polanski “Rosemary’s Baby”.
4. Ma affacciamoci a casa nostra. Resistendo alla tentazione di porre in cima alla lista la “ragazza con la pistola” Monica Vitti (bisognerà pur assegnare, non foss’altro, un qualche credito storico alla tetralogia di Antonioni) e Giancarlo Giannini (cui si devono riconoscere diversi successi, pur se reiterando il medesimo personaggio offertoci nel 1972 in “Mimì metallurgico”), restringiamo il campo a un quartetto di nomi: Paola Pitagora, Lina Sastri, Saverio Marconi e Alessio Orano, esordiente quest’ultimo ne “La moglie più bella” di Damiani accanto a Ornella Muti (1970) e successivamente barcamenatosi tra cinema e televisione. Di Marconi resta memorabile solo il ruolo nel film “Padre padrone” dei fratelli Taviani: interpretazione pluripremiata alla quale non seguì – perlomeno in cinema – una carriera altrettanto prestigiosa. La bella e simpatica Paola Pitagora conobbe il suo momento di notorietà nel debutto di Marco Bellocchio “I pugni in tasca” (1965), dopo di che, a parte la Lucia televisiva, non sapremmo indicare altre interpretazioni di riferimento. Dispiace infine non aver più avuto l’occasione di apprezzare l’indiscussa bravura della napoletana Lina Sastri dopo l’ottima prova fornita in “Mi manda Picone” (1984). Forse gli apprezzamenti possono talvolta risultare più dannosi degli appunti.
5. E’ ora permesso concludere dando una rapida occhiata al panorama registico? Trascurando il piccolo gruppo delle promesse non mantenute sorte tra gli anni sessanta e i settanta (2), vorremmo focalizzare l’attenzione soprattutto su due figure: Peter Bogdanovich e Mel Brooks. L’eccessivo tasso di cinefilia (oltre ad una notevole presunzione) ha fatto sì che il primo si perdesse ben presto, dopo il divertente “What’s up Doc”, in produzioni a basso costo e ancor più basso riscontro di pubblico. Per quanto riguarda Brooks, la sua fama ha sempre poggiato su di un equivoco: si ritenne che “Frankenstein junior” fosse un “capolavoro comico” e non una goliardata occasionalmente ben riuscita, come tutta la scadentissima produzione successiva di quest’autore ha dimostrato a iosa. Tornando infine in patria, pensiamo sopratutto al compianto Luigi Magni, rimasto prigioniero del meritato successo ottenuto nel 1969 dal suo “Nell’anno del Signore”.
_____
(1) Nell’originale nient’affatto un ispettore ma un “lieutenant”.
(2) Negli Stati Uniti i vari Fraker, Hellman, Richards…
LA MIA CLASSE
di Federico Govoni
 Nel raccontare l’esperienza dell’incontro con immigrati di diversi Paesi, Daniele Gaglianone e Valerio Mastandrea sovrappongono i ruoli artistici di regista e attore alla loro quotidiana vita di cittadini, intrecciando realtà e finzione. Gli spettatori non possono rimanere passivi e comodi nei loro punti di vista quando la macchina da presa inquadra il farsi del film in un discorso metalinguistico: le immagini mostrano la troupe mentre prova i microfoni e quando osserva il monitor delle riprese; vengono anche ripetute alcune varianti delle scene. Il regista pone delle domande, infrange le sicurezze interpretative, interrompendo la finzione: lo stesso Daniele Gaglianone entra in campo per svelare la complessità delle scelte da cui nessuno può sentirsi escluso. E’ necessario rompere degli schemi e assumersi le proprie responsabilità di fronte al problema globale delle migrazioni. Il film su una classe di studenti stranieri da alfabetizzare diventa un documentario quando la realtà forza la macchina da presa: uno degli attori stranieri, una volta scaduto il permesso di soggiorno, deve abbandonare il set durante le riprese. Qual è la cosa giusta da fare? Continuare con la finzione? Da una parte c’è la legge, dall’altra la dignità delle persone ed i loro diritti inalienabili: la sicurezza e l’indifferenza si contrappongono all’altruismo.
Nel raccontare l’esperienza dell’incontro con immigrati di diversi Paesi, Daniele Gaglianone e Valerio Mastandrea sovrappongono i ruoli artistici di regista e attore alla loro quotidiana vita di cittadini, intrecciando realtà e finzione. Gli spettatori non possono rimanere passivi e comodi nei loro punti di vista quando la macchina da presa inquadra il farsi del film in un discorso metalinguistico: le immagini mostrano la troupe mentre prova i microfoni e quando osserva il monitor delle riprese; vengono anche ripetute alcune varianti delle scene. Il regista pone delle domande, infrange le sicurezze interpretative, interrompendo la finzione: lo stesso Daniele Gaglianone entra in campo per svelare la complessità delle scelte da cui nessuno può sentirsi escluso. E’ necessario rompere degli schemi e assumersi le proprie responsabilità di fronte al problema globale delle migrazioni. Il film su una classe di studenti stranieri da alfabetizzare diventa un documentario quando la realtà forza la macchina da presa: uno degli attori stranieri, una volta scaduto il permesso di soggiorno, deve abbandonare il set durante le riprese. Qual è la cosa giusta da fare? Continuare con la finzione? Da una parte c’è la legge, dall’altra la dignità delle persone ed i loro diritti inalienabili: la sicurezza e l’indifferenza si contrappongono all’altruismo.
Valerio Mastandrea interpreta un professore che insegna italiano agli stranieri, è simpatico e professionale nell’applicazione della didattica in classe. Spesso il film scorre spumeggiante grazie all’ironia dovuta agli equivoci linguistici, alla correzione degli errori grammaticali alla lavagna o alla sorpresa per la gestualità individuale debitrice della cultura di provenienza. Mastandrea è bravo nel condurre il gruppo e scherzare mentre le lezioni simulano telefonate per la ricerca di lavoro, la descrizione della giornata tipo di una donna, una riflessione sui diversi significati della parola casa. Tutti questi adulti, da alunni, devono imparare l’italiano per mantenere il permesso di soggiorno e avere più opportunità di inserimento sociale, sono in una posizione di fragilità, tuttavia gli spettatori, inevitabilmente, si riconoscono nella loro umanità e nei bisogni essenziali che esprimono pur nella diversità della lingua, di abbigliamento o di colore della pelle.
Dal film si passa al documentario autoriflessivo per sottolineare che non deve esserci distanza tra l’atto artistico e la vita, almeno Gaglianone e Mastandrea dimostrano con coraggio che vogliono superare questo dualismo nonostante i dubbi e le difficoltà che si pongono (è più facile agire se protetti dal “ruolo” di attore, insegnante o regista mentre senza queste maschere la coscienza non fa sconti). Drammaticamente, le storie di viaggio degli stranieri vengono narrate, una per una: la loro memoria di sofferenza e di abbandono delle famiglie al fine di trovare una migliore esistenza, la confessione delle speranze e di come abbiano affrontato incertezze e pericoli, si sciolgono nelle lacrime. Da emarginati, per chi sa guardare bene, diventano eroi epici che racchiudono, nelle loro esperienze, le contraddizioni e le conseguenze della politica mondiale: chi è scappato dalla guerra, chi dalle violenze o dalla povertà, tutti, in classe, attraverso il racconto, hanno la possibilità di farsi conoscere come persone e non come impersonali numeri statistici.
In classe, una delle lezioni affronta il tema dell’indifferenza. Dopo aver ascoltato l’intensa canzone L’autostrada di Daniele Silvestri, unica colonna sonora che interrompe i dialoghi e la presa diretta dell’audio, gli stranieri riflettono sulla profonda solitudine che sentono quando sono discriminati ma anche sull’individualismo che attraversa il mondo occidentale. Un ragazzo africano si stupisce che sui treni o sugli autobus le persone non familiarizzano come accade nel suo Paese.
La storia contemporanea entra nel film, c’è anche il racconto di un giovane che porta la sua testimonianza dolorosa della Primavera araba.
 I protagonisti non sono solo gli studenti ma anche l’insegnante, cioè Mastandrea che regge il peso della relazione con la classe di stranieri; in lui le figure dell’attore e dell’uomo non si distinguono e lo rendono autentico nel suo impegno ma anche nelle sue debolezze (è malato, non sempre ha le risposte per i problemi che si presentano). E’ significativa la sua confessione, durante uno scambio di idee con gli allievi, sulla paura: riconosce di avere paura di loro ma di avere il coraggio di venire tutti i giorni in classe ad avere paura di loro. Il regista indugia spesso su Mastandrea con primi piani densi di emozioni e silenzi, che descrivono bene la psicologia dell’insegnante quando cerca di entrare in empatia con gli studenti, donando molto di sé fino ad un limite, personale/istituzionale che lo mette in crisi.
I protagonisti non sono solo gli studenti ma anche l’insegnante, cioè Mastandrea che regge il peso della relazione con la classe di stranieri; in lui le figure dell’attore e dell’uomo non si distinguono e lo rendono autentico nel suo impegno ma anche nelle sue debolezze (è malato, non sempre ha le risposte per i problemi che si presentano). E’ significativa la sua confessione, durante uno scambio di idee con gli allievi, sulla paura: riconosce di avere paura di loro ma di avere il coraggio di venire tutti i giorni in classe ad avere paura di loro. Il regista indugia spesso su Mastandrea con primi piani densi di emozioni e silenzi, che descrivono bene la psicologia dell’insegnante quando cerca di entrare in empatia con gli studenti, donando molto di sé fino ad un limite, personale/istituzionale che lo mette in crisi.
Durante una lezione per imparare i diritti ed i doveri, il dramma della mancanza del permesso di soggiorno sconvolge l’ordine delle riprese: la ricerca della felicità di un giovane straniero entra in conflitto con le leggi. Il cortocircuito scuote gli spettatori quando vedono la polizia identificare ed avviare verso l’espulsione uno dei ragazzi che fino a quel momento aveva partecipato alla storia. Sono immagini di un film che però, purtroppo, racconta ciò che avviene nella realtà.
“Ho sognato di camminare lungo una strada di una terra straniera, ad un tratto un cane magro e bagnato per la pioggia ha iniziato a seguirmi, come se fosse il mio cane. Poi sono arrivato davanti la porta di casa, sono entrato, ho attraversato il cancello e mi sono seduto sugli scalini ma il cane è rimasto fuori: la padrona di casa era stata chiara, non voleva nessun animale. Anche il cane si è seduto sull’ultimo scalino, ci siamo guardati negli occhi, poi ha iniziato a lamentarsi ed a urlare disperato che sono un traditore. Ho avuto paura perché, se avesse potuto, mi avrebbe aggredito.”
Il monologo di Mastandrea, sintetizza, alla fine del film, con un’immagine forte, un destino da modificare.
Intervista al regista Daniele Gaglianone
Il film è costruito su due livelli: la finzione e la messa in scena della finzione con lo stesso regista in campo.
Il film prima di iniziare le riprese ha deragliato, ci ha fatto deragliare. Noi volevamo addomesticare la realtà, come spesso capita quando uno pretende di raccontarla. A un certo punto ci siamo accorti che la realtà ci stava prendendo a sberle perché quello che avevamo in mente, come sceneggiatori, si stava verificando veramente. Quindi la storia di un ragazzo che perde il permesso di soggiorno, il professore che gli dice di non preoccuparsi ma di venire a scuola lo stesso, il fermo del ragazzo da parte della polizia, il suo rifiuto di essere rimpatriato e il suicidio, questa vicenda stava succedendo veramente. Poco prima di iniziare le riprese, al ragazzo africano Issa viene tolto sul serio il permesso di soggiorno e io gli avrei dovuto dire di non lavorare perché privo di documenti. Era una cosa grottesca perché stavo facendo un film su questo e la realtà ha fatto toccare con mano a me e Mastandrea una contraddizione che è sempre latente, cioè tra quello che pretendiamo di pensare e quello che pretendiamo di fare. Questo scollamento è incarnato dal personaggio di Mastandrea, è un po’ il contrasto che attraversa le democrazie in cui entrano in conflitto la legge della città e la legge morale. Il film diventa un pretesto per raccontare, in modo anche un po’ allegorico, il rapporto con l’altro, come funziona nella nostra società complessa, contraddittoria. Nel film, le parti dove la realtà sembra evidente sono le più costruite. Non abbiamo buttato fuori nessuno, abbiamo detto: “Ok, facciamo conto che quello che è successo prima delle riprese accada durante le riprese, fingiamo di comportarci nel modo opposto a quello in cui ci siamo comportati, sbattiamolo fuori in modo che lo spettatore pensi che abbiamo allontanato veramente il ragazzo senza permesso di soggiorno per far vivere quella contraddizione- l’ambivalenza della narrazione non risolve la contraddizione ma incoraggia a indagare”.
C’è la volontà di superare le contraddizioni tra il regista e il cittadino, tra la finzione e la realtà.
La mentalità che spesso abbiamo noi registi è un po’ quella di dire: “Faccio il mio film impegnato così, in qualche modo, pago la mia tassa etica, però, essendo solo un regista, un artista, non posso risolvere le cose del mondo”. Non funziona questo discorso. Il personaggio di Mastandrea incarna bene questa situazione duplice: quando lui è attore e quindi quando è protetto in modo rassicurante dal suo personaggio, può comportarsi facilmente in modo corretto, ma quando nella realtà il ragazzo senza permesso di soggiorno va da lui come persona, delega alla produzione organizzativa del film la soluzione del problema. Le immagini incarnano un po’ le contraddizioni che sono ovviamente del cittadino Mastandrea. C’è uno scollamento, spesso, tra le nostre idee di prenderci delle responsabilità e poi le azioni che dovrebbero essere coerenti con queste idee ma che spesso non lo sono anche perché il sistema ci induce a non poter essere coerenti. Ho tentato di sottolineare il fatto di essere disposti a fare qualcosa che vada al di là della rappresentazione e di superare la dicotomia tra artista, narratore ed essere umano.
Il ruolo dell’insegnante è descritto in modo complesso perché si sente che avverte il peso della responsabilità pur con le sue fragilità. E’ protagonista al pari dei suoi studenti?
Nel definire il personaggio interpretato da Mastandrea ci siamo ispirati a qualche insegnante che abbiamo conosciuto; poi abbiamo preferito farlo stare un po’ in bilico per cui non è completamente buono nel senso che comunque lui fa l’insegnante di italiano, non lo psicologo e quando la gente si mette a piangere, dice che ne avrebbero parlato un’altra volta. Però c’è anche un suo percorso di crescita e maturazione. Il professore è caratterizzato anche da una certa fragilità accentuata dalla scoperta di essere malato. La scena in cui lui perde la busta con il risultato delle analisi ci ha consentito di fare dell’ironia metacinematografica sul nostro lavoro ma è anche un momento intenso, emotivamente, quando la ragazza, in silenzio, fa capire all’insegnante che lei sa che sta male.
L’individualismo e l’indifferenza del mondo occidentale sono comportamenti criticati in contrapposizione alla solidarietà che caratterizza il tessuto sociale degli stranieri. L’episodio in cui si parla del viaggio in autobus è emblematico.
Soprattutto chi viene dall’Africa subsahariana ha un altro modo di rapportarsi con l’altro e quindi credo sia stato interessante sentire raccontare una situazione quotidiana a cui siamo abituati, quella di stare su un metrò, pullman e vederla ribaltata, è molto umano, molto semplice, non si può prescindere dal fatto che si tratta di persone che devono comunicare. E’ un momento che ribalta la prospettiva, non sono gli stranieri ad essere quelli che hanno bisogno ma siamo noi che non ci accorgiamo di vivere male e loro, spesso, sono in grado di cogliere questa cosa.
Il racconto conclusivo del sogno del cane che viene lasciato fuori dal cancello e abbaia è metaforico e allo stesso tempo poetico. Qual è stata la sua ispirazione?
Questo episodio del cane mi è capitato a Sarajevo nel 1998. Quando giravo il film mi è tornato prepotentemente a mente e allora, mentre stavamo girando, ho scritto il monologo. Credo sia efficace perché racconta il senso di colpa con cui è inevitabile fare i conti: siamo disposti a prenderci delle responsabilità fino in fondo oppure no? Va bene così? O no? E allora che facciamo ?
Nel film viene messa in evidenza la contraddizione tra il rispetto delle leggi di uno Stato ed i principi fondamentali ed inalienabili dell’uomo?
In questi anni, purtroppo, si è compiuta un’operazione veramente molto pericolosa senza che ce ne accorgessimo tanto, cioè quella di far diventare il concetto di legalità sinonimo di giustizia. In un Paese veramente democratico la legalità non è un valore in sè, è uno strumento al servizio di un valore che è la giustizia, altrimenti la disparità è dietro l’angolo.
Il film ha avuto delle difficoltà di distribuzione. Perché se è molto bello?
Il film ha la distribuzione di Pablo, di Gian Luca Arcopinto, ce lo siamo distribuiti da soli. La distribuzione del film ha funzionato molto bene nonostante gli spazi ristretti, angusti che questo sistema di falso mercato lascia per vivere. Fa arrabbiare il fatto che se non fai parte di un “cartello” sei penalizzato: il sistema di distribuzione è gestito con una logica per cui se gli esercenti hanno intenzione di tenere ancora il film dopo aver visto che per tre giorni erano pieni, non possono perché altrimenti non avrebbero altri film dal sistema. E’ una sopravvivenza in una situazione di assoluto ricatto dove tutto viene gestito secondo logiche che con il mercato e con i valori del cinema non c’entrano niente e nemmeno col gusto del pubblico. E’ una falsa storia quella che gli esperti sanno che cosa vuole il pubblico e quindi in base a questo decidono che cosa far vedere o no.
Forse c’è il pregiudizio che parlare di scuola e di emigrazione è impegnativo?
No, magari, fossero quelli i motivi, saremmo già in un campo molto più raffinato, parleremmo di politica invece stiamo parlando di sciatteria, di poca capacità di comprendere quello che si ha intorno perché dire che il film è troppo sperimentale e la gente non capirà, vuol dire avere un’idea del pubblico denigratoria. Dietro questi grandi esperti si nasconde un disprezzo per la gente che fa paura. Una cosa che è mancata, purtroppo, al film e sarebbe stato il giusto coronamento di una operazione economica interessante, è stata la scarsissima visibilità nelle due città dove il film, potenzialmente, poteva andare benissimo, Roma e Torino; lì il film è stato ammazzato, nel vero senso della parola. A Roma, dove c’è un ampio bacino di pubblico di stranieri e di chi segue con interesse Mastandrea, è uscito in una sola sala piccolissima per tre settimane. Poi poteva essere sfruttato meglio e fare numeri molto grossi a Torino, che è la mia città, dove tutti i film che ho fatto fino ad adesso sono andati sempre molto bene. Quando è stato messo in programma la gente faceva la coda per entrare, poi l’hanno tolto.
I festival hanno apprezzato molto il film.
Spesso si parla di cultura come qualcosa di etereo, che non ha bisogno di nulla, invece si sta parlando anche di economia. Questa è la cultura: economia, lavoro e soldi. Io sono molto contento. Sono appena tornato dal Portogallo, ho fatto un tour col film a Lisbona, Oporto, adesso vado in Austria, a Mosca, a Monaco, in Norvegia; va benissimo, va bene per me, per il film. Però alla fine i numeri, che ti consentono di andare a portare un progetto nuovo, sono meno di quanti il film ne avrebbe potuto avere ma non per colpa mia o del film ma per colpa del sistema, lo stesso sistema che però decide chi fa film e chi non li fa.
Intervista al Dirigente Beppe Cencio del CTP di Alba-Bra
Osservazioni sul film (Esperienze di relazione e di democrazia)
Ho assistito alla proiezione de La classe di Gaglianone, l’esperienza descritta nella prima parte del film è analoga a quello che si verifica nelle nostre classi del CTP, frequentate da ragazzi stranieri. In questa situazione non conta solo l’insegnamento di tipo strettamente linguistico ma anche l’esperienza umana. A scuola vengono portati i loro problemi, le esperienze personali, la relazione che si crea con gli insegnanti. In genere si tratta di una relazione molto interessante e positiva. E’ una esperienza di democrazia, di cittadinanza, conta l’integrazione. Gli studenti avvertono tutti questi aspetti e si creano dei legami personali. Nel film si parla dell’indifferenza. Le persone che vengono qui sono studenti, alunni, ma quando escono dalla scuola ritornano stranieri e questa è un’esperienza quotidiana che spero si verifichi sempre meno.
La responsabilità morale degli insegnanti e le contraddizioni
I protagonisti del film sono gli stranieri ma anche gli insegnanti che portano una sorta di peso e d’impotenza e anche di frustrazione perché alcuni dei ragazzi che non avevano il permesso di soggiorno devono andare via. Anche qui a scuola capita che ci siano degli abbandoni durante l’anno. Da due anni, il sabato mattina, una volta al mese, a scuola arrivano circa 40 persone del territorio che fanno richiesta alla Prefettura per avere il test di riconoscimento di conoscenza della lingua italiana a livello adulto, normalmente si arriva al livello A2, riuscendo ad ottenere la certificazione. Se ottengono quello hanno il permesso di soggiorno. In questa situazione io ho vissuto un po’ la stessa frustrazione che prova Mastandrea nel film perché su tutte le persone che vengono, 2 o 3 non superano l’esame e spesso si tratta di anziani. Gli insegnanti provano angoscia perché in questa situazione devono certificare la conoscenza della lingua però sanno anche che se non la certificano, questa signora o quel padre corre il rischio di essere rispedito al suo paese. Allora fra le regole non scritte le viene data la possibilità di sostenere l’esame due volte. La scuola viene “usata” perché la legge prevede che, per avere il permesso di lungo soggiorno, bisogna dimostrare di conoscere la lingua italiana. Ci sono due possibilità: o il test del sabato mattina o un corso d’italiano che dura alcuni mesi. L’altra possibilità è l’accordo- integrazione: coloro che arrivano adesso firmano e devono dimostrare che entro 2 anni hanno conseguito il livello A2, hanno trovato casa, lavoro, medico, per cui hanno diritto a tutta una serie di punteggi e, se raggiungono un certo livello, possono rimanere. Queste persone hanno un altro tipo di approccio con noi: vengono una volta ogni due mesi a seguire una sessione civica in cui sono costretti a stare di fronte ad un monitor per assistere a 5 ore di spiegazione su come funziona la Costituzione. Sarebbe preferibile offrire un corso d’italiano gestito da docenti che dialogano con loro e che parlano della Costituzione. Il Ministero dell’Interno ha preparato DVD in 15 lingue e loro stanno davanti al computer ottenendo così il titolo. Sarebbe preferibile impiegare queste 5 ore in alcuni incontri con insegnanti che spieghino che cosa è la Costituzione, come funzionano in Italia un ospedale, un ufficio postale, una banca ecc… Condivido il senso di frustrazione degli insegnanti perché, alla fine, spesso, si sentono quasi inutili in quanto tutto il lavoro che hanno fatto non può essere usufruito nella sua completezza dagli studenti. Si può dire quello che si vuole ma se poi non arriva quel benedetto permesso di soggiorno!
Il CTP (Centro Territoriale Permanente)
Il CTP nasce dopo l’esperienza, degli anni ’70, della scuola elementare per adulti. Poi ci sono state le 150 ore della scuola media. Dal ’98 il CTP è stato istituito dallo Stato per gestire l’istruzione di adulti italiani e stranieri. Nella scuola sono attivi corsi di alfabetizzazione, corsi ordinari di scuola media e poi è presente il rapporto con il carcere. La popolazione carceraria è costituita, nella maggior parte, da stranieri. Sono partiti i corsi di inglese, di informatica, di diverso genere; man mano si è inserito il flusso migratorio per cui buona parte degli utenti del CTP, adesso la maggioranza, è costituita dagli stranieri. L’utenza del CTP è diventata più legata ai corsi di alfabetizzazione, al conseguimento del titolo di scuola media per chi non ce l’ha o per chi ce l’ha nel suo paese ma non è riconosciuto in Italia. A breve il CTP dovrebbe essere scorporato, pare che in una Riforma sia previsto che i futuri corsisti possano frequentare solo i corsi di scuola media e non di alfabetizzazione. Il CTP è interessato anche a una parte della popolazione scolastica giovane a rischio di dispersione. Si tratta di ragazzi che hanno avuto nel loro percorso qualche problema e che il CTP può intercettare per evitare che vengano persi definitivamente. Bisogna tener conto che il nostro Paese è agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda le problematiche di analfabetismo di ritorno. Nella fascia di età che va dai 16 anni ai 64 anni, per quanto riguarda il titolo di scuola media e superiore noi siamo agli ultimi posti; non è degno di uno Stato democratico.




















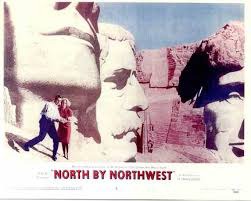
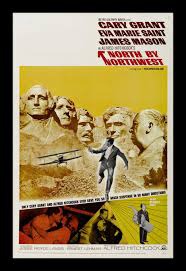

1 comment for “2014 numero 2”