Sommario
- 1 IL CUBO DI RUBIK
- 2 FEDIC
- 2.1 Sentimenti e tecnica all’11° stage FEDIC di formazione e approfondimento di Giorgio Ricci
- 2.2 Fedic: opportunità didattiche per un cambio generazionale di Roberto Merlino
- 2.3 SAGGI Cinema ed estetica analitica di Maurizio Villani
- 2.4 Ma gli ingegneri vanno al cinema? di Rita Castaldi
- 2.5 La costituzione immaginativa dell’oltre (su 2001: Odissea nello spazio) di Roberto Lasagna
- 2.6 Vendesi Killer di Giulio D’Amicone
- 3 FESTIVAL
- 3.1 La lunga estate calda del Sardinia Film Festival. VIII International Short Film Award 2013 – June 24-29 Sassari di Grazia Brundu
- 3.2 Venezia 2013: Una Mostra equilibrata con il “Leone d’oro” a un documentario di Paolo Micalizzi
- 3.3 31 ° Valdarno Cinema Fedic. Intitolato a Marino Borgogni il Premio Marzocco di Paolo Micalizzi
- 3.4 Rotterdam 2014 di Giampiero Raganelli
- 3.5 64^ Berlinale di Giampiero Raganelli
IL CUBO DI RUBIK
(LE MOLTEPLICI FACCE DI UN FILM)
Contributi di Paolo Micalizzi, Elena Galeotto, Giovanna Bonifazio, Valeria Mannelli
… E nel 1957 arrivò IL GRIDO – Paolo Micalizzi
Michelangelo Antonioni ha esordito nel lungometraggio nel 1950 con Cronaca di un amore dopo un’attività molto apprezzata nel documentario, dove contribuì ad un suo significativo rinnovamento. Un film che lo pose all’attenzione della critica per il suo stile di caratterizzare l’ambiente attraverso la carica espressiva dello studio psicologico dei personaggi. Iniziò a suscitare anche l’interesse del pubblico, anche se non riscosse un grande successo al botteghino. Malgrado ciò i film successivi non ebbero grande fortuna ed Antonioni rimase un regista incompreso che non riusciva ad essere capito e ad imporre la sua poetica dei sentimenti. Avvenne anche con Il grido (1957) che al suo apparire in Italia non convinse la critica e registrò anch’esso un insuccesso di pubblico. Ebbe, invece, un certo riscontro all’estero. Fu però nel 1959 che la sua opera iniziò ad essere presa nella giusta considerazione. Avvenne che in Francia, sull’”Express”, apparve un articolo del regista Alexandre Astruc (autore nel 1948 del fondamentale saggio “Camera stylo” in cui rivendicava per il regista le medesime libertà espressive e tematiche accordate all’autore letterario :divenne il “manifesto” della Nouvelle vague) in cui definiva il film un capolavoro.
Che Il grido potesse diventare un film interessante e importante, lo aveva previsto Paolo Gobetti che ne aveva seguito la realizzazione e ne aveva scritto le sue impressioni sul n°98 del 15 gennaio 1957 di “Cinema Nuovo”(“Dialoghi con l’operaio sugli argini del Po”). “C’è un’atmosfera d’inquietudine”, scriveva Paolo Gobetti, “che si disperde in una natura fredda e nebbiosa in cui i raggi del sole entrano come filtrati e dove il Po scorre sullo sfondo, disinteressato, senza passione”. Se Antonioni, si chiedeva Gobetti, “ riuscirà a renderla, se soprattutto il soggetto lo aiuterà a ricreare il mondo della Bassa padana ne uscirà indubbiamente un film interessante e importante. Ma è necessario che il Po sia veramente Po, che la Bassa e il Ferrarese e le valli di Comacchio corrispondano a una ben precisa geografia anche sociale perché la storia dell’operaio che non può dimenticare la moglie acquisti una dimensione autentica, italiana (anche se Cochran recita in inglese)”. “Bisogna insomma”, concludeva Paolo Gobetti, “che si tratti di una vcenda che si può svolgere solo in questo ambiente, in questa natura, che sia impensabile nel Texas: cosi ancora una volta il Po potrà dare al nostro cinema il suo prezioso contributo”. Caratteristiche che nel film si trovano e che la critica ha rilevato perché Antonioni si cala con sincerità ed emozioni in una storia che vede come protagonista Aldo, operaio del Polesine che viene abbandonato da Irma(Alida Valli), una donna della quale era innamorato e dalla quale aveva avuto una figlia, Rosina ( Mirna Girardi). Irma lo abbandona perché innamorata di un altro, e questo avviene nel momento in cui Aldo la vuole sposare. Lasciato il paese con la bambina, Aldo vaga per la pianura padana e nel suo girovagare ritorna da Elvia (Betsy Blair) alla quale era stato legato sentimentalmente ed ha altri amori, ma cade sempre più nella depressione. Un giorno ritorna nel suo paese, vede Irma che si è ben accasata e capisce che ormai non riuscirà più a riconquistarla. Disperato si lascia cadere dalla torre dello zuccherificio in cui aveva lavorato.
Con questo film il regista ferrarese ritorna ai paesaggi nebbiosi e all’umanità intorno al Po. Un paesaggio della memoria, quello della sua infanzia. Ed il senso del film è colto molto bene da Jacques Doniol-Valcroze che su “France Observateur” (11 dicembre 1958) scrive: “ Il grido è prima di tutto un uomo che cammina in un paesaggio”. E cosi poi prosegue: “Il paesaggio è l’inverno nei dintorni di Ferrara; nebbia pioggia neve freddo, una straordinaria sinfonia di grigi con qualche punto bianco, qualche tratto nero. L’uomo è uno ‘straniero’ dovunque, un ’uomo solo’ anche quando ha con sé la sua bambina: egli è già fuori della vita, le sue ultime compagnie sono dei fantasmi, egli sa di essere finito, ma non vuole ancora ammetterlo. Quello che vediamo sono gli ultimi soprassalti, la lenta agonia di un uomo che guarda le ultime manifestazioni di vita intorno a sé e si domanda se esiste ancora, al termine di questa notte, un posto per lui in un universo indifferente, silenzioso, impenetrabile. Ma al termine della notte, c’è la morte”. Altre le critiche francesi a favore del film. In seguito alla accoglienza in Francia, il mutamento di qualità dell’opera di Michelangelo Antonioni incomincia ad essere apprezzato in modo più convinto anche dalla critica italiana. Con Il grido il suo cinema incomincia a volare alto per raggiungere risultati di alto prestigio, da grande Maestro del cinema. E lo stile rigoroso e il rinnovamento del linguaggio costituiscono elementi di identificazione della sua alta statura di autore e di grande protagonista della cultura del Novecento.
IL GRIDO di Michelangelo Antonioni – Elena Galeotto
Se vogliamo conoscere chi è Aldo, protagonista de “Il grido” di Michelangelo Antonioni,occorre mettersi al suo fianco a cominciare dal momento in cui Irma, sua compagna da sette anni, lo abbandona per un uomo più giovane.
Lo sconcerto di Aldo alla notizia si colora ben presto di rabbia e quindi di disperazione, gettandolo in uno stato stuporoso che non lo abbandonerà per tutto lo svolgersi della storia.
Esce a tratti dal trance per improvvisare patetici tentativi per riconquistare la donna, preda com’è della sua incapacità a comprendere le ragioni della fine di un rapporto che avrebbe potuto prendere una strada definitiva, dopo l’annuncio della morte del marito di Irma. Quella che per sette anni è stata la sua compagna diventa improvvisamente un’estranea di cui non capisce più pensieri e intenzioni. La confusione aumenta quando Irma ammette di essere sempre stata trattata bene dal suo compagno.
Incapace di elaborare questa perdita, Aldo lascia il lavoro, la casa e con la figlioletta Rosina inizia a vagabondare per la pianura padana.
Fin dall’inizio la ricerca di una nuova stabilità si rivela difficile, soprattutto per l’ambiguità del desiderio di Aldo, che da una parte è preoccupato di trovare una sistemazione per Rosina e dall’altra dichiara esplicitamente di non voler essere mai più legato a nessun posto, a nulla. Dichiarazione che fa emergere ancor più dolorosamente il vero desiderio di Aldo, che tutto torni come prima. Forse è proprio questo l’errore di Aldo: tenere in vita un pensiero, un’immagine della vita di prima che presto o tardi finirà per idealizzare. Da questo momento in poi Aldo cercherà in ogni incontro, in ogni luogo le tracce della sua vita precedente come unica condizione per poter tornare a vivere.
La sua ricerca inizia con la visita a Elvia, la ragazza che ha lasciato per Irma. La ritrova nella solita casa, dove nulla è cambiato, dove il tempo sembra essersi fermato al momento in cui Aldo ha lasciato la ragazza. Elvia è rimasta congelata a quell’abbandono e il suo amore per Aldo si è perpetuato come amore ideale e impossibile, più difficile da dimenticare di ogni amore reale. Il rivederlo le fa balenare una possibilità che ormai credeva perduta, non sa risolversi tra l’incredulità dell’incontro e l’avverarsi di un desiderio mai sopito. Viene riportata alla cruda realtà quando Irma viene a trovarla per portare una valigia con effetti personali di Rosina e di Aldo che, nella furia della partenza da Goriano, aveva tralasciato di portare con sé. Il bivio che si apre innanzi a Elvia la costringe a prendere posizione di fronte a Aldo, ma soprattutto riguardo alla sua illusione. O restare con Aldo, sapendo che l’uomo è tornato sotto l’impulso dell’abbandono di Irma e quindi accettare di esserne il rimedio, o lasciare definitivamente la speranza di poter essere la sua donna. Sceglierà la seconda ipotesi ma questa volta sarà lei a prendere l’iniziativa, riconoscendo che i presupposti di un rapporto d’amore non possono nascere dal bisogno di sistemarsi. Per Aldo Elvia è forse la possibilità di lenire il dolore dell’abbandono di Irma attraverso l’escamotage del ritorno a un passato antecedente, quasi a voler rinnegare sette anni vissuti insieme e finiti nell’estraneità.
D’ora in poi gli incontri di Aldo saranno connotati dalla casualità, com’è tipico del peregrinare di un vagabondo. Si imbatte così in Virginia, una vedova che vive con il padre anziano e gestisce un distributore di benzina. Virginia è una donna sola, abituata a incastrare la sua solitudine con quella di chi passa di lì. La donna offre ad Aldo e Rosina ospitalità in un capanno e la bambina trova ben presto nell’anziano padre della donna un divertente compagno di giochi e di battute.
La malinconia di Aldo e la solitudine di Virginia cercano di neutralizzarsi a vicenda in brevi e fortuiti incontri rubati alla quotidianità e al lavoro. Ma quello che sembra essere un sogno per entrambi, viene continuamente interrotto dalla realtà delle bizze del vecchio e dagli arrivi imprevisti e inopportuni di Rosina. Quella che pare una inconsapevole congiura della realtà contro il sogno, pone Aldo di fronte ad una alternativa: o pensare a se stesso come uomo o pensare a se stesso come padre e occuparsi quindi di Rosina. E’ uno dei nodi che affliggono Aldo, un’espressione del suo dualismo nel quale non sa risolversi. Così la piccola Rosina si ritroverà su di un pullman che la riporterà dalla madre, inseguita dall’accorato appello del padre a perdonarlo, a capire ciò che è impossibile da capire per una bambina di quell’età.
La partenza di Rosina radicalizza ancor più la malinconia di Aldo, il suo sentirsi perduto. Il successivo approdo lo vede alle prese con alcuni conterranei che hanno fatto fortuna con il traffico di droga in Sudamerica. Lì incontra Andreina, una prostituta che tira avanti tra sogni di grandezza, fame e indigenza. L’abitazione della donna, una baracca adattata alla meglio nella quale Aldo si imbatte per caso, incute sentimenti contrastanti così come il personaggio che Andreina incarna. Ella gli ricorda una donna che è di tutti cioè di nessuno. Ricorrono le stesse parole pronunciate con disperazione e rabbia a Irma: “ E adesso torna a casa!”. Frase infelice che sortisce l’effetto contrario a quello desiderato da Aldo.
Elvia, Virginia e Andreina: altrettante ripetizioni di un rapporto impossibile, di una relazione fallita. Ognuna di esse esalta l’aspetto di contraddizione in cui Aldo si dibatte: il desiderio di legami e l’insofferenza verso di essi, il piacere intravisto in ogni donna e l’impossibilità di attingervi, la speranza in un futuro migliore e la malinconia per un passato che non riesce ad essere tale.
Le ultime scene del film vedono l’uomo a tornare a Goriano, all’inizio del suo viaggio e della sua disperazione. Ma la realtà che trova raggela in un istante le sue illusioni: quella di aver dimenticato e quella di ritrovare tutto come prima che Irma lo lasciasse. Lo scontro con il presente di Irma, felicemente sposata e madre di un altro bambino, lo manda alla deriva.
L’epilogo tragico dà un taglio netto al conflitto di Aldo : un viaggio inutile, senza elaborazione della perdita si conclude con un lancio nel vuoto. Il cerchio si chiude laddove era cominciato, lo zuccherificio presso il quale l’uomo lavorava. Dove tutto è iniziato, tutto finisce. Il grido, in sordina per tutto il film, esplode ora con tutta la sua forza.
DA ANTONIONI A WENDERS di Valeria Mannelli
Ho visto la prima volta “Il Grido” (1957) di Antonioni 25 anni fa, durante il corso di storia e critica del cinema di Guido Aristarco all’Università La Sapienza.
Non avevo notato allora tutto il fango e la terra sui vestiti dei protagonisti, in particolare di Aldo (Steve Cochran) e sua figlia (Mirna Girardi). Visto oggi, nei luoghi dell’infanzia e della giovinezza di Antonioni : Occhiobello, Pontelagoscuro, le rive del Po, gli stessi del suo primo documentario Gente del Po (1943), il film colpisce per la sua cifra neorealistica . Paesaggi e abitazioni povere, capanne, strade sterrate, fabbriche, nella miseria dell’Italia rurale degli anni Cinquanta, un formidabile bianco e nero per la fotografia di Gianni Di Venanzo.
“Questa è la mia sola presunzione: di aver imboccato da solo la strada del Neorealismo. Eravamo nel 1943. Visconti girava Ossessione sulle rive del Po, io a pochi chilometri di distanza giravo il mio primo documentario. Il Po di Volano appartiene al paesaggio della mia infanzia, il Po alla mia giovinezza. Gli uomini che passavano sull’argine, trascinando i barconi con una fune a passo lento, più tardi gli stessi trascinati a convoglio da un rimorchiatore, con le donne intente a cucinare, gli uomini al timone, le galline, i panni stesi, vere case ambulanti. Appena mi fu possibile tornai in quei luoghi con una macchina da presa. Così è nato Gente del Po. Tutto quello che ho fatto dopo, buono o cattivo che sia, parte da lì” (Michelangelo Antonioni).
I paesaggi del film Il Grido non sono abitati dalla borghesia italiana, “indagata” e “messa in discussione” nella propria “malattia dei sentimenti” dei film precedenti “Cronaca di un amore” (1950), “La signora senza camelie” (1952), “Le amiche” (1955) e successivi : “L’avventura” (1960), “La notte” (1961), “L’eclisse” (1962), “Deserto rosso” (1964). Il protagonista e i personaggi del film, che può considerarsi a suo modo un “road movie” ante litteram, convivono con la miseria, vivono alla giornata, indossano vestiti sporchi, soffrono il freddo, la pioggia, l’umidità e la malaria. Aldo (il protagonista) viene lasciato dalla sua donna Irma (Alida Valli) per un altro uomo, se ne va insieme alla figlia Rosina, perché soffre troppo. Inizia a vagare, “pedinato” dai lunghi movimenti della m.d.p, alla ricerca di un luogo e di una donna, dove poter reiniziare un’altra vita. Non ci riuscirà, la ferita e la solitudine sono troppo grandi; ad Aldo mancano la voglia di vivere e la forza interiore necessarie alla propria ricostruzione. Le donne che Aldo incontra e rincontra: Elvia (Betsy Blair), Virginia (Dorian Gray), Andreina (Lyn Shaw) sono a loro modo “personaggi positivi”, donne che lavorano e credono in un futuro migliore. Elvia è sarta, vive con la sorella Edera (Gabriella Pallotta), è pronta a riaccogliere Aldo e Rosina nella propria casa e ricominciare una vita insieme. Aldo, è ancora troppo legato ad Irma per accettare, dopo un breve tentativo, se ne va con la propria incapacità di riamare ed essere amato.
Virginia ha una pompa di benzina, è vedova, vive col padre ubriacone. Ha bisogno di un uomo che la protegga, offre ad Aldo un lavoro e la propria casa dove vivere tutti insieme. La convivenza diventa pesante, Virginia metterà il padre in una casa di riposo e chiederà ad Aldo di trovare per Rosina un’altra sistemazione. Andrà via anche da lei; metterà la figlia sulla corriera che la riporterà dalla mamma Irma. Rosina, per i suoi pochi anni ha già visto troppo ed è stata lasciata molto sola. Una delle ultime soste di Aldo è dalla prostituta Andreina, che vive sola in una baracca sulle rive del Po. Andreina non ha affetti. E’ in un certo senso quella che assomiglia di più ad Aldo nella sua condizione di “naufrago-sopravvissuto” , a differenza di lui però Andreina ha voglia e fame di vivere. Lo segue per un po’, ma capisce presto che “l’altrove tanto sognato” con Aldo non è possibile. A lui non resta che tentare di tornare a casa, dove scoprirà che Irma ha avuto un altro figlio. Si avvierà così verso la torre dello zuccherificio, dove prima faceva l’operaio per buttarsi nel vuoto davanti agli occhi e al grido disperato di Irma (“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” Cesare Pavese, potrebbe essere l’epigrafe del film).
La solitudine e l’incomunicabilità di Aldo ricordano quella di Trevis, protagonista del film “Paris Texas” (1984) di Wim Wenders, autore che ha sempre considerato Antonioni uno dei suoi “grandi maestri”, al punto di riuscire a girare un film “Al di la’ delle nuvole” (1992) con lui , tratto dal libro di racconti “Quel Bowling sul Tevere”, scritto dal regista negli Stati Uniti, quando stava girando “Zabriskie Point” (1969).
Trevis-Aldo rappresentano sia nel cinema di Wenders che in quello di Antonioni la crisi del personaggio-uomo, vale a dire l’esilio del cuore, il senso di fallimento e sfiducia nell’amore possibile tra un uomo e una donna, ma anche tra padri e figli. Aldo e Trevis non riescono ad amare come vorrebbero, congelati nella loro incomunicabilità. “Qualche certezza deve pur esistere se non di amare, almeno di non amare”, con questi versi di Dylan Thomas, Antonioni avrebbe voluto aprire il film “L’eclisse”. Poco importa chi pone fine alla relazione amorosa (uomo o donna che sia), entrambi i protagonisti dei due film non sanno amare, non riescono neanche con i loro figli Hunter (Paris Texas) e Rosina (Il grido), così desiderosi di riabbracciare le proprie madri (memorabile la scena dell’abbraccio tra il figlio e la madre in Paris Texas). Alla fine entrambi i protagonisti dei due film riprenderono (Trevis) o (Aldo ) pongono fine al proprio vagabondaggio.
“I miei personaggi sono morti nel deserto di Paris Texas” (Wim Wenders) , così come l’amore di Trevis (Harry Dean Stanton) e Jane (Nastassia Kinski). Anche il protagonista di Paris Texas, attraversa il deserto, così splendidamente fotografato da Robbie Muller, alla ricerca di se stesso, sta talmente male che non parla più, anche lui tornerà da Jane, per poi ripartire, stretto nel suo dolore di non riuscire ad amare.
L’immagine dell’uomo nei tempi che cambiano – Giovanna Bonifazio
Irma. Irma che si atteggia a donna enigmatica, che esprime una mimica che nemmeno Tamara di Lempicka, Irma che si interroga sui suoi falsi tormenti (sbaglierò? Che ne sarà di me? Aldo vorrà tenersi la bambina) quando in fondo ha già calcolato tutto, Irma egoista e crudele.
Irma che alla fine si riscatta e ottiene tutta la solidarietà del mondo femminile: come lo sopporti un uomo che non è ancora uscito dalla fase dell’egocentrismo infantile e dall’Edipo che lo lega alla figura virtuale della madre che proietta mentalmente nella donna ideale (o idealizzata)?
Questo giovane Werther noioso, capriccioso, maleducato (ma i posacenere non li avevano ancora inventati?) ed egoista, fissato su una figura fantasiosa di donna-madre che esiste solo nei suoi desideri, è l’immagine dell’uomo dei tempi che cambiano, che perde il controllo sulla figura femminile, figura che sfuma in forma di paesaggio desolato, quasi lunare nella sua scarsa e sconfortante antropizzazione.
E’ un tragedia sull’insuperata separazione dalla mamma, o per meglio dire della donna-mamma: quando un uomo cresce smette di vedere la mamma come immagine totalitaria dell’universo femminile, la ridimensiona, scopre che una donna è anche altro e con questo altro impara a costruire relazioni mature.
Antonioni la rappresenta in ogni aspetto della scenografia e della sceneggiatura. E’ una Madonna che non fa altro che dire al figlio “vai, io non posso bastarti, quello che potevo darti te l’ho dato ma adesso vai avanti”. Lo fa dire innanzitutto dalla madre che non si spreca in giri di parole: dice ”adesso ti devi arrangiare da solo” ad un figlio che ha l’espressione attonita di un bambino che ha appena scoperto che babbo Natale non esiste.
Lo ripete per tutto il film in un contesto dove questa Madre silenziosa, fredda, umida, appiccicosa e inafferrabile nello stesso tempo è lo sfondo che a volte si trova alle sue spalle, come se volesse spingerlo avanti (vai: “adesso ti devi arrangiare da solo”) e altre in cui Aldo è di schiena e sembra voler tornare.
E’ un’immagine ostile eppure onnipresente: l’intera vicenda si svolge in un arco temporale di un anno più o meno, ma stranamente è sempre autunno, piove sempre e se non piove comunque fa freddo e c’è la nebbia.
Cresci Aldo, cerca la tua primavera, guarda avanti. Ma il sole non compare mai e Aldo continua nella sua ricerca compulsiva:. Fugge da Irma e prende con sé Rosina, non perché la voglia veramente, altrimenti si preoccuperebbe un po’ di più di lei: parte di notte, non ha una valigia, solo gli indumenti che indossa, la fa dormire nelle topaie più improbabili.. La porta con sé perché non potrebbe lasciarla con Irma: la madre si dissolve assieme alla figura di donna, essendo le due figure inscindibili, e non può più occuparsi della bambina.
La porta con se e dove va?
Dalla ex fidanzata, Elvia di cui da tempo ormai non è più innamorato ma rappresenta la donna ideale. Elvia ha una casa accogliente, calda familiare, l’arredo è modesto ma disposto con amore: il ritratto di famiglia, la bambolina sul comò, centrini, piante… c’è dedizione in ogni angolo, quella stessa che una madre mette nella casa e nel prendersi cura dei figli.
Ma non la stessa con cui può amare un uomo che desidera.
Aldo capisce, si rende conto della differenza di aspettative e nella notte, dopo aver resistito ad un tentativo di seduzione da parte di Edera, sorella di Elvia, disperato abbraccia il materasso singhiozzando come un bambino: “Irma, Irma, Irma”.
Ed Elvia che non è disposta a far da materasso sia pure con dolore, lo metterà alla porta.
Il viaggio di Aldo prosegue fino a raggiungere la pompa di benzina dove Virginia vive col padre. E’ un contesto onirico, metafisico quello in cui si svolge questa parte, sembra davvero tratta da un famoso dipinto di Hopper. Anche i personaggi sembrano uscire dallo stesso pennello: persi ognuno nei propri pensieri e indifferenti all’altro come sconosciuti in ascensore.
Virginia si innamora di Aldo, lo invita a rimanere con lei in quella casa surreale in mezzo al nulla che ha comprato vendendo la fattoria del padre.
E’ una bella casa grande, confortevole, tenuta con una cura non sufficiente però per poterla definire ospitale. Virginia è una ragazza che lavora tanto ed ha le sue ambizioni. Non è egoista, il suo desiderio di emanciparsi in fondo è legittimo, così fa ricoverare l’anziano padre e propone ad Aldo di liberarsi di Rosina che viene rispedita a casa da sola su un pullman.
Ma proprio ora che potrebbero star bene insieme, scatta l’Edipo strisciante: “non mi prendo cura di mio padre figurati se mi prendo cura di tua figlia” dice onestamente Virginia. Che donna può essere una che pronuncia una frase del genere?
Aldo riprende la sua odissea di lavori trovati e perduti, progetti di viaggi che cadono nella rinuncia. In questo vagabondare abbiamo l’unica scena di convivialità: cinque uomini attorno ad un tavolo che parlano di viaggi ridendo, bevendo e fumando. E’ l’unica scena in cui si sente il calore e la genuinità nelle parole, negli sguardi, nello spazio angusto ma allegro.
Qui Aldo conosce Andreina. Bellissima e sfortunata vive in una baracca orrenda ma arredata con grazia, dignitosa e molto molto ricercata. Nella totale miseria non manca un vaso di cristallo con fiori, cornici che rimandano ad una famiglia, boccette di profumo…lei stessa è una bambolina che non rinuncia a vestire raffinato. Il suo cappotto è un modello elegante anche se pieno di macchie, porta scarpe col tacco anche nel fango. Andreina non vuole arrendersi, deve mascherare la tristezza della sua sconfinata solitudine e povertà. Ma pur di fuggire a questa solitudine va a vivere con Aldo che a sua volta è finito in un tugurio che non ha più nessuna sembianza che possa accomunarlo al termine casa. Il tetto è costituito da un telo che si imbarca sotto il peso della pioggia e fa cadere l’acqua all’interno. Aldo ridotto ormai all’imbruttimento non tenta nemmeno più di reagire.
Andreina capisce che quell’uomo non sarà mai un compagno al suo fianco; capisce che è lui ad aver ancora bisogno di essere accudito e così per procurarsi da mangiare si prostituisce. Per Aldo questo è insopportabile e l’abbandona nel disprezzo.
E’ il momento in cui capisce che non potrà continuare a scappare e, non si capisce con quali propositi torna al paese da Irma.
Irma ora ha un altro bambino, è una donna realizzata e Aldo, che la intravede da una finestra, getta definitivamente la spugna.
E’ un peccato che prima di gettarsi definitivamente tra le braccia di Madre terra, riesca a rovinare la vita a sei donne di cui una è la sua bambina di sei anni, vittima innocente di due genitori talmente presi da se stessi da ignorare totalmente la sua esistenza.
Il disagio esistenziale di Aldo si esprime attraverso la forza dell’immagine più che delle parole: Antonioni stesso, che è stato pittore, capisce il bisogno di esprimersi attraverso un linguaggio diverso dalla parola, in questo caso con l’arte figurativa. Il paesaggio fa emergere i lividi dell’anima. E poi le citazioni panoramiche di Sironi: edifici anonimi, trascurati, non del tutto fatiscenti, giusto quanto basta a rendere l’idea di desolazione, di disperazione senza però mai arrivare davvero alla ribellione, a quella presa di coscienza che porta ad intervenire.
Aldo si ferma dove la consapevolezza fa i conti con l’incapacità di reagire.
La storia finisce lì dov’era iniziato tutto: la fabbrica di zucchero, la ricerca della donna e l’abbandono infine tra le sue braccia, mentre le note alte della pianola accompagnano come un carillon il ricongiungimento con la Madre finalmente ritrovata.
FEDIC
Sentimenti e tecnica all’11° stage FEDIC di formazione e approfondimento di Giorgio Ricci
Dopo che, al termine dell’11° Stage di formazione e di approfondimento, l’instancabile Presidente della FEDIC, Dr. Roberto Merlino , ha voluto ringraziare Osvaldo Bargero per la collaborazione prestata, in modo inatteso, uno dei partecipanti, quasi commosso, rivolgendosi al maestro, lo ha ringraziato per i momenti di intenso amore che ha saputo trasmettergli durante la spiegazione dei motivi per i quali le scene dei film mostrati erano stati montati nel modo che avevamo visto. Dopo di lui quasi tutti si sono uniti nell’elogio e resi portatori di riconoscenza nei confronti di Osvaldo e della FEDIC che ha saputo offrire un evento di così alta qualità.
Ho preferito iniziare dalla fine dello stage perché non sono capace di trasmettere con la sola cronaca dello stage ciò che ciascuno di noi ha portato a casa. Indubbiamente la possibilità di mostrare suoi lavori effettuati al fianco di bravi registi e sceneggiatori ha facilitato il compito di Osvaldo il quale ha mostrato in questa occasione anche una buona ed efficace capacità di comunicazione. La sua collaborazione con il regista e sceneggiatore Alessandro D’Alatri lo ha portato a delle perfomance di montaggio di rara bellezza. Un ospite ad un certo punto ha chiesto se la scena che aveva appena vista e che aveva commosso tutti era frutto di un montaggio o “se era stata girata senza interruzione”; e il montaggio c’era ed era ovvio ma invisibile. Sono stati giorni intensi, vissuti lavorando dalle nove del mattino a mezzanotte interrotti solo dalle gioviali ed amichevoli pause pranzo e dai due eventi nella sala del consiglio comunale durante i quali abbiamo potuto apprezzare corti di vari autori FEDIC. Dopo pranzo , alla fine delle serate a notte inoltrata tutti alla caccia di Osvaldo per continuare a chiedere e pronti ad ascoltare. Non ho mai visto tanta partecipazione e tanto entusiasmo alla fine di uno stage.
Ventisette i presenti con una età media maggiore delle precedenti edizioni. C’ erano professionisti dell’industria cinematografica e televisiva e quindi alla alta qualità del maestro ha corrisposto anche una presenza qualificata degli ospiti.
Notevole ed apprezzata è stata anche la dimostrazione tecnica da parte di Giuseppe Capozzolo che ha voluto dare un saggio di ciò che potrà trasmetterci se e quando interverrà ad uno stage che avrà come oggetto la sua attività di compositore e light designer.
A far da cornice a queste entusiasmanti giornate lo splendido paesaggio, l’ospitalità generosa unita alla qualità della tavola ed il sorriso della gentilissima e ineguagliabile Caterina che ha fatto gli onori casa.
Fedic: opportunità didattiche per un cambio generazionale di Roberto Merlino
Se chiedi a un Presidente di Cineclub FEDIC quale sia il problema che maggiormente lo assilla, nella maggior parte dei casi ti senti rispondere: “Ci manca il ricambio generazionale: i nostri Soci invecchiano e i giovani non arrivano”.
Perché?
Come mai, a fronte di una crescita esponenziale degli appassionati, diminuisce il numero di coloro che si inseriscono nella vita di un Cineclub?
Forse -e lo dico con la dovuta cautela- molti Cineclub dovrebbero fare un po’ di autocritica, domandandosi se stanno offrendo ai giovani quelle opportunità e quegli stimoli di cui hanno veramente bisogno.
Non credo esista una “ricetta sicura” ma, ragionando in modo razionale, mi sembra ovvio che una possibilità concreta di fornire qualcosa di utile ai giovani consista nel trasmettere loro “esperienza” e “conoscenza”.
E’ anche in quest’ottica che la FEDIC, nell’ambito della Festa del Cinema 2013, ha progettato una giornata-evento, presso il Cineplex di Pontedera (PI), nel mese di maggio.
L’organizzazione tecnica era affidata al Cineclub FEDIC di Pisa “Corte Tripoli Cinematografica”, con l’adesione di altri 4 Cineclub FEDIC: Campolungo-FI, Cineamatori Apuane-MS, Sedicinoni-PT, 3D di Parma.
Il programma si componeva di 3 mini-laboratori di cinema nel pomeriggio, con proiezione di corti e dibattito in serata. In buona sostanza, insomma, utilizzando validi esperti, si sono creati momenti didattici, pieni di entusiasmo e di stimoli, iniziando a lavorare nel primissimo pomeriggio e concludendo in tarda serata.
I mini-laboratori hanno coinvolto numerosi giovani e giovanissimi (tutti i posti disponibili sono stati coperti) ed ha riscosso unanimi consensi, con la richiesta -a più voci- che progetti simili siano presi ad esempio e ripetuti anche in altre realtà territoriali.
La Direzione del Cineplex (struttura ospitante) ha espresso vivo compiacimento per quanto è stato realizzato, confermando la volontà di collaborare anche in futuro.
I docenti (Giuseppe Capozzolo, Francesco Giusiani, Roberto Merlino e Antonio Tosi) sono stati efficaci nel coinvolgere i partecipanti, tanto che molti si sono iscritti alla FEDIC, nella consapevolezza di trovare un punto di riferimento, qualificato e sicuro, per le loro prossime esperienze.
A tutti i partecipanti sono state donate due dispense, una di “sceneggiatura” (tratta dalle lezioni di Giacomo Scarpelli allo Stage Nazionale FEDIC del 2011) ed una di “illuminotecnica”, realizzata da Antonio Tosi.
Le proiezioni serali, gratis per gli “stagisti”, hanno previsto 9 cortometraggi-FEDIC, con tutti gli Autori presenti in sala:
- “Windows” di Nicolò Trunfio (6’)
- “Un ragazzo sfortunato” di Roberto Merlino (12’)
- “Il profumo dei fiori” di Jacopo Mancini (5’)
- “Riekajeski” Autori vari (7’)
- “L’inizio della fine” Cineclub Carrara (12’)
- “Bambino sarai tu!” di Barbara Sarri (12’)
- “Beyond Perception” di Alessio Biagioni (13’)
- “Innocenze perdute” di Francesco Giusiani (13’)
- “Primaria e fatale” di Stefano Terraglia (6’)
Terminata la visione dei film, l’interessante e acceso dibattito ha coinvolto e appassionato sia gli Autori che il pubblico.
La conclusione che mi viene spontanea, anche nella mia veste di Presidente FEDIC, è questa: “I giovani ci sono, hanno sete di sapere e di confrontarsi: offriamo loro -con i nostri Cineclub- quelle opportunità didattiche, di proiezione e di incontro di cui hanno bisogno… e ci ricambieranno con il loro entusiasmo e la loro energia!”
E avremo nuovi Soci nei nostri Cineclub.
Roberto Merlino
SAGGI
Cinema ed estetica analitica di Maurizio Villani
Nel dibattito che all’inizio del XXI secolo attraversa la filosofia dell’arte in generale e l’estetica filmica in particolare una rilevanza sempre più significativa, anche nella cultura europea, viene ad assumere la posizione dei pensatori di formazione analitica, tradizionalmente legati al mondo angloamericano.
Una informazione molto sintetica di questi orientamenti può essere utile per comprendere prospettive teoriche e approcci critici al linguaggio cinematografico, dominanti soprattutto negli Stati Uniti, ma che si vanno diffondendo anche di qua dell’Atlantico, grazie alle traduzioni delle opere più significative degli autori più noti.
Procederemo dando conto di due autori, attivi a partire dalla seconda metà del Novecento, il cui pensiero ha esercitato una influenza rilevante sull’estetica analitica statunitense: si tratta di Nelson Goodman (1906 –1998) e di Arthur Danto (1924).
Goodman: “i film sono opere allografiche a due stadi”
Nelson Goodman muove dalla convinzione, comune a tutta l’estetica analitica, che sia possibile applicare sia al linguaggio della critica d’arte sia agli “oggetti artistici” gli stessi metodi di analisi linguistica che la filosofia analitica applica al linguaggio in generale.
La questione teorica fondamentale che si pone in questa prospettiva nasce dalla difficoltà di definire i criteri di individuazione dell’ “oggetto artistico”. Devono essere criteri assiologici o normativi, valutativi o descrittivi? Goodman risponde escludendo la prospettiva assiologica e valutativa e scegliendo quella descrittiva. Dietro a questa posizioni si trova la tradizionale tesi neoempirista che distingue tra fatti e valori: tesi che, trasferita sul piano della fruizione artistica, porta a accentuare l’importanza della funzione cognitiva dell’arte a discapito del valore estetico. In un passo dell’opera più celebre di Goodman, I linguaggi dell’arte, uscita nel 1968 e tradotta in Italia nel 1998, si legge: «Dire che un’opera d’arte è buona, o anche dire quanto sia buona, non fornisce dopo tutto una grande quantità di informazione». La valutazione estetica non è esclusa, ma si aggiunge in un secondo tempo e non è “costitutiva dell’identità dell’opera in quanto opera d’arte”. «Concepire l’esperienza estetica come una forma di comprensione finisce per risolvere e insieme per svalutare la questione del valore estetico».
Emblematica, al riguardo, la proposta di Goodman di sostituire alla domanda “essenzialista” Che cosa è arte? con la domanda “funzionalista” Quando è arte?
La funzione e lo scopo dell’opera sono gli elementi costitutivi dell’identità dell’opera in quanto opera d’arte. Le opere d’arte sono simboli che svolgono alcune funzioni referenziali (rappresentazione, descrizione, esemplificazione, espressione). Nell’adempire a questo scopo la loro capacità di simbolizzazione va valutata «fondamentalmente dal fatto che servano più o meno bene allo scopo cognitivo: dalla sottigliezza delle sue discriminazioni e dall’appropriatezza delle sue allusioni; dal modo come opera nell’afferrare, esplorare e informare il mondo; da come analizza, classifica e organizza, da come concorre alla formazione, manipolazione, conservazione e trasformazione della conoscenza».
Importante per un discorso critico sul cinema che prenda le mosse dalle tesi di Goodman è la distinzione tra “opere autografiche” e “opere allografiche”, da lui proposta analizzando l’intero ambito della produzione simbolica (artistica) della cultura.
Le “opere autografiche” si rifanno a codici autoreferenziali in cui i segni rappresentano solamente (o principalmente) se stessi e di esse esista in un unico esemplare non ripetibile. Tale è, ad esempio la pittura, in cui l’opera ha un solo originale, che esclude la riproducibilità e che assegna alle copie uno status di prodotti derivati e impoveriti.
Al contrario, le “opere allografiche” hanno codici linguistici in cui i segni rappresentano qualcosa di diverso da se stessi. Tali sono le opere letterarie e musicali sono allografiche: possiamo identificare una poesia semplicemente leggendola, e possiamo identificare un’esecuzione musicale semplicemente ascoltandola.
Esistono poi anche opere autografiche ripetibili che Goodman definisce «autografiche a due stadi»: in quest’ultima categoria rientrano – al pari di incisioni e fotografie – e i film.
Scrive a questo proposito Enrico Turone, in un saggio sulla Filosofia analitica del cinema, che «di fronte a una proiezione di La sortie de l’usine Lumière non ho modo di stabilire direttamente (facendo affidamento solo su quel che vedo) che si tratta di una proiezione genuina del film dei fratelli Lumière e non di un falso che è stato prodotto in tempi successivi ricostruendo la scena originaria sul set, oppure mediante un’animazione digitale. In questo senso il film è un’opera autografica. Al tempo stesso, come sappiamo, il film è anche un’opera ripetibile. Ma il fatto che la ripetibilità del film sia garantita da un procedimento tecnico, anziché da una notazione, fa sì che la certezza nell’identificazione di un film, al cospetto di una proiezione, possa essere assicurata soltanto da conoscenze sul procedimento tecnico (storico-causale) che ha generato la copia proiettata, anziché dalla mera esperienza percettiva coniugata con competenze generali concernenti la notazione. Dunque i film sono opere allografiche a due stadi».
Danto: “l’arte adempie al proprio destino diventando infine filosofia”
Il più noto dei filosofi americani che si sono occupati di estetica è Arthur Danto. La sua riflessione sull’arte, centrata sulla Pop art e sull’arte concettuale, porta a ricercare, oltre l’oggetto in sé, tutto ciò che è implicito in esso. Nel saggio Il mondo dell’arte Danto scrive che «vedere qualcosa come arte richiede qualcosa che l’occhio non può cogliere – un’atmosfera di una teoria artistica, una conoscenza della storia dell’arte: un mondo dell’arte».
L’opera d’arte non è più tale per qualità estetiche sue proprie, come ad esempio la bellezza, ma in virtù di particolari relazioni che viene ad assumere con la struttura sociale in cui è collocata. Da questa tesi derivano due conseguenze: da un lato il rapporto tra arte e mondo quotidiano è modificato, in quanto finisce per scomparire la differenza tra l’oggetto esteticamente bello e quello esteticamente banale e il primo si riduce alla trasfigurazione del secondo; dall’altro lato, venuto meno il bello come criterio che decide dall’artisticità, quest’ultima è fatta dipendere da interpretazione teoriche extra-estetiche di tipo filosofico: l’arte perde la propria autonomia e «adempie al proprio destino diventando infine filosofia».
Questa posizione teorica ha trovato nella seconda metà del Novecento un’ampia accoglienza tra gli studiosi, ma anche obiezioni, che negli anni più recenti si sono fatte più consistenti, in concomitanza con la ripresa dell’attenzione per le componenti percettive presenti nell’esperienza estetica.
Le tesi di Danto hanno dato origine a un ampio dibattito, anche in Italia. Ne è un esempio il brano seguente di Alessandro Arbo, in cui la problematicità dell’estetica di Danto è evidenziata attraverso un esempio di critica cinematografica.
«All’apparenza, la soluzione di Danto è efficace: se vogliamo capire l’interesse artistico di un orinatoio rovesciato, non ha senso continuare a guardare le sue lucide forme sinuose; bisogna invece tenere presente chi lo ha fatto, perché lo ha messo lì, che cosa pensava di suggerire e a chi, perché gli ha dato un certo titolo. Di là dal suo carattere intuitivo, questa conclusione rischia però di condurci verso sentieri impervi o quantomeno trasversali rispetto alle vie del senso comune. Immaginiamo di chiedere a uno spettatore che ha assistito alla proiezione di Avatar che cosa ne pensi. Verosimilmente ci dirà che la storia gli è piaciuta, o che invece gli è sembrata banale, che si è sentito più o meno coinvolto o disturbato dalla grandezza delle immagini, dalla musica e dagli effetti sonori, dai contrasti dinamici, da certi colori, o da una certa “freschezza” della recitazione. Dovremmo forse dirgli che questi tratti sono in realtà insignificanti e che solo chi conosce per intero la storia del cinema hollywoodiano, dei colossal di James Cameron, della 20th Century Fox, delle musiche di James Horner e di altro ancora, e che ha discusso a fondo con produttori, registi, attori e critici cinematografici, può capire questo film? Non si tratta di negare che questi elementi possano effettivamente raffinare il gusto e aiutarci a giudicare; il nostro giudizio sarà però sicuramente condizionato da ciò che abbiamo visto e sentito: se Avatar fosse stato girato in VGA, se la sua foresta di felci assomigliasse, nel colore e nelle forme, alle siepi del giardino di casa, se gli attori avessero recitato in modo pessimo, non ne parleremmo nello stesso modo, con buona pace di critici e filosofi.
Questi ultimi potrebbero allora replicare – cavalcando un argomento che era stato al cuore della teoria dei francofortesi – che questi campioni sono solo dei prodotti di massa, una merce popolare o globalizzata, non esente da stereotipi sui quali la buona critica cinematografica ha avuto ragione di puntare il dito e che non conviene certo paragonare a opere più autentiche. Il problema di questa obiezione non sarebbe solo il suo palese snobismo. Per quale ragione, nel cercare di spiegare il modo di essere delle opere d’arte, dovremmo infatti pensare che rivolgerci a degli esemplari eccezionali – compresi quelli esposti nelle gallerie newyorkesi – sia meglio che prendere in esame l’arte di massa? Davvero abbiamo bisogno di credere che solo quando l’arte è portata all’estremo, cancellando ogni differenza fra i suoi oggetti e quelli del mondo ordinario, fa emergere una fondamentale domanda filosofica intorno al suo modo di essere? In realtà la differenza fra Avatar e le Brillo boxes non è così grande come può sembrare a prima vista. Anche volendo declassare il primo a prodotto dell’industria culturale, non riusciremmo a sopprimere il carattere prevalente del modo in cui entrambi si presentano alla nostra esperienza: come degli artefatti che, manipolando materia sensibile, si prestano a risposte, reazioni, commenti e giudizi – spesso sul loro valore – in chi li osserva. Questa evidenza non vuole cancellare, ma al contrario far balzare in primo piano il carattere enigmatico dell’uno o dell’altro esempio, entrambi ottimi candidati per un’indagine filosofica».
Il film come opera d’arte
Le questioni ora esposte introducono un altro tema intorno al quale convergono alcuni dei contributi più rilevanti dell’attuale discussione analitica: quella che riguarda artisticità del cinema. L’approccio in ambito angloamericano al problema della definizione del film come opera d’arte si differenzia da quello “classico” presente da molti decenni nella riflessione critica europea (e ritenuto da molti “risolto”) in quanto assume come tema centrale quello del rapporto tra film e realtà riprodotta.
Daniela Angelucci, nel saggio Cinema ed estetica analitica (2009) ha dato conto di due dei più significativi momenti di questo dibattito. Da una parte la posizione provocatoria sullo “specifico filmico” elaborata da Roger Scruton, secondo cui «dalla genesi meccanica della fotografia deriva il fatto che il procedimento cinematografico è casuale e non intenzionale, non comunicando pensieri né stati intenzionali dell’autore. Il cinema, dunque, non avrebbe interesse autenticamente estetico, poiché, se un film è un capolavoro, secondo questa tesi è in primo luogo un capolavoro drammatico, artisticamente riuscito in virtù della sua sceneggiatura o della recitazione, e non degli aspetti propriamente fotografici e filmici». Affermazioni rifiutate da Berys Gaut, che rigetta queste tesi e rivendica la presenza nella fotografia e nel cinema della trasformazione estetica della realtà e dell’intenzionalità dell’autore.
Riferimenti bibliografici e sitografici
Arbo A. e Cappelletto C., Estetica (o della sensibilità), in Filosofia contemporanea. Uno sguardo globale, Carocci editore, Roma 2012.
Angelucci D., Cinema, in Le arti nell’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, Macerata 2008.
Danto A. C., Il mondo dell’arte, in “Studi di estetica” n. 17, 2007.
Danto A. C., La destituzione filosofica dell’arte, Tema Celeste, Siracusa 1992.
Danto, A.C., La trasfigurazione del banale, a cura di S. Velotti, Laterza, Roma-Bari 2008.
Goodman N., I linguaggi dell’arte, Milano, il Saggiatore, Milano 1998.
Introduzione all’estetica analitica, a cura di P. D’Angelo, Roma-Bari 2008.
Angelucci D., Cinema ed estetica analitica (2009), in
http://www.treccani.it/enciclopedia/cinema-ed-estetica-analitica_(XXI_Secolo)/
Terrone E., Filosofia analitica del cinema, in
http://www.aphex.it/public/file/Content20130927_APhEx8,2013FilosofiadelCinema-Terrone.pdf
Ma gli ingegneri vanno al cinema? di Rita Castaldi
Giusto quarant’anni sono passati dalla scomparsa di Carlo Emilio Gadda, uno dei maggiori autori della letteratura italiana, interprete esemplare (in quanto anche protagonista) dei disagi individuali e collettivi del Novecento nostrano. Fu ingegnere per volontà materna, letterato per vocazione, filosofo “incompiuto” per aver sostenuto tutti gli esami della seconda laurea e preparato quasi integralmente una tesi, poi non discussa. Rispetto ai letterati lombardi otto-novecenteschi, che sapevano condurre un’acuta analisi sociale, prese le mosse da Manzoni (non era solo la comunanza d’ambiente, ma l’ammirazione verso il metodo), per differenziarsi con gli strumenti di una satira non semplicemente pungente, a volte «spastica», come la sua lingua, dimostrando forte vicinanza soprattutto ai modi dello scapigliato Carlo Alberto Pisani Dossi. Della vita, soprattutto dei fantasmi nevrotici dello scrittore, sappiamo tutto non solo per sua parola diretta ma particolarmente in virtù delle sue costruzioni letterarie. A condurlo verso i giudizi più esasperati furono proprio le parole, capaci di raggiungere l’espressività più audace ben più delle immagini (dispiace qui dirlo, un po’). Dagli studi filosofici (Leibniz era l’oggetto della sua tesi universitaria) aveva ricavato la sua concezione dell’uomo e dei rapporti con il reale: «Ognun di noi mi pare essere un groppo, o nodo, o groviglio, di rapporti fisici e metafisici: (la distinzione ha valore di espediente). Ogni rapporto è sospeso, è tenuto in equilibrio nel “campo” che gli è proprio: da una tensione polare. […] Fatti fisici, urti e strappi, lacerazioni del sentire, violenze e pressioni dal «di fuori», ingiurie e sturbi dal caso, dagli «altri», coartazioni dal costume, inibizioni ragionevoli e irragionevoli, estetiche ed etiche, dal mondo non nostro, eppure divenute nostre come per contagio, voi vedete, pesano siffattamente sull’animo, sull’intelletto, che l’uscir indenni dal sabba non ci è dato.»1 Gadda sosteneva, dunque, che è un groviglio di cause a sostituire la causa efficiente della logica classica e su questo costruiva personaggi, racconti o i “romanzi”, che risultavano monchi di una conclusione formalizzata pur al termine di lunghe analitiche ossessive indagini sugli eventi. Così lo scrittore giungeva a ribaltare le conclusioni dei suoi autori preferiti (Spinoza, Leibniz e Kant), per esempio sostituendo al principio di causalità (che è anche fondamento della narrazione) quello della coesistenza logica delle cause e, soprattutto, alla verifica leibniziana dell’«armonia prestabilita fin dall’inizio fra il sistema delle cause efficienti e quello delle cause finali» (principio d’ordine dell’universo) quella di un moto infinito di deformazioni del reale: dunque, indagare sulle cause di un fenomeno non significava per lui individuare la ragione del mondo ma la sua irragionevolezza, la «disarmonia prestabilita», come titolava un celebre saggio Gian Carlo Roscioni. Di più: la teoria delle concause, avvalendosi anche della “logica” dell’inconscio (fondamento della complessità dei personaggi), poteva portare a cogliere le relazioni fra le cose ma senza che il risultato dell’indagine sul reale potesse dirsi veramente sicuro. Il commissario Ingravallo e l’hidalgo Gonzalo Pirobutirro sono celebri personaggi che, in estrema sintesi, esemplificano il «nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo » dei fatti e il « male oscuro [… che] si porta dentro di sé per tutto il fulgorato scoscendere d’una vita, più greve ogni giorno, immedicato.» A generare il garbuglio prioritario risultava il tema della colpa, derivato da Spinoza, Leibniz e anche da Dostoevskij, risolto nell’idea della comune responsabilità di tutti di fronte al male commesso dal singolo.
Poteva un tale complesso di ambiguità trovare una soluzione cinematografica? In effetti l’unico testo gaddiano a trovare trasposizione filmica fu Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (apparso, ma non per intero, sulla rivista “Letteratura” nel 1946-47 e poi edito a sé nel 1957), divenuto nel 1959 Quel maledetto imbroglio con la regia di Pietro Germi, che ne fu anche interprete. Uomo di cinema nell’universo del neorealismo, riconosce Mario Sesti, Germi rimaneva tuttavia fortemente legato alle «strutture tradizionali del cinema, (i generi ad esempio)», soprattutto concepiva lo script come «il primo e decisivo strumento espressivo della sua idea di cinema», a ciò aggiungendo «l’intransigenza morale, l’idealismo civile, l’intervento sociale», che lo orientavano rispetto alla «presa diretta sulla realtà» tipica della cultura neorealistica 2. Non che Gadda amasse il neorealismo: in un intervento del 1950 rimarcava l’essere ogni fatto e ogni quadro, nella poetica del neorealismo, un «nudo nocciolo, … un grano di un rosario dove tutti i grani sono giustapposti ed eguali di fronte all’urgenza espressiva», con il di più della «tremenda serietà del referto», da cui risulta «quel tono asseverativo che non ammette replica, e che sbandisce a priori le meravigliose ambiguità di ogni umana cognizione»3. C’erano motivi di diversità e d’incontro fra i due: fra i primi, per esempio, questioni di carattere personale, che resero difficili i rapporti durante la lavorazione del film; li avvicinava la comune propensione per il genere poliziesco. Per Gadda il “giallo” era un modo di narrare adatto a esprimere il suo ossessivo e sarcastico rapporto con la realtà. Nel caso del Pasticciaccio la trama esterna risultava supportata, complicata e per ciò stesso, paradossalmente, resa più credibile dalle trame delle vicende individuali e fra loro intersecate dei vari personaggi agenti, a mostrare come si intrecciano, si integrano, si rivelano nella loro collusione i motivi profondi che spingono le vite delle donne e degli uomini. Dalla parte di Germi stavano la propensione per un cinema “popolare” e la volontà di costruire un genere poliziesco nuovo per l’Italia, non limitato dai consueti luoghi comuni a proposito dei protagonisti dello stesso, e il testo di Gadda (notoriamente modificato in più modi dal regista, fino allo scioglimento esplicito della vicenda) consentiva anche un arricchimento in termini di commedia. Ricordiamo pure che Federico Fellini riconosceva in Gadda il tipo del folle e goffo clown augusto: «inesauribile, un gigante entusiasmante, un pazzo favoloso, un grande acrobata che ti cucina a dovere con le sue pagine da applauso.»
Non entriamo nello specifico delle interpretazioni critiche che affrontarono il rapporto fra il libro e la pellicola di Germi, tali anche da individuare un collegamento quasi inspiegabile, ma chiaramente avvertibile, nella costruzione delle due opere (sintassi e lingua tese e deformate nell’uno, particolari inquadrature e movimenti di macchina nell’altro). Ricordiamo peraltro che il Pasticciaccio ebbe anche una riduzione televisiva nel 1983, con la regia di Piero Schivazappa e Flavio Bucci nei panni del commissario Ingravallo; in questa occasione la fedeltà al libro fu più evidente. Rimaniamo su Gadda, che -oltretutto- in epoca non sospetta, cioè verso il 1947 (tra l’uscita a puntate su Letteratura e la pubblicazione del libro) aveva preparato per la Lux un trattamento in 30 scene del futuro Pasticciaccio («Il palazzo degli ori») e attorno al 1956 aveva elaborato un accoppiamento giudizioso proposto come Antefatto (schematico progetto di racconto) seguito da un più ricco Dramma o Soggetto cinematografico sul tema di matrimoni combinati, rimasto inedito fino alla pubblicazione Adelphi del 2011 della raccolta Accoppiamenti giudiziosi.
Ebbene sì, allora: l’ingegnere “andava al cinema” e da tempo! Già nel 1926 aveva iniziato una collaborazione con la rivista «Solaria», diretta da Alberto Carocci, che nel 1927 pubblicò un numero monografico titolato Letterati al cinema, di grande attualità nel momento di massimo conflitto in Italia tra la cultura tradizionale e quella d’avanguardia. Nel novembre 1926 Gadda scriveva a Carocci proprio a tal proposito: «Avrei molto caro di collaborare con uno scritto al suo numero, che ritengo utilissimo. Le confesso però che io sono deciso fautore del cinematografo e che quindi il mio scritto non potrebbe essere che moderno e diciamo così futurista, tanto per intenderci.»4 Su «Solaria» l’anno successivo Gadda pubblicò un racconto dalla lunga elaborazione, edito successivamente anche nella prima raccolta gaddiana (La Madonna dei filosofi, 1931). La prima parte era presentata a Carocci come esempio di «psicologia da cinema», in quanto dava risalto alle locandine, alle luci e alla folla che costituiva «la stoffa panica del Cinema» e i temi principali erano «festosità, abbandono, povertà, sporcizia, disordine»; la seconda parte doveva lasciare spazio allo sviluppo di un film, ma non fu mai inviata alla rivista. Cinema raccontava in prima persona il pomeriggio festivo di un giovane intellettuale dalle scarse risorse economiche, che decideva di concedersi “follie” inconsuete per aver riscosso qualche soldo da lezioni private: una granita color «coda di ramarro … sublimata in uno smeraldo liquido detto menta glaciale », un sandwich ripieno di «un’oleosa sardina decapitata», caramelle ingoiate tre alla volta «crema caracca, menta glaciale e ratafià, (chissà poi che cos’è questo ratafià)» e, appunto, uno spettacolo cinematografico. Il racconto insiste sugli antefatti: la lezione, un giro per le strade del centro cittadino, l’ingresso al cinema “Garibaldi”, in un corso animato della gente più varia, la coda per il biglietto, fino all’entrata nella sala per prendere posto e allo spegnimento delle luci quando i «silenti sogni entrarono … nella sala». Ricchissima è la caratterizzazione dei vari spettatori nel loro look (sempre significativo di status sociale e carattere) e nei loro comportamenti: Gadda sapeva concentrarsi sui particolari fisici, spesso grotteschi e fortemente segnalati, sulle espressioni dei visi, sui tic, sui gesti inconsapevoli e registrare le emozioni individuali e collettive, a volte rabbiose o isteriche, delle persone di fronte a piccoli o grandi inconvenienti: primi piani davvero cinematografici, che la parola arricchisce di quello che non si vede immediatamente. La conclusione della giornata e la trama del film proiettato5 e i commenti degli spettatori sono nella seconda parte, rimasta inedita in vita dello scrittore, pubblicata in un numero di «Strumenti critici» (1982). Da essa e dalle lettere inviate a Carocci escono conferme importanti circa la predilezione di Gadda per il cinema: grande generatore di illusioni, oblio momentaneo della coscienza dal male. Saranno anche tutte balle, come riconosceva uno spettatore del “Garibaldi”, ma il cinema è cinema e Hollywood è un mito! Nessun sentimento di inferiorità della cultura di massa rispetto alla cultura alta: «Mentre sono molteplici le radici dell’arte, dalla religiosità, all’ironia, alla vanità, al bisogno estetico fondamentale, non bisogna dimenticare anche questo primo e speciale impulso: bisogno di stordirsi, che poi diventa cosa più perfetta, poi sale verso le cupole delle accademia.» Parole che coincidono con il pensiero espresso nel numero di «Solaria» sopra ricordato da Giacomo Debenedetti, per il quale il cinema ha la «capacità di farci sperimentare i nostri sentimenti allo stato puro», generando emozioni come quelle di «bambini» o «selvaggi», «con quei quattro o cinque sentimenti fondamentali (gioia, amore, odio, terrore e simili) che non siamo soliti riscontrare nella vita se non combinati in una chimica molto complessa».
Vita, ossessioni, scritti e ricordi di e sullo scrittore sono protagonisti del recentissimo docu-film di Mario Sesti, Fiamme di Gadda, affidato anche a letture di sue pagine, in cui si ripercorre la vicenda dell’«ingegnere in blu». Un aneddoto: la giovanissima Paola Bassani lo vedeva sempre rigorosamente in giacca cravatta e gilet nelle lontane calde estati in riva al Tirreno, durante le visite e i conversari di Gadda con il padre Giorgio e Pasolini (che con il cinema non scherzavano, fra l’altro).
La costituzione immaginativa dell’oltre (su 2001: Odissea nello spazio) di Roberto Lasagna
Nel secondo dopoguerra mondiale assistiamo a una nuova pagina della raffigurabilità delle inquietudini collettive attraverso il grande schermo. Con una formula esclamativa, G. Fofi e M. Flores possono asserire che “dopo Hiroshima, la fantascienza diventa un genere cinematografico a pieno diritto” (1). Di fatto, è la sua radice politica che offre alla fantascienza piena credibilità espressiva al seguito di avvenimenti che hanno mutato il modo di intendere il senso del pericolo totale. In questi anni affiorano senza troppi filtri le paure della distruzione planetaria, i mostri post-atomici giapponesi quali proiezioni di realtà inquietanti, gli alieni terrificanti e il terrore per le popolazioni di altri pianeti che maschera, spesso in modi benissimo riconoscibili, la paura per gli abitanti di altri pianeti del globo. E con Il pianeta proibito, nel 1956, è possibile parlare, da parte della fantascienza cinematografica, di un primo tentativo “alto” di contatto con la migliore fantascienza letteraria; pertanto, sin dalla seconda metà degli anni Cinquanta, assume tratti di riconoscibilità una nuova consapevolezza intellettuale capace di assorbire e sviluppare, tra i propri generi privilegiati, quello che più tardi permetterà una gamma di possibilità tematiche – nonché espressive – che solitamente sfugge ad ogni altro ambito fuorché a quello orientato alla documentazione e all’interpretazione delle inquietudini del reale. La fantascienza sembra ereditare lo scettro dell’autorevolezza filosofico-speculativa perché offre una libertà sui grandi temi e un’estensione delle possibili suggestioni ideologiche affini solitamente a un cinema altamente intellettuale, che però, a differenza del cinema di Science Fiction, non può usufruire delle facilitazioni di un genere riconoscibile capace di favorire la diffusione di massa delle sue riflessioni.
Se il ritardo della Science Fiction cinematografica su quella letteraria è stato di circa una decina d’anni, di quasi dieci anni è anche lo scarto tra il boom della fantascienza letteraria – riconducibile alla prima metà degli anni Sessanta – e quello della Science Fiction cinematografica (agitato e attraversato da due film di Kubrick, 2001: Odissea nello spazio e Arancia meccanica): uno scarto segnato da un periodo di cambiamenti importanti, di veri e propri sconvolgimenti nell’assetto politico mondiale e di trasformazioni profonde nei disegni sociali e culturali oltre che nelle aspettative tanto verso una soluzione pacifica dei contrasti internazionali e dei conflitti di classe, quanto verso quell’ottimismo che dopo il conflitto bellico mondiale gli Stati Uniti hanno propagandato quale eco propiziatorio di un mondo ordinato ed efficiente, sapientemente gestito da un supergoverno tecnocratico. L’ottimismo crolla con l’apoteosi della guerra fredda e dei film che hanno “fissato” sullo schermo il contemporaneo venir meno delle illusioni: L’ultima spiaggia, Il villaggio dei dannati; in questo clima di acuta inquietudine Losey gira, nel 1961, The damned, e Godard l’episodio Il mondo nuovo, incursioni di due grandi cineasti nel genere, che suscitano l’impressione di un ingresso definitivo della Science Fiction nel cinema cosiddetto “alto”. A partire da questo momento il filone fantastico viene a toccare ogni sorta di utopia e di anti-utopia; i mostri, pur senza scomparire del tutto, lasciano il posto al discorso sull’uomo e sul suo posto nel mondo di oggi. Alle meraviglie del possibile – pronte a riapparire con la “New Hollywood” di G. Lucas e S. Spielberg nella metà dei Settanta – si sostituiscono in buona misura le visioni che partono dalla conoscenza degli orrori della vita nella società contemporanea. Si tratta di paure reali, preoccupazioni che testimoniano di una crisi del controllo della propria esistenza, delegata a menti stolte e alle parole dei depositari del cinismo; in altri termini, è proprio in film come gli americani THX 1138, 2022: i sopravvissuti, i kubrickiani Il dottor Stranamore e Arancia meccanica, e negli europei Deliverance o L’uomo che uccideva a sangue freddo – per citare soltanto alcuni titoli significativi -, che affiora la presa di coscienza dell’invivibilità dell’ordine esistente gestito da una “normalità” patologica.
In questo quadro, non è proprio vero che 2001: Odissea nello spazio (1968) – titolo destinato a raffigurare il modello stesso della fantascienza cinematografica intellettuale – ottenga completa piazza pulita del precedente scenario di riferimenti letterari e cinematografici come vuole un diffuso consenso; il film, piuttosto, si installa centralmente all’interno del filone, di sua coessenziale matrice, dell’utopia positiva, allargando la portata autoriflessiva e l’ampiezza semantica del discorso sull’utopia nel cinema, quasi come Arancia meccanica, soltanto tre anni più tardi, sarà un punto di riferimento nel cinema degli orrori della realtà. E’ soprattutto indubitabile la caratteristica di opera nuova rappresentata dal film, in virtù dell’originale progettualità interna, quel suo offrirsi come viaggio e discorso sul tempo e sul progresso della conoscenza attraverso la visione di un futuro (forse) sempre reversibile. 2001: Odissea nello spazio quale film-evento “atteso”, come atteso è il lavoro che dica la parola definitiva sulla potenzialità di un genere (il film del regista più “innovativo” alle prese con il genere più ambizioso e filosofico), che sorprende subito per la sua qualità di “documentario mitologico” – una forma di racconto inconsueta che della tradizione letteraria conserva principalmente la figura dell’itinerario e l’epica dell’eroe -, la cui smagliante autonomia rispetto alla letteratura (non solo fantastica) e rispetto al cinema (non solo di fantascienza) risiede nel suo essere un racconto ellittico la cui eloquenza simbolica si polarizza su una serie di immagini-concetto; una caratteristica che, come avrebbe scritto il più “autorizzato” tra i critici di Kubrick, ne qualifica la singolare tessitura composta in buona misura di “enunciati visuali impliciti”, piuttosto che di “esplicite dichiarazioni verbali” (2).
2001: Odissea nello spazio, film per eccellenza della tensione-collaborazione tra una grande Major e un grande regista, è anche l’esempio celeberrimo di film quale “esperimento monumentale”, sintesi di opposti la cui brillantezza sancisce la via di una cinema autoriflessivo e autoreferenziale – spazio del cinema kubrickiano che diventa definitivamente lo spazio del cinema -, luogo in cui il cielo stellato è metafora luminosa di ogni visione (una metafora così avvolgente e debordante da rendersi, sin dal livello figurativo, visibilmente invisibile all’occhio dello spettatore). E’ nella composizione figurativa saldamente legata all’elemento intellettuale, alla strutturazione filosofico-metaforica, che si esplica la costituzione immaginativa di un film dove tra i protagonisti vi è il pensiero, l’intelletto umano incapace di commutarsi in ragione riflessiva e/o regolativa, il suo procedere in presenza di un’intelligenza extra-terrestre (il Monolite) la quale ha già compiuto e superato da tempo immemore i nostri passi. E per affrontare il tema dell’intelligenza extra-terrestre, mai toccato prima con tanta sottigliezza da un film di fantascienza, Kubrick concepisce l’immagine di 2001: Odissea nello spazio come lo schermo di un enorme planetario dal quale poter assistere, filosoficamente, senza alcuna fretta. Echi filosofici, d’altronde, sono disseminati lungo tutto il film, che omaggia Nietzche nel riferimento al super-feto e al Superuomo, ed è trionfalmente autoreferenziale sin dall’avvio al suono del poema sinfonico Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, allorquando il riferimento a Nietzche è anche il riferimento alla componente di novità in ambito culturale rappresentato dal quel testo al suo apparire storico, dove alla forma aforistica di “Umano, troppo umano” il grande filosofo antepose il modello della scrittura in versetti, propria dei Vangeli, una sorta di poesia in prosa, più conforme al tono rivelativo, intriso di pathos e di simboli e alieno da sviluppi troppo argomentativi (al contempo, il film di Kubrick si annuncia come il film “nuovo” in fatto di fantascienza cinematografica). La musica di Strauss, che trionfa all’inizio e alla fine del racconto, a sancire la circolarità “nietzscheiana” del film – il riferimento all’eterno ritorno – introduce la dimensione di scoperta tensione rivelativa delle immagini, e ne qualifica l’adesione intellettuale ad una dimensione filosofica nella quale “Dio è morto”, ma non è certo morto l’uomo che anzi rinasce di continuo al cospetto del progresso scientifico e di una super-intelligenza aliena che svolge il ruolo di Sentinella (dal titolo “Sentinella” del racconto del 1948 di Arthur Clarke, spunto per il romanzo di 2001: Odissea nello spazio e per il film omonimo). L’uomo muore e rinasce, ma non rinasce necessariamente come “Superuomo”, perché nel futuro delle macchine pensanti esisteranno pur sempre la lotta, il conflitto. Ciò che Zarathustra di Nietzsche insegna è una nuova libertà, la volontà libera, capace di creare il nuovo. Ma il nuovo affascina e spaventa, come il Monolite che condensa tutti i simboli e tutte le paure. Zarathustra è il “senza Dio”, un personaggio costruito da Nietzsche come contraltare della figura di Cristo: anch’egli è venuto per portar via molti dal gregge e dai pastori, cioè i seguaci dell’ortodossia che odiano chi “spezza le loro tavole dei valori”. Zarathustra annuncia la sua verità (che Dio è morto), cioè lascia cadere la supposizione di Dio per sancire che non c’è nulla da temere, né inferno, né diavolo, ma si può tornare a nutrire fiducia nella vita, lontano da speranze ultraterrene.
La leggerezza a cui invita Zarathustra è una danza che sovverte le vecchie tavole dei valori e perfino lo spirito di gravità, e 2001: Odissea nello spazio si compone formalmente di momenti di danza, dove la messa in forma dell’armonia raffigurata nelle circumnavigazioni delle astronavi ondeggianti nello spazio cosmico al suono di “Sul bel Danubio blu” di J. Strauss è mimesi allegorica di quell’impulso apollineo (un impulso di bellezza) che riluce per la sua magnificenza estetica ma che può anche inquietare in ragione del silenzio dell’uomo al suo cospetto. Come se la danza della tecnologia, esito della nuova vita in simbiosi con le macchine pur prodotte dall’uomo, fosse inscritta in un disegno “superiore” e umanamente ingovernabile (quasi una sublimazione della condizione umana ne Il dottor Stranamore) che lascia affiorare echi sinistri e non disomogenei con il pensiero evoluto delle “macchine pensanti” e dai poteri quasi divini cui allude Kubrick nell’intervista rilasciata alla rivista “ Positif” nel 1969. La messa in forma della luminescente danza tecnologica è dunque, essenzialmente, la raffigurazione estetica della condizione dell’uomo al cospetto con l’utopia del progresso scientifico, che obbliga necessariamente a una fotografia comprendente le sporgenze metaforiche e gli inquietanti interrogativi sul destino dell’individuo in uno scenario in cui, malgrado gli echi nietzschiani, la massificazione è palese e apparentemente irreversibile, come lo è la deriva di “irragione” amplificata dalla pur apollinea luminescenza delle forme create dall’uomo nello spazio. Di qui l’apertura simbolica del film e le accuse poco puntuali di “ambiguità” che spesso gli sono state rivolte. Perché l’ambiguità strutturale del film deriva dal suo essere un tentativo immaginativo di mimesi del cambiamento, di una evoluzione che può sembrare a tratti involuzione, dove la compiuta trasvalutazione dei valori ci proietta sideralmente nel futuro, quando il cammino di quell’“orango evoluto” che è il personaggio kubrickiano si confronta con nuove sfide che hanno il sapore perturbante della più scomoda rivelazione.
Tra tutte le definizioni del film, vale, per il senso di utopia proprio del tempo in cui le parole vennero scritte e per l’estrema risonanza con la progettualità kubrickiana, quella di Roman Polanski: “2001 è la scienza e l’immaginazione, che si incontrano in modo estremamente preciso” (3). Scienza e immaginazione, dunque, in altre parole, cinema; in questo senso, il “messaggio” del film risiede già nella sua superficie, nella sua struttura, e il Monolite, unione simbolica di concetto e materia (un parallelepipedo scolpito nella pietra), rimanda la nostra osservazione a qualcosa che ci è assolutamente lontano (l’alieno) ma ad un tempo vicino e familiare: la sua superficie liscia e “tattile”, nonché il ripetuto gesto dell’uomo primordiale il quale per comunicare non trova di meglio che sfiorarlo con le dita, ci ricordano il nostro atteggiamento di soggezione psicologica nei confronti dell’aspetto più sensuale e insieme perturbante della realtà; un aspetto che abbiamo contribuito noi stessi a creare attraverso la proiezione delle nostre paure. Il Monolite, oggetto astratto-materico, rappresenta in un film di sorprendenti immagini il sensuale del razionale, ovverosia “la sensualità inedita dell’astratto che si fa fisico” (4). E’ la mente colta e disvelata nel suo aspetto sensuale, o sensual-comunicativo. Il monolite, dunque, quale immagine mentale destinata a diventare specchio delle nostre proiezioni psichiche, poiché in Kubrick le paure coabitano con il ragionamento razionale minandone la salvaguardia. In questa prospettiva, oltre a darsi come entità extra-terrestre e come immagine di una perfezione ideale (cui rinvia la figuratività intrinseca alla sua forma geometrica), il parallelepipedo potrebbe ammettere anche un’interpretazione più scomoda ed inquietante: nella sua essenza di oggetto animato e insieme inanimato, nella compresenza in esso dell’elemento heimlich (familiare, domestico) con l’elemento unheimlich (sinistro, pericoloso, nascosto), l’oggetto è il simbolo inatteso e materializzato del perturbante di teorizzazione freudiana che ci riconduce alla concezione del mondo propria dell’animismo; “tale concezione era caratterizzata dagli spiriti inumani che popolavano il mondo, dalla sopravvalutazione narcisistica dei processi psichici, dall’onnipotenza dei pensieri e dalla tecnica della magia che su questa onnipotenza era costruita, dall’attribuzione di poteri magici accuratamente graduati a persone e cose estranee (mana), nonché da tutte le creazioni con le quali il narcisismo illimitato di questa fase dell’evoluzione si opponeva alle esigenze irrecusabili della realtà. Sembra che noi tutti, nella nostra evoluzione individuale, abbiamo attraversato una fase corrispondente a questo animismo dei primitivi; che questa fase non sia stata superata da nessuno di noi senza lasciarsi indietro residui e tracce ancora suscettibili di manifestarsi” (5).
Dalla ricerca di Freud la natura segreta del sentimento perturbante risiede in una parte dell’angoscia che accompagna la vita psichica sin da tempi antichissimi, è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo e riaffiora dopo essere rimasto nascosto a causa del processo di rimozione. Questo sentimento si offre quale spunto orientativo per collocare e studiare lo smarrimento esistenziale dei personaggi di Kubrick, i quali si muovono tante volte con malcelata afasia nel mondo che li circonda ricevendo impressioni di turbamento da fatti ed eventi. Il personaggio è in lotta con il mondo ma, con l’eccezione forse del solo Spartacus, è in lotta anche con se stesso. Dalla lotta, dal combattimento, sarà forse possibile uscire confrontandosi con la propria complessità, al seguito di un processo di individuazione che Kubrick ravvisa sin dalle prime mosse nel lungometraggio, tra le immagini del rinnegato e sorprendente Paura e desiderio. Il Monolite pertanto, figura simbolica per eccellenza, contenitore privilegiato per smodate interpretazioni ed insieme elemento sfuggente ad ogni tentativo di limitarne il senso, accoglie anche la funzione di uno specchio perturbante di portata cosmica pronto a riflettere le più antiche e diuturne paure dell’uomo.
Occorre ricordare che 2001: Odissea nello spazio sembra condensare nella parte introduttiva – nell’episodio “L’alba dell’uomo” – ogni sorta di conflittualità sociale, per lasciarsi, nelle successive tappe, all’emblematica e quasi apollinea contemplazione delle forme e dei movimenti dell’avventura spaziale, alla siderale iridescenza di una visione in cui hanno un ruolo di rilievo il metalinguaggio e la riflessione filosofica, dimensioni che appaiono strettamente legate tra di loro. L’itinerario dell’uomo nell’epopea di 2001 è principalmente un epos di conoscenza e in particolare di conoscenza visiva, tanto che lo sguardo e l’immagine diventano, nel futuro presentificato del film, i primi elementi dell’ideazione e del progresso conoscitivo. Nello sguardo e nelle tracce mnestiche di immagini ideative, e non invece nel contatto fisico immediato con i dati dell’esperienza oppure nella speculazione intellettuale, è infatti possibile situare l’avvio del movimento verso la comprensione. Indicativa, in questo senso, la scoperta del ruolo della clava da parte della scimmia. La prima idea dell’uomo primordiale nasce proprio dall’accostamento mentale di immagini: in un mondo in cui le scimmie non hanno ancora vissuto alcun “salto” verso un’esperienza significante, l’installazione del Monolite sul loro suolo provoca la comparsa della metafora (qui, come nella “Poetica” di Aristotele, la vista e l’udito sono i due sensi estetici per eccellenza, mentre la componente imitativa, ancora come in Aristotele, è all’origine dei comportamenti individuali); l’origine del ragionamento – il manifestarsi del processo intellettivo – è sancito dalle immagini che colgono figurativamente la genesi del pensiero e, al contempo, della civiltà. Il momento ejzenstejniano rappresentato dal raccordo che mostra il bue cadere sotto le ferite dei colpi solamente “ideati”, marca come il cinema, qui vistosamente attraverso il montaggio delle attrazioni (6), è quella forma di discorso che esprime oggettivamente il procedimento mentale del ragionamento per immagini. In altri termini, il cinema è quella forma immaginativa che permette, con Ejzenstejin, di prodursi come un’equivalente dei procedimenti del pensiero. Sotto un profilo figurativo, il raggiungimento dei processi ideativi attraverso la conoscenza visiva produce nel film anche una costante ossessione per l’occhio e per lo sguardo: l’immagine forse più vorticosa ed emblematica ritrae una giovane hostess dentro una grande astronave a forma di testa (a sua volta con due occhi rossi), la quale, in un corridoio a forma di iride, per salire nella sala del pilota deve capovolgersi, come scivolando sopra una retina ingrandita, e quindi viene raddrizzata comparendo, alla fine, in un interno rosso, proprio come all’arrivo dell’immagine nel cervello. Nella trasformazione delle forme e nei continui ribaltamenti prospettici cui il film invita estatico ad assistere, si esprime la principale caratteristica della macchina cinematografica kubrickiana, la sua forma e il suo smalto: la natura di un’esperienza che ruota su se stessa, contraendosi e dilatandosi nel chiasmo di un ordine imprevedibile; un’esperienza che diventa l’abito sensibilmente sovrasensibile dell’uomo con la sua pretesa di essere la “regione centrale” dell’universo (7). Figurativamente, l’uomo compare nel film di Kubrick spesso al centro dell’inquadratura, ma la sua “centralità” in 2001 è messa a repentaglio da posizioni spaziali inconsuete e da “sguardi” che sembrano originare unicamente da porzioni di nulla alle spalle della macchina da presa. Così, lo sguardo performato dell’eroe deve affrontare condizioni gravitazionali e continui mutamenti nei sistemi di orientamento che non sembravano affatto previsti nell’ordinarietà della vita terrestre, con il risultato rivoluzionario che i termini spaziali “su” e “giù”, come “destra” e “sinistra”, diventano le coordinate di un ordinamento inadeguato a comprendere la pienezza olistica del rapporto con il reale. E 2001: Odissea nello spazio è per lo spettatore, in primo luogo, un’esperienza di disorientamento, dove questo termine rivela qui la sua potenzialità strutturale di veicolo conoscitivo. Anzitutto, è sul piano della scrittura e dei procedimenti stilistici che vanno ricercati quegli elementi che permettono a Kubrick di reinventare, insieme al genere fantastico, un certo modo di intendere lo spettacolo cinematografico. Abbiamo già detto come il film stravolga le nostre quotidiane categorie di “alto” e “basso”, “sinistra” e “destra”, e ciò avviene perché la vita degli astronauti comporta il passaggio da un sistema di orientamento a un altro senza soluzione di continuità, ma in alcuni casi i differenti sistemi vengono anche a coesistere, senza implodere, nella stessa immagine: è il caso, ad esempio, del primo piano di Bowman visto dall’alto e del secondo piano di Poole visto frontalmente. Proprio in questo andirivieni di immagini “impossibili” si comprende l’intento di Kubrick di portare lo spettatore alla rottura delle sue abitudini percettive “normali”, per spingerlo a considerare, attraverso l’atto del vedere, come i nostri quadri di riferimento siano costruiti sopra una serie inattaccata di consuetudini (i “presupposti inavvertiti” di cui scrive Eugeni (8), e dunque il film si afferma come un itinerario anche straniante che viene a contemplare come argomento privilegiato proprio l’educazione dello sguardo a individuare l’essenziale di ogni movimento, umano o non umano. Si tratta, a ben vedere, di un’argomentazione che contempla le leggi del vedere e il loro confluire in una riflessione filosofica, attraverso le sequenze di un film che si dà come paradigma ontologico per la riformulazione dei processi metaforici nella rappresentazione cinematografica.
NOTE
1) G. Fofi – M. Flores, Cinema e fantascienza, Quaderno A.I.A.C.E, n° 15, 1975.
2) M. Ciment, Entretien avec Stanley Kubrick, in “Positif”, n° 139, 1972.
3) R. Polanski, “Cahiers du cinema”, n° 208, 1969.
4) E. Ghezzi, Stanley Kubrick, La nuova Italia, Firenze, 1977.
5) S. Freud, Il perturbante (1919), trad. it. Edizioni Theoria, Roma, 1984, pp. 55-56.
6) Il “montaggio delle attrazioni” è una teoria formulata dal regista russo Sergej Michajlovich Ejzenstejn nel 1924. Secondo tale teoria il cinema e il teatro dovrebbero essere utilizzati come strumenti volti a scuotere l’animo dello spettatore. Per raggiungere tale scopo è necessario realizzare un montaggio cinematografico magmatico in cui sono in tensione diversi elementi. Attraverso la messa in forma delle “attrazioni” lo spettatore deve essere spinto alla riflessione intellettuale. Ejzenstejn sostiene che proprio per sollecitare l’immaginazione dello spettatore il montaggio deve risultare scomposto, disarticolato, così da riprodurre il caos che caratterizza la vita. Ejzenstejn metterà in atto la sua teoria sin da Sciopero! (1924) in cui è rappresentato il caos della lotta e della rivoluzione attraverso una forma cinematografica scopertamente nuova.
7) La région centrale (1971) è il film di M. Snow, maestro dell’avanguardia cinematografica, nella quale una macchina da presa viene installata sopra l’apparecchiatura predisposta da un computer a fare percorrere ogni possibile movimento all’obiettivo, a tal punto che il disorientamento ottico e temporale ottiene addirittura di superare per rigore, in un ideale confronto tra “pesi massimi” della sperimentazione al cinema, l’elegante risultato di spaesamento spettatoriale raggiunto in 2001: Odissea nello spazio.
8) R. Eugeni, Invito al cinema di Kubrick, Mursia, Milano, 1995, pag. 79.
Vendesi Killer di Giulio D’Amicone
La figura del sicario è reperibile in diverse branche dell’arte, compresa l’opera lirica (Sparafucile nel Rigoletto). La letteratura ne abbonda: oltre al famosissimo racconto di Hemingway The killers, citerò soltanto il romanzo di Graham Greene Una pistola in vendita (1936), lo spionistico XPD di Len Deighton (1984) – che elegge a protagonista un elegante sicario dell’Intelligence Service – e il sarcastico Diario di un killer sentimentale di Sepùlveda (1996). Ma il cinema sembra nutrire per i rappresentanti di questo poco decoroso mestiere un particolare interesse. E’ pur vero che gli eroi dello schermo sono sempre stati abilitati all’uso delle armi, ma l’uccisore prezzolato non svolge i suoi incarichi al fine di purificare il mondo dai malvagi: egli raffigura invece proprio l’altra faccia della medaglia, il gregario prescelto dal villain come unico elemento valido in grado di opporsi all’eroe, e di conseguenza la sua entrata in scena rappresenta per lo spettatore una promessa di gustosi sviluppi narrativi. Fornirò di tale sfaccettato personaggio una breve panoramica senza pretese di completezza.
1. Una lista manichea
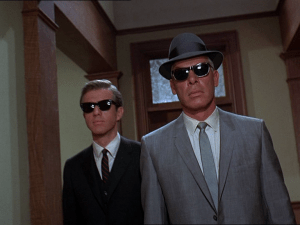 Sinteticamente, gli assassini a pagamento proposti dal cinema possono dividersi in due categorie: i buoni e i cattivi. Intendo per “buoni” quei personaggi in grado di mostrare una qualche dose di umanità a dispetto del mestiere. Per esempio Claude, il selfmade killer di Assassinio per contratto (Irving Lerner, 1958), si scopre a tal punto incapace di uccidere una donna da preferire la fuga all’adempimento dell’incarico; l’efficientissimo Léon (Luc Besson, 1994) instaura un profondo rapporto affettivo con la piccola Mathilda; e l’orientale protagonista di Crying Freeman (Christophe Gans, 1995) sparge addirittura calde lacrime dopo ogni missione compiuta. Spesso le attenuanti concesse sono legate alla famiglia: viene subito in mente il romantico Tony Arzenta (Duccio Tessari, 1973), tramutatosi in un’implacabile macchina di morte rivolta contro i suoi stessi capi dopo la fortuita eliminazione della moglie e del figlio. Nella parte finale di Little Odessa (James Gray, 1994) il canagliesco protagonista riallaccia i rapporti con i suoi familiari; Betty Love (Neil LaBute, 2000) pone in scena padre e figlio esercitanti la medesima professione (e il padre, Morgan Freeman, afferma di scegliere le sue vittime in base alla loro effettiva colpevolezza); infine il bellissimo Era mio padre (Sam Mendes, 2002) è incentrato sul profondo rapporto affettivo padre-figlio rinsaldatosi in una situazione di emergenza (la fuga da un assassino sardonicamente interpretato da Jude Law).
Sinteticamente, gli assassini a pagamento proposti dal cinema possono dividersi in due categorie: i buoni e i cattivi. Intendo per “buoni” quei personaggi in grado di mostrare una qualche dose di umanità a dispetto del mestiere. Per esempio Claude, il selfmade killer di Assassinio per contratto (Irving Lerner, 1958), si scopre a tal punto incapace di uccidere una donna da preferire la fuga all’adempimento dell’incarico; l’efficientissimo Léon (Luc Besson, 1994) instaura un profondo rapporto affettivo con la piccola Mathilda; e l’orientale protagonista di Crying Freeman (Christophe Gans, 1995) sparge addirittura calde lacrime dopo ogni missione compiuta. Spesso le attenuanti concesse sono legate alla famiglia: viene subito in mente il romantico Tony Arzenta (Duccio Tessari, 1973), tramutatosi in un’implacabile macchina di morte rivolta contro i suoi stessi capi dopo la fortuita eliminazione della moglie e del figlio. Nella parte finale di Little Odessa (James Gray, 1994) il canagliesco protagonista riallaccia i rapporti con i suoi familiari; Betty Love (Neil LaBute, 2000) pone in scena padre e figlio esercitanti la medesima professione (e il padre, Morgan Freeman, afferma di scegliere le sue vittime in base alla loro effettiva colpevolezza); infine il bellissimo Era mio padre (Sam Mendes, 2002) è incentrato sul profondo rapporto affettivo padre-figlio rinsaldatosi in una situazione di emergenza (la fuga da un assassino sardonicamente interpretato da Jude Law).
Passando ora alla lista dei secondi (senza dubbio più aderente alla realtà), si potrebbe iniziare col ributtante sicario dell’hitchockiano L’uomo che sapeva troppo (1956) per proseguire con gli scagnozzi presenti in Chi ucciderà Charley Varrick? (Don Siegel, 1973), Il mediatore (Robert Mulligan, 1974), I tre giorni del condor (Sydney Pollack, 1975), Gli intoccabili (Brian De Palma, 1987), Il rapporto Pelican (Alan Pakula,1993), Non è un paese per vecchi (fratelli Coen, 2007). Tali figure sono accomunate da un’ostentazione di sicumera sfociante nel compiacimento: spiccano per ironia il Molly siegeliano sessuofobo e razzista (Joe Don Baker), e l’impareggiabile Bo Hopkins del sottovalutato film di Mulligan; mentre De Palma, forse con un ricordo di Melville, dipinge la figura di Nitti – autentico uccisore al soldo di Capone – come una macchina di morte vestita di bianco (1). Ma nella categoria dei cattivi vanno pure inclusi alcuni illustri protagonisti: ricordiamo perlomeno lo splendido Michael Caine di Carter (Mike Hodges, 1971), James Fox in Il giorno dello sciacallo (Fred Zinnemann, 1973) e Tom Cruise in Collateral (Michael Mann, 2004). Tutti gli appartenenti a questa seconda tipologia sono peraltro destinati a fine ingloriosa (unica eccezione Joubert nel Condor pollackiano, peraltro l’unico che non agisce di mano propria).
Il titolo assegnato al paragrafo implica d’altronde l’esistenza di personaggi difficilmente riconducibili alle categorie suddette, primo fra tutti “il sicario in abito da sera” James Bond (la definizione è di Oreste De Fornari): creazione inizialmente non priva di qualche sfaccettatura, ma dal quarto film in poi (Operazione tuono, 1965) tramutatasi in un Rodomonte sovente ai confini del ridicolo (non a caso il grande pubblico lo scambia per americano) (2). Il volto intagliato nel cuoio di Charles Bronson, frequente sugli schermi negli anni settanta, ben si inserisce in questa sorta di terza suddivisione a rischio d’ignavia: per esempio il protagonista del bel film di Sergio Sollima Città violenta (1970) è sostanzialmente un vinto, anche se nel finale trova modo di prendersi una sanguinosa rivalsa su coloro che l’hanno ingannato. Molto singolare è pure la figura di Jonathan Hemlock in Assassinio sull’Eiger (Clint Eastwood, 1975), collezionista d’arte, scalatore provetto e pagatissimo eliminatore a tempo perso. Rinunciamo a compilare l’elenco dei criminali al servizio di mafie e camorre – copiosi sugli schermi nel periodo successivo al Padrino – limitandoci a menzionare una non memorabile apparizione di Walter Chiari nel film di Terence Young Joe Valachi (1972). Tra le recenti produzioni, Nessuna verità (Ridley Scott, 2008) mette in scena un agente della CIA (Leo Di Caprio) che può considerarsi un James Bond aggiornato ai tempi.
Infine uno sguardo all’altro sesso. Benché la compagine femminile sia meno nutrita, non mancano anche qui elementi di rilievo: si pensi all’atarassica Nikita dell’omonimo film di Besson (1990), dove compare anche, per la prima volta, Jean Reno nel personaggio che sarà da lui sviluppato in Léon; si pensi a CJ (Daryl Hanna) in The job (Kenny Golde, 2003), cresciuta nell’odio dopo l’assassinio della madre; si pensi alla solerte insegnante di tiro Angelina Jolie in Wanted (Timur Bekmabetov, 2008)… fino alla giovane Hanna (Joe Wright, 2011), educata alla poco nobile professione dallo stesso padre. Non va infine dimenticata la bella assassina di Munich (2005), posta in scena appena il tempo di eseguire un incarico che le costa assai caro, essendo di lì a poco eliminata in una delle scene più inutilmente crude della filmografia spielberghiana.
2. In due (talvolta) si lavora meglio
 Come quella dell’eroe, anche la figura del sicario conosce in molti casi un raddoppio (3). Sempre fondata su un deciso contrasto di età, di carattere e finanche di vestiario onde evitare uno sdoppiamento superfluo, la coppia si presenta in diverse varianti:
Come quella dell’eroe, anche la figura del sicario conosce in molti casi un raddoppio (3). Sempre fondata su un deciso contrasto di età, di carattere e finanche di vestiario onde evitare uno sdoppiamento superfluo, la coppia si presenta in diverse varianti:
- 1 – Coppia uomo-donna: L’onore dei Prizzi (John Huston, 1985), Mr. e Mrs. Smith e Shadowboxer, entrambi del 2005 (quest’ultima formata da una donna bianca e un uomo di colore più giovane) (4);
- 2 – Coppia di colleghi maschi: Crimine silenzioso (1958) e Contratto per uccidere (1964) di Don Siegel, Killer elite (Sam Peckinpah, 1975), Assassin(s) (Mathieu Kassovitz, 1997), In Bruges (Martin McDonagh, 2008). Al mantenimento di tale unione soggiace una temperie psicologica che non esclude connotazioni omosessuali.
- 3 – Coppia di avversari: Scorpio (Michael Winner, 1973), Assassins (Richard Donner, 1995: due sicari a confronto), Rogue il solitario (Philip Atwell, 2007: un agente FBI contro un impassibile omicida), The killer (John Woo, 1989) e Jimmy Bobo (Walter Hill, 2012): in questi ultimi due casi assistiamo ad uno scontro iniziale tra uccisore e rappresentante delle forze dell’ordine destinato a tramutarsi in alleanza contro un comune avversario (“Tutti e due usiamo le armi per vivere” dice l’assassino di Woo al poliziotto). Inoltre vanno nuovamente ricordati L’onore dei Prizzi (marito e moglie si scoprono alla fine nemici) e Killer elite (i due colleghi che divengono avversari).
3. Tipologia
 La più evidente peculiarità del sicario cinematografico è l’efficienza. Non di rado egli viene definito il migliore del mondo (o “il numero uno”, anche nel recentissimo Red 2): Assassins è basato proprio sul duello tra il detentore del titolo e un arrivista determinato a subentrargli. Spesso il nostro antieroe è fornito di un arsenale degno di una caserma dell’esercito (generalmente nascosto dietro un’entrata segreta). Gli incarichi sono eseguiti con freddezza e precisione, senza sprecare colpi ed utilizzando il silenziatore. Oltre alle armi da fuoco fanno la loro comparsa anche armi da taglio (Assassinio per contratto), ma all’occorrenza non ci si fa scrupolo di ricorrere a metodi più brutali: Bruce Willis in Slevin elimina una vittima spezzandogli il collo, ed il siegeliano Molly dimostra di saper ben usare i semplici pugni. La ricompensa è sempre alta, e in caso di contrattazione ci si muove nell’ordine di migliaia di dollari: esemplare in tal senso il dialogo tra Hemlock (Clint Eastwood in Assassinio sull’Eiger) e il suo mandante: la pretesa di una cifra superiore al normale è soddisfatta seduta stante dal capo il quale, prevedendo la richiesta, aveva già imbustato la somma. Quando l’imperturbabile Joubert (Max von Sydow) nei Tre giorni del condor tenta di convincere Turner a schierarsi dalla sua parte, gli fa anche balenare la possibilità di un guadagno alto e senza eccessivo impegno…
La più evidente peculiarità del sicario cinematografico è l’efficienza. Non di rado egli viene definito il migliore del mondo (o “il numero uno”, anche nel recentissimo Red 2): Assassins è basato proprio sul duello tra il detentore del titolo e un arrivista determinato a subentrargli. Spesso il nostro antieroe è fornito di un arsenale degno di una caserma dell’esercito (generalmente nascosto dietro un’entrata segreta). Gli incarichi sono eseguiti con freddezza e precisione, senza sprecare colpi ed utilizzando il silenziatore. Oltre alle armi da fuoco fanno la loro comparsa anche armi da taglio (Assassinio per contratto), ma all’occorrenza non ci si fa scrupolo di ricorrere a metodi più brutali: Bruce Willis in Slevin elimina una vittima spezzandogli il collo, ed il siegeliano Molly dimostra di saper ben usare i semplici pugni. La ricompensa è sempre alta, e in caso di contrattazione ci si muove nell’ordine di migliaia di dollari: esemplare in tal senso il dialogo tra Hemlock (Clint Eastwood in Assassinio sull’Eiger) e il suo mandante: la pretesa di una cifra superiore al normale è soddisfatta seduta stante dal capo il quale, prevedendo la richiesta, aveva già imbustato la somma. Quando l’imperturbabile Joubert (Max von Sydow) nei Tre giorni del condor tenta di convincere Turner a schierarsi dalla sua parte, gli fa anche balenare la possibilità di un guadagno alto e senza eccessivo impegno…
 Ma il prezzo da pagare per tutto questo è la solitudine, un’ascesi vissuta come una condanna perlomeno dai protagonisti di Cronaca di un assassinio (Allen Baron, 1961), Matador (Richard Shepard, 2007), Assassins (Stallone confessa a Julianne Moore di annoiarsi), mentre nel caso di Hitman (Xavier Gens 2007: poco riuscito adattamento dell’omonimo videogioco) si tratta di una scelta obbligata. In circostanze diverse l’eremitaggio può invece assumere tratti fascinosi. Nelle lunghe pause tra un incarico e l’altro, il nostro si gode la vita in riva a qualche solitario specchio d’acqua (Jason Statham in The mechanic) o si dedica a lavori da certosino (Michael Caine in Contratto marsigliese); una volta a riposo possiamo perfino trovarlo comodamente insediato alle isole Cayman (Charles Bronson in Professione giustiziere), anche se nessuno dubita che verrà richiamato di lì a poco per svolgere un nuovo incarico.
Ma il prezzo da pagare per tutto questo è la solitudine, un’ascesi vissuta come una condanna perlomeno dai protagonisti di Cronaca di un assassinio (Allen Baron, 1961), Matador (Richard Shepard, 2007), Assassins (Stallone confessa a Julianne Moore di annoiarsi), mentre nel caso di Hitman (Xavier Gens 2007: poco riuscito adattamento dell’omonimo videogioco) si tratta di una scelta obbligata. In circostanze diverse l’eremitaggio può invece assumere tratti fascinosi. Nelle lunghe pause tra un incarico e l’altro, il nostro si gode la vita in riva a qualche solitario specchio d’acqua (Jason Statham in The mechanic) o si dedica a lavori da certosino (Michael Caine in Contratto marsigliese); una volta a riposo possiamo perfino trovarlo comodamente insediato alle isole Cayman (Charles Bronson in Professione giustiziere), anche se nessuno dubita che verrà richiamato di lì a poco per svolgere un nuovo incarico.
Infine, a livello psicologico il nostro omicida è spesso assillato da un senso di colpa tale da condizionarne i comportamenti sia nel privato sia nello svolgimento dei suoi incarichi. Il citato Cronaca di un assassinio (nell’originale Blast of silence, cioè “raffica di silenzio”) è contraddistinto dalla voce fuori campo in seconda persona simboleggiante la coscienza e da una colonna sonora jazz atta a sottolineare la nevrosi del personaggio, un irrequieto asociale che trascorre l’ultimo periodo di vita – poco prima di essere eliminato ad opera dei compari – arrancando per le strade di una New York lugubre ad onta degli addobbi natalizi. Anche in The killer il senso di colpa è supportato dall’ambiente: il punto di riferimento di questo professionista azzimato – resosi accidentalmente responsabile della cecità di una ragazza durante una delle sue missioni svolte in completo nero e sciarpa candida – è la chiesa: lì incontra il suo mandante, lì si fa curare dalle ferite e lì affronta gli avversari nella mattanza conclusiva, sotto gli occhi di un’immagine della Madonna che alla fine va in frantumi abbandonandolo al suo destino.
 L’ingiustamente maltrattato Assassins vede un pagatissimo Robert Rath (Stallone) condizionato dal rimorso per essere stato costretto ad eliminare un suo caro amico (scoprirà solo alla fine di essere vittima di un equivoco). Il Matador Julian Noble (Pierce Brosnan) soffre di nervi e porta al dito un anello raffigurante la crocifissione; Armand Degas (Mickey Rourke), l’improbabile sicario indiano-canadese di Killshot (John Madden, 2008), si è invece reso responsabile senza volerlo della morte del fratello; il giovane Ray (Colin Farrell) del film di McDonagh In Bruges è invece angosciato per avere causato la morte di un bambino, mentre la decisione di ritirarsi di Jack (George Clooney) in The american (Anton Corbijn, 2010) è consequenziale al rimorso per l’omicidio della sua donna.
L’ingiustamente maltrattato Assassins vede un pagatissimo Robert Rath (Stallone) condizionato dal rimorso per essere stato costretto ad eliminare un suo caro amico (scoprirà solo alla fine di essere vittima di un equivoco). Il Matador Julian Noble (Pierce Brosnan) soffre di nervi e porta al dito un anello raffigurante la crocifissione; Armand Degas (Mickey Rourke), l’improbabile sicario indiano-canadese di Killshot (John Madden, 2008), si è invece reso responsabile senza volerlo della morte del fratello; il giovane Ray (Colin Farrell) del film di McDonagh In Bruges è invece angosciato per avere causato la morte di un bambino, mentre la decisione di ritirarsi di Jack (George Clooney) in The american (Anton Corbijn, 2010) è consequenziale al rimorso per l’omicidio della sua donna.
4. Conclusione
A dispetto delle perentorie dichiarazioni di Truffaut, talvolta anche le parodie possono offrirci opere riuscite. Passando oltre al fiacco Assassination bureau di Basil Dearden (1969), attendiamo ancora la versione completa del bellissimo Attento sicario: Crown è in caccia! di John Frankenheimer (1974). Il rompiballe di Molinaro (1973) e il rifacimento di Billy Wilder (Buddy Buddy, 1981) offrono entrambi coppie di interpreti di primo rango (Brel-Ventura e Lemmon-Matthau). Complessivamente riuscito anche Ho affittato un killer di Aki Kaurismaki (1990); mentre riteniamo Pulp fiction di Quentin Tarantino (1994) un’opera da non prendere troppo sul serio, come tutte le altre di questo cinefilo onnivoro. Sembra che il momento attuale sia particolarmente favorevole alle parodie (si veda il ciclo Machete di Rodriguez): nei tempi a venire avremo senza dubbio la possibilità di assistere a nuove avventure (serie o semiserie) di questa moderna personificazione dell’orco delle favole.
Giulio d’Amicone
______
(1) Intendo riferirmi al capitolo relativo alla bianchezza della balena nel Moby Dick.
(2) Ciò vale anche per il derivato Derek Flint nei due film interpretati da James Coburn, nonostante l’intento parodistico.
(3) E’ un tema ricorrente anche nel western: per esempio Ultima notte a Warlock di Edward Dmytryk (1959) mette in scena proprio un sicario (Henry Fonda) legato da vincoli di amicizia palesemente gay ad un ex baro claudicante (Anthony Quinn). Altri titoli inseribili nella nostra trattazione sono Invito ad una sparatoria (Richard Wilson, 1964), Missouri (Arthur Penn, 1976) e I cancelli del cielo (Michael Cimino, 1980) dove tuttavia Champion (Christopher Walken) non è il protagonista.
(4) Mentre nel film francese Il bersaglio (Robin Davis, 1982) il sicario Alain Delon fa coppia con Catherine Deneuve solo dopo averle rivelato il suo modo di guadagnarsi da vivere.
FESTIVAL
La lunga estate calda del Sardinia Film Festival. VIII International Short Film Award 2013 – June 24-29 Sassari di Grazia Brundu
L’estate 2013 è stata per il Sardinia Film Festival, il premio internazionale per cortometraggi organizzato dal Cineclub Sassari Fedic, un periodo impegnativo e ricco di novità. Sono soddisfatti il presidente Angelo Tantaro e il direttore artistico Carlo Dessì, che spiegano di aver lavorato «con grande impegno in tre direzioni complementari: la riconferma del prestigio ottenuto in otto anni di attività (testimoniato tra l’altro dal patrocinio del Mibac e della Presidenza del Consiglio, oltre che dai Premi di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, di quella della Camera e di quella del Senato, ndr); l’ “esportazione” del festival nel territorio come modello da seguire; la messa in cantiere di progetti per la prossima edizione».
Giusto per riassumere, prima di raccontare nei dettagli, l’estate del Sardinia Film Festival è iniziata a giugno, a Sassari, con la proiezione dei 150 film selezionati tra i quasi mille pervenuti, di fronte a un pubblico numeroso e attento. Proprio al festival si sono dati appuntamento attori, registi e maestranze provenienti da tutta la Sardegna per costituire “Moviementu, rete cinema Sardegna” e lanciare alla politica locale la richiesta di stanziamenti economici sicuri per fare del cinema un’industria sostenibile e redditizia. Poi, ad agosto, il Sardinia Film Festival, con 25 dei suoi corti in concorso, ha fatto da padrino al debutto del Premio Villanova Monteleone per i documentari. E infine, a settembre, insieme al regista Massimiliano Mazzotta, è partito un nuovo progetto, intitolato “Life after oil”, che costituirà una sezione speciale in concorso al Sardinia Film Festival 2014. Insomma, riconoscono Tantaro e Dessì, «attraversiamo un periodo di grande fervore, pur tra mille difficoltà, dovute soprattutto ai finanziamenti che diminuiscono di anno in anno. Noi comunque andiamo avanti, con il sostegno del pubblico e con la consapevolezza che il festival è, e ancora di più potrebbe essere se le amministrazioni fossero più presenti, una grande opportunità, culturale e turistica, per il territorio».
Passando ai dettagli, la novità più interessante dell’ ottava edizione del Sardinia Film Festival è stata la decisione di dedicare ciascuna delle sei giornate (24-29 giugno) a un tema di attualità. «Ci siamo accorti –racconta Carlo Dessì- che tra i 150 cortometraggi scelti per le proiezioni c’erano tre argomenti ricorrenti: il problema della disoccupazione, quello dei bambini maltrattati e sfruttati, la vita delle donne in società ancora troppo programmate al maschile». Così, prosegue: «abbiamo ideato le sezioni “Lavoro…quando posso”, “Donne nell’universo”, “ About children” per offrire al pubblico la possibilità di vedere come uno stesso argomento viene trattato in varie parti del mondo, quanto la globalizzazione ha uniformato i punti di vista e quanto rimane di intraducibile da una cultura a un’altra». L’ottava edizione ha avuto una doppia giuria, specchio di due nuove collaborazioni importanti. La prima collaborazione è con l’Accademia di Belle Arti di Sassari, da quest’anno nuovo partner del festival, che ha schierato nella giuria ufficiale il suo direttore Antonio Bisaccia e il docente di arti visive, Antonio Boscarino, insieme a Adriana Casu, esperta di cinema e socia del Cineclub. C’era poi una giuria di ragazzi, che ha assegnato una menzione speciale, formata da 5 giovani iscritti all’associazione europea “Carta Giovani”, che quest’anno ha voluto affiancare il festival con il quale condivide l’ attenzione per il mondo giovanile e per gli scambi internazionali.
Nelle ultime due giornate del Sardinia Film Festival sono arrivati a Sassari da tutta la Sardegna registi (tra i quali il presidente della Film Commission Antonello Grimaldi, Marco Antonio Pani, Bonifacio Angius), attori, costumisti, scenografi e tante altre maestranze del settore audiovisivo. È nato così, con il festival a fare da culla, il primo nucleo di “Moviementu, rete cinema Sardegna”, una rete che al momento conta centinaia di lavoratori del settore, stanchi delle vaghe promesse della politica locale e pronti a dare battaglia affinché vengano stanziati i fondi necessari perché il cinema diventi quell’industria pulita, sostenibile e redditizia della quale la Sardegna –delusa e inquinata da anni di industria petrolchimica e cassa integrazione- ha tanto bisogno. A dare un impulso decisivo alla costituzione della rete è stata la notizia, arrivata proprio durante il festival, dello stanziamento, da parte della Regione, di ben 200 mila euro per un evento di un solo giorno, in Costa Smeralda: il Premio cinematografico “Rodolfo Valentino” dedicato alla memoria dell’attore scomparso. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto che a luglio gli aderenti a Moviementu hanno manifestato compatti a Cagliari davanti all’Assessorato Regionale alla Cultura, dove hanno incontrato l’assessore Sergio Milia che ha promesso di prendere in considerazione le loro richieste. Staremo a vedere. Intanto si preannuncia un autunno caldo per il cinema sardo, ed è certo che quelli di “Movimentu” continueranno a farsi sentire finché non arriveranno i primi risultati concreti.
Dopo l’appuntamento di Sassari, una sezione distaccata del Sardinia Film Festival, costituita da 25 documentari, si è trasferita a Villanova Monteleone dal 22 al 24 agosto per dare vita alla prima edizione del “Premio Villanova Monteleone per i documentari”, una tre-giorni ricca di incontri, dibattiti e visioni. «Siamo orgogliosi –racconta il presidente del SFF Angelo Tantaro- di essere stati scelti come partner dall’amministrazione di Villanova in un progetto pilota della Regione Sardegna volto a rilanciare il territorio in prospettiva turistica». Che il progetto fosse giusto, l’ha dimostrato il pubblico che non ha perso una proiezione né un incontro. L’ esperimento è «riuscito anche oltre le aspettative –riconosce il direttore artistico del SFF Carlo Dessì. «Non solo per la grande affluenza di spettatori che ha toccato punte di 600 persone, tantissime per un paese, ma anche perché ha contribuito a sfatare il preconcetto secondo il quale il documentario è un genere di nicchia, un intrattenimento per “iniziati”». In realtà, prosegue, «il Premio Villanova Monteleone ha dimostrato che quando si toccano temi importanti che riguardano tutti, come la libertà, in particolare quella di stampa e di espressione, il pubblico risponde». Il successo, insieme alla qualità dei film, va attribuito agli ospiti presenti a Villanova, tra i quali la coppia (nella vita e nel giornalismo) Emanuela Falcetti-Amedeo Martorelli, che hanno infiammato gli animi del pubblico e dei documentaristi ricordando la scarsa libertà di cui godono i giornalisti italiani nel fare domande ai politici rispetto ai colleghi europei. Il pubblico si è lasciato coinvolgere anche dall’incontro con il giornalista dell’Unione Sarda, Sergio Naitza, che ha presentato il suo documentario “Le nostre storie ci guardano”, un viaggio affascinante nella memoria storica della Sardegna. Altro punto di forza, racconta Dessì «è il fatto che per tre giorni dodici giovani registi in concorso hanno vissuto a Villanova Monteleone, dando origine a uno scambio culturale e turistico molto riuscito: loro hanno raccontato agli abitanti del paese le proprie esperienze di vita e di lavoro, e allo stesso tempo sono rimasti affascinati dalla bellezza di Villanova. Sicuramente continueranno a parlarne e a fare pubblicità anche a casa e magari torneranno in vacanza con gli amici il prossimo anno».
Infine, per concludere la lunga estate impegnata del Sardinia Film Festival, il documentario, come riflessione su problemi attuali e non come rigida classificazione di genere, è il terreno da cui nasce un progetto al quale il Cineclub Sassari sta già lavorando e che a giugno del 2014 diventerà una sezione speciale della nona edizione del Sardinia Film Festival. Si tratta di “Life after oil”, in collaborazione con il regista Massimiliano Mazzotta, autore dei documentari-inchiesta “Oil” e “Oil secondo tempo” che testimoniano i disastri ambientali e sulla salute degli abitanti di Sarroch causati dalla raffineria Saras di proprietà della famiglia Moratti. Massimiliano Mazzotta e il Cineclub si rivolgono a tutti quei registi che –attraverso un cortometraggio non necessariamente documentaristico, ma anche dei generi fiction, animazione, o sperimentale,- vogliano esplorare vie alternative all’uso del petrolio come fonte principale di energia. Come dice Mazzotta, «sappiamo tutti che il petrolio, in quanto risorsa limitata e non rinnovabile, prima o poi finirà; l’unica incertezza è sul quando». A breve sarà diffuso il bando di partecipazione, ed è previsto anche un premio in denaro per il cortometraggio vincitore. C’è da scommettere che i registi desiderosi di partecipare non mancheranno, vista l’importanza dell’argomento e l’interesse sempre crescente per i documentari. Niente vacanze, quindi, per il Cineclub…il lavoro continua e tra poco si ricomincia con le selezioni per la nona edizione del Sardinia Film Festival.
Venezia 2013: Una Mostra equilibrata con il “Leone d’oro” a un documentario di Paolo Micalizzi
Una buona Mostra, equilibrata anche se non c’era il capolavoro. Ma tanti buoni film senz’altro se si considera non solo il Concorso “Venezia 70” ma anche “Orizzonti”, “Fuori concorso” e “Venezia classici” fino alla scelta del “Leone d’oro alla carriera” a William Friedkin e l’omaggio al nostro Francesco Rosi. Anche le “Giornate degli Autori” e la “Settimana della Critica” poi hanno offerto anche quest’anno opere che ampliano il panorama del cinema mondiale consentendo di constatare che in fondo il cinema gode di grande vitalità con storie e linguaggi innovativi di particolare interesse. L’aver inserito in Concorso i documentari “Sacro Gra” e “The unknown known” di Errol Morris è stato per il Direttore artistico Alberto Barbera una sfida. Un inserimento che aveva voluto nella giusta convinzione che “ormai la distinzione tra film e documentario appartiene al passato, è inadeguata e imprecisa: tutti e due sono opera di creazione”. E a verdetto emesso dalla Giuria, presieduta da un cineasta di cotanto prestigio come Bernardo Bertolucci (altra scelta vincente della Mostra), è stata una scommessa vinta. A conquistare il “Leone d’oro”, infatti,è stato il documentario di Gianfranco Rosi “Sacro Gra” ,vincendo cosi a sorpresa sulla fiction. E dando all’Italia, dopo 15 anni, il massimo riconoscimento della prestigiosa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: l’Italia, infatti, aveva trionfato l’ultima volta nel 1998 con “Cosi ridevano” di Gianni Amelio di cui quest’anno, purtroppo, il suo “L’Intrepido” non è stato considerato dalla critica all’altezza di un maestro come lui. “Sacro Gra” è un’opera che mostra una Roma mai vista sullo schermo, un film girato lungo il grande raccordo anulare raccontandone un mondo di cui scopre l’umanità che gli vive dentro, e intorno. Storie vere di personaggi singolari nel loro modo di vivere, storie bizzarre, autentiche e umanissime come quella di un botanico armato di sonde sonore e pozioni chimiche che cerca il rimedio per liberare le palme della sua oasi dalle larve divoratrici oppure quella di un pescatore di anguille che vive su di una zattera all’ombra di un cavalcavia. Ma anche quella di un nobile piemontese che con la figlia laureanda vive in un monolocale ai bordi del Raccordo o di un principe dei nostri giorni con un sigaro in bocca che fa ginnastica sul tetto del suo castello assediato dalle palazzine della periferia; o, ancora, la storia di un barelliere di un’autoambulanza del 118 di soccorso che gira giorno e notte sull’anello autostradale. Il documentario di Errol Morris, invece, è un avvincente ritratto di Donald Rumsfeld, Segretario della difesa degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Ford e quella di Bush jr, di cui racconta verità e bugie. Ma tanti altri documentari hanno attraversato le varie sezioni della Mostra. Fra essi, “Bertolucci on Bertolucci” di Luca Guadagnino e Walter Fasano, “Con il fiato sospeso” di Costanza Quatriglio, “Summer 82 when Zappa came in Sicily” di Salvo Cuccia, “Trepassing Bergman” di Jane Magnunson e Hynek Pallas, “Ukraine is not a brothel” (L’Ucraina non è un bordello) di Kitty Green sulla protesta delle “Femen”, “Donne nel mito: Anna Magnani a Hollywood” di Marco Spagnoli, “A Fuller Life” di Samantha Fuller, “Lino Miccichè, mio padre. Una visione del mondo” di Francesco Miccichè, “Profezia. L’Africa di Pasolini” di Enrico Menduni e Gianni Borgna, “Non eravamo solo…ladri di biciclette. Il neorealismo” di Gianni Bozzacchi. In quanto al Palmares, l’opera che in Concorso poteva contrastare la vittoria del film di Rosi era “Philomena”, dal nome di una persona attraverso la cui storia, vera, si racconta quella dei figli sottratti dalla chiesa irlandese agli inizi degli anni ’50. Il film dell’inglese Steve Frears si è dovuto accontentare del “ Premio per la migliore sceneggiatura”, che è un elemento importante del film che si reggeva comunque su una regia molto attenta a rendere la verità e la drammaticità del racconto e l’apporto di un’interpretazione straordinaria come quella di Judi Dench, penalizzata, fra l’altro nell’assegnazione dei premi, dalla scelta di attribuirlo a Elena Cotta per “Via Castellana Bandiera” di Emma Dante. Anche se l’attrice siciliana ha offerto una prestazione eccellente nel ruolo di una delle protagoniste di un duello dove i (o meglio le) protagonisti sono due guidatrici al volante di due macchine che si trovano ad attraversare, nello stesso momento e in senso opposto, una stradetta di un rione siciliano. E nessuna delle due è disposta a cedere. La non assegnazione del Premio alla Dench potrebbe quindi essere colpa della mentalità delle giurie che tendono a un criterio di distribuzione dei premi per accontentare tutti. Noi, e non solo noi, siamo del parere che se un film merita più riconoscimenti è bene assegnarglieli. Tanto più che quando si vuole, questo avviene (vedi, quest’anno, il caso del film “Miss Violence” del greco Alexandros Avranas, insignito, a nostro avviso, immeritatamente del “Leone d’argento” e della Coppa per la migliore interpretazione maschile a Themis Panou). Si può invece essere d’accordo con il Gran Premio della Giuria a “Stray dogs”(Cani randagi) di Tsai Ming-liang( Taipei cinese, Francia), che era giustamente tra i favoriti della vigilia, un’opera che si è distinta per un linguaggio innovativo che disintegra la tradizionale struttura narrativa. Il film racconta una storia di estrema solitudine, attraverso il personaggio di un padre che si guadagna da vivere pubblicizzando come “cartello umano” appartamenti di lusso mentre i due figli si procurano il cibo tra gli scarti dei centri commerciali e l’intera famiglia dorme in rifugi occasionali di periferia. In quanto al Premio speciale della Giuria al tedesco Philippe Groning per “Die frau des polizisten” (La moglie del poliziotto) si tratta di un riconoscimento ad un’opera interessante per l’uso di un linguaggio anticonvenzionale. E’ una storia di violenza familiare scandita in 57 capitoli: cronaca di un dramma raccontato quasi minuto per minuto. Il Concorso ha allineato poi altre opere di particolare interesse. Fra esse, molto applaudito dalla critica, “La jalousie” di Philippe Garrel, uno dei cineasti d’oltrealpe più irregolare, che svolge un racconto autobiografico. Da apprezzare anche “Ana Arabia” dell’israeliano Amos Gitai che auspica che il dialogo tra palestinesi ed israeliani non debba essere interrotto e si possa arrivare a convivere armoniosamente. Ha ricevuto il Premio Bresson, collaterale alla Mostra. In Concorso poi la Mostra ha presentato quello che dovrebbe essere, secondo sue dichiarazioni, l’ultimo film del padre del cinema d’animazione giapponese, il settantaquattrenne Hayao Miyazaki, “Si alza il vento”. Racconta la storia di un personaggio esistito, Jiro Horikoshi, ragazzo che negli anni Venti sognava di volare, ma essendo troppo miope per fare il pilota diventò allora un grande ingegnere aeronautico, progettista del miglior aereo da combattimento giapponese, utilizzato per l’attacco a sorpresa a Pearl Harbor. Non una vera favola, come ci aveva abituato Miyazaki, ma un film realistico in cui il sapore di essa è però molto evidente. “Venezia Orizzonti” ha annoverato alcune opere interessanti tra cui l’italiano “La prima neve” di Daniele Segre autore insignito nel 2011 del “Premio Fedic” con “Io sono Lì”. In questo secondo lungometraggio il regista racconta una storia incentrata sul rapporto tra culture diverse che nel rapporto tra adulti e ragazzi diventa l’occasione per capire e conoscere. E’ ambientato nei masi dell’inedito scenario della Valle dei Mocheni, luogo affascinante pieno di boschi. Italiano è anche “Piccola patria” di Alessandro Rossetto che mostra un’umanità meschina in un Triveneto desolato, territorio lacerato di capannoni industriali e terreni agricoli che il regista osserva con lo sguardo di un sensibile documentarista rivelandoci un Triveneto con i suoi pregiudizi e le sue contraddizioni. Il massimo riconoscimento è stato attribuito a “Still life” di Uberto Pasolini, un film, ispirato ad una storia vera, sul rispetto dei morti con protagonista un impiegato del Comune incaricato di trovare il parente prossimo di persone morte in solitudine: un’opera di dolce umanità interpretato da un Eddie Marsan che sorregge tutto il peso del film. Un altro film che rivela in Uberto Pasolini, malgrado i suoi 56 anni, un sicuro regista del futuro. Premi anche in “Venezia classici” che raccoglieva film restaurati e documentari sul cinema realizzati nell’ultimo anno. Ad aggiudicare i premi una Giuria composta da studenti di cinema provenienti da diverse università italiane: 28 laureandi in Storia del cinema indicati dai docenti di 13 DAMS e della veneziana Cà Foscari. Due i riconoscimenti: quello destinato al miglior film restaurato è stato attribuito all’indimenticabile “La proprietà non è più un furto” (1974) di Elio Petri, quello per il miglior documentario sul cinema a “Double play: James Benning and Richard Linklater” del brasigliano Gabe Klinger, opera che documenta l’amicizia di due animatori di un’associazione che nel 1985 ad Austin( Texas) proiettavano film classici e sperimentali facendo nascere una comunità di cinefili. Da evidenziare anche il “Leone del futuro. Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis” consistente in 100.000 USD che ben possono aiutare a realizzare un nuovo film: è stato assegnato, da un’apposita giuria, presieduta dalla regista araba Haifa Al Mansour, al film “White Shadow” (Ombra bianca) dell’esordiente Noaz Deshe. Racconta la storia di Alias, costretto a un’esistenza in fuga perché in Tanzania gli albini sono oggetto di uno spaventoso mercato della carne da parte di medici-stregoni che utilizzano parti del corpo per farne pozioni magiche. Film di grande interesse anche nella sezione “Fuori Concorso”. Quello che ha dato tante emozioni è stato “Che strano chiamarsi Federico” in cui “Scola racconta Fellini” come recita il sottotitolo, un amarcord, tra documentario e fiction, basato sui ricordi personali di Ettore Scola che ha ricostruito piccoli importanti episodi della vita del regista riminese, passando attraverso cinquant’anni di amicizia. Un viaggio che commuove. “Fuori Concorso” anche “Die andere Heimat” di Edgar Reitz e “Walesa” di Andrzej Wajda. Il primo racconta un dramma familiare sullo sfondo delle vicende che a metà del XIX secolo vide centinaia di migliaia di europei emigrare in America del Sud nel tentativo di sottrarsi alla povertà e al despotismo che dominavano i loro paesi. Il secondo, che si muove tra finzione e realtà, parte dalla figura di Walesa, l’elettricista che diventa Presidente, per raccontare mezzo secolo di Polonia. Momento chiave del film è l’incontro/scontro tra Walesa e la giornalista Oriana Fallaci (nel cui ruolo vediamo Maria Rosaria Omaggio che per questa interpretazione ha ricevuto una Menzione speciale nel “Premio Pasinetti” del SNGCI). La sezione annoverava anche “The Armstrong lie” di Alex Gibney, documentario che traccia uno spietato ritratto di un campione del ciclismo coinvolto in un un sistema sportivo fraudolento. Deludente “Moebius” di Kim Ki-duk (Corea del Sud), film infarcito di immagini scioccanti e di estrema violenza che, in fondo, sembrano fini a se stesse. Interessante, invece, “Locke” dell’inglese Steve Knight, un thriller in continuo crescendo di tensione tutto girato in un’auto ed interpretato da un solo attore (il bravissimo Tom Hardy). E’ incentrato su un uomo che mentre corre in ospedale dove la sua amante sta per partorire, attraverso le telefonate alla moglie e al figlio e con il suo capo furioso perché cosi diserterà un importantissimo appuntamento di lavoro, svela un dramma morale su una scelta di vita. Barbera l’avrebbe voluto in Concorso, ma non è stato possibile perché arrivato in ritardo e lui aveva già scelto tre titoli inglesi: poteva concorrere ad un premio importante. Ancora una volta positivo è stato l’interesse per le sezioni collaterali “Giornate degli Autori” e “Settimana della Critica”. Alle “Giornate degli Autori” ha vinto “Giovani ribelli” dello statunitense John Krokidas, un’opera che racconta gli anni della beat generation sottolineando figure come il poeta Allen Ginsberg (nel cui ruolo si cala sorprendentemente l’ex “maghetto” Daniel Radcliffe) , Jack Kerouac, William S.Burroughs. Proprio con un film delle “Giornate” la Mostra ha avuto una preapertura con “L’arbitro” di Paolo Zucca, opera che prima di diventare lungometraggio ha girato per Festival come cortometraggio: fra le prime apparizioni quella in Concoso a “Valdarno Cinema Fedic” dove ha conquistato il “Premio Marzocco”. Un film, ”L’arbitro”, in chiave ironica, ambientato in Sardegna e incentrato su un arbitro internazionale le cui vicende s’incrociano con quelle di un allenatore cieco, una bisbetica indomita, un pastore vendicativo e un improbabile goleador. Alla “Settimana della Critica” vincitore è stato “Zoran, il mio nipote scemo” di Matteo Oleotto in cui il regista riscopre la provincia veneta. Protagonista è Giuseppe Battiston nel ruolo di Paolo che come tanti che vivono in una piccola città di provincia sogna un altrove dove cominciare una nuova vita ma poi rimarrà nello stesso luogo tra le stesse facce, nella stessa osteria dove il vino, che nella vicenda ha un ruolo importante, annebbia e consola. Malgrado il sogno di accompagnare il nipote Zoran, campione nel lancio delle freccette, ad una gara internazionale. Il film ha avuto anche alcuni premi collaterali tra cui il “Premio Fedic”, presieduto da Roberto Barzanti, che lp ha premiato con la seguente motivazione:” per la freschezza di una commedia che evita i luoghi comuni adottati per lo più dal genere in Italia, proponendo un personaggio divertente e amaro insieme in un quadro ambientale insolito dove si confrontano due culture”. Alla “Settimana” era in Concorso anche “L’arte della felicità” di Alessandro Rak a cui il “Premio Fedic” ha assegnato una Menzione speciale “perché è un esperimento intelligente e coraggioso di animazione italiana che utilizza, sullo sfondo di una Napoli finalmente non convenzionale, questa tecnica anche per sviluppare tematiche attuali adulte”. Una vera rivelazione. Un premio alla carriera al regista americano William Friedkin, seguace di un cinema indipendente nella convinzione che il cinema può cambiare la società. La Mostra ha riproposto, con copie restaurate, i suoi “L’esorcista” e “Il salario della paura”. Un Omaggio particolare a Francesco Rosi con la proiezione di “Le mani sulla città”. Un evento che si è svolto, purtroppo con una pioggia battente che però non ha impedito che quasi duecento persone (poche in realtà) potessero assistere alla proiezione del film che, come ha dichiarato nell’occasione Alberto Barbera, “è un capolavoro assoluto ed è importante anche perché è stato apripista a livello internazionale di un cinema di denuncia sociale, preso a modello da moltissimi autori”. L’Italia, quindi, esce dalla Mostra di Venezia con tre prestigiosi riconoscimenti: “Leone d’oro” al documentario di Gianfranco Rosi ,Coppa Volpi a Elena Cotta, “Premio Orizzonti” al film di Uberto Pasolini. Ed ha indicato che il rinnovamento del cinema può incominciare anche dal documentario per trovare nuove strade. Lo testimonia anche l’interesse che hanno suscitato altri documentari presenti alla Mostra. Un’altra considerazione da fare è che alla Mostra si è constatato che il cinema al femminile sta crescendo sempre di più. Nelle varie sezioni hanno, infatti , partecipato ben 21 donne-registe: 2 in concorso,3 “fuori concorso”,5 in Orizzonti, 2 nei documentari di “Venezia classici”, 1 nella SIC e 8 alle “Giornate degli Autori”. Senza contare quelle presenti in Giuria come Haifa Al Mansour che presiedeva il Premio Opera Prima De Laurentiis in cui figurava anche Maria Sole Tognazzi. Da sottolineare poi che per la terza volta è tornato all’Hotel Excelsior il “Venice Film Market”, un luogo strutturato dove produttori, distributori e venditori hanno potuto organizzare il loro lavoro. Ma anche uno spazio per incontri culturali promossi dalle Associazioni cinematografiche. In quest’ambito ha avuto luogo anche il “Forum Fedic” che con l’avallo della Mostra da 18 anni si svolge al Lido. Quest’anno era incentrato sui Festival Fedic sui quali, dopo un’introduzione del curatore del Forum Paolo Micalizzi e del Presidente Fedic Roberto Merlino, ha relazionato Gianluca Castellini evidenziando la loro consistenza in una Rete che consta per ora in ben 11 Festival: di alcuni di essi hanno dato testimonianza lo stesso Castellini (direttore artistico di “Sedicicorto” di Forlì e “Animare” di Cesenatico), Marcello Zeppi(Presidente Montecatini International ShortFilmFestival-Filmvideo), Lorenzo Bianchi Ballano (Festival del Cinema di Brescello), Monique Martini(Presidente FilmCaravan di Imperia), Beppe Rizzo (Presidente Cineclub Alassio). Ma anche Ernesto G.Laura, critico e storico del cinema, nonché documentarista che segue sin dal 1950 le attività Fedic e che con le sue competenze ha dato ad essa un significativo contributo. Un Forum che è stato aperto con un intervento di Luigi Cuciniello, direttore organizzativo della Mostra, che ha dichiarato che, nelle polemiche in cui si trova a dibattere durante il Festival, trova nel Forum un’oasi in cui si parla di vero cinema, quello indipendente, quello che non necessariamente deve tenere conto di budget, star, divi, capricci, ecc. e che concentra l’attenzione nell’oggetto vero intorno al quale queste manifestazioni sono nate. Nel dibattito è intervenuto anche Marco Asunis che ha ribadito come la FICC (di cui è presidente) e la FEDIC collaborino da anni e appuntamenti come il Forum di Venezia rafforzano senz’altro le due Federazioni. Corti anche nell’omaggio ai 70 anni della Mostra con la proiezione di “Venezia 70. Future Reloaded”, un collier di 70 corti, tra i 60 e i 90 secondi, che raccontano il cinema di ieri e di oggi, realizzati da cineasti già consacrati nella loro prestigiosa carriera e autori emergenti sulla scena internazionale. Per noi quello della Mostra è un bilancio positivo: ha presentato opere di qualità e, nella giusta misura, di divi, cosi come si conviene ad una manifestazione che deve poter registrare l’interesse della critica e del mondo del cinema compresi i cinefili, ed attrarre un pubblico più vario e vasto. E le cifre, in questo senso, testimoniano che i risultati sono stati positivi: 20% in più di biglietti venduti rispetto all’edizione precedente. Una Mostra in cui si è avuta una consistente panoramica sul cinema contemporaneo e sulle direzioni verso cui è orientato. Ma che ha anche mostrato il cinema delle scoperte e delle provocazioni, che con una Mostra come quella di Venezia oltre agli addetti ai lavori ha delle possibilità di raggiungere anche il pubblico delle sale cinematografiche. E poi, come per gli altri anni, è stata l’occasione per incontri fra persone che condividono la passione per il cinema. E sono non solo momenti di arricchimento culturale ma anche umano.
31 ° Valdarno Cinema Fedic. Intitolato a Marino Borgogni il Premio Marzocco di Paolo Micalizzi
All’elenco degli ospiti di prestigio che negli anni hanno preso parte a “Valdarno Cinema Fedic” si sono aggiunti quest’anno il già affermato Silvio Soldini e l’esordiente Matteo Oleotto. Il primo è stato omaggiato con il conferimento del Premio Marzocco alla carriera, con una Masterclass che ha riscosso molto interesse e con la proiezione di due sue opere significative come il cortometraggio “Drimage”(1982) e il lungometraggio “L’aria serena dell’Ovest”, mentre il secondo ha presentato il suo “Zoran,il mio nipote scemo” che alla Mostra di Venezia aveva anche ottenuto il Premio Fedic, un a vera rivelazione. In quan to al Concorso(giunto alla 64. Edizione) il Premio Marzocco, che viene attribuita alla migliore opera in assoluto, è stato intitolato al compianto Marino Borgogni che da sempre è stato l’anima del Festival. La giuria, presieduta da Italo Moscati e composta da Chiara Bruno e Angelo Orlando, lo ha attribuito al film di Gaia Bonsignore “Bye-Bye Blackbird”, un corto di 15 minuti dall’affascinante atmosfera surreale che è stato premiato “ per l’originalità di una storia in cui si mescola la realtà con intensità poetica”. Per il lungometraggio (Premio Adriano Asti) la giuria ha premiato “Slot-Le intermittenti luci di Franco” di Dario Albertini in cui è protagonista un uomo, abbandonato da moglie e figlia per la sua irrefrenabile dipendenza dalle slot machine. Rimasto solo comprenderà che deve riallacciarsi alla famiglia e per questo lascia la Sardegna, con una macchina piena di formaggi, per raggiungere i suoi a Civitavecchia. La motivazione sottolinea che il premio gli viene attribuito “per lo sguardo mai giudicante sulle intermittenze emotive di un personaggio solo, perché accende e spenge dei fari discreti sull’uomo e trasforma una storia particolare in universale”. Ha anche conquistato il Premio Fedic per il miglior film prodotto da un autore Fedic. Miglior cortometraggio di fiction o documentario, che ha avuto il Premio Amedeo Fabbri, è stato proclamato “Dreaming apecar” di Dario Samuele Leone perché “comunica l’incomunicabilità con il respiro aperto di una tragicommedia quotidiana, sostenuto da due attori che accorciano la reciproca distanza sulla strada dei loro cammini”. Il cortometraggio è incentrato su una donna italiana di quarantacinque anni che, rimasta senza lavoro, accetta di fare la badante occupandosi di un esuberante ottantenne romeno. Ne nascerà un’esperienza che le cambierà la vita. Per un documentario di particolare rilevanza espressiva, come recita il Premio Luciano Becattini, il riconoscimento è stato assegnato a “The silent chaos” di Antonio Spanò. L’opera, ambientata a Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, documenta una realtà tragica in cui i ribelli Mai Mai cercano di mantenere l’identità perduta ,a causa della sanguinosa guerra civile, attraverso l’arcaismo, superstizione e credenza magica. E considerano il diverso, come i sordi di Butembo, come una minaccia. Alla giuria è piaciuto “per il respiro intenso che riempie ogni spazio di umana tenerezza di un altrove dimenticato”. Sulla scena attoriale sono balzati alla ribalta altri due bravi interpreti ai quali è andato un “Giglio Fiorentino”. Stefano Ambrogi è stato premiato come miglior interprete maschile per il suo ruolo di tassista nel cortometraggio “Le tette di una diciottenne” di Luca Gennari “perché nel monologo serratissimo di cui il passeggero del taxi è spettatore, parla anche e soprattutto con ciò che non dice. Ed, inoltre, “perché trasforma una maschera grottesca in un personaggio anche drammatico”. Eleonora Costanzo, invece, si è guadagnato il premio per la migliore interpretazione femminile come protagonista del cortometraggio “Ammore” di Paolo Sassanelli in cui è Rosy, una ragazzina diventata adulta che deve fare i conti con la realtà: la giuria l’ha premiata “ per la verità di una recitazione naturale e intensa in un percorso drammatico fatto di pause e silenzi che riescono a toccare corde altamente emotive”. “Valdarno Cinema Fedic “ ha poi portato alla ribalta del cinema dei filmakers, attraverso significativi riconoscimenti, altri autori promettenti. Alberto Giuliani e Francesca Es per “Ti amo,addio”, Enrico Iannacone per “L’esecuzione”, Cristian Natoli per “Mano ignota- Peteano una strage dimenticata “ che riporta alla luce un grave fatto: ha ricevuto il premio A.N.P.I. perché ha meglio interpretato e rappresentato i valori storici e ideali dai quali è nata la Costituzione della Repubblica Italiana. Riconoscimenti significativi anche da parte della Giuria Giovani che ha evidenziato l’opera di Vito Palmieri “Matilde” assegnandole la Medaglia del Presidente della Repubblica, attribuendo poi una menzione speciale a “Rapiti” di Manuele Moriconi. Quelle menzionate, le eccellenze, secondo le giurie, di una produzione indipendente in cui si è registrato l’impegno dei filmakers a tendere a proporre temi originali ,affrontandoli anche con una significativa proprietà di linguaggio, offrendo cosi al mondo del cinema altri momenti di riflessione. “Valdarno Cinema Fedic “ anche quest’anno è stato ricco di proposte. Tra esse, la “Vetrina Fedic”, il Concorso riservato alla Scuola, lo “Spazio Toscana” e “ I film Fedic 1963”. E poi una novità costituita dalla presentazione delle Webseries cui hanno partecipato i Blanket e i livornesi Licaoni, consentendo cosi di far conoscere un altro settore in cui i filmakers possono cimentarsi ed esprimere il proprio talento.
Paolo Micalizzi
Rotterdam 2014 di Giampiero Raganelli
Rotterdam arriva al secondo anno di direzione artistica ad interim di Mart Dominicus, per la temporanea assenza, dovuta a seri problemi di salute, del direttore Rutger Wolfson. Un periodo cruciale e di riassetto organizzativo che tuttavia non scalfisce minimamente i punti di forza del festival olandese, che rimangono inalterati da decenni. Le sue dimensioni elefantiache con oltre 660 film programmati, tutti generalmente replicati tre volte nelle 24 sale di proiezione, quasi tutte concentrate in tre grandi multisala, cinque sezioni e cinque retrospettive. Il carattere di assoluta nicchia di un festival senza passerelle, senza Hollywood e con una vocazione per il cinema del mondo, per le cinematografie meno conosciute e lontane da quelle occidentali. Il concorso di quest’anno vedeva opere provenienti paesi che non rientrano nel tradizionale glamour festivaliero, come Svezia, Croazia, Brasile, Austria, Tailandia, Canada, Bulgaria. E nutritissima, con 63 film, è la sezione Bright Future, dedicata a registi giovani.
Tra i grandi festival Rotterdam si avvicina alla concezione di Locarno e, non a caso, le due manifestazioni sono ancora improntate al modello Marco Müller che le ha plasmate nei suoi anni di direzione. Rotterdam paradossalmente ora soffre proprio la Roma passata nelle mani del suo ex direttore, che la anticipa di poco. Il film clou di quest’anno nella kermesse olandese, Hard to Be a God di Aleksey German, era già stato anticipato da Roma così come era successo l’anno scorso con il film della Muratova, Eternal Homecoming. Ma con Locarno Rotterdam ha anche in comune una fondazione emanazione del festival, sempre voluta da Müller, l’Hubert Bals Fund che quest’anno ha festeggiato il venticinquesimo anno dalla sua costituzione. Un bilancio che vede un migliaio di progetti finanziati, celebrato con una selezione di questi come una delle retrospettive dell’anno. Si è potuto vedere così il primo film prodotto dalla fondazione, Life on a String di Chen Kaige, regista che andò a bussare la porta di Huub Bals, ancora in vita, per chiedere un supporto del festival per poter completare il proprio film. E da lì nacque l’idea di trasformare questo aiuto in qualcosa di permanente. L’apertura stessa dell’IFFR è stata affidata a un film della fondazione, Qissa di Anup Singh, dramma sociale di una famiglia senza figli maschi, di religione Sikh del Punjab.
Un ritorno a Rotterdam per il regista Sergio Caballero, catalano, trionfatore a Rotterdam quattro anni fa con Finisterrae, codirettore del Sonar Festival di Barcellona sulle arti multimediali. Il suo nuovo lavoro, La distancia, è ispirato tanto a Stalker quanto a Kung Fu Panda, con protagonisti dei nani dotati di poteri telepatici in missione in una sperduta centrale elettrica dismessa in Siberia, per impadronirsi della cosa più preziosa in essa custodita: la distanza. Come nel film di Tarkovskij, Caballero ricrea una “zona”, un incrocio di paesaggi, una terra di nessuno dove non esiste il tempo, dove può avvenire la lievitazione, dove confluiscono fisica, magia, antropologia.
Trionfatore del festival il film giapponese Anatomy of a Paper Clip di Ikeda Akira, opera grottesca tra Tati e il teatro dell’assurdo, ambientata in una fabbrica dove si producono, a mano, graffette piegando un filo di ferro. Desolazione, alienazione e incomunicabilità trionfano nell’ambiente degli operai, vessati da un sadico padrone, dove vigono fordismo, taylorismo e toyotismo applicati anche a una lavorazione artigianale. Vincitore anche il sudcoreano Han Gong-Ju di Lee Su-Jin, titolo che è il nome del protagonista, un ragazzo costretto a lasciare il piccolo villaggio dove è cresciuto per riparare in una grande metropoli industriale. Costruito con una narrazione a incastro, con i ricordi, dolorosi, del protagonista che riaffiorano a galla, per far emergere una storia di abusi sessuali.
Terzo film insignito dell’Hivos Tiger Awards lo svedese Something Must Break di Ester Martin Bergsmark, storia di amori transgender, di passioni tormentate attraverso un viaggio personale nel proprio mondo interiore: il film è tratto da un romanzo cult scritto dal compagno del regista. Da segnalare, sempre in concorso, il tailandese Concrete Clouds di Lee Chatametikool, che rievoca i fantasmi di un passato, il 1997 del collasso dell’economia asiatica, per raccontare della solidarietà di due fratelli il cui padre si è suicidato per l’improvvisa crisi; lo spagnolo Stella cadente di Luis Miñarro, film storico sulla figura di Amedeo di Savoia che fu re di Spagna dal 1871 al 1873. Con uno stile calligrafico che comprende anche brani di musical, il regista racconta una storia di solitudine e frustrazione che strizza non pochi occhiolini al mondo attuale.
Ma il grande merito della Rotterdam di quest’anno è stata la personale completa dedicata all’autore danese Nils Malmros. Si tratta di un regista misconosciuto fuori dalla patria, dove paradossalmente è molto più popolare di Lars von Trier; il suo ultimo lavoro, Sorrow and Joy, non ha avuto l’accoglienza che si sarebbe meritato, a Roma dove è stato presentato, rimanendo un film incompreso forse anche perché non si conosce la filmografia del regista di cui quest’opera rappresenta un tassello. Quello di Malmros è un cinema intimista, il cui progetto estetico primario è l’essenza stessa della vita, e del cinema, in una filmografia dedicata alle varie stagioni dell’esistenza, dove i continui riferimenti autobiografici si mescolano alla finzione, dove gli stessi attori tornano, come degli Antoine Doinel, seguiti nella loro crescita. E soprattutto quello di Malmros è un cinema che si alimenta di se stesso, che si costruisce su progressive summe del cinema precedente, tra sequel non dichiarati, film sul making di altri film e sulla vita di attori dei suoi film, fino ad arrivare a Sorrow and Joy e al suo giocare a rimpiattino tra vita e cinema, in un cortocircuito dove il secondo può far tornare indietro, modificandola, la prima.
64^ Berlinale di Giampiero Raganelli
Edizione sottotono della Berlinale di quest’anno almeno per quanto riguarda un concorso mai così disomogeneo, capace di alternare opere importanti, anche di grandi maestri, con altre del tutto trascurabili. Risultato in definitiva di un festival che non arriva al potere e all’appeal di Cannes e Venezia e che riesce a tratti ad accaparrarsi le opere più importanti.
Quest’anno il colpo grosso è stato senza dubbio l’ultima fatica del sempreverde Alain Resnais, Aimer, Boire et Chanter, dove prosegue i suoi discorsi sul teatro, come nel precedente Vous n’avez encore rien vu e tornando al modello di Smoking/No Smoking – ma anche sul fumetto, sua grande passione – con fondi stilizzati e disegni, applausi e quarta parete. E ancora, attraverso teatro, metateatro e metacinema, il discorso arriva alla vita e alla morte, sempre con un tono di grande leggerezza, in una commedia con i soliti e sodali attori brillanti, Sabine Azéma e André Dussollier, che mettono in scena personaggi memorabili fatti della stessa sostanza dei sogni.
Tra i film più attesi, anche per la nemmeno troppo sottile operazione di marketing che faceva trapelare in pillole notizie morbose, è stato Nymphomaniac – Volume 1 di Lars von Trier. Film che esplicita, ancora dopo Antichrist, la ninfomania cinematografica dell’autore, l’anatomia di una sessualità nevrotica, associata a un senso patologico di depressione, e, proprio in quanto tale, da esibire e non occultare, in un percorso autoriale di ricerca del superamento del confine del non mostrabile che, a ben vedere, era già iniziata con Onde del destino.
Boyhood si palesa invece come l’opera definitiva di Richard Linklater. Ancora sotto l’azzurro del cielo terso del Texas, il film segue la vita, i sogni, la crescita di Mason, ragazzo che vive con la sorella e la madre separata. Linklater si cimenta in un’operazione vagheggiata più volte nella storia del cinema, anche in un fantomatico progetto dello stesso Von Trier, quella di far coincidere il più possibile cinema e vita, flusso temporale reale e flusso narrativo, con un film realizzato nel corso di dodici anni registrando così la crescita e l’invecchiamento dei protagonisti. La vita continua.
Meno conosciuto in occidente rispetto al suo coetaneo Akira Kurosawa, il maestro nipponico ottantatreenne Yamada Yoji con The Little House torna a un’epoca cruciale della storia del suo paese, quella della Seconda guerra mondiale, un nodo scoperto per una società che ancora ha problemi con i conti irrisolti con quel passato. E lo racconta in maniera delicatissima, con quel tocco che solo i grandi autori classici giapponesi hanno saputo dare, attraverso le memorie di una cameriera che lavorava a servizio di una famiglia borghese.
Fuori dal concorso va senz’altro segnalato il lavoro (tecnicamente un mediometraggio, vicino all’idea di videoinstallazione, ma ogni classificazione appare riduttiva) di Tsai Ming-Liang, Journey To the West. Marsiglia. Un uomo che respira, un uomo che cammina. Un monaco che passeggia nella grande città francese, tra la folla, a una velocità lentissima rispetto a quella ‘normale’ dei ritmi della città. Quasi impercettibile. Eppur si muove. Tsai prosegue il suo lavoro del progetto “Walk”, ma il film che più richiama questo è il seminale Good Bye, Dragon Inn. A confronto due velocità, due dimensioni, due battiti del cuore, due filosofie ma anche due tipi di cinema come si fronteggiavano in quel film. Le lunghissime inquadrature sul pubblico, il suo cinema ascetico, messe in risonanza e in opposizione con il film nel film, la velocità ipercinetica del wuxia.
Da ricordare ancora l’ultimo lavoro del regista rumeno Corneliu Porumboiu, The Second Game. Si tratta della riproposizione in tempo reale di una partita di calcio del 1988 che vedeva contrapposte, sotto un’abbondante nevicata, due squadre fiore all’occhiello del regime, Steaua e Dinamo, con i commenti off dello stesso regista e del padre Adrian che era l’arbitro di quel match. Dietro le immagini smangiate, traballanti, dalla pessima definizione, di un videotape anni Ottanta, si cela un mondo, quello di un sistema tirannico che celebra i propri fasti mentre è a un passo dal burrone, dallo sgretolamento proprio come le immagini che ne rappresentavano lo splendore.
Parallelamente a concorso e sezioni collaterali, la Berlinale riesce sempre a organizzare retrospettive di altissima qualità e valore scientifico. Un cinema ritrovato a fianco di quello contemporaneo. Quest’anno la rassegna aveva il titolo “Aesthetics of Shadow – Lighting Styles 1915-1920”, ed è stata curata dalla Deutsche Kinemathek e dal MoMA di New York, e ispirata da un saggio dello studioso Dasuke Miyao. Le basi e i tratti comuni, le influenze reciproche nell’uso della luce e delle ombre tra le cinematografie hollywoodiana, giapponese ed europea, tra il 1915 e il 1950, sono oggetto del saggio. Passano attraverso registi come il giapponese Kinugasa Teinosuke che realizza una via nipponica all’espressionismo tedesco con Jujiro (1928) o direttori della fotografia come Henry Kotani, giapponese emigrato in America, collaboratore di DeMille negli anni dieci, poi richiamato in patria dagli studios del Sol Levante come ambasciatore del cinema hollywoodiano. La rassegna dimostra così un continuum unico, un substrato comune tra cinematografie tradizionalmente considerate come a se stanti.




